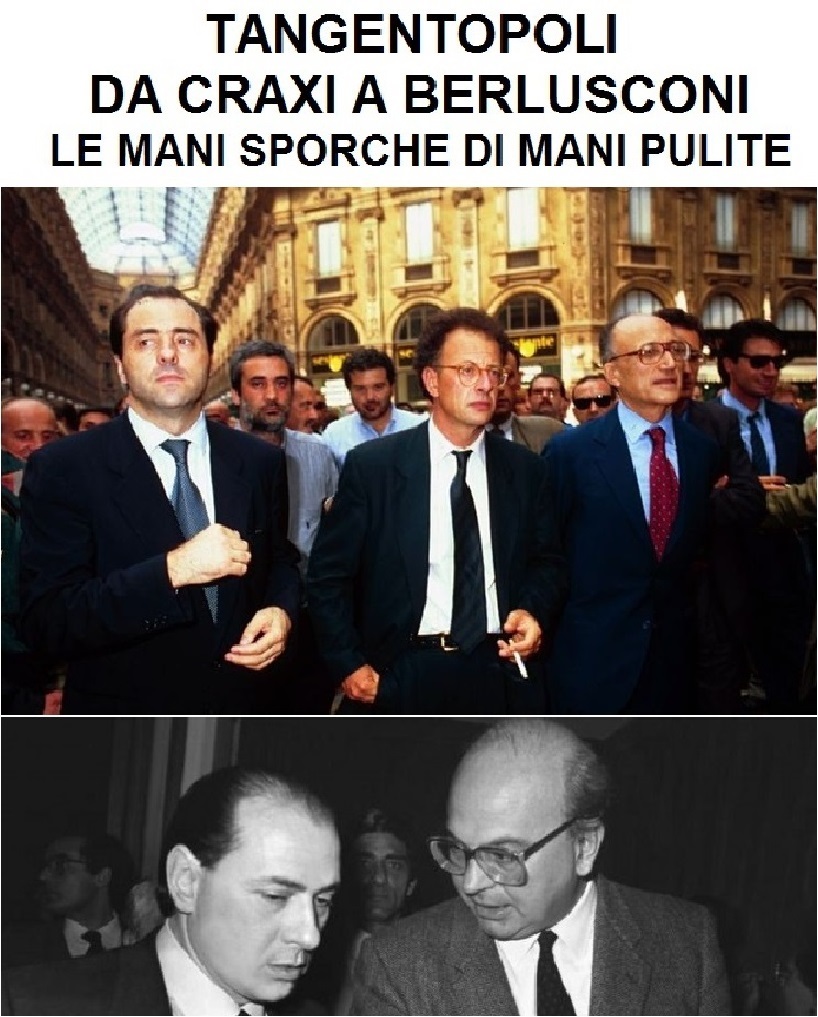Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per
cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma
tanto basta per loro per censurarmi.
I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo
di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.
Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza
censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio
personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della
Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali
fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali."
L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni
forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però
fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze
di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della
cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di
autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse
personale dell’autore.
L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del
1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza
degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le
seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa
lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali
e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette
citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata
dallo scopo.
Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e
notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli
usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro
in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile
un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto
parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza
illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale
inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.
Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di
riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,
discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o
didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e
perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con
i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera
parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e
di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge
contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di
autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.
Promuovo
in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e
censurato.
Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da
tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione
personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di
migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per
quello che scrivo
i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le
visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la
fonte.
Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare
per potermi mantenere. Non vivo solo di aria:
Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.
Dr Antonio Giangrande
NOTA BENE
NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I
MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB
SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE
DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA
NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE
NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER
IL CONTRADDITTORIO
LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:
-
accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601
- CAB 15800 - c/c n. 000092096221)
-
versamento in bollettino postale sul
c.c. n. 92096221. intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA
-
SCEGLI IL LIBRO
 PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
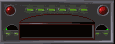
 presidente@controtuttelemafie.it
presidente@controtuttelemafie.it
 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996
 0999708396
0999708396
 INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:
CONTROTUTTELEMAFIE -
MALAGIUSTIZIA
-
TELEWEBITALIA
INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:
CONTROTUTTELEMAFIE -
MALAGIUSTIZIA
-
TELEWEBITALIA
 FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
(gruppi)
ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE -
TELE WEB ITALIA
ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI
(pagine)
GIANGRANDE
LIBRI
 WEB TV:
TELE WEB ITALIA
WEB TV:
TELE WEB ITALIA
 NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA

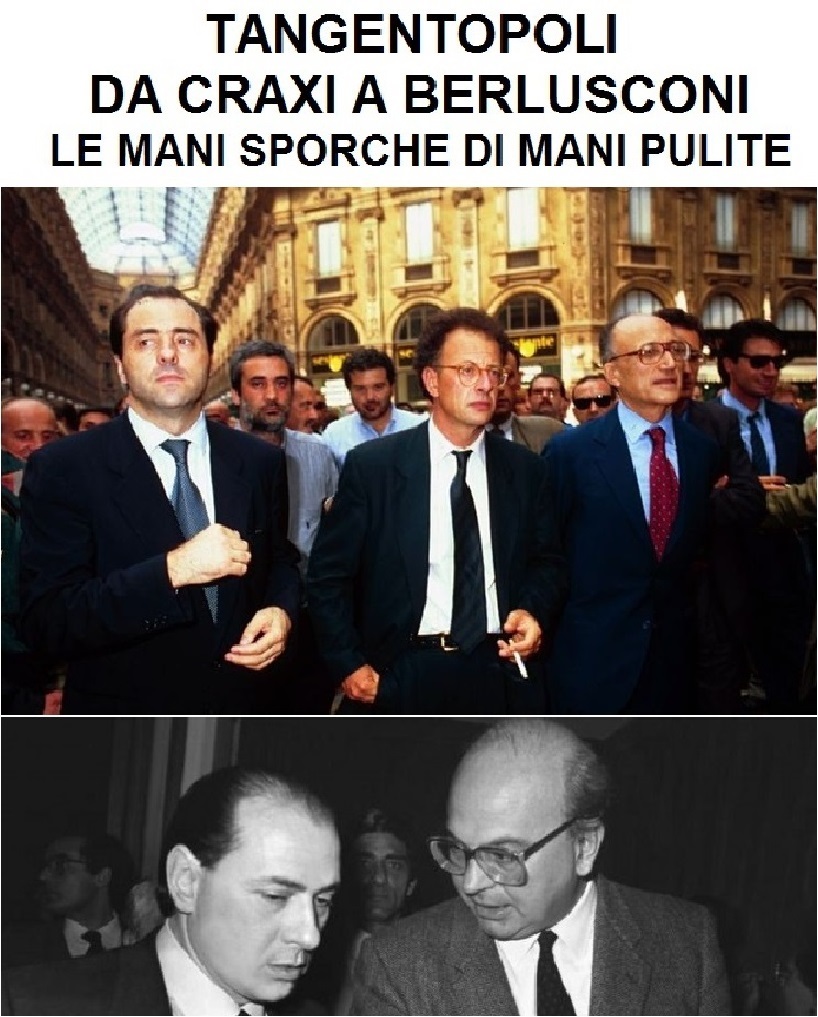
LA MAFIA
TI UCCIDE, TI AFFAMA, TI CONDANNA
IL
POTERE TI INTIMA: SUBISCI E TACI
LE MAFIE
TI ROVINANO LA VITA. QUESTA ITALIA TI DISTRUGGE LA SPERANZA
UNA VITA
DI RITORSIONI, MA ORGOGLIOSO DI ESSERE DIVERSO
"Fatti non
foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza". Dante, Inferno
XXVI
Antonio Giangrande, scrittore, accademico senza cattedra universitaria di
Sociologia Storica, giornalista ed avvocato non abilitato. "Prima di giudicare
la mia vita o il mio carattere mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho
percorso io, vivi i miei dolori, i miei dubbi, le mie risate...vivi gli anni che
ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io. Ognuno
ha la propria storia. E solo allora mi potrai giudicare." Luigi Pirandello.
"C’è
un’azione peggiore che quella di togliere il diritto di voto al cittadino e
consiste nel togliergli la voglia di votare.” (R. Sabatier)
Se
la religione è l’oppio dei popoli, il comunismo è il più grande spacciatore. Lo
spaccio si svolge, sovente, presso i più poveri ed ignoranti con dazione di beni
non dovuti e lavoro immeritato. Le loro non sono battaglie di civiltà, ma guerre
ideologiche, demagogiche ed utopistiche. Quando il nemico non è alle porte, lo
cercano nell’ambito intestino. Brandiscono l’arma della democrazia per asservire
le masse e soggiogarle alle voglie di potere dei loro ipocriti leader. Lo Stato
è asservito a loro e di loro sono i privilegi. Come tutte quelle religioni con
un dio cattivo, chi non è come loro è un’infedele da sgozzare. Odiano il
progresso e la ricchezza degli altri. Ci vogliono tutti poveri ed al lume di
candela. Non capiscono che la gente non va a votare perché questa politica ti
distrugge la speranza.
Quando il più importante sindaco di Roma, Ernesto Nathan, ai primi del ‘900
scoprì che tra le voci di spesa era stata inserita in bilancio, la TRIPPA,
necessaria secondo alcuni addetti agli archivi del comune, per nutrire i gatti
che dovevano provvedere a tenere lontani i topi dai documenti cartacei, prese
una penna e barrò la voce di spesa, tuonando la celeberrima frase: NON C'È PIÙ
TRIPPA PER GATTI, il che mise fine alla colonia felina del Comune di Roma.
I mediocri del Politically Correct negano sempre il merito. Sostituiscono sempre
la qualità con la quantità. Ma è la qualità che muove il mondo, cari miei, non
la quantità. Il mondo va avanti grazie ai pochi che hanno qualità, che valgono,
che rendono, non grazie a voi che siete tanti e scemi. La forza della ragione
(Oriana Fallaci)
“L'Italia tenuta al guinzaglio da un
sistema di potere composto da caste, lobbies, mafie e massonerie: un'Italia che
deve subire e deve tacere.
La “Politica” deve essere legislazione
o amministrazione nell’eterogenea rappresentanza d’interessi, invece è
meretricio o mendicio, mentre le “Istituzioni” devono meritarlo il rispetto, non
pretenderlo. Il rapporto tra cittadini e il rapporto tra cittadini e Stato è
regolato dalla forza della legge. Quando non vi è cogenza di legge, vige la
legge del più forte e il debole soccombe. Allora uno “Stato di Diritto” degrada
in anarchia. In questo caso è palese la responsabilità politica ed istituzionale
per incapacità o per collusione. Così come è palese la responsabilità dei media
per omertà e dei cittadini per codardia o emulazione."
TIRANNIDE indistintamente
appellare si debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto alla esecuzion
delle leggi, può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle,
sospenderle; od anche soltanto deluderle, con sicurezza d'impunità. E quindi, o
questo infrangi-legge sia ereditario, o sia elettivo; usurpatore, o legittimo;
buono, o tristo; uno, o molti; a ogni modo, chiunque ha una forza effettiva, che
basti a ciò fare, è tiranno; ogni società, che lo ammette, è tirannide; ogni
popolo, che lo sopporta, è schiavo. Vittorio Alfieri (1790).
"Quando si cerca di far progredire la conoscenza e l'intelligenza
umana si incontra sempre la resistenza dei contemporanei, simile a un fardello
che bisogna trascinare e che grava pesantemente al suolo, ribelle ad ogni
sforzo. Ci si deve consolare allora con la certezza che, se i pregiudizi sono
contro di noi, abbiamo con noi la Verità, la quale, dopo essersi unita al suo
alleato, il Tempo, è pienamente certa della sua vittoria, se non proprio oggi,
sicuramente domani."(Arthur Schopenhauer)
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo con la discultura e la
disinformazione. Ci si deve chiedere: perchè a scuola ci hanno fatto credere con
i libri di testo che Garibaldi era un eroe ed i piemontesi dei salvatori; perché
i media coltivano il luogo comune di un sud Italia cafone ed ignorante; perché
la prima cosa che insegnano a scuola è la canzone “bella ciao”? Per poi scoprire
da adulti e solo tramite il web: che il Sud Italia è stato depredato a causa
proprio di Garibaldi a vantaggio dei Piemontesi; che solo i turisti che scendono
a frotte nel meridione d’Italia scoprono quanto ci sia tanto da conoscere ed
apprezzare, oltre che da amare; che “Bella ciao” è solo l’inno di una parte
della politica italiana che in nome di una ideologia prima tradì l’Italia e poi,
con l’aiuto degli americani, vinse la guerra civile infierendo sui vinti,
sottomettendoli, con le sue leggi, ad un regime illiberale e clericale.
Ad Avetrana, il paese di Sarah Scazzi, non sono omertosi, sempre che non si
tratti di poteri forti. Ma qualcuno certamente vigliacco e codardo lo è. Sapendo
che io ho le palle per denunciare le illegalità, questi deficienti usano il mio
nome ed appongono falsamente la mia firma in calce a degli esposti che
colpiscono i poveri cristi rei di abusi edilizi o commerciali. I cretini, che
poi fanno carriera politica, non sanno che i destinatari dei miei strali sono
magistrati, avvocati, forze dell’ordine, e comunque pubblici ufficiali o
esercenti un pubblico servizio. Che poi queste denunce finiscono nell’oblio
perché “cane non mangia cane” e per farmi passare per mitomane o pazzo o
calunniatore o diffamatore, è un’altra cosa. Però da parte di questi coglioni
prendersela con i poveri cristi per poi far addossare la colpa a me ed essere
oggetto di ritorsioni ingiustificate è da veri vigliacchi. D'altronde un paese
di coglioni sarà sempre governato, amministrato, giudicato da coglioni.
È molto meglio osare cose straordinarie, vincere gloriosi trionfi, anche se
screziati dall'insuccesso, piuttosto che schierarsi tra quei poveri di spirito
che non provano grandi gioie né grandi dolori, perché vivono nel grigio e
indistinto crepuscolo che non conosce né vittorie né sconfitte. (...) Non è il
critico che conta, né l'individuo che indica come l'uomo forte inciampi, o come
avrebbe potuto compiere meglio un'azione. L'onore spetta all'uomo che realmente
sta nell'arena, il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore, dal sangue; che
lotta con coraggio; che sbaglia ripetutamente, perchè non c'è tentativo senza
errori e manchevolezze; che lotta effettivamente per raggiungere l'obiettivo;
che conosce il grande entusiasmo, la grande dedizione, che si spende per una
giusta causa; che nella migliore delle ipotesi conosce alla fine il trionfo
delle grandi conquiste e che, nella peggiore delle ipotesi, se fallisce, almeno
cade sapendo di aver osato abbastanza. Dunque il suo posto non sarà mai accanto
a quelle anime timide che non conoscono né la vittoria, né la sconfitta.
Franklin Delano Roosevelt
Cari signori, io ho iniziato a destare le coscienze 20 anni prima di Beppe
Grillo e nulla è successo. Io non cercavo gli onesti, ma le vittime del sistema,
per creare una rivoluzione culturale…ma un popolo di “coglioni” sarà sempre
governato ed amministrato da “coglioni”.
Un chierico medievale si imbatté in un groviglio di serpi su cui spiccava un
ramarro che già da solo sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia, confrontata a
quelle serpeggianti creature, la bestiola gli parve graziosa ed esclamò: «Beati
monoculi in terra caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo è re.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo
giudizi gratuiti, cattivi ed illogici lo facciamo con la nostra bocca ma
inconsapevolmente per volontà di altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto:
dall’educazione familiare, dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento
politico e religioso, dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro
sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo
che nessuno sarebbe capace e disposto ad ascoltarci.
In una Italia dove nulla è come sembra, chi giudica chi è onesto e chi no?
Lo hanno fatto i comunisti, i dipietristi, i leghisti, i pentastellati. Lor
signori si son dimostrati peggio degli altri e comunque servitori dei
magistrati. E se poi son questi magistrati a decidere chi è onesto e chi no,
allora se tutti stanno dalla parte della ragione, io mi metto dalla parte del
torto.
Ogni tema trattato sinteticamente in quest'opera è oggetto di approfondimento
analitico in un saggio dedicato.
Alcune puntualizzazioni sul Diritto di Cronaca, Diritto di Critica, Privacy e
Copyright.
In
seguito al ricevimento di minacce velate o addirittura palesi nascoste dietro
disquisizioni giuridiche, al pari loro si palesa quanto segue. I riferimenti ad
atti ed a persone ivi citate, non hanno alcuna valenza diffamatoria e sono solo
corollario di prova per l'inchiesta. Le persone citate, in forza di norme di
legge, non devono sentirsi danneggiate. Ogni minaccia di tutela arbitraria dei
propri diritti da parte delle persone citate al fine di porre censura in tutto o
in parte del contenuto del presente dossier o vogliano spiegare un velo di
omertà sarà inteso come stalking o violenza privata, se non addirittura
tentativo di estorsione mafiosa. In tal caso ci si costringe a rivolgerci alle
autorità competenti.
Come
è noto, il diritto di manifestare il proprio pensiero ex art. 21 Cost. non può
essere garantito in maniera indiscriminata e assoluta ma è necessario porre dei
limiti al fine di poter contemperare tale diritto con quelli dell’onore e della
dignità, proteggendo ciascuno da aggressioni morali ingiustificate. La decisione
si trova in completa armonia con altre numerose pronunce della Corte. La
Cassazione, infatti, ha costantemente ribadito che il diritto di cronaca possa
essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell’altrui reputazione,
costituendo così causa di giustificazione della condotta a condizione che
vengano rispettati i limiti della verità, della continenza e della pertinenza
della notizia. Orbene, è fondamentale che la notizia pubblicata sia vera e che
sussista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti. Il diritto di cronaca,
infatti, giustifica intromissioni nella sfera privata laddove la notizia
riportata possa contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti
oggettivamente rilevanti. Il principio di continenza, infine, richiede la
correttezza dell’esposizione dei fatti e che l’informazione venga mantenuta nei
giusti limiti della più serena obiettività. A tal proposito, giova ricordare che
la portata diffamatoria del titolo di un articolo di giornale deve essere
valutata prendendo in esame l’intero contenuto dell’articolo, sia sotto il
profilo letterale sia sotto il profilo delle modalità complessive con le quali
la notizia viene data (Cass. sez. V n. 26531/2009). Tanto premesso si può
concludere rilevando che pur essendo tutelato nel nostro ordinamento il diritto
di manifestare il proprio pensiero, tale diritto deve, comunque, rispettare i
tre limiti della verità, pertinenza e continenza.
Diritto di Cronaca e gli estremi della verità, della pertinenza e della
continenza della notizia. L'art. 51 codice penale (esimente dell'esercizio di un
diritto o dell'adempimento di un dovere) opera a favore dell'articolista nel
caso in cui sia indiscussa la verità dei fatti oggetto di pubblicazione e che la
stessa sia di rilevante interesse pubblico. In merito all'esimente del Diritto
di Cronaca ex art. 51 c.p., la Suprema Corte con Sentenza n 18174/14 afferma:
"la cronaca ha per fine l'informazione e, perciò, consiste nella mera
comunicazione delle notizie, mentre se il giornalista, sia pur nell'intento di
dare compiuta rappresentazione, opera una propria ricostruzione di fatti già
noti, ancorchè ne sottolinei dettagli, all'evidenza propone un'opinione". Il
diritto ad esprimere delle proprie valutazioni, del resto non va represso
qualora si possa fare riferimento al parametro della "veridicità della cronaca",
necessario per stabilire se l'articolista abbia assunto una corretta premessa
per le sue valutazioni. E la Corte afferma, in proposito: "Invero questa Corte è
costante nel ritenere che l'esimente di cui all'art. 51 c.p., è riconoscibile
sempre che sia indiscussa la verità dei fatti oggetto della pubblicazione,
quindi il loro rilievo per l'interesse pubblico e, infine, la continenza nel
darne notizia o commentarli ... In particolare il risarcimento dei danni da
diffamazione è escluso dall'esimente dell'esercizio del diritto di critica
quando i fatti narrati corrispondano a verità e l'autore, nell'esposizione degli
stessi, seppur con terminologia aspra e di pungente disapprovazione, si sia
limitato ad esprimere l'insieme delle proprie opinioni (Cass. 19 giugno 2012, n.
10031)".
La
nuova normativa concernente il rapporto tra il diritto alla privacy ed il
diritto di cronaca è contenuta negli articoli 136 e seguenti del Codice privacy
che hanno sostanzialmente recepito quanto già stabilito dal citato art. 25 della
Legge 675 del 1996. In base a dette norme chiunque esegue la professione di
giornalista indipendentemente dal fatto che sia iscritto all'elenco dei
pubblicisti o dei praticanti o che si limiti ad effettuare un trattamento
temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli saggi o altre manifestazioni del pensiero:
può
procedere al trattamento di dati sensibili anche in assenza dell'autorizzazione
del Garante rilasciata ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 196 del 2003;
può
utilizzare dati giudiziari senza adottare le garanzie previste dall'art. 27 del
Codice privacy;
può
trasferire i dati all'estero senza dover rispettare le specifiche prescrizioni
previste per questa tipologia di dati;
non
è tenuto a richiedere il consenso né per il trattamento di dati comuni né per il
trattamento di dati sensibili.
Il
mio utilizzo dei contenuti soddisfa i requisiti legali del fair use o del fair
dealing ai sensi delle leggi vigenti sul copyright. Le norme nazionali ed
internazionali mi permettono di fare copie singole di parti di opere per ricerca
e studio personale o a scopo culturale o didattico. Infatti sono autore del
libro che racconta della vicenda. A tal fine posso assemblarle o per fare una
rassegna stampa.'''
(* Per gli appalti truccati, qui
accennato, ho scritto appositamente un libro a parte).
(* Per i concorsi pubblici e per gli
Esami di Stato, qui accennato, ho scritto appositamente un libro a parte).
(* Per l’esame truccato di avvocato,
qui accennato, ho scritto appositamente un libro a parte).
(* Per il malgoverno, sprechi e
disservizi ho scritto appositamentedei libri a parte).
Di Antonio Giangrande
SOMMARIO
UNA BALLATA
PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande).
INTRODUZIONE
SILVIO E BETTINO, I LUPI DELLA MILANO DA BERE.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
GABRIELE
CAGLIARI E GLI ALTRI. SONO STATI SUICIDATI?
DEVASTATI DA MANI PULITE.
LA REPUBBLICA GIUDIZIARIA, ASPETTANDO LA TERZA REPUBBLICA.
RICORDANDO BETTINO CRAXI.
FIGLI DI PUTIN...
MANI GOLPISTE.
TANGENTOPOLI. LE MANI SPORCHE DI MANI PULITE.
I GIORNALISTI. I KILLER DELLA PRIMA REPUBBLICA.
TANGENTOPOLI. UN TEMA STORICO.
IN QUESTO
MONDO DI LADRI.
CHI FA LE LEGGI?
"PADRI
DELLA PATRIA" VITTIME E COMPLICI DELLA
NOSTRA ROVINA.
ONESTA’ E
DISONESTA’
IL
GIUSTIZIALISMO GIACOBINO E LA PRESCRIZIONE.
POOL MANI PULITE, MAGISTRATURA DEMOCRATICA E COMUNISMO:
ATTRAZIONE FATALE PER FAR FUORI AVVERSARI POLITICI E MAGISTRATI SCOMODI!
CRAXI E LE INTERPRETAZIONI DELLA STORIA TRA MANETTARI E
GARANTISTI.
OPERATORI
DI (IN)GIUSTIZIA…..
ANTONIO
GIANGRANDE, GABRIELLA NUZZI, SILVIO BERLUSCONI: LE RITORSIONI DEI MAGISTRATI.
IL PARTITO
INVISIBILE. ASTENSIONISMO, VOTO MIGRANTE E VOTO DI PROTESTA: I MOTIVI DI UNA
DEMOCRAZIA INESISTENTE.
LA PATRIA DELLA CORRUZIONE.
LE BUGIE
DEI POLITICANTI CHE SCHIAVIZZANO I NOSTRI GIOVANI.
MINISTRI. UNA IMPUNITA' TUTTA PER LORO.
PER GLI ONOREVOLI...NON C'E' FRETTA.
LA MAFIA DELL'ANTIMAFIA.
E’ TUTTA
QUESTIONE DI COSCIENZA.
I MEDIA ED
I LORO PECCATI: DISINFORMAZIONE, CALUNNIA, DIFFAMAZIONE.
PER UNA
LETTURA UTILE E CONSAPEVOLE CONTRO L’ITALIA DEI GATTOPARDI.
POLITICA,
GIUSTIZIA ED INFORMAZIONE. IN TEMPO DI VOTO SI PALESA L’ITALIETTA DELLE
VERGINELLE.
LA
REPUBBLICA DELLE MANETTE.
TUTTI
DENTRO CAZZO!
VADEMECUM
DEL CONCORSO TRUCCATO.
LA LEGGE
NON E’ UGUALE PER TUTTI.
ITALIA
PAESE DELL’IMMUNITA’ E DELLA CENSURA. PER L’EUROPA INADEMPIENTE SU OGNI NORMA.
STATO DI
DIRITTO?
CHI E’ IL
POLITICO?
CHI E’
L’AVVOCATO?
DELINQUENTE
A CHI? CHI E’ IL MAGISTRATO?
DUE PAROLE
SULLA MAFIA. QUELLO CHE LA STAMPA DI REGIME NON DICE.
CARMINE
SCHIAVONE. LA VERA MAFIA SONO I POLITICI, I MAGISTRATI E LE FORZE DELL’ORDINE.
2 OTTOBRE
2013. LE GIRAVOLTE DI BERLUSCONI. L’APOTEOSI DELLA VERGOGNA ITALICA.
ITALIA DA
VERGOGNA.
ITALIA
BARONALE.
CASA ITALIA.
ITALIA.
SOLIDARIETA’ TRUCCATA E DI SINISTRA.
LA GUERRA
TRA ASSOCIAZIONI ANTIRACKET.
ITALIA:
PAESE ZOPPO.
QUANDO I
BUONI TRADISCONO.
DUE COSE SU
AMNISTIA, INDULTO ED IPOCRISIA.
FACILE DIRE
EVASORE FISCALE A TUTTI I TARTASSATI. GIUSTO PER MANTENERE I PARASSITI. LA LOREN
E MARADONA.
ANCHE GESU'
E' STATO CARCERATO.
ANCHE GLI
STUDENTI SONO UNA CASTA.
QUANTO SONO
ATTENDIBILI LE COMMISSIONI D’ESAME?
LO STATO CON LICENZA DI TORTURARE ED UCCIDERE.
E LA CHIAMANO GIUSTIZIA. CHE CAZZO DI INDAGINI SONO?
27 NOVEMBRE 2013. LA DECADENZA DI BERLUSCONI.
FIGLI DI
QUALCUNO E FIGLI DI NESSUNO.
LA TERRA
DEI CACHI, DEI PARLAMENTI ABUSIVI E DELLE LEGGI, PIU’ CHE NULLE: INESISTENTI.
LO SPRECO
DI DENARO PUBBLICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO.
SONO BRAVI
I COMUNISTI. NIENTE DIRITTO DI DIFESA PER I POVERI.
MENTRE PER
LE LOBBIES LE PORTE SONO SEMPRE APERTE.
LA LOBBY
DEI DENTISTI E LA MAFIA ODONTOIATRICA.
UNIONE
EUROPEA: ITALIA 60 MILIARDI DI CORRUZIONE. CHI CAZZO HA FATTO I CONTI?
FATTI DI
CRONACA, DISFATTI DI GIUSTIZIA.
LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA. DA QUALE PULPITO
ARRIVA LA PREDICA, SE LO STATO E’ IL PRIMO EVASORE IN ITALIA?
L’ITALIA,
IL PAESE DEI NO. LA SINDROME DI NIMBY.
L’ITALIA
DEI COLPI DI STATO.
PER LA
TUTELA DEI DIRITTI DEGLI INDIGENTI. PRO BONO PUBLICO OBBLIGATORIO.
NON VI
REGGO PIU’.
BELLA ITALIA, SI’. MA ITALIANI DEL CAZZO!!!
FENOMENOLOGIA RANCOROSA DELL’INGRATITUDINE.
SE NASCI IN
ITALIA…
DIRITTO E
GIUSTIZIA. I TANTI GRADI DI GIUDIZIO E L’ISTITUTO DELL’INSABBIAMENTO.
GIUSTIZIA
DA MATTI E MOSTRI A PRESCINDERE.
L’ANTIMAFIA DEI RECORD.
LA CHIAMANO
GIUSTIZIA, PARE UNA BARZELLETTA. PROCESSI: POCHE PAGINE DA LEGGERE E POCHI
TESTIMONI.
IL SUD TARTASSATO.
ITALIANI. LA CASTA DEI "COGLIONI". FACCIAMO PARLARE CLAUDIO
BISIO.
IL NORD
EVADE PIU’ DEL SUD.
IGNORANTI
IN PARLAMENTO.
IGNORANTI NELLA
SOCIETA’ CIVILE.
LADRI IN PARLAMENTO. TANGENTOPOLI ED IL POOL MANI PULITE: LA
GENESI.
IL POOL DI MANI PULITE: FRANCESCO SAVERIO BORELLI. ILDA
BOCCASSINI. PIERCAMILLO DAVIGO. ARMANDO SPATARO. GERARDO D'AMBROSIO. GHERARDO
COLOMBO. FRANCESCO GRECO. ANTONIO DI PIETRO. TIZIANA PARENTI.
LE MITICHE TANGENTI ROSSE.
TANGENTOPOLI E TIFO DA STADIO, 20 ANNI DOPO.
LA CASTA. CON L'IMMUNITA' PARLAMENTARE SI DIFENDE.
"1992": LA STORIA SCRITTA DAI VINCITORI.
DA QUALE PULPITO VIEN LA PREDICA. CORRUZIONE NEL CUORE DELLO
STATO E DELLA SOCIETA' CIVILE.
LA SINISTRA: IERI DIVERSI. OGGI CATTIVI E DANNOSI...OSSIA UGUALI.
A SINISTRA: DA ACCUSATORI AD ACCUSATI LE COSE CAMBIANO.
SPUTTANATI E SPUTTANANDI.
CON LO SPUTTANAMENTO C'E' LA GALERA...ANCHE I MAGISTRATI.
REATO IMPUNITO: LA FUGA DI NOTIZIE.
LE COOP ED IL SISTEMA SCOPPIATO.
TANGENTOPOLI ED IL POTERE DELLE FONDAZIONI.
TANGENTOPOLI E LE CONSULENZE TRUCCATE.
LE MANI SPORCHE DI MANI PULITE. GIUSEPPE ORSI.
LE MANI SPORCHE DI MANI PULITE. BETTINO CRAXI.
LE MANI SPORCHE DI MANI PULITE. SILVIO BERLUSCONI.
LE MANI SPORCHE DI MANI PULITE. PASQUALE CASILLO.
SE SGARRI A PARLARE, I MANETTARI TI QUERELANO.
TOGHE
ROSSE…E TOGHE BIANCHE.
TOGHE
COLLUSE.
IL PARTITO DEI GIUDICI.
IL PARTITO DELLE TASSE E DELLE MANETTE…PER GLI ALTRI.
TANGENTI E MASSONERIA.
FILIPPO FACCI: UN TESTIMONE DI MANI PULITE.
NON SOLO MANI PULITE.
MIRACOLATI.
I SALVATI DA MANI PULITE.
IN MEMORIA
DI RENATO ALTISSIMO: L’INGANNO DI TANGENTOPOLI.
UNA BALLATA PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande)
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Tra i nostri avi abbiamo condottieri, poeti, santi, navigatori,
oggi per gli altri siamo solo una massa di ladri e di truffatori.
Hanno ragione, è colpa dei contemporanei e dei loro governanti,
incapaci, incompetenti, mediocri e pure tanto arroganti.
Li si vota non perché sono o sanno, ma solo perché questi danno,
per ciò ci governa chi causa sempre e solo tanto malanno.
Noi lì a lamentarci sempre e ad imprecare,
ma poi siamo lì ogni volta gli stessi a rivotare.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Codardia e collusione sono le vere ragioni,
invece siamo lì a differenziarci tra le regioni.
A litigare sempre tra terroni, po’ lentoni e barbari padani,
ma le invasioni barbariche non sono di tempi lontani?
Vili a guardare la pagliuzza altrui e non la trave nei propri
occhi,
a lottar contro i più deboli e non contro i potenti che fanno
pastrocchi.
Italiopoli, noi abbiamo tanto da vergognarci e non abbiamo più
niente,
glissiamo, censuriamo, omertiamo e da quell’orecchio non ci si
sente.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Simulano la lotta a quella che chiamano mafia per diceria,
ma le vere mafie sono le lobbies, le caste e la massoneria.
Nei tribunali vince il più forte e non chi ha la ragione
dimostrata,
così come abbiamo l’usura e i fallimenti truccati in una
giustizia prostrata.
La polizia a picchiare, gli innocenti in anguste carceri ed i
criminali fuori in libertà,
che razza di giustizia è questa se non solo pura viltà.
Abbiamo concorsi pubblici truccati dai legulei con tanta malizia,
così come abbiamo abusi sui più deboli e molta ingiustizia.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Abbiamo l’insicurezza per le strade e la corruzione e
l’incompetenza tra le istituzioni
e gli sprechi per accontentare tutti quelli che si vendono alle
elezioni.
La costosa Pubblica Amministrazione è una palla ai piedi,
che produce solo disservizi anche se non ci credi.
Nonostante siamo alla fame e non abbiamo più niente,
c’è il fisco e l’erario che ci spreme e sull’evasione mente.
Abbiamo la cultura e l’istruzione in mano ai baroni con i loro
figli negli ospedali,
e poi ci ritroviamo ad essere vittime di malasanità, ma solo se
senza natali.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Siamo senza lavoro e senza prospettive di futuro,
e le Raccomandazioni ci rendono ogni tentativo duro.
Clientelismi, favoritismi, nepotismi, familismi osteggiano
capacità,
ma la nostra classe dirigente è lì tutta intera da buttà.
Abbiamo anche lo sport che è tutto truccato,
non solo, ma spesso si scopre pure dopato.
E’ tutto truccato fin anche l’ambiente, gli animali e le risorse
agro alimentari
ed i media e la stampa che fanno? Censurano o pubblicizzano
solo i marchettari.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Gli ordini professionali di istituzione fascista ad imperare e
l’accesso a limitare,
con la nuova Costituzione catto-comunista la loro abolizione si
sta da decenni a divagare.
Ce lo chiede l’Europa e tutti i giovani per poter lavorare,
ma le caste e le lobbies in Parlamento sono lì per sé ed i loro
figli a legiferare.
Questa è l’Italia che c’è, ma non la voglio, e con cipiglio,
eppure tutti si lamentano senza batter ciglio.
Che cazzo di Italia è questa con tanta pazienza,
non è la figlia del rinascimento, del risorgimento, della
resistenza!!!
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Questa è un’Italia figlia di spot e di soap opera da vedere in
una stanza,
un’Italia che produce veline e merita di languire senza speranza.
Un’Italia governata da vetusti e scaltri alchimisti
e raccontata sui giornali e nei tg da veri illusionisti.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma se tanti fossero cazzuti come me, mi piacerebbe tanto.
Non ad usar spranghe ed a chi governa romper la testa,
ma nelle urne con la matita a rovinargli la festa.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Rivoglio l’Italia all’avanguardia con condottieri, santi, poeti e
navigatori,
voglio un’Italia governata da liberi, veri ed emancipati sapienti
dottori.
Che si possa gridare al mondo: sono un italiano e me ne vanto!!
Ed agli altri dire: per arrivare a noi c’è da pedalare, ma
pedalare tanto!!
Antonio Giangrande (scritta l’11 agosto 2012)
INTRODUZIONE
Antonio
Giangrande, orgoglioso di essere diverso.
Se si è
omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non
si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più
fortunato a precederti.
In un mondo
caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi
sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla
rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o
perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che
cazzo di vita è?
Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Dove si
sentono alti anche i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non
conta quanti passi fai e quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del
tuo percorso.
Il difetto
degli intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il
pregio degli ignoranti è che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti
di avere già le risposte.
Un popolo
di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato da “coglioni”.
Un chierico
medievale si imbatté in un groviglio di serpi su cui spiccava un ramarro che già
da solo sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle
serpeggianti creature, la bestiola gli parve graziosa ed esclamò: «Beati
monoculi in terra caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo è re.
Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo giudizi
gratuiti, cattivi ed illogici lo facciamo con la nostra bocca ma
inconsapevolmente per volontà di altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto:
dall’educazione familiare, dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento
politico e religioso, dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro
sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo
che nessuno sarebbe capace e disposto ad ascoltarci.
E’ comodo
definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’
facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia.
In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano.
Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte
dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per
farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando
si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale.
Da sempre
diffido di chi, vestito da lupo, è pecora genuflessa alla magistratura. I
saccenti giustizialisti dei 5 stelle che provino a proporre la figura del
difensore civico giudiziario con poteri di magistrato, senza essere uno di loro,
per poter metter le mani nelle carte dei fascicoli e poterle sparigliare. Io da
anni mi batto inascoltato per questo. I signori dei 5 stelle non si degnano
nemmeno di rispondere ai messaggi degli esperti: tanto san tutto loro. A
sbraitare son bravi, ma a proporre leggi sensate, mi sa che non son capaci.
Parlan solo di soldi, soldi, soldi ed onestà, certificata dai loro magistrati, e
mai parlano di libertà ed opportunità senza concorsi ed esami pubblici truccati.
Ad ogni azione
umana nefasta si trova sempre una giustificazione...lo si fa per le piante...lo
si fa per gli animali...lo si fa per le persone! Ma, alla fine, rimane solo
un'azione nefasta che fa male al prossimo...e, spesso, il prossimo siamo noi. A
parte il partito preso, noi siamo tutti responsabili delle azioni nefaste di
uno, quando gli permettiamo di farle.
Parlare nei
miei libri del caso singolo del semplice cittadino significa incorrere
nell’accusa di mitomania, pazzia o calunnia, oltre che ne disinteresse. Invece
parlo di loro, delle istituzioni che delinquono impunite. Parlo della vera
mafia. Cosa posso dire di più di quello che ho scritto e che altri non dicono?
Credo che quanto divulgato possa essere di grande soddisfazione per le vittime,
non potendo avere altro che quella in questa Italia con italiani di merda a cui
interessa solo di loro stessi e se ne fottono degli altri.
Caro Caselli, il blocco dei soccorsi lo ha realizzato un
magistrato, scrive Piero Sansonetti il 30 agosto 2018
su "Il Dubbio". Nell’intervista molto ampia e argomentata che ci ha rilasciato,
e che abbiamo pubblicato sul giornale di ieri, Gian Carlo Caselli, ex
procuratore di Torino e di Palermo che nella sua vita è stato per lunghi anni
impegnato in primissima linea, e con buoni successi, nell’attività investigativa
su terrorismo e mafia ha sostenuto diverse idee che in buona parte non
condivido. Caro Caselli, il blocco dei soccorsi lo ha realizzato un magistrato.
Qui però mi interessa discutere su due soli punti, che mi sono sembrati i più
importanti nella sua esposizione. Il primo riguarda l’anomalia italiana in fatto
di rapporti tra politica e magistratura. Il secondo riguarda l’intervento della
magistratura in questioni che forse – a mio, ma non a suo giudizio – dovrebbero
essere di competenza esclusiva della politica. Sul primo punto Gian Carlo
Caselli ha una tesi molto chiara che riassumo trascrivendo due brevi frasi
pronunciate nell’intervista alla nostra Giulia Merlo. Prima frase: «Ed ecco lo
scatenarsi, ormai da oltre 25 anni, di una crociata anti-giudiziaria senza
eguali nelle democrazie occidentali». Seconda frase: «Nel nostro paese è antico
e diffuso il malvezzo di ostacolare i magistrati scomodi perché adempiono il
loro dovere senza riguardi per nessuno e con troppa indipendenza». Ora io faccio
questa considerazione. Chiedo: a parità di livelli di corruzione (come ci dicono
molti dati statistici raccolti dall’Eurispes e da vari altri istituti
internazionali di statistica, l’Italia è nella media europea) esistono altri
paesi, in Occidente, dove siano stati inquisiti in più occasioni il Presidente
del Consiglio, più una trentina di ministri, più i governatori di quasi tutte le
Regioni (o forse tutte: vado a memoria e non ricordo governatori inquisiti solo
in Toscana)? Per non contare i sindaci: a occhio in questo quarto di secolo ne
sono stati inquisiti più di mille. No, non esiste nessun altro paese. E
oltretutto la grandissima maggioranza di questi esponenti della politica è stata
prosciolta o assolta (basta dire che il capofila degli inquisiti, e cioè
Berlusconi, ha collezionato almeno 70 tra assoluzioni, proscioglimenti e
prescrizioni, e solo una condanna, per evasione fiscale, peraltro assai
discutibile e comminata in via definitiva da un magistrato che è oggi un
abituale commentatore del Fatto di Travaglio). Non mi risulta che tra i
magistrati che hanno condotto in questo venticinquennio l’azione contro la
politica ci siano molte teste cadute, o che qualcuno di loro abbia pagato un
prezzo (tranne, forse, lo stesso Caselli, che fu sbarrato dalla politica quando
concorreva per diventare Procuratore nazionale antimafia). Ci sono dei
magistrati che hanno perso processi su processi contro i politici (o i loro
parenti….) e continuano ad operare, peraltro godendo di molta fama e sostenuti
come eroi da diversi giornali. Mi pare difficile dire che c’è stato un assalto
della politica alla magistratura e non il contrario. Chiedo ancora: qualcuno, in
questi anni, ha toccato l’indipendenza della magistratura, fissata dalla
Costituzione? No. Qualcuno ha separato le carriere dei magistrati? No. E poi
chiedo: Qualcuno ha toccato l’immunità parlamentare o quella dei ministri? Sì, è
stata abolita l’autorizzazione a procedere, stabilita anch’essa dalla
Costituzione. Qualcuno ha varato qualche legge che rende incandidabile e
ineleggibile un esponente politico condannato da un tribunale in primo grado?
Si, l’ha varata il governo Monti a furor di Parlamento. Passo al secondo punto,
che è quello più attuale. L’opportunità dell’intervento del Procuratore di
Agrigento Patronaggio che ha indagato Salvini. Caselli difende Patronaggio,
sostenendo che ha solo fatto il suo dovere, avendo riscontrato un reato, e cioè
la limitazione della libertà dei 150 eritrei, e avendo riscontrato anche la
violazione dell’articolo 13 della Costituzione che regola il diritto alla
libertà personale. Anch’io penso che Salvini abbia violato l’articolo 13 della
Costituzione. Ma questa è una questione assolutamente politica, oppure è una
questione che riguarda la legittimità delle sue decisioni di impedire lo sbarco.
Assumere una iniziativa politica in contrasto con la Costituzione è una cosa
molto grave, in termini politici, ma di per sé non costituisce il reato. A
Caselli io vorrei porre questa semplice domanda: non crede che l’intervento
della magistratura nelle scelte politiche dei governi sia estremamente
pericoloso per la tenuta della democrazia (e anche per la tenuta e la
credibilità della magistratura)? Per questa semplice ragione: che il singolo
magistrato – il singolo: una persona sola – ha un potere spropositato. Vi
ricordo che la situazione nella quale Salvini ha operato, bloccando la Diciotti,
si è creata perché precedentemente era stato realizzato (non da Salvini) il
blocco dei soccorritori nel Mediterraneo. Questo blocco non era stato provocato
o deciso dalla politica, ma proprio da un magistrato: da un singolo magistrato.
Il procuratore di Catania, che ha aperto un’inchiesta – con forte sostegno di
stampa – contro le Ong e le navi dei soccorritori. L’inchiesta non aveva alcuna
base giuridica – e infatti si è conclusa con un flop – ma aveva una gigantesca
potenza politica. Il Procuratore di Catania con quell’inchiesta – e quella
campagna di stampa – ha scardinato e demolito l’intero sistema dei soccorsi in
mare, ed in questa situazione favorevole è poi intervenuto Salvini. La scomparsa
della navi di soccorso ha provocato un incredibile aumento dei morti nei
naufragi. Siamo sicuri che questa scelta – assolutamente politica – di ripulire
il mare dalle Ong spettasse a un magistrato, e siamo sicuri che non mettesse a
rischio la Costituzione assai più delle trovate propagandistiche e un po’
ciniche di Salvini?
Mi piacerebbe se si riuscisse a discutere più approfonditamente di queste cose.
Non si tratta solo di discutere sulla divisione dei poteri tra politica e
magistratura. Ma anche di controllo dei poteri. Di questi poteri. Un
parlamentare non possiede neanche un’oncia del potere che ha in mano un
giovanissimo sostituto procuratore (anche perché, come sappiamo tutti, il
contrappeso dei Gip è, di solito, praticamente inesistente). E’ giusto lasciare
che le cose restino così, e che i magistrati (non la magistratura) abbiano un
potere politico molto superiore a quello dei politici? In nome di che? Di
un’idea dell’Etica, francamente, molto discutibile.
La sinistra sovranista riparte da Che Guevara: «Patria o muerte».
Dalla retorica del capo storico dei guerriglieri, a Ho Chi Min, Mao, e anche
alla tradizione del Pci di Togliatti, scrive Paolo Delgado il 2 Settembre 2018
su "Il Dubbio". “Patria o muerte. Venceremos”: non il grido di battaglia di
qualche formazione ultranazionalista iberica o latino- americana. Era la formula
comunemente usata per chiudere tutte le sue lettere e i messaggi dal massimo
idolo politico del lontano ‘ 68, Ernesto “Che” Guevara. Nell’Unione sovietica,
ma anche nella Russia di Putin, la definizione per noi comune “Seconda Guerra
Mondiale” è poco conosciuta e ancor meno adoperata: quella contro il nazismo è
la “Grande Guerra Patriottica”. Casomai qualcuno, nelle nebbie della memoria
lontana, dovesse dimenticare che la chiamata alle armi in difesa della Patria
Socialista, dopo l’avvio dell’Operazione Barbarossa, l’invasione tedesca,
mobilitò con il richiamo alla Patria più che con quello al socialismo. Ha fatto
molto scandalo un articolo di Stefano Fassina, ex ministro nel governo Renzi, ex
Pd, oggi deputato di LeU, nel quale venivano rivendicate parole che nella
sinistra non avevano quasi più corso almeno dagli anni settanta: “Patria” e
Nazione”. Fassina, che è un sovranista di sinistra, merce rara in Italia ma
molto meno nel resto d’Europa, sottolinea la continuità con la tradizione
storica del Movimento operaio italiano e del Pci. Cita un noto brano di
Togliatti del 1945, da un articolo uscito su Rinascita: ‘ Assai spesso i nemici
dei lavoratori tentano di contestare il patriottismo dei comunisti e dei
socialisti, invocando il loro internazionalismo e presentandolo come una
manifestazione di cosmopolitismo, di indifferenza e di disprezzo per la patria.
Anche questa è una calunnia’. Ricorda che nel simbolo del Partito la bandiera
rossa con la falce e il martello si accompagnava al tricolore, pare per
insistenza con Renato Guttuso (che disegnò quel simbolo) dello stesso Togliatti.
Segnala che nella Costituzione italiana un solo dovere è definito addirittura
“sacro”, quello di cui si parla nell’art. 52: “La difesa della Patria è sacro
dovere del cittadino”. Per il Pci, durante la Resistenza e dopo, tra
patriottismo e lotta per l’emancipazione dei lavoratori non solo non c’era
contraddizione ma si trattava al contrario quasi di sinonimi. Fino agli anni ‘
80 e all’uscita del libro di Claudio Pavone sulla Resistenza Una guerra
civile, la storiografia comunista aveva sempre rifiutato, e anche con sdegno,
l’interpretazione della Resistenza come “guerra civile”. Era la “Guerra di
Liberazione Nazionale” e dubitarne significava esporsi al sospetto d’eresia. Del
resto il giornale dell’Anpi si chiamava, e ancora si chiama Patria
Indipendente. Nel clima della guerra fredda, nel 1957, il Pci votò contro la
ratifica dell’oggi sempre osannato Trattato di Roma, quello che istituiva la
Cee, la Comunità economica europea, detta abitualmente all’epoca Mec, Mercato
comune europeo. “Il Mec – spiegava allora la scelta del partito il relatore
Giuseppe Berti – è la forma sovranazionale che assume nell’Europa occidentale il
capitale monopolistico”. Solo negli anni tra il 1979 e il 1984, con l’adesione
di Altiero Spinelli al Pci e con una serie di spostamenti direttamente ispirati
dal segretario Berlinguer il Pci avrebbe capovolto la sua posizione
trasformando- si in partito compiutamente europeista. Non si tratta solo
dell’ennesima specificità del caso italiano. Tanto più negli anni della
decolonizzazione, socialismo e patriottismo formavano davvero una coppia
inscindibile. Ho Chi Minh spiegava così la straordinaria capacità del popolo
vietnamita di resistere prima alla Francia e poi agli stessi Stati Uniti: “La
nostra gente è ispirata da un ardente patriottismo che è una nostra
irrinunciabile tradizione e la nostra più grande forza”. Il presidente Mao
concordava: “Un comunista, per essere internazionalista, deve per forza essere
un patriota”. L’elenco di dichiarazioni sulla medesima lunghezza d’onda, da Bela
Kun a Thomas Sankara, sarebbe in realtà infinito. A lungo l’internazionalismo è
stato interpretato a sinistra come rifiuto del tantativo delle singole nazioni
di sottometterne altre, non delle differenze e delle specificità nazionali. Il
citato articolo di Togliatti, del resto, mirava proprio a negare l’accusa di
“cosmopolitismo” rivolta ai comunisti. Fassina prova dunque a recuperare una
tradizione della sinistra storica a lungo considerata archiviata una volta per
tutte ma che inevitabilmente torna in campo in una fase storica segnata proprio
dalla reazione, non solo in Europa ma in Europa più che altrove, a un
superamento degli Stati nazionali che non ha mantenuto nessuna delle sue
promesse. Non è certo un caso se due delle principali formazioni di sinistra in
Europa, Podemos in Spagna e France Insoumise in Francia, ricorrono senza esitare
a suggestioni patriottiche, sia pur declinate in senso molto diverso e spesso
opposto a quello del sovranismo di destra di cui è principale esponente in
Europa il premier ungherese Viktor Orban. Naturalmente c’è una distanza
incommensurabile tra l’idea compiutamente reazionaria di patria che sbandiera
l’ungherese e quella dello spagnolo Iglesias, che qualche anno fa spiegava: “La
patria non è una spilletta sulla giacca, non è un braccialetto, la patria è
quella comunità che assicura che si proteggano tutti i cittadini, che rispetta
le diversità nazionali, che assicura che tutti i bambini, qualunque sia il
colore della loro pelle, vadano puliti e ben vestiti a una scuola pubblica, la
patria è quella comunità che assicura che i malati vengano assistiti nei
migliori ospedali con le migliori medicine, la patria è quella comunità che ci
permette di sognare un paese migliore”. Tuttavia un punto in comune c’è, e
vistoso: quel nodo della sovranità nazionale che sembra essere la causa della
crisi dell’Unione europea e invece di quella crisi è il prodotto.
Quel saggio su Proudhon con cui Bettino Craxi segnò la storia
della sinistra in Italia. Nell’agosto del 1978 il
segretario del Psi pubblicava sull'Espresso il "vangelo" del suo socialismo. Uno
spartiacque per la sinistra di ieri. Un modello per gli aspiranti leader di
oggi? Scrive Marco Damilano il 30 agosto 2018 su "L'Espresso". Il Vangelo
socialista, lo titolò il direttore dell’Espresso Livio Zanetti, con malizia,
perché dopo tanto girovagare il popolo socialista aveva finalmente trovato il
suo messia: una buona novella, soprattutto per lui, l’autore del testo, il
segretario del Psi Bettino Craxi. «Un baedeker ideologico e un argomento di
discussione», si leggeva nel sommario, «il segnale d’avvio di un’offensiva
destinata a tenere alta la temperatura tra il Pci e il Psi per molte settimane»,
precisava nell’introduzione Paolo Mieli, giornalista del settimanale di via Po,
come ci chiamavano all’epoca sugli altri giornali, ma alla fine il saggio
firmato da Craxi si rivelò molto di più. «Un colpo di fucile, o piuttosto di
cannone», lo ha definito Ernesto Galli della Loggia, la rottura con il comunismo
di matrice leninista ma anche gramsciana. Il taglio della barba del profeta Karl
Marx, scrisse a botta calda Eugenio Scalfari su “Repubblica”: «L’articolo
sull’Espresso segna una data storica nella vita del Partito socialista
italiano». Uscì il 27 agosto 1978, quarant’anni fa, alla fine di un mese in cui
era morto un papa (Paolo VI), era stato appena eletto un altro (il patriarca di
Venezia Albino Luciani con il nome Giovanni Paolo I, morirà 33 giorni dopo),
Mina aveva tenuto il suo ultimo concerto pubblico al Bussoladomani di Viareggio
e la politica si apprestava a riprendere il suo cammino dopo i giorni del
sequestro e dell’omicidio di Aldo Moro, le dimissioni del presidente della
Repubblica Giovanni Leone, i referendum per abrogare la legge Reale sull’ordine
e la sicurezza e soprattutto il finanziamento pubblico dei partiti, che aveva
raccolto il 46 per cento dei sì nonostante la contrarietà di tutte le forze
politiche tranne i radicali, ben più di un campanello d’allarme per il sistema
politico. Vacillava il governo di solidarietà nazionale, il monocolore dc di
Giulio Andreotti con il Pci in maggioranza, il Psi si era smarcato con due mosse
clamorose, la rottura del fronte della fermezza con le Brigate rosse nel caso
Moro e l’elezione di Sandro Pertini alla presidenza della Repubblica, il primo
socialista al Quirinale. Ma il giovane segretario del Psi Craxi, 44 anni in quel
momento, aspettava di fare un passo in più. La definizione di una nuova carta di
identità: dire chi si è, prima ancora di cosa si vuole fare. Un manifesto
ideologico, come nell’Ottocento. Curioso che a intestarsi la battaglia delle
idee fosse un leader pragmatico, per nulla attratto dalle fumisterie teoriche,
considerato spregiudicato e privo di scrupoli: Bettino l’Amerikano, il tedesco
del Psi, come lo appellavano gli avversari. Se ne sorprese il vecchio Pietro
Nenni che il 5 settembre annotava sul suo diario: «Continua la polemica aperta
da Bettino sul marxismo e sul leninismo. Il partito cerca in essa una
qualificazione che però potrà venire solo dai fatti». Più stupiti di tutti i
comunisti, l’oggetto polemico del saggio craxiano. «Non si esita a dare versioni
incredibilmente semplificate e unilaterali dell’esperienza storica del movimento
operaio, a presentare un’immagine quanto mai riduttiva e sommaria di una
personalità come quella di Lenin (e ancor di più di quella di Gramsci), e a
tacere dell’elaborazione originale dei comunisti italiani», si lamentò Giorgio
Napolitano sull’Unità. In linea con il giudizio dello storico Paolo Spriano:
«Toni e espedienti idonei all’addestramento dei commandos delle teste di cuoio
ma non al dibattito culturale». Ancora più brutale il vicecapogruppo del Pci
alla Camera Fernando Di Giulio: «Perché Craxi ha scelto Proudhon, questo strano
modesto pensatore francese? Secondo alcuni, perché ricorda una marca di
champagne». Eppure era stato Enrico Berlinguer ad aprire lo scontro ideologico.
Con una lunga intervista a Scalfari su Repubblica, il 2 agosto, in cui il
segretario del Pci aveva rivendicato «la complessa eredità» del leninismo,
affermando che «il Pci è nato sull’onda della rivoluzione proletaria dei soviet,
e su impulso di Lenin»: «siamo continuatori, ma anche critici e interpreti» di
quel «patrimonio ricchissimo e complesso». E aveva concluso: «La verità è che ci
si vorrebbe sentir dire: ci siamo sbagliati a nascere, evviva la
socialdemocrazia, unica forma di progresso politico e sociale. Allora i nostri
esaminatori si direbbero soddisfatti: “la risposta è esatta, sciogliete il
partito e tornatevene a casa”». Tra gli esaminatori, Berlinguer indicava il Psi
di Craxi: «C’è una neo-vocazione a farci l’esame da parte dell’attuale gruppo
dirigente socialista. È un fatto nuovo e preoccupante». Il direttore
dell’Espresso Zanetti chiese una reazione a Craxi, il segretario socialista fece
sapere che voleva pensarci, poi si ricordò di aver commissionato al giovane
sociologo Luciano Pellicani un saggio su leninismo e socialismo per un volume
dell’Internazionale socialista in onore di Willy Brandt. Quindici cartelle, le
rimaneggiò personalmente prima di partire per le vacanze ad Hammamet e le spedì
all’Espresso. «Avevo citato molti autori, ma Proudhon fece più effetto», ammise
in seguito Pellicani. Pierre-Joseph Proudhon, vissuto tra il 1809 e il 1865,
promotore di un socialismo anti-scientifico, liberale, anarchico, mutualista,
contrario alla violenza. Chi avrebbe mai detto che sarebbe diventato lui il
primo profeta del socialismo craxiano? Andò così, anche se nel saggio erano
nominati tanti altri autori. Rosa Luxemburg, l’ex comunista jugoslavo Milovan
Gilas, il francese Gilles Martinet, Bertrand Russell, Carlo Rosselli, Norberto
Bobbio con il riferimento che chiudeva lo scritto: «Il socialismo è la
democrazia pienamente sviluppata, dunque è il superamento storico del pluralismo
liberale e non già il suo annientamento. È la via per accrescere e non per
ridurre i livelli di libertà e di benessere e di uguaglianza». La sintesi delle
idee di Pellicani, poi direttore di Mondoperaio, un pensatore in polemica con
tutte le dottrine politiche dei “fini ultimi”, depositarie della salvezza e del
paradiso in terra destinato a trasformarsi in un inferno per gli uomini, come lo
descrive Giovanni Scirocco nel volume “Il vangelo socialista” (Aragno). Il
saggio firmato da Craxi fu uno spartiacque per i rapporti a sinistra. «Nella sua
polemica anti-marxista il segretario socialista arriva a Robespierre e ai
giacobini della Rivoluzione francese, avesse avuto più spazio, c’è da giurare
che nella sua condanna avrebbe coinvolto anche Rousseau. Ideologia e cultura a
parte, la posizione di Craxi significa che l’unità a sinistra è rotta per
sempre», profetizzò Scalfari, a ragione. Scontro ideologico e politique
politicienne si tenevano insieme, all’interno delle pagine craxiane L’Espresso
pubblicava un box sulla rottura tra comunisti e socialisti negli enti locali, a
San Benedetto del Tronto, a Comiso, a Quartu Sant’Elena, dove il Psi mollava i
comunisti per tornare alle giunte di centro-sinistra con i democristiani. Da
Proudhon a Quartu, si anticipava il ritorno del Pci all’opposizione e il
pentapartito degli anni ’80. E anche fenomeni di più lungo periodo: «Il Vangelo
socialista dimostra quanto Craxi sia convinto della possibilità di spingere
anche in Italia in direzione di un’americanizzazione del partito politico»,
commentò Paolo Franchi sul settimanale del Pci Rinascita. E Enzo Forcella su
Repubblica: «Bastano poche paginette, qualche contrapposizione azzeccata tipo
Proudhon e Marx, la scelta del momento e del canale giusti per segnare una data
storica nella vita del Psi. Per quel che riguarda il modo di fare politica,
stiamo soltanto ora entrando veramente nella dimensione delle comunicazioni di
massa». Riletto oggi il saggio di Craxi appare irrimediabilmente datato per il
linguaggio e per i contenuti, ma per nulla semplificatorio e superficiale,
soprattutto se paragonato a quanto visto e letto nelle stagioni successive e in
quella attuale, di svolte epocali annunciate via twitter. Nell’immaginario Craxi
è ancora il Capo delle scenografie congressuali a forma di piramide, dei templi
dorici e delle discoteche, del rampantismo vorace e insaziabile, di
Tangentopoli. Ma in quel saggio lontano dell’ex presidente del Consiglio
condannato e morto nel 2000 in Tunisia, sepolto in un piccolo cimitero accanto
alla tomba di un francese ricoperta dalla sabbia e dalla salsedine, si
ritrova un leader inserito in una formazione secolare, impegnato in una cosa
antica e buona della politica: la tenzone delle idee, la svolta affidata a uno
scritto che riconosce la storia precedente anche quando intende superarla. Un
politico di sinistra, attrezzato ad affrontare lo scontro sul terreno
ideologico, convinto che non esista una politica con l’ambizione di vincere
senza un sistema di idee alle spalle. Un capo-partito che almeno all’inizio
della sua avventura si era circondato di intellettuali, non di yesmen,
ghostwriter, inventori di hashtag come oggi: la redazione raccolta attorno a
Mondoperaio, intelligenze inquiete, competenze raffinate (Federico Coen, Luciano
Cafagna, Paolo Flores d’Arcais, Ernesto Galli della Loggia, Giampiero Mughini,
Luciano Pellicani), alcune pronte ad andarsene al primo segnale di
degenerazione, in quella fase nascente del craxismo che è stata il momento più
fecondo. Non era del resto una disputa teologica quella che voleva affrontare il
quarantenne segretario del Psi, ma una dura battaglia di egemonia, di potere. Ma
sapeva che un’idea, in politica, è l’arma più dirompente. Dopo ha pensato che
per vincere servisse altro: soldi, poltrone, rendite di posizione non solo
politiche. E ha cominciato a perdere, rovinosamente. Nel merito, su chi avesse
ragione e torto tra Berlinguer e Craxi su leninismo e socialismo, fu lo stesso
segretario del Pci tre anni dopo ad abiurare di fronte alle telecamere
ammettendo all’indomani del colpo di Stato in Polonia che la spinta propulsiva
della Rivoluzione d’ottobre si era esaurita. Il Pci si è sciolto, senza
diventare compiutamente socialdemocratico, come Berlinguer temeva nel 1978, e
solo l’esperienza originale del comunismo italiano è riuscita a far trapassare
il partito, l’organizzazione, i dirigenti oltre la fine del blocco sovietico. Ma
il Psi di Craxi non è riuscito a costruire su quell’identità di socialismo
liberale un’alternativa di sinistra (parola che nel saggio ricorre appena tre
volte), fino ad arrivare alla dissipazione e alla scomparsa, qualcosa che pesa
ancora sul nostro presente. Un vuoto che nessuno è riuscito a colmare, tantomeno
gli epigoni craxiani slittati a destra, nel berlusconismo, come satelliti fuori
orbita. La storia di una doppia sconfitta, catastrofica. Rousseau è ora il nome
della piattaforma del Movimento 5 Stelle, ma del progetto politico non ha
l’auto-coscienza, la consapevolezza di sé. Manifesti politici gli aspiranti
leader ne producono spesso, un foglio di giornale o un libro da presentare in
giro, ma sono nel migliori dei casi un’elencazione di cose da fare, un catalogo
di wiki-programmi senza anima, i cento punti, i mille punti e via numerando.
L’ultimo tentativo di stilare una carta di identità è stato il manifesto dei
valori del Partito democratico di Walter Veltroni nel 2008, ma si è visto com’è
andata. E si potrebbe concludere che questa è la modernità politica, vincere (e
perdere) senza dire chi sei: pragmatismo puro, appiattimento sull’esistente. O
arrivare alla conclusione opposta: che senza una visione della società, senza
una lettura della realtà non si può costruire nulla di solido, come dimostrano
le esperienze a sinistra degli ultimi 25 anni. Oggi il socialismo muore in
Europa e risorge negli Stati Uniti, dove socialisti si definiscono i candidati
più giovani del nuovo Partito democratico che prova a ricostruirsi nell’era
Trump. Chissà se ci penserà qualcuno, nei prossimi mesi di congressi, di
leadership da inventare, di una presenza culturale da ritrovare. E se qualcuno
sbotterà: aveva ragione Craxi, maledizione, ci serve un Proudhon!
Craxi dagli osanna alla polvere. Memorie del socialismo,
scrive Gaetano Cellura su Licata net il 5 agosto 2018. De Martino gli lasciò un
partito al minimo storico. E su quel risultato influì anche la campagna
elettorale del 1976. Condotta sulla falsariga che votare per il Psi o per il Pci
fosse la stessa cosa. Pure Berlinguer diceva questo, ma perché gli conveniva: il
successo del suo partito – un 34 per cento mai toccato prima – appariva fuori
discussione. Così come l’assorbimento del Partito socialista e del suo
elettorato. Ma nessuno aveva ancora fatto i conti con lui. Né a sinistra. Né
dentro lo stesso partito. Dove la sua elezione a segretario, in un momento di
forte scontro tra demartiniani e nenniani, venne considerata debole e di
transizione. A chi si mostrava preoccupato per il calo elettorale del partito,
Craxi rispose: “Tranquilli, con l’otto per cento si governa l’Italia”. E già da
queste parole si capiva che non sarebbe stato affatto un segretario di
transizione. La politica la conosceva e capiva sin da bambino. Da quando suo
padre, viceprefetto di Milano e poi prefetto di Como, accompagnava gli ebrei al
confine per metterli in salvo dai nazifascisti. Alle elezioni del 1948 faceva
già propaganda per il padre, candidato con il Fronte democratico. Entrato in
parlamento nel 1968, dopo l’esperienza di consigliere comunale a Milano, Bettino
Craxi la sua Bad Godesberg l’aveva elaborata nella propria testa ancora prima
della svolta del 1959 dei socialdemocratici tedeschi. E divenuto segretario del
Psi uno dei suoi primi atti di revisionismo ideologico fu l’articolo pubblicato
sull’Espresso e intitolato Il Vangelo socialista. Proudhon al posto di Marx.
Rifiuto totale del leninismo. Eliminazione della falce e martello dal simbolo
del Partito. “Il socialismo – scrisse – non coincide con lo stalinismo: è il
superamento storico del pluralismo liberale, non già il suo annientamento”. Con
lui nasceva finalmente il partito riformista che era sempre mancato all’Italia.
E non è un caso – nulla in fondo è davvero casuale nella storia – che sette anni
dopo la sua elezione a segretario e l’avvio di una nuova politica, Craxi sarà il
primo presidente del consiglio socialista. Ora ne sono passati trentacinque da
quel 4 agosto del 1983. Presidente della repubblica era un altro socialista,
Sandro Pertini. E il Psi di Craxi era cresciuto di voti e di seggi – e ancora
sarebbe aumentato nel 1987 – rispetto al partito in deperimento ereditato da De
Martino. Non staremo qui a ripercorrere le tappe di quel governo pentapartito.
Molto note e quasi tutte significative. Nella politica estera e nella politica
interna. E neppure gli scontri durissimi con il Pci. Che riservò a quel governo
un’opposizione mai vista verso i governi democristiani. Vogliamo solo
ricordare come in un decennio sia radicalmente mutato l’umore degli italiani. E
d’altra parte – piazzale Loreto docet – non era neppure la prima volta che un
leader osannato finiva poi nella polvere. Non era la prima volta che il popolo
si faceva tribunale e plotone d’esecuzione. Certo, di mezzo c’erano stati un
fatto epocale, come la caduta del muro di Berlino, e la più grande inchiesta
giudiziaria contro la classe politica a partire dal 1992. Ma la constatazione
(non solo storica) che siamo un popolo di voltagabbana, bravo a rinnegare un
sistema in cui si riconosceva ci sta tutta. Un popolo facile a passare dagli
osanna al lancio delle monetine e al grido: “Chi non salta socialista è!”
“Lanciatori di rubli” – li chiamava Craxi mentre usciva dall’hotel Raphaël.
Certo d’esser vittima di un complotto comunista. Molti di quelli che lanciavano
monete venivano da un comizio del Pds. E c’erano pure dei “moralizzatori” di
altri partiti o schieramenti che avrebbero fatto politica nella seconda
repubblica e sarebbero stati arrestati per corruzione. Il giorno prima
nessuno aveva osato contestare il suo discorso in parlamento sul processo
“storico e politico ai partiti che per lungo tempo hanno governato il paese”. E
quattro delle sei richieste di autorizzazione a procedere furono respinte.
Ciononostante Craxi venne lasciato solo. Parte di quel parlamento sperava in
fondo di poterla far franca e che lui avrebbe pagato per tutti. E quanto agli
italiani plaudenti di un tempo, forse erano sicuri che bastava il “lavacro del
Raphaël” a ripulire anche loro. Gaetano Cellura
Craxi, il leader dimenticato che voleva un'Italia globale.
Un saggio a più mani per ripensare un politico, travolto da
Tangentopoli, che aveva una visione lungimirante, scrive Roberto Chiarini,
Lunedì 07/05/2018, su "Il Giornale". La figura di Craxi è rimasta sinora
ostaggio della polemica politica che ha individuato in lui l'icona prediletta
per etichettare e combattere tutti i mali della politica italiana odierna. Il
segretario del Psi è stato additato, di volta in volta, come l'emblema della
dilagante corruzione partitocratica della Prima Repubblica, del diffondersi
negli anni della «Milano da bere» dell'individualismo, dell'edonismo e del
consumismo, del degrado morale della classe politica e dei partiti, della
commistione perversa di politica, impresa e finanza, per non dire della
personalizzazione della politica e della sua deriva leaderistica e autoritaria
in atto. Talora si è andati ancor più per le spicce. Al leader socialista si
sono ricondotti un po' tutti insieme questi vizi che a partire dagli anni
Ottanta avrebbero fatto tralignare la Repubblica italiana in una democrazia a
rischio, o meglio: di una democrazia a perdere. Raramente il politico Craxi è
diventato materia su cui si sia seriamente esercitata la riflessione
storiografica con quello spirito di comprensione del passato che, se non si deve
tradurre in una sua piatta giustificazione, non può nemmeno risolversi in una
sua mera esecrazione. Non è stata giudicata indispensabile una valutazione di
merito del suo operare politico, delle motivazioni riconducibili al suo
orizzonte ideale, delle scelte da lui operate, dell'impatto da queste esercitato
nel breve e nel lungo periodo sul sistema politico e, più in generale, sul
sistema Paese. Ne è conseguito il paradosso che Craxi, il fautore di un nuovo
riformismo, il temerario fautore di una Bad Godesberg italiana sino allora
rifiutata dalla sinistra nostrana, caparbiamente refrattaria alle implacabili
repliche della storia, è stato relegato nel girone dei rinnegati. Al contrario
Berlinguer, il comunista convinto, l'intemerato apostolo di una velleitaria
quanto indeterminata «fuoriuscita dal capitalismo», è stato innalzato alla
gloria dell'altare con l'aureola di santo protettore della sinistra, della
sinistra di sempre, anche di quella seguita al crollo dell'Urss, destinata a
prescindere totalmente dagli schemi classici della tradizione comunista, a
divenire cioè riformista: fuor dai denti, di una sinistra chiamata a
riconciliarsi col capitalismo. Ne discende il paradosso di una sinistra che,
sintonizzatasi da ultimo - in ritardo di oltre mezzo secolo dal resto
dell'Europa e solo dopo il collasso del socialismo reale - sulla lunghezza
d'onda del riformismo, ha continuato a richiamarsi al magistero di un
indefettibile profeta del comunismo e a rifuggire viceversa da un convinto
fautore del socialismo democratico. C'è un secondo nodo storiografico e politico
da sciogliere a proposito di Craxi. Quanti pensano di aver saldato, una volta
per tutte, i conti con il leader socialista inserendolo come personaggio
centrale nel grande romanzo criminale di Tangentopoli devono decidersi se lo
vogliono inserire nella galleria dei leader storici della sinistra o viceversa
in quella opposta, in quanto alfiere della destra in gestazione, tenuta poi a
battesimo da Berlusconi. Non è una differenza di poco conto. È di tutta evidenza
che a seconda della parte politica cui lo si attribuisce, cambia di segno la sua
esperienza politica. Cambia il senso complessivo della sua attività di leader di
partito e di capo del governo come pure quello dei suoi singoli atti. Sciogliere
quesiti del genere significa non solo mettere a fuoco i tratti caratterizzanti
di un leader di partito e capo di governo la cui azione ha contrassegnato
un'intera stagione della vita pubblica nazionale. Comporta conferire altresì un
diverso senso, orientamento e continuità alla storia repubblicana. Cambia di
netto la prospettiva se si considera il craxismo l'apoteosi e insieme l'epilogo
di una Repubblica dei partiti, depredatrice, collusa con poteri occulti e con
settori malavitosi della società, fonte e fomite di corruzione, disposta persino
a conculcare principi e istituti cardine della Costituzione pur di perpetuarsi
come regime o viceversa l'avvio, stentato, contraddittorio, velleitario fin che
si vuole ma pur sempre di una modernizzazione dell'impianto istituzionale e
delle politiche - sia economica che di welfare - utili a riattrezzare e
rivitalizzare una democrazia in crescente affanno di fronte alle impegnative
sfide provenienti dalla società post-fordista e dalla globalizzazione. Quesiti
cruciali e laceranti ieri come oggi, eppur irrisolti: il che dimostra come sia
per questo carica di attualità, e per questo motivo ineludibile, una riflessione
critica sull'azione di governo di Craxi in un'Italia che accusa ancor oggi un
ritardo incontenibile, per usare un'espressione di Mauro Calise, «nel passaggio
dal corporate millenium al secolo monocratico».
Quando Montanelli mi disse: “Caro Foa…” E gliene sono ancora
grato, scrive Marcello Foa il 21 luglio 2018 su “Il
Giornale". Il 22 luglio 2001 Montanelli ci lasciava e mi perdonerete se questa
volta mi permetto un post personale e non di analisi politica. Indro fu l’idolo
della mia adolescenza. C’era chi sognava il Che Guevara e chi solo calciatori,
io divoravo i suoi libri, leggevo i suoi articoli su il Giornale, che egli fondò
quando ero bambino e se sono diventato giornalista lo devo, verosimilmente, a
lui, perché fu Montanelli a far nascere in me la passione per quella che resta
la più bella professione del mondo. Iniziai a Lugano, da studente lavoratore,
alla Gazzetta Ticinese e poi al Giornale del Popolo. Non avevo tempo di andare
all’università: studiavo a casa al mattino e al pomeriggio andavo in redazione,
fino a tarda sera. Poi, quando avevo 26 anni, accadde il miracolo: fui assunto
proprio al Giornale dal mio idolo e da subito con la carica di vice responsabile
degli Esteri. Il primo giorno di lavoro bussai alla sua porta, per ringraziarlo,
ancora una volta, per quella straordinaria opportunità. Indro usciva da una
delle sue ricorrenti depressioni, era cordiale ma malinconico, mi guardò con i
suoi occhi azzurri ancora velati dal male oscuro, fu cortese e alla fine mi
disse: “Mi raccomando, non deludere”. Quegli occhi che con il passare delle
settimane tornarono ad essere scintillanti. Da subito, poco più che pivello,
partecipavo alle riunioni di redazione e fu lui a Presto fui messo alla prova
sul campo. Mi mandò a Mosca poco prima del crollo dell’Unione sovietica e a
Berlino a seguire la riunificazione economica delle due Germanie. Quando
rientravo mi riceveva nella sua stanza, pregandomi di raccontare gli aneddoti,
gli imprevisti, le emozioni che avevo provato in quei viaggi. Lo faceva con
tutti noi, soprattutto con i più giovani, che erano i più entusiasti e per i
quali dimostrava un’affettuosa simpatia, come se volesse rivivere, tramite i
nostri palpitanti racconti, quei momenti, lui che divenne direttore suo malgrado
e che nell’animo continuò a sentirsi innanzitutto un inviato speciale, forse il
più grande di tutti i tempi. Poi, nel dicembre 1992, una sera pensai di
scrivergli una lettera. Erano i tempi di Mani Pulite e l’Italia era attraversata
da tensioni e trasformismi che mi turbavano e finita la lunga, nel cuore della
notte, la vergai. Il giorno dopo gliela portai nel suo ufficio, che varcavo
sempre in punta di piedi, in giovanile e ineludibile rispetto per il mio
mito. Indro la prese e, senza leggerla, la ripose sulla scrivania,
congedandomi. Non mi aspettavo nulla e nulla mi fece sapere. Dopo due giorni la
pubblicò nella rubrica più letta, quella in cui dialogava con i lettori,
titolandola “Sul carro degli onesti” e aggiungendo una sola riga di commento:
"Questa lettera, caro Foa, potrei averla scritta io". Il giorno dopo scesi in
tipografia e recuperai l’originale con la frase scritta a penna di suo pugno.
Sono passati quasi 25 anni da quel giorno e questo resta il riconoscimento più
bello e fino ad oggi più intimo, non avendone mai parlato pubblicamente.
Talvolta mi sorprendo a pensare cosa scriverebbe Montanelli di questa Italia se
fosse ancora tra noi. Domanda sciocca: la storia non si fa con le ipotesi e
Indro apparteneva al suo tempo. Però di una cosa sono certo: mai avrebbe
approvato la violenza verbale di certa stampa e avrebbe denunciato con forza il
conformismo intimidatorio, che ben conosceva avendolo subito per lunghi anni
della sua carriera. Era un anarchico conservatore, ma soprattutto un uomo libero
che riteneva doveroso per un giornalista pensare con la propria testa,
soprattutto quando è scomodo e rischioso uscire dal coro, perché solo così si
onora davvero la professione. Questo insegnava a noi, suoi giovani allievi, e
non l’ho mai dimenticato.
(Marcello Foa, “Sul carro degli onesti”, lettera pubblicata sul “Giornale” del
21 dicembre 1992 dall’allora direttore Indro Montanelli, che in calce alla
missiva aggiuse: «Questa lettera, caro Foa, potrei avrela scritta io». Lo
rammenta lo stesso Foa, in un affettuoso ricordo che dedica a Montanelli sul
blog “Il cuore del mondo”, pubblicato sul “Giornale” il 21 luglio 2018.
Impegnato a denunciare le ipocrisie dei mediamainstream con saggi di successo
come “Gli stregoni della notizia”, oggi Foa condanna l’ostracismo moralistico
del vecchio establishment, ostile a Salvini e al sovranismo democratico
“gialloverde”).
Caro direttore, ci risiamo. L’Italia opportunista, l’Italia che, come sempre è
accaduto nella sua storia, è maestra nell’abbandonare i perdenti salendo sul
carro dei vincenti, sta prevalendo ancora una volta, appropriandosi i risultati
di quella che fino ad oggi era stata la battaglia della parte pulita del paese.
Sembra un paradosso, eppure purtroppo non lo è. Ricorda com’era la situazione a
febbraio, quando scoppiò lo scandalo della Baggina? Il regime era solido e
potente, poteva ancora sperare di limitare i danni, di far apparire quella
vicenda un episodio isolato attribuibile ai “mariuoli”, o addirittura di
insabbiare tutto con la complicità di giudici compiacenti. Di Pietro non si
lasciò intimidire e, se ha potuto proseguire arrivando dove tutti sappiamo, il
merito in parte è anche nostro, di quella fetta dell’opinione pubblica che sin
dall’inizio si è schierata con entusiasmo dalla parte del “giustiziere di
Tangentopoli”. A febbraio eravamo in pochi a gioire e a combattere. Era
l’Italia pulita, onesta, che non ama gli schiamazzi di piazza. Tra questi pochi
c’erano in blocco i nostri lettori. Per qualche giorno, Di Pietro ci ha fatto
rivivere le emozioni degli anni ‘70: si tifava per lui come si tifava per
Montanelli contro la tracotanza dei comunisti e le pallottole delle Brigate
Rosse. Ma oggi a quale spettacolo assistiamo? Sul carro della denuncia di
Tangentopoli sono saliti tutti gli onesti e le persone per bene, certo, ma anche
i corrotti, i furbastri, gli opportunisti. Insomma, il peggio del paese. Ed è
proprio la loro voce a tuonare sempre più forte, surclassando quella
dell’Italia dal volto pulito. Sono questi maestri della propaganda e del
conformismo ad aver ispirato alcune delle recenti spettacolari iniziative e a
coniare gli slogan più incisivi a sostegno dei giudici di Milano, così brillanti
da far apparire naif è un po’ patetiche le scritte sui muri “Forza Di Pietro”
che ci entusiasmavano la primavera scorsa. C’è da preoccuparsi. Quelle centinaia
di persone che oggi gareggiano a chi urla nelle piazze gli insulti più virulenti
contro i potenti caduti in disgrazia sono le stesse che fino a pochi mesi fa
bazzicavano nelle anticamere del potere, nella speranza di partecipare alla
spartizione del malloppo. Portaborse, intellettuali alla moda, giornalisti
di regime, arrampicatori e affaristi. Il loro scopo è evidente: appropriarsi la
bandiera dell’Italia onesta e introdursi nelle forze politiche emergenti (Lega,
Rete, Msi, movimenti referendari) per continuare a fare quel che hanno sempre
fatto ho sognato di fare: la dolce vita e le carriere facili a spese del paese.
Ormai manca solo che anche mafiosi e camorristi esprimano solidarietà e appoggio
a Di Pietro. Per questo, caro direttore, “Il Giornale” vada ancora una volta
controcorrente, iniziando una di quelle battaglie per le quali i nostri lettori
dal 1974 ci appoggiano con passione ed entusiasmo. Come nel 1988, quando
svelammo lo scandalo dell’“Irpiniagate”. Come agli inizi degli anni 80, quando
fummo i primi a denunciare la corruzione della partitocrazia e a invocare la
riforma del sistema elettorale. Continuiamo a schierarci con Di Pietro, ma fuori
del gregge dell’ormai gratuito “dipietrismo”. Lasciamo ad altri le chiassate di
piazza e diamoci da fare per smascherare gli eterni furbi d’Italia.
Parnasi favoriva i politici. Parola di pm.
Il Gip: "Finanziava i partiti per realizzare gli interessi del gruppo". Gravi
accuse ma il suo entourage lo difende. Storia di un imprenditore rampante,
scrive Valeria Di Corrado il 14 Giugno 2018 su "Il Tempo". Cambiare per restare
uguali a se stessi. La seconda Repubblica ha lasciato il posto alla terza, la
politica è diventata 2.0, al Governo sono saliti due leader populisti. Per i
magistrati ci sono cose, però, che in Italia non mutano mai: come la corruzione
che permea chi sta al potere. Anzi, con la crisi economica, ci si accontenta di
poco per vendere la propria funzione pubblica. «Un modello di corruzione
sistemica – spiegano i pm romani Paolo Ielo e Barbara Zuin – insensibile ai
mutamenti politici e istituzionali», che si concretizza in tangenti
«pulviscolari». Per la procura lo spiega con parole ancor più eloquenti
l’imprenditore Luca Parnasi, che, dopo lo stadio della Roma, aveva in progetto
di costruire quello del Milan. «Io spenderò qualche soldo sulle elezioni...che
poi con Gianluca vedremo come vanno girati ufficialmente coi partiti politici.
Anche questo è importante perché in questo momento noi ci giochiamo una fetta di
credibilità per il futuro. Ed è un investimento che io devo fare, molto moderato
rispetto a quanto facevo in passato, quando ho speso cifre che manco te le
racconto...Però la sostanza è che la mia forza è che alzo il telefono e...». Non
serve molta fantasia - lasciano intendere gli inquirenti - per capire come si
conclude la frase di Parnasi, omissata nell’ordinanza...
Follie di casa nostra, scrive Mauro del
Bue il 30-06-2018 su "Avanti On Line". Salvini, per rispondere a chi accusa la
Lega dei 48 milioni spariti e non giustificati, dichiara che i soldi sono stati
spesi. Resta il fatto di sapere come. Ma é troppo per un movimento che non è più
lo stesso. La Lega non è più la Lega nord. Dunque che c’entrano loro anche se
sono quelli di prima? Parnasi, il costruttore dello stadio della Roma che per
ora é come l’araba fenice, sostiene, con minuzia di particolari, di aver pagato
tutti i principali partiti per farseli buoni. Non certo il Psi e neppure i
radicali. Tutti, compreso il movimento Cinque stelle hanno intascato denaro
dell’imprenditore che doveva tenersi buoni i politici, attraverso le rispettive
fondazioni e anche direttamente. Neanche pochi. Per la Lega sarebbero 250mila
euro, 130 per il Pd, non si conosce la cifra esatta per i grilliini concordata
col grande brasseur d’affaires che era questo Lanzalone, ancora in carcere. Il
Tevere emana uno strano odore. Non sarà la prima volta, ma stavolta inaspettato
e improvviso. Il primo ministro Conte partecipa da avvocato al vertice di
Bruxelles e viene preso in giro da Macron che gli vorrebbe insegnare come si
legge un ordine del giorno, poi dal premier svedese Stefan Loften, che gli
ricorda d’aver fatto il saldatore, mentre quello bulgaro ha subito aggiunto il
suo mestiere precedente: il pompiere. Meno male che il presidente del Consiglio
italiano non era Di Maio. Cosa avrebbe dichiarato? Conte si é detto soddisfatto
all’80 per cento dei risultati e nessuno ha capito perché. Si é portato a casa
500milioni contro i tre miliardi della Turchia e l’impegno degli altri paesi ad
approntare campi di accoglienza, ma su base volontaria. Cioè nulla, giacché gl
impegni solenni già non si mantengono. Figurarsi quelli su base volontaria.
Intanto sul Mediterraneo si continua a morire. Un’imbarcazione al largo delle
coste libiche é naufragata e cento persone sono morte nell’indifferenza
generale. Tre cadaveri di bambini sono stati recuperati. La colpa non sarà del
governo italiano, ma questa indifferenza alla sorte di uomini, donne e bambini
che fuggono dalla miseria é allucinante. Chiudere i porti e criminalizzare tutte
le Ong dove ci porterà? Meno male che Giggino Di Maio si é portato a casa i
vitalizi, la cui modifica, con l’introduzione del contributivo integrale che non
solo non si applica a nessun’altra categoria di pensionati, ma non si applica
nemmeno ai senatori, verrà bocciata perché contiene larghi tratti di
incostituzionalità. Serve per recuperare 40 milioni, 8 in meno di quelli che si
è fottuti la Lega, ma Di Maio, che considera ladri non Lanzalone, né quelli che
hanno preso i soldi da Parnasi, ma gli ex deputati che hanno fatto la storia
della nostra democrazia, gongola contento. Salvini respinge i migranti, lui ruba
ai ladri (tranne a quelli di casa sua). Un furbone.
Parnasi ai magistrati, "ho pagato tutti i partiti". Il
costruttore ammette le dazioni per accreditarsi,
scrive la Redazione ANSA il 28 giugno 2018. "Ho pagato tutti i partiti".
E' quanto avrebbe confermato agli inquirenti Luca Parnasi, il costruttore romano
interrogato per quasi 11 ore nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della
Roma. Nel corso dell'interrogatorio, l'indagato avrebbe ammesso di avere
elargito denaro alla politica per tornaconto personale, per accreditarsi, per
avere rapporti con tutti i partiti. E' terminato l'interrogatorio, durato
complessivamente 11 ore, di Luca Parnasi, figura chiave dell'indagine della
Procura capitolina sul nuovo stadio della Roma. Dopo la prima tranche di ieri
che si è protratta fino alle 22, oggi nuovo confronto tra il costruttore e i pm
di piazzale Clodio durato circa cinque ore. L'atto istruttorio si è svolto nel
carcere di Rebibbia dove Parnasi si trova detenuto dopo il trasferimento dal San
Vittore di Milano. Primo faccia a faccia tra il costruttore e i pm capitolini -
In una saletta del carcere di Rebibbia, si è svolto il primo confronto tra il
costruttore Luca Parnasi e i pm della Procura capitolina che hanno chiesto il
suo arresto nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Un atto
istruttorio voluto dallo stesso Parnasi e che potrebbe rappresentare un punto di
svolta nella maxinchiesta dei pm di piazzale Clodio. L'imprenditore, accusato
anche di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, aveva infatti
scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al gip
nell'interrogatorio di garanzia, svolto dopo il suo arresto a Milano. Un lungo
faccia a faccia con gli inquirenti che puntano a chiarire il "sistema Parnasi",
ossia quel meccanismo di finanziamento ai partiti, organizzazioni, associazioni
e onlus che il 40enne romano ha fatto diventare una sorta di 'core business'
della sua attività imprenditoriale. Questa prima tranche dell'interrogatorio
avrebbe riguardato le contestazioni presenti nell'ordinanza di custodia
cautelare, il suo ruolo nella società Eurnova e il rapporto con Luca Lanzalone,
l'ex presidente di Acea, e consulente "di fatto" del Comune di Roma nella
trattativa, datata gennaio-febbraio del 2017, per l'abbattimento delle cubature
nel progetto stadio. Domani l'atto istruttorio potrebbe approfondire la
pulviscolare attività di erogazione di denaro al mondo della politica, che
avveniva spesso in modo del tutto tracciabile ma sulla quale i pm vogliono
andare fino in fondo. Un approccio quello di Parnasi che emerge spesso nelle
carte dell'inchiesta. "Io pago tutti", ammette Parnasi in una delle tante
intercettazioni presenti negli atti. "Un investimento molto moderato - ammette
in un altro dialogo registrato - rispetto a quanto facevo in passato quando ho
speso cifre che manco te racconto però la sostanza è che la mia forza è quella
che alzo il telefono...". In base all'impianto accusatorio, il gruppo Parnasi
avrebbe garantito finanziamenti a molte formazioni politiche o ad organizzazioni
ad esse vicine. Nelle carte vengono citati i 250 mila euro erogati, tramite una
società del gruppo, all'associazione "Più Voci" vicina alla Lega. E' lo stesso
Parnasi ad ammettere nelle intercettazioni il suo modus operandi. In un dialogo
si lamenta del fatto di dover "elargire somme ai politici" per avere "le
autorizzazioni". In una informativa i carabinieri scrivono che "nella
conversazione sul finanziamento ad esponenti politici, Parnasi indica nominativi
e quote da corrispondere: Francesco Giro 5 (5000 euro), Ciocchetti 10 (10 mila
euro), Buonasorte 5 (5000 euro): allo stato non e' chiaro se Parnasi stia
parlando di finanziamenti leciti o meno, anche se il riferimento a fatture
emesse a giustificazione dell'erogazione lascia presumere la natura illecita
della stessa", annotano gli investigatori. In un passaggio il costruttore
precisa: "domani c'ho un altro meeting dei Cinque stelle, perchè pure ai Cinque
Stelle gliel'ho dovuti dare".
Marco Travaglio: “Tangentopoli, embè?”,
scrive Marco Travaglio – il Fatto Quotidiano del 30 giugno 2018 – “Soldi a tutti
i partiti”, “Ho pagato tutti i partiti”, “Mazzette a tutti da sempre”. Chi legge
i titoli sull’interrogatorio fiume di Luca Parnasi, il palazzinaro romano
arrestato per corruzione sul nuovo stadio della Roma e altri affari, dirà:
oddio, adesso chissà che succede. Invece è molto probabile che non succeda
niente o quasi in aggiunta alla retata di metà giugno. Eppure i fatti sono
gravissimi. Un imprenditore che contratta con la Pubblica amministrazione, cioè
con partiti o loro emissari, non dovrebbe poter pagare nessuno di coloro che ha
trovato o che troverà dall’altro capo del tavolo delle trattative per affari che
lo riguardano. E nessun partito dovrebbe poter ricevere denaro da imprenditori
che hanno ricevuto o riceveranno appalti dai suoi amministratori. Ma purtroppo,
per le nostre leggi, non è così. Non sempre i fatti gravi – quando a commetterli
sono colletti bianchi – coincidono con i reati, soprattutto nell’Italia
post-1992-’93 che, anziché darsi gli anticorpi contro il riprodursi di
Tangentopoli (lo scandalo), si è data quelli contro il ripetersi di Mani Pulite
(l’inchiesta). In una parola: ha legalizzato le mazzette. Vedremo cosa dirà la
Cassazione quando esaminerà i ricorsi degli arrestati. C’è la questione
giuridica, non da poco, della figura del superconsulente dei 5Stelle Luca
Lanzalone, ritenuto da pm e gip un “pubblico ufficiale di fatto” perché delegato
dalla sindaca Raggi di seguire il dossier stadio e poi nominato presidente della
società mista Acea. Se la Corte confermerà quel ruolo, l’accusa di corruzione
reggerà. In caso contrario, senza il pubblico ufficiale o l’incaricato di
pubblico servizio, crollerà, anche se il fatto (gravissimo) sarà accertato: e
cioè che, mentre trattava o dopo aver trattato con Parnasi sullo stadio per il
Comune, Lanzalone accettò consulenze legali per le società del costruttore per
oltre 100 mila euro. A quel punto i pm potrebbero ripiegare sul traffico
d’influenze, reato tipico del mediatore che chiede soldi o altri vantaggi per
raccomandare il privato al pubblico ufficiale. Però quel reato non prevede
intercettazioni né manette, dunque bisognerebbe pure chiedere scusa agli
arrestati. L’accusa di corruzione riguarda una miriade di politici locali del
Pd, di FI ecc. che da Parnasi avrebbero ricevuto denaro o altre utilità (qualche
migliaio di euro o la promessa di assunzione di un figlio). Essendo politici,
assessori o consiglieri comunali o regionali, non c’è dubbio che siano pubblici
ufficiali: ma bisognerà dimostrare il “nesso causale” fra soldi (o favori)
ricevuti e decisioni assunte a favore di Parnasi. Decisioni – quelle sullo
stadio – che la Procura ritiene corrette. È vero che la Cassazione considera
corrotto anche l’amministratore pubblico che sta sul libro paga di un privato
non in cambio di questo o quell’atto, ma una volta per tutte, “a disposizione”.
Ma l’asservimento permanente di un politico non può valere poche migliaia di
euro. Infatti i legali di Parnasi sostengono che quelle di Parnasi ai politici
non erano mazzette, ma finanziamenti elettorali (in parte leciti perché
dichiarati, in parte illeciti perché in nero) per avere buoni rapporti con tutti
ed evitare che qualcuno si mettesse di traverso. Due anni fa, su Libero, Franco
Bechis pubblicò la lista dei politici romani finanziati da Parnasi in campagna
elettorale: erano di tutti i principali partiti di centrosinistra e
centrodestra, salvo i Radicali e il M5S (che infatti lo costrinsero a dimezzare
il mega-progetto dello stadio rispetto a quel monumento alla speculazione che
era l’iniziale progetto Marino-Caudo). È normale che un palazzinaro che vuol
costruire uno stadio sui propri terreni e, per farlo, necessita del via libera
del Comune e della Regione, paghi le campagne elettorali a chi quel via libera
ha dato o dovrà dare? No, è una vergogna: eppure era tutto lecito, tant’è che
Bechis aveva tratto quelle informazioni da fonti “aperte”. Ora si scopre che
Parnasi finanziò pure il Pd con 50 mila euro per la campagna elettorale di Sala
(che lo ringraziò), visto che a Milano voleva realizzare il mega-stadio del
Milan; versò 150 mila euro alla fondazione Eyu, legata al Pd renziano; e ne
scucì 200 mila alla onlus leghista Più Voci. E il bello (si fa per dire) è che
quasi certamente è tutto lecito, anche se l’abbiamo scoperto perlopiù dalle
intercettazioni: perché onlus, fondazioni & altre casse occulte dei partiti
possono coprire i loro finanziatori con la privacy. Non solo: partiti e singoli
politici, grazie alla legge del governo Letta, possono non dichiarare
finanziamenti fino a 100 mila euro se i donatori chiedono l’anonimato.
Intervistato dal Fatto, il sottosegretario leghista Giorgetti ha detto che
occorreva cambiare la legge e il vicepremier Di Maio ha promesso nuove norme sui
fondi a partiti, politici, fondazioni, onlus e altre opere pie per imporre
trasparenza assoluta. Se possiamo permetterci, suggeriremmo una norma di tre
articoli semplici semplici:
1. “Il partito o il politico o l’associazione a essi legata che riceve fondi
superiori a 10 euro deve dichiararli in un apposito registro presso la
segreteria del partito, o l’assemblea o l’organismo in cui il politico è stato
eletto o candidato, o nel bilancio della società.
2. Il privato che finanzia partiti, politici o associazioni a essi legate deve
registrare i contributi nei bilanci della sua società o nella dichiarazione dei
redditi e non potrà contrattare né operare con la PA nei 10 anni successivi.
3. Chi contravviene agli articoli 1 e 2 commette il reato di illecito
finanziamento dei partiti, punibile col carcere fino a 10 anni e, se esercita
pubbliche funzioni, decàde subito e diventa ineleggibile in perpetuo. Se si
tratta di un partito, perde i finanziamenti pubblici diretti e indiretti ed è
escluso dalle successive elezioni”.
Tutto il resto è chiacchiera. […]
Le mani sulla città? Macché: stadiopoli è un film di Monicelli…Presunte
mazzette pagate via bonifico e un paio di assunzioni. Nell’inchiesta romana però
manca una cosa: la pistola fumante…, scrive Davide Varì il 15 giugno 2018 su "Il
Dubbio". C’è l’imprenditore che “unge” gli ingranaggi, i politici e i burocrati
che si fanno oliare e c’è l’immancabile faccendiere. Anzi due: l’eterno Luigi
Bisignani e Luca Lanzalone, l’uomo di Grillo e Di Maio: il famigerato “Wolf
risolvo problemi”, premiato dai grillini con la presidenza dell’Acea. E c’è
addirittura il controllo dell’informazione, rappresentata, pare, da un giovane
cronista di Dagospia al quale era stato gentilmente chiesto di correggere un
articolo sulla vita privata di Lanzalone. Insomma, in uno scenario degno del
miglior Gianfranco Rosi di Mani sulla città, nell’inchiesta “stadiopoli” dei pm
romani non manca quasi nulla. C’è solo una cosa che non si riesce a trovare, a
mettere a fuoco: la famosa pistola fumante, la prova provata della corruzione.
E’ chiaro che chiunque mastichi un po’ di diritto sa che la prova prende forma
in dibattimento. Dunque il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo, lo stesso
che ha combattuto e perso nel processo Mafia capitale, avrà modo e tempo di
mostrare ai giudici, imputati e pubblica opinione quale sia la prova madre
dell’inchiesta “stadiopoli” e come si concretizzi quel «sistema pulviscolare»
che, come un «crescendo rossiniano» (parole dei pm) ha infettato Roma. Perché
scorrendo tra le centinaia di pagine dell’ordinanza, non è chiarissimo quale sia
il centro del sistema corruttivo. Si parla di passaggi di soldi: ma tutti
bonificati e rendicontati: e di certo sarebbe la prima volta di mazzette via
Iban. E se davvero fosse così, altro che Gianfranco Rosi: ci troveremmo dentro I
soliti ignoti di Monicelli. L’altro capitolo riguarda i favori: posti di lavoro
promessi per amici e congiunti ma, tranne nel caso del figlio dell’ex assessore
Civita, niente più che promesse. In ogni caso, come in tutti i “film” politico-
giudiziari degli ultimi anni, tutto ha inizio con un’intercettazione. Nel foglio
numero 9 dell’ordinanza viene infatti riportato il colloquio tra Luca Parnasi,
il centro del “sistema pulviscolare”, e il suo collaboratore Gianluca Talone:
«Io – spiega Parnasi – spenderò qualche soldo sulle elezioni. È un investimento
che devo fare, molto moderato rispetto a quanto facevo in passato, quando ho
speso cifre che manco te lo racconto”. Non solo, gli stessi pm sono costretti ad
ammettere (foglio numero 11) che i “finanziamenti talvolta hanno natura lecita».
Poi c’è la politica. Il primo obiettivo è il capogruppo 5Stelle in Campidoglio
Paolo Ferrara. Il consigliere grillino che aveva un posto nel tavolo per
l’approvazione dello Stadio, avrebbe “ricevuto”, non soldi, ma un progetto di
restyling per il lungomare di Ostia. Il che lascerebbe pensare che “il Ferrara”
abbia aziende a cui affidare l’eventuale appalto. Macché, Ferrara non ha niente
di niente ma i magistrati sanno bene che il solo nome di Ostia evoca alla mente
dell’opinione pubblica il clan Fasciani e quello degli Spada, che peraltro sono
tutti in “gattabuia”. D’un tratto, e non si sa bene come e perché, tra le pagine
dell’ordinanza spunta anche il nome di Roberta Lombardi, un pezzo grosso dei
5Stelle. Un nome speso dai pm per mettere in luce il livello di pervasività «del
Parnasi». Ma nelle carte non emerge nulla di illecito: se non un incontro – che
sarà il primo e l’ultimo – avvenuto in Parlamento. Ma per i pm tanto basta a
classificarlo come «attività di promozione in favore del candidato alla Regione,
Roberta Lombardi». Ma anche qui, ovviamente, non c’è neanche l’ombra di una
mazzetta. E in questo caso neanche di un “restyling”. Poi c’è il lungo capitolo
del presidente dell’Acea Lanzalone, l’uomo della Casaleggio, il bersaglio grosso
della procura. Secondo i pm Lanzalone «svolgeva le funzioni di assessore per lo
stadio». E nell’ordinanza il gip va oltre: «Le indagini hanno offerto elementi
concreti per ritenere che le figure istituzionali interessate, a cominciare dal
sindaco Raggi, non solo hanno tollerato tale funzione di fatto esercitata, ma al
contrario le hanno dato piena legittimazione». Insomma, Lanzalone, nel disegno
dei pm, è l’uomo che conduce alla sindaca Raggi, la quale, sempre secondo i pm,
era a conoscenza del “sistema pulviscolare”. Infine c’è la questione Lega. Anche
qui la posizione dei pm non è chiarissima. Si parla di un finanziamento
all’associazione “Più voci”, vicina al Carroccio. Ma qui i pm, almeno per il
momento, si limitano alla censura morale. Insomma, l’unica, evidente pistola
fumante emerge dalla penosa vicenda dell’ex assessore regionale Michele Civita
il quale, senza più lo straccio di una poltrona, chiede e (forse) ottiene da
Parnasi un posto di lavoro per il figlio disoccupato. E qui si staglia il
faccione grottesco di Alberto Sordi nella commedia all’italiana. Altro che Mani
sulla città.
Il Pantheon dei capri espiatori. La
storia politica dell’Italia repubblicana raccontata attraverso l’odio per il
singolo, scrive Francesco Damato il 17 Aprile 2018 su "Il Dubbio". L’articolo di
Angela Azzaro in difesa del Pd, e del suo ex segretario, diventato la sentina di
tutti i mali della politica e persino della società italiana dopo i risultati
elettorali del 4 marzo, mi ha fatto tornare alla mente un po’ di capri espiatori
nella storia più che settantennale ormai della Repubblica. Tutto sommato, Matteo
Renzi può sentirsi in buona compagnia, pur con tutti gli errori che ha
sicuramente compiuti, compreso quello che personalmente gli ho più volte
rimproverato di avere negato il Pantheon della sinistra riformista italiana a
Bettino Craxi. Di cui pure, volente o nolente, lui ha ripercorso alcune tappe
nell’azione di partito e di governo, persino quelle delle reazioni più scomposte
e indegne dei suoi avversari, che ne hanno sognato l’arresto, sprovvisto com’era
prima dell’elezione a senatore di Scandicci, di quel poco che è rimasto della
vecchia immunità parlamentare. O lo hanno più semplicemente scambiato per un
aspirante tiranno, come fece appunto con Craxi nel 1983 l’allora segretario del
Pci Enrico Berlinguer. Che pure Renzi è tornato anche di recente a preferire al
leader socialista nella galleria della sinistra.
Nel 1953 il ruolo del capro espiatorio toccò addirittura al protagonista della
ricostruzione post- bellica del Paese: Alcide De Gasperi. Al quale non fu
rimproverata, per quanto neppure scattata nelle elezioni di quell’anno, una
legge chiamata “truffa” perché contemplava un premio di maggioranza in
Parlamento per chi avesse raccolto il 50 per cento più uno dei voti. Roba da
ridere rispetto ai premi adottati o tentati durante la cosiddetta seconda
Repubblica. Il povero De Gasperi subì l’onta della sfiducia parlamentare ad un
governo appena formato, l’ottavo della sua storia personale, e si ritirò fra le
montagne del suo Trentino per morirvi praticamente di crepacuore. E ciò mentre
il suo successore alla guida della Dc, l’allora giovane Amintore Fanfani, si
vantava di essere stato da lui stesso aiutato a subentrargli. «Una fantasia»,
soleva commentare a labbra strette Giulio Andreotti, che di De Gasperi era stato
il braccio destro.
Toccò poi al medesimo Fanfani diventare il capro espiatorio di una rivolta di
partito che lo estromise contemporaneamente da segretario, da presidente del
Consiglio e da ministro degli Esteri. Furono utilizzati contro di lui persino
alcuni incidenti ferroviari per dargli del menagramo. E appendergli in
fotografia al collo un corno, come fece in una copertina un settimanale allora
in voga – Il Borghese – fondato da Leo Longanesi.
Aldo Moro, succeduto a Fanfani come segretario della Dc nel 1959 e poi anche
come presidente del Consiglio alla testa, nel 1963, del primo governo “organico”
di centrosinistra, con tanto di trattino, divenne nel 1968 il capro espiatorio
del mancato successo elettorale dell’unificazione socialista. Che pure lui aveva
cercato di favorire, fra le proteste della maggiore corrente della Dc, quella
dei “dorotei”, sponsorizzando nel 1964 l’elezione del suo ministro degli Esteri
Giuseppe Saragat al Quirinale. Dove peraltro qualche mese prima il democristiano
Antonio Segni era stato colto da ictus in un alterco proprio con Saragat. Fu
proprio la mancanza dell’appoggio di Saragat, nell’estate del 1968, a
determinare l’allontanamento di Moro da Palazzo Chigi. «Non lasciatemi morire
con Moro», si lasciò supplicare quell’estate Pietro Nenni, che ne era stato il
vice al vertice del governo. Estromesso dalla presidenza del Consiglio per
convergenza di interessi e risentimenti democristiani e socialisti, Moro divenne
il bersaglio persino del coltissimo ed ecumenico Giovanni Spadolini. Che da
direttore del Corriere della Sera ne contestò in un fondo domenicale il voto
espresso nella competente commissione della Camera a favore di un emendamento
comunista alla riforma degli esami di Stato, approvato per garantire la
promozione dello studente in caso di parità di giudizi. In quel voto Spadolini
vide addirittura tracce o indizi della Repubblica conciliare, anticipatrice di
quello che sarebbe poi diventato con Berlinguer il progetto del “compromesso
storico”. Ricordo ancora lo sconforto confidatomi da Moro per essere stato
frainteso da un professore universitario dimentico – mi disse l’ex presidente
del Consiglio – che anche un imputato va assolto a parità di voti. Debbo dire
che poi Moro, quando gli capitò da presidente del Consiglio, in un bicolore Dc-
Pri con Ugo La Malfa, di far nominare Spadolini ministro gli ‘ regalò’ – mi
disse – il Ministero dei Beni Culturali fornendogli con un decreto legge il
portafogli di cui quel dicastero non disponeva ancora. Dopo tre anni Moro, nel
frattempo detronizzato di nuovo da Palazzo Chigi, sarebbe stato sequestrato e
ucciso dalle brigate rosse. Il capro espiatorio anche di quella vicenda, e non
solo di un presunto deterioramento dei rapporti fra società civile e politica
avvertito dal Pci nei risultati stentati di un referendum contro la legge che
disciplinava il finanziamento pubblico dei partiti, fu Giovanni Leone. Il quale
fu costretto dalla mattina alla sera a dimettersi da presidente della
Repubblica, quando mancavano solo sei mesi alla scadenza del mandato
quirinalizio.
Così il povero Leone pagò pure, o soprattutto, la colpa di essersi messo di
traverso alla linea della fermezza adottata dal governo di fronte al sequestro
del presidente della Dc. Di cui invece il capo dello Stato aveva voluto tentare
uno scambio predisponendo la grazia per Paola Besuschio, compresa nell’elenco
dei tredici detenuti che i terroristi avevano chiesto di liberare per restituire
vivo l’ostaggio.
Il turno successivo di capro espiatorio toccò ad Arnaldo Forlani, dimessosi da
presidente del Consiglio nel 1981 per le liste della loggia massonica P2 di
Licio Gelli, in cui c’era anche il nome di un prefetto che era il suo capo di
Gabinetto. Poi Forlani dovette difendersi in una causa alla Corte dei Conti per
i danni subiti dai massoni, e risarcibili dallo Stato, a causa della diffusione
delle liste, per quanto avvenuta d’intesa tra il governo e la competente
autorità giudiziaria. Una vicenda tutta italiana per confusione, caccia alle
streghe e quant’altro.
Decisamente più drammatica fu, come capro espiatorio, la sorte di Bettino Craxi,
perseguito con «una durezza senza uguali», certificata dopo anni con lettera
dell’allora capo dello Stato Giorgio Napolitano alla vedova, per il
finanziamento illegale della politica, e reati connessi. Come se Craxi non
avesse ereditato ma inventato lui quel fenomeno, per giunta coperto nel 1989 con
un’amnistia che aveva consentito a un bel po’ di politici di farla franca.
Giulio Andreotti divenne invece negli stessi anni il capro espiatorio delle
carenze nella lotta alla mafia, per quanto il suo ultimo governo avesse
trattenuto con un decreto legge di controversa costituzionalità un bel po’ di
mafiosi che avevano maturato il diritto di uscire dal carcere. E avesse
arruolato al Ministero della Giustizia, proprio per la lotta alla mafia, un
campione come il giudice Giovanni Falcone, eliminato per questo dai criminali
con la strage di Capaci. Processato, in sovrappiù, ed assolto anche per il
delitto Peccorelli, il sette volte presidente del Consiglio, nonché senatore a
vita di nomina quirinalizia avendo «illustrato la Patria – secondo la formula
dell’articolo 59 della Costituzione – per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario», si è portata nella tomba l’onta, ancora
rimproveratagli ogni volta che gli capita dal pubblico accusatore Gian Carlo
Caselli, di una prescrizione del reato di associazione a delinquere, prima che
diventasse concorso esterno in associazione mafiosa. Da cui in ogni modo
Andreotti fu assolto, per ammissione anche di Caselli.
Passati dalla prima alla seconda Repubblica, ci siamo dovuti accontentare,
sempre nel campo politico, di capri espiatori, diciamo così, più alla buona.
Come il povero Achille Occhetto, sostanzialmente deposto nel 1994 da Massimo
D’Alema al vertice dell’ex Pci per la sorprendente e strepitosa vittoria
elettorale conseguita sulla sinistra dall’esordiente Silvio Berlusconi. E poi lo
stesso Berlusconi per le sue abitudini di vita non da seminario, o per i suoi
affari, analoghi a quelli di tutti gli altri imprenditori della sua stazza
finanziaria, o persino per le speculazioni subite dai titoli del debito pubblico
italiano nell’estate del 2011, quando irruppe sulla scena il loden austero di
Mario Monti.
Il ruolo di capro espiatorio è inoltre toccato a D’Alema per essere subentrato
nel 1998 a Romano Prodi senza passare per gli elettori con le elezioni
anticipate, e per una certa spocchia rimproveratagli a volte a ragione ma a
volte anche a torto.
Il povero Fausto Bertinotti, a dispetto delle buone maniere che tutti gli
riconoscono, è stato buttato dal mio amico Giampaolo Pansa tra le fiamme come ‘
il parolaio rosso’ per non aver voluto a suo tempo sostenere i governi Prodi
oltre le loro materiali capacità di resistenza politica.
Walter Veltroni divenne nel 2009 il capro espiatorio di alcuni rovesci locali
del Pd da lui stesso fondato due anni prima, scampando al torto più consistente
e per lui dannoso di essersi apparentato a livello nazionale nelle elezioni del
2008 con Antonio Di Pietro, subendone la linea. Matteo Renzi chiude, per ora, la
lista per le rottamazioni sbagliate, o per quelle incompiute. E per sopravvivere
fisicamente alle sue dimissioni da segretario del Pd dopo la sconfitta del 4
marzo. Già, perché la sua stessa presenza fisica sembra infastidire i vecchi e
nuovi avversari politici. E’ incredibile ma vero in questo Paese che continua a
chiamarsi Italia.
Vittorio
Feltri e la tragica verità su Bettino Craxi: "Ho dato io il via alla caccia del
Cinghialone, ma...",
scrive il 19 Settembre 2018 "Libero Quotidiano". Pubblichiamo un capitolo del
libro del direttore Vittorio Feltri "Il borghese. La mia vita e i miei incontri
da cronista spettinato", in libreria per Mondadori. Si tratta del ricordo
di Bettino Craxi: dal Raphael alla morte ad Hammamet. Conobbi Bettino Craxi nel
periodo in cui collaboravo con Enzo Biagi nel suo programma tv. Erano gli anni
Ottanta. Quella sera erano ospiti della trasmissione sia Craxi sia Gianni
Agnelli. Quest' ultimo indossava un vestito grigio di flanella, calzava scarpe
di camoscio, un paio di Clarks, e se ne stava seduto con le gambe divaricate
come fosse un cowboy tornato a casa sfinito dalla cavalcata. Bettino, che gli
era accanto, invece, era abbigliato come un manichino, eppure alla vista
risultava sciatto. Non era una trasandata eleganza la sua, che pure sarebbe
stata chic, sembrava più pigrizia nel selezionare i capi. Craxi era alto quasi
due metri e corpulento, il suo aspetto da gigante mal si conciliava con la
pacatezza e la cordialità dei modi. Era affabile persino con me, che ero un
semplice autore che si muoveva dietro le quinte. Restai colpito e affascinato
dal suo essere mellifluo. Allorché alcuni anni dopo andai a dirigere L' Europeo,
feci un titolo riferito proprio a Bettino: Figlio di un dio minore. Craxi non
godeva di un numero esorbitante di voti, eppure comandava l'Italia. La
titolazione non suscitò molte proteste. Anche il mio editore, la Fiat, non ebbe
nulla da ridire al riguardo, del resto era cosa nota che i rapporti tra la casa
editrice e Bettino non fossero propriamente idilliaci. A quell' epoca Dc e Psi
iniziavano a perdere appeal mentre il consenso alla Lega, su cui nessuno avrebbe
scommesso un soldo, lentamente cresceva. Intuivo che si stava apprestando un
cataclisma. E così fu così. Ero appena passato alla direzione dell'Indipendente
quando scoppiò il caso "Mani pulite". Il sostituto procuratore Antonio Di Pietro
condusse le indagini che si estesero fino a inglobare esponenti politici di
rilievo, tra cui Bettino Craxi, che finì sotto tiro e divenne l'emblema del
malaffare. Scrissi che sarebbe stato opportuno acciuffare "il cinghialone", che
era appunto il leader dei socialisti. Lo battezzai io con questo simpatico
epiteto, che peraltro gli calzava a pennello considerata la sua mole. Da quel
momento, per tutti Craxi fu "il cinghialone" e fu davvero perseguitato. Sembrava
insomma che l'unico ladro fosse lui, eppure tutti i partiti, incluso quello
comunista, si facevano finanziare. Il caprone espiatorio - Il caprone espiatorio
di Mani pulite un bel dì mi telefonò chiedendomi un incontro. Il suo tono era
intimo, quasi disperato, diceva che voleva assolutamente parlarmi di persona.
Quindi mi scomodai e raggiunsi la capitale un po' impietosito da quell' uomo che
io avevo contribuito a mettere alla gogna e un po' incuriosito dal vis-à-vis con
la bestia. Il cinghialone mi aspettava presso l'hotel Raphaël, nel quale si
favoleggiava che Bettino avesse un attico stratosferico dagli anni Settanta e
vivesse nel lusso sfrenato grazie ai soldi delle tangenti. L' albergo aveva un
certo fascino visto dall' esterno, forse anche per il manto di leggende che lo
avvolgeva, ed era ricoperto di edera. Sceso dal taxi, sollevai d' istinto lo
sguardo per scorgere l'appartamento del leader semidecaduto. Poi raggiunsi
l'ultimo piano e, uscito dall' ascensore, mi ritrovai in una sorta di topaia. In
quei locali regnava la sciatteria: i posacenere erano traboccanti di cicche di
sigarette, l'odore di fumo era avvinghiato alle pareti, le tappezzerie erano
vecchie e logore, i divani sdruciti, l'atmosfera squallida e fané. Ero alquanto
impressionato, ma cercai di nasconderlo, intanto Bettino aveva cominciato il suo
discorso, lo stesso che poi fece alla Camera. Sembrava che volesse tenere al mio
cospetto l'esercitazione preliminare, che avesse deciso che io dovessi essere lo
spettatore e l'ascoltatore primo di ciò che egli aveva da raccontare all' Italia
intera. Erano le prove generali. Il cinghialone vomitò lì la verità,
liberandosi: disse che il sistema era completamente marcio, che in molti ne
avevano approfittato, non soltanto lui e i membri del suo partito. Aggiunse che
aveva preferito non intervenire per porre fine a tale andazzo malsano in quanto
sarebbe stato preso per matto. «Non è che si rubasse per il partito, si rubava
anche al partito» spiegò. Nessuno lo ammise, l'unico a farlo fu Craxi. E lo fece
in quella stanza di albergo, davanti a me, che ero amico di Antonio Di Pietro e
rappresentante numero uno dei manipulitisti, e poi anche in tribunale. Da
allora, dopo profonde riflessioni, cambiai registro. Bettino fu condannato dal
Tribunale di Milano. Quando la sentenza divenne definitiva, al fine di scampare
la carcerazione, si rifugiò ad Hammamet. Lontano dalla Madre Patria, dai
sontuosi palazzi del potere, da quello che per due decenni era stato il suo
appartamento all' ultimo piano dell'hotel Raphaël, dai tribunali festanti perché
Giustizia era stata fatta ma non appagati perché il cinghialone era fuggito via
prima della cattura, Bettino quasi tutte le sere, puntuale come un orologio
svizzero, alle ore 23 mi telefonava a casa, a Milano, affamato di notizie e
desideroso di dire la sua su quanto succedeva. Era un modo per non sentirsi del
tutto tagliato fuori, estromesso senza lode e senza onori dalla storia italiana.
Bettino si fidava di me, capiva che ero in buonafede. Si dice che per costruire
un sentimento di fiducia tra due persone siano necessari diversi lustri, ma è
una balla. Esso può nascere all' improvviso, guardandosi negli occhi in una
stanza piena di posacenere sudici, in un pomeriggio qualunque in cui un uomo
disperato si mette nelle mani di colui che gli ha sferrato uno dei colpi meglio
piazzati, aizzando la folla. Io sbagliai. E lo ammetto. E ho imparato dal mio
errore. Durante le nostre conversazioni dall' Africa all' Italia, Bettino
esprimeva le sue opinioni, sosteneva che Berlusconi, in procinto di fare il suo
ingresso sulla scena politica, non sarebbe riuscito a governare come Dio comanda
e che non disponesse dell'esperienza e della duttilità indispensabili a un
leader. La mia era una sorta di nota politica, in quanto, nel luogo in cui si
trovava Bettino, i quotidiani arrivavano in ritardo. Craxi non lasciava
trasparire le sue emozioni, c'era in lui un amaro sentimento di abbandono. Era
un tifoso di Garibaldi, possedeva un marcato spirito patriottico, perciò gli
mancava in modo insopportabile la partecipazione alla vita pubblica. In fondo,
egli era stato un perno della politica italiana, sebbene la gente ora lo
disprezzasse e lo volesse linciare come quella famosa sera del 30 aprile 1993,
quando, dopo essersi rifiutato di uscire dal retro dell'albergo in cui viveva al
fine di evitare la folla, fu assalito dai dimostranti che gli tirarono addosso
monetine, accendini, sassi e qualsiasi altra cosa capitasse loro a tiro. E
l'impavido Bettino, salito in macchina, li osservava dal finestrino con un
sorriso strano, come se lo stessero festeggiando. Le nostre telefonate furono
intercettate e su tutti i giornali fu pubblicata la notizia come si trattasse di
uno scandalo o un gravissimo reato: il direttore del Giornale, Vittorio Feltri,
conversa con Bettino Craxi. Il contenuto di quelle chiamate non era un segreto e
i nostri discorsi erano persino noiosi. Insomma, nulla di avvincente. Fui
sputtanato, ma io me ne fregai e continuai a parlare con Bettino, che mi piaceva
anche perché era stato tradito da tutti, persino dai suoi compagni. Lo
rispettavo e provavo pena per lui; proprio io, che all'inizio lo avevo attaccato
in modo brutale, ora lo difendevo. Era un tipo in gamba, l'unico italiano ad
avere capito che il comunismo era morto, quando ancora nessuno lo sospettava. Lo
rivalutai completamente, imparando a stimarlo poiché era lucido, sagace e anche
simpatico. Tra noi si instaurò una speciale empatia e diventai anche amico della
figlia, iniziando a frequentare la famiglia Craxi. La sua morte fu un vero
dolore per me. Il telefono alle 23 non squillò più da un giorno all' altro,
proprio quando avevo convinto Bettino a scrivere per me in qualità di
collaboratore per il Giornale. Il politico, che già aveva diverse problematiche
di salute, fu stroncato dal logorante malessere interiore che gli procurava
quella insopportabile emarginazione.
1993: quel
giorno al Raphael Craxi non uscì dal retro.
Certo non gli mancava il fegato, a Bettino Craxi. Gli avevano suggerito di
uscire dal retro dell'hotel Raphael, per evitare la folla che assiepava davanti,
ma lui non ne aveva voluto sapere. E allora – è la sera del 30 aprile 1993 – la
affronta, quella folla. E succede quel che tutti sappiamo, scrive Alessandro
Marzo Magno il 17 Settembre 2011 su "L'Inchiesta". «“La macchina è pronta?”.
“Sì”, “Bene”. Una pausa. “Allora andiamo”. Carica la giacca blu sulla spalla, e
un poliziotto si precipita alla porta. Passa Craxi e dà un altro calcione tipo
saloon, è fuori, è un boato. La sera è illuminata a giorno da flash e faretti, a
guardarla in televisione sembra un primo pomeriggio. Eccolo, eccoli, salgono
sulla Thema marroncina, Nicola alla guida, il fotografo Umberto Cicconi
affianco, Craxi e Josi dietro, e volano urla, sassi, monetine, accendini,
pacchetti di sigarette, un ombrello, Cicconi sanguina alla testa, Josi si è
preso qualcosa in un occhio, Craxi niente, sorride, è pazzo, e intanto sono
pugni sul vetro, colpi di casco e sacchetti di sassi sulla carrozzeria, non c’è
filtro tra l’auto e i dimostranti, i poliziotti sono tutti spersi o travolti,
via, si parte, via, Craxi sorride ancora rivolto al finestrino, “tiratori di
rubli”, mormora». Certo non gli mancava il fegato, a Bettino. Gli avevano
suggerito di uscire dal retro del Raphael, per evitare la folla che assiepava
davanti, ma lui non ne aveva voluto sapere. E allora – è la sera del 30 aprile
1993 – la affronta, quella folla. E succede quel che tutti sappiamo: gli tirano
le monetine, gli sventolano banconote da 1000 lire urlando: «Prenditi anche
queste». Accade quel che Filippo Facci rievocherà dieci anni dopo, nel brano
citato all’inizio. Le monetine del Raphael entreranno nella storia. La sera
prima, il 29 aprile, la Camera aveva salvato Bettino Craxi negando
l’autorizzazione a procedere per quattro delle sei imputazioni a suo carico. Lo
stato maggiore del Psi si riunisce a festeggiare nella suite dell’albergo romano
dove il segretario socialista viveva dagli anni Settanta, il Raphael, appunto.
Si fa vivo anche un imprenditore amico di Craxi, Silvio Berlusconi, che però,
lui sì, ha l’accortezza di uscire dal retro. «Che rispetto potremmo avere di noi
stessi», dichiarerà Berlusconi ai giornalisti, «se essendo amici di qualcuno da
anni dovessimo voltargli le spalle proprio nei momenti della cattiva sorte e
della difficoltà? Sono amico di Bettino Craxi da vent’anni, e da amico,
personalmente, sono contento per lui. Mi sembra che basti». Forse, in quel suo
ostinato ripetere «non farò la fine di Craxi», Berlusconi ha ben viva la memoria
del Raphael e forse è proprio quella la «piazza urlante che grida, che inveisce,
che condanna» citata da Berlusconi nel video della sua discesa in campo. La sera
del 29 aprile, quindi, i socialisti festeggiano lo scampato pericolo del voto
parlamentare, il Tg1 di Luca Giurato fa finta di niente e nemmeno riferisce
delle mancate autorizzazioni a procedere. Parla del governo presieduto da Carlo
Azeglio Ciampi (alla presidenza della Repubblica siede Oscar Luigi Scalfaro) e
poi passa a un servizio su Gino Giugni, socialista, e padre dello Statuto dei
lavoratori. Articolo su La Stampa del 1 maggio 1993 firmato da Augusto
Minzolini, oggi direttore del Tg1. Il 30 Craxi se ne sta chiuso tutto il giorno
nel suo alloggio. Ci entravano le ragazze, in quelle stanze, ma non a decine per
volta, invece ne entrava soprattutto una che ne valeva decine: Moana Pozzi. La
pornostar ha avuto una relazione col leader socialista di cui tutta Roma
mormorava, ma entrambi sono stati ben accorti a non farla finire sui giornali.
La Repubblica, quel giorno titola: “Vergogna, assolto Craxi”. Tutti i quotidiani
pubblicano editoriali di fuoco. L’Italia è quella di sempre: pronta a osannare i
vincitori e altrettanto veloce ad abbandonare al proprio destino gli sconfitti;
è già successo, accadrà ancora. Craxi è finito, ormai è chiaro, la questione non
è più “se”, ma “quando”. Verso sera, saranno le 18, il segretario socialista si
affaccia alla finestra dell’albergo. «Cos’è questo casino?», domanda. Giù, in
Largo Febo si sta riunendo una folla sempre più rumorosa. Proprio lì vicino, in
Piazza Navona, si sta tenendo un comizio a cui partecipano Giuseppe Ayala, ex
magistrato antimafia al tempo parlamentare repubblicano, Francesco Rutelli, al
tempo non ancora baciabanchi, e Achille Occhetto, al tempo segretario del Pds. A
mano a mano che passa il tempo, contingenti crescenti di militanti, soprattutto
del Pds, lasciano Piazza Navona per andare a protestare sotto le finestre
dell’albergo dove vive Craxi. Scandiscono slogan: «In galera», «Suicidio», «Un
sogno nel cuore, Craxi a San Vittore». Intanto Occhetto finisce il suo
intervento, si ode un boato, il comizio si scioglie e una parte della folla
converge in Largo Febo. «Perché non li cacciano?», aveva chiesto Craxi guardando
i manifestanti e subito erano partite telefonate per il capo della polizia,
Vincenzo Parisi. Questi tranquillizza e rassicura, ma intanto manda un gruppo di
agenti in tenuta antisommossa sotto il Raphael. I poliziotti sono pochissimi e
capiscono subito che se la situazione degenerasse, non potrebbero farci
nulla. Nicola, l’autista del segretario socialista, fa da ambasciatore tra i
dirigenti della polizia, nella hall, e i piani alti. Craxi deve andare a
registrare un’intervista con Giuliano Ferrara, l’appuntamento è per le otto, e
cercano di convincerlo a uscire dal retro, evitare la protesta e svignarsela
senza dare nell’occhio. Lui decide altrimenti. A un certo punto, riferisce
Filippo Facci, si sente un colpo secco. Craxi ha spalancato la porta
dell’ascensore con una pedata. È facile a infuriarsi, ma ora è assolutamente
freddo. Si scusa con alcuni turisti per la confusione. Non degna nemmeno di
un’occhiata i dirigenti di polizia che lo invitano a andarsene alla chetichella.
Gli agenti si aprono e gli fanno ala, si avvicina alla porta d’ingresso, la apre
con un calcio pure quella, e...Qualcuno dirà che Craxi è morto quel
giorno. Certo è invece che tutto è cambiato perché nulla cambi. La Chiesa, al
tempo, si schiera apertamente; il cardinale Carlo Maria Martini che invita i
cittadini alla «veglia dei lavoratori» fa apparire ancora più assordante
l’attuale silenzio del cardinale Tarcisio Bertone. Riccardo De Corato, allora
orgogliosamente missino, si ammanetta per un paio d’ore in Piazza Duomo, a
Milano, inalberando il cartello: «Craxi in libertà, manette all’onestà». Umberto
Bossi marcia su Milano. Dalla sede della Lega, allora in via Arbe, arringa i
suoi accorsi con bandieroni verdi. Minaccia di tirare “un sac de tumat” (un
sacco di pomodori, per i non lumbard) a chi vuol tenere in piedi il governo.
Dice che bisogna approvare la nuova legge elettorale per la Camera, e poi:
«Tutti a votare entro giugno, tangentisti a casa e si ricomincia a lavorare».
Altri tempi.
Con una fuga di notizie infilzarono Craxi. 25 anni fa la congiura
che lo escluse da palazzo Chigi, scrive Francesco
Damato il 10 giugno 2017 su "Il Dubbio". Dopo la strage di Capaci e l’elezione
in 48 ore di Oscar Luigi Scalfaro al Quirinale, dove per quindici votazioni
avevano inutilmente tentato di arrivare, con candidature formali o sotterranee,
Arnaldo Forlani, Giulio Andreotti e persino il presidente uscente e
dimissionario Francesco Cossiga, nulla fu più uguale sul piano politico.
Terminato di comporre il suo staff al Quirinale il 4 giugno con la nomina del
generale Paolo Scaramucci a consigliere militare, Scalfaro predispose le
consultazioni per la formazione del nuovo governo: quello di esordio della
legislatura nata con le elezioni del 5 e 6 aprile. Ma la prima sfilata delle
delegazioni dei partiti davanti al capo dello Stato terminò il 10 giugno senza
altro risultato che la constatazione di un clima politico irrespirabile, con
veti e controveti all’interno e all’esterno della maggioranza uscente composta
da democristiani, socialisti, socialdemocratici e liberali. Era una maggioranza
peraltro troppo risicata per fronteggiare una difficile situazione economica e
un’ancora più difficile situazione politica nel contesto delle indagini
giudiziarie in corso a Milano su Tangentopoli. Scalfaro non riuscì a venirne a
capo neppure moltiplicando le sue preghiere alla Madonna di Lourdes, dove
peraltro si era proposto prima della imprevista elezione a capo dello Stato di
recarsi in pellegrinaggio. Si scusò della rinuncia esortando gli organizzatori
del viaggio a pregare anche perché lui venisse illuminato. In attesa di un
secondo giro di consultazioni formali, il presidente della Repubblica vide o
sentì privatamente un’infinità di amici, fra i quali i ministri uscenti
dell’Interno e della Giustizia: il democristiano Enzo Scotti e il socialista
Claudio Martelli, invitati insieme al Quirinale formalmente per discutere di un
provvedimento in gestazione per intensificare la lotta alla mafia dopo la strage
di Capaci. Ma il discorso scivolò subito sul tema della formazione del governo.
Vuoi su sollecitazione di Scalfaro, come poi avrebbe raccontato Martelli, vuoi
di iniziativa dei due ministri, il capo dello Stato ricavò l’impressione, a
torto o a ragione, che fossero entrambi convinti di potere insieme tentare la
formazione di un governo di decantazione, scambiandosi i ruoli di presidente e
vice presidente, capace di guadagnarsi se non l’appoggio, almeno la benevola
opposizione del Pds- ex Pci guidato da Achille Occhetto. Informato, non si è mai
ben capito se dallo stesso Scalfaro, col quale aveva allora eccellenti rapporti,
tanto da averne sostenuto con la solita baldanza l’elezione prima a presidente
della Camera e poi a capo dello Stato, Marco Pannella confidò la cosa a Bettino
Craxi. Che – convinto di avere ancora buone carte da giocare per tornare a
Palazzo Chigi, da dove riteneva di essere stato allontanato malamente da Ciriaco
De Mita nel 1987, con la storia di una staffetta con Andreotti prima promessa
per l’ultimo anno della legislatura e poi negata – a sentire Pannella cadde
dalle nuvole. Ma di brutto, perché se la prese subito con Martelli, essendo
ancora convinto che Scalfaro gli fosse leale, come lo era stato al Ministero
dell’Interno nei quattro anni di governo da lui presieduto: tanto leale non solo
da avere rifiutato di prestarsi a fare il governo elettorale offertogli da De
Mita, come ho già ricordato qui, ma anche da avere cercato e trovato una decina
d’anni prima negli archivi del Viminale un documento da tutti negato in
precedenza, ma utile alla difesa dei socialisti finiti sotto processo a Milano
per gli attacchi ai pubblici ministeri che avevano indagato per l’assassinio di
Walter Tobagi. Era un’informativa dei servizi segreti che nel 1980 aveva
inutilmente segnalato il pericolo di un imminente agguato mortale delle brigate
rosse al famoso giornalista del Corriere della Sera, peraltro amico personale
del leader socialista. Notizia di quell’informativa era stata data personalmente
a Craxi all’indomani dell’uccisione del povero Walter dal generale dei
Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa. Craxi girò la confidenza di Pannella
sull’incontro di Scotti e Martelli con Scalfaro al segretario della Dc Arnaldo
Forlani, facendo cadere dalle nuvole pure lui. Ed entrambi si ripromisero di
punire, diciamo così, i due giovani aspiranti alla guida del nuovo governo o non
confermandoli ai loro posti o lasciandoli proprio fuori. Ma né l’uno né l’altro
ebbero poi la voglia di raccontare come fossero veramente andate le cose, dopo
molti anni, ai magistrati di Palermo che li interrogarono sulle presunte
trattative fra lo Stato e la mafia della stagione stragista. Essi diedero agli
inquirenti l’impressione di essere stati sacrificati perché contrari a quelle
trattative, contribuendo così all’impianto accusatorio del processo contro
mafiosi, generali e uomini politici ancora in corso a Palermo. Ma da cui è stato
già assolto, avendo scelto il rito abbreviato, l’ex ministro democristiano
Calogero Mannino, che pure era stato accusato di essere stato addirittura il
promotore della trattativa per scongiurare una minaccia della mafia alla sua
vita. Non ci fu tuttavia soltanto l’incidente o l’equivoco della coppia Scotti-
Martelli durante le consultazioni informali di Scalfaro per la formazione del
nuovo governo. Ci fu anche, fra l’altro, una rovinosa fuga di notizie sui
documenti pervenuti dalla Procura di Milano alla Camera, e assegnati subito alla
giunta delle cosiddette autorizzazioni a procedere per Tangentopoli sul conto
degli ex sindaci di Milano Paolo Pillitteri e Carlo Tognoli, entrambi
socialisti. Il “verde”, ed ex direttore del Manifesto, Mauro Paissan fu
indicato, a torto o a ragione, come fonte di quella fuga con interpretazioni
troppo estensive di alcune parti dei fascicoli, da cui avrebbe ricavato, come
esponente dell’apposita giunta di Montecitorio, l’impressione di un
coinvolgimento anche di Craxi nelle indagini chiamate Mani pulite. Ricordo
ancora nitidamente quella giornata in cui le agenzie avevano inondato le
redazioni dei giornali di lanci a dir poco allarmanti sulla posizione
giudiziaria del segretario socialista ancora in corsa per il ritorno a Palazzo
Chigi. Nelle prime ore del pomeriggio, tornando a piedi da casa alla redazione
del Giorno, di cui ero direttore, incrociai per caso in Piazza della Scala
Antonio Di Pietro, il magistrato ormai simbolo di quell’inchiesta che stava
demolendo la cosiddetta prima Repubblica. Allontanata la scorta con un cenno di
mano, “Tonino” mi disse che nelle carte partite da Milano per la Camera non
c’erano elementi contro Craxi, di cui lui parlava volgendo lo sguardo verso la
Galleria, cioè verso gli uffici milanesi del segretario del Psi. E mi
preannunciò un comunicato della Procura, che in effetti fu diffuso dopo qualche
ora per precisare che nulla risultava “allo stato” delle indagini contro Craxi.
Il quale tuttavia il giorno dopo si trovò su tutte le prime pagine dei giornali
ugualmente come uno ormai compromesso nell’inchiesta. Non ricordo se l’ho già
riferito ai lettori del Dubbio in altre circostanze riferendo del biennio
“terribile” 1992- 93, ma il clima nei giornali, ormai di tutte le tendenze, era
tale che la sera di quel giorno mi telefonò l’amico Ugo Intini, portavoce di
Craxi, per chiedermi come avessi deciso di uscire con la prima pagina del
Giorno. Alla confidenza che sarei uscito col titolo sul comunicato di smentita
diffuso dalla Procura, che ai miei occhi costituiva l’unica notizia certa della
giornata rispetto a tutte le voci col condizionale diffuse dalle agenzie, Ugo mi
chiese se poteva consigliare al comune amico Roberto Villetti, direttore
dell’Avanti, di chiamarmi. Cosa che Villetti fece subito, ma non per
consultarsi, come si aspettava il povero Intini, bensì per dissentire fermamente
dal modo garantista in cui avevo deciso di titolare. Rimasi francamente di
stucco. Neppure Scalfaro al Quirinale dovette rimanere convinto del comunicato
della Procura milanese se volle parlarne direttamente col capo Francesco Saverio
Borrelli, peraltro figlio di un suo vecchio collega ed amico. L’impressione che
ne ricavò l’uomo del Colle fu di paura di mandare a Palazzo Chigi un “amico” –
quale ancora egli considerava il suo ex presidente del Consiglio – destinato
prima o dopo ad essere davvero coinvolto nelle indagini, come avvenne a fine
anno con i primi avvisi di garanzia, e poi anche con richieste di arresto. Lo
stesso Craxi mi raccontò di essersi sentito dire da Scalfaro all’incirca così:
“Tu sai quanto ti stimi e ti voglia bene, ma è opportuno, anche nel tuo
interesse, che tu faccia un passo indietro in questo momento. Dimmi tu stesso il
nome di un socialista al quale io possa dare l’incarico”. E il 10 giugno, nel
secondo ed ultimo giro di consultazioni, Craxi maturò la decisione del doloroso
passo indietro. Che annunciò personalmente all’uscita dall’ufficio del capo
dello Stato dicendo di avergli indicato “in un ordine non solo alfabetico”
Giuliano Amato, già ministro con De Mita e suo sottosegretario a Palazzo Chigi,
Gianni De Michelis e Claudio Martelli. La delegazione della Democrazia
Cristiana, ricevuta per ultima, non ebbe così neppure la possibilità di proporre
Craxi, contro la cui destinazione si erano già espressi nel partito alcuni
esponenti, fra i quali De Mita, convinti che Palazzo Chigi spettasse ancora alla
Dc, nonostante il ritorno di un democristiano al Quirinale dopo il movimentato
settennato di Cossiga. Pertanto fu Amato l’uomo al quale Scalfaro diede
l’incarico, che fu espletato con una certa difficoltà, avendo impiegato il nuovo
presidente del Consiglio una decina di giorni, sino al 28 giugno, per la
definizione del programma e soprattutto della lista. Dove Scotti risultò
spostato dal Viminale alla Farnesina, che formalmente era una promozione, da lui
però rifiutata perché Forlani aveva deciso di sperimentare dentro la Dc la
incompatibilità fra le cariche di ministro e di deputato o senatore. Scotti
reclamò inutilmente una deroga per conservare il mandato parlamentare, che alla
fine preferì alla guida della diplomazia italiana. Martelli invece entrò nella
lista all’ultimo momento, dopo essere andato da Craxi, su suggerimento dello
stesso Amato, per chiedergli di essere confermato al Ministero della Giustizia,
come poi mi avrebbe raccontato lo stesso Craxi, per portare a termine il lavoro
svolto col povero Giovanni Falcone, suo prezioso collaboratore sino alla morte –
e che morte – come direttore degli affari penali del dicastero di via Arenula. E
Craxi acconsentì, parendogli – mi disse – “una richiesta umanamente
ragionevole”, lungi forse dall’immaginare che Martelli fosse destinato pure lui
dopo qualche mese ad essere investito da Tangentopoli e costretto alle
dimissioni. Comunque, Martelli fu l’ultimo ministro e il primo governo di Amato
l’ultimo sul quale il leader socialista riuscì a dire la sua, perché di fatto in
quel mese di giugno di 25 anni fa al falconicidio col sangue, preceduto
dall’ostracismo in vita praticatogli da tanti colleghi, seguì il craxicidio
senza sangue. I rapporti di Craxi con Scalfaro rimasero buoni ancora per poco.
Col procedere delle indagini e del linciaggio politico da cui pochi lo difesero,
neppure quando subì il famoso lancio di monetine e insulti davanti all’albergo
romano dove abitava, e donde usciva per andare ad una trasmissione televisiva
dopo essere scampato a scrutinio segreto ad alcune, le più gravi, delle
autorizzazioni a procedere chieste contro di lui dalla magistratura, il leader
socialista si fece del presidente della Repubblica l’idea da lui stesso espressa
in una serie di litografie raffiguranti falsi “extraterrestri”: finti
inconsapevoli del finanziamento generalmente illegale della politica e delle
forzature con le quali la magistratura aveva deciso di trattarlo. Oltre a
Scalfaro, furono definiti extraterrestri anche Achille Occhetto, Eugenio
Scalfari, Giorgio Napolitano e l’ormai compianto Giovanni Spadolini, la cui foto
fu sostituita con un manifesto bianco listato a lutto. Craxi stesso mi raccontò
nel suo rifugio di Hammamet di avere scritto più volte al presidente della
Repubblica, anche come presidente del Consiglio Superiore della Magistratura,
contro gli eccessi che stavano compiendo i magistrati, ma di non avere mai
ricevuto una risposta, né diretta né indiretta. Il Quirinale non lo considerò
più degno di riconoscimento alcuno. Ci vollero del resto la morte di Craxi e
l’arrivo sul colle più alto di Roma di Giorgio Napolitano perché un presidente
della Repubblica parlasse di lui riconoscendone il servizio politico reso al
Paese e lamentando, fra le solite proteste dei manettari in servizio permanente
effettivo, irriducibili anche di fronte alla morte, “la severità senza uguali”
con cui era stato trattato dalla magistratura. Proprio alla magistratura,
vantando di averne fatto parte, Scalfaro nel suo discorso di insediamento,
pronunciato il 28 maggio a Montecitorio, davanti alle Camere in seduta congiunta
con la partecipazione dei delegati regionali, aveva chiesto “energia, serenità e
perseveranza” parlando della “questione morale”. Di energia e perseveranza
sicuramente i magistrati si dimostrarono capaci nei mesi e negli anni
successivi. Di serenità, francamente, un po’ meno, nella sostanziale e
incresciosa disattenzione proprio di chi l’aveva reclamata insediandosi al
vertice dello Stato sull’onda peraltro di una strage neppure citata per luogo e
per nomi nel discorso alle Camere, essendosi Scalfaro limitato a parlare di una
“criminalità aggressiva e sanguinaria”, forse aiutata anche da qualche mano
straniera. Di cui nessuno, a dire il vero, aveva avuto sentore a Capaci e
dintorni.
Così la sentenza Stato-mafia è un teorema per incolpare il Cav.
Ogni evento rimanda a Berlusconi. Che non era imputato, scrive Luca Fazzo,
Sabato 21/07/2018, su "Il Giornale". La bellezza di 5.252 pagine scritte in
appena novanta giorni (media di quasi 60 al giorno, sabati e domeniche compresi)
dal giudice Alfredo Montalto per sancire che lo Stato scese a patti con la
mafia: la sentenza del processo di Palermo è un documento colossale, che nessun
cronista ha ancora letto per intero, ma il cui obiettivo appare chiaro. Perché
gli imputati per la Corte d'assise sono tutti colpevoli (tranne l'ex ministro
Mannino) ma ancor più colpevole è un signore che imputato non era, e che si
chiama Silvio Berlusconi. È lui il coimputato di pietra, la figura che aleggia
su tutte le 5.252 pagine, evocato come terminale e referente ultimo del patto
scellerato. Eh sì, perché della presunta trattativa tra Cosa Nostra e pezzi
delle istituzioni, avviata secondo i giudici all'epoca del governo di Giuliano
Amato, la sentenza non indica alcun vantaggio concreto di cui i mafiosi
avrebbero goduto né all'epoca del governo Amato né di quello - succedutogli
nell'aprile 1993 - di Carlo Azeglio Ciampi. Il favore postumo ai boss sarebbe
stato ovviamente promesso dal governo Berlusconi, salito al potere nel maggio
1994. Fino al dicembre 1994, scrive la sentenza, Marcello Dell'Utri incontrava
Vittorio Mangano «per le problematiche relative alle iniziative che i mafiosi si
attendevano dal governo». La sentenza, citando il pentito Gaspare Spatuzza, dice
che Dell'Utri avrebbe informato Mangano di una imminente modifica legislativa in
materia di arresti per mafia. «Ciò dimostra che Dell'Utri informava Berlusconi
dei suoi rapporti con i clan anche dopo l'insediamento del governo da lui
presieduto, perché solo Berlusconi da premier avrebbe potuto autorizzare un
intervento legislativo come quello tentato e riferirne a Dell'Utri per
tranquillizzare i suoi interlocutori». Il percorso logico è già di per se
piuttosto ardito: si prende per certo ciò che dice lo stragista Spatuzza, e se
ne deduce che se Dell'Utri parlava di modifiche legislative il mandante poteva
essere solo Berlusconi. Ci si aspetterebbe che a questo teorema inquietante la
sentenza indichi un qualche riscontro anche labile, una legge o almeno un
disegno di legge, un progetto, una dichiarazione d'intenti, insomma una traccia
qualunque che confermi che in quel periodo ben determinato di tempo - tra maggio
e dicembre 1994 - il governo abbia almeno ipotizzato un intervento legislativo
di alleggerimento sul trattamento dei mafiosi. Invece di quel riscontro non c'è
traccia, per il semplice motivo che nulla accadde. Anzi, negli otto mesi del
primo governo Berlsconi finiscono in galera cento boss mafiosi. Ed è ancora con
Berlusconi al governo, nell'aprile 2006, che viene arrestato Bernardo
Provenzano, che la Procura di Palermo indica come il terminale ultimo della
trattativa, e che morirà in carcere tredici anni dopo. Un affarone, per i clan,
la trattativa con Berlusconi. Spatuzza insomma parla a vanvera, almeno in questo
caso. Ma per i giudici palermitani è credibile come lo è l'altro testimone
chiave, Giovanni Brusca, il capo del commando di Capaci, che pure in aula ha
detto cose senza capo né coda. Ma il capolavoro vero, nella sentenza-kolossal, è
quando si teorizza - sfidando ogni logica - che la trattativa abbia causato o
almeno anticipato la strage di via D'Amelio e la morte di Paolo Borsellino. Non
c'è scritto, nella sentenza, che il vero colpevole della morte di Borsellino è
Berlusconi. Ma il concetto è quello.
Il Tempo, la prima pagina epocale per Silvio Berlusconi: adesso
basta, il titolo cubitale, scrive il 21 Luglio 2018
Libero Quotidiano”. Una reazione d'orgoglio, nel silenzio generale. "Siamo tutti
Berlusconi". Così il Tempo, in prima pagina, titola a caratteri cubitali. Un
sostegno al Cav nella settimana più dura, quella che riassume le accuse di 25
anni di fango con il video rubato delle serate con le olgettine e le motivazioni
della sentenza sulla trattativa Stato-Mafia pubblicate a poche ore di distanza
l'uno dalle altre. "Dalla pedofilia alle stragi - scrive il Tempo -, non se ne
può più". Per questo il quotidiano romano smonta punto per punto tutti gli
attacchi all'ex premier.
SIAMO TUTTI BERLUSCONI. Dalla pedofilia
alle stragi, 25 anni di fango. Ora pure il video con le Olgettine. Non se ne può
più nemmeno della Trattativa: Il Tempo smonta le accuse al Cav, scrive Luca
Rocca il 21 Luglio 2018 su “Il Tempo”. Non è provato che Marcello Dell’Utri
abbia «minacciato» Silvio Berlusconi, però Dell’Utri è ugualmente colpevole
perché, ipoteticamente, potrebbe averlo fatto. Sta tutto qui il fallace
ragionamento della Corte d’Assise di Palermo che due giorni fa ha depositato le
motivazioni alla sentenza del processo sulla «trattativa» Stato-mafia; sta
tutto, dunque, nell’ammissione dell’assenza della «prova regina», che pure si
tenta di scavalcare con quelle che il giudice Alfredo Montalto chiama «ragioni
logico-fattuali». La tesi della procura di Palermo, accolta dai giudici, è
chiara: verso la fine del 1993, i boss Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca
avrebbero contattato Vittorio Mangano, stalliere di Arcore negli anni ’70,
chiedendogli di riferire a Dell’Utri che, se non avessero ottenuto dei benefici
di legge, le stragi di mafia sarebbero riprese. E Dell’Utri, processato per
«minaccia a Corpo politico dello Stato», stando alle accuse avrebbe recapitato
quella minaccia a Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio dall’aprile al
dicembre del 1994. Ma, come detto, la Corte d’Assise di Palermo è costretta ad
ammettere che questo assunto non è dimostrato, tanto da scrivere che «se pure
non vi è prova diretta dell’inoltro della minaccia mafiosa da Dell’Utri a
Berlusconi, perché solo loro sanno i contenuti dei loro colloqui, ci sono
ragioni logico-fattuali che inducono a non dubitare che Dell’Utri abbia riferito
a Berlusconi quanto di volta in volta emergeva dai suoi rapporti con
l’associazione mafiosa Cosa nostra mediati da Vittorio Mangano». La prova non
c’è, dunque, ma non potendosi escludere che da qualche parte ci sia, si condanna
ugualmente Dell’Utri a 12 anni di galera. I giudici, poi, sottolineano che la
disponibilità dell’ex senatore a porsi come intermediario tra i clan e
Berlusconi fornì «le premesse della rinnovazione della minaccia al governo
quando, dopo il maggio del 1994, questo sarebbe stato appunto presieduto dallo
stesso Berlusconi». In questo senso si ritiene provata, dunque, la teoria della
«cinghia di trasmissione» della minaccia di Cosa nostra all’ex premier. Ma
davvero quella «filiera» sarebbe dimostrata? I fatti dicono il contrario.
Intanto, Brusca ha affermato di aver saputo della permanenza di Mangano ad
Arcore, fatto notorio in mezza Sicilia, leggendo l’Espresso. Il pentito,
inoltre, ha collocato l’incontro in cui avrebbe chiesto a Mangano di riprendere
i rapporti con Dell’Utri nell’aprile del 1994, sostenendo di aver ricevuto una
risposta pochi giorni dopo. Peccato che quando si trattò di precisare il momento
esatto, lo associò a un furto di vitelli avvenuto a Partinico nel novembre del
1993. In sostanza, a voler dar retta al capo mandamento di San Giuseppe Jato,
l’incarico a Mangano di contattare Dell’Utri sarebbe avvenuto nell’aprile del
1994 e la risposta...cinque mesi prima...
L’ardua verità del patto. Il compito
più duro per gli storici sarà quello di far quadrare la memoria «politica» di
ciò che accadde nel 1992-94 con le incongruenze di quella «giudiziaria», scrive
Paolo Mieli il 23 luglio 2018 su "Il Corriere della Sera". Prima di archiviare
l’ennesimo giudizio (stavolta di primo grado) sulla trattativa Stato-mafia, è
opportuno mettere agli atti qualche considerazione. Fortunati gli storici del
futuro i quali, per quel che attiene ai rapporti tra vertici istituzionali
italiani e Cosa nostra, avranno a disposizione sentenze, le più varie, al cui
interno potranno trovare pezze d’appoggio a qualsiasi congettura li abbia
precedentemente affascinati. Ad esser baciati dalla fortuna saranno, beninteso,
solo gli storici disinvolti. Per gli altri — quelli seri che non cercano
riscontri a ciò che avevano già «intuito» ma, anzi, si impegnano, con metodo, ad
individuare elementi di contraddizione con le proprie ipotesi di partenza —
saranno dolori. Perché la magistratura, allorché si è occupata di vicende
nazional-siciliane, ha da tempo accantonato la terraferma che dovrebbe esserle
propria, quella del «sì sì, no no», per immergersi nell’immensa palude del «dico
e non dico», delle circonlocuzioni ipotetiche, delle allusioni non esplicite,
delle porte né aperte né chiuse, dei verdetti double face. Gli imputati
eccellenti in genere sono usciti indenni dai giudizi definitivi. Ma tali giudizi
definitivi non lo sono mai per davvero perché, nei tempi successivi ad ogni
sentenza, nuovi processi sono tornati (e torneranno) ad occuparsi delle stesse
vicende, talché qualche macchia inevitabilmente resterà sugli abiti dei suddetti
imputati. Anche nel caso in cui siano stati assolti dall’ultima sentenza prima
del loro decesso. Ma il compito più arduo per gli storici sarà quello di far
quadrare la memoria «politica» di ciò che accadde tra il 1992 e il 1994 con le
incongruenze di quella «giudiziaria». Per la memoria politica si ebbero in quel
biennio (allungatosi poi al 1995) due stagioni tra loro assai diverse. La prima
— dal ’92 ai primi mesi del ’94, sotto la regia dell’allora presidente della
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro — fu in terremotata continuità con la cosiddetta
Prima Repubblica e conobbe due capi di governo di sinistra moderata: Giuliano
Amato e Carlo Azeglio Ciampi. È in questo biennio che, mentre la vita
parlamentare veniva sconvolta da Tangentopoli, si verificarono i più rilevanti
fatti di sangue riconducibili alla mafia: l’uccisione di Falcone e Borsellino
(’92), gli attentati di via Fauro a Roma, di via dei Georgofili a Firenze, di
via Palestro a Milano oltreché alle basiliche romane di San Giovanni e San
Giorgio al Velabro, i quali provocarono complessivamente 15 morti e decine di
feriti (’93). Ed è proprio in questo periodo che, stando alla sentenza appena
depositata, tre carabinieri di medio-alto rango, Mario Mori, Antonio Subranni e
Giuseppe De Donno, con la mediazione dell’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino,
avrebbero preso contatto con il vertice di Cosa Nostra (Totò Riina) provocando
un’«accelerazione» dell’azione criminosa. A nome di chi si sarebbero mossi Mori,
Subranni e De Donno? La sentenza non lo dice in modo esplicito ma lascia
intendere che esponenti del governo Ciampi abbiano avallato l’iniziativa dei tre
magari, come ha già fatto notare su queste pagine Giovanni Bianconi, senza
averne una effettiva «consapevolezza». Sarà arduo per gli storici del futuro
dare conto dell’attività di questa nutrita schiera di «inconsapevoli» che da
Scalfaro in giù si attivarono per quasi due anni a favorire l’«improvvida
iniziativa» di Mori arrivando nell’autunno 1993 a «liberare dal 41 bis», per
decisione del ministro della Difesa Giovanni Conso, 334 mafiosi. Mafiosi che
forse non erano di primissimo piano ma la cui uscita dal carcere duro fu —
secondo i magistrati — un segnale a Cosa nostra dei passi avanti compiuti,
appunto, dalla trattativa di cui si è detto. Dopodiché venne una seconda
stagione, più breve (otto mesi tra il 1994 e il gennaio ‘95), in cui dominus
politico fu Silvio Berlusconi alla sua prima esperienza di governo. Berlusconi,
tramite Marcello Dell’Utri, avrebbe proseguito, intensificandola,
l’interlocuzione con Cosa nostra avviata dai suoi predecessori. Strano: la
memoria politica ci dice che tra Scalfaro e Berlusconi i rapporti furono pessimi
e lo stesso discorso vale, anche se con minore intensità, per presidenti del
Consiglio e ministri dei governi della legislatura ’92-’94: tutti, nessuno
escluso, ostili a Berlusconi e Bossi. Marco Taradash ha fatto notare che l’unico
campo in cui — stando alla sentenza — ci sarebbe stata un’assoluta opaca
continuità tra la stagione dominata da Scalfaro e quella successiva di
Berlusconi sarebbe stato il terreno dei patteggiamenti tra lo Stato italiano e
Cosa nostra. Per i giudici questo non è un problema ma per gli storici lo sarà
quando dovranno spiegare come mai le due Italie, quella berlusconiana e quella
antiberlusconiana, si scontrarono su tutto tranne che sul rapporto con Riina e i
suoi successori sul quale l’intesa fu pressoché totale. E come mai queste
diaboliche relazioni siano iniziate ai tempi dell’ultimo centrosinistra quando
la «discesa in campo» di Berlusconi era (forse) solo nei propositi del padrone
della Fininvest. La sentenza lascia intendere — ma è un’interpretazione nostra —
che ci sarebbe stato un salto dalla stagione della «inconsapevolezza» a quella
della «consapevolezza», quando Berlusconi sarebbe stato informato da Dell’Utri
(che aveva nello «stalliere» Vittorio Mangano il trait d’union con Cosa nostra)
di ogni passaggio della trattativa, trattativa alla quale avrebbe dato
incremento con specifici atti di governo. Prendiamo per buona questa tesi. C’è
però un particolare di cui si è accorto Marco Travaglio che è destinato a
complicare il lavoro degli storici. Di che si tratta? Procediamo con ordine:
nell’estate del ’94 (13 luglio) ci fu il decreto del ministro della Giustizia
berlusconiano Alfredo Biondi, che avrebbe dovuto porre un argine agli arresti
dei corrotti, ma anche favorire i mafiosi. Quasi tutti i giornali si accorsero
della parte che riguardava gli imputati di Mani Pulite talché quel pacchetto di
norme fu ribattezzato «decreto salvaladri». Il capo del pool giudiziario
milanese, Francesco Saverio Borrelli, fece caso al fatto che il decreto Biondi
fosse stato approvato all’unanimità (e subito controfirmato da Scalfaro) mentre
ai mondiali di calcio era in corso una partita contro la Bulgaria (vinta
dall’Italia): il magistrato ironizzò sulla circostanza che il governo volesse
nascondere quel suo atto di considerevole rilievo «dietro un pallone». Subito
dopo i pm di Milano Antonio Di Pietro, Piercamillo Davigo, Francesco Greco e
Gherardo Colombo protestarono a gran voce e chiesero pubblicamente di essere
assegnati «ad altro e diverso incarico». Al che il ministro dell’Interno
leghista Roberto Maroni «scoprì» che il testo del dispositivo era diverso da
quello approvato in Consiglio dei ministri e nel giro di poche ore Berlusconi fu
costretto a ritirare il decreto. Passarono pochi mesi, a fine anno il governo
cadde e, con quello che fu definito un «ribaltone», venne sostituito da un nuovo
gabinetto guidato da Lamberto Dini, ex titolare berlusconiano del Tesoro, futuro
ministro del centrosinistra. Il tutto ancora una volta sotto la regia di
Scalfaro. E qui veniamo al punto messo in evidenza dal direttore del Fatto: nel
1995, quella norma del decreto Biondi riguardante i mafiosi (solo quella) fu
entusiasticamente votata dalle due Camere ai primi di agosto, quando Scalfaro,
dopo aver negato a Berlusconi le elezioni anticipate, aveva ripreso in mano le
redini dell’intera politica italiana. E fu approvata, sottolinea Travaglio,
«grazie al fondamentale apporto del centrosinistra». E nel silenzio, aggiungiamo
noi, di tutta (o quasi) la società civile che si era ribellata al «salvaladri».
Tutti di nuovo «inconsapevoli»? Curiosa coda della «trattativa»… È facile per i
giudici collocare una tale bizzarra successione di eventi sullo sfondo sfocato
della loro ricostruzione. Ma sarà problematico per gli studiosi di storia dar
conto in maniera rigorosa e ad un tempo plausibile di come in quei mari in
tempesta l’unica imbarcazione che riuscì a navigare tranquilla, trovando sponde
compiacenti sia sul versante del centrodestra che su quello antiberlusconiano,
sia stata la zattera, non priva di falle, del generale trattativista.
La farsa di Palermo, scrive Piero
Sansonetti il 20 gennaio 2018 su "Il Dubbio". La grande stampa nazionale ha
deciso di risolvere il problema tacendo, o scrivendo solo qualche riga. Un po’
per pudore, un po’ probabilmente per imbarazzo. Come si fa a riferire delle
fantasiosissime requisitorie che in questi giorni vengono pronunciate al
processo di Palermo – quello sulla trattativa stato mafia – senza riderne un po’
o senza chiedersi come sia possibile che nella solennità di un aula di tribunale
vengano lanciate accuse folli, e senza il briciolo di un briciolo di un briciolo
di prova, verso personaggi che hanno avuto una grande rilievo nella storia
recente dell’Italia? Non sembra più neanche un processo, sembra la ribalta di
uno spettacolo trash, dove tutti tirano palle di fango. Perciò la maggior parte
dei direttori ha deciso di glissare. Perché le possibilità sono solo due: o fai
finta di niente, vista la assoluta inattendibilità delle cose che vengono dette;
oppure t’indigni e chiedi che qualcuno intervenga. Purtroppo, a occhio e croce,
nessuno è in grado di intervenire. E così ieri abbiamo sentito un Pm dire che
Riina è stato venduto da Provenzano agli inquirenti. In particolare al generale
Mori e probabilmente al capitano Ultimo, che lo catturò. Il Pm ha detto che la
cattura di Riina è stata una vergogna per l’Italia. E ha finito per mettere sul
banco degli imputati i giudici, che hanno già ampiamente assolto Mori da questa
accusa, e anche l’ex procuratore di Palermo Caselli, che ancora recentemente ha
sostenuto che la cattura di Riina è stata la salvezza per il paese. Poi i Pm
hanno indicato l’ex presidente della Repubblica Scalfaro come responsabile, a
occhio e croce, del reato di alto tradimento. E con lui il ministro Conso, il
ministro Mancino e qualcun altro. Indizi? Prove? No: «Fidatevi di noi». Davvero
non c’è nessuna possibilità che qualche autorità intervenga, interrompa questo
scempio della storia e del diritto, e disponga, se serve, anche un po’ di aiuto
psicologico per i Pm?
Il processo Stato-mafia finisce in farsa, scrive Piero Sansonetti il 27 gennaio
2018 su "Il Dubbio". Il pm Di Matteo chiede sei anni di galera per Mancino, 12
per Dell’Utri, 15 per il generale Mori e zero per il boss Brusca. Se volete
leggere questo articolo dovete mettervi nello stato d’animo di chi non si
stupisce di niente. Altrimenti lasciate stare. I Pm del processo di Palermo (il
famoso processo sulla presunta trattativa Statomafia) hanno chiesto una
novantina d’anni di galera per alcuni degli imputati. Tra i quali un paio di
mafiosi e una decina tra esponenti della politica e dell’arma dei carabinieri.
Cinque anni li hanno chiesti per il giovane Ciancimino, Massimo, figlio di Vito
(ex famigerato sindaco di Palermo), accusato di calunnia contro gli altri
imputati. La sua testimonianza, giudicata calunniosa, è in realtà l’unico
puntello alle tesi dell’accusa (ma questa cosa naturalmente fa un po’ sorridere,
o sobbalzare, l’osservatore poco informato – non è l’unico non sense prodotto
dal processo). Poi hanno chiesto 15 anni per il generale Mori, 12 per Marcello
Dell’Utri e 6 per l’ex presidente del Senato Nicola Mancino. Non hanno potuto
chiedere anni di galera per l’ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi
Scalfaro, perché nel frattempo è morto, ma nelle loro requisitorie lo hanno più
volte indicato come il capintesta di tutta la congiura. Naturalmente è molto
complicato qui dirvi di quale congiura si tratti. Perché i Pm ne hanno delineate
almeno un paio e tra loro in netta contraddizione. Basta dire che al vertice del
gruppo criminale, secondo le requisitorie, ci sarebbero stati lo stesso Scalfaro
e Berlusconi. Capite? Scalfaro e Berlusconi, cioè i due personaggi più lontani
tra loro di tutto lo scenario politico degli anni novanta. Del resto i Pm hanno
mostrato una conoscenza molto superficiale di quello scenario politico, e dunque
non c’è molto da stupirsi che possano confondere la sinistra Dc con Forza Italia
e cose del genere. Tuttavia l’aspetto più preoccupante di questa vicenda non sta
neanche nelle richieste cervellotiche, o nell’osservazione che non c’è uno
straccio di prova a carico degli imputati, e neppure nel fatto che si chiedano
pene per delitti che altri processi (a Mori stesso, all’on Calogero Mannino e ad
altri) hanno già accertato non esistere. L’aspetto più preoccupante è
l’impostazione dell’accusa. Leggete qui con quali parole il Pm Di Matteo (che
ora è diventato uno dei procuratori nazionali antimafia) ha spiegato il senso
del processo: «Questo è un processo che punta a scoprire livelli più alti e
causali più complesse. Legati non a un fatto criminoso ma a una strategia più
ampia».
Che vuol dire? Vuol dire che i Pm di Palermo (o quantomeno Di Matteo, non
sappiamo se gli altri si dissociano da questa idea) ritiene che il suo compito
non sia quello di perseguire i reati ma di stabilire, con la sua autorità, la
verità storica, e poi di sanzionare questa verità con delle esemplari punizioni.
In questo modo Di Matteo aggira l’ostacolo principale di questo processo, e cioè
il fatto che non c’è uno straccio di prova dei reati contestati agli imputati.
Dice Di Matteo, in sostanza: «E che io devo stare lì col misurino a vedere se
c’è qualche reato? Io sto più in alto: a me interessano le grandi strategie».
Per dirla con parole ancora più semplici, il Pm dichiara in modo esplicito che
quello di Palermo non è un processo penale ma un processo politico. Veniamo al
merito della vicenda. Dunque, questo è un processo che è stato avviato dieci
anni fa, il dibattimento va avanti da cinque anni, si riferisce ad avvenimenti
di 26 anni fa, nessuno è in grado di stabilire quanto sia costato ai
contribuenti. La tesi dell’accusa è che quando la mafia, all’inizio degli anni
novanta, alzò il tiro sullo Stato, compiendo stragi, uccidendo magistrati,
leader politici e comuni cittadini, ci fu un pezzo dello Stato (pezzo di
governo, pezzo dei carabinieri e pezzo dei servizi segreti) che si adoperò per
cercare di frenare queste stragi, ed evitare nuovi morti, trattando con i
vertici mafiosi. Scambiò la fine delle stragi con alcuni benefici carcerari,
compresa l’abolizione del 41 bis. Il punto però è che non esiste nessun indizio
che questa trattativa ci fu. Anche perché nei processi paralleli a questo di Di
Matteo e degli altri Pm palermitani, sono piovute assoluzioni. Il generale Mori,
ad esempio, è stato già dichiarato innocente. E così Calogero Mannino, ex
ministro, che fin qui è l’unico rappresentante del governo che è stato accusato
di aver trattato.
Ora uno si chiede: ma se noi sappiamo che non trattò il governo, non trattarono
i servizi segreti, non trattarono i carabinieri, ma che diavolo di trattativa
fu? E poi sappiamo anche che nessuno dei benefici indicati dagli accusatori fu
concesso. Mancano i protagonisti del reato e manca il bottino. Voi capite che
sembra una commedia surreale. Ma è più surreale ancora perché assieme all’accusa
verso lo Stato (e fondamentalmente verso la sinistra Dc) di avere trattato con
la mafia, c’è anche l’accusa a Dell’Utri (e quindi a Berlusconi) di avere fatto
la stessa cosa, ma, sembrerebbe, con un intento opposto. Perché l’accusa
immagina i berlusconiani che trattano con la mafia per destabilizzare la Dc, la
quale intanto tratta con la mafia per stabilizzare. C’è da diventare pazzi.
Sembra una farsa. Una farsa, però, fino a un certo punto. Oltre il quale diventa
davvero un dramma. E un po’ indigna. Indigna per esempio il modo nel quale è
stato trattato l’ex presidente del Senato. Nessuno al mondo riesce a capire di
cosa sia accusato Nicola Mancino, 86 anni, prestigiosissimo leader
democristiano, più volte ministro, ex presidente del Senato. Dicono che non si
ricordi di un incontro che forse ha avuto con il magistrato Borsellino, prima
che Borsellino fosse ucciso dalla mafia, e che non si ricordi nemmeno di una
telefonata di Claudio Martelli, che l’avrebbe messo in guardia su alcuni
comportamenti dei Ros che non lo convincevano. Embé?
Si tratta di cose avvenute un quarto di secolo fa. E nessuno sa se l’incontro e
la telefonata ci furono oppure no. E comunque, anche se ci furono, furono
episodi normalissimi che non c’è nessun bisogno di nascondere. Eppure i
magistrati chiedono che Mancino trascorra sei anni in carcere. Qui c’è poco da
scherzare. C’è da avere seriamente paura. Qualche Pm una mattina si sveglia e ha
il potere, sulla base di nulla, di riempire di fango un padre della democrazia
italiana, e di chiedere, con arroganza, che sia sbattuto in carcere. E per di
più questo Pm confessa bellamente che lui non cerca reati, ma “strategie più
complessive”. Siamo sicuri che non esistano le condizioni per intervenire, da
parte delle istituzioni? Sicuri che sia giusto che un magistrato rivendichi che
la sua funzione non è quella di accertare i reati ma quella di processare la
politica seguendo sue idee e teorie? Diceva Piero Calamandrei: «Non spetta alle
toghe giudicare la storia di un paese». Già, Calamandrei. Chissà se i Pm di
Palermo conoscono il nome di Calamandrei. Certo che se Calamandrei avesse
conosciuto i Pm di Palermo, sarebbe inorridito…
Trattativa Stato-mafia, i pm: "Provenzano vendette Riina ai carabinieri". A
ripercorrere l'arresto del padrino, finito in manette dopo decenni di latitanza
il 15 gennaio del 1993, è Vittorio Teresi, scrive il 19 gennaio 2018 "La
Repubblica". "L'arresto di Riina fu frutto di un compromesso vergognoso che
certamente era noto ad alcuni ufficiali del Ros come Mori e de Donno, fu frutto
di un progetto tenuto nascosto a quegli esponenti delle istituzioni e quei
magistrati che credevano invece nella fermezza dell'azione dello Stato contro
Cosa nostra". La cattura del boss corleonese Totò Riina come snodo della seconda
fase della trattativa tra parte delle istituzioni e la mafia è al centro
dell'udienza odierna del processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia,
dedicata alla prosecuzione della requisitoria dei pubblici ministeri Nino Di
Matteo, Roberto Tartaglia, Francesco Del Bene e Vittorio Teresi. A ripercorrere
l'arresto del padrino, finito in manette dopo decenni di latitanza il 15 gennaio
del 1993, è il pm Teresi certo, secondo quanto prospetta l'ipotesi accusatoria,
che Riina venne "consegnato" ai carabinieri dall'ala di Cosa nostra vicina a
Bernardo Provenzano. Riina, con cui i militari del Ros imputati al processo
avevano intavolato un dialogo finalizzato a far cessare le stragi, era ritenuto
un "interlocutore" troppo intransigente. Perciò gli si sarebbe preferito
Provenzano, fautore della linea della sommersione, e lontano dall'idea del
"papello", l'ultimatum che Riina avrebbe presentato allo Stato tramite i
carabinieri. Provenzano dunque, dopo le stragi del '92, sarebbe entrato in gioco
e avrebbe consentito la cattura del compaesano con la complicità del Ros
pretendendo, tra l'altro, che il covo del capomafia "venduto" non fosse
perquisito. "Era chiaro che tutto questo doveva essere tenuto segreto - ha
spiegato Teresi - E dopo la cattura di Riina e l'uscita di scena anche di
Ciancimino le linee dell'accordo sono chiare e si passa ai fatti". "Così come
per i carabinieri è fondamentale mantenere il segreto sulla cattura di Riina -
ha aggiunto il magistrato - altrettanto è importante, per la mafia, che nulla
trapeli sul fatto". La Procura descrive uno Stato diviso in due: da una parte
pezzi delle istituzioni pronti a trattare dopo gli attentati a Falcone e
Borsellino per "paura e incompetenza", dall'altra un "manipolo" di uomini come
l'ex Guardasigilli Claudio Martelli e l'ex capo del Dap Nicolò Amato, convinti
che si dovesse mantenere la linea dura contro Cosa nostra. I timori e
l'incapacità di far fronte all'emergenza dunque avrebbero portato alcuni
rappresentanti delle istituzioni a piegarsi al ricatto nell'illusione che alcuni
cedimenti, come ad esempio, una attenuazione all'odiato 41 bis, potesse far
cessare le bombe mafiose. "Non si comprese, ha detto il pm, che la mafia avrebbe
letto tutto questo come il segno che si poteva rilanciare come avvenne con gli
attentati nel Continente e trattare ancora per ricevere altri benefici". Teresi
ha ricostruito tutta la parte dell'impianto accusatorio relativa alle
concessioni fatte dallo Stato a Cosa nostra, nel 1993, sulla politica
carceraria: dalla sostituzione dei vertici del Dap, come Amato, ritenuto troppo
duro e allontanato senza preavviso dal suo incarico, alla revoca del 41 bis
nelle carceri di Poggioreale e Secondigliano a febbraio del 1993, alla nomina al
ministero della Giustizia di Giovanni Conso che prese il posto di Claudio
Martelli, il politico che, dopo le stragi del '92, aveva istituito il regime
carcerario duro per i mafiosi. E ha fatto nomi e cognomi di chi "per paura o
incompetenza" avrebbe avallato la politica della distensione: l'ex capo dello
Stato Oscar Luigi Scalfaro, l'ex Guardasigilli Giovanni Conso, Aldalberto
Capriotti, subentrato ad Amato al Dap e il suo vice Francesco Di Maggio. Sullo
sfondo, nella ipotesi dell'accusa, restano entità non precisate che avrebbero
consigliato a Cosa nostra la strategia da seguire. "Centri occulti che hanno
suggerito alla mafia cosa fare per indurre lo Stato a cedere. Ci fu
un'intelligenza esterna che ha orientato i comportamenti di Cosa nostra e si è
fatta comprimario occulto dell'azione mafiosa riuscendo ad agire indisturbata
perché poteva confidare nella linea della distensione scelta da pezzi delle
istituzioni". "Se avesse prevalso la durezza - ha aggiunto il magistrato -
nessuno spazio ci sarebbe stato per un dialogo che ha invece rafforzato la mafia
e la sua azione terroristica. Se avesse prevalso la durezza, i consiglieri dei
mafiosi sarebbero stati individuati e assicurati alla giustizia, ma nel clima di
compromesso che ci fu, tutto si è confuso".
Trattativa Stato-mafia: condannati Mori, Dell'Utri e Ciancimino.
Assolto Mancino. Dopo la morte del capomafia Totò
Riina, erano 9 gli imputati: condannati gli ex vertici del Ros Mario Mori,
Giuseppe De Donno e Antonio Subranni, l'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri, i
boss Leoluca Bagarella e Nino Cinà, scrive Felice Cavallaro il 20 aprile 2018 su
"Il Corriere della Sera". Per dire che il processo sulla «trattativa
Stato-mafia» era sbagliato, definendo un errore il riferimento al reato di
«minaccia a corpo politico dello Stato», erano scesi in campo giuristi di gran
fama, a cominciare dal professore Giovanni Fiandaca, il cattedratico di Palermo
con il quale studiò e si laureò l’ex pm Antonio Ingroia. E invece la corte di
assise presieduta da Alfredo Montalto, confermando la tesi dell’accusa, ha
condannato a pene severissime sia Marcello Dell’Utri, uno dei fondatori di Forza
Italia indicato come gran manovratore della presunta trattativa nel ’94 con il
governo Berlusconi, sia i vertici del Ros, gli ufficiali dei carabinieri
ritenuti responsabili di sotterranee intese a cavallo delle grandi stragi
sfociate nei massacri di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle loro scorte.
Dell’Utri gran manovratore. Una pagina di storia che grazia l’ex presidente del
Senato Nicola Mancino, assolto dal sospetto di una falsa testimonianza, e si
rovescia invece su boss e apparati investigativi. Scomparsi Totò Riina e
Bernardo Provenzano, scattata la prescrizione per il pentito Giovanni Brusca, la
responsabilità della trama e della stagione di sangue viene attribuita con una
pena di 28 anni di carcere soprattutto al cognato di Riina, lo stragista
Leolucua Bagarella già in cella, e al boss Antonino Cinà, 12 anni. Ma ad
alimentare polemiche sul piano giudiziario e politico è il verdetto che si
abbatte sui destini degli ex generali del Ros Mario Mori e Antonio Subranni,
condannati a 12 anni di reclusione come Dell’Utri, ritenuto il trait d’union fra
politica, mafia e apparati, già in cella per un altro processo. Durissima la
Corte anche con l’ex colonnello Giuseppe De Donno, otto anni. Stessa pena
attribuita a Massimo Ciancimino, il superteste del processo, il rampollo dell’ex
sindaco mafioso che con le sue rivelazioni consentì alla Procura di riaprire le
indagini, a sua volta accusato di calunnia nei confronti dell’ex capo della
polizia Gianni De Gennaro. Ciancimino jr. può però tirare un sospiro di sollievo
perché assolto dall’accusa di associazione mafiosa.
Lo sconforto dei carabinieri. Bisognerà leggere le motivazioni di questa
sentenza che arriva dopo 5 anni e sei mesi di processo, ma alla evidente euforia
dei magistrati, a cominciare da quella di Nino Di Matteo che rilevò la
sostanziale guida del dibattimento dopo la corsa di Ingroia verso la politica,
corrisponde la delusione di Mori, De Donno e Subranni. A cominciare da
quest’ultimo, anziano e malato: «Andremo avanti, in appello, per contestare una
sentenza ingiusta. Le responsabilità che ci attribuiscono non sono state affatto
commesse. Ma non posso dire niente, senza leggere le motivazioni...». Dello
stesso tono l’amarezza del generale Mori confidata al legale dei tre ufficiali,
Basilio Milio, che a sua volta parla di «grande sconforto e sbigottimento»,
certo però che «la verità è dalla nostra parte». E ai suoi assistiti concede un
barlume di fiducia: «Possiamo sperare che finalmente, dopo 5 anni, in appello vi
sarà un giudizio. Perché questo è stato un pregiudizio caratterizzato
dall’adesione alle istanze della Procura e quasi mai della difesa. Una sentenza
dura che non sta né in cielo né in terra perché questi fatti sono stati già
smentiti da quattro sentenze definitive».
I supporter di Nino di Matteo. Di opposto parere i cinquanta supporter dei pm
raccolti davanti all’aula bunker del carcere Pagliarelli dalle associazioni
Agende rosse e Scorta civica, fra grandi applausi per i pm Francesco Del Bene,
Roberto Tartaglia e Vittorio Teresi e Nino Di Matteo. Con quest’ultimo incisivo
e solenne: «Che la trattativa ci fosse stata non occorreva che lo dicesse questa
sentenza. Ciò che emerge oggi e che viene sancito è che pezzi dello Stato si
sono fatti tramite delle richieste della mafia. Mentre saltavano in aria
giudici, secondo la sentenza, qualcuno nello Stato aiutava Cosa nostra a cercare
di ottenere i risultati che Riina e gli altri boss chiedevano. Qualcuno dello
Stato ha trattato con Riina e Bagarella e altri stragisti, trasmettendo le
richieste, i messaggi di Cosa nostra ai governi. Prima si era messa in
correlazione Cosa nostra con il Silvio Berlusconi imprenditore, adesso questa
sentenza per la prima volta la mette in correlazione col Berlusconi politico. Le
minacce subite attraverso Dell’Utri non risulta che il governo Berlusconi le
abbia mai denunciate e Dell’Utri aveva veicolato tutto. Ecco perché è una
sentenza storica». Una ragione in più perché il meno giovane dei pm, Teresi,
affondi con un commento lapidario: «Questo processo e questa sentenza sono
dedicati a Paolo Borsellino, a Giovanni Falcone e a tutte le vittime innocenti
della mafia».
Fiandaca e l’accusa sbagliata. La sentenza spiazza uno dei maestri dei pm
palermitani, appunto il professore Fiandaca: «Mi aspettavo un esito assolutorio
per la difficoltà tecnica di configurare il reato di ‘minaccia a corpo politico
dello Stato’, il reato previsto dall’articolo 338 del codice penale. La sua
applicazione agli occhi di un giurista di professione -e non sono soltanto io a
pensarlo- è sbagliata sotto il profilo di una interpretazione sistematica...».
Ed ancora: «La questione è abbastanza tecnica e probabilmente una corte di
assise in cui sono presenti i giudici popolari, di solito non molto esperti di
diritto, non è la sede più adatta per approfondire questioni di questo tipo...
Ma comprendo che il problema era la rilevanza penale della trattativa. E la
linea della procura ha vinto, pur persistendo le mie riserve di giurista,
convinto che la materia offrirà spunti di riflessione in appello e in
Cassazione».
Graziano Nicola Mancino. Come dire che, a un quarto di secolo dai fatti e dopo
cinque anni di processo, ci vorrà ancora tempo per un definitivo accertamento
della verità giudiziaria. Non per l’unico assolto, Nicola Mancino, coinvolto
anche per le sospette telefonate al Quirinale durante la presidenza di Giorgio
Napolitano. Rilassato, ma segnato dalle accuse l’ex presidente del Senato:
«Relegato per anni in un angolo, posso ora dire di non aver atteso invano. Ma
che sofferenza...». Poi una riflessione più generale su questi anni: «Ho sempre
avuto fiducia che a Palermo ci fosse un giudice. La lettura del dispositivo che
esclude la mia responsabilità nel processo sulla cosiddetta trattativa ne è una
solenne conferma. Sono stato vittima di un teorema che doveva mortificare lo
Stato e un suo uomo, che tale è stato ed è tuttora...».
Sistemi criminali. Caso Mancino a parte, lo Stato non ne esce bene ed è come se
riprendesse forma la vecchia inchiesta sui “sistemi criminali” avviata tanti
anni fa dall’allora pm Roberto Scarpinato. Un’inchiesta che teorizzava un
presunto golpe che avrebbe visto protagonisti negli anni Novanta, in un
tentativo di destabilizzazione del Paese, Cosa nostra, massoneria deviata, pezzi
di Stato ed eversione nera. Indagine poi archiviata, ma fu allora che si
ipotizzò per la prima volta il reato oggi convalidato da una sentenza di primo
grado: la violenza o minaccia a corpo politico dello Stato.
Di Maio ringrazia. Immediati i riflessi politici di una sentenza non a caso
commentata con un twitter dal capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, da
sempre in contatto con Di Matteo: «La trattativa Stato-mafia c’è stata. Con le
condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai
magistrati di Palermo che hanno lavorato per la verità». Passeranno almeno un
paio di mesi per le motivazioni di una sentenza che condanna gli imputati anche
al risarcimento in solido dei danni in favore della parte civile della
Presidenza del consiglio dei ministri liquidati in 10 milioni di euro. Pagano
tutti. Tranne chi ha ha premuto il pulsante della strage di Capaci, Giovanni
Brusca, lo stesso che sciolse il piccolo Giuseppe di Matteo nell’acido, ormai
pentito. Un quadro complessivo che lascia zone d’ombra, oltre la verità
giudiziaria.
Trattativa Stato-mafia: gli attentati, gli ufficiali, il presunto
accordo con i boss. Ecco cos’è, dall’omicidio Lima a Ciancimino.
La mafia avrebbe alzato il tiro contro le istituzioni dopo la
sentenza definitiva sul maxiprocesso, lo Stato, per fermare l’ondata di sangue
avrebbe intavolato un dialogo segreto con i boss. Le fonti di prova (e i punti
deboli) del teorema, scrive Claudio Del Frate il 17 aprile 2018 su "Il Corriere
della Sera".
Personaggi e interpreti. Il processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia ha
fatto «ballare» politica e giustizia in Italia per una ventina d’anni. L’accusa
si è mossa sulla base di un «teorema» in base al quale di fronte all’offensiva
di Cosa Nostra che insanguinò l’Italia a partire dagli anni ‘90, lo Stato
avrebbe risposto cercando un accordo con i capi della mafia. Sul banco degli
imputati davanti alla Corte d’Assise di Palermo si sono trovati rappresentanti
delle istituzioni (gli ufficiali dei carabinieri Mario Mori, Antonio Subranni e
Giuseppe De Donno) , Marcello Dell’Utri e i capimafia Antonio Cinà, Leoluca
Bagarella e Giovanni Brusca. All’inizio delle udienze nel processo erano
accusati anche Totò Riina e Bernardo Provenzano, poi deceduti. Stralciata la
posizione degli ex ministri Calogero Mannino (nel frattempo assolto) e Nicola
Mancino (quest’ultimo accusato solo di falsa testimonianza).
La rottura: l’omicidio Lima. Il fatto da cui sarebbe scaturita la trattativa
viene fissato dai pm di Palermo nell’omicidio dell’europarlamentare Dc Salvo
Lima (marzo 1992): ritenuto contiguo ai clan, Lima agli occhi dei boss sarebbe
stato ucciso in quanto non più in grado di garantire i rapporti tra Cosa Nostra
e istituzioni. La frattura avviene in particolare dopo la sentenza definitiva
sul maxiprocesso di Palermo. Rotti questi equilibri, la mafia si sarebbe
vendicata alzando il tiro contro lo Stato. Tale strategia sarebbe passata
attraverso gli omicidi «eccellenti» di Falcone e Borsellino, gli attentati del
‘93 a Milano, Firenze e Roma, tutti attribuiti a Totò Riina e ai suoi complici.
Mannino diede il via alla trattativa? Sempre nel quadro «disegnato» dall’accusa,
il primo passo dello Stato verso la mafia viene compiuto da Calogero Mannino:
divenuto bersaglio di minacce l’indomani dell’omicidio Lima (gli viene
recapitata una corona funebre), l’esponente Dc contatta i vertici dei
carabinieri e questi ultimi avrebbero a loro volta avvicinato l’ex sindaco di
Palermo condannato per mafia Vito Ciancimino. Da qui si sarebbe dipanata la
trattativa i cui «segnali» sarebbero stati la revoca del carcere duro per oltre
300 condannati per mafia nel ‘93, la cattura di Riina («venduto ai carabinieri»
in cambio della latitanza per Provenzano), l’omicidio Borsellino (ucciso perché
contrario alla trattativa) e presunti incontri tra capimafia (ad esempio i
fratelli Graviano) ed esponenti della politica. E più avanti un abboccamento per
far convergere i voti di Cosa Nostra su Forza Italia attraverso Cinà e
Dell’Utri.
Il «papello» mai trovato. Cuore della trattativa sarebbe però il cosiddetto
«papello»: un documento fatto recapitare da Riina agli esponenti delle
istituzioni (attraverso i carabinieri) con una serie di richieste. Tra esse ci
sarebbero state l’abolizione del carcere duro per i mafiosi e del reato di
associazione per delinquere di stampo mafioso. In cambio di quelle richiesta
veniva promessa una «pax» mafiosa e la cessazione degli attentati. Quel pezzo di
carta, tuttavia, non è mai stato ritrovato. Anzi: una copia messa a disposizione
degli inquirenti da parte di Massimo Ciancimino, figlio di Vito, si è rivelato
una «patacca». Costata l’incriminazione allo stesso Ciancimino junior.
Le fonti di prova? I pentiti. Le fonti di prova per questa trama portate dalla
procura all’attenzione della Corte sono state essenzialmente le deposizioni dei
pentiti. Giovani Brusca in primis, ma anche Salvatore Cancemi, Nino Giuffrè e
Gaspare Spatuzza. Tutti (ma solo loro) avvalorano il fatto che l’indomani del
delitto Lima e degli attentati venne avviato il dialogo tra i carabinieri e i
capimafia. Anche alcune sentenze avvalorano l’ipotesi che sia esistito un
patteggiamento tra Stato e malavita organizzata ma sempre sulla scorta dei
collaboratori di giustizia. Vengono ritenute inoltre rilevanti le
intercettazioni in carcere dei colloqui di Totò Riina con un compagno di cella.
In particolare una frase («Sono loro che si sono fatti sotto...») che
alluderebbe secondo i pm a una volontà dello Stato di avvicinare i capi della
mafia per intavolare la trattativa.
I punti deboli dell’accusa. L’impianto dell’accusa, tuttavia, ha subito alcuni
colpi che ne hanno messo in dubbio la solidità. Questi colpi sono arrivati in
particolare da sentenze «esterne» al processo Stato-mafia ma ad esso connesse.
Ad esempio, Calogero Mannino è già stato assolto in primo grado da tutte le
accuse: dunque nel suo comportamento non è stato ravvisato alcun «avvicinamento»
con le cosche. Anche il generale dei carabinieri Mario Mori è stato assolto
dall’accusa di aver favorito la latitanza di Bernardo Provenzano: questa avrebbe
dovuto essere una delle «monete di scambio» tra la mafia e le istituzioni. E
infine era già crollata la credibilità di Massimo Ciancimino, le cui presunte
rivelazioni (ad esempio sulla partecipazione di un fantomatico «signor Franco»
dei servizi segreti alla partecipazione delle stragi mafiose) sono rumorosamente
crollate a dispetto della loro eco mediatica.
Trattativa Stato-mafia, condannati Mori, De Donno, Dell'Utri e
Bagarella. Assolto Mancino. La sentenza della corte
d’assise di Palermo dopo 5 anni di processo. I giudici accolgono la
ricostruzione della procura sulla stagione del 1992-1993. Mancino: "Ho avuto
sempre fiducia che a Palermo ci fosse un giudice". Di Matteo: "Sentenza
storica". Maxi risarcimento per la presidenza del consiglio: dieci milioni di
euro, scrive Salvo Palazzolo il 20 aprile 2018 su "La Repubblica". Condannati
gli uomini delle istituzioni e i mafiosi per la trattativa Stato-mafia. Dodici
anni per gli ex generali Mario Mori e Antonio Subranni, dodici anni per l'ex
senatore Marcello Dell'Utri, 8 anni per l'ex colonnello Giuseppe De Donno.
Ventotto anni per il boss Leoluca Bagarella. Assolto l'ex ministro Nicola
Mancino, perché il fatto non sussiste. Massimo Ciancimino, il supertestimone del
processo, è stato condannato a 8 anni per calunnia nei confronti dell'ex capo
della polizia Gianni De Gennaro, è stato invece assolto dall'accusa di concorso
esterno in associazione mafiosa. E' scattata la prescrizione per il pentito
Giovanni Brusca. Dopo 5 anni e 6 mesi di processo, 5 giorni di camera di
consiglio, ecco il verdetto della Corte d’assise di Palermo presieduta da
Alfredo Montalto (giudice a latere Stefania Brambille) nel processo chiamato a
indagare sulla terribile stagione del 1992-1993, insanguinata dalle stragi
Falcone e Borsellino e poi dagli attentati di Roma, Milano e Firenze. All’ex
ministro Mancino era stata contestata la falsa testimonianza; agli altri uomini
delle istituzioni, il reato di concorso in minaccia a un corpo politico dello
Stato, minaccia lanciata dai mafiosi con le bombe. La condanna attribuisce la
responsabilità agli ufficiali del Ros per il periodo 1992-1993; a Dell'Utri, per
il "periodo del governo Berlusconi". Ovvero, il 1994. I giudici hanno anche
stabilito un maxi risarcimento dei danni nei confronti della presidenza del
consiglio dei ministri: 10 milioni di euro. Secondo i pubblici ministeri Nino Di
Matteo, Francesco Del Bene, Roberto Tartaglia e Vittorio Teresi, in quei mesi
uomini dello Stato avrebbero trattato con i vertici di Cosa nostra: la finalità
dichiarata era quella di bloccare il ricatto delle bombe, ma per l’accusa gli
ufficiali dei carabinieri avrebbero finito per veicolare il ricatto lanciato dai
mafiosi, trasformandosi in ambasciatori dei boss. Era questo il cuore dell’atto
d’accusa dei magistrati, che nella requisitoria avevano chiesto pesanti
condanne. Le motivazioni della sentenza arriveranno fra novanta giorni.
Esulta Mancino, che aveva scelto di aspettare a casa la lettura della sentenza:
"Ho sempre avuto fiducia che a Palermo ci fosse un giudice. Sono stato vittima
di un teorema che doveva mortificare lo Stato e un suo uomo, che tale è stato ed
è tuttora. Sono stato volutamente additato ad emblema di una trattativa, benchè
il mio capo di imputazione, che oggi è caduto, fosse di falsa testimonianza". In
aula, il pm Nino Di Matteo parla invece di una "sentenza storica". Dice: "Ora
abbiamo la certezza che la trattativa ci fu. La corte ha avuto la certezza e la
consapevolezza che mentre in Italia esplodevano le bombe nel '92 e nel '93
qualche esponente dello Stato trattava con Cosa nostra e trasmetteva la minaccia
di Cosa nostra ai governi in carica. E questo è un accertamento importantissimo,
che credo renda un grosso contributo di chiarezza del contesto in cui sono
avvenute le stragi. Contesto criminale e purtroppo istituzionale e politico. Ci
sono spunti per proseguire le indagini su quella stagione". "Prima si era messa
in correlazione Cosa nostra con il Silvio Berlusconi imprenditore, adesso questa
sentenza per la prima volta la mette in correlazione col Berlusconi politico -
dice ancora Di Matteo - le minacce subite attraverso dell'Utri non risulta che
il governo Berlusconi le abbia mai denunciate e Dell'Utri ha veicolato tutto. I
rapporti di Cosa nostra con Berlusconi vanno dunque oltre il '92".
LA PRIMA TRATTATIVA. Secondo l'accusa, nel 1992, "i carabinieri del Ros avevano
avviato una prima trattativa con l'ex sindaco mafioso di Palermo, Vito
Ciancimino, che avrebbe consegnato un ‘papello’ con le richieste di Totò Riina
per fermare le stragi". Circostanza negata dai carabinieri imputati. Mori ha
negato anche di avere incontrato l'ex sindaco mafioso prima della strage
Borsellino, i primi contatti sarebbero stati tenuti da De Donno. La procura
riteneva diversamente. E la corte ha accolto la ricostruzione della procura.
Durante l'inchiesta "Trattativa" è emerso che un mese dopo la morte di Falcone,
l'allora capitano De Donno chiese una "copertura politica" per l'operazione
Ciancimino (il dialogo segreto con l'ex sindaco) al direttore degli Affari
penali del ministro della Giustizia Liliana Ferraro, che però rimandò
l'ufficiale ai magistrati di Palermo. Il 28 giugno, la Ferraro parlò del Ros e
di Ciancimino a Borsellino, che le disse: "Ci penso io". E da quel momento, il
mistero è fitto. Cosa sapeva per davvero Borsellino? A due colleghi disse in
lacrime (un'altra circostanza emersa nell'inchiesta di Palermo): "Un amico mi ha
tradito". Chi è "l'amico" che tradì? Resta il giallo.
L'ACCUSA A MANCINO. Sono state le parole dell'allora ministro della Giustizia
Claudio Martelli ad aver messo nei guai l'ex ministro dell'Interno Mancino. "Mi
lamentai con lui del comportamento del Ros", ha messo a verbale l'ex ministro
della Giustizia davanti ai giudici di Palermo. "Mi sembrava singolare che i
carabinieri volessero fare affidamento su Vito Ciancimino". Martelli ha
affermato senza mezzi termini di aver chiesto conto e ragione a Mancino dei
colloqui riservati fra gli ufficiali del Ros e l'ex sindaco mafioso di Palermo.
Mancino ha sempre negato: ha detto di non avere mai parlato del Ros e di
Ciancimino con Claudio Martelli. Lo ha ribadito poco prima che i giudici
entrassero in camera di consiglio. E la Corte ha creduto alla sua versione.
LA SECONDA TRATTATIVA. Secondo l’accusa, dopo l'arresto di Riina, avvenuto il 15
gennaio 1993, i boss avrebbero avviato una seconda Trattativa, con altri
referenti, Bernardo Provenzano e Marcello Dell'Utri. Mentre le bombe mafiose
esplodevano fra Roma, Milano e Firenze, un altro ricatto di Cosa nostra per
provare a ottenere benefici. "Dell'Utri ha fatto da motore, da cinghia di
trasmissione del messaggio mafioso", hanno accusato i pubblici ministeri. "Il
messaggio intimidatorio fu trasmesso da Dell'Utri e recapitato a Berlusconi". E
ancora:
"Nel 1994, Dell'Utri riuscì poi a convincere Berlusconi ad assumere iniziative
legislative che se approvate avrebbero potuto favorire l'organizzazione".
All’esito di questa seconda trattativa, sosteneva l’accusa, sarebbe stato
attenuato il regime del carcere duro.
Trattativa Stato-Mafia: tutti condannati tranne Nicola Mancino.
Lo scambio di favori ci fu. Così la corte d'assise palermitana ha espresso
condanne da 12 a 28 anni di reclusione per Leoluca Bagarella, Antonino Cinà,
Marcello Dell'Utri, Antonio Subranni, Mario Mori, Giuseppe De Donno e Massimo
Ciancimino, scrive Maurizio Tortorella il 20 aprile 2018 su "Panorama". Ci fu
veramente la “Trattativa” tra Stato e Cosa nostra? Dopo cinque anni di processo,
arriva una risposta, per quanto provvisoria. E la risposta è sì, almeno secondo
i giudici della seconda sezione della Corte d’assise di Palermo. Quei giudici,
riuniti in camera di consiglio da lunedì 16 aprile, hanno pronunciato il
verdetto di primo grado nell’aula-bunker del carcere Pagliarelli, nella
periferia a sud-ovest della città: la stessa aula sorda e beige dove per oltre
cinque anni, inanellando 212 udienze e intrecciando migliaia di ore nell’ascolto
di oltre 200 testimoni (tra i quali, nell’ottobre 2014, l’allora presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano), si è celebrato uno dei procedimenti
penali più difficili, complicati e controversi nella storia d’Italia. Sempre per
la prima volta nella storia, del resto, con l’inchiesta sulla “Trattativa
Stato-mafia” la Procura di Palermo ha messo insieme sul banco degli
imputati capi mafiosi, alti ufficiali delle forze dell’ordine e uomini delle
istituzioni. Attraverso di loro, la Procura ha voluto a tutti i costi processare
il “patto illecito” che sarebbe stato ordito nel 1992-93 da pezzi delle
istituzioni con i vertici di Cosa nostra, uniti in un inconfessabile scambio:
l’organizzazione criminale avrebbe dovuto interrompere la stagione delle stragi
(Capaci, Palermo, Firenze, Milano…) in cambio di un allentamento del regime
carcerario duro riservato ai boss mafiosi. La Corte d’assise palermitana,
presieduta da Alfredo Montalto, ha deciso oggi che quell’accusa avesse un
fondamento e per questo ha condannato sette imputati su otto. L’unico assolto
è l’ex ministro dell’Interno Nicola Mancino, che era stato accusato di falsa
testimonianza. Per il reato di minaccia e violenza a un corpo politico dello
Stato, invece, la Corte ha inflitto 28 anni di reclusione al boss Leoluca
Bagarella; 12 anni ad Antonino Cinà, il medico del boss Totò Riina; 12 anni
all'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri (già in carcere perché
condannato in via definitiva a sette anni per concorso esterno in associazione
mafiosa). Sono dure anche le condanne inflitte all’ex capo del Raggruppamento
operativo speciale dei carabinieri Antonio Subranni (12 anni), al suo vice del
tempo Mario Mori (12 anni) e all’allora capitano Giuseppe De Donno (otto
anni). Massimo Ciancimino, figlio dell’ex sindaco mafioso di Palermo Vito
Ciancimino, è stato condannato infine a otto anni di reclusione per calunnia.
Gli inizi. Tutto era cominciato nel 2008-2009. L’inchiesta sulla “Trattativa”
era nata allora, con il diverso nome in codice “Sistemi criminali”, per
iniziativa del pubblico ministero palermitano Antonio Ingroia (poi dedicatosi
alla politica con fortuna inversamente proporzionale all’intensità degli
ideali). A dare il via all’inchiesta di Ingroia era stato proprio uno degli
imputati del processo sulla “Trattativa”: Massimo Ciancimino, sedicente
depositario delle “verità” che negli ultimi 30 anni si sarebbero accumulate nei
rapporti tra mafia, politica e servizi segreti. Ciancimino jr aveva rivelato
anche l’esistenza di un documento scritto, il cosiddetto “papello” vergato da
suo padre, contenente i termini dell’accordo. Di quel documento, contestato dai
periti delle difese, non è però mai stata fornita una versione originale ma
soltanto fotocopie. Teste controverso e più volte screditato, Massimo Ciancimino
è poi paradossalmente entrato nel processo sulla “Trattativa” cui lui stesso ha
contribuito perché accusato di avere calunniato l’ex capo della Polizia, Gianni
De Gennaro. Per lo stesso reato di calunnia, peraltro, Ciancimino è già stato
condannato (in primo grado) per ben tre volte a Palermo, Bologna e
Caltanissetta. E attualmente è in carcere perché condannato per concorso in
associazione mafiosa, per riciclaggio di denaro e per detenzione d’esplosivo.
Contro le tesi di Ingroia e dei suoi successori, per tutti questi anni gli
avvocati degli imputati e i critici dell’inchiesta sulla “Trattativa” hanno
sempre sottolineato il carattere ideologico-politico dell’inchiesta, e criticato
l’inconsistenza e l’inverosimiglianza delle accuse. Alcuni grandi giuristi e
tecnici del diritto penale, come Giovanni Fiandaca, ne hanno addirittura
contestato le stesse fondamenta giuridiche, sostenendo che la politica aveva e
ha il pieno diritto costituzionale d’intervenire in ogni materia, anche per
cercare di fermare le stragi di mafia.
Le richieste. Lo scorso 26 gennaio i quattro pubblici ministeri Nino Di Matteo,
Vittorio Teresi, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia avevano concluso le loro
requisitorie presentando alla Corte queste richieste di pena per gli otto
imputati: 12 anni per i mafiosi Leoluca Bagarella e Antonino Cinà, e altrettanti
per Marcello Dell’Utri (già in carcere perché condannato in via definitiva a
sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa). I pm avevano chiesto
sei anni per l’ex ministro Nicola Mancino e avevano stabilito invece il “non
doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato” nei confronti del
collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, e la Corte d’assise ne ha convenuto.
Per Antonio Subranni e per l’allora capitano Giuseppe De Donno la Procura aveva
chiesto 12 anni, mentre ne aveva domandati 15 per Mario Mori. Per la calunnia
attribuita a Massimo Ciancimino, infine, la Procura aveva chiesto 5 anni. Il
procuratore aggiunto Teresi aveva concluso così la requisitoria: “Noi siamo
convinti che tutte le tessere che abbiamo ricostruito e abbiamo offerto, dagli
anni Settanta fino alla metà degli anni Novanta, si incastrino in un quadro
d’insieme che ha a che fare con i reati contestati. Un quadro nel quale qualche
tessera è sporca del sangue delle vittime di quelle stragi. Possiamo dire che
la strage di Capaci è una strage consumata per vendetta e per fermare quella
grande evoluzione normativa che Giovanni Falcone aveva impresso dal ministero
della Giustizia...”. Nel processo, il cui svolgimento in aula era cominciato il
7 marzo 2013, gli imputati inizialmente erano 11. In questi ultimi cinque anni,
però, i due boss Totò Riina e Bernardo Provenzano sono morti in carcere, da
ergastolani. L’undicesimo imputato, l'ex ministro democristiano Calogero
Mannino, l’unico ad avere scelto il rito abbreviato, è invece stato assolto il 4
novembre 2015 dall'accusa di violenza e minaccia a corpo politico dello Stato
"per non aver commesso il fatto": per lui, all’epoca, la Procura di Palermo
aveva chiesto nove anni di reclusione. Nel suo caso, inutilmente. E anche questa
incongruenza, probabilmente, peserà sull’inevitabile giudizio d’appello.
Trattativa Stato-mafia, cold case all'italiana.
Criticato anche da molti magistrati, il processo è rimasto digiuno di prove.
Ormai è solo materiale per film e serie tv (Sabina Guzzanti docet), scrive
Claudio Martelli il 9 agosto 2017 su "Panorama". Si chiamano cold case, casi - o
delitti - raffreddati, cioè remoti, irrisolti e archiviati. Ogni tanto qualcuno
di questi casi che, dopo molto scalpore, lasciò più domande che risposte,
riemerge. A risollevarli sono talvolta i parenti delle vittime, più spesso un
giornalista o uno sceneggiatore televisivo che, spulciando, trova spunto in
qualche vecchio caso. In America ai cold case alcuni distretti di polizia
riservano un ufficio: didattica per le teste calde o passatempo sull'orlo della
pensione. Invece la tv ne ha fatto una specializzazione, una branca delle serie
Crime. Anche in Italia l'archeologia giudiziaria è un'attività fiorente e ha
fatto la fortuna di produttori, registi e attori. Di diverso c'è che da noi
alcuni magistrati hanno costruito le loro carriere e conquistato la fama
dedicando centinaia di indagini e decine di anni di processi sempre agli stessi,
pochi, fatti e alle stesse, moltissime, dicerie e supposizioni mai provate. A
questo genere appartiene certamente il processo alla cosiddetta trattativa tra
Stato e mafia. Criticato anche da molti magistrati, il processo spettacolare
negli annunci è rimasto digiuno di prove e riscontri. Come stupirsi? Alla
vigilia del rinvio a giudizio, il pm Antonio Ingroia, che l'aveva imbastito,
pensò bene di trasferirsi in Nicaragua per conto dell'Onu. Non prima di aver
dato alle stampe un suo libricino intitolato Io so. Chissà l'umore dei colleghi
che ereditarono l'indagine nel leggere il seguito di Io so. Testualmente: "Io so
ma non lo posso dimostrare". Così è toccato a Nino Di Matteo osare quel che
Ingroia aveva fallito. Intanto, in altri processi paralleli, le corti
mandavano assolti gli ufficiali del Ros che la Procura di Palermo aveva posto al
centro della trattativa, colpevoli di non aver perquisito il covo di Riina e di
non aver arrestato Provenzano. Analoga assoluzione ha ottenuto l'ex ministro
Calogero Mannino, accusato di essere stato la mente della trattativa. Viceversa
è stato sbugiardato e arrestato quel Massimo Ciancimino che la Procura aveva
elevato a eroe dell'antimafia. Così, orfano, il processo alla trattativa è
diventato materiale per film e serie tv. Sabina Guzzanti ne ha fatto
un docufilm e l'ha presentato alla mostra di Venezia. La trama ha lo stesso
assunto dell'inchiesta di Palermo e anche la stessa efficacia probatoria. In
breve: tra il '92 e il '94 la mafia siciliana delusa dai vecchi partiti che si
erano messi a contrastarla cerca nuovi referenti politici e prima ancora che
fosse nata e che vincesse le elezioni si affida a Forza Italia tramite Marcello
Dell'Utri il quale giace sì in carcere, ma che da questa accusa è stato assolto
dalla Cassazione. A febbraio Sabina presenta il suo film a Catanzaro in una
serata tutta 5 Stelle. A luglio la Procura replica il copione: stessi pentiti,
stesse accuse, stessa trama. Al patto tra Stato e mafia avrebbe aderito anche la
'ndrangheta calabrese "con l'avallo di massoneria e servizi segreti deviati". Il
canovaccio originale che "i pm calabresi hanno acquisito e aggiornato" è sempre
quello: l'inchiesta sui cosiddetti "Sistemi criminali" di Roberto
Scarpinato. L'inchiesta fu archiviata ma i diritti d'autore, non c'è dubbio,
sono suoi.
Stato-Mafia, così la sentenza Mannino seppellisce il teorema
della trattativa. Il legale di Mori: "Ora serve
un'indagine sugli enormi costi giudiziari a carico della collettività", scrive
Anna Germoni il 7 novembre 2016 su "Panorama". "Questa sentenza è una
ulteriore pietra tombale sul teorema della trattativa. Già nel 2013 i giudici
della quarta sezione del tribunale di Palermo, che assolsero il generale Mario
Mori e il colonnello Mauro Obinu, demolirono tali fantasie (quelle della
trattativa Stato-mafia, ndr) scrivendo 1.322 pagine. Ora ne arrivano altre 500,
con l'assoluzione di Calogero Mannino, che mi sembrano anche un atto d'accusa
contro alcuni metodi d'indagine in uso a Palermo”. Con queste parole molto dure
nei confronti dei magistrati titolari dell'inchiesta Stato-mafia, l'avvocato
Basilio Milio, legale dei prefetto Mario Mori, commenta le motivazioni del gup,
Marzia Petruzzella, che il 3 novembre del 2015 aveva assolto l'ex ministro Dc,
per “non aver commesso il fatto”. Milio aggiunge, “sarebbe ora che ci si
interrogasse sulle vere ragioni di tali processi e si avviasse un'indagine sugli
enormi costi giudiziari a carico della collettività”. Una stoccata al ministro
della Giustizia, Andrea Orlando, al Csm e al sindacato dei magistrati, l'Anm.
Calogero Mannino era accusato di violenza o minaccia a corpo politico dello
Stato ma aveva scelto il rito abbreviato, mentre il processo principale è in
corso a Palermo, con imputati, tra gli altri, Riina, Bagarella, Mori, De Donno e
Mancino. Secondo l'accusa, il politico aveva cercato di aprire un canale con i
boss temendo per la propria incolumità. Subito dopo il verdetto i pm
dichiararono di ricorrere in appello, mentre il procuratore capo Lo Voi, più
cauto commentò di voler “valutare dopo le motivazioni”. Ebbene le motivazioni
sono arrivate, dopo un anno dalla sentenza di assoluzione. Il giudice per le
udienze preliminari, scusandosi per il ritardo del deposito, ha scritto oltre
500 pagine di motivazioni della sentenza, sviscerando e analizzando una mole di
faldoni impressionanti, considerando che nel processo in corso sono stati
depositati oltre un milione di pagine. La giudice Petruzzella, nelle motivazioni
più volte ammonisce i magistrati dell'inchiesta Stato-mafia, Vittorio Teresi,
Roberto Tartaglia, Francesco Del Bene e Antonino Di Matteo per l'impianto
accusatorio, anzi sarebbe meglio scrivere per l'assenza di impianto accusatorio.
E la Petruzzella non va tenera.
Gup contro Pm. La gup scrive: “il procedimento “trattativa” si inserisce
nell’alveo di un’altra nutrita serie di indagini (i cui atti sono in parte pure
compresi nel fascicolo del Pm), svolte nell’ultimo trentennio soprattutto dalle
Procure di Palermo, Caltanissetta e Firenze, ché, parallelamente alla
celebrazione dei processi contro mandanti ed esecutori materiali, via via
individuati, hanno sondato se dietro la strategia stragista di quegli anni si
annidasse una regia politica occulta. Vi rientrano: l’indagine contro Berlusconi
e Dell’Utri, dalla Procura di Caltanissetta, archiviata nel 2002, e quella della
stessa Procura, cosiddetta "mandanti occulti bis", archiviata nel 2003,
l’indagine della Procura di Palermo denominata “sistemi criminali”, archiviata
nel 2001, oltre la già più volte richiamata primigenia indagine “trattativa”
della Procura di Palermo iscritta nel 2000 (…) la Procura di Palermo nel 2008 ha
continuato invece a privilegiare l’ipotesi della trattativa stato-mafia, secondo
l’originaria formulazione (del papello ricattatorio di Riina con la
partecipazione alla trattativa di Vito Ciancimino), considerando Massimo
Ciancimino una fonte di una qualche “criticità” ma tuttavia suscettibile di
sviluppi validi a chiudere il quadro degli interrogativi, che erano rimasti
aperti al momento della archiviazione del 2004, soprattutto sull’ipotesi che
l’invio della lista di richieste di Riina fosse stata sollecitata da Mori, quale
intermediario per conto di una parte istituzionale". Analizzando gli elementi
probatori la gup sottolinea la linea “unidirezionale prescelta dal Pm nella
lettura della serie di dati di fatto messi in rilievo e posti a sostegno del suo
impianto” e che “molti degli elementi indicati dall’organo dell’accusa
afferiscono a situazioni in realtà notorie o pacifiche, che quindi non avrebbero
bisogno di essere provate, o persino irrilevanti (quando suscettibili di
plausibili letture alternative). E ancora, “la consequenzialità logica di questa
analisi del Pm appare molto fragile ed affetta da un evidente vizio di
circolarità” (…) “i Pm si sono soffermati ad illustrare il compendio probatorio
posto a sostegno della loro complessa rappresentazione accusatoria (..) ma in
un’ottica più ampia di quella adottata qui dal Pm (tutti tratti dagli oltre
cento faldoni, che compendiano la documentazione dell’indagine e quella affluita
nel corso dell’udienza preliminare) il giudice deve restituire a questo processo
“la necessaria dialettica, rimasta inevitabilmente frustata dalle
caratteristiche del rito abbreviato, unite alla straordinarie dimensioni della
documentazione prodotta dalla pubblica accusa, ed acuita, appunto, dalla lettura
unidirezionale dei fatti adottata dal Pm”. Il giudice infine nelle ultime pagine
delle motivazioni della sentenza assolutoria nei confronti dell'ex ministro Dc,
ammonisce i magistrati: “gli indizi devono essere, infatti, prima vagliati
singolarmente, per accertarne il valore probante individuale in base al grado di
inferenza dovuto alla loro gravità e precisione, per poi essere esaminati
unitariamente per porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo,
univoco e pregnante contesto dimostrativo. Ogni "episodio" va dapprima
considerato di per sé come oggetto di prova autonomo onde poter poi ricostruire
organicamente il tessuto della "storia" racchiusa nell'imputazione”.
Il "papello" di Massimo Ciancimino. Sul papello ci eravamo già soffermati,
anticipando nel 2013 le dichiarazioni della giudice Petruzzelli, non per
vaticinio ma per aver analizzato gli atti processuali. Il gup scrive che
“l'analisi integrale delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino ne ha rivelato
l'assenza di coerenza e ha reso palese la strumentalità del comportamento
processuale, la gravità degli artifici adoperati per rendere credibili le sue
sensazionali rivelazioni e giustificare le sue molteplici contraddizioni e per
tenere sulla corda i pubblici ministeri col postergare la promessa di consegnar
loro il papello, carpirne così la considerazione e mantenere sempre alta su di
sé l'attenzione generale, accompagnato nel suo luminoso cammino dalla stampa e
dal potente mezzo televisivo, stuzzicati con altrettanta astuzia". "In
particolare - prosegue il gup - sul finire del 2008 il Ciancimino creava
abilmente nei pm, che lo interrogavano sulla trattativa tra il padre e i due
carabinieri del Ros, l'aspettativa del papello, che forniva solo in fotocopia
sul finire del 2009, dopo averli riempiti di documenti del padre, selezionati a
suo scelta e consegnati nei tempi da lui decisi, e di informazioni modulate a
seconda delle evoluzioni del suo racconto e delle contraddizioni in cui andava
incespicando. Non può mancarsi di notare ancora una volta: che l'autore del
papello consegnato dal Ciancimino in copia ai Pm non è stato identificato". Il
gup elenca tutti i punti oscuri della collaborazione di Ciancimino che, con le
sue rivelazioni, ha dato vita a un'indagine già archiviata in passato: come le
dichiarazioni sul misterioso signor Franco, 007 che, da dietro le quinte,
avrebbe mosso i fili della trattativa. "Non ha fornito alcun dato autentico e
utile ad identificarlo", scrive il gup che definisce "defatiganti, dispendiose e
del tutto inutili" le ricerche investigative per identificare l'agente dei
Servizi. Il giudice ricorda anche il documento falso predisposto da Ciancimino
"ai danni di Gianni De Gennaro, all'epoca capo della polizia, e la vicenda dei
candelotti di dinamite, fatti rinvenire ai Pm nel giardino della sua abitazione
a Palermo, nell'aprile del 2011, per la cui detenzione ha già ricevuto una
condanna". Ciancimino "lo ha fornito solo in fotocopia senza dare di ciò alcuna
motivazione plausibile, posto che la circostanza che si trovasse in cassaforte
all'estero non avrebbe impedito la consegna dell'originale; - scrive il gup - ed
è evidente che le fotocopie, con l'uso di carte e inchiostri datati, impediscano
l'accertamento delle epoche degli originali, oggetto della copiatura; non ha
voluto rivelare chi gli avesse spedito il papello dall'estero, come da lui
sostenuto, né perché non potesse dirlo ai pm e ha detto di non conoscerne
l'autore". "E naturalmente - stigmatizza il giudice - non si può non
sottolineare come il castello accusatorio si sia fondato su documenti prodotti
da Massimo Ciancimino in semplice fotocopia e non in originale".
La scarsa attendibilità di Giovanni Brusca. Il gup ha anche parole pesanti nei
confronti del collaboratore di giustizia, Giovanni Brusca. Così scrive: “le sue
dichiarazioni a causa della loro farraginosità e delle modalità del loro
progredire si rivelano di scarsa attendibilità. È soprattutto l’insieme delle
caratteristiche e dei contesti in cui dette dichiarazioni del collaboratore si
sviluppano, che impedisce di dar loro peso processuale” soprattutto “quello
della retrodatazione dell’invio del papello o il ripensamento su altri aspetti
relativi alla cronologia degli eventi, connessi all’avvio e ai fatti seguiti
alla medesima trattativa, che in astratto potrebbero considerarsi dovuti a
naturali difetti della memoria e di poco conto ai fini della valutazione dalla
credibilità del dichiarante, invero nel contesto in cui sono avvenute si
rivelano frutto di suggestioni o di scelte personali di Brusca, indotte anche
dal ruolo d’eccezione di cui si è sentito investito nei processi”. E ancora la
Petruzzelli aggiunge che “da quanto illustrato emerge che l’eccesso di
interrogatori in Brusca determinò ad un certo punto un inevitabile
condizionamento mentale, accentuando la sua tendenda a reputarsi depositario di
molte verità non rivelate e a non distinguere più le opinioni dai fatti da lui
conosciuti” e che dai pm “sono state attribuite a Brusca cognizioni di fatti,
facoltà interpretative e ricostruttive che all’atto pratico il collaboratore ha
mostrato di non possedere. L’esame degli interrogatori passati in rassegna
evidenzia le evoluzioni dichiarative di Brusca, la confusione dei suoi ricordi,
soprattutto con riferimento ai tempi degli episodi chiave, e l’innegabile e
ingiustificata progressione delle sue accuse, dimostrando “invero di avere sulle
situazioni di cui riferisce, su tali temi, delle conoscenze frammentarie e
limitate”.
L'opinione su Ciancimino. Giudizio pesante del gup, non solo nei confronti del
teste su cui ruota tutto l'impianto accusatorio della “Trattativa”, ma anche nei
confronti dei magistrati titolari del processo, “i Pm tra i cento interrogatori
documentati di Massimo Ciancimino, hanno indicato come maggiormente organici e
significativi (ai quali pertanto il giudice nella sua attività decisoria avrebbe
dovuto fare speciale riferimento), solo quattro di essi, espletati tra febbraio
e marzo del 2010” e “un’autentica valutazione dell’attendibilità del Ciancimino
non potrebbe certo fondarsi sull’esame di quattro dei cento interrogatori cui il
medesimo è stato sottoposto nel tempo” ma “al contrario, esaminare il complesso
degli interrogatori di Massimo Ciancimino è indispensabile innanzitutto per
comprendere cosa abbia determinato la necessità del loro protrarsi per una così
lunga durata, considerato che fin dall’inizio il campo dei temi di interesse
degli inquirenti era ben delineato (l’esistenza di referenti politici dietro i
Ros, quando andarono a trattare con Vito Ciancimino, le date dei loro colloqui,
i contatti di Vito Ciancimino con altri, e soprattutto il papello e le
circostanze che avrebbero portato alla sua spedizione) e le risposte al riguardo
di Massimo Ciancimino rivelavano quali effettive informazioni sarebbe stato
possibile trarne, oltre che la sua non linearità”. Il gup spiega che “dalla
lettura delle registrazioni integrali degli interrogatori di Massimo Ciancimino,
salta agli occhi una sua forte suggestionabilità, con la tendenza ad assecondare
la direzione data all’esame dai Pm” con “una propensione alla rappresentazione
fantasiosa e spettacolare, e al contempo manipolatoria”.
Nessun ricatto allo Stato. “Gli eventi stragisti del ‘93- così scrive la
Petruzzella - possono avere spiegazioni diverse e maggiormente plausibili di
quelle sposate dai Pm e non essere stati necessariamente determinati dai
contatti che i Carabinieri nel ’92 ebbero con Vito Ciancimino. Le informazioni
che ci sono giunte attraverso i mafiosi che sono diventati poi collaboratori di
giustizia e la somma dei risultati delle lunghe inchieste sui mandanti occulti
delle stragi e sui portatori di “interessi convergenti”, ci rivelano che sullo
sfondo di quella azioni ci furono scenari molto più fluidi e dinamiche molto più
irrazionali e imprevedibili di quelle della trattativa e del subentrare di
Provenzano al posto di Riina, ritenuta dal Pm” e che l'idea di colpire i
monumenti “era già dal ’92 presente nelle menti dei Brusca, Bagarella, Messina
Denaro e Graviano”. Dunque gli attentati stragisti si conclusero con “con
l’attentato a Totuccio Contorno in Toscana, preceduti dalla preparazione del più
enigmatico attentato all’Olimpico di Roma. Dopo di che il gruppo si sfaldò, per
dissapori tra i suoi membri, dovuti a ragioni di interesse economico e allo
scoraggiamento generale, dovuto al fallimento della strategia, dal momento che
lo Stato non si era piegato al loro ricatto, i collaboratori di giustizia
aumentavano, il maxiprocesso non fu rivisto, la repressione di polizia non
cessò, l’indignazione dell’opinione pubblica si acuì”.
Le reazioni. Nicoletta Piergentili Piromallo, difensore di Nicola Mancino,
unitamente al legale Massimo Krogh, dopo aver letto le motivazioni della
sentenza di assoluzione dell'ex ministro Calogero Mannino, a Panorama.it
dichiara che “ tale sentenza esamina i temi processuali evidenziando incertezze
e approssimazioni (dell'impianto accusatorio ndr) e che “vengono valutate
analiticamente anche le testimonianze dall'accusa nei confronti del ministro
Mancino, per ricavarne incongruenze e contraddizioni, viceversa nessuna critica
viene espressa all'operato del ministro degli Interni ( di quel periodo ndr).
Per questo esprimiamo la nostra piena fiducia nei giudici (della corte d'Assise
di Palermo dove il processo è ancora in corso ndr) auspicando una decisione
breve”. Francesco Antonio Romito, difensore dell'ex ufficiale dell'Arma Giuseppe
De Donno, dichiara: “Nel rispetto della Corte che deve giudicare i coimputati di
Mannino mi riduco a poche osservazioni: è davvero onorevole il fatto che giudice
si scusi per il ritardo nel deposito delle motivazioni, ma tale lungo tempo è la
garanzia di un miglior esame degli atti processuali. Con riserva di approfondire
meglio, mi pare di leggere che sotto il profilo del dolo non ci sono neanche
quei tanto pallidi quanto ambigui elementi indiziari presenti nella condotta del
coimputato Mannino, che, penso, per questo, avrebbe meritato un'assoluzione
con formula più favorevole; se sotto il profilo del dolo non esistono neanche
pallidi indizi, l'eventuale appello della Procura ancora più difficilmente potrà
sortire un ribaltamento della assoluzione. E ciò conforta ancor più la
professione di innocenza dei pubblici ufficiali coimputati nostri assistiti”.
Mancino: «Io distrutto per un teorema. Grazie ai giudici».
Parla l’ex ministro dell’Interno assolto al processo per la trattativa
Stato-mafia, scrive Fiorenza Sarzanini il 20 aprile 2018 su "Il Corriere della
Sera". «Si può uccidere con le bombe, ma anche con le parole e loro me l’hanno
ammazzato. Se non ci fossimo stati io, mia figlia e i nipotini non so che cosa
sarebbe successo». Si commuove Gianna Mancino ripercorrendo questi cinque anni
di processo contro suo marito Nicola, l’ex ministro dell’Interno accusato di
aver mentito. Ma poi non riesce a contenere la gioia per l’assoluzione e gli
passa il telefono.
Presidente Mancino si aspettava questa sentenza?
«Non poteva andare diversamente perché io ho sempre servito lo Stato e ho sempre
combattuto in ogni modo la criminalità organizzata esponendomi in prima
persona».
Lei è stato assolto ma gli stessi giudici hanno ritenuto che trattativa c’è
stata visto che hanno emesso dure condanne nei confronti di chi l’avrebbe
condotta.
«Potranno pure averla fatta ma io non ne ho mai saputo nulla. E sono contento
perché finalmente questa verità viene riconosciuta dai giudici».
L’ex ministro Claudio Martelli ha raccontato di essersi lamentato con lei,
all’epoca al Viminale, proprio perché i carabinieri del Ros erano andati a
parlare con Vito Ciancimino. Lei lo ha negato ed è scattata l’accusa di falsa
testimonianza.
«La prima volta in cui Martelli ha parlato di questa circostanza ha detto
“propendo per Mancino”, solo in seguito è stato più netto, ma dopo aver parlato
anche del mio predecessore Vincenzo Scotti. Adesso lo posso ripetere confortato
dal giudizio della Corte d’Assise: non ho mai parlato del Ros con Martelli».
Finora non le avevano creduto.
«Ho presentato numerosi esposti nella precedente gestione della procura, ma
evidentemente il procuratore di Palermo ha fatto il sordo».
Si riferisce all’ex capo dell’ufficio Francesco Messineo?
«È tutto documentato. E invece loro dicevano che mi ribellavo senza fondamento».
Sta dicendo che c’è stato un accanimento personale?
«Sicuramente c’era malanimo nei miei confronti. Hanno detto che io non avevo
coraggio. Io ho sempre stimato Scotti e non dico che non fosse un duro, ma io
certamente non mi sono mai piegato a nessuno. E mi sono difeso in ogni modo
possibile perché avevo il dovere di farlo anche rispetto alle mie origini umili
e ai sacrifici fatti dalla mia famiglia».
Con chi ce l’ha?
«Io sono stato mandato a giudizio su richiesta dei pm. Durante le indagini ci
sono stati molti momenti delicati e complicati. Filtravano notizie sul fatto che
sarei stato il prossimo indagato. Per me è stato un tormento, anche per il ruolo
che ricoprivo».
Era vicepresidente del Csm. Non crede sarebbe stato giusto dimettersi?
«Sarebbe stata una resa e invece, come si vede adesso, avevo ragione. Ma questo
ha avuto comunque gravi conseguenze su di me che volevo difendere a tutti i
costi lo Stato di diritto anche in questo modo. Sapevo che era un teorema e non
potevo cedere. Mi hanno distrutto e ora risorgo. Per questo adesso ringrazio i
giudici».
Sua moglie ha raccontato che per questa vicenda lei non ha più chiamato il capo
dello Stato Giorgio Napolitano.
«Lo avevo contattato quando lui era al Quirinale e io al Csm per gli auguri di
Natale e poi dopo il discorso del 31 dicembre attraverso la batteria del
Viminale. Uscirono le notizie che esistevano le intercettazioni e io mi sono
vergognato. Non ho più chiamato».
È stato quello il momento più difficile?
«È stato tutto molto complicato. Ho sempre vissuto con la paura che qualcuno
pensasse che avevo fatto qualcosa di male. E invece io non ho mai fatto niente
che non fosse al servizio dello Stato».
Il pm Di Matteo: «Messi in evidenza rapporti mafia-Berlusconi
politico». Il magistrato e la trattativa tra Stato e
Cosa nostra: «Dell’Utri cinghia di trasmissione», scrive Giovanni Bianconi il 20
aprile 2018 su "Il Corriere della Sera". «Finora avevamo una sentenza che
metteva in correlazione Cosa nostra con Berlusconi imprenditore, ora ne abbiamo
un’altra che per la prima volta la mette in correlazione con il Berlusconi
politico». Nino Di Matteo, divenuto il pm simbolo dell’inchiesta e del processo
sulla trattativa Stato-mafia, ora in servizio alla procura nazionale antimafia,
commenta a caldo il verdetto della corte d’assise.
Da che cosa deriva questa sua analisi?
«La sentenza dice che Marcello Dell’Utri ha fatto da cinghia di trasmissione tra
le richieste di Cosa nostra e l’allora governo Berlusconi, che si era da poco
insediato. Non risulta che il governo Berlusconi abbia mai denunciato le minacce
subite attraverso Dell’Utri. I rapporti di Cosa nostra con Berlusconi vanno
dunque oltre il 1992».
Al di là di quella singola posizione, qual è il significato di questa sentenza?
«Che la trattativa ci fosse stata non occorreva che lo dicesse questa sentenza,
lo aveva già stabilito la corte d’assise di Firenze sostenendo che aveva
rafforzato Riina nell’idea che la strategia delle bombe fosse pagante. Ciò che
emerge oggi è che pezzi dello Stato si sono fatti tramite delle richieste
mafiose mentre saltavano in aria giudici e cittadini comuni. Abbiamo dimostrato
che qualcuno nello Stato aiutò Cosa nostra a cercare di ottenere i risultati che
Riina e gli altri boss chiedevano. È una sentenza storica».
Lo dice perché per voi, più volte e da più parti finiti sotto accusa per come
avete istruito il processo, si tratta di una rivincita?
«Per noi non è importante avere il consenso, ma che i cittadini sappiano che
abbiamo fatto solo il nostro dovere, considerando tutti uguali davanti alla
legge. Il lavoro dei magistrati può essere criticato, anche in maniera aspra e
perfino cattiva, ma noi siamo stati accusati di perseguire finalità politiche ed
eversive, e di fronte a questo nessuno ci ha difeso. Oggi la corte d’assise ha
detto che non era così».
Questo verdetto è uno spunto per continuare le indagini ancora aperte sulle
stragi di mafia?
«Io credo e spero che oltre ai fatti reati già accertati, le inchieste aperte a
Caltanissetta, Firenze e alla Procura nazionale antimafia vadano avanti per
stabilire se oltre a quelle dei macellai di Cosa nostra sono configurabili altre
responsabilità, ad altri livelli».
Quindi il vostro lavoro non è finito?
«No».
"Sentenza storica dedicata a Borsellino, vittima della trattativa
Stato-mafia". Parla l'ex Procuratore Nazionale
antimafia Franco Roberti, scrive Maria Antonietta Calabrò il 20 aprile 2018 su
"Huffingtonpost.it". È contento della sentenza di Palermo, Franco Roberti, ex
Procuratore Nazionale antimafia che ha seguito passo passo le indagini della
Procura di Palermo sulla trattativa Stato-Mafia, nell'arco di questi anni,
essendo stato nominato dal CSM il 25 luglio 2013, fino al suo pensionamento
avvenuto lo scorso 16 novembre 2017.
"Sono lieto che sia stato riconosciuta dalla Corte di assise palermitana la
fondatezza dell'impianto accusatorio. La sentenza mi conforta. Laicamente ho
sempre sostenuto che fosse doveroso cercare la verità fino in fondo e senza
riguardi per nessuno".
Le condanne sono state pesanti. Anche per Marcello Dell'Utri.
"Il punto non è solo vedere le singole posizioni processali o le singole
condanne, che potrebbero essere riformate in appello. Leggeremo tra qualche
tempo le motivazioni della sentenza. Quello che mi preme sottolineare è che la
ricostruzione complessiva di quanto è avvenuto, portata avanti dai pubblici
ministeri, è stata confermata dalla sentenza. Questo è un dato molto
importante".
Il pm Nino Di Matteo ha parlato di sentenza storica. Condivide?
"Senz'altro: è una sentenza storica, non c'è alcun dubbio su questo".
Perché?
"Perché aiuterà a capire quello che è successo in Italia nei primi anni Novanta.
E che tanto pesa ancora oggi sullo sviluppo democratico del nostro Paese. Sono
stato io che ho applicato il sostituto procuratore nazionale antimafia Di
Matteo, insieme al collega Francesco Del Bene, al processo sulla trattativa
Stato-mafia, in modo che anche dopo la sua nomina a Roma potesse continuare il
suo lavoro e il nuovo incarico non fosse considerato una fuga da quel processo".
Questa sentenza segnerà veramente la fine della seconda Repubblica come ha
dichiarato il leader M5S Di Maio?
"Oggi c'è fame e sete di chiarezza e di verità per permettere all'Italia di
andare avanti. Tragedie come quelle di Aldo Moro o le stragi di mafia - con i
loro lati ancora oscuri - continuano a pesare sullo sviluppo democratico del
nostro Paese. La sentenza di Palermo è fondamentale perché può costituire
l'inizio di un percorso di ricerca della verità sulle complicità esterne ai
gruppi criminali, ancora non accertate".
Il coordinatore del pool dei pubblici ministeri, Vittorio Teresi ha dedicato
questa sentenza a Paolo Borsellino, perché Borsellino?
"Il 18 luglio dell'anno scorso, in occasione della commemorazione davanti al
Consiglio superiore della Magistratura del venticinquesimo anniversario della
strage di via D'Amelio, ho sostenuto in presenza del Capo dello Stato che la
decisione di uccidere Borsellino fu accelerata proprio perché egli sarebbe stato
d'ostacolo alla trattativa Stato- mafia, appena avviata dopo la strage di
Capaci. Tanto più Borsellino se fosse divenuto Procuratore nazionale antimafia,
dopo la morte di Giovanni Falcone. Borsellino era percepito come un macigno
sulla strada della trattativa: ecco perché Cosa nostra decise subito di
ricorrere ad una nuova strage. Borsellino si sarebbe certamente opposto alla
trattativa, da qui la necessità di ricorrere a un secondo clamoroso delitto in
così breve tempo".
Basilio Milio: «Se fosse vivo Riina, festeggerebbe».
Intervista di Giovanni M. Jacobazzi del 21 Aprile 2018 su "Il Dubbio". «Sono
sbigottito», dice l’avvocato Basilio Milio, difensore del generale dei
carabinieri Mario Mori, al termine della lettura della sentenza del processo
sulla trattativa Stato- mafia».
Avvocato, la condanna è pesantissima.
«Aspettiamo di leggere le motivazioni,
però è chiaro che 12 anni di carcere non lasciano dubbi sulla decisione della
Corte d’Assise di Palermo».
Si aspettava una sentenza del genere?
«Guardi, a favore del generale Mori
c’erano già quattro sentenze dove era stato sempre assolto per fatti analoghi».
Allora perché questa condanna?
«Non so proprio darmi una spiegazione».
Forse ci sono stati errori nella linea di difesa?
«Abbiamo fatto tutto quello che
bisognava fare. Anche di più. Sotto quest’aspetto non possiamo recriminare
nulla.
Nessuna scelta di cui pentirsi, quindi?
«No. E voglio essere anche positivo».
Cioè?
«C’è in me oggi un barlume di
contentezza, in un mare di sconforto. Sono contento perché sono consapevole che
la verità è dalla nostra parte. Questo è un giorno di speranza. Possiamo sperare
che in appello ci sarà un giudizio perché questo é stato un pregiudizio».
Ha delle contestazioni da muovere alla Corte d’Assise di Palermo
ed al presidente Alfredo Montalto?
«Non ho intenzione adesso di lamentarmi
su come è stato condotto questo dibattimento. Dico solamente che ci sono stati
tagliati molti testi e impedito di depositare centinaia di documenti che erano
importanti per la difesa».
Quali testi non sono stati ammessi?
«I magistrati Ilda Boccassini, Antonio
Di Pietro e Giuseppe Ayala. Strano, no?»
Analogo atteggiamento di chiusura c’è stato nei confronti della
Procura?
«La Procura di Palermo in questi anni
ha prodotto ogni tipo di documento possibile. E’ stato addirittura depositato
tutto il fascicolo personale del generale Mori acquisito al Comando generale
dell’Arma dei carabinieri. Senza contare tutte le intercettazioni dei colloqui
in carcere del boss Giuseppe Graviano. Giorni, anzi, settimane di
intercettazioni che abbiamo dovuto ascoltare con uno sforzo senza pari».
La Corte d’Assise si è “appiattita” in questi anni di processo
sulla Procura?
«La Corte ha quasi sempre aderito alle
istanze dei pm e mai alle nostre. I pm di Palermo sono andati anche in Sud
Africa per interrogare Gianadelio Maletti (ex numero due del Sid negli anni
Settanta, ndr) sui rapporti avuti con Mori quando prestava servizio alle sue
dipendenze dal 1972 al 1975».
Mi permetta una riflessione.
«Prego».
Era difficile per chiunque affrontare un simile dibattimento
condizionato da una pressione mediatica senza pari. Alcuni giornali hanno
sposato per anni le tesi del pm Nino Di Matteo, dal M5S considerato un eroe
tanto da essere proposto come ministro in un futuro governo Di Maio.
«Sì, la pressione c’è stata. E’
indubbio. Un circo mediatico messo su da chi sappiamo bene. Però in questo
processo non c’era nulla, e dico nulla, che potesse configurare un qualsiasi
reato a carico di Mori. Questo è stato un processo senza reato ma con una ben
precisa finalità: “mascariare” (sporcare, ndr) il generale quando invece
l’Italia intera dovrebbe ringraziarlo. Mori è stato un grande servitore del
Paese ed invece è stato perseguitato. E’ una sentenza dura che non sta né in
cielo né in terra. E faccio anche una considerazione».
Dica pure.
«Se Totò Riina fosse ancora vivo
avrebbe gioito di tutto questo. E io mi sono un po’ vergognato di essere
italiano sentendo la condanna a 12 anni per colui che ha fatto arrestare il
feroce boss corleonese».
Stravince Di Matteo: assolto il mafioso, punito il nemico dei boss. Accolte le
tesi dei pm Di Matteo. Dopo cinque anni, il primo grado del processo sulla
cosiddetta trattativa Stato–mafia si chiude con condanne pesanti, scrive Errico
Novi il 21 Aprile 2018 su "Il Dubbio". La trattativa con la mafia ci fu. In due
fasi: prima la condussero gli ufficiali del Ros, poi il senatore Marcello
Dell’Utri. A dirlo è la Corte d’assise di Palermo, al termine di un processo
durato 5 anni, con una sentenza piena di paradossi, e interpretata in modo
altrettanto illogico da un festante Nino Di Matteo. Primo: come fanno notare i
difensori del generale Mario Mori (Basilio Milio) e del cofondatore di Forza
Italia (Giuseppe Di Peri), «mai la Procura di Palermo ha indicato i luoghi e le
circostanze in cui gli uomini delle istituzioni avrebbero presentata la minaccia
di Cosa nostra ai vertici dello Stato». Eppure boss e “intermediari” sono
condannati, con pene che vanno dai 28 anni per Bagarella agli 8 inflitti al
colonnello De Donno, per “minaccia a corpo politico dello Stato”. Secondo: i
maggiori imputati (sempre i boss e i loro “portavoce istituzionali”) sono
condannati anche a risarcire per 10 milioni la presidenza del Consiglio. Cioè,
Dell’Utri dovrebbe risarcire Berlusconi. Eppure il pm Di Matteo ha il coraggio
di dire che la sentenza «dimostra l’esistenza di rapporti tra la mafia e il
Berlusconi politico». È vero che non c’è nulla che abbia senso, nell’emozionata
pronuncia di Alfredo Montalto, presidente del collegio. Ma sorprende come gli
unici a parlare, doverosamente, di sentenza «assurda» siano i radicali, in un
comunicato in cui ricordano che «Mori e i suoi uomini, Totò Riina l’hanno pur
sempre arrestato». E invece: Montalto, la giudice a latere Stefania Brambille e
i 7 giudici popolari si sono convinti che pezzi di Stato avrebbero trattato con
i boss stragisti. Condannato anche il teste chiave, ma non per concorso esterno,
ipotesi caduta in prescrizione: Massimo Ciancimino incassa una pena di 8 anni
per calunnia nei confronti dell’ex capo della polizia Gian- ni De Gennaro,
superiore dunque ai 5 anni chiesti dalla Procura. L’unico assolto è l’ex
ministro dell’Interno Nicola Mancino, sul quale pendeva una richiesta di 6 anni
per falsa testimonianza. È la vittoria dei pm palermitani, tutti (tranne
ovviamente l’ex aggiunto Antonio Ingroia, dimessosi dalla magistratura) presenti
in aula: Vittorio Teresi, Roberto Tartaglia, Francesco Del Bene e il succitato
Di Matteo. Premiata la tesi di una pressione esercitata prima dai vertici del
Ros, fino al 1993, e poi dal braccio destro di Berlusconi, dopo il 1993,
affinché fossero accolte le pretese avanzate, a suon di stragi, dalla mafia. Ma
come fa notare il difensore del generale Mori. Eppure, come ricorda l’avvocato
Di Peri, «c’erano già state precedenti sentenze che avevano respinto le stesse
ipotesi per il mio assistito e per gli ufficiali dei Ros: quella sulla mancata
perquisizione al covo di Riina e la pronuncia Mori– Obinu». Quei giudizi si
rovesciano: la trattativa ci fu. E come detto, in due tempi distinti, con
Dell’Utri che avrebbe veicolato le minacce di Cosa nostra, nel breve periodo del
primo governo Berlusconi, tra maggio ’ 94 e gennaio ’ 95. «Quell’esecutivo mai
denunciò quanto aveva subito», dichiara trionfante Di Matteo. Evidentemente non
ha importanza, per lui, il fatto che le presunte richieste non siano mai state
accolte in alcun provvedimento. Circostanza che, a voler seguire la sentenza, fa
del Cavaliere un eroe dell’antimafia. Di Matteo segue invece la pseudologica
delle suggestioni storiografiche: «Prima si era messa in correlazione Cosa
nostra con il Silvio Berlusconi imprenditore, adesso questa sentenza per la
prima volta la mette in correlazione col Berlusconi politico e si chiarisce
dunque che i suoi rapporti con Cosa nostra vanno oltre il ’ 92». Rapporti? Sì,
in cui il Cavaliere sarebbe vittima. Quisquilie.
LE CONDANNE. I vuoti logici in parte si giustificano con la mancanza delle
motivazioni, che saranno depositate entro novanta giorni. Allora, forse, si
comprenderà meglio il senso di alcune difformità fra le richieste dei pm e le
condanne inflitte. Nel caso dei boss, è stata dichiara la prevista prescrizione
per il reato ascritto a Giovanni Brusca, viene confermata la pena di 12 anni
invocata per Antonino Cinà ma è innalzata di molto quella relativa a Leoluca
Bagarella: dai 16 anni chiesti ai 28 comminati. Identiche a quanto atteso dalla
Procura sono le condanne per Dell’Utri e il generale del Ros Antonio Subranni:
12 anni. Di poco più bassa quella per il generale Mario Mori (12 anni di carcere
anziché 15). Il terzo ufficiale dell’Arma, il colonnello Giuseppe De Donno, è
punito con 8 anni di carcere contro i 12 richiesti. Mancino come detto è il solo
a poter esprimere la propria gioia, affidata all’avvocata Nicoletta Piergentili
e alle agenzie: «Sapevo che c’era un giudice a Palermo, è stato smentito il
teorema costruito contro di me, ma ho vissuto 8 anni di sofferenza».
I PM E LA REAZIONE DI FI. Tutti e quattro i pm si immergono nella selva di
taccuini un minuto dopo la lettura del dispositivo. Vittorio Teresi dedica la
vittoria «a Falcone e Borsellino», Tartaglia trova una conferma: «Abbiamo
lavorato bene». Nessuno degli inquirenti dà conto però di un vulnus enorme. Di
carattere logico, che rende urgentissimo il giudizio d’appello: su quello
conclusosi ieri si ha l’impressione di un peso straordinario dei giudici
popolari. Il vulnus è nella lunga parte della sentenza legata ai risarcimenti:
il più clamoroso ammonta a 10 milioni di euro, da dividersi tra i mafiosi,
Dell’Utri e i Ros, e andrà destinato alla presidenza del Consiglio. Cioè a
Berlusconi. Che dunque per i giudici è vittima. Di Matteo ribalta tutto: «La
Corte intanto ritiene provato il fatto che dopo il rapporto con il Berlusconi
imprenditore c’è quello con il politico». Un’interpretazione temeraria che Forza
Italia spiega anche «con la partecipazione del dottor Di Matteo alle iniziative
dei cinquestelle» e che «sarà oggetto dei necessari passi in ogni sede».
Sentenza grillina sulla Trattativa. La
Corte d’assise di Palermo condanna Mori, Subranni e Dell’Utri e apre una nuova
stagione di assedio giudiziario contro il Cav. Le sentenze ignorate, il mistero
del pataccaro Ciancimino, il trionfo del circo mediatico, i populismo dei
giudici popolari, scrive Giuseppe Sottile il 20 Aprile 2018 su "Il Foglio".
Chapeau. Il galateo istituzionale insegna che di fronte a una sentenza emessa in
nome del popolo italiano non c’è altro da fare che scappellarsi. Dopo cinque
anni di discussioni e di polemiche la Corte di assise di Palermo, presieduta da
Alfredo Montalto, ha stabilito che negli anni delle stragi di mafia, alcuni
funzionari dello Stato scesero a patti con i boss di Cosa nostra. Magari con la
migliore intenzione, che poi era quella di fermare il fiume di sangue. Ma la
trattativa ci fu. Ed è bastata questa convinzione per spingere i giudici togati
e i giudici popolari a distribuire condanne pesantissime a tutti gli imputati. A
cominciare dai due generali dei carabinieri, Mario Mori e Antonio Subranni, che
tra il 1992 e il 1994 si trovarono nell’inferno di Palermo e, da bravi
investigatori, attivarono tutti i mezzi per contrastare il disegno eversivo di
Totò Riina e dei sanguinari corleonesi. La sentenza non gli riconosce una sola
attenuante e li condanna a dodici anni di carcere. Prima di restare impigliati
nel processo istruito dal procuratore aggiunto Antonio Ingroia e sostenuto in
aula con particolare forza dal pubblico ministero Antonino Di Matteo, i due alti
ufficiali dell’Arma erano addirittura convinti di dovere ricevere prima o poi
una medaglia a nome di tutti gli italiani: perché erano riusciti a fermare la
strategia delle bombe; e perché avevano arrestato e sepolto nel carcere duro
Totò Riina, il capo dei capi. Invece sono stati costretti per oltre dieci anni a
salire e scendere le scale dei tribunali. E pur avendo collezionato assoluzioni
nei processi specifici – a cominciare da quello per la mancata cattura di
Bernardo Provenzano, il boss che secondo il teorema della trattativa avrebbe
tradito il capo dei capi, consegnandolo agli sbirri – si sono ritrovati oggi
nell’aula bunker del Pagliarelli sotto il maglio impietoso di una condanna
difficilmente sopportabile. Ovviamente, i loro avvocati presenteranno appello.
Ma ci vorranno almeno altri due o tre anni prima che si possa arrivare a una
sentenza di secondo grado. Intanto il calvario si allunga: da qui al 2021, se
tutto filerà liscio, avranno collezionato quindici anni di sofferenze, di
sospetti, di gogna, di disperazione di morte civile. Né Mori né Subranni sono
più dei giovanotti. E quando si è vecchi, annotava Luis de Góngora, “ogni caduta
è un precipizio”. Farà i conti con la propria età e con una giustizia senza fine
anche Marcello Dell’Utri, l’ex braccio destro di Silvio Berlusconi, in carcere
già da quattro anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo i
giudici di Palermo ha avuto anche lui un ruolo nella Trattativa e ai sette anni
precedenti, quelli inflitti per concorso esterno, andranno cumulati altri dodici
anni. Fine pena mai. In fondo è andata meglio ai mafiosi. Leoluca Bagarella,
cognato di Riina, sulle cui spalle gravavano già una decina di ergastoli,
aggiunge al suo casellario giudiziario un’ulteriore condanna a ventotto anni. Ma
il pluriassassino Giovanni Brusca, l’uomo che nel maggio del ’92, premette il
telecomando e fece saltare in aria a Capaci il giudice Giovanni Falcone, se l’è
cavata alla grande: il reato gli è stato prescritto, forse in virtù del fatto
che da quando è stato catturato – con grande clamore e giubilo delle forze
dell’ordine – lui ha molto opportunamente abbracciato la professione di
“pentito” con un programma a maglie larghe che gli ha consentito anche di
godersi un po’ di bella vita. Ma la sorpresa più clamorosa sta nella condanna
inferta a Massimo Ciancimino, figlio dell’ex sindaco mafioso di Palermo, e
testimone centrale di tutta la trama accusatoria. Al giovane Massimuccio – già
in carcere pure lui per altre ribalderie consumate mentre Ingroia lo elevava al
rango di “icona dell’antimafia” e il fratello di Paolo Borsellino lo abbracciava
e lo baciava nelle pubbliche manifestazioni – la Corte d’assise ha riconosciuto
il ruolo di pataccaro: difatti lo ha condannato a otto anni per le calunnie
rivolte all’ex capo della polizia, Gianni De Gennaro e non per concorso esterno
in associazione mafiosa. Dimenticando, probabilmente, un dettaglio: che Massimo
Ciancimino era il teste chiave di questo processo. Anzi. Questo processo non si
sarebbe potuto imbastire senza le sue clamorose “rivelazioni”. Lui, furbissimo,
si era trasformato nel ventriloquo di suo padre e in quanto tale raccontava non
solo a Ingroia ma anche a tutti i giornalisti che lo intervistavano gli incontri
che il vecchio Don Vito, corleonese e amico di Riina e Provenzano, aveva avuto
non solo con il generale Mario Mori, ma anche con il capitano Giuseppe De Donno,
anch’egli processato e condannato a otto anni di carcere. Come si dice in questi
casi, per chiarire un dubbio bisognerà doverosamente aspettare le motivazioni
della sentenza. Intanto però il dubbio resta in piedi: se il principale teste è
un pataccaro, su quali elementi i giudici hanno costruito le granitiche certezze
che li hanno spinti a formulare condanne così gravi e ferrose? Ciancimino –
giudiziariamente parlando, per carità – era stato fatto a pezzi già nel novembre
del 2015 dal giudice Marina Petruzzella che con rito abbreviato aveva giudicato
e assolto l’ex ministro democristiano Calogero Mannino, imputato nella
trattativa alla stregua di Mori, di Subranni e di Dell’Utri. Le sue
dichiarazioni, stando alla valutazioni di Marina Petruzzella, erano da
considerare “contraddittorie, confuse, divagatorie e incoerenti”. Eppure quelle
dichiarazioni hanno trovato spazio e accoglimento nel maxi processo concluso
oggi con sette durissime condanne. (L’unica assoluzione è stata quella dell’ex
ministro dell’Interno, Nicola Mancino, imputato di falsa testimonianza). Come
mai? La credibilità assegnata dalla Corte al pataccaro Ciancimino non è tuttavia
l’unico mistero che i giudici dovranno chiarire nel momento in cui si siederanno
a un tavolo per scrivere le motivazioni. Bisognerà capire anche per quali
ragioni siano stati ignorati i verdetti delle precedenti assoluzioni. Secondo
l’impostazione originaria data da Antonio Ingroia la presunta Trattativa tra i
boss e alcuni settori, ovviamente deviati, dello Stato si basava su alcuni
riscontri, su alcuni fatti strani e inquietanti: primo, Mori e i suoi
carabinieri avevano tutti gli elementi in mano per catturare Bernardo
Provenzano, il numero di due di Riina, ma non lo hanno fatto per avere in cambio
la “soffiata” che li avrebbe portati alla cattura del mammasantissima; secondo,
sempre Mori e i suoi carabinieri, dopo avere ammanettato Riina, avrebbero dovuto
immediatamente perquisire il covo di via Bernini dove il capo dei capi aveva
vissuto la latitanza, ma non lo hanno fatto per consentire ai più stretti
complici del boss, come Leoluca Bagarella, di fare sparire tutte le carte,
soprattutto quelle che avrebbero potuto portare le indagini ai santi protettori,
anche politici, della mafia. Ma questi riscontri, chiamiamoli così, erano stati
polverizzati da due sentenze di assoluzione pronunciate dai tribunali chiamati a
giudicare, per quei reati, sia Mori che De Donno. Con quale criterio la Corte
d’assise li ripesca e li fa propri? Quali solidi argomenti, insomma, hanno
spinto il collegio presieduto da Alfredo Montalto a ignorare la sentenza di
Marina Petruzzella e i due verdetti dei tribunali che non hanno trovato macchia
nel comportamento dei carabinieri? Probabilmente – e non sarebbe il primo caso –
una spiegazione andrebbe ricercata nel fatto che, nelle Corti d’assise, un peso
non indifferente viene assegnato ai giudici popolari. I quali, per definizione,
risentono maggiormente degli umori che pervadono la comunità. Il giudice togato
ha un distacco professionale, ha una “terzietà” costruita con i propri studi e
lungo la propria carriera. I giudici popolari, no. Hanno assistito e
probabilmente assimilato un processo mediatico durato quasi dieci anni.
Ricordate Ingroia che, pur di collegarsi con tutti i talk-show e predicare le
sue verità sulla trattativa se n’era persino andato in Guatemala? E ricordate
Massimo Ciancimino che parlava in nome del padre e denunciava le più improbabili
nefandezze di uomini, come Mori o De Gennaro, che invece avevano rischiato la
vita pur di arginare la litania dei massacri testardamente voluta da Totò “u’
curtu”, da Bagarella, da Brusca e dagli altri scellerati corleonesi? E ricordate
quanti altri giudici e quanti giornalisti si erano accodati al populismo facile
della tesi secondo la quale Berlusconi, tramite Dell’Utri, palermitano e amico
del boss Antonino Cinà, era sceso a patti con la mafia? E ricordate i
riconoscimenti e le cittadinanze onorarie che i magistrati della Trattativa,
primo fra tutti Nino Di Matteo, andavano raccogliendo nei comuni piccoli e
grandi d’Italia per il semplice fatto di credere nelle accuse che Ingroia e
Ciancimino avevano costruito e che altri tribunali avevano invece
demolito? Comizi, conferenze, riconoscimenti, associazioni adoranti – come
Agende rosse, come Scorta civica – avevano trasformato i pubblici ministeri di
questo processo in eroi, in campioni buoni per le piazze soprattutto grilline. E
non è certamente un caso che proprio Di Matteo fosse stato indicato da Beppe
Grillo come probabile ministro di un eventuale governo a cinque stelle. Potevano
i giudici popolari girarsi dall’altra parte? Oggi, dopo la lettura della
sentenza il pm Di Matteo si è presa la sua legittima soddisfazione. “Nella
nostra impostazione accusatoria, che ha retto completamente, si sostiene che
Dell’Utri sia stato la cinghia di trasmissione tra Cosa nostra e il governo
Berlusconi”, ha detto. E così dicendo ha sollevato un altro dubbio. Nella
sentenza che quattro anni fa ha spedito in carcere l’ex senatore per concorso
esterno era scritto e stabilito che l’imputato aveva mantenuto rapporti con i
boss fino al 1992. La sentenza smentisce questo assioma, verificato persino
dalla Cassazione, e sostiene che Dell’Utri entra in gioco nel ’93 e continua a
mafiare tranquillamente fino al ’94 quando Berlusconi è già a Palazzo Chigi. Su
quali prove? Lo diranno, se sapranno dirlo, le motivazioni. Intanto la squadra
che fa capo a Di Matteo prepara una nuova stagione giudiziaria. Bisognerà
tornare alle stragi, alle trame oscure, ai registi occulti e a tutto il
campionario della giustizia populista. Per altri vent’anni, se Dio gli darà
vita, Berlusconi non avrà pace.
La sentenza tra politica, circo e populismo giudiziario.
Tortora in primo grado fu condannato come camorrista. In questo caso è diverso.
A Napoli si limitarono a brindare alcuni giornalisti, qui si è applaudito in
aula. E’ iniziata la terza repubblica, commenta Di Maio, scrive Massimo Bordin
il 21 Aprile 2018 su "Il Foglio". E’ stata una sentenza politica quella di ieri
sulla “trattativa”. Da vari punti di vista. C’è un aspetto, diciamo così,
tecnico e qui se ne era già parlato un paio di mesi fa, presentandolo come
l’unico rischio che la difesa correva: rispetto alle quattro sentenze che hanno
assolto Mario Mori su vicende relative alla trattativa, questa di ieri a Palermo
è stata pronunciata da una corte d’assise, ovvero è stata l’unica con giuria
popolare. Leoluca Orlando, commentando entusiasta la sentenza, ha parlato di
verità storica che diviene verità giudiziaria, laddove per verità storica devono
intendersi le intere mensole di libri, molti scritti da magistrati, che per una
decina d’anni hanno consacrato le tesi dell’accusa prima del giudizio. La verità
storica di Orlando si costruisce nelle procure, si ufficializza nelle
pubblicazioni dei pm e dei loro addetti stampa e consente al pregiudizio di
sostanziarsi in verità giudiziaria grazie a una giuria popolare, nel tripudio in
aula del popolo delle agende rosse e della “scorta civica” del dottore Di
Matteo. Fosse solo un problema giudiziario saremmo nel campo di un orrore ben
noto. Enzo Tortora in primo grado fu condannato a dieci anni come camorrista. In
questo caso è diverso. A Napoli si limitarono a brindare alcuni giornalisti, qui
si è applaudito in aula. E’ iniziata la terza repubblica, quella dei cittadini,
ha commentato Luigi Di Maio. Forse precorre i tempi, siamo ancora a Weimar, ma
almeno in Germania, un magistrato che trovò il modo di assolvere Dimitrov pure
ci fu, quando le cose erano già precipitate e la “Terza Repubblica” si stava già
insediando. Ieri ci si è limitati a Mancino.
Stato- mafia: seconda requisistoria: «Niente prove, ma non
servono», scrive il 17 Dicembre 2017 "Il Dubbio". Per
i magistrati ci sarebbe “un elemento costituito dalle stesse perle di Mori e De
Donno alla Corte d’Assise di Firenze”. Davanti alla Corte d’assise di Palermo,
presieduta da Alfredo Montalto, va in scena la seconda puntata della
requisitoria dei pm del processo per la “trattativa” Stato- mafia. È stata la
volta di sostituto della Procura nazionale antimafia, Nino Di Matteo, che cita
in primo luogo l’audizione, il 20 marzo 1992, nelle commissioni parlamentari
dell’allora capo della Polizia Vincenzo Parisi e del ministro dell’interno,
Vincenzo Scotti. “Il decreto sul carcere duro, il 41 bis, – ha detto Di Matteo –
nacque esclusivamente sull’asse Martelli- Scotti, ministri della Giustizia e
dell’Interno. Fu varato l’otto giugno 1992 anche se la prima vera applicazione
avvenne dopo la strage di via D’Amelio. Il clima nel nostro Paese era di scontro
totale: il 41 bis era una questione che assillava Cosa nostra ed è su questo
terreno che si assiste in quel periodo alla contrapposizione tra due linee:
quella della fermezza (Scotti- Martelli) e quella della prudenza dettata dal
timore che dopo Capaci, Cosa nostra proseguisse nel suo progetto contro i
politici. In quello che Riina ave- va definito la “puliziata dei piedi”, ovvero
eliminare i rami secchi, cioè i politici che non avevano rispettato i patti,
prima di iniziare un nuovo percorso con nuovi referenti’. ‘ In questo clima
arroventato – ha continuato Di Matteo – si inserisce il dialogo, la mediazione o
per meglio dire la trattativa – tra il Ros, i suoi massimi vertici, cioè
Subranni, Mori e De Donno, con Vito Ciancimino’. E Vito Ciancimino viene
individuato quale ‘ canale privilegiato per avviare la trattativa – ha aggiunto
– in virtù dei pregressi rapporti esistenti tra Mario Mori e l’avvocato Ghiron,
quest’ultimo divenuto poi legale di Vito Ciancimino’. Il pm traccia lo scenario:
‘ Voglio partire da una elemento di prova acquisito quando nessuno ipotizzava di
aprire una indagine sui vertici del Ros e su Vito Ciancimino. Questo elemento di
prova è costituto dalle stesse parole di Mori e De Donno davanti alla Corte
d’assise di Firenze. Parole chiare – secondo Di Matteo – inequivoche che non
lasciano spazio al dubbio sull’esistenza della trattativa”.
Trattativa Stato-mafia, Calenda: "Preoccupano i pm alle riunioni
di partito". Il ministro dimissionario contro Di
Matteo. Forzisti all'attacco. Di Maio: "Sentenza che fa da spartiacque".
L'associazione Rita Atria: "No ai berlusconiani nel governo", scrive Claudio
Reale il 21 aprile 2018 su "La Repubblica". "Non conosco i fatti a sufficienza e
in mancanza di approfondimento tendo a non commentare sentenze della
magistratura. Sul piano della comunicazione magistrati che vanno a riunioni di
partito e fanno dichiarazioni che vanno oltre le sentenze mi preoccupano". Il
ministro dimissionario Carlo Calenda va all'attacco il giorno dopo la sentenza
sulla trattativa Stato-mafia e soprattutto sulle polemiche seguite alle
dichiarazioni di Nino Di Matteo, che ieri aveva parlato di un verdetto che
"sancisce i rapporti col Berlusconi politico". Su Di Matteo piovono soprattutto
gli strali forzisti: "A pensar male si fa peccato - dice la deputata Micaela
Biancofiore - ma mi sembra perlomeno curiosa la coincidenza della presenza ad
Ivrea al convegno dei 5 stelle del pm Di Matteo, con relativa ovazione contro
Berlusconi, e il fatto che alla vigilia della sentenza di ieri, sia saltato
proprio il governo dato per fatto centro destra-5 stelle. Forse qualcuno sapeva
e ha rivelato l'esito della sentenza per impedire la soddisfazione del voto
espresso dagli italiani". Le conseguenze, del resto, sono intrinsecamente
politiche. "Siamo in un momento del Paese, da ieri, in cui stiamo riscrivendo i
libri di storia - dice il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio -
È un nuovo futuro. La sentenza di ieri di Palermo è uno spartiacque tra passato
e futuro del Paese". "Noi - dice l'associazione Rita Atria - chiediamo che le
forze politiche parlamentari, elette in rappresentanza del popolo italiano,
isolino politicamente Forza Italia (non ci risulta che all'interno di Forza
Italia sia stato aperto un dibattito sulla problematica e quindi riteniamo siano
ancora compatti con il loro leader e fondatore), la cui genesi ormai è scritta
in due sentenze di due tribunali italiani, e rifiutino come irricevibile ogni
proposta di governo che contempli la presenza del partito tra le forze di
maggioranza o in appoggio esterno all'esecutivo". "La mia considerazione -
commenta il presidente della Lombardia, il leghista Attilio Fontana - è che
forse questa sentenza è caduta in un momento non del tutto opportuno. E diciamo
che forse sarebbe stato meglio non subordinare scelte politiche a questioni
extrapolitiche. Non voglio ventilare nulla, ma dico che casualmente cade male e
ora sarà il nostro segretario Matteo Salvini a fare le scelte del caso". Il
mondo dell'antimafia, dal canto suo, adesso tira le somme. "Avevamo sempre
saputo e sospettato che vi fosse una trattativa tra Stato e mafia - dice Alice
Grassi, figlia di Libero, l'imprenditore ucciso dalla mafia per essersi
ribellato al racket - Proprio in quegli anni, nel 1991 è stato ucciso mio padre,
o lo Stato non aveva gli strumenti o palesemente non interveniva per debellare
questo fenomeno. Mio padre in quell'intervista rilasciata a Michele Santoro, a
Samarcanda, parla della qualità del consenso. Se era la mafia che condizionava
il voto, è ovvio che ci ritrovavamo tra i nostri legislatori la gente che
difendeva i 'diritti' dei mafiosi e non della gente perbene". Sulla stessa linea
d'onda il sindaco di Palermo Leoluca Orlando: "I palermitani - dice - lo sanno,
lo hanno sempre saputo; oggi grazie al lavoro coraggioso e puntiglioso di alcuni
magistrati, ai quali non è mai mancato il sostegno e l'incoraggiamento della
società civile e del Comune di Palermo, abbiamo anche le prove confermate da una
sentenza: in quegli anni un pezzo importante dello Stato tradì lo Stato e i
cittadini per farsi mafia, permettendo alla mafia di farsi Stato".
La crociata di Di Matteo, pm anti Berlusconi e "ministro" dei
grillini. Il magistrato attacca il leader azzurro che
ha fatto saltare il governo Lega-M5s, scrive Domenico Di Sanzo, Domenica
22/04/2018, su "Il Giornale". La solita tempistica della toga. Silvio Berlusconi
attacca il Movimento Cinque Stelle e Nino Di Matteo, magistrato antimafia
innamorato dei grillini, se la prende con il leader di Forza Italia. Il
Cavaliere è colpevole, soprattutto di aver fatto saltare i piani di Luigi Di
Maio per un governo Lega-M5s. E venerdì, nel giorno della sentenza di primo
grado del processo sulla presunta trattativa tra lo Stato e la mafia, è partita
la contraerea. Di Matteo ha così argomentato, in merito alla condanna di
Marcello Dell'Utri: «Oggi la correlazione con Cosa Nostra non riguarda il Silvio
Berlusconi imprenditore ma il Silvio Berlusconi politico». Il magistrato,
nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha proseguito: «Dell'Utri ha
fatto da cinghia di trasmissione tra le richieste di Cosa Nostra e l'allora
governo Berlusconi, che si era da poco insediato». Forza Italia ha annunciato
querela, ma quello che desta maggiore sospetto nell'intemerata dell'eroe della
trattativa è, appunto, il tempismo. Berlusconi nella stessa giornata aveva
stroncato ogni ipotesi di accordo tra il centrodestra e il M5s. E Di Matteo, che
per molti sarà pure una specie di santino, di certo non è imparziale. L'amore
con i 5 Stelle, dopo anni di abboccamenti reciproci, scoppia ufficialmente a
fine maggio del 2017. Il pm della trattativa, sostituto alla Direzione Nazionale
Antimafia, va a Montecitorio e partecipa al convegno organizzato dai deputati
del Movimento sulle «visioni e questioni della giustizia». Nel parterre ci sono
anche Marco Travaglio, giornalista preferito dei grillini, e Piercamillo Davigo,
l'ex pm di Mani Pulite che Beppe Grillo voleva addirittura come candidato
premier. Già allora si parlava di Di Matteo come del possibile Ministro
dell'Interno del governo a 5 Stelle. Lui si schermiva: «L'impegno in politica di
un pm non mi scandalizza». E a chi gli domandava se volesse sedersi sulla
poltrona del Viminale non rispondeva. Né conferme né smentite. Ma si dice che
l'operazione non gli dispiacesse affatto. Nel frattempo l'eroe, dopo la
dipartita di Antonio Ingroia, a Palermo ha continuato ad occuparsi del processo
sulla trattativa. E, all'inizio di novembre dell'anno scorso, ha convinto la
Procura di Firenze a riaprire il procedimento sulle stragi del '92-93. Per la
toga amica dei 5 Stelle toccava ripartire dalle dichiarazioni del pentito
Giuseppe Graviano, che parlavano di Berlusconi come del «mandante» di quelle
bombe. Ma la fedeltà grillina e l'ossessione per il Cav non sono bastate per la
scalata al Viminale o al Ministero della Giustizia. Luigi Di Maio, nella sua
squadra di ministri, ha indicato, rispettivamente, per i due dicasteri la
criminologa dell'Università Link Campus Paola Giannetakis e il fedelissimo
avvocato siciliano Alfonso Bonafede. Però Di Matteo non ha abbandonato il campo
dell'impegno tra le fila pentastellate. Il 7 aprile scorso, a Ivrea durante la
kermesse organizzata da Davide Casaleggio, l'intervento del pm è stato tra i più
applauditi. In quell'occasione Di Matteo aveva parlato di un «patto tra
Berlusconi e la mafia durato 18 anni». Standing ovation del pubblico. Dallo
stesso palco la star giudiziaria del M5s si era fatta portavoce del programma di
Di Maio sulla giustizia. Dagli «agenti provocatori» anti corruzione fino
«all'ampliamento dell'uso delle intercettazioni». Insomma, niente di nuovo sotto
le 5 stelle.
Stato-Mafia, sulla trattativa di governo irrompe quella con Cosa
nostra, scrive il 21 Aprile 2018 Francesco Specchia su
“Libero Quotidiano”. Non è solo una decisione storica striata di politico,
ammettiamolo. Non è soltanto una bomba sganciata al cuore aritmico delle
istituzioni, alla sacralità del «corpo dello Stato», la sentenza della Corte di
Assise di Palermo che condanna, assieme ai mafiosi, gli ex vertici del Ros e
Marcello Dell' Utri, protesi extraparlamentare di Berlusconi (e che quindi, per
sillogismo, condannerebbe moralmente pure Berlusconi...). Dopo anni di processi
e migliaia d' imputati, di cadaveri, di fascicoli e riesami, la consacrazione
giudiziaria della trattativa Stato/mafia non dà solo corpo a «ai rapporti
esterni della mafia con le istituzioni negli anni delle stragi sotto i governi
Ciampi e Berlusconi». No. Essa, oggi, letta in controluce, assume quasi la
funzione di grimaldello per scardinare lo stallo tra Lega e Cinque Stelle nella
formazione del nuovo governo. Quasi un'accelerata, dal tempismo innaturale, per
eliminare del tutto Berlusconi dalla pochade delle consultazioni con la coda fra
le gambe. Basta scorrere i commenti del Movimento.
«La trattativa Stato-mafia c' è stata. Con le condanne di oggi muore
definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai magistrati di Palermo che hanno
lavorato per la verità», twitta Luigi Di Maio. Ed ecco che gli si accodano gran
parte dei Cinque Stelle che contano. Riccardo Fraccaro dice: «Dell' Utri fece da
tramite tra Cosa nostra e Berlusconi: politicamente è una pietra tombale sull'
ex Cavaliere.
Ora Salvini decida». Carlo Sibilia scrive: «Berlusconi è una persona che deve
sparire dalla scena politica nazionale».
Di Battista rincara: «Ora il Caimano sarà ancora più nervoso. Il suo sistema di
potere gli sta franando sotto i piedi...».
E il tutto può esser interpretato sia come un invito affinchè la Lega si mondi
dal peccato originale arcoriano; sia, soprattutto, come un sotterraneo sostegno
a smuoversi verso il Pd. Se la lettura politica della sentenza si basa su una
temperie di ammicchi e percezioni, quella giudiziaria è una mazzata. Gli ex
vertici del Ros Mario Mori e Antonio Subranni sono stati condannati a 12 anni
per minaccia a corpo politico dello Stato. A 12 anni, per lo stesso reato, è
stato condannato l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell' Utri; a 28 anni,
sempre per minaccia a corpo politico dello Stato, il capo mafia Leoluca
Bagarella. Per lo stesso reato dovrà scontare 12 anni il boss Antonino Cinà.
Otto anni all' ex ufficiale del Ros Giuseppe De Donno, per le stesse
imputazioni. Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo - che
con ambigue rivelazioni nel 2008 riaprì il caso che era già stato archiviato per
ben due volte- già accusato in concorso in associazione mafiosa e calunnia
dell'ex capo della polizia De Gennaro, si è beccato 8 anni. Prescritte le accuse
nei confronti del pentito Giovanni Brusca. Assolto, invece (l'unico) dall'
accusa di falsa testimonianza l'ex ministro Dc Nicola Mancino, la cui
intercettazione con l'ex Presidente Giorgio Napoletano fu oggetto di burrascose
polemiche. Oggi la trattativa Stato/mafia è comunque stata acclarata.
E questo nonostante lo scenario storico-politico sia completamente cambiato
rispetto rispetto agli anni 90, quando la miccia s' era accesa. Una miccia
lunga. Antonio Ingroia, l'ideatore del teorema giudiziario sulla trattativa
dello Stato con i boss non è più pm, è diventato un aspirante politico poi
trombato e successivamente indagato egli stesso. Il suo successore, il pm Nino
Di Matteo, si è trasferito alla Dna a Roma; ed è -guarda caso- considerato un
potenziale ministro della Giustizia da molti grillini. I principali imputati
boss, Bernardo Provenzano e Totò Riina, sono defunti. Inoltre esistono comunque
delle sentenze a latere che ne avevano smontato l'impianto accusatorio: quella,
per stralcio, dell'ex ministro Calogero Mannino; o quella del generale Mori, per
la mancata cattura di Provenzano. E, se vogliamo, ci sono pure le sentenze di
condanna, come quelle che sbugiardano, appunto, il teste chiave, Massimo
Ciancimino. Ciononostante, fermo restando che la legge è legge, la tempistica
rivela quasi un'efficienza inusitata per la giustizia italiana...di Francesco
Specchia
Palermo, trattativa Stato-Mafia parla Mancino: «Nessun accordo,
ho detto la verità», scrive Lunedì 16 Aprile 2018 "Il
Messaggero". La sentenza è attesa per la fine di questa settimana. Oggi però,
nel corso dell'ultima udienza, ha preso la parola l'ex ministro Nicola Mancino.
Si è rivolto alla corte d'assise di Palermo che dovrà emettere la sentenza e ha
ripetuto quel che da sempre va dicendo: lui la mafia l'ha combattuta senza
arretrare mai. Mancino è l'unico imputato del processo sulla cosiddetta
trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra a rivolgersi ai magistrati prima
della camera di consiglio che deciderà le sorti del dibattimento. «Ho sofferto
in tutto questo periodo e soffro ancora pur essendo consapevole di avere sempre
detto la verità», dice respingendo l'imputazione per cui è finito a giudizio:
l'avere mentito davanti ai giudici che processavano il suo attuale coimputato,
il generale Mario Mori, per favoreggiamento al boss Bernardo Provenzano. Un
giudizio «clone» rispetto a quello in corso sulla trattativa conclusosi con
l'assoluzione dell'ufficiale. Il reato che si contesta a Mancino e per cui i pm
hanno chiesto la condanna a 6 anni è dunque la falsa testimonianza. Altra cosa
rispetto alla minaccia a Corpo politico dello Stato e al concorso in
associazione mafiosa contestate agli altri imputati: i boss Leoluca Bagarella e
Nino Cinà, Massimo Ciancimino, Marcello Dell'Utri, il pentito Giovanni Brusca e
gli ex vertici del Ros. Mancino avrebbe detto il falso, negando che l'allora
Guardasigilli Claudio Martelli, già nel '92, gli avesse accennato ai suoi dubbi
sull'operato dei carabinieri di Mori e sui suoi rapporti con l«ex sindaco
mafioso Vito Ciancimino. «Non ne abbiamo mai parlato», ha sempre detto
Mancino, smentendo il collega di governo. «E non capisco perché tra me e
Martelli si debba credere a lui», ribadisce oggi. In effetti sulla discordanza
tra le testimonianze un tribunale si è già pronunciato, sollevando dubbi forti
sulla ricostruzione dell'ex Guardasigilli. Ma questo non è bastato a salvare
l'ex ministro dell'Interno messo, secondo i pm, alla guida del Viminale perché
fautore di una linea più soft verso la mafia rispetto al suo predecessore
Vincenzo Scotti. Una scelta che, per l'accusa, rientrava tutta nella trattativa
intavolata dallo Stato, tramite il Ros di Mori, e fatta di concessioni e
impunità ai boss in cambio della fine della stagione stragista. Su un punto,
però, Mancino accenna a un'autocritica: a posteriori penso che sarebbe stato
preferibile non telefonare a D'Ambrosio. Ma ero preoccupato, eravamo in piena
bufera giornalistica, spiega ai giudici ricordando le conversazioni intercettate
con l'ex consigliere giuridico del Colle in cui l'ex ministro cercava di evitare
il confronto, chiesto dalla Procura, con Martelli. Intercettazioni che, secondo
l'accusa, proverebbero il timore di Mancino nell'affrontare davanti al tribunale
l'ex collega. «Per me era un confronto inutile - spiega però - E a Grasso
(Piero Grasso, allora capo della Dna ndr) non chiesi mai l'avocazione
dell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia, ma solo il coordinamento
dell'azione delle sei procure coinvolte nell'indagine. C'era troppa confusione:
basta pensare che nessun ufficio inquirente riteneva attendibile Ciancimino,
mentre Ingroia, allora alla Procura di Palermo, dichiarava che avrebbe valutato
le sue dichiarazioni volta per volta». Subito dopo la difesa di Mancino la
corte entra in camera di consiglio. L'accusa si era congedata con una polemica
finale con le difese e i toni tenuti durante le arringhe. Ma gli avvocati non
replicano. Il verdetto è atteso nei prossimi giorni: per la procura sarà
presente anche Nino Di Matteo, pm storico del processo ora in Dna.
Stato-mafia. Martelli. Condannato chi arrestò Totò Riina,
scrive il 21 aprile 2018 agenpress.it. “Sono contento per Mancino assolto, ma
non comprendo una responsabilità così grave in capo ai vertici del Ros,
giudicata in precedenza in modo totalmente difforme dallo stesso Tribunale di
Palermo. Un rompicapo pirandelliano generato da giudizi difformi. Sembravano più
robusti gli elementi nell’accusa di aver lasciato libero Provenzano, o non aver
perquisito il covo di Riina, ossia un accordo in cambio di sconti di pena o
dell’impunità”. Lo dice al Messaggero Claudio Martelli, all’epoca della
trattativa Stato-mafia ministro della Giustizia, per il quale è singolare che
siano state “rimosse le responsabilità politiche” e riconosciuto il dolo dei
vertici del Ros. “Gli ufficiali dei carabinieri condannati sono gli stessi che
hanno guidato l’arresto del capomafia per eccellenza, Riina. Suscita sgomento
assiemare i birri e gli sbirri, direbbe Manzoni, e solleva interrogativi e
perplessità”. Il loro comportamento, afferma, “fu poco chiaro, scorretto. Mai
però li ho considerati ufficiali felloni. Ho pensato a un eccesso di potere
nello sviluppare indagini in proprio, nel cercare coperture politiche dal
ministero della giustizia o dal presidente della commissione parlamentare
antimafia Violante, nel non riferire alla Dia, ai magistrati. Mai però ho
immaginato che quel comportamento configurasse un reato così grave. Quale
sarebbe il corpo politico dello Stato sottoposto a minacce o violenza?”.
Claudio martelli in difesa dei vertici del ros: sono state
rimosse le responsabilità politiche, scrive il 21
aprile 2018 Marco Ventura per “il Messaggero”. «Gli ufficiali dei carabinieri
condannati sono gli stessi che hanno guidato l’arresto del capomafia per
eccellenza, Riina. Suscita sgomento assiemare i birri e gli sbirri, direbbe
Manzoni, e solleva interrogativi e perplessità». Per Claudio Martelli, all’
epoca ministro della Giustizia, è singolare che siano state «rimosse le
responsabilità politiche» e riconosciuto il dolo dei vertici del Ros. Il loro
comportamento «fu poco chiaro, scorretto. Mai però li ho considerati ufficiali
felloni. Ho pensato a un eccesso di potere nello sviluppare indagini in proprio,
nel cercare coperture politiche dal ministero della giustizia o dal presidente
della commissione parlamentare antimafia Violante, nel non riferire alla Dia, ai
magistrati. Mai però ho immaginato che quel comportamento configurasse un reato
così grave. Quale sarebbe il corpo politico dello Stato sottoposto a minacce o
violenza?»
Il governo?
«Quale governo? L’accusa al governo Andreotti regge poco, Mannino è uscito
assolto dallo stralcio di processo, e già era paradossale accusarlo di violenza
o minaccia all’esecutivo di cui faceva parte. Sono contento per Mancino assolto,
ma non comprendo una responsabilità così grave in capo ai vertici del Ros,
giudicata in precedenza in modo totalmente difforme dallo stesso Tribunale di
Palermo. Un rompicapo pirandelliano generato da giudizi difformi. Sembravano più
robusti gli elementi nell’ accusa di aver lasciato libero Provenzano, o non aver
perquisito il covo di Riina, ossia un accordo in cambio di sconti di pena o
dell’impunità.»
Quali le responsabilità politiche rimosse?
«C’era una pista non trascurabile: le dichiarazioni di Conso, l’ex ministro
della Giustizia che mi sostituì nel febbraio ’93, che forse in un eccesso di
generosità, forse nell’ intento di non nascondersi chiamando in causa livelli
più alti del suo, si assunse la responsabilità confessando d’ aver voluto dare
un segnale di disponibilità all’ ala moderata di Cosa Nostra con la revoca a
centinaia di mafiosi del regime carcerario del 41bis».
Due pesi e due misure, verso il Ros e verso i politici?
«Mannino era uscito dal processo, Conso è morto, né si può intentare un processo
alla memoria di Scalfaro, se ne occuperanno semmai gli storici».
Perché Scalfaro?
«Ci sono alcuni episodi, dalla sostituzione di Scotti con Mancino ministro
dell’Interno a quella improvvisa di Niccolò Amato direttore degli Affari
penitenziari con un uomo segnalato a Scalfaro dai cappellani delle carceri. Lui
li convoca, loro si lamentano della durezza di Amato, lui chiede il nome di un
magistrato che lo sostituisca, lo si individua, e Amato viene rimosso. Colpisce
che il Presidente si occupi di questo. E che la strategia rigorosa mia, di
Scotti e di Falcone, stroncare cupola ed esercito della mafia, sia stata
interrotta, il che non ha impedito poi l’arresto di tutti i latitanti… Difficile
che Conso, grande giurista ma non esperto di lotta a Cosa Nostra, da solo si
fosse immaginato lo stop alle stragi attraverso il 41bis. E che avesse coscienza
già nella primavera 93 che esistevano due linee nella Cupola: Riina stragista,
Provenzano trattativista».
E la condanna di Marcello Dell’ Utri?
«La sua responsabilità sembra arrestarsi al ’93, prima che il governo Berlusconi
si insediasse. Di Maio la butta in politica e così rischia in realtà di buttarla
in cagnara, aggiungendo veleni alla partita che si è aperta nel centrodestra.
Non mi sembra che Berlusconi sia direttamente coinvolto.»
La verità qual è?
«C’ è stato un brusco cambio di strategia anti-mafia all’ indomani delle mie
dimissioni, sapevano che la linea di Conso io non l’avrei mai perseguita anzi
l’avrei denunciata. Però ho sempre parlato di responsabilità politiche, ho
raccontato la visita del capitano De Donno alla vice di Falcone, Ferraro, in cui
chiedevano cose che non dovevano chiedere: la copertura politica a un’indagine
fatta in solitudine. Questo mi inquietò, chiesi spiegazioni, ne informai
Borsellino, ma mai ho pensato che ci fosse dolo. Sull’altro fronte mi colpisce
che le responsabilità politiche affiorate di tanto in tanto siano state tenute
in non cale».
Con una fuga di notizie infilzarono Craxi. 25 anni fa la congiura
che lo escluse da palazzo Chigi, scrive Francesco
Damato il 10 giugno 2017 su "Il Dubbio". Dopo la strage di Capaci e l’elezione
in 48 ore di Oscar Luigi Scalfaro al Quirinale, dove per quindici votazioni
avevano inutilmente tentato di arrivare, con candidature formali o sotterranee,
Arnaldo Forlani, Giulio Andreotti e persino il presidente uscente e
dimissionario Francesco Cossiga, nulla fu più uguale sul piano politico.
Terminato di comporre il suo staff al Quirinale il 4 giugno con la nomina del
generale Paolo Scaramucci a consigliere militare, Scalfaro predispose le
consultazioni per la formazione del nuovo governo: quello di esordio della
legislatura nata con le elezioni del 5 e 6 aprile. Ma la prima sfilata delle
delegazioni dei partiti davanti al capo dello Stato terminò il 10 giugno senza
altro risultato che la constatazione di un clima politico irrespirabile, con
veti e controveti all’interno e all’esterno della maggioranza uscente composta
da democristiani, socialisti, socialdemocratici e liberali. Era una maggioranza
peraltro troppo risicata per fronteggiare una difficile situazione economica e
un’ancora più difficile situazione politica nel contesto delle indagini
giudiziarie in corso a Milano su Tangentopoli. Scalfaro non riuscì a venirne a
capo neppure moltiplicando le sue preghiere alla Madonna di Lourdes, dove
peraltro si era proposto prima della imprevista elezione a capo dello Stato di
recarsi in pellegrinaggio. Si scusò della rinuncia esortando gli organizzatori
del viaggio a pregare anche perché lui venisse illuminato. In attesa di un
secondo giro di consultazioni formali, il presidente della Repubblica vide o
sentì privatamente un’infinità di amici, fra i quali i ministri uscenti
dell’Interno e della Giustizia: il democristiano Enzo Scotti e il socialista
Claudio Martelli, invitati insieme al Quirinale formalmente per discutere di un
provvedimento in gestazione per intensificare la lotta alla mafia dopo la strage
di Capaci. Ma il discorso scivolò subito sul tema della formazione del governo.
Vuoi su sollecitazione di Scalfaro, come poi avrebbe raccontato Martelli, vuoi
di iniziativa dei due ministri, il capo dello Stato ricavò l’impressione, a
torto o a ragione, che fossero entrambi convinti di potere insieme tentare la
formazione di un governo di decantazione, scambiandosi i ruoli di presidente e
vice presidente, capace di guadagnarsi se non l’appoggio, almeno la benevola
opposizione del Pds- ex Pci guidato da Achille Occhetto. Informato, non si è mai
ben capito se dallo stesso Scalfaro, col quale aveva allora eccellenti rapporti,
tanto da averne sostenuto con la solita baldanza l’elezione prima a presidente
della Camera e poi a capo dello Stato, Marco Pannella confidò la cosa a Bettino
Craxi. Che – convinto di avere ancora buone carte da giocare per tornare a
Palazzo Chigi, da dove riteneva di essere stato allontanato malamente da Ciriaco
De Mita nel 1987, con la storia di una staffetta con Andreotti prima promessa
per l’ultimo anno della legislatura e poi negata – a sentire Pannella cadde
dalle nuvole. Ma di brutto, perché se la prese subito con Martelli, essendo
ancora convinto che Scalfaro gli fosse leale, come lo era stato al Ministero
dell’Interno nei quattro anni di governo da lui presieduto: tanto leale non solo
da avere rifiutato di prestarsi a fare il governo elettorale offertogli da De
Mita, come ho già ricordato qui, ma anche da avere cercato e trovato una decina
d’anni prima negli archivi del Viminale un documento da tutti negato in
precedenza, ma utile alla difesa dei socialisti finiti sotto processo a Milano
per gli attacchi ai pubblici ministeri che avevano indagato per l’assassinio di
Walter Tobagi. Era un’informativa dei servizi segreti che nel 1980 aveva
inutilmente segnalato il pericolo di un imminente agguato mortale delle brigate
rosse al famoso giornalista del Corriere della Sera, peraltro amico personale
del leader socialista. Notizia di quell’informativa era stata data personalmente
a Craxi all’indomani dell’uccisione del povero Walter dal generale dei
Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa. Craxi girò la confidenza di Pannella
sull’incontro di Scotti e Martelli con Scalfaro al segretario della Dc Arnaldo
Forlani, facendo cadere dalle nuvole pure lui. Ed entrambi si ripromisero di
punire, diciamo così, i due giovani aspiranti alla guida del nuovo governo o non
confermandoli ai loro posti o lasciandoli proprio fuori. Ma né l’uno né l’altro
ebbero poi la voglia di raccontare come fossero veramente andate le cose, dopo
molti anni, ai magistrati di Palermo che li interrogarono sulle presunte
trattative fra lo Stato e la mafia della stagione stragista. Essi diedero agli
inquirenti l’impressione di essere stati sacrificati perché contrari a quelle
trattative, contribuendo così all’impianto accusatorio del processo contro
mafiosi, generali e uomini politici ancora in corso a Palermo. Ma da cui è stato
già assolto, avendo scelto il rito abbreviato, l’ex ministro democristiano
Calogero Mannino, che pure era stato accusato di essere stato addirittura il
promotore della trattativa per scongiurare una minaccia della mafia alla sua
vita. Non ci fu tuttavia soltanto l’incidente o l’equivoco della coppia Scotti-
Martelli durante le consultazioni informali di Scalfaro per la formazione del
nuovo governo. Ci fu anche, fra l’altro, una rovinosa fuga di notizie sui
documenti pervenuti dalla Procura di Milano alla Camera, e assegnati subito alla
giunta delle cosiddette autorizzazioni a procedere per Tangentopoli sul conto
degli ex sindaci di Milano Paolo Pillitteri e Carlo Tognoli, entrambi
socialisti. Il “verde”, ed ex direttore del Manifesto, Mauro Paissan fu
indicato, a torto o a ragione, come fonte di quella fuga con interpretazioni
troppo estensive di alcune parti dei fascicoli, da cui avrebbe ricavato, come
esponente dell’apposita giunta di Montecitorio, l’impressione di un
coinvolgimento anche di Craxi nelle indagini chiamate Mani pulite. Ricordo
ancora nitidamente quella giornata in cui le agenzie avevano inondato le
redazioni dei giornali di lanci a dir poco allarmanti sulla posizione
giudiziaria del segretario socialista ancora in corsa per il ritorno a Palazzo
Chigi. Nelle prime ore del pomeriggio, tornando a piedi da casa alla redazione
del Giorno, di cui ero direttore, incrociai per caso in Piazza della Scala
Antonio Di Pietro, il magistrato ormai simbolo di quell’inchiesta che stava
demolendo la cosiddetta prima Repubblica. Allontanata la scorta con un cenno di
mano, “Tonino” mi disse che nelle carte partite da Milano per la Camera non
c’erano elementi contro Craxi, di cui lui parlava volgendo lo sguardo verso la
Galleria, cioè verso gli uffici milanesi del segretario del Psi. E mi
preannunciò un comunicato della Procura, che in effetti fu diffuso dopo qualche
ora per precisare che nulla risultava “allo stato” delle indagini contro Craxi.
Il quale tuttavia il giorno dopo si trovò su tutte le prime pagine dei giornali
ugualmente come uno ormai compromesso nell’inchiesta. Non ricordo se l’ho già
riferito ai lettori del Dubbio in altre circostanze riferendo del biennio
“terribile” 1992- 93, ma il clima nei giornali, ormai di tutte le tendenze, era
tale che la sera di quel giorno mi telefonò l’amico Ugo Intini, portavoce di
Craxi, per chiedermi come avessi deciso di uscire con la prima pagina del
Giorno. Alla confidenza che sarei uscito col titolo sul comunicato di smentita
diffuso dalla Procura, che ai miei occhi costituiva l’unica notizia certa della
giornata rispetto a tutte le voci col condizionale diffuse dalle agenzie, Ugo mi
chiese se poteva consigliare al comune amico Roberto Villetti, direttore
dell’Avanti, di chiamarmi. Cosa che Villetti fece subito, ma non per
consultarsi, come si aspettava il povero Intini, bensì per dissentire fermamente
dal modo garantista in cui avevo deciso di titolare. Rimasi francamente di
stucco. Neppure Scalfaro al Quirinale dovette rimanere convinto del comunicato
della Procura milanese se volle parlarne direttamente col capo Francesco Saverio
Borrelli, peraltro figlio di un suo vecchio collega ed amico. L’impressione che
ne ricavò l’uomo del Colle fu di paura di mandare a Palazzo Chigi un “amico” –
quale ancora egli considerava il suo ex presidente del Consiglio – destinato
prima o dopo ad essere davvero coinvolto nelle indagini, come avvenne a fine
anno con i primi avvisi di garanzia, e poi anche con richieste di arresto. Lo
stesso Craxi mi raccontò di essersi sentito dire da Scalfaro all’incirca così:
“Tu sai quanto ti stimi e ti voglia bene, ma è opportuno, anche nel tuo
interesse, che tu faccia un passo indietro in questo momento. Dimmi tu stesso il
nome di un socialista al quale io possa dare l’incarico”. E il 10 giugno, nel
secondo ed ultimo giro di consultazioni, Craxi maturò la decisione del doloroso
passo indietro. Che annunciò personalmente all’uscita dall’ufficio del capo
dello Stato dicendo di avergli indicato “in un ordine non solo alfabetico”
Giuliano Amato, già ministro con De Mita e suo sottosegretario a Palazzo Chigi,
Gianni De Michelis e Claudio Martelli. La delegazione della Democrazia
Cristiana, ricevuta per ultima, non ebbe così neppure la possibilità di proporre
Craxi, contro la cui destinazione si erano già espressi nel partito alcuni
esponenti, fra i quali De Mita, convinti che Palazzo Chigi spettasse ancora alla
Dc, nonostante il ritorno di un democristiano al Quirinale dopo il movimentato
settennato di Cossiga. Pertanto fu Amato l’uomo al quale Scalfaro diede
l’incarico, che fu espletato con una certa difficoltà, avendo impiegato il nuovo
presidente del Consiglio una decina di giorni, sino al 28 giugno, per la
definizione del programma e soprattutto della lista. Dove Scotti risultò
spostato dal Viminale alla Farnesina, che formalmente era una promozione, da lui
però rifiutata perché Forlani aveva deciso di sperimentare dentro la Dc la
incompatibilità fra le cariche di ministro e di deputato o senatore. Scotti
reclamò inutilmente una deroga per conservare il mandato parlamentare, che alla
fine preferì alla guida della diplomazia italiana. Martelli invece entrò nella
lista all’ultimo momento, dopo essere andato da Craxi, su suggerimento dello
stesso Amato, per chiedergli di essere confermato al Ministero della Giustizia,
come poi mi avrebbe raccontato lo stesso Craxi, per portare a termine il lavoro
svolto col povero Giovanni Falcone, suo prezioso collaboratore sino alla morte –
e che morte – come direttore degli affari penali del dicastero di via Arenula. E
Craxi acconsentì, parendogli – mi disse – “una richiesta umanamente
ragionevole”, lungi forse dall’immaginare che Martelli fosse destinato pure lui
dopo qualche mese ad essere investito da Tangentopoli e costretto alle
dimissioni. Comunque, Martelli fu l’ultimo ministro e il primo governo di Amato
l’ultimo sul quale il leader socialista riuscì a dire la sua, perché di fatto in
quel mese di giugno di 25 anni fa al falconicidio col sangue, preceduto
dall’ostracismo in vita praticatogli da tanti colleghi, seguì il craxicidio
senza sangue. I rapporti di Craxi con Scalfaro rimasero buoni ancora per poco.
Col procedere delle indagini e del linciaggio politico da cui pochi lo difesero,
neppure quando subì il famoso lancio di monetine e insulti davanti all’albergo
romano dove abitava, e donde usciva per andare ad una trasmissione televisiva
dopo essere scampato a scrutinio segreto ad alcune, le più gravi, delle
autorizzazioni a procedere chieste contro di lui dalla magistratura, il leader
socialista si fece del presidente della Repubblica l’idea da lui stesso espressa
in una serie di litografie raffiguranti falsi “extraterrestri”: finti
inconsapevoli del finanziamento generalmente illegale della politica e delle
forzature con le quali la magistratura aveva deciso di trattarlo. Oltre a
Scalfaro, furono definiti extraterrestri anche Achille Occhetto, Eugenio
Scalfari, Giorgio Napolitano e l’ormai compianto Giovanni Spadolini, la cui foto
fu sostituita con un manifesto bianco listato a lutto. Craxi stesso mi raccontò
nel suo rifugio di Hammamet di avere scritto più volte al presidente della
Repubblica, anche come presidente del Consiglio Superiore della Magistratura,
contro gli eccessi che stavano compiendo i magistrati, ma di non avere mai
ricevuto una risposta, né diretta né indiretta. Il Quirinale non lo considerò
più degno di riconoscimento alcuno. Ci vollero del resto la morte di Craxi e
l’arrivo sul colle più alto di Roma di Giorgio Napolitano perché un presidente
della Repubblica parlasse di lui riconoscendone il servizio politico reso al
Paese e lamentando, fra le solite proteste dei manettari in servizio permanente
effettivo, irriducibili anche di fronte alla morte, “la severità senza uguali”
con cui era stato trattato dalla magistratura. Proprio alla magistratura,
vantando di averne fatto parte, Scalfaro nel suo discorso di insediamento,
pronunciato il 28 maggio a Montecitorio, davanti alle Camere in seduta congiunta
con la partecipazione dei delegati regionali, aveva chiesto “energia, serenità e
perseveranza” parlando della “questione morale”. Di energia e perseveranza
sicuramente i magistrati si dimostrarono capaci nei mesi e negli anni
successivi. Di serenità, francamente, un po’ meno, nella sostanziale e
incresciosa disattenzione proprio di chi l’aveva reclamata insediandosi al
vertice dello Stato sull’onda peraltro di una strage neppure citata per luogo e
per nomi nel discorso alle Camere, essendosi Scalfaro limitato a parlare di una
“criminalità aggressiva e sanguinaria”, forse aiutata anche da qualche mano
straniera. Di cui nessuno, a dire il vero, aveva avuto sentore a Capaci e
dintorni.
È Stato contro la mafia. Chi era per la linea dura. Il caso di
Scotti e Martelli, scrive Francesco Bechis su
Formiche.net il 22 aprile 2018. Dalle rogatorie dei pm del processo
"Stato-Mafia" emerge un volto (buono) della politica che nessuno vuole
raccontare: il caso degli ex ministri Vincenzo Scotti e Claudio Martelli. La
politica esce malconcia, ma non distrutta, dalla sentenza della Corte d’Assise
di Palermo sulla cosiddetta trattativa Stato-Mafia, in cui vertici dello
istituzioni e delle forze armate si sarebbero ritrovati a scendere a patti con
Cosa Nostra per porre fine alla stagione stragista del 1992-1993. Una sentenza
di primo grado, che dunque lascia intatta la presunzione di innocenza degli
imputati: è bene ricordarlo a chi, preso dall’euforia, ha dato per chiusa la
fase processuale apertasi nel 2013. Se è giusto sottolineare l’impatto
dirompente che la sentenza letta venerdì pomeriggio dal presidente della corte
Alfredo Montalto avrà sullo scenario politico italiano, è altrettanto doveroso
ricordare che non tutta la politica di quegli anni è finita sul banco degli
imputati. Oltre all’ex ministro Nicola Mancino, assolto dall’accusa di falsa
testimonianza perché “il fatto non sussiste”, la chiusura della prima fase del
processo lascia integra, fra le altre, la figura di due uomini di Stato
protagonisti di quella stagione politica che a più riprese sono stati sentiti
dai magistrati in questi anni: l’ex ministro dell’Interno democristiano Vincenzo
Scotti e l’ex ministro della Giustizia socialista Claudio Martelli. E in
particolare gli atti, le dichiarazioni e le vicende politiche dell’attuale
presidente della Link Campus sono state usate come supporto delle tesi
accusatorie, confermando la totale estraneità di Scotti e Martelli ai fatti al
vaglio dei pubblici ministeri. La lunga requisitoria dei pm ha fatto ampio
ricorso alla vicenda pubblica di Scotti, che fu a capo del Viminale dall’ottobre
del 1990 al giugno del 1992. Significativi a riguardo alcuni stralci tratti
dall’esposizione degli elementi accusatori da parte del pm Roberto Tartaglia il
14 dicembre del 2017 e del pm Nino Di Matteo il 15 dicembre e l’11 gennaio 2018.
Secondo l’accusa tre sono i passaggi che provano la ferrea volontà dell' “asse
Scotti-Martelli” nella lotta senza compromessi contro la mafia. Il primo
consiste nel “cambio di passo” impresso da Scotti alla politica di contrasto
alla criminalità organizzata una volta ottenuto l’incarico agli Interni. Spiega
Tartaglia il 14/12: “Cosa Nostra vede in questi tre soggetti e in questi tre
poli (Scotti, Martelli, Falcone), l’emblema, l’immagine del cambiamento
dell’azione politica […]”. Un cambio di passo che prese forma in una serie di
iniziative concrete. Decisivo, ha spiegato Tartaglia, fu il decreto legge n. 60
del 1 marzo 1991 che delegava all’ “interpretazione autentica” del governo il
calcolo della decorrenza dei termini di custodia cautelare. Un intervento che
rimise in carcere 43 imputati mafiosi del maxi-processo che meno di un mese
prima erano stati liberati dopo una condanna di primo grado e che il pm nella
requisitoria definisce “un segnale devastante per le aspettative di Cosa
Nostra”. Rilevanti nella lotta alla mafia furono due riforme giudiziarie
introdotte dall’allora guardasigilli: la regola della turnazione nei ricorsi di
mafia in deroga del principio di competenza per materia, e infine
l’introduzione, il 15 gennaio del 1993, del 41-bis, il regime carcerario duro
per i mafiosi la cui paternità ancora oggi Martelli rivendica con orgoglio. Poi
il secondo passaggio della requisitoria che sottolinea la linea di fermezza del
ministro Scotti con il crimine organizzato: si tratta delle sue prese di
posizione pubbliche durante il mandato, dove non mancò mai di mettere al
corrente l’opinione pubblica e gli organi dello Stato di un piano “sovversivo”
di Cosa Nostra. Riecheggiano ancora oggi le dure parole del titolare del
Viminale, a pochi giorni dall’omicidio di Salvo Lima, in un’audizione
parlamentare del 17 marzo 1992: “Oggi, dopo questo omicidio, siamo in presenza
di un fenomeno che non mira a distruggere le istituzioni ma a piegarne gli
apparati ai propri fini, a condizionarli”. Preoccupazioni ribadite il 20 marzo
successivo davanti alla commissione Affari Costituzionali del Senato:
“Nascondere ai cittadini che siamo di fronte ad un tentativo di
destabilizzazione delle istituzioni da parte della criminalità organizzata è un
errore gravissimo. Io ritengo che ai cittadini vada detta la verità e non
edulcorata, la verità: io me ne assumo tutta la responsabilità”. L’allora
premier Giulio Andreotti definì “una patacca” l’allarmismo del suo ministro,
scatenando involontariamente un polverone mediatico che non fu privo di
strumentalizzazioni. A dare ulteriore conferma della rettitudine dell’operato di
Scotti e Martelli, secondo i pm del processo sulla “trattativa”, ci sarebbe
infine la tesi del “golpe bianco”. Nella requisitoria dello scorso 11 gennaio il
pm Nino Di Matteo sostiene che la “prima condizione essenziale nel 1992 per
portare avanti la linea del dialogo con la mafia era quella di cacciare Scotti
dalla titolarità del Viminale”. L’avvicendamento del ministro dell’Interno con
Nicola Mancino nel giugno 1992, che portò Scotti alla guida della Farnesina (su
indicazione del presidente della Dc Ciriaco De Mita) mentre Giuliano
Amato entrava a Palazzo Chigi, fu letto da molti come un promoveatur ut
amoveatur. Anche l’uscita di Martelli dal Ministero della Giustizia nel febbraio
del 1993 attirò gli stessi sospetti. Di Matteo è sicuro che non si è trattato di
due semplici avvicendamenti: il pm palermitano l’11 gennaio ha affermato che è
stata messa in atto piuttosto una strategia per “liberarsi di chi della
contrapposta linea del rigore e delle intransigenza aveva fatto la sua bandiera
e lo aveva dimostrato con i fatti”. Chiamato a parlare davanti alla Corte
d’Assise di Palermo, Martelli in questi anni ha confermato la tesi della
“rimozione forzata” del 1993, dovuta soprattutto, a suo parere, all’introduzione
del 41-bis. Scotti invece ha preferito una linea di maggior riserbo, pur avendo
manifestato davanti ai giudici le sue perplessità su quel cambio di vertice al
Viminale.
Trattativa Stato mafia, anomalo riferimento a Berlusconi nella
sentenza, scrive il 21 aprile 2018 Affari Italiani.
"Marcello Dell'Utri è colpevole del reato ascrittogli limitatamente alle
condotte contestate come commesse nei confronti del Governo presieduto da Silvio
Berlusconi": così i giudici della corte d'assise, nel dispositivo della sentenza
del processo sulla trattativa Stato-mafia, "circoscrivono" la responsabilità
penale di Marcello Dell'Utri. L'ex senatore di Forza Italia, imputato di
minaccia a Corpo politico dello Stato, è stato condannato a 12 anni. Un
dispositivo ritenuto dagli addetti ai lavori "anomalo" perchè la corte non si
limita a un riferimento temporale "dopo il '93", ma fa espressamente riferimento
a Berlusconi. Anomalia ancora più evidente se si ritiene che per gli altri
imputati, i vertici del Ros, condannati per lo stesso reato nel lasso temporale
precedente al '93 la formula cambia. E manca completamente il riferimento
specifico al premier in carica all'epoca. E tra i politici di Forza Italia c'è
chi grida alla sentenza politica, sottolineando la vicinanza tra il pm Di Matteo
e il M5s.
Altro che patti con la mafia, ecco tutti i boss messi in galera
dai governi Berlusconi. L'assurda sentenza di Palermo
non dice che il centrodestra ha raggiunto i maggiori risultati sul campo.
Scovati i latitanti più pericolosi, scrive Luca Fazzo, Domenica 22/04/2018, su
"Il Giornale". Una casupola bianca e un po’ malconcia in una masseria sulle
colline di Montagna dei Cavalli, fuori Corleone: un braccio che si allunga per
ritirare un pacco di biancheria lasciato da poco lì fuori. «Via, entriamo», dice
la radio dei trenta poliziotti arrivati fin lassù, nel silenzio del martedì di
aprile. Finisce così, dopo quarantatré anni, la latitanza di Bernardo
Provenzano, Binnu u’ Tratturi. Era l’11 aprile 2006. Da tredici anni, dalla
cattura di Totò Riina, Binnu era il numero uno di Cosa Nostra, il latitante più
importante d’Italia. Bisogna ripartire da quel fotogramma, dal braccio che si
sporge, per capire quanto stia in piedi la teoria di un governo Berlusconi
addomesticato ai voleri di Cosa Nostra, come sostengono trionfanti i pm di
Palermo dopo la indiscutibile vittoria ottenuta nel processo per la presunta
trattativa Stato- Mafia. Bisogna partire da quella foto, guardare le date,
ragionare. Provenzano viene arrestato nella fase finale della XIV legislatura.
Ministro dell’Interno è Beppe Pisanu, capo del governo è Silvio Berlusconi: cioè
l’uomo politico che secondo la tesi della Procura di Palermo, fatta propria
dalla sentenza di ieri, avrebbe ricevuto «una serie di richieste finalizzate ad
ottenere benefici di varia natura per gli aderenti a Cosa Nostra». Una
trattativa in tre fasi, l’ultima - secondo i pm - gestita in prima persona da
Provenzano medesimo. Che però viene catturato e sepolto in un carcere di massima
sicurezza. Ne uscirà solo dieci anni dopo, ormai demente, per andare a morire in
una stanza d’ospedale. Cosa era accaduto tra il 1993 della presunta trattativa e
l’arresto di Provenzano? Si potrebbe ipotizzare che gli accordi di non
belligeranza tra Stato e mafia avessero dispiegato un qualche effetto, almeno
nella prima fase. Macché. Berlusconi va a Palazzo Chigi la prima volta il 10
maggio 1994, ci resta fino al 17 gennaio successivo; ministro dell’Interno è
Roberto Maroni. Una manciata di mesi: ma nello stesso periodo finiscono in
galera quasi cento latitanti per reati di mafia, criminali inseguiti da anni da
mandati di cattura. Sono camorristi, ’ndranghetisti, ma il prezzo più alto lo
paga Cosa Nostra, anche nelle sue propaggini internazionali: il 20 luglio 1994 a
Long Island viene catturato dallo Sco, Paolo Lo Duca, latitante dal 1990, l’uomo
di raccordo tra Cosa Nostra, i clan americani e il cartello di Medellin, un
personaggio chiave nell’economia mafiosa. Tre mesi dopo a Palermo la Mobile
arresta Francesco Inzerillo, cugino del boss ammazzato dai Corleonesi nel 1980,
e interfaccia in Sicilia dei Gambino di New York. A novembre in Canada viene
individuato e preso Salvatore Ferraro, successore di «Piddu » Madonia alla testa
di Cosa Nostra a Caltanissetta. Si azzannano i tentacoli della Piovra
oltreconfine. Berlusconi torna al governo nel 2001, al Viminale vanno prima
Scajola e poi Pisanu. E la musica non cambia. La «Lista dei Trenta», l’elenco
dei latitanti più pericolosi, deve venire aggiornata di continuo, perché uno
dopo l’altro i boss cadono nella rete. Il 16 aprile 2002 a Roccapalumba tocca a
Antonino Giuffrè: è il sanguinario braccio destro di Provenzano, in fuga da nove
anni, condannato a otto ergastoli. Appena arrestato si pente e comincia ad
accusare Marcello Dell’Utri e Forza Italia. L’anno dopo, a luglio, finiscono le
latitanze anche di Salvatore Rinella e Salvatore Sciarabba: sono gli uomini che
proteggono Provenzano. Il cerchio intorno a «Binnu» si sta stringendo. Saranno
questi, i «benefici di varia natura» di cui parla la Procura di Palermo? Ad
aprile 2006 tocca a Provenzano. Due settimane più tardi si vota, il centrodestra
lascia Palazzo Chigi. Ci torna due anni dopo, l’8 maggio 2008. Premier è di
nuovo Berlusconi, ministro degli Interni di nuovo Bobo Maroni. E la musica
riprende. È il periodo d’oro della caccia ai boss, quello in cui Maroni a conti
fatti potrà vantare l’arresto di 6.754 mafiosi, compresi ventotto della «Lista
dei Trenta». Vengono smantellati santuari della criminalità organizzata in tutto
il Mezzogiorno. La ’ndrangheta, che nel 2004 aveva visto la fine della
interminabile latitanza di Giuseppe Morabito, «Peppe Tiradrittu» tra il 2008 e
il 2009 vede finire in cella imprendibili di lungo corso come Francesco e
Antonio Pelle; il 10 dicembre 2008 termina la fuga di Giuseppe De Stefano, «il
top della ’ndrangheta» nelle parole del procuratore Giuseppe Pignatone. Il 17
novembre 2010 catturano nella sua Casal di Principe il superboss della camorra
Antonio Iovine: «Abbiamo preso un re nel suo regno», commenta il procuratore
antimafia Piero Grasso. «Questa è l’antimafia dei fatti», dice Maroni. Ma è in
Sicilia, nella terra dove il progetto della trattativa avrebbe preso forma e
sostanza, che l’assedio alla criminalità mafiosa continua con i risultati
maggiori. Matteo Messina Denaro non si trova, ma - come all’epoca di Provenzano
polizia e carabinieri fanno terra bruciata intorno al padrino in fuga. A
settembre 2009 viene catturato Domenico Raccuglia, il collaboratore che gestisce
la latitanza di Messina Denaro. A dicembre nello stesso giorno vengono presi a
Palermo il giovane boss rampante Giovanni Nicchi e a Milano Gaetano «Tanino»
Fidanzati, 78 anni, uno dei primi uomini d’onore a sbarcare al nord. Nel giugno
successivo prendono Giuseppe Falsone, il capo di Cosa Nostra ad Agrigento: vive
sotto falso nome a Marsiglia, la città dove Provenzano era riuscito a farsi
operare alla prostata durante la latitanza. E poi centinaia di arresti solo
apparentemente minori, esponenti di seconda fila dei clan e anche semplici
gregari: che però costituiscono l’ossatura dei clan, la pianta organica senza la
quale il potere dei boss diventa una scatola vuota. Sono risultati imponenti,
figli del lavoro oscuro e tenace delle forze dell’ordine. E di una volontà
politica.
"Con me al Viminale li catturammo tutti. Salvini non cada nella
trappola del fango". L'ex ministro: "Illazioni
ridicole. Berlusconi alla mafia ha fatto un c...o così", scrive Giannino Della
Frattina, Domenica 22/04/2018, su "Il Giornale". «Trattativa con la mafia? Il
governo Berlusconi alla mafia ha fatto un culo così. Che ancora se lo ricordano.
Mi scusi il francesismo».
Presidente Roberto Maroni, lei è stato due volte ministro dell'Interno e la
prima proprio in quel 1994 toccato dalla sentenza della corte di Assise di
Palermo.
«Un primo grado. Aspetterei prima di parlare di teorema confermato».
Cosa ha provato sentendo una sentenza che accusa lo Stato di essere sceso a
patti con Cosa Nostra?
«Prima la gioia per l'assoluzione di Nicola Mancino, mio predecessore al
Viminale. Un galantuomo».
Mai avuto dubbi?
«Arrivato al ministero mi sono fatto portare dal direttore del Sisde Domenico
Salazar i dossier. C'erano quelli sui partiti, quello sulla Lega Nord. E ce
n'era uno anche su Mancino».
Il ministro dell'Interno dossierato dai servizi?
«Si figuri se poteva essere lui al centro di una trattativa con la mafia».
Non ha avuto alcun sentore di possibili accordi. Del famoso «papello» con le
richieste di Totò Riina?
«Lo escludo. Il capo del Sisde e poi della polizia era Vincenzo Parisi, un uomo
che mai avrebbe permesso una cosa simile. Un maestro per me».
Perché è così sicuro?
«Veniva ogni mattina al ministero e quando parlavamo di mafia voleva che
scendessimo in giardino. Non c'erano le intercettazioni di oggi, ma lui diceva
che era meglio così».
E Berlusconi?
«Garantisco che non solo non si è mai permesso di ostacolare il mio lavoro, ma
anzi mi ha sempre spronato a combattere la criminalità organizzata».
All'arresto del camorrista Antonio Iovine nel novembre del 2010, lei parlò di
6.754 mafiosi in manette con il governo Berlusconi con un incremento del 34 per
cento.
«Non solo, noi arrestammo 28 dei 30 latitanti più pericolosi».
Quindi non ci fu indulgenza?
«Di più, fummo noi a far diventare legge la proposta di Giovanni Falcone per
colpire la mafia nei patrimoni. Oltre 35mila beni sequestrati o confiscati».
Come?
«Prima i beni venivano sequestrati ai mafiosi in quanto pericolosi. Ma in caso
di morte o intestazione ai nipotini (come succedeva speso), tutto tornava agli
eredi. Noi abbiamo separato la misure di prevenzione personali da quelle
patrimoniali. E ha funzionato».
Fu Pietro Grasso, in altri tempi, a chiedere «un premio speciale a Silvio
Berlusconi e al suo governo per la lotta alla mafia».
«Mi ha fatto piacere perché le misure di aggressione ai patrimoni mafiosi le ho
introdotte io: l'Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e
confiscati e il Fug, il Fondo unico giustizia che con i soldi della criminalità
aiuta le vittime e i testimoni di giustizia».
Importante.
«Abbiamo consegnato alle forze dell'ordine le auto sequestrate. Sa cosa
significa polizia e carabinieri in un quartiere mafioso con la macchina che fino
al giorno prima era del boss?».
Berlusconi la incitava alla lotta alla mafia o le diceva di frenare?
«Ogni mese facevo una relazione al consiglio dei ministri. E quando nel '94
Berlusconi presentò il governo al senato, io non c'ero e la sinistra mi
criticò».
Come mai?
«Ero in Sicilia dove un sindaco aveva trovato una testa di vitello mozzata sulla
porta di casa. Berlusconi mi disse di lasciar perdere il Senato e di andare lì.
Era la prima volta che vedevano il ministro con il procuratore di Palermo che
era Gian Carlo Caselli, i capi di polizia e carabinieri. Altro che trattativa».
Eppure c'è questa sentenza.
«Questi sono i fatti, non opinioni. Quelle le lascio ai professionisti
dell'antimafia di Sciascia».
Ora quella trattativa entra in un'altra trattativa, quella per il governo.
«Lo scrivono i giornali, non vedo proprio come possa influire».
Sarà un appiglio per i 5 Stelle.
«Sono cose che danno fastidio, ma sono anni che si dice di Berlusconi e lui è
sempre lì».
Il momento è cruciale.
«Io dico a Matteo Salvini di lasciar perdere tutto questo fango buttato in giro.
Non cada nella trappola e mantenga salda la guida del centrodestra. Se questa
alleanza scompare, a vincere saranno gli altri».
Avesse saputo di una trattativa Stato-mafia, l'avrebbe denunciata?
«Immediatamente».
"Il Cavaliere mi ordinò di attuare il carcere duro contro Cosa
nostra". L'ex presidente del Senato: "Mafia colpita
con il 41bis reso stabile e i sequestri dei beni", scrive Mariateresa Conti,
Domenica 22/04/2018, su "Il Giornale". Altro che obbedire alle richieste del
«papello» di Riina, prima tra tutte quella sull'abolizione del 41 bis, il
carcere duro. Altro che avere favorito la mafia con i provvedimenti del governo,
come accusa il pm Di Matteo. Renato Schifani, oggi senatore di Forza Italia ma
in passato capogruppo e presidente del Senato azzurro, non ci sta. E ricorda,
dal 41 bis reso definitivo dal centrodestra alle norme sui sequestri dei beni ai
mafiosi. Tutte leggi promosse da Berlusconi.
Senatore Schifani, si aspettava che il pm Di Matteo coinvolgesse Berlusconi
nella trattativa Stato-mafia?
«Lo ritengo strumentale sotto il profilo politico e mediatico. Tra l'altro
Berlusconi non è stato mai imputato né indagato in questo processo. Ed inoltre
la sentenza Dell'Utri, definitiva, esclude ogni rapporto di Berlusconi e di
Forza Italia con la mafia. Il pm Di Matteo, assiduo frequentatore di convegni
Cinque stelle, si è lasciato andare a dichiarazioni più politiche che
giudiziarie. Dando per scontata la colpevolezza di pezzi dello Stato e di
Dell'Utri il pm dimentica che i livelli di giudizio sono tre e che quindi
nessuna responsabilità penale è ancora acclarata definitivamente».
La condanna di Dell'Utri è pesante, pensa che potrà incidere sulla sua vicenda?
«Non è detta l'ultima parola. Attendiamo che la Cedu si pronunci sulla
legittimità della sentenza definitiva di condanna, visto che il caso Dell'Utri è
perfettamente assimilabile al caso Contrada, per il quale la Cedu ha stabilito
che il concorso esterno non era definito giuridicamente prima del '94».
Berlusconi ha sempre rivendicato l'attività contro la mafia dei suoi governi...
«Per esperienza vissuta, ha ragione. Nel 2002, Dell'Utri era parlamentare e io
capogruppo. Mi pervenne dal governo Berlusconi il ddl che prorogava di tre anni
il 41 bis, il carcere duro. Sino ad allora si era andati avanti a proroghe, e
queste ingeneravano aspettative nella mafia, se ne trova traccia nel papello di
Riina. Mi confrontai con Berlusconi e gli chiesi se era d'accordo a trasformare
quell'istituto in un modello permanente. Da lui ebbi immediato consenso e il
provvedimento fu approvato, al Senato e alla Camera. Fu un passaggio delicato,
ci rendevamo conto di cosa significasse per la mafia. In Berlusconi non trovai
alcuna titubanza, al contrario ebbi il suo totale sostegno, soprattutto a me che
ero siciliano».
Altri provvedimenti?
«L'inasprimento del sequestro dei beni. Nel 2008 abbiamo introdotto una norma
più incisiva, che ci ha consentito di combattere la mafia aggredendola di più
sui patrimoni. Il mafioso si vede profondamente ferito e colpito quando lo si
priva dei beni. L'aggressione ai patrimoni è un'arma più efficace per indebolire
il fenomeno mafioso. Il governo Berlusconi è stato coraggioso».
Come nacque?
«Era il 2008, da presidente del Senato ero intervenuto alla Festa della Polizia
a Palermo. Nel mio discorso istituzionale avevo detto che ero pronto a recepire
suggerimenti per il pacchetto sicurezza Maroni/Alfano. Al termine della
cerimonia alcuni inquirenti mi segnalarono l'esigenza di intervenire sulla
Rognoni-La Torre perché non si poteva intervenire su alcuni beni dei mafiosi,
quelli ereditari e quindi legittimi in sostituzione di quelli illegittimi
venduti a terzi. Chiesi un appuntamento all'allora procuratore antimafia Grasso
che venne a trovarmi subito e mi disse che si poteva. Così preparai una bozza di
emendamento e ne parlai con Berlusconi. Anche in questo caso, pieno via libera.
Nacque così il sequestro per equivalente, che per me si chiama Silvio
Berlusconi».
Grasso disse che i governi Berlusconi meritavano un premio speciale per le norme
antimafia...
«Da Grasso ci dividono le idee politiche, ma fu corretto con noi, le nostre
normative antimafia sono senza precedenti».
Questa sentenza è caduta nel mezzo delle trattative per il governo e qualcuno
dice che ha favorito i grillini...
«Non cambia nulla. Forza Italia è orgogliosa della propria storia e del proprio
leader. Di Maio ha sempre sostenuto di non volersi sedere al tavolo con
Berlusconi, e quindi intende trarre dalla sentenza basso e strumentale profitto.
Non ha vinto le elezioni e si è assunta la responsabilità di paralizzare il
paese con i suoi giochetti da doppio forno. Il centrodestra resta unito perché
questa è stata e sarà sempre la sua forza».
Dell’Utri senza scampo: deve morire in cella.
Marcello Dell’Utri proprio due giorni fa è rientrato a Rebibbia, dopo due mesi
di ricovero per effettuare la radioterapia a causa di un tumore alla prostata,
scrive Valentina Stella il 21 Aprile 2018, su "Il Dubbio". «Siamo profondamente
delusi e sorpresi: è una sentenza che non ci aspettavamo assolutamente perché
eravamo sicuri di aver dimostrato che l’ipotesi accusatoria non aveva alcun
fondamento», così ha commentato al Dubbio l’avvocato Francesco Centonze a pochi
minuti dalla sentenza che ha condannato Marcello Dell’Utri, accusato di
“violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario” – art.
338 cp -, a 12 anni di carcere e all’“interdizione perpetua dai pubblici uffici
e in stato di interdizione legale durante la pena” nel processo sulla Trattativa
Stato Mafia. Dell’Utri, secondo l’accusa, si sarebbe fatto “portavoce” delle
minacce mafiose presso il governo Berlusconi. «Noi ritenevamo – prosegue il
legale – di aver dimostrato contro ogni ragionevole dubbio l’assoluta innocenza
di Dell’Utri in questa vicenda. Siamo ansiosi di leggere come i giudici
motiveranno questa decisione. Ricorreremo ovviamente in appello». Come possiamo
leggere nella memoria difensiva di quasi 300 pagine presentata dall’avvocato
Centonze “la tesi della pubblica accusa della formulazione di una minaccia
stragista da parte di Cosa Nostra non ha trovato alcun supporto nell’istruttoria
dibattimentale. Nessuno dei testimoni della Procura ha mai fatto cenno a
messaggi intimidatori da parte dell’organizzazione criminale a Dell’Utri e al
Presidente Silvio Berlusconi”. Aspetto ancora più rilevante, evidenziato dalla
difesa, è che “all’esito del dibattimento non c’è la prova che Mangano (lo
stalliere di Arcore, ndr.) abbia incontrato Marcello Dell’Utri dopo aver
ricevuto le indicazione da Giovanni Brusca (ex boss della mafia, poi divenuto
collaboratore di giustizia, ndr.) e, anche ammesso che si siano incontrati, in
ogni caso, non è stato dimostrato che Mangano abbia effettivamente trasmesso a
Dell’Utri il messaggio minatorio”. Intanto Marcello Dell’Utri proprio due giorni
fa è rientrato nel carcere romano di Rebibbia, dopo essere stato per circa due
mesi ricoverato al Campus biomedico di Roma per effettuare la radioterapia a
causa di un tumore alla prostata. Deve scontare ancora un anno e mezzo di
detenzione per la condanna definitiva a 7 anni per concorso esterno in
associazione mafiosa. La situazione giudiziaria alquanto complessa di Dell’Utri
comprende al momento anche un ricorso pendente alla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo attraverso cui, in sintesi, si chiede di applicare quanto già deciso
per Bruno Contrada, ossia l’annullamento della sentenza per concorso esterno in
associazione mafiosa perché all’epoca dei fatti contestati a Contrada, così come
a Dell’Utri, il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non era
sufficientemente tipizzato, quindi il processo sarebbe stato celebrato
illegittimamente. Lo scorso marzo la seconda sezione della Corte d’Appello di
Caltanissetta aveva rigettato la richiesta di revisione di tale processo,
decisione che i legali di Dell’Utri intendono impugnare in Cassazione.
Probabilmente la pronuncia della Cedu arriverà dopo l’estate: se la richiesta
dei legali venisse accolta l’Italia poi dovrebbe riconoscere l’eventuale
accoglimento ottenuto in sede europea; considerando i tempi della giustizia si
prevede che Dell’Utri dovrà scontare tutta la pena residua in cella.
Travaglio di bile. Il Fatto vuole
dimostrare che Berlusconi è un "delinquente naturale". Ma anche il condannato
Travaglio è delinquente, scrive Vittorio Sgarbi, Venerdì 20/04/2018, su "Il
Giornale". Se le dicono e se le cantano fra loro. Sul Fatto, sono sempre loro,
Travaglio o Gomez. E adesso anche Gregorio De Falco. Questa volta Travaglio si è
messo in testa di dimostrare che Berlusconi è un «delinquente naturale». Perché
delinque, egli dice. Più o meno come lui, condannato a pagare 150mila euro per
diffamazione degli onesti magistrati del processo Mori. Numerose sono le
condanne di Travaglio. Per accusare Berlusconi, Travaglio e i suoi ricorrono
spesso al tema della corruzione di un senatore. Se le sentenze che lo dimostrano
sono quelle del caso De Gregorio, stiamo freschi. Conclusioni insensate, basate
sulle dichiarazioni di un personaggio palesemente in contrasto con tutto quello
che è agli atti del Senato. Ma è inutile dirlo: i Travaglio e i Gomez,
innamorati del «delinquente naturale», non ascoltano e non verificano. Perché
comprare un senatore che non era più di centrosinistra, non era più nel gruppo
di «Italia dei valori», ma era passato, fin dal 2006 (due anni prima della
caduta del governo Prodi), nel Gruppo misto, per stare con il centrodestra, che
lo avrebbe nominato presidente della commissione Difesa del Senato? Basta
leggere gli atti. Solo quando non le critica lui, per Travaglio le sentenze sono
infallibili. E se dobbiamo ritenerle tali, anche il condannato Travaglio è
delinquente, e per di più recidivo, e per di più contro magistrati. Insomma,
l'altra faccia della medaglia di Berlusconi.
La trattativa Stato-mafia c’è stata, forse. E con questo?
Scrive Rocco Todero il 21 Aprile 2018 su "Il Foglio". La storiografia più
accreditata è da tempo concorde nel sostenere che durante la seconda guerra
mondiale il Governo degli Stati Uniti chiese aiuto alla mafia, soprattutto a
quella di New York, per tirarsi fuori dalla drammatica situazione che
imperversava nello specchio delle acque territoriali americane dove i
sottomarini tedeschi, con la probabile complicità di agenti segreti del loro
servizio d’intelligence acquartierati dentro il porto della Grande Mela,
imperversavano senza trovare ostacolo alcuno nell’affondare decine di navi
destinate a trasportare aiuti per sostenere lo sforzo bellico d’Inghilterra e
Francia contro Adolf Hitler. Le autorità militari, a torto o a ragione (questo
ancora non è chiaro), erano persuasi del fatto che solo coloro che detenevano
l’effettivo controllo del porto di New York avrebbero potuto fornire un
fondamentale contributo per non rendere vani gli sforzi statunitensi contro
l’aggressore tedesco. La trattativa coinvolse gente del calibro di Lucky
Luciano, Meyer Lansky, Benjamin Siegel, Joe Adonis e Frank Costello, la cupola
della più potente mafia americana allora in attività. I “mangia spaghetti”
furono, inoltre, il canale d’informazione principale per l’organizzazione
dell’operazione Husky, nome in codice con il quale fu identificato lo sbarco
delle truppe alleate in Sicilia nel luglio del 1943. Lucky Luciano e suoi
“compari” riuscirono a fare in modo che i soldati a stelle e strisce trovassero
la minore resistenza possibile nell’Isola e potessero beneficiare, già nel
momento stesso in cui avessero messo piede sulle spiagge, di una rete di
“picciotti” fidati capaci di descrivere a menadito, strade, postazioni nemiche,
ed ogni sorta di anfratto. Per i servizi resi durante il conflitto bellico Lucky
Luciano (assassino, sfruttatore di prostitute, commerciante di droga, estorsore
e corruttore) fu liberato anticipatamente ed estradato in Italia grazie ad un
provvedimento firmato da Thomas Edmund Dewey, il procuratore distrettuale della
contea di New York che lo aveva fatto condannare ad un pena “non inferiore a 30
anni” qualche anno prima e che era poi divenuto Governatore di quello stesso
Stato. Questo squarcio di storia del novecento racconta in tutta la sua
drammaticità della fortissima tensione alla quale può essere sottoposto lo Stato
di diritto nei momenti più difficili della vita delle liberal democrazie,
soprattutto quando esse sono sotto attacco, allorché, cioè, praticare
l’eccezione alla regola di diritto potrebbe rappresentare l’unica soluzione per
salvare l’intero sistema della convivenza civile. Si tratta di una deviazione
dall’ordinario, da quella che dovrebbe essere l’inviolabile regola del “governo
delle leggi”, che conduce nel sentiero ambiguo, fosco, e discrezionale del
“governo degli uomini”. Non vi è da parte dei rappresentanti del governo
complicità col sodalizio criminale, né volontà di rafforzarne il potere e la
struttura organizzativa, ma soltanto il desiderio di tentare di evitare mali
maggiori in un contesto di grave debolezza istituzionale cui non è possibile
porre rimedio repentinamente. Non si assiste nemmeno ad una sospensione della
lotta fra il bene e il male, quanto più semplicemente all’individuazione di un
pericolo di maggior rilievo da sventare in una situazione di grave svantaggio
nei confronti del nemico che potrebbe preludere a guai ben maggiori. Dopo la
liberazione di Lucky Luciano le autorità americane ripresero senza indugio la
loro battaglia contro la malavita organizzata italoamericana e diedero filo da
torcere per anni ad infinite schiere di boss e famiglie mafiose. A Palermo,
invece, un Tribunale della Repubblica italiana ci ha fatto sapere che per gli
ufficiali dei Carabinieri che avrebbero tentato (ammesso che così sia stato) di
fermare la mattanza di politici, giudici, poliziotti ed inermi cittadini, fatti
esplodere in aria e ridotti a brandelli sulle autostrade siciliane, in pieno
centro cittadino a Palermo o in ogni altra parte d’Italia, può esserci solo il
carcere. Nonostante la gravissima debolezza del corpo e dell’anima dello Stato
in quei terribili mesi, resa evidente dal caos istituzionale e dalla incapacità
di organizzare una risposta investigativa immediatamente idonea a mettere a
riparo la vita di rappresentanti delle istituzioni e di ignari cittadini,
malgrado il concreto pericolo che la Repubblica crollasse definitivamente sotto
i colpi serrati della più spietata organizzazione criminale italiana mai vista,
sebbene la lotta alla mafia quegli autori della trattativa non avrebbero poi mai
smesso di continuare senza sosta alcuna, il tentativo di far riprendere fiato
alle istituzioni democratiche deve essere considerato, secondo i pubblici
ministeri ed i giudici della Corte, alla stregua di un crimine ingiustificabile.
A nulla vale argomentare che il nemico ti aveva messo oramai il coltello alla
gola e che avevi ritenuto necessaria una tregua (e non una resa) per riprendere
le forze, non soccombere definitivamente e contrattaccare. A nulla vale
sottolineare che anche la pubblica accusa in questo processo sulla presunta
trattativa è consapevole che non ci fu mai, nemmeno per un momento, la volontà
da parte dei rappresentati dello Stato di concorrere con la mafia nel disegno
criminale portato avanti dai corleonesi per più di trent’anni. A nulla serve
ricordare che la trattativa (ammesso ci sia stata) avrebbe permesso comunque di
assestare un colpo micidiale al Capo dei capi e, da lì a qualche anno,
all’intera organizzazione malavitosa. Il fanatismo, infatti, quello massimamente
manicheo, quello assolutamente intransigente, quello disumano, ti spiega, con
fare censorio e teatrale allo stesso tempo, che non avresti dovuto nemmeno
parlare con il nemico (ammesso che tu lo abbia fatto), piuttosto avresti dovuto
preferire farti ammazzare dopo avere assistito al disfacimento generale di
quello che sarebbe rimasto dello Stato di diritto, soprammobile d’arredo, a quel
punto, ad uso e consumo della mafia che avremmo voluto sconfiggere.
"Sentenza Trattativa, Stato fallito che non protegge i suoi
servitori", scrive il 21 Aprile 2018 la Redazione de
La Pressa. Stefano Parisi, segretario di Energie per l’Italia: "Politicizzazione
del pm Di Matteo, fanno di tale caso uno dei punti più bassi del nostro stato di
diritto". “È incredibile come si possa gioire della sentenza di Palermo che
condanna dei servitori dello Stato che hanno arrestato Totò Riina e, con la loro
azione, inferto dei colpi durissimi alla mafia. Uno Stato che non protegge i
suoi servitori è uno Stato fallito. A supporto di questa sentenza non ci sono
prove ma solo dichiarazioni di pentiti la cui totale assenza di credibilità è
stata già provata”. Lo ha scritto su Facebook Stefano Parisi, segretario di
Energie per l’Italia commentando la sentenza di Palermo che condanna Mori e De
Donno. Parisi aggiunge: “La spinta mediatica intorno alla presunta trattativa
Stato-mafia, la forte ed esplicita politicizzazione del pm Di Matteo, fanno di
questo caso uno dei punti più bassi del nostro stato di diritto. I leader
politici che in queste ore esultano rappresentano il dramma ultimo che sta
vivendo il nostro Paese. Che il neoeletto presidente della Camera dei deputati
inneggi a questa sentenza è senza dubbio un fatto molto grave a cui il
Parlamento dovrebbe dare una risposta chiara a difesa della nostra democrazia e
dello stato di diritto”.
Un amaro processo, la guerra alla mafia. Perché le coscienze non
possono tacere, scrive Marco Tarquinio sabato 21
aprile 2018 su Avvenire. "Gentile direttore, quando le armi urlano le coscienze
tacciono e, quando la coscienze tacciono, non esistono più né regole né onore ma
solo eroi. Me lo diceva sempre mio nonno, combattente in Africa durante la
Seconda guerra mondiale, ogni qual volta gli confidavo di voler fare il
carabiniere. Ciò, in un periodo in cui più che mai la mafia sparava, metteva le
bombe e uccideva innocenti. Poi, un giorno mi sono ritrovato “in guerra” e, solo
allora, ho capito che cosa mio nonno volesse dire. Apprendo con grande rammarico
della condanna del generale Mori e degli altri carabinieri che hanno operato in
contesti in cui «le coscienze erano atterrite dall’urlo delle armi e regole ed
onore erano prerogativa solo degli eroi». Di questa storia non posso e non
voglio giudicare i fatti e neppure le “carte”, che non conosco, sono sicuro,
però, che a volte le carte dicono cose diverse rispetto ai fatti. Così, mi viene
ancora in mente un’altra cosa che mio nonno ogni tanto ribadiva: «Nipotino mio,
quando sei in guerra e combatti veramente, ti possono succedere solo cose
brutte, puoi morire, rimanere ferito o, se proprio sei “fortunato”, essere fatto
prigioniero. La differenza però è che, se muori o rimani ferito,
indipendentemente da come è successo, vieni ricordato come un eroe, se invece ti
fanno prigioniero, rimani semplicemente uno che si è arreso». Io so che il
Generale e gli altri carabinieri, dopo lunghi anni di “guerra” alla mafia,
stanno ancora combattendo per non essere fatti prigionieri, ai posteri giudicare
chi è stato il loro vero nemico, se lo Stato o la mafia. Vincenzo Drosi,
maresciallo dei Carabinieri in congedo".
È davvero emozionata ed emozionante, gentile maresciallo Drosi, questa sua
lettera sulla prima sentenza nel processo sulla «trattativa Stato-mafia». E mi
ha molto colpito. Di lei so ciò che lei stesso mi dice, e cioè che ha servito
nell’Arma, ma anche che è stato posto in congedo prima del previsto a causa di
gravi ferite riportate facendo il suo dovere. Ciò che racconta di suo nonno,
aiuta ancor meglio me e gli altri amici lettori a capire di che pasta anche lei
è fatto e quali ideali l’hanno formata: certamente improntati al quel binomio
«disciplina e onore» che la nostra Costituzione propone come misura e stile del
servizio reso da quanti esercitano, a ogni livello e con diverso grado di
responsabilità, un ruolo pubblico. Tutto ciò mi induce a considerare con ancora
più rispetto le sue parole e a fare ogni sforzo per comprendere la sua amarezza.
Non conosco abbastanza neppure io le “carte” del processo su quella che abbiamo
definito sulla nostra prima pagina di ieri «la malatrattativa» e commentato con
il lucido e coraggioso fondo di Danilo Paolini. E quel che so non mi autorizza
ad azzardare sul complesso dell’operato dei magistrati giudizi che sarebbero
pregiudizi. Ma conosco molti uomini delle Forze dell’ordine e, tra loro, non
pochi che vestono la divisa dei Carabinieri. So bene che non sono infallibili,
ma so altrettanto bene che le “mele marce” sono la triste eccezione che conferma
la regola di una grande pulizia di vita e d’azione e di una generosa fedeltà
alla Repubblica (che non è un’entità astratta, ma siamo tutti noi), regola sulla
quale gli stessi uomini delle forze dell’ordine sono chiamati a vigilare con
speciale attenzione. Per quel che vale, a mia volta sono certo che il generale
Mori e gli uomini del Ros oggi condannati continueranno a battersi per
dimostrare la giustezza del proprio operato. Conosco, poi, molti dei fatti. E
ciò che conosco mi aiuta a rendermi conto che qualcosa di molto serio e poco
limpido accadde dietro le quinte degli anni concitati e decisivi della «risposta
dello Stato» che seguirono la terribile stagione stragista di “cosa nostra” del
1992-93. Certo accaddero anche cose riprovevoli, come in ogni guerra. Ed è
proprio questo che ha mosso un processo giudiziario che ha scosso e inquietato
anche me. I lettori sanno che nell’estate del 2012 mentre questa vicenda
processuale toccava e coinvolgeva in modo clamoroso importanti personalità e tra
esse persone «per bene» che in anni di lavoro ho avuto la possibilità di
conoscere, vedere all’opera e stimare, non esitai a dire e scrivere parole ferme
e chiare di preoccupazione. E di dissenso. Penso in particolare a come venne
investito tramite intercettazioni “impossibili” Loris D’Ambrosio, uomo e
magistrato di grande levatura morale e professionale, morto letteralmente di
crepacuore. E penso a ciò che ha dovuto vivere in questi anni Nicola Mancino,
già ministro dell’Interno e presidente del Senato, ora assolto totalmente
dall’accusa di falsa testimonianza. Mancino – da giurista e politico galantuomo
qual è – si è difeso “nel processo e non dal processo”, mostrando ancora una
volta a non pochi protagonisti di quella che a lungo è stata chiamata «nuova
politica» (oggi ormai vecchia e quasi archiviata) che cosa significhi nutrire
autentico senso delle Istituzioni anche davanti a una palese ingiustizia
aggravata dallo stringersi di una tenaglia politico-mediatica mirata a tagliarti
fuori, e con immeritata ignominia, dalla vita pubblica. Un amico molto profondo,
che veste a sua volta la toga del magistrato, mi ha consegnato in questi giorni
una riflessione che considero molto utile e saggia e sono certo che non si dorrà
se la richiamo qui, ora, sia pure un po’ sommariamente. «Se una “trattativa” tra
uomini dello Stato e uomini della mafia ci fu, va giudicata politicamente e
storicamente. Si potrà dire che è stata un grave errore politico o, al
contrario, che fu necessitata. Ma, in ogni caso, non la si potrà chiudere nel
“vestitino” di una norma penale. Comunque sia andata, l’elemento psicologico che
può aver mosso uomini di Stato a un contatto con uomini della mafia non sarà mai
lo stesso dei mafiosi». Di questo sono convinto anch’io. Così come sono
consapevole del fatto che ci sono verità storiche (e morali) che non sempre
coincidono con quelle che possono essere rincorse e accertate (eppur si deve...)
in un’aula giudiziaria. Un ultimo pensiero è per la fulminante frase con cui
lei, gentile maresciallo ha aperto la sua lettera. Ne capisco il senso e posso
intenderne anche la buona intenzione, ma sono di un’altra scuola. Quando le armi
urlano, le coscienze non possono tacere. E questo l’«eroismo», cristiano e
civile, che ci è chiesto di vivere con semplicità e tenacia e che motiva ogni
resistenza al male, all’ingiustizia, all’indifferenza, alla mafia.
Il giurista che definì il processo sulla trattativa Stato-Mafia
una "boiata" non cambia idea dopo la sentenza: "Non andava fatto".
Lo studioso di diritto penale Giovanni Fiandaca critico verso l'accusa, scrive
il 21/04/2018 "Huffingtonpost.it". Qualche anno fa, in piena bufera mediatica,
quando quello sulla trattativa Stato-mafia veniva definito il processo del
secolo, usò parole dure, bollando l'atto di accusa della Procura di Palermo come
una "boiata pazzesca". Oggi Giovanni Fiandaca, tra i massimi studiosi italiani
di diritto penale, non usa la scure, ma ribadisce dubbi e perplessità
manifestati da sempre sul lavoro dei pm palermitani dicendo che il processo non
si doveva fare. Il commento arriva dopo il verdetto che, invece, ha accolto
praticamente in pieno l'impianto dei magistrati condannando a pene pesantissime
quelli che sarebbero stati i protagonisti del dialogo tra pezzi delle
istituzioni e Cosa nostra negli anni delle stragi: dall'ex generale del Ros
Mario Mori, all'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri condannati a 12 anni di
carcere. Le critiche di Fiandaca sono tutte in diritto. "Fermo restando che
aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza - dice - rimangono invariate
le mie perplessità sul reato ipotizzato: la minaccia a Corpo politico dello
Stato. Il Governo italiano non è un organo politico ma costituzionale e la
tutela degli organi costituzionali è assicurata da un'altra norma del codice
penale: l'articolo 289 che, peraltro, è stato modificato nel 2006. La nuova
formulazione non parla di minaccia ma di 'atti violenti', ed è questo il motivo
per cui la Procura alla fine ha ripiegato sull'articolo 338. Resta il nodo di
fondo: la pressione sul governo da parte della mafia e dei concorrenti,
ipotizzata dall'accusa, ricade solo nella previsione dell'articolo 289. La
scelta del reato dunque è sbagliata". Questioni in diritto complesse che - e
questa è un'altra criticità individuata da Fiandaca - troppo spinose per una
Corte d'Assise composta da giudici popolari. "Io ritengo che siano questioni di
competenza di un giudice solo professionale", dice. La Corte d'Assise come
competente a celebrare il processo venne individuata dal gup che dispose i
rinvii a giudizio sulla base della ricostruzione della procura che vedeva
nell'omicidio dell'erurodeputato Salvo Lima, reato di competenza della corte,
uno degli snodi da cui avrebbe preso il via la cosiddetta trattativa. Che quella
della Procura sia stata comunque una vittoria a 360 gradi il professore non lo
crede. "Ciancimino è stato assolto dal concorso in associazione mafiosa - dice -
e Mancino dalla falsa testimonianza: a mio avviso in questo modo vengono meno
due punti chiave della ricostruzione. Sono curioso di capire il ragionamento
seguito dai giudici". Di una cosa Fiandaca è sicuro. Nonostante il verdetto.
Quello sulla trattativa è un processo che non si doveva avviare. "La mia -
spiega - è un'opinione condivisa anche da altri giuristi, ma negli ultimi anni
sempre meno noi professori e i magistrati ci siamo capiti, nel senso che la
magistratura in buona fede ricorre a interpretazioni estensive delle norme
incriminatrici anche sorvolando su questioni di stretto diritto pur di arrivare
ai risultati repressivi che ritiene necessari". "E un problema generale -
conclude - che prescinde dal processo trattativa. C'è la tendenza, diventata
crescente, di alcuni magistrati a percepire il proprio ruolo come quello di
difensori contro il crimine a dispetto del garantismo individuale".
La sentenza di Palermo. C’era una volta il Diritto.
La sentenza di Palermo sulla presunta trattativa Stato-mafia
lascia perplessi, scrive Piero Sansonetti il 21 Aprile 2018 su "Il Dubbio". È
una sentenza che lascia perplessi. Dico meglio: lascia un po’ sbigottiti. Per
cinque ragioni.
La prima è che non ci sono prove contro gli imputati. Soprattutto contro gli
imputati di maggiore valore mediatico: il generale Mori (e i suoi collaboratori)
e l’ex senatore Dell’Utri. Non ci sono neanche indizi. La tesi dell’accusa si
fonda tutta o su alcune testimonianze giudicate false da questo e da altri
tribunali, o sulla parola di qualche mafioso, o su ricostruzioni dei pubblici
ministeri molto interessanti ma costruite esclusivamente su ipotesi o sulla
letteratura.
La seconda è che prima che si concludesse questo processo se ne erano svolti
altri, paralleli e sulle stesse ipotesi di reato, e si erano conclusi tutti,
logicamente, con le assoluzioni degli imputati (tra i quali lo stesso Mori e
l’on. Mannino). Questa sentenza, nella sostanza, ci dice che sì, probabilmente
non ci fu il reato, ma ci sono i colpevoli.
La terza ragione dello stupore è il reato per il quale sono stati condannati gli
imputati eccellenti. Il reato si chiama così: «Attentato e minaccia a corpo
politico dello Stato». Gli esperti e i professori dicono che nella storia
d’Italia questo reato è stato contestato una sola volta. Nessuno però ricorda
bene quando. Ma comunque quella volta non fu per minacce nei confronti del
governo – ed è di questo che sono accusati Mori e Dell’Utri – perché esiste nel
codice un reato specifico, scritto nell’art 289 del codice penale, che prevede
appunto l’attentato contro un organismo costituzionale (cioè il governo).
La quarta ragione non è di diritto ma è di buon senso. E sta nella assoluzione
(seppure per prescrizione) del capo della mafia (Giovanni Brusca, uno dei boss
più feroci del dopoguerra) che sarebbe l’autore della minaccia, contrapposta
alla condanna del generale Mo- ri che è forse il militare che ha catturato più
mafiosi dai giorni dell’Unità d’Italia ad oggi e che dalla mafia è stato sempre
considerato nemico acerrimo.
La quinta ragione del nostro sincero sbigottimento sta nello scenario kafkiano
che viene disegnato da questa sentenza. Lasciamo stare per un momento il
dettaglio dell’assenza di prove. Cerchiamo di capire cosa l’accusa e la giuria
ritengono che sia successo nel 1993- 94. Sarebbe successo questo: la mafia,
guidata da Riina avrebbe minacciato lo Stato, prima e dopo le uccisioni di
Falcone, Borsellino e delle loro scorte. Avrebbero chiesto l’allentamento del
rigore carcerario con un ricatto: «Altrimenti seminiamo l’Italia di stragi». In
una prima fase questa minaccia sarebbe stata mediata sempre da Dell’Utri e Mori,
evidentemente con Ciampi e Scalfaro. Questa però è solo la tesi dell’accusa,
perché la giuria non ci ha creduto, gli è parsa davvero troppo inverosimile. Poi
succede che Mori – evidentemente mentre trattava con lui – arresta Riina
assestando alla mafia il colpo più pesante dal dopoguerra. In una seconda fase,
dopo gli attentati del ‘ 93 (uno dei quali contro un giornalista Mediaset molto
legato a Berlusconi, e cioè Maurizio Costanzo) la minaccia sarebbe stata portata
a Berlusconi, che nel frattempo era diventato Presidente del Consiglio,
attraverso Marcello Dell’Utri e forse attraverso lo stesso Mori, evidentemente
colpito da un fenomeno grave di schizofrenia. Nessuna delle richieste dei
mafiosi, però, fu accolta. E questo, in teoria, dimostrerebbe un comportamento
rigorosissimo di Berlusconi: uomo davvero incorruttibile. E infatti la sentenza
condanna gli imputati a risarcire con 10 milioni la presidenza del Consiglio,
cioè Berlusconi. Le richieste mafiose che Dell’Utri, e forse Mori, avrebbero
portato a Berlusconi (e forse a Mancino, ministro dell’Interno, che però ha
negato, è stato imputato per falso e poi assolto) erano contenute in un
“papello” consegnato dall’ex sindaco Ciancimino, così sostiene il figlio dell’ex
sindaco che però è stato a sua volta condannato per calunnia (e dunque il
papello è falso).
Ma una persona che legge queste cose qui e ha un po’ di sale in zucca, che deve
pensare? Beh, probabilmente gli viene in mente un’idea molto semplice: che
quello di Palermo sia stato semplicemente un processo politico. E qualche
conferma a questo sospetto viene da un paio di elementi. Il primo è che il
Pubblico ministero che ha condotto l’accusa fino all’ultimo minuto, si è
candidato a fare il ministro coi 5 Stelle, ha partecipato a diversi convegni
politici dei 5 Stelle, ha presentato a nome dei 5 Stelle un programma per
riformare la giustizia, e, appena emessa la sentenza, ha rilasciato
dichiarazioni feroci contro Berlusconi, che oltretutto è parte lesa e non
imputato. Possiamo tranquillamente dire che il Pubblico ministero era un uomo
politico. Il suo predecessore, quello che avviò il processo (si chiama Antonio
Ingroia) ha partecipato recentemente alle elezioni in qualità di candidato
premier con una lista di sinistra. Anche questa circostanza (almeno in forma
così esplicita) è senza precedenti, credo, in tutti i paesi dell’Occidente. Il
secondo elemento sta in tutto quello che ha preceduto il processo. E cioè il
processo mediatico, che difficilmente non ha condizionato fortemente la giuria
di Palermo. Ho sentito molti commentatori dire che comunque ci sarà un processo
di appello, che potrà correggere gli errori del primo grado. Vero. Per fortuna
l’impianto della nostra giustizia è solido. Però è difficile digerire
l’arroganza del processo di Palermo, e la sua superficialità, e l’ingiustizia
palese di alcune condanne, come quella contro il generale Mori. Ed è difficile
non considerare il fatto che l’ex senatore Dell’Utri, che sta in cella in
condizioni di salute gravissime, difficilmente, dopo questa nuova stangata,
potrà sperare di ottenere cure adeguate e di rivedere il cielo senza sbarre. No,
non è stata una bella giornata.
Stato-Mafia, Mancino, il legale: «Intercettato per mesi senza
essere indagato», scrive il 16 Febbraio 2018 Il
Mattino. «Per molti mesi Nicola Mancino è stato intercettato senza neppure
essere iscritto nel registro degli indagati». Così, l'avvocato Nicoletta
Piergentili proseguendo la sua arringa difensiva al processo sulla trattativa
tra Stato e mafia che vede imputato l'ex Presidente del Senato Nicola Mancino,
accusato di falsa testimonianza. «Le sue parole intercettate - dice ancora
Piergentili - provano in ogni caso una linearità di comportamenti e
dichiarazioni che si pretende costituiscano prove di accuse contro la falsa
testimonianza, mentre non c'è nessuna traccia di quello che sarà la sua tesi.
Quello che traspare sono disorientamento, non solo di Nicola Mancino ma anche, e
soprattutto, del suo interlocutore, Loris D'Amborsio, poi scomparso
prematuramente». D'Ambrosio era il consigliere giuridico dell'ex Capo dello
Stato Giorgio Napolitano, morto per un infarto nel luglio del 2012. Secondo la
Procura di Palermo dietro quelle conversazioni si celava il tentativo dell'ex
ministro di condizionare le indagini. «In modo suggestivo l'accusa ha fatto
notare che il cittadino Mancino si rivolgeva a persone di alto rango, persino al
Presidente della Repubblica - dice l'avvocato Piergentili, che difende Mancino
con il collega Massimo Krogh - ma costoro erano i rappresentanti delle
istituzioni a lui più vicine per la carica e il ruolo ricoperto, sono persone
che hanno fatto parte del suo mondo, un mondo dal quale è stato spazzato via». E
cita alcune intercettazioni: «Colpisce - dice Piergentili - lo stupore del
consigliere D'Amborsio, nella telefonate del 25 novembre 2011, quando Mancino lo
chiama alle nove di sera per comunicargli che è stato di nuovo convocato per il
successivo 6 dalla Procura come persona informata dei fatti. E questo è il
motivo per il quale sono state disposte le telefonate». «Nessun dialogo - dice
l'avvocato - tra Mancino ed esponenti delle istituzioni, nessuna telefonata
parla di quello che si andrà a dire».
L’omicidio Lima è stato il grimaldello per ottenere la giuria
popolare. La strategia della procura per andare in
Corte d’Assise, scrive il 26 Aprile 2018 "Il Dubbio". Il processo sulla
“trattativa” Stato- mafia, conclusosi la scorsa settimana con le pesanti
condanne degli allora vertici del Raggruppamento operativo speciale dell’Arma
dei Carabinieri, i generali Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno,
offre all’interprete e all’operatore del diritto argomenti di riflessione sulla
disciplina codicistica relativa alla competenza per materia del giudice penale.
Il processo “trattativa”, com’è noto, si è celebrato davanti alla Corte d’Assise
di Palermo. Il motivo del radicarsi della competenza davanti alla Corte composta
anche da giudici popolari è stato determinato dal fatto che parte integrante
della presunta “trattativa” era l’omicidio, avvenuto a Palermo a marzo del 1992,
dell’europarlamentare della Dc Salvo Lima. Le difese degli alti ufficiali
dell’Arma avevano chiesto di essere giudicati dal Tribunale monocratico in
quanto l’articolo 338 del codice penale, rubricato “violenza o minaccia ad un
Corpo politico, amministrativo o giudiziario”, contestato agli imputati, è
punito con la reclusione nel massimo di sette anni. Nicola Mancino, accusato di
falsa testimonianza, aveva invece chiesto di essere giudicato dal Tribunale dei
ministri, in quanto il fatto per cui era accusato, la falsa testimonianza,
sarebbe stato commesso in ragione dell’aver rivestito la carica di ministro
della Repubblica. La competenza veniva contestata dalle difese non soltanto
sotto il profilo della composizione dell’organo del giudice, ma anche con
riferimento alla competenza territoriale: se una “trattativa” fra lo Stato e la
mafia era avvenuta, il luogo di consumazione del reato non poteva che essere
Roma, capitale del Paese e sede del Governo. L’omicidio di Lima era per la
Procura di Palermo un «dato fondante del castello accusatorio, il primo atto del
ricatto che mafia e pezzi delle Istituzioni fecero allo Stato», disse l’allora
procuratore aggiunte Vittorio Teresi, esultando per la decisione del presidente
della Corte d’Assise Alfredo Moltalto di respingere ogni eccezione presentata
dalle difese, sposando appieno le considerazione della Procura e dando dunque il
via a luglio del 2013 al dibattimento. Con il senno di poi, un cattivo presagio
per gli imputati. Lo stesso Di Matteo, che cinque anni dopo accuserà l’Anm e il
Csm di averlo lasciato solo, fu estremamente contento della decisione di
Montalo, presidente “di una autorevole Corte d’assise che ha eliminato critiche
pregiudiziali all’indagine radicando il processo a Palermo”. La Corte d’assise
giudica i reati più gravi e di grande allarme sociale come, appunto, l’omicidio
volontario. In virtù del collegamento con l’omicidio di Salvo Lima, la
competenza è passata alla Corte d’assise di Palermo, cosi chiamata a giudicare
non per tale fatto di sangue ma sul reato, il 338 codice penale, che senza
questo filo conduttore sarebbe stato di esclusiva competenza del giudice togato
monocratico. Il 338 cp è, come stato ripetuto più volte, un reato rispetto al
quale non esiste ampia giurisprudenza e che vede la necessità di definizioni di
concetti squisitamente tecnico giuridici come quello delle nozioni di “corpo
politico” e di “turbamento”, idonei alla sua configurazione. E’ sufficientemente
attrezzato sotto questo aspetto un giudice popolare? Senza contare, poi, il
condizionamento mediatico che questo dibattimento ha innegabilmente avuto, con
una martellante campagna colpevolista nei confronti degli imputati. Inoltre,
bisogna ricordare l’incredibile lunghezza di tale dibattimento che ha, a
memoria, ben pochi precedenti in termini di durata nella storia della
Repubblica. Oltre 220 udienze in cinque anni costituiscono un vero record per un
giudizio di primo grado. Per fare un esempio, il processo alla maxi tangente
Enimont, “la madre di tutte le tangenti” nell’indagine Mani pulite, si celebrò
in sole 44 udienze ed in meno di un anno. Già questi numeri dovrebbero far
riflettere. In Francia è in corso di approvazione una riforma della procedura
penale che limita drasticamente il ricorso alle giurie popolari. La
sperimentazione è già in atto in alcuni distretti. Da ora in poi saranno di
competenza della Corte d’assise solo i reati punibili con l’ergastolo e quelli
con gravi casi di recidiva. Sarebbe auspicabile che anche in Italia si aprisse
un serio dibattito sulle giurie popolari, per evitare che fattispecie di reato
eccessivamente “tecniche” vengano giudicate da persone non del tutto adeguate.
Anche sotto l’aspetto che non “appaiano” preparate al ruolo.
Nel 1993 fu la Consulta a revocare il 41bis ai boss.
Si opposero soltanto i Ros di Subranni e De Donno, scrive Damiano
Aliprandi il 28 Aprile 2018, su "Il Dubbio". Esiste la sentenza della Corte
costituzionale citata da Luciano Violante, ovvero quella che avrebbe influenzato
l’ex ministro della giustizia Giovanni Conso riguardante la decisione di non
prorogare il 41 bis a 334 detenuti. L’altro ieri, durante la deposizione al
processo d’appello all’ex ministro Calogero Mannino, assolto in primo grado
dall’accusa di minaccia a Corpo politico dello Stato, Violante ha detto le
testuali parole: « Le revoche dei 41 bis ai mafiosi disposte dal ministro Conso
nel ’ 93, furono conseguenza di una sentenza della Corte costituzionale che
impose valutazioni individuali per ciascun provvedimento di carcere duro a
differenza di quanto era avvenuto in precedenza e in passato per i terroristi» .
Ricordiamo che, secondo l’impianto accusatorio (al processo Stato- Mafia), le
revoche di diversi provvedimenti di 41 bis decise da Conso sarebbero state uno
dei segnali mandati dallo Stato alla mafia a dimostrazione della linea soft
scelta nel contrasto ai clan in ossequio alla cosiddetta trattativa e in cambio
della fine delle stragi. La sentenza della Consulta c’è stata e Il Dubbio l’ha
potuta visionare. È la numero 349 e depositata in cancelleria il 28 Luglio del
1993. Ricordiamo che il 29 ottobre – quindi 3 mesi dopo la sentenza – lo stesso
Dipartimento di amministrazione penitenziaria inviò un documento in cui si
chiedeva a diverse autorità – dalla magistratura alle forze dell’ordine – un
parere sull’eventuale proroga del provvedimento a oltre trecento persone
detenute. A questo si aggiunge un altro particolare. Il 30 Luglio del’ 93 –
quindi due giorni dopo la sentenza della Consulta – l’ufficio dei carabinieri
relativo al coordinamento servizi sicurezza degli istituti di prevenzione e pena
ha chiesto un parere sull’eventuale proroga dei detenuti al 41 bis direttamente
ai Ros. A rispondere fu l’allora generale di brigata comandante Antonio Subranni
– condannato assieme a Mori in primo grado per avere partecipato alla presunta
trattativa – che ripose di essere favorevole all’applicazione del 41 bis «per
ottenere la recisione dei detenuti interessati dalle loro organizzazioni
criminale, nonché la collaborazione di giustizia in favore dell’attività
investigativa». Quindi anche questo dettaglio – non di poco conto perché mette
in discussione l’accusa nei confronti dei Ros che avrebbero trattato con la
mafia – conferma le parole di Conso quando disse di aver agito in solitudine e
secondo coscienza. I Ros erano contrari a concedere questo beneficio (se di
beneficio si può parlare) ai detenuti. Conso, giurista, ex vicepresidente del
Csm e della Corte Costituzionale, ministro tecnico nel governo di Carlo Azeglio
Ciampi, non poteva disattendere ad alcune indicazioni tratte dalla sentenza
della Consulta. Da dove aveva attinto l’imposizione di valutazioni individuali?
Il passaggio è a pagina 9 del dispositivo: «Misure di tal genere – è bene
sottolinearlo – devono uniformarsi anche ai principi di proporzionalità e
individualizzazione della pena, cui l’esecuzione deve essere improntata;
principi, questi ultimi, che a loro volta discendono dagli artt. 27, primo e
terzo comma, e 3 della Costituzione (cfr. sent. n. 50 del 1980 e n. 203 del
1991) nel senso che eguaglianza di fronte alla pena significa proporzione della
medesima alle personali responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne
conseguono (cfr. sent. n. 299 del 1992 e n. 306 del 1993) – ed implicano
anch’essi l’esercizio di una funzione esclusivamente propria dell’ordine
giudiziario». Altro passaggio cruciale della sentenza è a pagina 11: «Deve
ritenersi implicito – anche in assenza di una previsione espressa nella norma,
ma sulla base dei principi generali dell’ordinamento – che i provvedimenti
ministeriali debbano comunque recare una puntuale motivazione per ciascuno dei
detenuti cui sono rivolti ( in modo da consentire poi all’interessato
un’effettiva tutela giurisdizionale), che non possano disporre trattamenti
contrari al senso di umanità, e, infine, che debbano dar conto dei motivi di
un’eventuale deroga del trattamento rispetto alle finalità rieducative della
pena». La Corte, pur riconoscendo la costituzionalità dell’applicazione del
regime duro, aveva indicato che la modalità di esecuzione del regime rispettasse
il diritto di libertà senza reprimerlo in modo assoluto. Fu proprio per
garantire, tra gli altri, il rispetto dell’art. 27 della costituzione che la
stessa Consulta, con le osservazioni sopra riportate, impose di personalizzare
la valutazione nel caso di applicazione del regime del carcere duro, anche in
ragione dell’obbligatorietà della motivazione, che avrebbe cosi reso effettivo
il diritto del detenuto di richiedere una valutazione dell’autorità giudiziaria.
La finalità riabilitativa della detenzione non può essere derogata, soppressa o
sospesa nemmeno per esigenze di ordine e sicurezza. L’allora ministro e uomo di
diritto come Conso, non poteva quindi disattendere le indicazioni della
consulta.
E ALLORA PERCHÉ NON PROCESSANO I GIURISTI, TUTTI CELEBERRIMI, CHE EMISERO LA
SENTENZA NEL ‘ 93? FORSE PERCHÈ SANNO GIÀ COSA RISPONDEREBBERO: «QUESTO È IL
DIRITTO, VOSTRO ONORE…»
La storia messa alla rovescia. I Ros dissero no, la Consulta
disse sì. La storia messa alla rovescia, scrive Piero
Sansonetti il 29 Aprile 2018 su "Il Dubbio". Nell’articolo qui accanto, Damiano
Aliprandi spiega come andò la decisione di revocare il 41 bis (carcere duro) a
334 detenuti, presa nell’autunno del 1993 dal ministro Giovanni Conso. Quella fu
l’unica misura che potesse essere considerata un beneficio ai mafiosi. Quindi se
bisogna parlare di trattativa tra Stato e mafia (come ha fatto la sentenza di
Palermo) bisogna riferirsi prima di tutto a quella decisione di Conso. Prima
però bisogna chiarire chi era Giovanni Conso. Non era un ministro prodotto dai
“berluscones” o dai “partiti corrotti”. I “berluscones” ancora non si vedevano
all’orizzonte. I “partiti corrotti” boccheggiavano sotto i colpi di Di Pietro.
Conso era un giurista di primissimo ordine, e come tecnico era stato chiamato a
far parte del governo tecnico di Carlo Azeglio Ciampi. Il quale a sua volta era
uno tra gli economisti più prestigiosi di Europa. Conso in realtà era entrato
anche nel precedente governo, quello di Giuliano Amato, il 2 febbraio del 1993
per sostituire Claudio Martelli, affondato da un avviso di garanzia del pool di
Milano. Conso era stato chiamato proprio per il valore della sua figura, sia sul
piano culturale che su quello morale, in un momento di crisi politica
devastante, nella quale i partiti, come dicevamo, erano stati rasi al suolo
dalla magistratura e dalla stampa. Benissimo: Conso si è sempre assunto la
responsabilità di quella decisione. Non ha mai scaricato le responsabilità.
Perché la prese? Ci fu una trattativa? No – spiega nel suo articolo Aliprandi, e
ha accennato due giorni fa Violante – la decisione fu presa sulla base di una
sentenza della Corte Costituzionale depositata in cancelleria il 28 luglio del
1993. Questa sentenza stabiliva che il 41 bis può essere applicato solo caso per
caso, e deve essere motivato adeguatamente. Non può essere deciso in blocco per
una categorie di detenuti. Per esempio quelli accusati di mafia. E siccome il 41
bis era stato invece assegnato a quei 334 in blocco, non era valido e non poteva
essere rinnovato. Giovanni Conso, in novembre, quando prese la decisione, non
poteva fare altro che rispettare la sentenza della Corte. Poi, se volete
divertirvi, potete giocare al gioco delle coincidenze con le date. La sentenza
dell’alta Corte fu depositata in cancelleria la mattina dopo l’attentato di via
Palestro, a Milano (5 morti), esattamente due mesi dopo l’attentato a Firenze
(cinque morti). E la decisione di Conso fu operativa qualche giorno dopo il
fallito attentato allo stadio Olimpico di Roma (che, se fosse riuscito, avrebbe
provocato decine e decine di morti) che è del 31 ottobre. Ma i processi non si
fanno con il gioco delle coincidenze. Poi però ci sono delle cose che non sono
coincidenze ma fatti reali. Per esempio è un fatto che i carabinieri del Ros,
che oggi sono stati condannati per aver favorito (o addirittura realizzato) la
trattativa, furono consultati prima della revoca del 41 bis. Fu chiesto loro:
«Siete d’accordo su questa revoca?». Sapete cosa risposero, con una nota firmata
dal generale Subranni in persona? Risposero secco: «No». Personalmente nutro
moltissimi dubbi sulla legittimità della risposta di Subranni. Il quale disse:
niente revoca perché il 41 bis serve per favorire dissociazioni e pentimenti. A
me pare che una misura cautelare (come mi dicono sempre sia il 41 bis) non possa
essere usata come strumento di pressione sul detenuto, per farlo parlare,
confessare, pentire o altro. Ma oggi non è questa polemica che ci interessa. Ci
interessano i fatti. Risulta che il governo Berlusconi non fece nulla per
favorire i detenuti, risulta che non fece nulla il governo Amato, e risulta che
il governo Ciampi prese una misura che era imposta da una sentenza della Corte
Costituzionale. Risulta che a questa sentenza si opposero quasi solo i Ros, e
cioè i carabinieri che poi sono stati condannati. Capite bene che c’è qualcosa
che non va. Se davvero i magistrati di Palermo sono convinti che la trattativa
ci fu, dovrebbero forse interrogare i giudici dell’Alta Corte che presero quella
decisione. Chi erano? Erano il gotha del diritto italiano. Giuristi del calibro
di Francesco Paolo Casavola (che era il Presidente), Ugo Spagnoli, Vincenzo
Caianiello, Mauro Ferri, Enzo Cheli, Renato Granata, Cesare Mirabelli, Francesco
Greco, Gabriele Pescatore, Fernando Santosuosso. I magistrati dovrebbero, col
piglio che ha contrassegnato tutti gli interrogatori a questo processo, chiedere
loro: «chi vi spinse a emettere una sentenza che portava benefici ai detenuti
sospettati o condannati per mafia». Loro risponderebbero, all’unisono: «Il
diritto, signor Pubblico Ministero. Il diritto che in uno stato di diritto vale
più di ogni altra cosa».
Mannino: «La mia Dc espulse Ciancimino e fui punito da Cosa
Nostra». Intervista con Calogero Mannino: «Nel nono
congresso espulsi Vito Cincimino e vinse il rinnovamento: Mattarella, Nicolosi e
io». Intervista di Giovanni M. Jacobazzi del 28 gennaio 2017 su "Il Dubbio".
Calogero Mannino è un politico di razza. Esponente di punta della Prima
Repubblica, è stato più volte ministro. Arrestato nel 1994 con l’accusa di
concorso esterno in associazione mafiosa, dopo nove mesi di carcere, tredici di
arresti domiciliari e una trafila giudiziaria estenuante, nel 2010 è assolto
definitivamente dalla Cassazione perché il fatto non sussiste. Le traversie
giudiziarie non hanno piegato il suo orgoglio di uomo del Sud. Attualmente è
titolare di una azienda vinicola a Pantelleria dove produce un eccellente
passito. Oltre all’attività imprenditoriale, dal 2012 è di nuovo sul banco degli
imputati nel processo trattativa Stato- Mafia.
Onorevole Mannino, la procura di Palermo non molla?
«Nel 2012 ho scelto di essere
processato con il rito abbreviato. Rito che si basa solo sugli elementi di prova
portati dall’accusa. Ero certo dalla mia innocenza. Nel 2015, sono stato assolto
in udienza preliminare per non aver commesso il fatto. La procura, nelle scorse
settimane, ha presentato appello. I pm di Palermo sono convinti da sempre che io
abbia nel corso della mia vita intessuto rapporti con Cosa nostra. E’ una
narrazione “funambolica” che si trascina da anni».
Lei è stato un dirigente della Dc siciliana negli anni in cui
Cosa nostra è cresciuta…
«Prima dell’approvazione del disegno di
legge La Torre sul 416bis, vorrei ricordare che il tema del contrasto a Cosa
nostra è un punto qualificante della mozione presentata dalla Dc alla fine del
1979, poi discussa ed approvata in parlamento il 2 febbraio 1980. In quella
mozione si approvavano le conclusioni della Commissione antimafia. I relativi
lavori interessarono le due legislature precedenti. Quella mozione era stata
scritta da me in rappresentanza del gruppo parlamentare della Dc su incarico
dell’allora presidente Gerardo Bianco. In un primo momento questa mozione doveva
portare la firma dell’On. La Torre e del gruppo del Pci. Il lavoro di
preparazione era stato intenso. Sia da parte mia e di Bianco che da Di Giulio e
La Torre per il Pci. Il Pci di Berlinguer aveva, però, poi fatto marcia
indietro, sfilandosi dalla politica di solidarietà nazionale. E non sottoscrisse
più la mozione. Nel 1980 optò per una propria mozione anche se nel merito
condivideva la mozione della Dc. L’atto fondamentale sul piano politico
istituzionale con il quale la politica si accingeva ad affrontare Cosa nostra
alla fine degli anni ‘ 70 e ‘ 80 è dato dalle proposte contenute nella mia
mozione. Dopo il governo Cossiga fu la volta di Forlani e poi di Spadolini. Il
1982 anno tragico: assassinio di Dalla Chiesa e dello stesso La Torre. Fu a quel
punto che il governo diede la propria adesione al testo approvando
l’introduzione del 416bis».
Tornando alla procura di Palermo, il pool segnò un cambiamento
nel forme di contrasto a Cosa Nostra?
«Il pool ha avuto una genesi
particolare. Un gruppo di lavoro composto da magistrati della procura della
Repubblica e dall’Ufficio istruzione. Giovanni Falcone ebbe il merito di aver
avuto l’intuizione investigativa di puntare sui collaboratori di giustizia, con
il primo pentito Tommaso Buscetta. E’, però, indiscutibile che questa operazione
segnò non solo la storia giudiziaria della lotta alla mafia ma la storia del
Paese non si sarebbe potuta realizzare senza il consenso della linea politica
assicurata dalla Dc siciliana di quegli anni. Voglio ricordare che nessuno,
neanche Salvo Lima, nel 1983 volle i voti di Vito Ciancimino. Al nono congresso
regionale della Dc siciliana, l’ex sindaco di Palermo offrì ben 45mila voti. Io
espulsi Ciancimino e vinse il rinnovamento. Salvo Lima sconfitto, Vito
Ciancimino umiliato. La Dc siciliana sceglieva l’immagine dei quarantenni,
Sergio Mattarella, Rino Nicolosi ed io. Chi ha voglia di leggere il libro di
Ciancimino junior troverà che questa estromissione avrebbe segnato l’inizio del
suo “percorso giudiziario”».
Che ricordo ha di Giovanni Falcone?
«Una mente finissima. Anche se in vita
Falcone fu spesso osteggiato. Non superò le votazioni per il Csm. E lo stesso
Csm gli negò la responsabilità dell’ufficio istruzione del Tribunale di Palermo.
In pochi giorni il Ministro istituì allora il posto di aggiunto alla procura
della Repubblica in modo che potesse avere una posizione di rilevo all’interno
dell’ufficio».
Come legge il 1992, l’anno delle stragi?
«Cosa nostra ritenne di dover dare
l’ultima battaglia contro lo Stato. Molti dei suo esponenti erano in galera, ma
non tutti. Quelli che erano fuori puntavano alla vendetta. Gli episodi
stragisti, in coincidenza con i fatti di tangentopoli, determinarono la crisi
del sistema politico. Il parlamento venne sciolto e le elezioni, con un sistema
elettorale di tipo maggioritario, segnarono la fine della Dc. Nessuno può negare
che le stragi di quel periodo segnarono un cambiamento radicale dell’impianto
istituzionale. A ciò si devono aggiungere i processi Andreotti e Mannino. Cosa
nostra è stato un mezzo per spazzare via un sistema che aveva governato dalla
fine delle seconda guerra mondiale. La narrazione giornalistica fornisce, però,
un altro quadro».
E veniamo al processo trattativa Stato-Mafia…
«Io non so se c’è stata una trattativa
con Cosa nostra. Non so cosa abbiamo fatto gli ufficiali dei Carabinieri, i
Generali Mori e Subranni con cui sono coimputato. Dico solamente che il Ros di
Mori consegnò al procuratore capo Caselli un finto pentito, Gioacchino Pennino,
“il Buscetta della politica palermitana”. Pennino era un medico chirurgo della
Palermo bene che aveva fatto fortuna con i casinò in Croazia. Nel marzo del ’ 94
è stato arrestato ed estradato per associazione a delinquere. Decide di
collaborare accettando l’estradizione per associazione mafiosa. Pennino si
definisce “un vero cataro”. Parla, anzi straparla, e io fui arrestato. I fatti
dimostrano che io ero la vittima designata. Per la mia storia non mi vedo come
un riferimento in una trattativa. Solo la mia forza d’animo mi sta aiutando a
sopportare questo calvario. Certo, a volte penso cosa possa indurre i Pm su
queste tesi. Non si rendono conto dell’abbaglio?»
Mario Mori: breve storia del generale che e colpì al cuore Cosa
nostra. Figlio di un ufficiale dei carabinieri, nel
’93 arrestò Totò Riina, scrive Giulia Merlo il 27 Aprile 2018 su "Il Dubbio". Di
Mario Mori, quando lo si incontra, colpisce la fredda serietà. Non alza mai la
voce, nemmeno in mezzo al rumore. Si muove secco, dritto come un fuso. Calibrato
in ogni affermazione, ricorda spesso che la memoria non l’ha mai tradito ma che,
se anche lo facesse, dal 1982 compila ogni giorno un’agenda con nomi e orari e
fatti. Un piccolo brigadiere della Dalmazia, con i capelli bianchi e i baffi
corti che porta sulle spalle tutto il peso di un nome che è parte della storia
d’Italia: per chi lo accusa, è il capo dei servizi deviati che sono scesi a
patti con la mafia. Per chi lo difende, è il generale che ha servito lo Stato
negli anni più bui della repubblica. Nato nel 1939 in terra di frontiera, a
Postumia Grotte, una cittadina «ex Trieste» passata alla Jugoslavia nel 1947,
come ogni figlio di un ufficiale dei carabinieri segue gli spostamenti del
padre: medie a Trento, liceo a Roma, poi l’accademia militare di Modena e la
Scuola di applicazione di Torino. Entra nell’arma nel 1966 e si guadagna presto
i gradi di capitano: così arriva al Sid, l’allora servizio segreto militare
comandato da Vito Miceli (il generale arrestato nel 1974 per cospirazione contro
lo Stato nell’inchiesta sulla Rosa dei Venti, poi assolto nel 1978) e Gianadelio
Maletti.
L’ANTITERRORISMO. Dopo qualche anno passato a Napoli, Mori prende servizio a
Roma, a capo della Sezione Anticrimine del Reparto Operativo, il 16 marzo del
1978: il giorno del sequestro di Aldo Moro. La sua sezione opera sotto il Nucleo
speciale Antiterrorismo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che era stato
sciolto nel 1976 ma ricostituito in tutta fretta dall’allora presidente del
consiglio Giulio Andreotti. Nei 55 giorni di prigionia è a capo delle indagini
ed è in piedi vicino al ministro dell’Interno Francesco Cossiga, davanti alla
Renault rossa, il 9 maggio. Dopo l’uccisione di Moro, sotto la direzione di
Dalla Chiesa, il gruppo guidato da Mori mette a segno duri colpi alle Br: prima
l’individuazione del covo di via Montenevoso, a Milano, dove furono rinvenute le
lettere di Moro e il cosiddetto memoriale, poi, negli anni successivi, gli
arresti eccellenti della colonna romana delle Br, come quello di Barbara
Balzerani nel 1985. Da Dalla Chiesa, Mori assimila un metodo che utilizzerà poi
anche nelle indagini sulla mafia in Sicilia e che pone a fondamento dei principi
guida del Ros: conoscere e possibilmente anche usare il vocabolario e le
tecniche degli avversari per essere in grado di individuare il filo conduttore
dei loro ragionamenti e di anticipare le loro mosse: “Sapere il più possibile
dell’avversario, far sapere il meno possibile di noi”. Di Mori, il generale
Dalla Chiesa nella valutazione finale scrive: “Ufficiale molto serio, molto
riflessivo, molto responsabile ha dato nuova conferma di un patrimonio brillante
di qualità intellettuali, morali, militari e di carattere. Nel particolare e
delicato incarico della lotta frontale alla eversione, ha attinto a piene mani
alla sua esperienza ed alla sua qualificata preparazione tecnico- professionale
per condurre un’azione penetrante, responsabile, generosa, per offrire una
collaborazione permeata di entusiasmo e di spirito di sacrificio e per
garantire, con tatto ed efficacia, relazioni proficue con organi paralleli e con
la stessa Autorità Giudiziaria. Gli esprimo la mia gratitudine. Rendimento pieno
e sicuro”.
ROS. Mori viene mandato in Sicilia nel settembre 1986, durante il primo
maxiprocesso alla mafia. L’allora comandante dell’Arma decide di chiamare
sull’isola ufficiali di provata esperienza ma senza precedenti di servizio sul
territorio, che potessero agire senza condizionamenti ambientali e personali.
Così a Palermo arriva un capitano triestino, che non capisce il dialetto
siciliano ma che coglie subito lo spirito siciliano: i carabinieri sono come i
piemontesi invasori, e per la mafia vale la stessa tecnica usata coi terroristi:
bisogna prima di tutto impararne la lingua. Forte di quell’esperienza
professionale, nel 1990 Mori torna al comando generale con il mandato di
organizzare un nuovo reparto dell’Arma: il Raggruppamento operativo speciale, il
Ros. Una struttura che ancora oggi si occupa di contrasto alla mafia e al
terrorismo in tutta Italia, derogando alla rigida logica territoriale dei
carabinieri. Principale sostenitore del progetto: il magistrato Giovanni
Falcone, che Mori aveva conosciuto nei suoi anni in Sicilia. La sede del nuovo
reparto diventa la caserma di via Talamo, vicino a Villa Ada a Roma, che era
stata occupata a suo tempo dell’Antiterrorismo, e a capo viene nominato il
generale Antonio Subranni. Con la carica di comandante di reparto, Mori torna in
Sicilia e riprende l’inchiesta “mafia e appalti”, avviata nel suo primo
soggiorno sull’isola e che teorizzava il rapporto tra la mafia e il settore
economico imprenditoriale. A sostenerlo c’è di nuovo Giovanni Falcone e, dopo la
sua morte, Paolo Borsellino. Entrambi la considerano un salto di qualità nella
lotta a Cosa nostra, e Borsellino la ritiene causa scatenante della strage di
Capaci. Proprio durante la conduzione di questa inchiesta, tuttavia, sorgono i
primi dissapori tra il Ros di Mori e la Procura di Palermo, in particolare a
causa delle indagini sulle presunte connivenze tra i boss e una parte della
politica del capoluogo. A conferma dei timori di Mori, “Mafia e appalti” si
chiude con gli arresti di una serie di imprenditori molto vicini ai vertici di
Cosa nostra ma la Procura chiede l’archiviazione delle posizioni dei politici
indagati, proprio il giorno dopo la strage di via D’Amelio.
L’ARRESTO DI RIINA. Il boss dei boss di Cosa nostra, Totò Riina, viene arrestato
il 15 gennaio 1993 e a Palermo è una giornata d’inverno isolano, 11 gradi e
nemmeno una nuvola in cielo. L’indagine che porta alla cattura del capo della
più grande organizzazione criminale d’Europa è iniziata nell’infuocata estate
del 1992, cioè nella stagione in cui l’aggressività contro lo Stato della
strategia mafiosa voluta da Riina ha visto la sua escalation con le stragi di
Capaci e di via D’Amelio. In quell’anno, Mario Mori viene nominato
vicecomandante del Ros, con responsabilità dell’attività operativa del reparto.
Forma così un’unità speciale e a capo nomina Sergio De Caprio, il capitano
Ultimo: la peculiarità del gruppo è di operare in modo svincolato
dall’organizzazione dei carabinieri per evitare qualsiasi fuga di notizie e
limitare qualsiasi contatto con il mondo esterno. Le informazioni iniziano ad
arrivare: prima il fatto che Riina si nasconde da qualche parte nel quartiere
della Noce, capeggiata dalla famiglia mafiosa dei Ganci. Poi che uno dei figli
del boss, Domenico, si reca spesso in un complesso residenziale in via Bernini.
La svolta, però, arriva quando viene arrestato a Novara Baldassare Di Maggio,
boss che inizia a collaborare col giudice Giancarlo Caselli e racconta del
cosiddetto “fondo Gelsomino” dove avvengono le riunioni di Cosa nostra e di due
costruttori palermitani favoreggiatori del latitante Riina (già noti ai
carabinieri perchè indagati durante l’inchiesta “mafia e appalti”). E’ questa
l’informazione chiave: nel complesso di via Bernini risulta un’utenza telefonica
intestata a loro. Il 13 gennaio scatta l’operazione: su un furgone “balena”, con
impianto per le riprese audiovisive, sono appostati gli uomini di Ultimo e il
boss Di Maggio, che riconosce in un’auto che entra nel condominio la moglie di
Riina, Ninetta Bagarella. Il secondo giorno di appostamento, a bordo di una
Citroen ZX che esce dal complesso residenziale, Di Maggio riconosce un uomo
d’onore alla guida e, accanto a lui, Totò Riina in persona. La squadra
di Ultimo, coordinata da Mori, fa scattare la trappola pochi chilometri dopo in
un motel Agip e cattura entrambi i boss. L’uomo più ricercato d’Italia,
l’ultrapotente Riina, è in trappola. Eppure, il generale lo considera il suo più
grande rimpianto professionale: «Non ho avuto la forza di aspettare, di andare
avanti nel pedinamento, se avessi atteso ancora qualche chilometro prima di dare
l’ordine li avremmo presi tutti: seppi poi che Riina si stava dirigendo a una
riunione della “commissione” provinciale di Cosa nostra. La correttezza era
quella di andare avanti come insegnava la dottrina Dalla Chiesa, ma sentivo
idealmente sopra di me il peso del comando generale dell’Arma del ministero
dell’Interno e mi mancò il coraggio di attendere». Dalla sua operazione più
brillante, prende corpo il primo processo a suo carico. Mori viene rinviato a
giudizio dalla procura di Palermo per favoreggiamento aggravato nei confronti di
Cosa nostra, per aver ritardato la perquisizione nell’ultimo covo di Riina. Il
giorno dell’arresto, il magistrato torinese Caselli ha assunto le funzioni di
procuratore della Repubblica di Palermo e proprio lui viene convinto da Mori e
De Caprio ad aspettare ad entrare nella casa di via Bernini. «Una richiesta
assolutamente coerente con la dottrina investigativa e la tecnica operativa
dell’antiterrorismo dei Carabinieri, secondo le quali da ogni azione si dovevano
ricavare i presupposti per poter proseguire l’indagine con efficacia», ha
scritto Mori. In altre parole, se la perquisizione fosse avvenuta
immediatamente, tutte le persone che avevano frequentato il covo si sarebbero
sentite bruciate. Così si consuma l’ennesima rottura con la procura di Palermo:
il Ros di Mori vuole evitare l’intervento e sfruttare la superiorità
informativa; i magistrati palermitani subentrati nell’operazione, invece,
richiedono un’osservazione costante, incompatibile secondo i carabinieri con il
luogo senza venire notati. Così De Caprio sospende l’osservazione con le
modalità richieste dai pm, dopo alcuni giorni, e procede alla perquisizione
della casa vuota. L’incomprensione porta al procedimento penale: «Il danno e la
beffa, perché la responsabilità del ritardo nella perquisizione ricadde
esclusivamente su me e De Caprio», ha commentato successivamente Mori. I due
carabinieri, però, vengono assolti il 20 febbraio 2006 e i pm Antonio Ingroia e
Michele Prestipino non presentano ricorso in appello. La sentenza conferma che
si è trattata di una scelta investigativa legittima e che “l’accettazione del
rischio fu condivisa da tutti”.
L’AFFARE PROVENZANO. Dopo l’arresto di Riina, le indagini si spostano sul suo
braccio destro Bernardo Provenzano, detto Binnu ‘ u tratturi per la ferocia con
cui elimina gli avversari, latitante dal 1964. Un primo tentativo di indagine
viene portato avanti grazie alla collaborazione di don Tano Badalamenti, boss di
Cinisi detenuto in America, nel carcere federale di Memphis, ed esponente della
cosiddetta mafia tradizionale, uscita perdente dalla guerra contro i corleonesi
di Riina e Provenzano. Il boss si fida del maresciallo Nino Lombardo e sembra
disposto a qualche forma di collaborazione di giustizia, ma il suicidio di
Lombardo in seguito a notizie di una sua presunta collusione con la mafia
(pronunciate durante la trasmissione di Michele Santoro da parte del sindaco di
Palermo Leoluca Orlando) blocca l’operazione. L’iniziativa del Ros è già però
oggetto di maldicenze: in particolare si fa circolare la voce che che i
carabinieri volessero favorire il ritorno della vecchia mafia. Chiuso quel
tentativo, nel 1996 viene chiesto un impegno operativo del Ros alla Dda di
Reggio Calabria e Mori cessa le sue attività in Sicilia, ma il nome di
Provenzano (catturato nel 2006) torna, sempre attraverso un’iniziativa della
Procura di Palermo. Nel 2008 i sostituti procuratori Antonio Ingroia e Nino Di
Matteo sostengono l’accusa contro Mori e il colonnello Mauro Obinu per aver
assecondato la latitanza di Provenzano, col movente di garantire un patto
siglato tra pezzi delle istituzioni e Cosa nostra. La tesi del pm si incrocia
con l’inchiesta sulla presunta trattativa Stato- mafia, che negli stessi giorni
inizia il suo iter processuale. La linea accusatoria è che “Mori e Obinu,
obbedendo a un indirizzo di politica criminale, hanno ritenuto di trovare una
sciagurata soluzione nell’assecondare le fazioni più moderate di Provenzano e di
Cosa nostra” e ancora che si è trattato di “una scelta sciagurata di politica
criminale, e cioè la prosecuzione della latitanza di Provenzano. Allo stesso
modo il governo e il Dap assecondarono il dialogo agendo in questa ottica di
trattativa”. Secondo i pm, infatti, proprio il mancato arresto di Provenzano fa
parte delle clausole del patto tra mafia e istituzioni. All’origine delle accuse
ci sono le dichiarazioni del colonnello Michele Riccio, che ha sostenuto di
avere ricevuto la soffiata da un pentito di un summit nelle campagne di
Mezzojuso a cui avrebbe partecipato anche il nuovo capo di Cosa nostra e di
essersi visto negare la possibilità di fare un blitz e procedere all’arresto:
«Quel blitz non fu possibile perché i vertici del Ros non misero a disposizione
i mezzi necessari». In primo grado viene messa in dubbio l’attendibilità del
testimone d’accusa, poi indagato per falsa testimonianza, e Mori e Obinu sono
assolti con formula piena perché “il fatto non costituisce reato”. Il
procuratore generale Roberto Scarpinato fa appello ridimensionando
l’imputazione, ma la Corte ribadisce l’assoluzione aggiungendo che “Non può
ritenersi provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli imputati abbiano
posto in essere la condotta loro contestata con la coscienza e la volontà di
favorire il latitante Bernardo Provenzano”, ma soprattutto che “le risultanze
processuali sono inidonee a provare la sussistenza del movente della
trattativa”. Per i giudici c’è stata una “omissione” e una “sottovalutazione
dell’importanza dello spunto investigativo”, ma nulla più. Infine, nel 2016 la
Cassazione ritiene inammissibile il ricorso della procura di Palermo. «Avendo la
coscienza a posto, sono sempre stato molto tranquillo», è stato il lapidario
commento del generale al termine dell’ultimo grado di giudizio.
IL SISDE. I’ 1 ottobre 2001, a meno di un mese dall’attacco alle Torri Gemelle,
Mori viene trasferito da Milano a Roma, per prendere servizio come direttore del
Sisde, il servizio segreto civile. E’ il suo ultimo incarico operativo prima
della pensione, nel 2006. Mori affronta il nuovo compito con le stesse tecniche
imparate nel contrasto con il terrorismo politico e la mafia e, durante gli anni
a capo del servizio, mette a segno arresti eccellenti sul fronte internazionale:
il primo, quello del boss mafioso Giovanni Bonomo, tra i trenta ricercati più
pericolosi e latitante dal 1996, rifugiato all’estero in Costa d’Avorio e
catturato in Senegal; poi, la cattura degli assassini del colonnello Antonio
Varisco, ucciso a Roma dalle Br nel 1979. «Avevo un debito da saldare nei
confronti di un caro amico», ha detto Mori. I membri del gruppo di fuoco erano
Prospero Gallinari, Rita Algranati, Alessio Casimirri e Antonio Savasta e gli
ultimi tre erano ancora latitanti, in Nicaragua e Maghreb. Non riuscì a
catturare Casimirri e Savasta, mentre Algranati, nota come la “compagna Marzia”,
venne fermata al Cairo nel 2004, dopo averne seguito gli spostamenti in tutto il
nord Africa. Infine, con l’operazione “Tramonto rosso”, fornì alla Digos di
Milano, coordinata da Ilda Boccassini, gli strumenti necessari per sgominare le
nuove Br, che stavano progettando l’omicidio del giuslavorista Pietro Ichino,
arrestando tutti i membri.
TRATTATIVA STATO- MAFIA. La storia del generale Mori, forse uno degli
investigatori più noti nella storia dell’Arma, avrebbe potuto concludersi con la
pensione. Invece, dopo i due processi e le due assoluzioni, la Procura di
Palermo porta avanti contro di lui un terzo filone di indagine. La tesi richiama
in modo diretto quella sostenuta nel processo per il mancato l’arresto di
Provenzano e anche i pm sono gli stessi: Antonio Di Matteo, Antonio Ingroia, con
Vittorio Teresi e Roberto Tartaglia. Del resto, il procuratore capo Scarpinato,
che Mori ha conosciuto negli anni Novanta e con il quale da capo del Ros non ha
mai instaurato alcun rapporto di fiducia, ha sostenuto più volte che: «C’è un
filo rosso che attraversa tutte le vicende di cui il generale Mario Mori si è
reso protagonista». Nel caso del processo sulla Trattativa Stato- Mafia, Mori è
considerato l’anello di congiunzione tra pezzi deviati dello Stato e Cosa
nostra, in una trattativa che punta a fermare lo stragismo mafioso “concedendo”
una tregua. Tra i punti di questa tregua, proprio la latitanza di Provenzano,
capo dei capi succeduto a Riina. Caposaldo dell’ipotesi di una trattativa,
secondo la Procura palermitana, è l’incontro tra Mori e l’ex sindaco di Palermo,
il democristiano in odore di mafia, Vito Ciancimino, nel 1992. Per la procura, è
l’inizio del dialogo con Cosa nostra. Per Mori, Ciancimino è una tra le fonti da
sondare per arrestare Riina e del cui contatto non venne allertata la Procura di
Palermo, con la quale i rapporti di fiducia si erano molto compromessi dopo
l’archiviazione di “mafia e appalti”. «Mi avvalsi delle mie facoltà e decisi di
non comunicare alla procura che stavamo tentando di acquisire come fonte Vito
Ciancimino», ha spiegato Mori, allora convinto che «non tutti i pubblici
ministeri di Palermo fossero decisi a combattere Cosa nostra». Su questo
elemento si fonda l’inchiesta per minaccia a corpo politico dello Stato e la
Corte accoglie la tesi della Procura: il capo di imputazione per Mori non è
identico a quello su Provenzano per cui è stato assolto dalla Cassazione, perché
il fatto storico del mancato arresto nel 1995 viene considerato dall’accusa come
conseguenza del dialogo avviato nel 1992 e non è l’oggetto principale. Dopo 5
anni di udienze, nel 2018 il Tribunale di Palermo condanna in primo grado Mario
Mori a 12 anni di carcere, quale anello di congiunzione della trattativa,
insieme a chi all’epoca dei fatti collaborava con lui nel Ros. Assolve invece
per prescrizione il boss Leoluca Bagarella e perché il fatto non sussiste il
politico Dc Nicola Mancino. A chi gli domanda come abbia affrontato il processo,
di cui ha presenziato ad ogni udienza, Mori risponde secco: «con la testa». E a
chi gliene ha chiesto conto prima della sentenza, ha sempre replicato che i
processi si discutono nelle aule di tribunale. In attesa della sentenza, ha
preso parte a un documentario- intervista dal titolo “Generale Mori, un’Italia a
testa alta”, che suscita polemiche dovunque venga presentato, delle quali lui si
cura molto poco. Del resto, nella sua biografia “Ad alto rischio” (scritta a
quattro mani col giornalista Giovanni Fasanella) ha sintetizzato così il suo
stato d’animo: «Se sono amareggiato? No. Conosco la storia del mio paese con
tutte le sue anomalie, so che servire lealmente lo Stato colpendo interessi
consolidati, come abbiamo fatto io e i miei commilitoni, comporta dei rischi».
Il rischio, per lui, sono stati vent’anni di processi e la condanna più odiosa:
quella per collusione con il sistema mafioso, affrontata con la stessa freddezza
di sempre. Infatti, dopo la lettura del dispositivo nell’aula bunker di Palermo,
non ha rilasciato alcun commento.
La mafia e Berlusconi: furono loro i mandanti di Di Pietro e
Davigo! Scrive Piero Sansonetti il 19 Dicembre 2017 su
"Il Dubbio". Le pensate del Pm Di Matteo. È molto istruttivo leggere le
requisitorie o le interviste del dottor Di Matteo, ex Pm palermitano ora passato
alla Procura nazionale antimafia. Raramente ci si trovano elementi interessanti
dal punto di vista giuridico, ma sono affascinanti le sue teorie politiche o le
sue ricostruzioni storiche, sempre molto fantasiose e impreviste. La mafia e il
Cav: furono loro i mandanti di Di Pietro e Davigo! L’ultima fatica di Di Matteo
è stata la requisitoria pronunciata un paio di giorni fa al famoso processo
sulla trattativa stato- mafia. I giornali non ne hanno parlato molto, perché
ormai, in realtà, hanno capito un po’ tutti che questa storia della trattativa
non sta in piedi. In effetti, nella requisitoria, della trattativa si è parlato
poco poco, perché i Pm in tutti questi anni non sono riusciti a trovare uno
straccio di prova, e poi perché la maggior parte degli imputati è stata già
assolta in vari stralci del processo condotti col rito abbreviato. Di Matteo
però si è concentrato su una storia parallela all’ ipotetica e improbabile
trattativa: la storia della nascita di Forza Italia, e in particolare del ruolo
svolto da Marcello Dell’Utri. Probabilmente perché, date le ultime vicende (il
rifiuto da parte del tribunale di sorveglianza della scarcerazione di Dell’Utri
per ragioni di salute) Di Matteo ha intuito che il tema avrebbe potuto
incontrare l’interesse della stampa, al quale lui non è mai del tutto
indifferente. In effetti Il Fatto Quotidiano gli ha concesso un discreto spazio.
Con un bel titolo in prima pagina e un titolo ancora più forte in pagina
interna. Il titolo di prima dice: «Dopo Capaci, Riina puntò su Dell’Utri e B.».
Il titolo interno dice: «Dell’Utri andò dai boss prima di fare Forza Italia». Il
racconto di Di Matteo è molto articolato, però è costruito su terribili pasticci
di date, e questi pasticci producono effetti davvero strabilianti. E cioè
accreditano una ipotesi un po’ grottesca, che è quella contenuta nel titolo di
questo articolo: e cioè l’ipotesi che Riina e Berlusconi siano i mandati
dell’inchiesta “Mani Pulite” che spazzò via la prima Repubblica. Seguiamo il
racconto di Di Matteo. Primo capitolo: attentati della mafia alla Standa di
Catania. La Standa apparteneva a Berlusconi. Siamo nel 1990, quasi quattro anni
prima della fondazione di Forza Italia. Secondo Di Matteo, dopo gli attentati,
Berlusconi mandò Dell’Utri a Catania per trattare con la mafia affinché
smettesse di colpire la Standa. Per dimostrare questa sua tesi, Di Matteo non si
limita a citare un paio di pentiti (non dei maggiori e comunque senza alcun
riscontro) ma cita la famosa intercettazione realizzata nel 2013, nella quale
Totò Riina, parlando con un infiltrato al 41 bis, dice tra l’altro che dopo
l’attentato qualcuno ( probabilmente Berlusconi) « mandò a quello di Palermo che
parlò con uno e si mise d’accordo… questo senatore però poi finì in galera…» .
Di Matteo ha commentato: «Lascio a voi capire chi è il senatore che scese e poi
finì in galera». Qui si pone un primo problema di date. Perché l’intercettazione
di Riina è dell’agosto del 2013, come dicevamo, mentre Dell’Utri finisce in
prigione nell’aprile del 2014. Riina aveva la palla di vetro? Potrebbe, in via
teorica, esserci una spiegazione, ma non regge molto: in realtà Dell’Utri nel
1995 andò in prigione per qualche giorno per una storia, credo, di falsi in
bilancio. Molto improbabile che Riina si riferisse a quell’episodio, poco
conosciuto e brevissimo, ma diamolo per buono. Secondo capitolo. Di Matteo
racconta il Fatto Quotidiano, che è considerato il giornale di famiglia del Pm –
sostiene che il primo contatto di Cosa Nostra con Dell’Utri, dopo Lima, «arriva
da Catania, con gli attentati alla Standa, e gli incendi furono decisi dai
corleonesi, e fu deliberato di attaccare la Standa per assoggettare Berlusconi e
realizzare un nuovo progetto politico». Nasce così Forza Italia, destinata a
sostituire la Dc travolta dalla fine della prima Repubblica. Dunque Berlusconi
non mandò Dell’Utri per far finire gli attentati, ma per fondare un partito. Qui
però c’è un nuovo inguacchio di date. Gli attentati alla Standa avvennero due
anni prima del delitto Lima, non dopo. E immaginare che la mafia nel 1990 avesse
in mente di sostituire la Dc con Berlusconi è davvero un’impresa difficile,
persino per una persona convincente come Di Matteo. Nel 1990 la Dc era ancora
fortissima in sella, e il suo declino era assolutamente inimmaginabile. Ma
ammettiamo pure che i pasticci di date che rendono molto poco credibile tutta la
requisitoria siano semplici incidenti tecnici. Ok. Dunque la mafia e Dell’Utri e
Berlusconi nel 1990 e poi “con le riunioni della cupola dell’autunno del 91 che
conducono alla formazione di Forza Italia” (cito sempre “Il Fatto”) stabiliscono
che è ora di far fuori la Dc. Ma a chi affidano il compito? Chi è che poi,
concretamente, si incarica di eliminare la Dc e di radere al suolo la sua Prima
Repubblica? Beh, questa risposta è facile: il pool dei magistrati milanesi
guidati da Di Pietro e Davigo. Dunque torna la teoria del complotto, che fin qui
era stata una esclusiva di qualche ambiente socialista. I socialisti però hanno
sempre puntato il dito sugli americani. Ora invece, clamorosamente, si rovescia
tutto: Di Pietro e Davigo erano uno strumento nelle mani dei corleonesi, di
Dell’Utri e di Berlusconi. E per conto loro agirono aprendo la strada al
successo elettorale del cavaliere del 1994. Tutto questo, naturalmente, non ha
niente a che vedere con l’ipotesi di una trattativa tra Stato (all’epoca guidato
dalla Dc) e mafia, che dovrebbe in realtà essere l’oggetto del processo. Anzi, è
una ricostruzione storica che smonta alla radice l’ipotesi della trattativa. La
mafia, secondo Di Matteo, se ne fregava della Dc perché stava tramando per
andare al potere con Forza Italia, e dunque non aveva nessuna ragione per
trattare con la Dc che considerava in estinzione. E dunque? Non so, le
conclusioni le lascio a voi. Anche perché il dottor Di Matteo, nella sua
requisitoria, si è lanciato in un invettiva contro i giornali “di nicchia” che
lo criticano e lo delegittimano. Chiarendo qual è la sua idea “imperiale” sul
ruolo e i diritti della magistratura: unica istituzione autorizzata a sfuggire
al diritto di critica dei giornali. Persino di quelli di nicchia…
Ingroia: «Berlusconi sa che meriterebbe l’arresto».
L’ex pm a un Giorno da pecora su Rai Radio1: «Lui ha una serie di condanne, di
fatti penali, politici ed etico morali pesantissimi. E, ciò nonostante, oggi è
ancora a controllare la politica del nostro Paese», scrive Franco Stefanoni il
22 novembre 2017 su "Il Corriere della Sera". Antonio Ingroia, ex pm tra coloro
che interrogarono Silvio Berlusconi e oggi leader della Lista del Popolo, con
Giulietto Chiesa, ha parlato, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, di
Silvio Berlusconi. Ingroia, dopo tutti i suoi `scontri´ verbali col Cavaliere
quando lei faceva il Pm, lo ha più incontrato? «No, è capitato solo che quando
si faceva l’ultima campagna elettorale, lui mi fece il gesto delle manette». Un
gesto simpatico... «Un gesto simpatico, ma lui sotto sotto lo sa che meriterebbe
di essere arrestato». Ancora lo meriterebbe? «Sempre lo meriterebbe», ha detto
Ingroia a Un giorno da pecora. Come dovrebbe esser giudicato Berlusconi da
Strasburgo? «Lui ha una serie di condanne, di fatti penali, politici ed etico
morali pesantissimi. E ciò nonostante, oggi è ancora a controllare la politica
del nostro paese». E cosa bisognerebbe fare per sconfiggerlo? «Bisogna
abbatterlo politicamente».
Gasparri: «È solo un cacciatore di poltrone». «Ingroia parla come un
guerrigliero e dice di arrestare e abbattere Berlusconi. Poi scodinzola davanti
a Musumeci, nuovo presidente della Sicilia, per mantenere le immeritate poltrone
di sottogoverno che ha preteso da Crocetta. Già stratrombato dagli elettori e
sconfitto nei processi intentati a eroici carabinieri, fonda partitini destinati
al disastro. Davvero un esempio emblematico dell’Italia peggiore. Rivoluzionario
alla radio, si spaccia per cacciatore di Berlusconi, ma si rivela solo un
cacciatore di poltrone nelle anticamere di Palermo. Più che la mossa del cavallo
ama il salto della quaglia». Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia
e vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri.
Ingroia, torna l'ossessione per Silvio Berlusconi: "Andrebbe
arrestato immediatamente", scrive il 23 Novembre 2017
"Libero Quotidiano". Ci sono ossessioni difficili da metabolizzare, come quella
dell'ex magistrato Antonio Ingroia per Silvio Berlusconi. Non pago
dell'umiliazione elettorale subita con l'omonima lista nel 2013, Ingroia è
tornato in pista accanto al giornalista Giulietto Chiesa per lanciare una
roboante Lista del Popolo. Il programma del nuovo partito è chiaro già dai primi
passi, l'antiberlusconismo è tornato vivo e vibrante come ai tempi d'oro, tanto
che Ingroia lo ripropone in una epocale rispolverata a Un giorno da pecora su
Radiouno. All'ex magistrato è stato chiesto se avesse mai incontrato Berlusconi.
Così ha ripescato quell'incrocio memorabile di qualche anno fa: "È capitato solo
quando si faceva l'ultima campagna elettorale, lui mi fece il gesto delle
manette". Che il senso dell'umorismo facesse un po' difetto all'ex pm era fatto
noto, con il passare del tempo però sembra essere molto peggiorato. Al punto che
ricordando quel gesto simpatico, Ingroia ha sparato: "Un gesto simpatico sì, ma
lui sotto sotto lo sa che meriterebbe di essere arrestato". Ancora? Gli chiedono
in studio, lui non ha dubbi: "Sempre lo meriterebbe". Raddrizza il tiro però
quando gli viene chiesto come si dovrebbe fermare uno come il Cav: "Bisogna
abbatterlo politicamente". Roba da brividi.
Grasso, la persecuzione di Ingroia. Si può capire l'ex pm quando
critica su Repubblica il presidente del Senato, ma a tutto c'è un limite,
scrive Massimo Bordin il 5 Dicembre 2017 su "Il Foglio". In fondo Antonio
Ingroia, se non giustificare, si può comprendere. Non ci sono solo questioni
professionali, ormai antiche ma tutt'ora presenti alla memoria. Il problema è
che l’ascesa politica di Pietro Grasso rischia di essere vissuta dall’ex pm dei
due mondi come una persecuzione personale. La storia, che ricorda quella di
Paperino e Gastone, inizia nel 2013 quando Ingroia si sospende da magistrato per
candidarsi a presidente del Consiglio alla testa di un raggruppamento a sinistra
del Pd. Fu un disastro di notevolissime proporzioni e mentre Ingroia rimaneva
fuori non solo da Palazzo Chigi ma anche da Montecitorio, Grasso entrava a
palazzo Madama, eletto nel Pd, e diventava presidente del Senato nel giro di
pochi giorni. Ora Ingroia ritenta con una lista bizzarramente battezzata "La
mossa del cavallo" senza che nemmeno i circoli degli scacchi se ne siano
accorti, mentre Grasso raccoglie ovazioni, titoli di apertura sui giornali e
grandi foto, sia pure con Speranza, Fratojanni e Civati che non sono un gran che
ma sempre meglio di Giulietto Chiesa. Si può capire dunque l’ex pm quando
critica Grasso su Repubblica, è una reazione umana. A tutto c’è comunque un
limite, che viene ampiamente superato quando da parte sua si sostiene la
necessità di facce nuove in politica e quando, dopo aver comunque perorato la
candidabilità dei magistrati si aggiunge che "dovrebbe essere loro vietato di
tornare in magistratura dopo aver fatto politica" contando evidentemente sul
fatto che tutti si siano dimenticati come si comportò dopo la sua mancata
elezione.
Tutti i silenzi sul caso Ingroia. Quando gli indignati tacciono,
scrive Salvo Toscano Martedì 19 Dicembre 2017 su "Live Sicilia". Dopo la prima
inchiesta un'altra. Ma i professionisti dell'indignazione non se ne sono
accorti. C'è qualcosa che colpisce dopo la notizia della nuova indagine per
peculato a carico di Antonio Ingroia. Non si sente ma colpisce. È un'assenza
pesante, un rumoroso silenzio. Quello dell'esercito dei professionisti
dell'indignazione. Quelle truppe di moralizzatori in servizio permanente
effettivo pronte a intonare il peana a ogni avviso di garanzia o notizia
d'inchiesta finita sui giornali. I cantori devoti delle gesta delle italiche
procure, insofferenti verso ogni forma di garantismo, che da quelle parti è
sempre per definizione “peloso”, confermano una prassi ben collaudata: si
distraggono quando il moralizzatore finisce moralizzato e disinnescano in quel
caso l'automatismo della richiesta di dimissioni. Quella che scatta quando sotto
la lente d'ingrandimento dei magistrati inquirenti finisce il quisque de populo
slegato dalla conventicola dell'indignazione o peggio ancora l'avversario
politico da fare a pezzi. E' la parrocchia del mantra degli
"impresentabili", che rinfaccia l'avviso di garanzia anche al cugino di secondo
grado. Farà lo stesso con l'ex pm oggi politico che alle prossime elezioni
battezzerà la sua Lista del Popolo? Vedremo. Per ora tutto tace. Non pervenute
le penne fustigatrici, l'antimafia col bollino blu e la politica
dell'onestà. Quella che per una Monterosso s'è vestita da sanculotto e che
adesso non si fa sentire, vedi alla voce Cinque stelle. E dire che la vicenda
presenta delle peculiarità che colpiscono. In particolare la circostanza che per
una storia che sembrerebbe analoga, un'inchiesta c'era già stata a carico
dell'ex pm. La precedente indagine, giunta alle battute finali come ha
ricostruito Riccardo Lo Verso, si concentrava sulle retribuzioni dal 2013 al
2016. Ora i pm indagano sul 2017. La questione riguarda i suoi emolumenti tra
stipendi, premi e rimborsi spese, anche per hotel di lusso e noti ristoranti,
per l'incarico di sottogoverno attribuitogli da Rosario Crocetta alla guida di
Scilia e-servizi. Nel marzo scorso, ricorda Livesicilia, Ingroia era stato pure
interrogato dai suoi ex colleghi. L'ex pm, che spera di mantenere il posto dopo
il cambio a Palazzo d'Orleans, ha sempre rivendicato la correttezza del suo
operato. E sembrerebbe che dopo le prime contestazioni dei suoi ex colleghi,
Ingroia abbia ritenuto di tirare dritto – era “una storia totalmente infondata",
disse all'epoca, “correggendo” i pm (da quando ha lasciato la toga l'avvocato
Ingroia ha dispensato diverse bacchettate ai meno celebri ex colleghi) – finendo
così nella seconda inchiesta. Quando forse prudenza, vista l'inchiesta in corso,
avrebbe potuto suggerire altra condotta. Ma questa è in effetti una annotazione
che spetterebbe ai professionisti dell'indignazione. Se non fossero distratti.
SILVIO E BETTINO, I LUPI DELLA MILANO DA BERE.
Berlusconi racconta Craxi: «Bettino morì e la famiglia non aveva
neanche i soldi del funerale». Sul palco del Teatro
Franco Parenti di Milano, il leader di Forza Italia per presentare il libro di
inediti del leader socialista, scrive il 30 ottobre 2018 Nino Luca su Corriere
tv.
Berlusconi tra nostalgia e minacce: “Salvini lasci questo governo
o rompiamo le alleanze”. Invitato al lancio del libro
di pensieri di Bettino Craxi, il leader di Forza Italia, in un’atmosfera più di
nostalgia che di energia, parte all’attacco dei Cinque Stelle e invoca il
ritorno di Matteo Salvini, scrive il 30 ottobre 2018 L’Inkiesta. «Oggi ho
guardato lo specchio e ho visto un signore che conoscevo. “Tu sei quello che più
di 20 anni fa ha salvato l’Italia dai comunisti”, ho detto. “È incredibile che
sia ancora tu, adesso che devi salvare l’Italia dai grillini”». Applausi,
sorrisi e inchino da seduto. Silvio Berlusconi rompe il silenzio degli ultimi
giorni e sale sul palco del Parenti per ricordare Bettino Craxi insieme a
Sallusti e Stefania Craxi, in occasione della presentazione del libro di scritti
del leader socialista intitolato “Uno sguardo sul mondo”. E sfodera il sorriso
di una volta. Ma è una delle poche cose rimaste. Il pubblico – complice la
pioggia battente – non è certo quello delle grandi occasioni. Gli applausi
cadono, ma si dividono tra quelli per Craxi e quelli per lui. Doveva essere una
commemorazione della Prima Repubblica ed è diventata, quasi in modo
impercettibile, una cerimonia di ricordo della Seconda. I ricordi, le frasi al
passato, espressioni come “il mio governo fu”, o “il mio governo fece”, si
alternavano ad altri ricordi, ad altre frasi al passato, a “il suo governo fu” e
“il suo governo fece”. Berlusconi amico di Bettino, e Berlusconi come
continuazione di Bettino. «Lui voleva un’Italia attenta al Mediterraneo, in
quanto unico luogo in cui poteva giocare una funzione di leadership. E l’ultimo
atto di politica estera in questa direzione è stata la firma degli accordi con
la Libia di Gheddafi, fatti dal governo Berlusconi». Appunto, una vita fa. Il
passaggio dal Milan al Monza non poteva essere più chiaro. Eppure, anche se si
tratta di un campetto di periferia, è pur sempre un campo. E Silvio Berlusconi,
rallentato e acciaccato, non vuole smettere di scenderci. Prima di tutto,
all’ingresso al teatro, comunica il suo no alla manovra del governo. «Non è per
il timore di una procedura di infrazione. Ma è perché fa il male degli
italiani». Poi si scaglia contro il reddito di cittadinanza: «L’assistenzialismo
non ha mai fatto crescere il Paese». Poi ancora, dal palco, picchia di nuovo sui
Cinque Stelle: «Questi sono peggio del Pds di Occhetto: coltivano
l’assistenzialismo, vanno avanti con il giustizialismo e sono anche
incompetenti». E: «Non hanno mai lavorato: non si può affidare un’impresa a chi
non sa come si gestisce un’impresa». «È fondamentale mandare a casa questo
governo. Una nuova maggioranza, con questo stesso Parlamento, è possibile»,
Silvio Berlusconi. Ma soprattutto, lancia la zampata del campione: «A quelli
della Lega diciamo: dateci una data con cui metterete fine a questa innaturale
alleanza. Tra poco ci sono elezioni regionali, cittadine. Come potremo
presentarci insieme se ignorate il programma elettorale – scritto da me e
ripreso da Salvini – con cui avete tradito il voto dei vostri elettori?».
Insomma, tra la nostalgia per le glorie di Pratica di Mare («Con cui continuai
lo spirito della politica estera di Bettino Craxi») e la leggenda dei «cinque
colpi di Stato» che si sarebbero susseguiti durante i suoi governi (chi se la
ricordava più questa), Berlusconi riesce a piazzare la minaccia di far saltare
tutte le coalizioni locali. «È fondamentale mandare a casa questo governo. Una
nuova maggioranza, con questo stesso Parlamento, è possibile». E se non lo
fosse, «dovremo andare subito a nuove elezioni». Eppure, nonostante la lotta per
il potere non sia ancora finita, qualcosa è cambiato. Lo si vede anche nei
dialoghi sul palco. I temi trattati da Craxi, cioè la critica alla
globalizzazione, all’immigrazione dall’Africa e agli accordi di Maastricht (il
leader socialista sosteneva, già negli anni ’90, che andassero rivisti), ormai
sono moneta corrente della nuova Lega di Matteo Salvini. Anche il lessico
(«Craxi fu un vero patriota») viene da lì. E poco conta che Silvio si dica
«europeista», se poi aggiunge che «questa non è la nostra Europa». L’egemonia
culturale, per usare parole da professoroni, gli è stata strappata di mano.
Restano i ricordi, però. Le rivendicazioni. Le vendette e le denunce. Una è già
un leitmotiv: «Questo spread è diverso da quello del 2011». Allora si trattava
di «un complotto, appoggiato dalla sinistra italiana e da una persona che
abitava uno dei Colli più alti di Roma, con cui è stato fatto cadere il
governo». E così rivela, proprio nel giorno in cui Angela Merkel annuncia la
fine, de facto, della sua esperienza politica, che si trattava di una punizione,
da parte della Germania, per aver fatto nominare Mario Draghi a capo della Bce.
«Fui io, con la mia abilità, a mettere d’accordo i rappresentanti dei vari Paesi
del Mediterraneo. Creai un fronte comune che non si aspettavano» e si decise di
andare contro la volontà tedesca. E così, quando la Cancelliera Angela Merkel
presentò come candidato il presidente della Bundesbank, «lo votarono solo in
tre: la Germania, la Francia di Sarkozy e la Finlandia. Sì, anche la Finlandia».
Ma perché mai? «Perché – sorride – il presidente finlandese fu l’unico che non
riuscii a raggiungere al telefono». E cadono altri applausi, altre risate, e di
nuovo, un inchino da seduto. Berlusconi è ancora qua.
Stefania Craxi: “Berlusconi l’unico vero leader a seguire le orme
di mio padre, anche lui vuole riformare l’Europa”,
scrive il 27 ottobre 2018 Agen Press. Agenpress. C’è sempre stata una forte
affinità tra la politica estera di Craxi e quella di Berlusconi. Stefania Craxi,
figlia dello statista socialista, senatrice di Forza Italia, vicepresidente
della commissione Esteri di Palazzo Madama, spiega la ragione per la quale ha
voluto accanto a sé l’ex premier e leader azzurro alla presentazione, lunedì 29
ottobre a Milano alle 18 al teatro Parenti, insieme con il direttore del
“Giornale” Alessandro Sallusti, del libro di Bettino Craxi “Uno sguardo sul
mondo” (Mondadori), a cura della Fondazione Craxi. Se l’Europa fosse stata
costruita in modo più equo e solidale – dichiara Stefania Craxi – forse il mondo
non sarebbe in preda alle diseguaglianze che provocano guasti: dall’immigrazione
incontrollata al divario sempre più grande tra ricchezza e povertà, fino a una
nuova riedizione della guerra fredda con la corsa al riarmo di questi giorni.
Quelle lezioni contenute nel libro sono ancora oggi di estrema attualità. Craxi
voleva che l’Europa si costruisse secondo regole e principi di giustizia
sociale, di solidarietà tra Nazioni aperte al mondo, un’Europa vicina ai
cittadini. Oggi Craxi avrebbe lavorato per la riforma dell’Europa. Sigonella è
la dimostrazione che si può stare all’interno di sistemi nazionali e
sovranazionali e al tempo stesso difendere gli interessi nazionali. È stato
grave non averlo ascoltato allora, sarebbe grave non ascoltarlo oggi. C’ è una
forte affinità nella politica estera di cambiamento tra Craxi e Berlusconi.
Craxi lavorò per la fine della guerra fredda; Berlusconi ha lavorato per
l’accordo (Usa-Russia) di Pratica di Mare. Craxi aveva una visione di insieme
nel Mediterraneo e del ruolo chiave dell’Italia; Berlusconi firmò quel
capolavoro diplomatico che fu il trattato di cooperazione e amicizia con la
Libia. L’Europa Craxi voleva riformarla. È quella stessa intuizione che oggi
viene rilanciata senza intenti distruttori da Berlusconi.
SILVIO E BETTINO, I LUPI DELLA MILANO DA BERE,
scrive Nicolò Zuliani il 14 maggio 2018 su The Vision. Silvio
Berlusconi nasce a Milano nel 1936. A vent’anni lavora come cantante sulle navi
da crociera insieme al suo migliore amico, Fedele Confalonieri, poi vende
aspirapolveri porta a porta. A 25 anni, dopo la laurea in giurisprudenza,
acquista il primo terreno per 190 milioni di lire grazie alla fideiussione di
Carlo Rasini, titolare della banca Rasini dove lavorava suo padre. È una banca
particolare: puoi diventarne cliente solo tramite raccomandazione, possiede
quote di società offshoree custodisce i soldi di personaggi del calibro di
Filippo Calò, Totò Riina, Bernardo Provenzano – e, soprattutto, è una banca
collegata a Michele Sindona. Inizia così la carriera imprenditoriale di Silvio
Berlusconi, che fonda la Cantieri Riuniti Milanesi Srl e inizia a costruire.
Sono gli anni del boom, in cui esplode il settore edilizio e Silvio, coi suoi 28
anni, è un giovanissimo imprenditore rampante.
Bettino Craxi nasce a Milano nel 1934. Dimostra da subito un carattere
aggressivo e turbolento, e per correggerlo i genitori lo mandano in un collegio
cattolico. A 17 anni, seguendo l’esempio del padre, prende la tessera del
partito socialista. Studia giurisprudenza, poi scienze politiche; all’università
tiene i primi discorsi in pubblico, entra nel Nucleo Universitario Socialista,
organizza conferenze e dibattiti; poi, a 23 anni, entra nel comitato
centrale del partito e nel 1968, dopo esser stato consigliere comunale, diventa
deputato. La sera mangia a L’Angolo, una trattoria di Brera, ritrovo di pittori
e artisti, e il proprietario – comunistissimo – li fa mangiare a sbafo in cambio
di quadri. A Craxi piace l’ambiente, gli permette di ascoltare le conversazioni
tenendosi in disparte, per farsi un’idea dei discorsi e delle opinioni della
sinistra; ed è qui che conosce Filippo Panseca, artista squattrinato di fervente
fede socialista, di cui diventa amico. L’Italia di quegli anni è attraversata da
omicidi, gambizzazioni, studenti che parlano di alzare il livello dello scontro,
simpatizzano con le Brigate Rosse e che insieme agli operai aspettano l’arrivo
della rivoluzione proletaria. Alcuni, con le armi, cercano di anticiparla. A
metà degli anni Settanta, gli italiani sono sfiniti dagli omicidi della malavita
organizzata, dagli attentati, dall’odio che impregna le strade e senza
promettere di risolversi; Milano, soprattutto, è stanca di vivere in un mondo
dove persino le fantasie delle camicie o gli sport diventano simboli borghesi da
abbattere. Divertirsi sembra un reato, ma in questa cappa di miseria, paura e
desolazione, in via Carducci c’è un posto dove si trovano i milanesi benestanti:
si chiama Vogue club, e per entrare serve una chiave d’oro che viene assegnata a
discrezione del proprietario. Non è ancora il tempio del jet set che diventerà
di lì a poco, ma è molto intimo. Si ballano pezzi come “Superstition” o “Lady
Bump”, gli uomini portano la cravatta, i pantaloni dei completi sono a zampa; è
il periodo d’oro dei liquori amari, mentre i cocktail vengono snobbati. Grazie
all’amicizia con Bettino, Filippo Panseca è diventato “artista del Psi”, fa lo
scenografo e lavora sull’immagine e sull’estetica dei socialisti, precorrendo i
tempi del marketing, fino ad allora reputato frivolo e inutile. È di questo che
stanno parlando un venerdì notte Filippo e Bettino, quando si imbattono in
Silvio Berlusconi: ha appena fondato la Fininvest, con metodi e manovre
economiche controverse, e ha grandi progetti per il futuro. Prima di chiunque in
Italia ha compreso il potenziale della televisione e reputa i socialisti l’unica
sinistra possibile, perché davvero progressisti, a differenza del Pci. Nel 1976,
con la caduta del governo Moro, il Partito Comunista ha un’impennata, mentre il
gradimento del Psi è sotto il 6%. De Martino, il segretario, è costretto a
dimettersi. L’Italia cambia a un ritmo vertiginoso e tutto ciò che appare
tradizionale o tradizionalista rappresenta il male. Si può essere solo giovani o
vecchi, e i vecchi sono il nemico. In un clima di lotta generazionale, parlare
di rinnovamento in un partito di sessantenni è improbabile, e Craxi ha appena 40
anni: è un volto nuovo, ma con alle spalle oltre 28mila voti e una lunga
gavetta. I socialisti lo eleggono segretario “di transizione”, credendolo, a
torto, un ragazzino manipolabile: Craxi è davvero il rinnovamento, con tutte le
contraddizioni del caso. Come quando, pochi mesi dopo l’elezione, rilascia
un’intervista in cui spiega come e dove gli piace scopare. Sistema i suoi uomini
nei ruoli chiave del partito. Delega a Panseca il compito di ripensare il
simbolo del Psi, toglie la falce e il martello e ci mette un garofano rosso, il
fiore usato dagli operai il 1° maggio. Con il Presidente della Repubblica Sandro
Pertini ha un rapporto di amore e odio: quando lo convoca nel 1979 al Quirinale,
Craxi si presenta sì in giacca e cravatta, ma come pantaloni indossa un paio di
jeans. Pertini lo rispedisce a casa, intimandogli di tornare in abito scuro “o
di non scomodarsi a tornare”. Quello che Craxi sta cercando di fare,
riuscendoci, è trasformare la forma e l’immagine del Psi dalle fondamenta. Dà
indicazioni ai suoi uomini su come vestire e comportarsi e persino su dove
andare a ballare e a divertirsi, in un Paese bacchettone che deve presentarsi
come serio e impegnato a ogni costo. Essere socialista, per lui, significa
essere di sinistra, ma più sorridenti. Il ‘77 è l’anno della televisione a
colori e con la sua diffusione arrivano spot pubblicitari che incitano a uscire,
bere, godersela: Craxi intuisce che all’Italia basta un pretesto per scrollarsi
di dosso l’orrore e il grigiore degli anni di piombo.
Silvio Berlusconi, intanto, nel ’78 compra Telemilano – poi ribattezzata Canale
5 – e altre stazioni televisive, tutte regionali. In Italia infatti non esiste
ancora una legge che regoli la diffusione sulle frequenze nazionali delle
televisioni private. Poi va a Cannes, acquisisce le serie tv più belle
dell’epoca (tra cui Magnum PI, Dallas e Uccelli di rovo), strappandole alla Rai
che si era presentata in ritardo e offrendo pochi soldi. Negli studi di Milano,
Berlusconi programma 12 ore di trasmissioni, le registra, organizza un ponte via
elicotteri, aerei e taxi e recapita quelle registrazioni a tutte stazioni tv che
ha acquistato in giro per il Paese. Ufficialmente sono tutte emittenti
regionali, ma nella pratica formano una tv nazionale. L’audience di Canale 5,
comunque, non è abbastanza alta, così Berlusconi, racconta il giornalista Jean
Claude Bourret, manda in giro suoi emissari a caccia delle famiglie che
possiedono il Meter, una scatola collegata al proprio televisore che misura
l’audience nazionale. Una volta trovate, viene loro offerto un televisore ultimo
modello e 500mila lire di rimborso per la corrente elettrica. In cambio viene
chiesto solo di tenere il vecchio televisore sintonizzato su Canale 5
ventiquattr’ore su ventiquattro, senza mai spegnerlo – va bene anche tenerlo
chiuso in un armadio, con il volume regolato al minimo. Tutti accettano,
l’audience di Canale 5 schizza alle stelle e le aziende pagano uno spazio
pubblicitario il doppio che su un canale nazionale. C’è uno spot dell’Amaro
Ramazzotti del 1979 che racchiude tutta la mentalità italiana, appena prima
dell’esplosione di tracotanza degli imminenti anni Ottanta. “Ma dai, venite
fuori. Fuori è tutta un’altra cosa. Basta un niente per divertirsi: per esempio,
basta sapersi divertire.” La deflagrazione definitiva si manifesta nei clacson e
nelle bandiere che inondano il Paese nell’estate del 1982, quando l’Italia
arriva in finale contro la Germania. Di quella partita tutti ricordano Pertini
in tribuna che dopo il terzo goal di Altobelli muove il dito a destra e
sinistra urlando “I tedeschi non ci prendono più” – una frase che, pronunciata
da un partigiano, ha decisamente impatto. Un giornalista domanda al Presidente
se quell’entusiasmo non corrisponda a una fuga dai veri problemi della Nazione:
“Ma buon Dio,” sbotta Pertini, “Dopo sei giorni di lavoro viene la domenica, no?
Ebbene, chi ha lavorato i sei giorni ha il diritto di andare con la famiglia a
gioire sulla spiaggia, o in montagna, o altrove. E gli si dovrebbe dire: “Come
mai tu gioisci quando ti attende il lunedì?” Io penso a gioire la domenica, per
il lunedì verrà il suo tempo!”. Gli anni di piombo finiscono in quel momento.
All’improvviso, divertirsi, avere successo e arricchirsi diventano le uniche
cose per cui valga la pena preoccuparsi. I soldi si fanno in borsa, dove un
normale operatore guadagna un miliardo e mezzo l’anno. “Girls just wanna have
fun” canta Cindy Lauper. Il pranzo “è per chi non ha niente da fare” dice Gordon
Gekko in Wall Street. Esplode il mito dell’abbondanza e dell’opulenza; le donne
devono essere maggiorate, come Carmen Russo su Drive in per i padri, e Margot
di Lupin III per i figli. Gli uomini devono adattarsi al canone di palestrati,
giovani, belli, in carriera e non dormire mai. I vestiti diventano abbondanti, i
capelli cotonati, i drink si tingono di colori fluo e decorazioni esagerate.
Giorgio Armani diventa famoso con American gigolò e il Made in Italy decolla;
Cerrutti, Ferragamo, Armani, Versace, fanno capi richiesti in tutto il mondo,
venduti a prezzi incredibili. Durante le settimane della moda le strade
traboccano di donne stupende che si riversano nei club di grido, dove vengono
sedotte da imprenditori, politici e playboy. Nell’instancabile vita notturna
milanese il Vogue diventa quello che è il Dorsia in American psycho: il locale
più ambito, dove chiunque conti, in Italia come nel mondo, deve passare.
Berlusconi, intanto, continua la sua conquista del mondo dei media e acquista
nel 1982 l’emittente televisiva Italia 1. Il 4 agosto 1983, mentre buona parte
del Paese cerca di sopravvivere a una delle estati più calde della Storia
d’Italia, Craxi diventa presidente del Consiglio. Berlusconi ne è felice – con
buona pace di Indro Montanelli, che dalle pagine de Il Giornale (dal 1979 di
proprietà di Berlusconi) definisce il governo Craxi “una jattura” e chiama
Bettino “un guappo di cartone”. Nel 1983 un operaio generico guadagna 600mila
lire. E mentre un caffè costa 400 lire, al Vogue una cena ne costa circa
100mille, le bottiglie di champagne 500mila e un grammo di cocaina 50mila. Il
culto della bella vita è obbligatorio, e i soldi sembrano spuntare dal nulla. Le
banche espongono monitor che registrano i livelli delle azioni in tempo reale,
davanti ai quali è comune vedere gente accalcata che si abbraccia come di fronte
a una partita. In periferia, intanto, una dose di eroina costa quanto un grammo
di coca nei locali e tutto vale per procurarsela. In mezzo a questi due mondi,
Craxi non si fa problemi a farsi fotografare in costume da bagno, sorridente,
mentre indossa un pareo o una giacca di pelle. In politica è uno schiacciasassi:
trasforma l’ora di religione da obbligatoria a facoltativa, scioglie il vecchio
comitato centrale creando un’assemblea socialista e trasformandola in un circo.
Dalle panche deserte e l’atmosfera sonnacchiosa si passa a un pienone di
personalità della moda, attrici di grido, cantanti, intellettuali; essere
presenti all’assemblea è fondamentale per la propria immagine, essere socialisti
è cool. Fanno persino cantare Frank Sinatra al Palatrussardi. È proprio
all’assemblea che Berlinguer prende i fischi, e Bettino se la gode non poco,
perché detesta quella politica grigia, burocratica e verbosa di chi “non ha
neanche la televisione a colori e parla di futuro”. I politici socialisti vivono
in mezzo alla gente; mangiano a Brera, al Matarel di via Mantegazza Solera, alla
Trattoria dell’Angolo in via Fiori Chiari o al Garibaldi di via Monte Grappa.
Bevono al bar Jamaica e al club Turati, di Carlo Ripa di Meana. Gianni De
Michelis, vicepresidente del Consiglio, pubblica con Mondadori Dove andiamo a
ballare questa sera?, la guida a 250 discoteche italiane. Dopo Italia 1,
Berlusconi acquista Rete 4 e si guadagna il soprannome di “sua emittenza”; dai
canali televisivi dipinge un mondo di festa e allegria posticcia, che gli
italiani reduci dagli anni di piombo bevono come acqua fresca. Fa concorrenza
diretta alla Rai e il suo strapotere inizia a destare qualche sospetto, tanto
che i questori di Torino, Pescara e Roma gli sequestrano gli impianti e gli
danno un ultimatum: interrompere l’interconnessione entro il 16 ottobre 1984,
pena l’oscuramento. Per Berlusconi sarebbe un disastro, dovrebbe rimborsare
tutti i clienti che pagano la pubblicità sui suoi canali, finendo sul lastrico.
Lo salva Bettino Craxi: in un giorno fa approvare un decreto legge che
liberalizza il settore audiovisivo italiano permettendo ai privati di avere
diffusione nazionale e, salvando così l’impero finanziario di Berlusconi. Il 19
ottobre 1987 i monitor fuori dalle banche cominciano a segnalare i negativi. A
Wall street è in atto il più grande crollo economico della Storia, il Dow
Jones perde il 22% e vengono bruciati 11mila miliardi. Anche se si tratta di un
crollo anomalo, è il segnale che gli anni Ottanta stanno finendo. Arriverà
Tangentopoli, i pianti sotto la doccia di Berlusconi, le detenzioni preventive,
la fuga di Craxi nella sua villa ad Hammamet dopo essere stato identificato come
il male assoluto della politica. Tutte le feste, prima o poi, finiscono. Di
quegli anni molti si domandavano cosa sarebbe restato: per tanti hanno
costituito un’epoca dei sogni, dove tutto era possibile e il mondo era dietro
l’angolo; per altri, l’epoca dell’infanzia, dei giocattoli da collezionisti, dei
cartoni animati e degli spot del Mulino bianco. Per altri ancora, soprattutto, è
stata quella di Berlusconi.
BERLUSCONI, CRAXI E 10 MILIARDI,
scrivono Piero Colaprico e Luca Fazzo il 24 novembre 1995 su "la Repubblica". Da
una parte Silvio Berlusconi. Dall'altra Bettino Craxi. In mezzo, una matassa di
collaboratori, prestanome, conti cifrati svizzeri, società off shore di mezzo
mondo. Per un anno il pool Mani pulite si è dedicato a un solo obiettivo:
dipanare i grovigli di questa matassa. E l'obiettivo è stato raggiunto quasi
all' improvviso, in una limpida e gelida notte di novembre, un anno esatto dopo
la notte in cui l'allora presidente del consiglio venne colpito dall' invito a
comparire che lo associò d' ufficio al popolato club di Tangentopoli. I
magistrati scoprono che quella matassa nascondeva lo straordinario andirivieni
di quindici miliardi. Soldi che partono dai fondi esteri di Silvio Berlusconi,
approdano nelle casse svizzere di Bettino Craxi, e da qui - evento assolutamente
inedito - un terzo della somma ritorna al mittente. Lo scambio avviene in tre
rate, undici giorni in tutto, durante l'ottobre 1991: mancavano quattro mesi
all' esplodere di Mani pulite, Bettino Craxi era forse il politico più potente
d' Italia, Silvio Berlusconi il presidente della Fininvest. Mercoledì, dopo il
tramonto, la svolta nelle indagini. Per violazione alla legge sul finanziamento
pubblico dei partiti, il giudice preliminare Maurizio Grigo dispone l'arresto di
Bettino Craxi, dei suoi prestanome Mauro Giallombardo e Giorgio Tradati, e di un
fondamentale dirigente Fininvest: Giorgio Vanoni, responsabile del settore
estero del gruppo di Silvio Berlusconi. E' il manager accusato di avere gestito
in prima persona una galassia di società-schermo, create dalla Fininvest nei
paradisi fiscali. Uno solo degli ordini viene eseguito dai finanzieri: Tradati,
amico d' infanzia dei fratelli Craxi, lascia la casa milanese di Porta Venezia
per San Vittore, tredici mesi dopo il suo primo, breve arresto. Degli altri
"catturandi", l'unico di cui si hanno notizie precise è Craxi: saprà di aver
ricevuto il quarto ordine di custodia nella tranquilla oasi giudiziaria di
Hammamet. Giallombardo dovrebbe essere in Lussemburgo, Giorgio Vanoni da qualche
parte nel mondo, forse a Londra. Di prima mattina, i finanzieri perquisiscono
anche gli uffici della Fininvest e trovano - almeno a giudicare dai sorrisoni in
mostra nel pomeriggio - nuove conferme documentali del quadro d' accusa
disegnato dal pool, quello che trascina per la prima volta nello stesso filone
d' inchiesta i più indomiti tra gli indagati di Mani pulite: Bettino Craxi e
Silvio Berlusconi. Il nome di Berlusconi potrebbe essere già stato iscritto nel
registro degli indagati: all' accusa di finanziamento illecito rischia di
aggiungersi quella ancora più grave di falso in bilancio. Da molti mesi il pool
scavava sul mistero della All Iberian, la società panamense con conti a Lugano
da cui nell' ottobre 1991 erano partiti i miliardi per Bettino Craxi. Le
rogatorie del pool si erano scontrate con le opposizioni continue degli avvocati
svizzeri della oscura società. Ma il muro difensivo salta grazie alla clamorosa
confessione di una gola profonda dall'interno della Fininvest: si chiama
Giovanni Romagnoni e ricopre una carica delicata, è responsabile della tesoreria
di gruppo. I magistrati hanno raccolto parecchio materiale, hanno realizzato più
d' un interrogatorio utile (non trapela mezza parola) e Romagnoni, mercoledì
sera, non può non fornire al pool Mani pulite il tassello che manca: All
Iberian, dice, è controllata da Fininvest, i soldi che muove sono soldi che
vengono dalla Silvio Berlusconi Finanziaria SA, società lussemburghese che -
spiega - è la cassaforte estera del Biscione. Non è la prima volta che questa
società compare nelle indagini: con il suo nuovo nome - Société financière
internationale d'investissement - si batte per impedire l'assistenza svizzera al
pool milanese. Interrogato Romagnoni, i pm Boccassini, Colombo e Greco ottengono
l'ordine di custodia in carcere per i quattro indagati. Sei pagine dense di
accuse: "Craxi Benedetto detto Bettino, quale segretario del Psi e deputato al
Parlamento" è accusato insieme ai suoi prestanome di avere incassato i quindici
miliardi dalla Fininvest. L' accusa si regge su documenti, accertamenti bancari,
testimonianze: tra queste, le dichiarazioni dei funzionari dello studio
londinese Carnelutti-Mackenzie-Mills, che si occupò di creare la rete delle
società off shore. "Dal complesso degli atti sopraindicati - si legge nell'
ordine di cattura - emerge che la società All Iberian, gestita da Vanoni Giorgio
ed alimentata con finanziamenti diretti della Silvio Berlusconi Finanziaria,
ebbe ad erogare a Craxi Bettino, sul conto Northern Holding, la somma di 10
miliardi; che, inoltre, in un primo momento, ebbe a bonificare un'ulteriore
somma di 5 miliardi, che su disposizione personale di Craxi venne retrocessa
alla stessa All Iberian". Il provvedimento parla anche di un "preciso disegno
finalizzato ad impedire la ricostruzione dell'operazione e, soprattutto, la
riconducibilità della stessa al gruppo Fininvest". "Solo quest' ultima società
poteva avere interesse a finanziare, seppure illecitamente, il Craxi, di cui
sono noti i legami ed i rapporti con gli alti dirigenti del gruppo Fininvest".
Se le cose stanno così come si legge, resta in sospeso una domanda: perché il
gruppo Berlusconi fece avere a Craxi dieci miliardi? E' quanto cercano di capire
gli inquirenti: "L' inchiesta - dice il pm Piercamillo Davigo, lasciando il
palazzo - è all' inizio". Frase già sentita. La Repubblica 02/08/2005, pag.38-39
Pietro Citati, 2 agosto 2005
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
La legalità è un comportamento conforme alla legge. Legalità e legge sono facce
della stessa medaglia.
Nei regimi liberali l’azione normativa per intervento statale, per regolare i
rapporti tra Stato e cittadino ed i rapporti tra cittadini, è limitata. Si
lascia spazio all’evolvere naturale delle cose. La devianza è un’eccezione, solo
se dannosa per l'equilibrio sociale.
Nei regimi socialisti/comunisti/populisti l’intervento statale è inflazionato da
miriadi di leggi, oscure e sconosciute, che regolano ogni minimo aspetto della
vita dell’individuo, che non è più singolo, ma è massa. Il cittadino diventa
numero di pratica amministrativa, di cartella medica, di fascicolo giudiziario.
Laddove tutti si sentono onesti ed occupano i posti che stanno dalla parte della
ragione, c’è sempre quello che si sente più onesto degli altri, e ne limita gli
spazi. In nome di una presunta ragion di Stato si erogano miriadi di norme
sanzionatrici limitatrici di libertà, spesso contrastati, tra loro e tra le loro
interpretazioni giurisprudenziali. Nel coacervo marasma normativo è impossibile
conformarsi, per ignoranza o per necessità. Ne è eccezione l'indole. Addirittura
il legislatore è esso medesimo abusivo e dichiarato illegittimo dalla stessa
Corte Costituzionale, ritenuto deviante dalla suprema Carta. Le leggi partorite
da un Parlamento illegale, anch'esse illegali, producono legalità sanzionatoria.
Gli operatori del diritto manifestano pillole di competenza e perizia pur
essendo essi stessi cooptati con concorsi pubblici truccati. In questo modo
aumentano i devianti e si è in pochi ad essere onesti, fino alla assoluta
estinzione. In un mondo di totale illegalità, quindi, vi è assoluta impunità,
salvo l'eccezione del capro espiatorio, che ne conferma la regola. Ergo: quando
tutto è illegale, è come se tutto fosse legale.
L’eccesso di zelo e di criminalizzazione crea un’accozzaglia di organi di
controllo, con abuso di burocrazia, il cui rimedio indotto per sveltirne l’iter
è la corruzione.
Gli insani ruoli, politici e burocratici, per giustificare la loro esistenza,
creano criminali dove non ne esistono, per legge e per induzione.
Ergo: criminalizzazione = burocratizzazione = tassazione-corruzione.
Allora, si può dire che è meglio il laissez-faire (il lasciare fare dalla natura
delle cose e dell’animo umano) che essere presi per il culo e …ammanettati per i
polsi ed espropriati dai propri beni da un manipolo di criminali demagoghi ed
ignoranti con un’insana sete di potere.
Prendiamo per esempio il fenomeno cosiddetto dell'abusivismo edilizio, che è
elemento prettamente di natura privata. I comunisti da sempre osteggiano la
proprietà privata, ostentazione di ricchezza, e secondo loro, frutto di
ladrocinio. Sì, perchè, per i sinistri, chi è ricco, lo è perchè ha rubato e non
perchè se lo è guadagnato per merito e per lavoro.
Il perchè al sud Italia vi è più abusivismo edilizio (e per lo più tollerato)?
E’ presto detto. Fino agli anni '50 l'Italia meridionale era fondata su piccoli
borghi, con case di due stanze, di cui una adibita a stalla. Paesini da cui
all’alba si partiva per lavorare nelle o presso le masserie dei padroni, per poi
al tramonto farne ritorno. La masseria generalmente non era destinata ad
alloggio per i braccianti.
Al nord Italia vi erano le Cascine a corte o Corti coloniche, che, a differenza
delle Masserie, erano piccoli agglomerati che contenevano, oltre che gli edifici
lavorativi e magazzini, anche le abitazioni dei contadini. Quei contadini del
nord sono rimasti tali. Terroni erano e terroni son rimasti. Per questo al Nord
non hanno avuto la necessità di evolversi urbanisticamente. Per quanto
riguardava gli emigrati bastava dargli una tana puzzolente.
Al Sud, invece, quei braccianti sono emigrati per essere mai più terroni. Dopo
l'ondata migratoria dal sud Italia, la nuova ricchezza prodotta dagli emigranti
era destinata alla costruzione di una loro vera e bella casa in terra natia,
così come l'avevano abitata in Francia, Germania, ecc.: non i vecchi tuguri dei
borghi contadini, nè gli alveari delle case ringhiera o dei nuovi palazzoni del
nord Italia. Inoltre quei braccianti avevano imparato un mestiere, che volevano
svolgere nel loro paese di origine, quindi avevano bisogno di costruire un
fabbricato per adibirlo a magazzino o ad officina. Ma la volontà di chi voleva
un bel tetto sulla testa od un opificio, si scontrava e si scontra con la
immensa burocrazia dei comunisti ed i loro vincoli annessi (urbanistici,
storici, culturali, architettonici, archeologici, artistici, ambientali,
idrogeologici, di rispetto, ecc.), che inibiscono ogni forma di soluzione
privata. Ergo: per il diritto sacrosanto alla casa ed al lavoro si è costruito,
secondo i canoni di sicurezza e di vincoli, ma al di fuori del piano regolatore
generale (Piano Urbanistico) inesistente od antico, altrimenti non si potrebbe
sanare con ulteriori costi sanzionatori che rende l’abuso antieconomico. Per
questo motivo si pagano sì le tasse per una casa od un opificio, che la
burocrazia intende abusivo, ma che la stessa burocrazia non sana, nè dota quelle
costruzioni, in virtù delle tasse ricevute e a tal fine destinate, di
infrastrutture primarie: luce, strade, acqua, gas, ecc.. Da qui, poi, nasce
anche il problema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Burocrazia su
Burocrazia e gente indegna ed incapace ad amministrarla.
Per quanto riguarda, sempre al sud, l'abusivismo edilizio sulle coste, non è uno
sfregio all'ambiente, perchè l'ambiente è una risorsa per l'economia, ma è un
tentativo di valorizzare quell’ambiente per far sviluppare il turismo, come
fonte di sviluppo sociale ed economico locale, così come in tutte le zone a
vocazione turistica del mediterraneo, che, però, la sinistra fa fallire, perchè
ci vuole tutti poveri e quindi, più servili e assoggettabili. L'ambientalismo è
una scusa, altrimenti non si spiega come al nord Italia si possa permettere di
costruire o tollerare costruzioni alle pendici dei monti, o nelle valli
scoscese, con pericolo di frane ed alluvioni, ma per gli organi di informazione
nazionale, prevalentemente nordisti e razzisti e prezzolati dalla sinistra, è un
buon viatico, quello del tema dell'abusivismo e di conseguenza della criminalità
che ne consegue, o di quella organizzata che la si vede anche se non c'è o che è
sopravalutata, per buttare merda sulla reputazione dei meridionali.
Prima della rivoluzione francese “L’Ancien Régime” imponeva: ruba ai poveri per
dare ai ricchi.
Erano dei Ladri!!!
Dopo, con l’avvento dei moti rivoluzionari del proletariato e la formazione
ideologica/confessionale dei movimenti di sinistra e le formazioni settarie
scissioniste del comunismo e del fascismo, si impose il regime contemporaneo
dello stato sociale o anche detto stato assistenziale (dall'inglese welfare
state). Lo stato sociale è una caratteristica dei moderni stati di diritto che
si fondano sul presupposto e inesistente principio di uguaglianza, in quanto
possiamo avere uguali diritti, ma non possiamo essere ritenuti tutti uguali: c’è
il genio e l’incapace, c’è lo stakanovista e lo scansafatiche, l’onesto ed il
deviante. Il capitale di per sé produce reddito, anche senza il fattore lavoro.
Lavoro e capitale messi insieme, producono ricchezza per entrambi. Il lavoro
senza capitale non produce ricchezza. Il ritenere tutti uguali è il fondamento
di quasi tutte le Costituzioni figlie dell’influenza della rivoluzione francese:
Libertà, Uguaglianza, Solidarietà. Senza questi principi ogni stato moderno non
sarebbe possibile chiamarlo tale. Questi Stati non amano la meritocrazia, né
meritevoli sono i loro organi istituzionali e burocratici. Il tutto si baratta
con elezioni irregolari ed a larga astensione e con concorsi pubblici truccati
di cooptazione. In questa specie di democrazia vige la tirannia delle minoranze.
L’egualitarismo è una truffa. E’ un principio velleitario detto alla “Robin
Hood”, ossia: ruba ai ricchi per dare ai poveri.
Sono dei ladri!!!
Tra l’antico regime e l’odierno sistema quale è la differenza?
Sempre di ladri si tratta. Anzi oggi è peggio. I criminali, oggi come allora,
saranno coloro che sempre si arricchiranno sui beoti che li acclamano, ma oggi,
per giunta, ti fanno intendere di fare gli interessi dei più deboli.
Non diritto al lavoro, che, come la manna, non cade dal cielo, ma diritto a
creare lavoro. Diritto del subordinato a diventare titolare. Ma questo principio
di libertà rende la gente libera nel produrre lavoro e ad accumulare capitale.
La “Libertà” non è statuita nell’articolo 1 della nostra Costituzione catto
comunista. Costituzioni che osannano il lavoro, senza crearne, ma foraggiano il
capitale con i soldi dei lavoratori.
Le confessioni comuniste/fasciste e clericali ti insegnano: chiedi e ti sarà
dato e comunque, subisci e taci!
Io non voglio chiedere niente a nessuno, specie ai ladri criminali e menzogneri,
perché chi chiede si assoggetta e si schiavizza nella gratitudine e nella
riconoscenza.
Una vita senza libertà è una vita di merda…
Cultura e cittadinanza attiva. Diamo voce alla piccola editoria indipendente.
Collana editoriale “L’Italia del Trucco, l’Italia che siamo”. Una lettura
alternativa per l’estate, ma anche per tutto l’anno. L’autore Antonio
Giangrande: “Conoscere per giudicare”.
"Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza". Dante,
Inferno XXVI.
La collana editoriale indipendente “L’Italia del Trucco, l’Italia che siamo”
racconta un’Italia inenarrabile ed inenarrata.
È così, piaccia o no ai maestrini, specie quelli di sinistra. Dio sa quanto gli
fa torcere le budella all’approcciarsi del cittadino comune, ai cultori e
praticanti dello snobismo politico, imprenditoriale ed intellettuale, all’élite
che vivono giustificatamente separati e pensosi, perennemente con la puzza sotto
il naso.
Il bello è che, i maestrini, se è contro i loro canoni, contestano anche
l’ovvio.
Come si dice: chi sa, fa; chi non sa, insegna.
In Italia, purtroppo, vigono due leggi.
La prima è la «meritocrazia del contenuto». Secondo questa regola tutto quello
che non è dichiaratamente impegnato politicamente è materia fecale. La
conseguenza è che, per dimostrare «l'impegno», basta incentrare tutto su un
contenuto e schierarsene ideologicamente a favore: mafia, migranti,
omosessualità, ecc. Poi la forma non conta, tantomeno la realtà della vita
quotidiana. Da ciò deriva che, se si scrive in modo neutro (e quindi senza farne
una battaglia ideologica), si diventa non omologato, quindi osteggiato o
emarginato o ignorato.
La seconda legge è collegata alla prima. La maggior parte degli scrittori
nostrani si è fatta un nome in due modi. Primo: rompendo le balle fin
dall'esordio con la superiorità intellettuale rispetto alle feci che sarebbero i
«disimpegnati».
Secondo modo per farsi un nome: esordire nella medietà (cioè nel tanto odiato
nazional-popolare), per poi tentare il salto verso la superiorità.
Il copione lo conosciamo: a ogni gaffe di cultura generale scatta la presa in
giro. Il problema è che a perderci sono proprio loro, i maestrini col ditino
alzato. Perché è meno grave essere vittime dello scadimento culturale del Paese
che esserne responsabili. Perché, nonostante le gaffe conclamate e i vostri moti
di sdegno e scherno col ditino alzato su congiuntivi, storia e geografia, gli
errori confermano a pieno titolo come uomini di popolo, gente comune, siano
vittime dello scadimento culturale del Paese e non siano responsabili di una sub
cultura menzognera omologata e conforme. Forse alla gente comune rompe il cazzo
il sentire le prediche e le ironie di chi - lungi dall’essere anche solo
avvicinabile al concetto di élite - pensa di saperne un po’ di più. Forse perché
ha avuto insegnanti migliori, o un contesto famigliare un po’ più acculturato, o
il tempo di leggere qualche libro in più. O forse perchè ha maggior dose di
presunzione ed arroganza, oppure occupa uno scranno immeritato, o gli si dà
l’opportunità mediatica immeritata, che gli dà un posto in alto e l’opportunità
di vaneggiare.
Non c'è nessun genio, nessun accademico tra i maestrini. Del resto, mai un vero
intellettuale si permetterebbe di correggere una citazione errata, tantomeno di
prenderne in giro l'autore. Solo gente normale con una cultura normale pure
loro, con una alta dose di egocentrismo, cresciuti a pane, magari a
videocassette dell’Unità di Veltroni e citazioni a sproposito di
Pasolini. Maestrini che vedono la pagliuzza negli occhi altrui, pagliuzza che
spesso non c'è neppure, e non hanno coscienza della trave nei loro occhi o su
cui sono appoggiati.
Intervista all’autore, il dr Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo storico,
giurista, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie.
«Quando ero piccolo a scuola, come in famiglia, mi insegnavano ad adempiere ai
miei doveri: studiare per me per sapere; lavorare per la famiglia; assolvere la
leva militare per la difesa della patria; frequentare la chiesa ed assistere
alla messa domenicale; ascoltare i saggi ed i sapienti per imparare, rispettare
il prossimo in generale ed in particolare i più grandi, i piccoli e le donne,
per essere rispettato. La visita giornaliera ai nonni ed agli zii era
obbligatoria perché erano subgenitori. I cugini erano fratelli. Il saluto
preventivo agli estranei era dovuto. Ero felice e considerato. L'elargizione dei
diritti era un premio che puntuale arrivava. Contava molto di più essere onesti
e solidali che non rivendicare o esigere qualcosa che per legge o per
convenzione ti spettava. Oggi: si pretende (non si chiede) il rispetto del
proprio (e non dell'altrui) diritto, anche se non dovuto; si parla sempre con
imposizione della propria opinione; si fa a meno di studiare e lavorare o lo si
impedisce di farlo, come se fosse un dovere, più che un diritto; la furbizia per
fottere il prossimo è un dono, non un difetto. Non si ha rispetto per
nessun'altro che non sia se stesso. Non esiste più alcun valore morale. Non c'è
più Stato; nè Famiglia; nè religione; nè amicizia. Sui social network, il bar
telematico, sguazzano orde di imbecilli. Quanto più amici asocial si hanno, più
si è soli. Questa è l'involuzione della specie nella società moderna
liberalcattocomunista».
Quindi, oggi, cosa bisogna sapere?
«Non bisogna sapere, ma è necessario saper sapere. Cosa voglio dire? Affermo che
non basta studiare il sapere che gli altri od il Sistema ci propinano come
verità e fermarci lì, perché in questo caso diveniamo quello che gli altri hanno
voluto che diventassimo: delle marionette. E’ fondamentale cercare il retro
della verità propinata, ossia saper sapere se quello che sistematicamente ci
insegnano non sia una presa per il culo. Quindi se uno già non sa, non può
effettuare la verifica con un ulteriore sapere di ricerca ed approfondimento. Un
esempio per tutti. Quando si studia giurisprudenza non bisogna fermarsi alla
conoscenza della norma ed eventualmente alla sua interpretazione. Bisogna sapere
da chi e con quale maggioranza ideologica e perchè è stata promulgata o emanata
e se, alla fine, sia realmente condivisa e rispettata. Bisogna conoscere il
retro terra per capirne il significato: se è stata emessa contro qualcuno o a
favore di qualcun'altro; se è pregna di ideologia o adottata per interesse di
maggioranza di Governo; se è un'evoluzione storica distorsiva degli usi e dei
costumi nazionali o influenzata da pregiudizi, o sia una conformità alla
legislazione internazionale lontana dalla nostra cultura; se è stata emanata per
odio...L’odio è un sentimento di rivalsa verso gli altri. Dove non si arriva a
prendere qualcosa si dice che non vale. E come quel detto sulla volpe che non
riuscendo a prendere l’uva disse che era acerba. Nel parlare di libertà la
connessione va inevitabilmente ai liberali ed alla loro politica di
deburocratizzazione e di delegificazione e di liberalizzazione nelle arti,
professioni e nell’economia mirante all’apoteosi della meritocrazia e della
responsabilità e non della inadeguatezza della classe dirigente. Lo statalismo è
una stratificazione di leggi, sanzioni e relativi organi di controllo, non fini
a se stessi, ma atti ad alimentare corruttela, ladrocinio, clientelismo e
sopraffazione dei deboli e degli avversari politici. Per questo i liberali sono
una razza in estinzione: non possono creare consenso in una massa abituata a
pretendere diritti ed a non adempiere ai doveri. Fascisti, comunisti e clericali
sono figli degeneri di una stessa madre: lo statalismo ed il centralismo. Si
dicono diversi ma mirano tutti all’assistenzialismo ed alla corruzione culturale
per influenzare le masse: Panem et circenses (letteralmente «pane e [giochi]
circensi») è una locuzione latina piuttosto nota e spesso citata, usata
nell'antica Roma e al giorno d'oggi per indicare in sintesi le aspirazioni
della plebe (nella Roma di età imperiale) o della piccola borghesia, o d'altro
canto in riferimento a metodi politici bassamente demagogici. Oggi la politica
non ha più credibilità perchè non è scollegata dall’economia e dalle caste e
dalle lobbies che occultamente la governano, così come non sono più credibili i
loro portavoce, ossia i media di regime, che tanto odiano la "Rete". Internet,
ormai, oggi, è l'unico strumento che permette di saper sapere, dando modo di
scoprire cosa c'è dietro il fronte della medaglia, ossia cosa si nasconda dietro
le fake news (bufale) di Stato o dietro la discultura e l'oscurantismo
statalista».
Cosa racconta nei suoi libri?
«Sono un centinaio di saggi di inchiesta composti da centinaia di pagine, che
raccontano di un popolo difettato che non sa imparare dagli errori commessi.
Pronto a giudicare, ma non a giudicarsi. I miei libri raccontato l’indicibile.
Scandali, inchieste censurate, storie di ordinaria ingiustizia, di regolari
abusi e sopraffazioni e di consueta omertà. Raccontano, attraverso testimonianze
e documenti, per argomento e per territorio, i tarli ed i nei di una società
appiattita che aspetta il miracolo di un cambiamento che non verrà e che,
paradosso, non verrà accettato. In più, come chicca editoriale, vi sono i saggi
con aggiornamento temporale annuale, pluritematici e pluriterritoriali. Tipo
“Selezione dal Reader’s Digest”, rivista mensile statunitense per famiglie,
pubblicata in edizione italiana fino al 2007. Gli argomenti ed i territori
trattati nei saggi periodici sono completati ed approfonditi nei saggi analitici
specificatamente dedicati e già pubblicati negli stessi canali di distribuzione
internazionale in forma Book o E-book. Canali di pubblicazione e di
distribuzione come Amazon o Google libri. Opere oggetto di studio e fonti
propedeutiche a tesi di laurea ed inchieste giornalistiche. I testi hanno una
versione video sui miei canali youtube».
Qual è la reazione del pubblico?
«Migliaia sono gli accessi giornalieri alle letture gratuite di parti delle
opere su Google libri e decine di migliaia sono le pagine lette ogni giorno.
Accessi da tutto il mondo, nonostante il testo sia in lingua italiana e non sia
un giornale quotidiano. Si troveranno, anche, delle recensioni deliranti e
degradanti di queste opere. Il mio intento non è soggiogare l'assenso parlando
del nulla, ma dimostrare che siamo un popolo difettato. In questo modo è ovvio
che l'offeso si ribelli con la denigrazione del palesato».
Perché è poco conosciuto al grande pubblico generalista?
«Perché sono diverso. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro
grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore
intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o
ignorati. Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre
dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il
più furbo o il più fortunato a precederti. In un mondo caposotto (sottosopra od
alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia
è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non
subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in
mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è? Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Dove si
sentono alti anche i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non
conta quanti passi fai e quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del
tuo percorso. Il difetto degli intelligenti è che sono spinti a cercare le
risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è che non hanno dubbi e
qualora li avessero sono convinti di avere già le risposte. Un popolo di
“coglioni” sarà sempre governato ed amministrato, informato, istruito e
giudicato da “coglioni”».
Qual è la sua missione?
«“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente…Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli
altri posti erano occupati. Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi,
altri che lottano un anno e sono più bravi, ci sono quelli che lottano più anni
e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che lottano tutta la vita: essi
sono gli indispensabili”. Citazioni di Bertolt Brecht. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio
i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!»
Perché è orgoglioso di essere diverso?
«E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta...” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli
stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è
adesso...” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che
per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo
senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale».
Dr. Antonio Giangrande. Orgoglioso di essere diverso.
La massa ti considera solo se hai e ti votano solo se dai. Nulla vali se tu sai.
Victor Hugo: "Gli uomini ti stimano in rapporto alla tua utilità, senza tener
conto del tuo valore." Le persone si stimano e si rispettano in base al loro
grado di utilità materiale, tangibile ed immediata, da rendere agli altri e non,
invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli
inutili da sempre, pur con altissimo valore, sono emarginati o ignorati,
inibendone, ulteriormente, l’utilità.
Dr. Antonio
Giangrande. Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger, youtuber,
presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie.
Fa quello che si sente di fare e crede in quello che si sente di credere.
La Democrazia non è la Libertà.
La libertà è vivere con libero arbitrio nel rispetto della libertà altrui.
La democrazia è la dittatura di idioti che manipolano orde di imbecilli
ignoranti e voltagabbana.
Cattolici e comunisti, le chiese imperanti, impongono la loro libertà, con la
loro morale, il loro senso del pudore ed il loro politicamente corretto.
Per questo un popolo di coglioni sarà sempre governato ed amministrato,
informato, istruito e giudicato da coglioni.
Facciamo
sempre il solito errore: riponiamo grandi speranze ed enormi aspettative in
piccoli uomini senza vergogna.
Un altro
errore che commettiamo è dare molta importanza a chi non la merita.
"Fatti non
foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza". Dante, Inferno
XXVI
Le pecore
hanno paura dei lupi, ma è il loro pastore che le porta al macello.
Da sociologo
storico ho scritto dei saggi dedicati ad ogni partito o movimento politico
italiano: sui comunisti e sui socialisti (Craxi), sui fascisti (Mussolini), sui
cattolici (Moro) e sui moderati (Berlusconi), sui leghisti e sui pentastellati.
Il sottotitolo è “Tutto quello che non si osa dire. Se li conosci li eviti.”
Libri che un popolo di analfabeti mai leggerà.
Da queste
opere si deduce che ogni partito o movimento politico ha un comico come leader
di riferimento, perché si sa: agli italiani piace ridere ed essere presi per il
culo. Pensate alle battute di Grillo, alle barzellette di Berlusconi, alle
cazzate di Salvini, alle freddure della Meloni, alle storielle di Renzi, alle
favole di D’Alema e Bersani, ecc. Partiti e movimenti aventi comici come leader
e ladri come base.
Gli effetti di
avere dei comici osannati dai media prezzolati nei tg o sui giornali, anziché
vederli esibirsi negli spettacoli di cabaret, rincoglioniscono gli elettori. Da
qui il detto: un popolo di coglioni sarà sempre amministrato o governato,
informato, istruito e giudicato da coglioni.
Per questo non
ci lamentiamo se in Italia mai nulla cambia. E se l’Italia ancora va,
ringraziamo tutti coloro che anziché essere presi per il culo, i comici e la
loro clack (claque) li mandano a fanculo.
Antonio Giangrande, scrittore, accademico senza cattedra universitaria di
Sociologia Storica, giornalista ed avvocato non abilitato. "Prima di giudicare
la mia vita o il mio carattere mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho
percorso io, vivi i miei dolori, i miei dubbi, le mie risate...vivi gli anni che
ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io. Ognuno
ha la propria storia. E solo allora mi potrai giudicare." Luigi Pirandello.
Dapprima ti
ignorano. Poi ti deridono. Poi ti emarginano. Poi ti combattono. Tu sei solo, ma
non per sempre. Loro sono tanti, ma non per sempre. Ed allora sarai vincente, ma
solo dopo la tua morte. I primi a combatterti sono i prossimi parenti ed i
compaesani ed allor "non ragioniam di loro, ma guarda e passa" (Dante
Alighieri). “Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la
gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i
prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre, non si chiama Maria?
E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle, non
stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?». Ed era per
loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se
non nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non
fece molti prodigi”. Mt 13, 54-58.
Se si
disprezza quello che gli altri sono e fanno, perché, poi, si è come gli altri e
si osteggiano i diversi?
"C’è
un’azione peggiore che quella di togliere il diritto di voto al cittadino e
consiste nel togliergli la voglia di votare.” (R. Sabatier)
«La
disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che
vivere onestamente sia inutile» - Corrado Alvaro, Ultimo diario, 1961.
Vivere senza
leggere, o senza sfogliare i libri giusti scritti fuori dal coro o vivere
studiando dai saggi distribuiti dal sistema di potere catto comunista savoiardo
nelle scuole e nelle università, è molto pericoloso. Ciò ti obbliga a credere a
quello che dicono gli altri interessati al Potere e ti conforma alla massa.
Allora non vivi da uomo, ma da marionetta.
Se scrivi e dici la verità con il coraggio che gli altri non hanno, il risultato
non sarà il loro rinsavimento ma l’essere tu additato come pazzo. Ti scontri
sempre con la permalosità di magistrati e giornalisti e la sornionità degli
avvocati avvezzi solo ai loro interessi. Categorie di saccenti che non ammettono
critiche. Se scrivi e sei del centro-nord Italia, i conterranei diranno: che bel
libro, bravo, è uno di noi. Se scrivi e sei del centro-sud Italia i conterranei
diranno: quel libro l’avrei scritto anch’io, anzi meglio, ma sono solo cazzate.
Chi siamo noi? Siamo i “coglioni” che altri volevano che fossimo o potessimo
diventare. Da bambini i genitori ci educavano secondo i loro canoni, fino a che
abbiamo scoperto che era solo il canone di poveri ignoranti. Da studenti i
maestri ci istruivano secondo il loro pensiero, fino a che abbiamo scoperto che
era solo il pensiero di comunisti arroganti. Prima dell’ABC ci insegnavano
“Bella Ciao”. Da credenti i ministri di culto ci erudivano sulla confessione
religiosa secondo il loro verbo, fino a che abbiamo scoperto che era solo la
parola di pedofili o terroristi. Da lettori e telespettatori l’informazione (la
claque del potere) ci ammaestrava all’odio per il diverso ed a credere di vivere
in un paese democratico, civile ed avanzato, fino a che abbiamo scoperto che si
muore di fame o detenuti in canili umani. Da elettori i legislatori ci
imponevano le leggi secondo il loro diritto, fino a che abbiamo scoperto che
erano solo corrotti, mafiosi e massoni. Ecco, appunto: siamo i “coglioni” che
altri volevano che fossimo o potessimo diventare. E se qualcuno non vuol essere
“coglione” e vuol cambiare le cose, ma non ci riesce, vuol dire che è “coglione”
lui e non lo sa, ovvero è circondato da amici e parenti “coglioni”.
John
Keating: Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il
mondo. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre
guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù.
Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando
credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Carpe
diem. Cogliete l'attimo, ragazzi... Rendete straordinaria la vostra vita!
Gerard
Pitts: Cogli la rosa quando è il momento, che il tempo, lo sai, vola e lo stesso
fiore che sboccia oggi, domani appassirà. John Keating: Non leggiamo e scriviamo
poesie perché è carino: noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri
della razza umana; e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge,
economia, ingegneria sono nobili professioni, necessarie al nostro
sostentamento; ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore, sono queste
le cose che ci tengono in vita. Dal film L'attimo fuggente (Dead Poets Society),
film del 1989 diretto da Peter Weir e con protagonista Robin Williams.
Studiare non
significa sapere, volere non significa potere. Ai problemi non si è capaci di
trovare una soluzione che accontenti tutti, perché una soluzione per tutti non
esiste. Alla fine nessuno è innocente, perché in questa società individualista,
violenta e superficiale tutti sono colpevoli. Io ho preso la mia decisione
mentre la totalità di voi non sa prenderne alcuna (anche nelle cose più
semplici). Come potreste capire cosa è veramente importante nella vita? Non
saprete mai se avete preso la decisione giusta perché non vi siete fidati di voi
stessi. Accusate il sistema, ma il sistema è freddo inesorabile matematico, solo
chi è deciso a raggiungere la riva la raggiungerà. Vi auguro tutto il meglio per
la vostra vita. “Class Enemy”, di Rok Bicek film del 2013.
Dr. Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo storico, giurista, blogger,
youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, destinatario delle
denunce presentate dai magistrati per tacitarlo e ricevente da tutta Italia di
centinaia di migliaia di richieste di aiuto o di denunce di malefatte delle
istituzioni. Ignorato dai media servi del potere.
Come far buon viso a cattivo gioco ed aspettare che dal fiume
appaia il corpo del tuo nemico. "Subisci e taci" ti intima il Sistema. Non
sanno, loro, che la vendetta è un piatto che si gusta freddo. E non si può
perdonare...
Un padre regala al figlio un sacchetto di chiodi. “Tieni figliolo, ecco un
sacchetto di chiodi. Piantane uno nello steccato Ogni volta che che perdi la
pazienza e litighi con qualcuno perchè credi di aver subito un'ingiustizia” gli
dice. Il primo giorno il figlio piantò ben 37 chiodi ma nelle settimane
successive imparò a controllarsi e il numero di chiodi cominciò piano piano a
diminuire. Aveva infatti scoperto che era molto più facile controllarsi che
piantare chiodi e così arrivò un giorno in cui non ne piantò nemmeno uno. Andò
quindi dal padre e gli disse che per quel giorno non aveva litigato con nessuno,
pur essendo stato vittima d'ingiustizie e di soprusi, e non aveva piantato alcun
chiodo. Il padre allora gli disse: “Benissimo figliolo, ora leva un chiodo dallo
steccato per ogni giorno in cui non hai perso la pazienza e litigato con
qualcuno”. Il figlio ascoltò e tornò dal padre dopo qualche giorno,
comunicandogli che aveva tolto tutti i chiodi dallo steccato e che non aveva mai
più perso la pazienza. Il padre lo portò quindi davanti allo steccato e
guardandolo gli disse: “Figliolo, ti sei comportato davvero bene. Bravo. Ma li
vedi tutti quei buchi? Lo steccato non potrà più tornare come era prima. Quando
litighi con qualcuno, o quando questi ha usato violenza fisica o psicologica nei
tuoi confronti, rimane una ferita come questi buchi nello steccato. Tu puoi
piantare un coltello in un uomo e poi levarlo, e lo stesso può fare questi con
te, ma rimarrà sempre una ferita. E non importa quante volte ti scuserai, o lui
lo farà con te, la ferita sarà sempre lì. Una ferita verbale è come il chiodo
nello steccato e fa male quanto una ferita fisica. Lo steccato non sarà mai più
come prima. Quando dici le cose in preda alla rabbia, o quando altri ti fanno
del male, si lasciano delle ferite come queste: come i buchi nello steccato.
Possono essere molto profonde. Alcune si rimarginano in fretta, altre invece,
potrebbero non rimarginare mai, per quanto si possa esserne dispiaciuti e si
abbia chiesto scusa".
Io non reagisco, ma mi si permetta di raccontare l'accaduto. Voglio far
conoscere la verità sui chiodi piantati nelle nostre carni.
La mia esperienza e la mia competenza mi portano a pormi delle domande sulle
vicende della vita presente e passata e sul perché del ripetersi di eventi
provati essere dannosi all’umanità, ossia i corsi e i ricorsi storici.
Gianbattista Vico, il noto filosofo napoletano vissuto fra il XVII e XVIII
secolo elaborò una teoria, appunto dei corsi e ricorsi storici. Egli era
convinto che la storia fosse caratterizzata dal continuo e incessante ripetersi
di tre cicli distinti: l’età primitiva e divina, l’età poetica ed eroica, l’età
civile e veramente umana. Il continuo ripetersi di questi cicli non avveniva per
caso ma era predeterminato e regolamentato, se così si può dire, dalla
provvidenza. Questa formulazione di pensiero è comunemente nota come “teoria dei
corsi e dei ricorsi storici”. In parole povere, tanto per non essere troppo
criptici, il Vico sosteneva che alcuni accadimenti si ripetevano con le medesime
modalità, anche a distanza di tanto tempo; e ciò avveniva non per puro caso ma
in base ad un preciso disegno stilato della divina provvidenza.” Io sono
convinto, invece, che l’umanità dimentica e tende a sbagliare indotta dalla
stupidità e dall’egoismo di soddisfare in ogni modo totalmente i propri bisogni
in tempi e spazi con risorse limitate. Trovare il perché delle discrepanze
dell’ovvio raccontato. Alle mie domando non mi do io stesso delle risposte. Le
risposte le raccolgo da chi sento essere migliore di me e comunque tra coloro
contrapposti con le loro idee sullo stesso tema da cui estrapolare il sunto
significativo. Tutti coloro che scrivono, raccontano il fatto secondo il loro
modo di vedere e lo ergono a verità. Ergo: stesso fatto, tanti scrittori,
quindi, tanti fatti diversi. La mia unicità e peculiarità, con la credibilità e
l’ostracismo che ne discende, sta nel raccontare quel fatto in un’unica sede e
riportando i vari punti di vista. In questo modo svelo le mistificazioni e
lascio solo al lettore l’arbitrio di trarne la verità da quei dati.
Voglio conoscere gli effetti, sì, ma anche le cause degli accadimenti: il post e
l’ante. La prospettiva e la retrospettiva con varie angolazioni. Affrontare le
tre dimensioni spaziali e la quarta dimensione temporale.
Si può competere con l’intelligenza, mai con l’idiozia. L’intelligenza ascolta,
comprende e pur non condividendo rispetta. L’idiozia si dimena nell’Ego,
pretende ragione non ascoltando le ragioni altrui e non guarda oltre la sua
convinzione dettata dall’ignoranza. L’idiozia non conosce rispetto, se non
pretenderlo per se stessa.
Quando fai qualcosa hai tutti contro: quelli che volevano fare la stessa cosa,
senza riuscirci, impediti da viltà, incapacità, ignavia; quelli che volevano
fare il contrario; e quelli, ossia la stragrande maggioranza, che non volevano
fare niente.
Certe persone non sono importanti, siamo noi che, sbagliando, gli diamo
importanza. E poi ci sono quelle persone che non servono ad un cazzo, non fanno
un cazzo e si credono sto cazzo.
Correggi un sapiente ed esso diventerà più colto. Correggi un ignorante ed esso
diventerà un tuo acerrimo nemico.
Molti non ti odiano perché gli hai fatto del male, ma perché sei migliore di
loro.
Più stupido di chi ti giudica senza sapere nulla di te è colui il quale ti
giudica per quello che gli altri dicono di te. Perché le grandi menti parlano di
idee; le menti medie parlano di fatti; le infime menti parlano solo male delle
persone.
E’ importante stare a posto con la propria coscienza, che è molto più importante
della propria reputazione. La tua coscienza sei tu, la reputazione è ciò che gli
altri pensano di te e quello che gli altri pensano di te è un problema loro.
Le bugie sono create dagli invidiosi, ripetute dai cretini e credute dagli
idioti, perché un grammo di comportamento esemplare, vale un quintale di parole.
Le menti mediocri condannano sempre ciò che non riescono a capire.
E se la strada è in salita, è solo perché sei destinato ad attivare in alto.
Ci sono persone per indole nate per lavorare e/o combattere. Da loro ci si
aspetta tanto ed ai risultati non corrispondono elogi. Ci sono persone nate per
oziare. Da loro non ci si aspetta niente. Se fanno poco sono sommersi di
complimenti. Guai ad aspettare le lodi del mondo. Il mondo è un cattivo pagatore
e quando paga lo fa sempre con l’ingratitudine.
Il ciclo vitale biologico della natura afferma che si nasce, si cresce, ci si
riproduce, si invecchia e si muore e l’evoluzione fa vincere i migliori. Solo a
noi umani è dato dare un senso alla propria vita.
Ergo. Ai miei figli ho insegnato:
Le ideologie, le confessioni, le massonerie vi vogliono ignoranti;
Le mafie, le lobbies e le caste vi vogliono assoggettati;
Le banche vi vogliono falliti;
La burocrazia vi vuole sottomessi;
La giustizia vi vuole prigionieri;
Siete nati originali…non morite fotocopia.
Siate liberi. Studiare, ma non fermarsi alla cultura omologata. La conoscenza è
l'arma migliore per vincere.
Antonio
Giangrande, orgoglioso di essere diverso.
Lettera ad un
amico che ha tentato la morte.
Le difficoltà
rinforzano il carattere e certo quello che tu eri, oggi non lo sei.
Le difficoltà
le affrontano tutti in modi diversi, come dire: in ogni casa c’è una croce.
L’importante portarla con dignità. E la forza data per la soluzione è
proporzionale all’intelligenza.
Per cui: x
grado di difficoltà = x grado di intelligenza.
Pensa che io
volevo studiare per emergere dalla mediocrità, ma la mia famiglia non poteva.
Per poter
studiare dovevo lavorare. Ma lavoro sicuro non ne avevo.
Per avere un
lavoro sicuro dovevo vincere un concorso pubblico, che lo vincono solo i
raccomandati.
Ho partecipato
a decine di concorsi pubblici: nulla di fatto.
Nel “mezzo del
cammin della mia vita”, a trentadue anni, avevo una moglie e due figli ed una
passione da soddisfare.
La mia vita
era in declino e le sconfitte numerose: speranza per il futuro zero!
Ho pensato ai
miei figli e si è acceso un fuoco. Non dovevano soffrire anche loro.
Le difficoltà
si affrontano con intelligenza: se non ce l’hai, la sviluppi.
Mi diplomo in
un anno presso la scuola pubblica da privatista: caso unico.
Mi laureo alla
Statale di Milano in giurisprudenza in due anni: caso raro.
Sembrava
fatta, invece 17 anni per abilitarmi all’avvocatura senza successo per
ritorsione di chi non accetta i diversi. Condannato all’indigenza e al
discredito, per ritorsione dei magistrati e dei media a causa del mio essere
diverso.
Mio figlio ce
l’ha fatta ad abilitarsi a 25 anni con due lauree, ma è impedito all’esercizio a
causa del mio disonore.
Lui aiuta gli
altri nello studio a superare le incapacità dei docenti ad insegnare.
Io aiuto gli
altri, con i miei saggi, ad essere orgogliosi di essere diversi ed a capire la
realtà che li circonda.
Dalla mia
esperienza posso dire che Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Quando esprimiamo giudizi o valutazioni lo facciamo con la nostra
bocca ma inconsapevolmente per volontà di altri. Lo facciamo in virtù di quanto
ricevuto: dall’educazione familiare, dall’istruzione di regime,
dall’indottrinamento politico e religioso, dall’influenza mediatica. Niente è
farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze staremmo
solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace e disposto ad ascoltarci.
Per questo un
popolo di coglioni sarà sempre governato ed amministrato, informato, istruito e
giudicato da coglioni.
Quindi, caro
amico, non guardare più indietro. Guarda avanti. Non pensare a quello che ti
manca o alle difficoltà che incontri, ma concentrati su quello che vuoi
ottenere. Se non lasci opere che restano, tutti di te si dimenticano, a
prescindere da chi eri in vita.
Pensa che più
difficoltà ci sono, più forte diventerai per superarle.
Volere è
potere.
E sii
orgoglioso di essere diverso, perché quello che tu hai fatto, tentare la morte,
non è segno di debolezza. Ma di coraggio.
Le menti più
eccelse hanno tentato o pensato alla morte. Quella è roba da diversi. Perché? Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo.
Per questo
bisogna vivere, se lo hai capito: per ribellione e per rivalsa!
Non si deve
riporre in me speranze mal riposte.
Io posso dare
solidarietà o prestare i miei occhi per leggere o le mie orecchie per sentire,
ma cosa posso fare per gli altri, che non son stato capace di fare per me
stesso?
Nessuno ha il
potere di cambiare il mondo, perché il mondo non vuol essere cambiato.
Ho solo il
potere di scrivere, senza veli ideologici o religiosi, quel che vedo e sento
intorno a me. E’ un esercizio assolutamente soggettivo, che, d’altronde, non mi
basta nemmeno a darmi da vivere.
E’ un lavoro
per i posteri, senza remunerazione immediata.
Essere diversi
significa anche essere da soli: senza un gruppo di amici sinceri o una claque
che ti sostenga.
Il fine dei
diversi non combacia con la meta della massa. La storia dimostra che è tutto un
déjà-vu.
Tante volte ho
risposto no ai cercatori di biografie personali, o ai sostenitori di battaglie
personali. Tante volte, portatori delle loro bandiere, volevano eserciti per
lotte personali, elevandosi a grado di generali.
La mia
missione non è dimostrare il mio talento o le mie virtù rispetto agli altri, ma
documentare quanto questi altri siano niente in confronto a quello che loro
considerano di se stessi.
Quindi
ritienimi un amico che sa ascoltare e capire, ma che nulla può fare o dare ad
altri, perché nulla può fare o dare per se stesso.
Sono solo un
Uomo che scrive e viene letto, ma sono un uomo senza Potere.
Dell’uomo
saggio e giusto si segue l’esempio, non i consigli.
Se si è
omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non
si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più
fortunato a precederti.
In un mondo
caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi
sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla
rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o
perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che
cazzo di vita è?
Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Dove si
sentono alti anche i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non
conta quanti passi fai e quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del
tuo percorso.
Il difetto
degli intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il
pregio degli ignoranti è che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti
di avere già le risposte.
Un popolo
di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato, informato, istruito e
giudicato da “coglioni”.
Un chierico
medievale si imbatté in un groviglio di serpi su cui spiccava un ramarro che già
da solo sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia, confrontata a quelle
serpeggianti creature, la bestiola gli parve graziosa ed esclamò: «Beati
monoculi in terra caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo è re.
Il ciclo
vitale, in biologia, è l'intervallo tra il susseguirsi di generazioni di una
specie. L'esistenza di ogni organismo si svolge secondo una sequenza ciclica di
stadi ed eventi biologici, caratterizzata in base alla specie di appartenenza.
Queste sequenze costituiscono i cosiddetti Cicli Biologici. Ogni essere vivente
segue un ciclo vitale biologico composto dai seguenti stadi: nascita, crescita,
riproduzione, senescenza e morte. Per quanto possa essere breve o corta la vita,
nessun essere vivente preso singolarmente è immortale. Ma la sua specie diventa
immortale attraverso la riproduzione e l'evoluzione. Gli esseri viventi si
evolvono nel corso del tempo per potersi meglio adattare alla natura che li
circonda. Attraverso la riproduzione le generazioni trasmettono i propri geni a
quelle future. Durante questo passaggio le nuove generazioni possono assumere
caratteristiche nuove o perderne alcune. Le differenze si traducono in vantaggi
o in handicap per chi le possiede, agendo direttamente sul processo evolutivo
tramite la selezione naturale degli individui. Le nuove caratteristiche che
agevolano l'adattamento all'ambiente offrono all'individuo maggiori probabilità
di sopravvivenza e, quindi, di riproduzione. E' innaturale non riprodursi. Senza
riproduzione non vi è proseguimento ed evoluzione della specie. Senza
riproduzione il ciclo vitale biologico cessa. Ciò ci rende mortali. Parlare in
termini scientifici dell'eterosessualità e del parto, quindi di stati naturali,
fa di me un omofobo ed un contrabortista, quindi un non-comunista? Cercare di
informare i simili contro la deriva involutiva, fa di me un mitomane o pazzo?
Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo giudizi
gratuiti, cattivi ed illogici lo facciamo con la nostra bocca ma
inconsapevolmente per volontà di altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto:
dall’educazione familiare, dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento
politico e religioso, dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro
sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo
che nessuno sarebbe capace e disposto ad ascoltarci.
E’ comodo
definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’
facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia.
In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano.
Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte
dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per
farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando
si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale.
Da sempre
diffido di chi, vestito da lupo, è pecora genuflessa alla magistratura. I
saccenti giustizialisti dei 5 stelle che provino a proporre la figura del
difensore civico giudiziario con poteri di magistrato, senza essere uno di loro,
per poter metter le mani nelle carte dei fascicoli e poterle sparigliare. Io da
anni mi batto inascoltato per questo. I signori dei 5 stelle non si degnano
nemmeno di rispondere ai messaggi degli esperti: tanto san tutto loro. A
sbraitare son bravi, ma a proporre leggi sensate, mi sa che non son capaci.
Parlan solo di soldi, soldi, soldi ed onestà, certificata dai loro magistrati, e
mai parlano di libertà ed opportunità senza concorsi ed esami pubblici truccati.
Ad ogni azione
umana nefasta si trova sempre una giustificazione...lo si fa per le piante...lo
si fa per gli animali...lo si fa per le persone! Ma, alla fine, rimane solo
un'azione nefasta che fa male al prossimo...e, spesso, il prossimo siamo noi. A
parte il partito preso, noi siamo tutti responsabili delle azioni nefaste di
uno, quando gli permettiamo di farle.
Parlare nei
miei libri del caso singolo del semplice cittadino significa incorrere
nell’accusa di mitomania, pazzia o calunnia, oltre che nel disinteresse. Invece
parlo di loro, delle istituzioni che delinquono impunite. Parlo della vera
mafia. Cosa posso dire di più di quello che ho scritto e che altri non dicono?
Credo che quanto divulgato possa essere di grande soddisfazione per le vittime,
non potendo avere altro che quella in questa Italia con italiani di merda a cui
interessa solo di loro stessi e se ne fottono degli altri.
Alla fine di
noi rimane il nostro operato, checché gli altri ne dicano. E quello bisogna
giudicare. Nasco da una famiglia umile e povera. Una di quelle famiglie dove la
sfortuna è di casa. Non puoi permetterti di studiare, né avere amici che
contano. Per questo il povero è destinato a fare il manovale o il contadino. Mi
sono ribellato e contro la sorte ho voluto studiare, per salire nel mondo non
mio. Per 17 anni ho cercato di abilitarmi nell’avvocatura. Non mi hanno voluto.
Il mondo di sotto mi tiene per i piedi; il mondo di sopra mi calca la testa. In
un esame truccato come truccati sono tutti i concorsi pubblici in Italia: ti
abilitano se non rompi le palle. Tutti uguali nella mediocrità. Dal 1998 ho
partecipato all’esame forense annuale. Sempre bocciato. Ho rinunciato a
proseguire nel 2014 con la commissione presieduta dall’avv. Francesco De Jaco.
L’avvocato di Cosima Serrano condannata con la figlia Sabrina Misseri per il
delitto di Sarah Scazzi avvenuto ad Avetrana. Tutte mie compaesane. La
Commissione d’esame di avvocato di Lecce 2014. La più serena che io abbia
trovato in tutti questi anni. Ho chiesto invano a De Jaco di tutelare me, dagli
abusi in quell’esame, come tutti quelli come me che non hanno voce. Se per lui
Cosima è innocente contro il sentire comune, indotti a pensarla così dai media e
dai magistrati, perché non vale per me la verità che sia vittima di un sistema
che mi vuol punire per essermi ribellato? Si nega l’evidenza. 1, 2, 3 anni,
passi. 17 anni son troppi anche per il più deficiente dei candidati. Ma gli
effetti sono sotto gli occhi di tutti. Compiti non corretti, ma ritenuti tali in
tempi insufficienti e senza motivazione e con quote prestabilite di abilitati.
Così per me, così per tutti. Gli avvocati abilitati negano l’evidenza. Logico:
chi passa, non controlla. Ma 17 anni son troppi per credere alla casualità di
essere uno sfigato, specialmente perché i nemici son noti, specie se sono nelle
commissioni d’esame. In carcere o disoccupato. Tu puoi gridare a squarciagola le
ingiustizie, ma nessuno ti ascolta, in un mondo di sordi. Nessuno ti crede. Fino
a che non capiti a loro. E in questa Italia capita, eccome se capita! La tua
verità contro la verità del potere. Un esempio da raccontare. Ai figli non
bisogna chiedere cosa vogliono fare da grandi. Bisogna dir loro la verità.
Chiedergli cosa vorrebbero che gli permettessero di fare da grandi. Sono nato in
quelle famiglie che, se ti capita di incappare nelle maglie della giustizia, la
galera te la fai, anche da innocente. A me non è successo di andare in galera,
pur con reiterati tentativi vani da parte della magistratura di Taranto, ma sin
dal caso Tortora ho capito che in questa Italia in fatto di giustizia qualcosa
non va. Pensavo di essere di sinistra, perché la sinistra è garantismo, ma non
mi ritrovo in un’area dove si tollerano gli abusi dei magistrati per garantirsi
potere ed impunità. E di tutto questo bisogna tacere. A Taranto, tra i tanti
processi farsa per tacitarmi sulle malefatte dei magistrati, uno si è chiuso,
con sentenza del Tribunale n. 147/2014, con l’assoluzione perché il fatto non
sussiste e per non doversi procedere. Bene: per lo stesso fatto si è riaperto un
nuovo procedimento ed è stato emesso un decreto penale di condanna con decreto
del Gip. n. 1090/2014: ossia una condanna senza processo. Tentativo stoppato
dall’opposizione.
Zittirmi sia
mai. Pur isolato e perseguitato. Gli italiani son questi. Ognuno dia la sua
definizione. Certo è che gli italiani non mi leggono, mi leggono i forestieri.
Mi leggeranno i posteri. Tutto regolare: lo ha detto la tv, lo dicono i giudici.
Per me, invece, è tutto un trucco. In un mondo di ladri nessuno vien da Marte.
Tutti uguali: giudicanti e giudicati.
E’ da decenni che studio il sistema Italia, a carattere locale come a livello
nazionale. Da queste indagini ne sono scaturiti decine di saggi, raccolti in una
collana editoriale "L'Italia del Trucco, l'Italia che siamo", letti in tutto il
mondo, ma che mi sono valsi l’ostruzionismo dei media nazionali. Pennivendoli
venduti ai magistrati, all’economia ed alla politica, ma che non impediscono il
fatto che di me si parli su 200.000 siti web, come accertato dai motori di
ricerca. Book ed E-Book che si possono trovare su Amazon.it, Lulu.com.
CreateSpace.com e Google Libri, oltre che in forma di lettura gratuita e free
vision video su
www.controtuttelemafie.it
, mentre la promozione del territorio è su
www.telewebitalia.eu.
Ho la
preparazione professionale per poter dire la sua in questioni di giustizia?
Non sono un
giornalista, ma a quanto pare sono l’unico a raccontare tutti i fatti. Non sono
un avvocato ma mi diletto ad evidenziare le manchevolezze di un sistema
giudiziario a se stante. La mia emigrazione in piena adolescenza in Germania a
16 anni per lavorare; la mia laurea quadriennale in Giurisprudenza presa in soli
due anni all’Università Statale di Milano, lavorando di notte e con moglie e due
figli da mantenere, dopo aver conseguito il diploma da ragioniere in un solo
anno da privatista presso un Istituto tecnico Statale e non privato, per non
sminuirne l’importanza, portando tutti i 5 anni di corso; tutto ciò mi ha reso
immune da ogni condizionamento culturale od ambientale. I miei 6 anni di
esercizio del patrocinio legale mi hanno fatto conoscere le magagne di un
sistema che non è riuscito a corrompermi. Per questo dal 1998 al 2014 non mi
hanno abilitato alla professione di avvocato in un esame di Stato, che come
tutti i concorsi pubblici ho provato, con le mie ricerche ed i miei libri,
essere tutti truccati. Non mi abilitano. Perché non sono uguale agli altri, non
perché son meno capace. Non mi abilitano perché vedo, sento e parlo. Ecco perché
posso parlare di cose giuridiche in modo di assoluta libertà, senza
condizionamento corporativistico, anche a certezza di ritorsione. E’ tutta
questione di coscienza.
Alle sentenze
irrevocabili di proscioglimento del Tribunale di Taranto a carico del dr Antonio
Giangrande, già di competenza della dr.ssa Rita Romano, giudice di Taranto poi
ricusata perché denunciata, si aggiunge il verbale di udienza dell’11 dicembre
2015 della causa n. 987/09 (1832/07 RGNR) del Tribunale di Potenza, competente
su fatti attinenti i magistrati di Taranto, con il quale si dispone la
perfezione della fattispecie estintiva del processo per remissione della querela
nei confronti del dr Antonio Giangrande da parte del dr. Alessio Coccioli, già
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, poi
trasferito alla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Remissione della
querela volontaria, libera e non condizionata da alcun atto risarcitorio.
Il Dr Antonio
Giangrande era inputato per il reato previsto e punito dall’art. 595 3° comma
c.p. “perchè inviando una missiva a sua firma alla
testata giornalistica La Gazzetta del Sud Africa e pubblicata sui siti internet
lagazzettadelsudafrica.net, malagiustizia.eu, e
associazionecontrotuttelemafie.org, offendeva l’onore ed il decoro del dr.
Alessio Coccioli, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Taranto, riportando in detto su scritto la seguente frase: “…il PM Alessio
Coccioli, inopportunamente delegando i carabinieri di Manduria, quali PG, ha
reso lecito tale modus operandi (non rilasciare attestato di ricezione da parte
dell’Ufficio Protocollo del Comune di Manduria ndr), motivandolo dal fatto che
non è dannoso per il denunciante. Invece in denuncia si è fatto notare che tale
usanza di recepimento degli atti, prettamente manduriana, può nascondere
alterazioni procedurali in ambito concorsuale e certamente abusi a danno dei
cittadini. Lo stesso PM Alessio Coccioli, inopportunamente delegando i
carabinieri di Manduria, quali PG, per la colleganza con il comandante dei
Vigili Urbani di Manduria, ha ritenuto le propalazioni del Giangrande, circa il
concorso per Comandante dei Vigili Urbani, ritenuto truccato (perché il medesimo
aveva partecipato e vinto in un concorso da egli stesso indetto e regolato in
qualità di comandante pro tempore e dirigente dell’ufficio del personale), sono
frutto di sue convinzioni non supportate da riscontri di natura obbiettiva e
facendo conseguire tali riferimenti, al predetto dr. Coccioli, ad altre
notazioni, contenute nello stesso scritto, nelle quali si denunciavano
insabbiamenti, o poche richieste di archiviazioni strumentali attribuite ai
magistrati della Procura della Repubblica di Taranto”.
Il Processo di
Potenza, come i processi tenuti a Taranto, sono attinenti a reati di opinione.
Lo stesso dr. Alessio Coccioli, una volta trasferito a Lecce, ha ritenuto che le
opinioni espresse dal Dr Antonio Giangrande riguardo la Giustizia a Taranto non
potessero continuare ad essere perseguite.
Ultimo atto. Esame di Avvocato 2015. A Lecce uno su quattro ce l’ha fatta. Sono
partiti in 1.108: la prova scritta è stata passata da 275 praticanti. Preso
atto.....
All'attenzione dell'avv. Francesco De Jaco. Illustre avv. Francesco De Jaco, in
qualità di Presidente della Commissione di Esame di Avvocato 2014-2015, chi le
scrive è il dr Antonio Giangrande. E’ quel signore, attempato per i suoi 52 anni
e ormai fuori luogo in mezzo ai giovani candidati, che in sede di esame le
chiese, inopinatamente ed invano, Tutela. Tutela, non raccomandazione. Così come
nel 2002 fu fatto inutilmente con l’avv. Luigi Rella, presidente di commissione
e degli avvocati di Lecce. Tutela perché quel signore il suo futuro lo ha
sprecato nel suo passato. Ostinatamente nel voler diventare avvocato ha perso le
migliori occasioni che la vita possa dare. Aspettava come tutti che una
abilitazione, alla mediocrità come è l’esame forense truccato, potesse, prima o
poi, premiare anche lui. Pecori e porci sì, lui no! Quel signore ha aspettato
ben 17 anni per, finalmente, dire basta. Gridare allo scandalo per un esame di
Stato irregolare non si può. Gridare al complotto contro la persona…e chi gli
crede. Eppure a Lecce c’è qualcuno che dice: “quello lì, l’avvocato non lo deve
fare”. Qualcuno che da 17 anni, infastidito dal mio legittimo operato anche
contro i magistrati, ha i tentacoli tanto lunghi da arrivare ovunque per potermi
nuocere. Chi afferma ciò è colui il quale dimostra con i fatti nei suoi libri,
ciò che, agli ignoranti o a chi è in mala fede, pare frutto di mitomania o
pazzia. Guardi, la sua presidenza, in sede di scritto, è stata la migliore tra
le 17 da me conosciute. Purtroppo, però, in quel di Brescia quel che si temeva
si è confermato. Brescia, dove, addirittura, l’ex Ministro Mariastella Gelmini
chiese scampo, rifugiandosi a Reggio Calabria per poter diventare avvocato. Il
mio risultato delle prove fa sì che chiuda la fase della mia vita di aspirazione
forense in bruttezza. 18, 18, 20. Mai risultato fu più nefasto e, credo,
immeritato e punitivo. Sicuro, però, che tale giudizio non è solo farina del
sacco della Commissione di esame di Brescia. Lo zampino di qualche leccese c’è!
Avvocato… o magistrato… o entrambi…: chissà? Non la tedio oltre. Ho tentato di
trovare Tutela, non l’ho trovata. Forse chiedevo troppo. Marcire in carcere da
innocente o pagare fio in termini professionali, credo che convenga la seconda
ipotesi. Questo è quel che pago nel mettermi contro i poteri forti
istituzionali, che io chiamo mafiosi. Avvocato, grazie per il tempo che mi ha
dedicato. Le tolgo il disturbo e, nel caso l’importasse, non si meravigli, se,
in occasione di incontri pubblici, se e quando ci saranno, la priverò del mio
saluto. Con ossequi.
Avetrana lì 26 giugno 2015. Dr Antonio Giangrande, scrittore per necessità.
E’ da scuola l’esempio della correzione dei compiti in magistratura, così come
dimostrato, primo tra tutti gli altri, dall’avv. Pierpaolo Berardi, candidato
bocciato. Elaborati non visionati, ma dichiarati corretti. L’avvocato astigiano
Pierpaolo Berardi, classe 1964, per anni ha battagliato per far annullare il
concorso per magistrati svolto nel maggio 1992. Secondo Berardi, infatti, in
base ai verbali dei commissari, più di metà dei compiti vennero corretti in 3
minuti di media (comprendendo “apertura della busta, verbalizzazione e richiesta
chiarimenti”) e quindi non “furono mai esaminati”. I giudici del tar gli hanno
dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il Csm, nel 2008, è stato costretto ad
ammettere: “Ci fu una vera e propria mancanza di valutazione da parte della
commissione”. Giudizio che vale anche per gli altri esaminati. In quell’esame
divenne uditore giudiziario, tra gli altri, proprio Luigi de Magistris, giovane
Pubblico Ministero che si occupò inutilmente del concorso farsa di abilitazione
forense a Catanzaro: tutti i compiti identici e tutti abilitati. Al Tg1 Rai
delle 20.00 del 1 agosto 2010 il conduttore apre un servizio: esame di accesso
in Magistratura, dichiarati idonei temi pieni zeppi di errori di ortografia. La
denuncia è stata fatta da 60 candidati bocciati al concorso 2008, che hanno
spulciato i compiti degli idonei e hanno presentato ricorso al TAR per manifesta
parzialità dei commissari con abuso del pubblico ufficio. Risultato: un buco
nell'acqua. Questi magistrati, nel frattempo diventati dei, esercitano.
Esperienza diretta dell'avvocato Giovanni Di Nardo che ha scoperto temi pieni di
errori di ortografia giudicati idonei alle prove scritte del concorso in
magistratura indetto nel 2013 le cui prove si sono tenute nel Giugno del 2014.
Se trovate che sia vergognoso condividete il più possibile, non c'è altro da
fare.
Concorsi Pubblici ed abilitazioni Truccati. Chi è senza peccato scagli la prima
pietra.
CUORI, TRUFFE E MAZZETTE: È LA FARSA “CONCORSONI”,
scrive Virginia Della Sala su "Il Fatto Quotidiano" il 15 agosto 2016. Erano in
6mila per 340 posti. Luglio 2015, concorso in magistratura, prova scritta.
Passano in 368. Come in tutti i concorsi, gli altri sono esclusi. Stavolta però
qualcosa va diversamente. “Appena ci sono stati comunicati i risultati, a marzo
di quest’anno, abbiamo deciso di fare la richiesta di accesso agli atti. Abbiamo
preteso di poter visionare non solo i nostri compiti ma anche quelli di tutti i
concorrenti risultati idonei allo scritto”, spiega uno dei concorrenti, Lugi
R. Milleduecento elaborati, scansionati e inviati tramite mail in un mese. Per
richiederli, i candidati hanno dovuto acquistare una marca da bollo da 600 euro.
Hanno optato per la colletta: 230 persone hanno pagato circa 3 euro a testa per
capire come mai non avessero passato quel concorso che credevano fosse andato
bene. E, soprattutto, per verificare cosa avessero di diverso i loro compiti da
quelli di chi il concorso lo aveva superato. “Ci siamo accorti che su diversi
compiti compaiono segni di riconoscimento: sottolineature, cancellature, strani
simboli, schemi”. Anche il Fatto ha potuto visionarli: asterischi, note a piè di
pagina, cancellature, freccette. In uno si contano almeno due cuoricini. In un
altro, il candidato ha disegnato una stellina. “Ora non c’è molto che possiamo
fare per opporci a questi risultati – spiega Luigi – visto che sono scaduti i
termini per ricorrere al Tar. Inoltre, molti di noi stanno tentando di nuovo il
concorso quest’anno. Ecco perché preferiamo non esporci molto mediaticamente”.
IL RAPPORTO DI BANKITALIA. Eppure, decine di sentenze dimostrano come sia
possibile richiedere l’annullamento anche per un solo puntino. “Cancellature,
scarabocchi, codici alfanumerici. Decisamente un cuoricino è un segno distintivo
per cui può essere sollecitata l’amministrazione – spiega l’avvocato Michele
Bonetti –. Qui si parla di un concorso esteso. Ma mi è capitato di assistere
persone che partecipavano a un concorso in cui, dei cinque candidati, c’era solo
un uomo. Capirà che la grafia di un uomo è facilmente riconoscibile come
tale”. Al di là delle scorrettezze, una ricerca della Banca d’Italia pubblicata
qualche giorno fa ha dimostrato che in Italia, i concorsi pubblici non
funzionano. O, per dirlo con le parole dei quattro economisti autori del dossier
Incentivi e selezione nel pubblico impiego (Cristina Giorgiantonio, Tommaso
Orlando, Giuliana Palumbo e Lucia Rizzica), “i concorsi non sembrano
adeguatamente favorire l’ingresso dei candidati migliori e con il profilo più
indicato”. Si parla di bandi frammentati a livello locale, di troppe differenze
metodologiche tra le varie gare, di affanno nella gestione coordinata a livello
nazionale. Tra il 2001 e il 2015, ad esempio, Regioni ed Enti locali hanno
bandito quasi 19mila concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, con una
media di meno di due posizioni disponibili per concorso. Macchinoso anche il
metodo: “Prove scritte e orali, prevalentemente volte a testare conoscenze
teorico-nozionistiche” si legge nel paper. Ogni concorrente studia in media
cinque mesi e oltre il 45 per cento dei partecipanti rinuncia a lavorare. Così,
se si considera che solo nel 2014, 280mila individui hanno fatto domanda per
partecipare a una selezione pubblica, si stima che il costo opportunità per il
Paese è di circa 1,4 miliardi di euro l’anno. La conseguenza è che partecipa
solo chi se lo può permettere e chi ha più tempo libero per studiare. Anche
perché si preferisce la prevalenza di quesiti “nozionistici” che però rischiano
di “inibire la capacità dei responsabili dell’organizzazione di valutare il
possesso, da parte dei candidati, di caratteristiche pur rilevanti per le
mansioni che saranno loro affidate, quali le ambizioni di carriera e la
motivazione intrinseca”. A tutto questo si aggiungono l’eccesso delle liste
degli idonei – il loro smaltimento determina “l’irregolarità della cadenza” dei
concorsi e quindi l’incertezza e l’incostanza dell’uscita dei bandi, dice il
dossier.
LA BEFFA SICILIANA. Palermo, concorsone scuola per la classe di sostegno nelle
medie. Quest’anno, forse per garantire l’anonimato e l’efficienza, il concorso è
stato computer based: domande e risposte al pc. Poi, tutto salvato su una penna
usb con l’attribuzione di un codice a garanzia dell’anonimato. Eppure, la
settimana scorsa i 32 candidati che hanno svolto la prova all’istituto Pio La
Torre a fine maggio sono stati riconvocati nella sede. Dovevano indicare e
ricordarsi dove fossero seduti il giorno dell’esame perché, a quanto pare, erano
stati smarriti i documenti che avrebbero permesso di abbinare i loro compiti al
loro nome. “È assurdo – commenta uno dei docenti – sembra una barzelletta:
dovremmo fare ricorso tutti insieme, unirci e costringere una volta per tutte il
Miur ad ammettere che forse non si era ancora pronti per questa svolta
digitale”.
IL VOTO SUL COMPITO CHE NON È MAI STATO FATTO. Maria Teresa Muzzi è invece una
docente che si era iscritta al concorso nel Lazio ma poi aveva deciso di non
parteciparvi. Eppure, il 2 agosto, ha ricevuto la convocazione per la prova
orale per la classe di concorso di lettere e, addirittura, un voto per uno
scritto che però non ha mai fatto: 30,4. Avrebbe potuto andare a fare l’orale
con la carta d’identità e ottenere una cattedra, mentre il legittimo concorrente
avrebbe perso la sua chance di cambiare vita. Ha deciso di non farlo e ancora si
attende la risposta dell’ufficio scolastico regionale che spieghi come sia stato
possibile un errore del genere. In Liguria per la classe di concorso di sostegno
nella scuola secondaria di I grado, l’ufficio scolastico regionale ha disposto
la revoca della nomina della Commissione giudicatrice e l’annullamento di tutti
i suoi atti perché sarebbero emersi “errori che possono influire sull’esito
degli atti e delle operazioni concorsuali”. I candidati ancora attendono di
avere nuovi esiti delle prove svolte. E, va ricordato, la correzione dei compiti
a risposta aperta nei concorsi pubblici ha una forte componente
discrezionale. “Ogni concorso pubblico ha margini di errore ed è perfettibile –
spiega Bonetti –. In Italia, però, di lacune ce ne sono troppe e alcune sono
strutturali al tipo di prova che si sceglie di far svolgere. L’irregolarità vera
è propria, invece, riguarda le scelte politiche che, se arbitrarie e ingiuste,
sono sindacabili”.
LE BUSTARELLE DI NAPOLI. Il problema è che si alza sempre più la soglia di
accesso in nome della meritocrazia, ma si continuano a lasciare scoperti posti
che invece servirebbe coprire. Favorendo così le chiamate dirette e i contratti
precari. “Dalla scuola al ministero degli esteri all’autority delle
telecomunicazioni – spiega Bonetti. La scelta politica è ancora più evidente nel
settore della sanità: ci sono meccanismi di chiusura già nel mondo
universitario. Oggi il corso di medicina è previsto per 10mila studenti in tutta
Italia mentre le statistiche Crui dal 1990 hanno sempre registrato una media di
130mila immatricolati. Sono restrizioni con un’ideologia. Una volta entrati, ad
esempio, c’è prima un altro concorso per la scuola di specializzazione e poi
ancora un concorso pubblico che però è per 5mila persone. E gli altri? Attendono
e alimentano il settore privato, che colma le lacune del sistema pubblico. O
sono chiamati come collaboratori, con forme contrattuali che vanno dalla partita
iva allo stage”. Nelle settimane scorse, il Fatto Quotidiano ha raccontato
dell’algoritmo ritrovato dalla Guardia di Finanza di Napoli che avrebbe
consentito ai partecipanti di rispondere in modo corretto ai quiz di accesso per
un concorso. Ad averlo, uno degli indagati di un’inchiesta sui concorsi truccati
per accedere all’Esercito. Nel corso delle perquisizioni la Finanza ha ritrovato
100mila euro in contanti, buste con elenchi di nomi (forse i clienti) e un
tariffario: il prezzo per superare i concorsi diviso “a pacchetti”, a seconda
dell’esame e del corpo al quale accedere (esercito, polizia, carabinieri). La
tariffa di 50.000 euro sarebbe relativa al “pacchetto completo”: dai test fisici
fino ai quiz e alle prove orali. Solo 20.000 euro, invece, per chi si affidava
ai mediatori dopo aver superato le prove fisiche. Uno sconto consistente. Tutto
è partito da una soffiata: un ragazzo al quale avevano fatto la proposta
indecente, ha rifiutato e ha denunciato. Un altro pure ha detto no, ma senza
denunciare. Virginia Della Sala, il Fatto Quotidiano 15/8/2016.
Concorsi truccati all’università, chi controlla il controllore?
Scrive Alessio Liberati il 27 settembre 2017 su "Il Fatto Quotidiano". Sta
avendo una grande eco in questi giorni l’inchiesta sui concorsi truccati
all’università, ove, come la scoperta dell’acqua calda verrebbe da dire, la
procura di Firenze ha individuato una sorta di “cupola” che decideva carriere e
futuro dei professori italiani. La cosiddetta “raccomandazione” o “spintarella”
(una terminologia davvero impropria per un crimine tanto grave) è secondo me uno
dei reati più gravi e meno puniti nel nostro ordinamento. Chi si fa raccomandare
per vincere un concorso viene trattato meglio, nella considerazione sociale e
giuridica (almeno di fatto) di chi ruba un portafogli. Ma chi ti soffia il posto
di lavoro o una progressione in carriera è peggio di un ladro qualunque: è un
ladro che il portafogli te lo ruba ogni mese, per sempre. Gli effetti di delitti
come questo, in sostanza, sono permanenti.
Ma come si è arrivati a ciò? Va chiarito che il sistema giuridico
italiano prevede due distinti piani su cui operare: quello amministrativo e
quello penale. Di quest’ultimo ogni tanto si ha notizia, nei (rari) casi in cui
si riesce a scoperchiare il marcio che si cela dietro ai concorsi pubblici
italiani. Di quello relativo alla giustizia amministrativa si parla invece molto
meno. Ma tale organo è davvero in grado di assicurare il rispetto delle
regole quando si fa ricorso?
Personalmente, denuncio da anni le irregolarità che sono state commesse proprio
nei concorsi per l’accesso al Consiglio di Stato, massimo organo di giustizia
amministrativa, proprio quell’autorità, cioè, che ha l’ultima parola su tutti i
ricorsi relativi ai concorsi pubblici truccati. Basti pensare che uno dei
vincitori più giovani del concorso (e quindi automaticamente destinato a una
carriera ai vertici) non aveva nemmeno i titoli per partecipare. E che dire dei
tempi di correzione? A volte una media di tre pagine al minuto, per leggere,
correggere e valutare. E la motivazione dei risultati attribuiti? Meramente
numerica e impossibile da comprendere. Tutti comportamenti, si intende, che sono
in linea con i principi giurisprudenziali sanciti proprio dalla giurisprudenza
dei Tar e del Consiglio di Stato.
E allora il problema dei concorsi truccati in Italia non può che partire
dall’alto: si prenda atto che la giustizia amministrativa non è in grado di
assicurare nemmeno la regolarità dei concorsi al proprio interno e che, quindi,
non può certo esserle affidato il compito istituzionale di decidere su altri
concorsi: con un altro organo giurisdizionale che sia davvero efficace nel
giudicare le irregolarità dei concorsi pubblici, al punto da costituire un
effettivo deterrente, si avrebbe una riduzione della illegalità cui si assiste
da troppo tempo nei concorsi pubblici italiani.
Se questa è antimafia…. In Italia, con
l’accusa di mafiosità, si permette l’espropriazione proletaria di Stato e la
speculazione del Sistema su beni di persone che mafiose non lo sono. Persone che
non sono mafiose, né sono responsabili di alcun reato, eppure sottoposte alla
confisca dei beni ed alla distruzione delle loro aziende, con perdita di posti
di lavoro. Azione preventiva ad ogni giudizio. Alla faccia della presunzione
d’innocenza di stampo costituzionale. Interventi di antimafiosità incentrati su
un ristretto ambito territoriale o di provenienza territoriale.
Questa antimafia, per mantenere il sistema, impone la delazione e la calunnia ai
sodalizi antiracket ed antiusura iscritti presso le Prefetture provinciali. Per
continuare a definirsi tali, ogni anno, le associazioni locali sono sottoposte a
verifica. L’iscrizione all’elenco è condizionata al numero di procedimenti
penali e costituzioni di parti civili attivate. L’esortazione a denunciare,
anche il nulla, se possibile. Più denunce per tutti…quindi. Chi non denuncia,
anche il nulla, è complice od è omertoso.
Ma cosa sarebbe codesta antimafia, che tutto gli è concesso, se non ci fosse lo
spauracchio mediatico della mafia di loro invenzione? E, poi, chi ha dato la
patente di antimafiosità a certi politicanti di sinistra che incitano le masse…e
chi ha dato l’investitura di antimafiosità a certi rappresentanti
dell’associazionismo catto-comunista che speculano sui beni…e chi ha dato
l’abilitazione ad essere portavoci dell’antimafiosità a certi scribacchini di
sinistra che sobillano la società civile? E perché questa antimafiosità ha
immenso spazio su tv di Stato e giornali sostenuti dallo Stato per fomentare
questa deriva culturale contro la nostra Nazione o parte di essa. Discrasia
innescata da gruppi editoriali che influenzano l’informazione in Italia?
Fintanto che le vittime dell’antimafia useranno o subiranno il linguaggio dei
loro carnefici, continueremo ad alimentare i cosiddetti antimafiosi che
lucreranno sulla pelle degli avversari politici.
Se la legalità è l’atteggiamento ed il comportamento conforme alla legge, perché
l’omologazione alla legalità non è uguale per tutti,…uguale anche per gli
antimafiosi? La legge va sempre rispettata, ma il legislatore deve conformarsi a
principi internazionali condivisi di più alto spessore che non siano i propri
interessi politici locali prettamente partigiani.
Va denunciato il fatto che l’antimafiosità è solo lotta politica e di propaganda
e la mafia dell’antimafia è più pericolosa di ogni altra consorteria criminale,
perchè: calunnia, diffama, espropria e distrugge in modo arbitrario ed impunito
per sola sete di potere. La mafia esiste ed è solo quella degli antimafiosi, o
delle caste o delle lobbies o delle massonerie deviate. E se per gli
antimafiosi, invece, tutto quel che succede è mafia…Allora niente è mafia. E se
niente è mafia, alla fine gli stranieri considereranno gli italiani tutti
mafiosi.
Invece mafioso è ogni atteggiamento e comportamento, da chiunque adottato, di
sopraffazione e dall’omertà, anche istituzionale, che ne deriva.
Non denunciare
ciò rende complici e di questo passo gli sciasciani non avranno mai visibilità
se rimarranno da soli ed inascoltati.
L’Italia
non è un paese per giovani (avvocati): elevare barriere castali e di censo non è
una soluzione,
scrive il 28 Aprile 2017 “L’Inkiesta”. Partiamo da due disfunzioni che
affliggono il nostro Paese e che stanno facendo molto parlare di sé. Da una
parte, la crisi delle libere professioni e, in generale, delle lauree, con
importanti giornali nazionali che ci informano, per esempio, che i geometri
guadagnano più degli architetti. Dall’altra, le inefficienze del sistema
giudiziario. Queste, sono oggetto di dibattito da tempo immemorabile, ci rendono
tra i Paesi peggiori dell’area OCSE e ci hanno fatti condannare da
niente-popò-di-meno-che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Incrociate ora i
due trend. Indovinate chi ci rimane incastrato in mezzo? Ovviamente i giovani
laureati/laureandi in giurisprudenza, chiusi tra un percorso universitario
sempre più debole e una politica incapace di portare a termine una riforma
complessiva e decente dell’ordinamento forense. Come risolvere la questione? Con
il numero chiuso a giurisprudenza? Liberalizzando la professione legale? Niente
di tutto questo, ci mancherebbe. In un Paese dove gli avvocati rappresentano una
fetta rilevante dei parlamentari, la risposta fornita dall’ennesima riforma è
facile facile. Porre barriere di censo e di casta all’accesso alla professione.
Da questa prospettiva tutte le recenti novità legislative acquistano un senso e
rivelano una logica agghiacciante. I malcapitati che si laureeranno in
Giurisprudenza a partire dall’anno 2016/2017 avranno una prima sorpresina:
l’obbligo di frequentare una scuola di formazione per almeno 160 ore. Anche a
pagamento se necessario, come da parere positivo del Consiglio Nazionale
Forense.
La questione
sarebbe da portare all’attenzione di un bravo psicanalista. Giusto qualche
osservazione: (1) se la pratica deve insegnare il mestiere, perché aggiungere
un’altra scuola obbligatoria?; (2) Se la Facoltà di Legge - che in Italia è
lunghissima: 5 anni, contro i 3 di Stati Uniti e Regno Unito e i 4 della
Francia, per esempio – serve a così poco, tanto da dover essere integrata anche
dopo la laurea, perché non riformarla?; (3) perché fermare i ragazzi dopo la
laurea, invece di farlo prima? Ci sarebbero anche altre questioni. Per esempio,
160 ore di formazione spalmate su 18 mesi, per i fortunati ammessi, non sono
molte in teoria. Tuttavia, basta vedere le sempre maggiori proteste riportate
dai giornali, e rigorosamente anonime, di praticanti-fotocopisti senza nome,
sfruttati e non pagati, per accorgersi che la realtà è molto diversa dalla
visione irenica (ipocrita è offensivo?) dei riformatori. E, in ogni caso, anche
se il praticante fosse sufficientemente fortunato da avere qualche soldo in
tasca, ciò non gli permetterebbe di godere del dono dell’ubiquità. Ma così si
passerebbe dal settore della psicanalisi a quello della parapsicologia. Meglio
evitare. Andiamo oltre.
Abbiamo
superato la prima trincea. Coi soldi del nonno ci manteniamo nella nostra
pratica non pagata o mal pagata. Magari siamo bravissimi ed accediamo ai corsi
di formazione a gratis o con borsa. Arriva il momento dell’esame. Presto l’esame
scritto sarà senza codice commentato. E fin qui, nessun problema. Meglio
ragionare con la propria testa che affannarsi a cercare la “sentenza giusta”,
magari senza capirla. Le prove verteranno sempre su diritto civile, diritto
penale e un atto. Segue un esame orale con quattro materie obbligatorie: diritto
civile, diritto penale, le due relative procedure, due materie a scelta e la
deontologia forense. E qui il fine giurista si deve trasformare in una specie di
Pico de La Mirandola, mandando a memoria tutto in poco tempo. Magari col capo
che non ti concede più di un mese di assenza dalla tua scrivania. Ma il problema
di questo esame è un altro. Poniamo che io sia un praticante in gamba e che
abbia trovato lavoro in un grosso studio internazionale leader nel settore del
diritto bancario. Plausibilmente, lavorerò con professionisti fantastici e avrò
clienti prestigiosi. Serve a qualcosa per l’esame di stato? Risposta: no.
Riformuliamo la questione. Se io mi occupo di diritto bancario o di diritto
societario, cosa me ne frega di studiare diritto penale, materia che non mi
interessa e che non praticherò mai? Mistero. L’esame di abilitazione fu regolato
per la prima volta nel 1934 e la sua logica è rimasta ferma lì. Come se
l’avvocato fosse ancora un piccolo professionista individuale che fa
indifferentemente tutto. Pensateci la prossima volta che sentite qualcuno
sciacquarsi la bocca con fregnacce sulla specializzazione degli avvocati e sulla
dipartita dell’avvocato generico. Pensateci.
Passata anche
la seconda trincea. Siete avvocati. Tutto bene? No. Tutto male. Finirete sotto
il fuoco della Cassa Forense, obbligatoria, che vi mitraglierà. Non importa se
siete potentissimi astri nascenti o piccoli professionisti. I risultati?
Migliaia di giovani avvocati che si cancellano dall’albo ogni anno. Sgombriamo
subito il campo da equivoci. Spesso quando si introduce questo tema ci si sente
rispondere che in Italia ci sono troppi avvocati e se si sfoltiscono è meglio.
Giusto. Ma ciò non può condurre ad affermare che dei giovani siano tagliati
fuori da un sistema disfunzionale. La selezione dura va bene; il terno al lotto
no. La competizione, anche spietata, va bene; le barriere all’accesso
strutturate senza la minima logica no. Dietro le belle parole, si nasconde un
sistema che, come avviene anche per altre professioni, cerca di tutelare se
stesso sbattendo la porta in faccia ai giovani che vorrebbero entrare. Non tutti
ovviamente. Senza troppa malizia vediamo che avrà meno crucci: (1) chi ha il
padre, nonno, zio, fratello maggiore ecc… titolare di uno studio legale. Una
mancetta arriverà sempre, con essa il tempo libero per frequentare la formazione
obbligatoria e una study leave succulenta di un paio di mesi per preparare
l’esame; (2) chi è ricco di famiglia e che, dunque, può godere dei vantaggi di
cui sopra per vie traverse; (3) chi, date le condizioni di cui ai punti 1 e 2,
può sostenere l’esame due, tre, quattro, cinque volte. E la meritocrazia? Naaaa,
quello è uno slogan da sbandierare in campagna elettorale, cosa avete pensavate,
sciocconi? In definitiva, il sistema come si sta concependo non fa altro che
porre barriere all’ingresso che favoriscono il ceto e di casta. Una volta che si
è entrati, invece, si fa in modo di cacciare fuori coloro che non arrivano a
fine mese, tendenzialmente i più giovani o i più piccoli.
Ci sono
alternative? Guardiamo un paese come la Francia. Lì, l’esame duro e temutissimo
è quello per l’accesso all’école des Avocats, superato ogni anno da meno di un
terzo dei candidati. Ma, (1) lo si sostiene appena terminata l’università,
quando si è “freschi”; (2) è la precondizione per l’accesso al tirocinio, non un
terno al lotto che viene al termine di 18/24 mesi di servaggio, spesso inutile
ai fini del superamento dell’esame. Quindi, se si fallisce, al netto della
delusione, si può subito andare a fare altro. Oppure si riprova (fino a tre
volte). In ogni caso, però, non si buttano due anni di vita. La conclusione è
sempre la stessa. L’Italia è un Paese che investe poco nei giovani. E che ci
crede poco, a giudicare dalle frequenti sparate e rimbrotti di ministri vari.
Sperando che non si cerchi, di fatto, di risolvere il problema con
l’emigrazione, il messaggio deve essere chiaro. Non si faccia pagare ai giovani
l’incapacità del sistema di riformarsi seriamente e organicamente. Le
alternative ci sono.
Giornalisti? E’ meglio se andate a fare gli operai,
scrive di Andrea Tortelli, Responsabile di "GiornalistiSocial.it". E’ meglio se
andate a fare gli operai, credetemi. Lo dicono i numeri. Chiunque aspiri a fare
il giornalista, in Italia, deve confrontarsi con un quadro di mercato ben più
drammatico di quello di altri settori in crisi. Il giornalista rimane una
professione molto (troppo) ambita, ma non conferisce più prestigio sociale a chi
la pratica e soprattutto non è più remunerativa. Diverse classifiche, non solo
italiche, inseriscono quello del reporter fra i lavori a maggiore rischio di
indigenza. E chi pratica bazzica in questo mondo non può stupirsene.
Qualche numero sui media. Il mondo dei media è in crisi da tempo, ben prima che
arrivassero i social a dare il colpo di grazia. In una provincia come Brescia,
dove vivo, non c’è un solo giornale cartaceo o una televisione locale che
nell’ultimo quinquennio non abbia ridotto il proprio organico e chiuso qualche
bilancio in rosso. Tutto ciò mentre gli on line sopravvivono, ma non prosperano:
generando numeri, ma recuperando ben poche delle risorse perse per strada dai
media tradizionali. In Italia, va detto, i giornali non hanno mai goduto di
troppa gloria. Da sempre siamo una delle popolazioni al mondo che legge meno.
Meno di una persona su venti, oggi, compra un quotidiano in edicola e il calo è
costante. Il Corriere della Sera, solo per fare un esempio, tra il 2004 e il
2014 ha dimezzato le proprie copie (l’on line, nello stesso periodo, è passato
da 2 milioni di utenti al mese a 1,5 al giorno, Facebook da zero a 2 milioni di
fan…). Nel 2016, ancora, i cinque giornali cartacei più venduti (Corsera,
Repubblica, Sole 24 Ore, La Stampa e Gazzetta dello Sport) hanno perso un decimo
esatto delle copie.
Non va meglio sul fronte dei fatturati. Dal 2004 al 2014 – permettetemi di
riciclare un vecchio dato – il mercato pubblicitario italiano è passato da 8
miliardi 240milioni di euro a 5 miliardi e 739milioni (fonte DataMediaHub). La
tv è scesa da 4 miliardi 451 milioni a 3.510 milioni, la stampa si è più che
dimezzata da 2 miliardi 891 milioni a 1 miliardo 314 milioni, il web è cresciuto
sì. Ma soltanto da 116 milioni a 474. Vuol dire che – dati alla mano – per ogni
euro perso dalla carta stampata in questo decennio sono arrivati sul web
soltanto 22 centesimi (del resto, agli attuali prezzi di mercato, mille clic
vengono pagati oggi meno di due euro…). E gli altri 80 centesimi dove sono
finiti? Un po’ si sono persi a causa della crisi. Ma una grossa fetta – non
misurabile – è finita alle big del web, nel grande buco nero fiscale di Google e
Facebook. Cioè è uscita dal circuito dell’informazione e dell’editoria.
I giornalisti che fanno? A una drastica riduzione delle copie e dei fatturati
consegue ovviamente una drastica riduzione degli organici. Ma a questo dato si
somma un aumento significativo dell’offerta (complici le scuole di giornalismo,
ma non solo…) e un aumento esponenziale della concorrenza “impropria”, dovuta al
fatto che Facebook è ormai la prima fonte di informazione degli italiani e sono
molti a operare fuori dal circuito tradizionale (e spesso anche fuori dal
circuito legale) dei media. In questo contesto, le possibilità di spuntare un
contratto ex Articolo 1 (Cnlg) per un giovane sono praticamente nulle. Ma anche
portare a casa almeno mille euro lordi al mese è un’impresa se ci sono
quotidiani locali, anche di gruppi importanti, che pagano meno di 10 euro un
articolo. E on line, a quotazioni di “mercato”, un pezzo viene pagato anche un
euro. Lordo. Non è un caso che sempre più colleghi abbiano decisi di cambiare
vita, e molto spesso sono i più validi. Ne conosco molti. C’è chi fa l’operaio
part time a tempo indeterminato e arrotonda scrivendo (quasi per passione), chi
ha mollato tutto per una cattedra da precario alle superiori, chi all’ennesima
crisi aziendale ha deciso di andare a lavorare a tempo pieno in fabbrica per
mantenere i figli e chi ancora era caporedattore di un noto giornale – oltre che
penna di grandissimo talento – e ora si dedica alla botanica. Con risultati di
eguale livello, pare. I dati dell’Osservatorio Job pricing, del resto, indicano
che nel 2016 un operaio italiano guadagnava mediamente 1.349 euro. Il
collaboratore di una televisione locale, a 25 euro lordi a servizio, dovrebbe
fare più di 50 uscite (con montaggio annesso) per portare a casa la stessa
cifra. Il collaboratore di un quotidiano locale dovrebbe firmare almeno 100
pezzi, tre al giorno. Senza ferie, tredicesima, malattia e possibilità di andare
in banca a chiedere un mutuo se privo della firma di papi. Insomma: il vecchio
adagio del “sempre meglio che lavorare” è ancora attuale, ma ha drammaticamente
cambiato significato. Visto che il giornalismo è diventato per molti un hobby o
una moderna forma di schiavitù, quasi al livello dei raccoglitori di pomodori
pugliesi. Dunque?
La soluzione. Dunque… Quando qualcuno mi contatta per chiedermi come si fa a
diventare giornalista (circostanza piuttosto frequente, visto che gestisco
GiornalistiSocial.it) cerco sempre di fornirgli un quadro completo e oggettivo
della situazione, per non illudere nessuno. Alcuni si incazzano e spariscono.
Altri ringraziano delusi. I più ascoltano, ma non sentono. Una piccola parte
comprende che il mestiere del giornalista, nel 2017, ha un senso solo se
sussistono due elementi: una grande passione e la volontà di fare gli
imprenditori di se stessi. Fare il giornalista, in Italia ma non solo, richiede
oggi una grande capacità di adattamento al sistema della comunicazione e un
sistema di competenze tecniche estese (fotografia, grafica, video, social, web,
seo e anche marketing, parola che farebbe accapponare la pelle a quelli della
vecchia scuola) per sopravvivere a un mercato sempre meno chiuso, in cui i
concorrenti sono tanto i colleghi e gli aspiranti colleghi, quanto tutti i
laureati privi di occupazione e i liberi professionisti dell’articolato mondo
web. Ma questo è un altro capitolo. Nel frattempo, è meglio che andiate a fare
gli operai. Oppure ribellatevi.
I mediocri del Politically Correct negano sempre il merito. Sostituiscono sempre
la qualità con la quantità. Ma è la qualità che muove il mondo, cari miei, non
la quantità. Il mondo va avanti grazie ai pochi che hanno qualità, che valgono,
che rendono, non grazie a voi che siete tanti e scemi. La forza della ragione
(Oriana Fallaci)
“L'Italia tenuta al guinzaglio da un
sistema di potere composto da caste, lobbies, mafie e massonerie: un'Italia che
deve subire e deve tacere.
La “Politica” deve essere legislazione
o amministrazione nell’eterogenea rappresentanza d’interessi, invece è
meretricio o mendicio, mentre le “Istituzioni” devono meritarlo il rispetto, non
pretenderlo. Il rapporto tra cittadini e il rapporto tra cittadini e Stato è
regolato dalla forza della legge. Quando non vi è cogenza di legge, vige la
legge del più forte e il debole soccombe. Allora uno “Stato di Diritto” degrada
in anarchia. In questo caso è palese la responsabilità politica ed istituzionale
per incapacità o per collusione. Così come è palese la responsabilità dei media
per omertà e dei cittadini per codardia o emulazione."
TIRANNIDE indistintamente
appellare si debbe ogni qualunque governo, in cui chi è preposto alla esecuzion
delle leggi, può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle,
sospenderle; od anche soltanto deluderle, con sicurezza d'impunità. E quindi, o
questo infrangi-legge sia ereditario, o sia elettivo; usurpatore, o legittimo;
buono, o tristo; uno, o molti; a ogni modo, chiunque ha una forza effettiva, che
basti a ciò fare, è tiranno; ogni società, che lo ammette, è tirannide; ogni
popolo, che lo sopporta, è schiavo. Vittorio Alfieri (1790).
"Quando si cerca di far progredire la conoscenza e l'intelligenza
umana si incontra sempre la resistenza dei contemporanei, simile a un fardello
che bisogna trascinare e che grava pesantemente al suolo, ribelle ad ogni
sforzo. Ci si deve consolare allora con la certezza che, se i pregiudizi sono
contro di noi, abbiamo con noi la Verità, la quale, dopo essersi unita al suo
alleato, il Tempo, è pienamente certa della sua vittoria, se non proprio oggi,
sicuramente domani."(Arthur Schopenhauer)
Il pregio di
essere un autodidatta è quello che nessuno gli inculcherà forzosamente della
merda ideologica nel suo cervello. Il difetto di essere un autodidatta è quello
di smerdarsi da solo.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo con la discultura e la
disinformazione. Ci si deve chiedere: perchè a scuola ci hanno fatto credere con
i libri di testo che Garibaldi era un eroe ed i piemontesi dei salvatori; perché
i media coltivano il luogo comune di un sud Italia cafone ed ignorante; perché
la prima cosa che insegnano a scuola è la canzone “bella ciao”? Per poi scoprire
da adulti e solo tramite il web: che il Sud Italia è stato depredato a causa
proprio di Garibaldi a vantaggio dei Piemontesi; che solo i turisti che scendono
a frotte nel meridione d’Italia scoprono quanto ci sia tanto da conoscere ed
apprezzare, oltre che da amare; che “Bella ciao” è solo l’inno di una parte
della politica italiana che in nome di una ideologia prima tradì l’Italia e poi,
con l’aiuto degli americani, vinse la guerra civile infierendo sui vinti,
sottomettendoli, con le sue leggi, ad un regime illiberale e clericale.
Ad Avetrana, il paese di Sarah Scazzi, non sono omertosi, sempre che non si
tratti di poteri forti. Ma qualcuno certamente vigliacco e codardo lo è. Sapendo
che io ho le palle per denunciare le illegalità, questi deficienti usano il mio
nome ed appongono falsamente la mia firma in calce a degli esposti che
colpiscono i poveri cristi rei di abusi edilizi o commerciali. I cretini, che
poi fanno carriera politica, non sanno che i destinatari dei miei strali sono
magistrati, avvocati, forze dell’ordine, e comunque pubblici ufficiali o
esercenti un pubblico servizio. Che poi queste denunce finiscono nell’oblio
perché “cane non mangia cane” e per farmi passare per mitomane o pazzo o
calunniatore o diffamatore, è un’altra cosa. Però da parte di questi coglioni
prendersela con i poveri cristi per poi far addossare la colpa a me ed essere
oggetto di ritorsioni ingiustificate è da veri vigliacchi. D'altronde un paese
di coglioni sarà sempre governato, amministrato, giudicato, istruito ed
informato da coglioni.
È molto meglio osare cose straordinarie, vincere gloriosi trionfi, anche se
screziati dall'insuccesso, piuttosto che schierarsi tra quei poveri di spirito
che non provano grandi gioie né grandi dolori, perché vivono nel grigio e
indistinto crepuscolo che non conosce né vittorie né sconfitte. (...) Non è il
critico che conta, né l'individuo che indica come l'uomo forte inciampi, o come
avrebbe potuto compiere meglio un'azione. L'onore spetta all'uomo che realmente
sta nell'arena, il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore, dal sangue; che
lotta con coraggio; che sbaglia ripetutamente, perchè non c'è tentativo senza
errori e manchevolezze; che lotta effettivamente per raggiungere l'obiettivo;
che conosce il grande entusiasmo, la grande dedizione, che si spende per una
giusta causa; che nella migliore delle ipotesi conosce alla fine il trionfo
delle grandi conquiste e che, nella peggiore delle ipotesi, se fallisce, almeno
cade sapendo di aver osato abbastanza. Dunque il suo posto non sarà mai accanto
a quelle anime timide che non conoscono né la vittoria, né la sconfitta.
Franklin Delano Roosevelt
Cari signori, io ho iniziato a destare le coscienze 20 anni prima di Beppe
Grillo e nulla è successo. Io non cercavo gli onesti, ma le vittime del sistema,
per creare una rivoluzione culturale…ma un popolo di “coglioni” sarà sempre
governato ed amministrato, informato, istruito e giudicato da “coglioni”.
"Il popolo cornuto era e cornuto resta: la differenza è che il fascismo
appendeva una bandiera sola alle corna del popolo e la democrazia lascia che
ognuno se l'appenda da sé, del colore che gli piace, alle proprie corna... Siamo
al discorso di prima: non ci sono soltanto certi uomini a nascere cornuti, ci
sono anche popoli interi; cornuti dall'antichità, una generazione appresso
all'altra...- Io non mi sento cornuto - disse il giovane - e nemmeno io. Ma noi,
caro mio, camminiamo sulle corna degli altri: come se ballassimo..." Leonardo
Sciascia dal libro "Il giorno della civetta".
Un chierico medievale si imbatté in un groviglio di serpi su cui spiccava un
ramarro che già da solo sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia, confrontata a
quelle serpeggianti creature, la bestiola gli parve graziosa ed esclamò: «Beati
monoculi in terra caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo è re.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Quando esprimiamo
giudizi gratuiti, cattivi ed illogici lo facciamo con la nostra bocca ma
inconsapevolmente per volontà di altri. Lo facciamo in virtù di quanto ricevuto:
dall’educazione familiare, dall’istruzione di regime, dall’indottrinamento
politico e religioso, dall’influenza mediatica. Niente è farina del nostro
sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze staremmo solo zitti, sapendo
che nessuno sarebbe capace e disposto ad ascoltarci.
In una Italia dove nulla è come sembra, chi giudica chi è onesto e chi no?
Lo hanno fatto i comunisti, i dipietristi, i leghisti, i pentastellati. Lor
signori si son dimostrati peggio degli altri e comunque servitori dei
magistrati. E se poi son questi magistrati a decidere chi è onesto e chi no,
allora se tutti stanno dalla parte della ragione, io mi metto dalla parte del
torto.
Ognuno di noi, anziché migliorarsi, si giova delle disgrazie altrui. Non
pensando che a cercar l’uomo onesto con il lanternino si perde la ragione. Ma
anche a cercarlo con la lanterna di Diogene si perde la retta via. Diogene di
Sinope (in greco antico Διογένης Dioghénes)
detto il Cinico o il Socrate pazzo (Sinope, 412 a.C. circa – Corinto, 10
giugno 323 a.C.) è stato un filosofo greco antico. Considerato uno dei fondatori
della scuola cinica insieme al suo maestro Antistene, secondo l'antico
storico Diogene Laerzio, perì nel medesimo giorno in cui Alessandro Magno spirò
a Babilonia. «[Alessandro Magno] si fece appresso a Diogene, andandosi a mettere
tra lui e il sole. "Io sono Alessandro, il gran re", disse. E a sua volta
Diogene: "Ed io sono Diogene, il cane". Alessandro rimase stupito e chiese
perché si dicesse cane. Diogene gli rispose: "Faccio le feste a chi mi dà
qualcosa, abbaio contro chi non dà niente e mordo i ribaldi."» (Diogene
Laerzio, Vite dei filosofi, Vita di Diogene il Cinico, VI 60). Diogene aveva
scelto di comportarsi, dunque, come "critico" pubblico: la sua missione era
quella di dimostrare ai Greci che la civiltà è regressiva e di dimostrare con
l'esempio che la saggezza e la felicità appartengono all'uomo che è indipendente
dalla società. Diogene si fece beffe non solo della famiglia e dell'ordine
politico e sociale, ma anche delle idee sulla proprietà e sulla buona
reputazione. Una volta uscì con una lanterna di giorno. Questi non indossava una
tunica. Portava come solo vestito un barile ed aveva in mano una lanterna.
"Diogene! - esclamo Socrate - con quale nonsenso tenterai di ingannarci oggi?
Sei sempre alla ricerca, con questa lanterna, di un uomo onesto? Non hai ancora
notato tutti quei buchi nel tuo barile?". Diogene rispose: "Non esiste una
verità oggettiva sul senso della vita". A chi gli chiedeva il senso della
lanterna lui rispondeva: "cerco l'uomo!". “... (Diogene) voleva significare
appunto questo: cerco l’uomo che vive secondo la sua più autentica natura, cerco
l’uomo che, aldilà di tutte le esteriorità, le convenzioni o le regole imposte
dalla società e aldilà dello stesso capriccio della sorte e della fortuna,
ritrova la sua genuina natura, vive conformemente a essa e così è felice."
Aste e usura:
chiesta ispezione nei tribunali di Taranto e Potenza. Interrogazione dei
Senatori Cinque Stelle: “Prassi illegali e vicende inquietanti”, titola
“Basilicata 24” nel silenzio assordante dei media pugliesi e tarantini.
Da presidente
dell’ANPA (Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati) già dal 2003, fin
quando mi hanno permesso di esercitare la professione forense fino al 2006, mi
sono ribellato a quella realtà ed ho messo in subbuglio il Foro di Taranto,
inviando a varie autorità (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto,
Procura della Repubblica di Taranto, Ministro della Giustizia) un dossier
analitico sull’Ingiustizia a Taranto e sull’abilitazione truccata degli
avvocati. Da questo dossier è scaturita solo una interrogazione parlamentare di
AN del Senatore Euprepio Curto (sol perché ricoprivo l’incarico di primo
presidente di circolo di Avetrana di quel partito). Eccezionalmente il Ministero
ha risposto, ma con risposte diffamatorie a danno dell’esponente. Da allora e
per la mia continua ricerca di giustizia come Vice Presidente provinciale di
Taranto dell’Italia dei Valori (Movimento da me lasciato ed antesignano dei 5
Stelle, entrambi a me non confacenti per mia palese “disonestà”) e poi come
presidente nazionale dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, sodalizio
antimafia riconosciuto dal Ministero dell’Interno, per essermi permesso di
rompere l’omertà, gli abusi e le ingiustizie, ho subito decine di procedimenti
penali per calunnia e diffamazione, facendomi passare per mitomane o pazzo,
oltre ad inibirmi la professione forense. Tutte le mie denunce ed esposti e la
totalità dei ricorsi presentati a tutti i Parlamentari ed alle autorità
amministrative e politiche: tutto insabbiato, nonostante la mafiosità
istituzionale è sotto gli occhi di tutti.
I procedimenti
penali a mio carico sono andati tutti in fumo, non riuscendo nell’intento di
condannarmi, fin anche a Potenza su sollecitazione dei denuncianti magistrati.
Il 3 ottobre
2016, dopo un po’ di tempo che mancavo in quel di Taranto, si apre un ulteriore
procedimento penale a mio carico per il quale già era intervenuta sentenza di
assoluzione per lo stesso fatto. Sorvolo sullo specifico che mi riguarda e qui
continuo a denunciare alla luna le anomalie, così già da me riscontrate molti
anni prima. Nei miei esposti si parlava anche di mancata iscrizione nel registro
generale delle notizie di reato e di omesse comunicazioni sull’esito delle
denunce.
L’ufficio
penale del Tribunale è l’ombelico del disservizio. Non vi è traccia degli atti
regolarmente depositati, sia ufficio su ufficio (per le richieste
dell’ammissione del gratuito patrocinio dall’ufficio del gratuito patrocinio
all’ufficio del giudice competente), sia utenza su ufficio per quanto riguarda
in particolare la lista testi depositata dagli avvocati nei termini perentori.
Per questo motivo è inibito a molti avvocati percepire i diritti per il gratuito
patrocinio prestato, non essendo traccia né delle istanze, né dei decreti
emessi. Nell’udienza del 3 ottobre 2016, per gli avvocati presenti, al
disservizio si è provveduto con una sorta di sanatoria con ripresentazione in
udienza di nuove istanze di ammissione di Gratuito patrocinio e di nuove liste
testi (fuori tempo massimo); per i sostituiti avvocati, invece, ogni diritto è
decaduto con pregiudizio di causa. Non un avvocato si è ribellato e nessuno mai
lo farà, perché mai nessuno in quel foro si è lamentato di come si amministra la
Giustizia e di come ci si abilita. Per quanto riguarda la gestione degli uffici
non si può alludere ad una fantomatica mancanza di personale, essendo l’ufficio
ben coperto da impiegate, oltretutto, poco disponibili con l’utenza.
Io ho già dato
per fare casino, non foss’altro che ormai sono timbrato tra i tarantini come
calunniatore, mitomane o pazzo, facendo arrivare la nomea oltre il Foro
dell’Ingiustizia.
La presente,
giusto per rendere edotti gli ignoranti giustizialisti e sinistroidi in che mani
è la giustizia, specialmente a Taranto ed anche per colpa degli avvocati.
GABRIELE
CAGLIARI E GLI ALTRI. SONO STATI SUICIDATI?
Da
Tangentopoli ai crac internazionali: ecco i suicidi eccellenti.
Non hanno retto il peso di scandali finanziari e si sono tolti la vita. La
storia della finanza italiana e internazionale annovera numerosi suicidi di
manager, investitori e operatori finanziari. Con qualche giallo, scrive Vito
Lops su "Il Sole 24 ore" il 7 marzo 2013.
1. Gabriele
Cagliari (Eni) e il giallo del sacchetto di plastica. Siamo in piena mani
pulite. Il presidente dell'Eni, Gabriele Cagliari, viene arrestato con l'accusa
di aver pagato tangenti. Contestato il suo ruolo nella valutazione di Enimont
fatta dall'Eni in fase di acquisizione. Il 20 luglio 1993 viene ritrovato morto
nelle docce del carcere di San Vittore, dove ha trascorso quattro mesi di
carcerazione preventiva. Secondo la ricostruzione si è ucciso soffocandosi con
un sacchetto di plastica. La vicenda presenta contorni pochi chiari. Sul corpo
sono state trovate contusioni che gettano un'ombra di dubbio sul suicidio.
Inoltre alcuni testimoni, fra poliziotti penitenziari e compagni di cella, hanno
raccontato che il sacchetto era ancora gonfio quando è stato ritrovato.
Lasciando il sospetto che fosse ancora in vita. Giallo anche sulle lettere che
avrebbe spedito alla famiglia per giustificare il gesto, che sarebbero state
ricevute dai famigliari circa due settimane prima della morte.
2. Raul
Gardini e lo scandalo Tangentopoli. Sposato con la figlia di Serafino Ferruzzi,
Raul Gardini acquisisce le deroghe operative dell'aziende dopo la morte di
Ferruzzi in un incidente aereo. Negli anni Ottanta mette a segno la celebre
scalata Montedison, dopo le spregiudicate manovre finanziarie
dell'amministratore Mario Schimberni, con l'assenso si Enrico Cuccia. In seguito
guida la fusione delle attività chimiche con Eni, fondando Enimont. Negli anni
Novanta, in piena Tangentopoli (1992), Gardini – quando vengono alla luce le
tangenti generate dalla vendita del 40% di Enimont – si toglie la vita. Viene
trovato morto nella sua casa di Milano, il settecentesco palazzo Belgioioso, il
23 luglio del 1993, tre giorni dopo la morte del presidente dell'Eni Gabriele
Cagliari.
1992:
questa è la realtà, non la fiction. La lettera del suicida Gabriele Cagliari,
scrive “Tempi”. Grazie alla serie in onda su Sky si torna a parlare di
Tangentopoli e Mani Pulite. Ripubblichiamo il messaggio inviato alla famiglia
dall’allora presidente di Eni prima di togliersi la vita in carcere.
Grazie alla fiction in onda su Sky, “1992”, in Italia si è tornato a parlare di
Tangentopoli e Mani Pulite. A nostro modesto avviso, non c’è modo migliore per
capire cosa accadde in quegli anni che rileggere questa lettera di Gabriele
Cagliari, presidente dell’Eni arrestato nel 1993 dai pm milanesi Fabio De
Pasquale ed Antonio Di Pietro. Cagliari fu accusato di aver versato ai partiti
una maxi tangente. Dopo quattro mesi nel carcere di San Vittore a Milano si
suicidò il 20 luglio del 1993. Questa è la lettera che inviò alla sua famiglia
il 10 luglio 1993. «Miei carissimi Bruna, Stefano, Silvano, Francesco,
Ghiti: sto per darvi un nuovo, grandissimo dolore. Ho riflettuto intensamente e
ho deciso che non posso sopportare più a lungo questa vergogna. La
criminalizzazione di comportamenti che sono stati di tutti, degli stessi
magistrati, anche a Milano, ha messo fuori gioco soltanto alcuni di noi,
abbandonandoci alla gogna e al rancore dell’opinione pubblica. La mano pesante,
squilibrata e ingiusta dei giudici ha fatto il resto. Ci trattano veramente come
non-persone, come cani ricacciati ogni volta al canile. Sono qui da oltre
quattro mesi, illegittimamente trattenuto. Tutto quanto mi viene contestato non
corre alcun pericolo di essere rifatto, né le prove relative a questi fatti
possono essere inquinate in quanto non ho più alcun potere di fare né di
decidere, né ho alcun documento che possa essere alterato. Neppure potrei
fuggire senza passaporto, senza carta d’identità e comunque assiduamente
controllato come costoro usano fare. Per di più ho sessantasette anni e la legge
richiede che sussistano oggettive circostanze di eccezionale gravità e
pericolosità per trattenermi in condizioni tanto degradanti. Ma, come sapete, i
motivi di questo infierire sono ben altri e ci vengono anche ripetutamente detti
dagli stessi magistrati, se pure con il divieto assoluto di essere messi a
verbale, come invece si dovrebbe regolarmente fare. L’obbiettivo di questi
magistrati, quelli della Procura di Milano in modo particolare, è quello di
costringere ciascuno di noi a rompere, definitivamente e irrevocabilmente, con
quello che loro chiamano il nostro “ambiente”. Ciascuno di noi, già compromesso
nella propria dignità agli occhi della opinione pubblica per il solo fatto di
essere inquisito o, peggio, essere stato arrestato, deve adottare un
atteggiamento di “collaborazione” che consiste in tradimenti e delazioni che lo
rendano infido, inattendibile, inaffidabile: che diventi cioè quello che loro
stessi chiamano un “infame”. Secondo questi magistrati, a ognuno di noi deve
dunque essere precluso ogni futuro, quindi la vita, anche in quello che loro
chiamano il nostro “ambiente”. La vita, dicevo, perché il suo ambiente, per
ognuno, è la vita: la famiglia, gli amici, i colleghi, le conoscenze locali e
internazionali, gli interessi sui quali loro e loro complici intendono mettere
le mani. Già molti sostengono, infatti, che agli inquisiti come me dovrà essere
interdetta ogni possibilità di lavoro non solo nell’Amministrazione pubblica o
parapubblica, ma anche nelle Amministrazioni delle aziende private, come si fa a
volte per i falliti. Si vuole insomma creare una massa di morti civili,
disperati e perseguitati, proprio come sta facendo l’altro complice infame della
magistratura che è il sistema carcerario. La convinzione che mi sono fatto è che
i magistrati considerano il carcere nient’altro che uno strumento di lavoro, di
tortura psicologica, dove le pratiche possono venire a maturazione, o ammuffire,
indifferentemente, anche se si tratta della pelle della gente. Il carcere non è
altro che un serraglio per animali senza teste né anima. Qui dentro ciascuno è
abbandonato a stesso, nell’ignoranza coltivata e imposta dei propri diritti,
custodito nell’inattività nell’ignavia; la gente impigrisce, si degrada e si
dispera diventando inevitabilmente un ulteriore moltiplicatore di malavita. Come
dicevo, siamo cani in un canile dal quale ogni procuratore può prelevarci per
fare la propria esercitazione e dimostrare che è più bravo o più severo di
quello che aveva fatto un’analoga esercitazione alcuni giorni prima o alcune ore
prima. Anche tra loro c’è la stessa competizione o sopraffazione che vige nel
mercato, con differenza che, in questo caso, il gioco è fatto sulla pelle della
gente. Non è dunque possibile accettare il loro giudizio, qualunque esso sia.
Stanno distruggendo le basi di fondo e la stessa cultura del diritto, stanno
percorrendo irrevocabilmente la strada che porta al loro Stato autoritario, al
loro regime della totale asocialità. Io non ci voglio essere. Hanno distrutto la
dignità dell’intera categoria degli avvocati penalisti ormai incapaci di
dibattere o di reagire alle continue violazioni del nostro fondamentale diritto
di essere inquisiti, e giudicati poi, in accordo con le leggi della Repubblica.
Non sono soltanto gli avvocati, i sacerdoti laici della società, a perdere la
guerra; ma è l’intera nazione che ne soffrirà le conseguenze per molto tempo a
venire. Già oggi i processi, e non solo a Milano, sono farse tragiche,
allucinanti, con pene smisurate comminate da giudici che a malapena conoscono il
caso, sonnecchiano o addirittura dormono durante le udienze per poi decidere in
cinque minuti di Camera di consiglio. Non parliamo poi dei tribunali della
libertà, asserviti anche loro ai pubblici ministeri, né dei tribunali di
sorveglianza che infieriscono sui detenuti condannati con il cinismo dei
peggiori burocrati e ne calpestano continuamente i diritti. L’accelerazione dei
processi, invocata e favorita dal ministro Conso, non è altro che la sostanziale
istituzionalizzazione dei tribunali speciali del regime di polizia prossimo
venturo. Quei pochi di noi caduti nelle mani di questa “giustizia” rischiano di
essere i capri espiatori della tragedia nazionale generata da questa
rivoluzione. Io sono convinto di dover rifiutare questo ruolo. E’ una decisione
che prendo in tutta lucidità e coscienza, con la certezza di fare una cosa
giusta. La responsabilità per colpe che posso avere commesso sono esclusivamente
mie e mie sono le conseguenze. Esiste certamente il pericolo che altri possano
attribuirmi colpe non mie quando non potrò più difendermi. Affidatevi alla mia
coscienza di questo momento di verità totale per difendere e conservare al mio
nome la dignità che gli spetta. Sento di essere stato prima di tutto un marito e
un padre di famiglia, poi un lavoratore impegnato e onesto che ha cercato di
portare un po’ più avanti il nostro nome e che, per la sua piccolissima parte,
ha contribuito a portare più in alto questo paese nella considerazione del
mondo. Non lasciamo sporcare questa immagine da nessuna “mano pulita”. Questo vi
chiedo, nel chiedere il vostro perdono per questo addio con il quale lascio per
sempre. Non ho molto altro da dirvi poiché questi lunghissimi mesi di lontananza
siamo parlati con tante lettere, ci siamo tenuti vicini. Salvo che a Bruna, alla
quale devo tutto. Vorrei parlarti Bruna, all’infinito, per tutte le ore e i
giorni che ho taciuto, preso da questi problemi inesistenti che alla fine mi
hanno fatto arrivare qui. Ma in questo tragico momento cosa ti posso dire,
Bruna, anima dell’anima mia, unico grandissimo amore, che lascio con un
impagabile debito di assiduità, di incontri sempre rimandati, fino a questi
ultimi giorni che avevamo pattuito essere migliaia da passare sempre insieme, io
te, in ogni posto, e che invece qui sto riducendo a un solo sospiro? Concludo
una vita vissuta di corsa, in affanno, rimandando continuamente le cose
veramente importanti, la vita vera, per farne altre, lontane come miraggi e,
alla fine, inutili. Anche su questo, soprattutto su questo, ho riflettuto a
lungo, concludendo che solo così avremo finalmente pace. Ho la certezza che la
tua grande forza d’animo, i nostri figli, il nostro nipotino, ti aiuteranno a
vivere con serenità e a ricordarmi, perdonato da voi per questo brusco addio.
Non riesco a dirti altro: il pensiero di non vederti più, il rimorso di avere
distrutto i nostri anni più sereni, come dovevano essere i nostri futuri, mi
chiude la gola. Penso ai nostri ragazzi, la nostra parte più bella, e penso con
serenità al loro futuro. Mi sembra che abbiano una strada tracciata davanti a
sé. Sarà una strada difficile, in salita, come sono tutte le cose di questo
mondo: dure e piene di ostacoli. Sono certo che ciascuno l’affronterà con
impegno e con grande serenità come ha già fatto Stefano e come sta facendo
Silvano. Si dovranno aiutare l’un l’altro come spero che già stiano facendo,
secondo quanto abbiamo discusso più volte in questi ultimi mesi, scrivendoci
lettere affettuose. Stefano resta con un peso più grave sul cuore per essere
improvvisamente rimasto privato della nostra carissima Mariarosa. Al dolcissimo
Francesco, piccolino senza mamma, daremo tutto il calore del nostro affetto e
voi gli darete anche il mio, quella parte serena che vi lascio per lui. Le mie
sorelle, una più brava dell’altra, in una sequenza senza fine, con le loro
bravissime figliole, con Giulio e Claudio, sono le altre persone care che lascio
con tanta tristezza. Carissime Giuliana e Lella, a questo punto cruciale della
mia vita non ho saputo fare altro, non ho trovato altra soluzione. Ricordo
Sergio e la sua famiglia con tanto affetto, ricordo i miei cugini di Guastalla,
i Cavazzani e i loro figli. Da tutti ho avuto qualcosa di valore, qualcosa di
importante, come l’affetto, la simpatia, l’amicizia.
A tutti lascio il ricordo di me che vorrei non fosse quello di una scheggia che
improvvisamente sparisce senza una ragione, come se fosse impazzita. Non è così,
questo è un addio al quale ho pensato e ripensato con lucidità, chiarezza e
determinazione. Non ho alternative. Desidero essere cremato e che Bruna, la mia
compagna di ogni momento triste o felice, conservi le ceneri fino alla morte.
Dopo di che siano sparse in qualunque mare. Addio mia dolcissima sposa e
compagna, Bruna, addio per sempre. Addio Stefano, Silvano, Francesco; addio
Ghiti, Lella, Giuliana, addio. Addio a tutti. Miei carissimi, vi abbraccio tutti
insieme per l’ultima volta. Il vostro sposo, papà, nonno, fratello. Gabriele»
Gabriele
Cagliari, lettere dal 1993.
Il figlio Stefano racconta in «Storia di mio padre», curato da Costanza
Rizzacasa d’Orsogna (Longanesi), il presidente dell’Eni suicida in carcere
durante Mani Pulite, scrive Luigi Ferrarella l'1 marzo 2018 su "Il Corriere
della Sera". Gabriele Cagliari era nato a Guastalla, Reggio Emilia, il 14 giugno
1926. Presidente dell’Eni dal 1989, venne arrestato l’8 marzo 1993 con l’accusa
di avere autorizzato il pagamento di tangenti. Si tolse la vita 134 giorni dopo,
il 20 luglio, nel carcere milanese di San Vittore. «Il carcere e i suoi
problemi, la sua gestione paradossale, sono argomenti che devono interessare la
gente: il mondo non è fatto di buoni e cattivi; tutti possiamo essere a volte
cattivi anche se siamo normalmente buoni». Le 28 lettere inedite (come questa
del 18 luglio 1993, 2 giorni prima del suicidio a San Vittore) scritte in
carcere dal 67enne presidente dell’Eni Gabriele Cagliari nei 134 giorni di
custodia cautelare, e recuperate nel 2016 dal figlio Stefano in soffitta, adesso
insieme a quelle già note vengono proposte dalla riflessione del figlio
in Storia di mio padre (a cura di Costanza Rizzacasa d’Orsogna per Longanesi) in
una chiave per certi versi sorprendente. Al punto da risultare arnesi
inservibili tanto a chi non si trattiene dal praticare con spregiudicatezza
l’uso contundente dei suicidi a fini di revisionismo storico-giudiziario di Mani
Pulite, quanto a chi cinicamente sorvola sui destini personali delle persone
coinvoltevi e non ammette altro che esaltazione integrale di quella stagione. Il
libro di Stefano Cagliari, «Storia di mio padre», a cura di Costanza Rizzacasa
d’Orsogna, è edito da Longanesi (prefazione di Gherardo Colombo, pp. 264, euro
18,80). Non somiglia infatti a una polemica italiota, ma a una sorta di tragedia
greca quella evocata da Stefano Cagliari, all’epoca architetto 35enne: a
cominciare dal crudele tempismo di un destino che, lo stesso 8 marzo
dell’arresto di suo padre per tangenti, vede abbattersi una diagnosi infausta su
suo fratello Silvano (che morirà tre anni dopo), e sulla propria moglie Mari
l’incurabilità di una malattia che la ucciderà due mesi dopo, lasciandolo solo
con un bimbo di 3 anni. Un arresto quasi annunciato dalle cronache sulle
indagini, e tuttavia inatteso perché «era un po’ come stare sotto le bombe: si
sperava solo che la prossima non colpisse te ma qualcun altro», ma «nessuno in
casa osava parlarne». Nessuno, salvo l’agghiacciante inconsapevolezza del
nipotino che, preso in braccio dal nonno pochi giorni prima dell’arresto, ripete
parole ascoltate all’asilo: «“In galera! in galera!”, gridò. Rimanemmo tutti di
sasso». Solo l’arroganza di psicologismi d’accatto può pensare di spiegare i
motivi per i quali una persona si toglie la vita. E se il libro vi rifugge è
anche grazie alla franchezza con cui il figlio racconta il proprio «dolore in
quegli anni» nel «pensare non solo che il sistema, che dava soldi ai partiti
secondo uso consolidato e illegale, fosse sbagliato, ma che mio padre vi si
fosse adeguato e lo considerasse necessario. Mi sentivo tirato da due parti
opposte. Ci aveva insegnato a scegliere l’interesse generale (...), ma in questo
caso qual era l’interesse generale? Nelle sue lettere la polemica coi magistrati
continuava a crescere. Ormai per lui erano il pericolo per il Paese». È in fondo
la stessa lacerazione restituita dalle lettere alla moglie Bruna (morta nel
1998). Quelle nelle quali Cagliari scrive «sono la vergogna della famiglia»;
constata che «certamente era molto meglio non commettere alcun reato reale o
presunto (…) ma spero che questo lavoro vada avanti con mani più “pulite” delle
nostre che non abbiamo saputo (o potuto?) evitare»; e radiografa quanti «non si
sono resi conto di cadere in compromissioni irrimediabili e sono stati colti di
sorpresa, io tra questi ed è giusto che paghi». Ma anche quelle in cui addita
«l’ideologia del rancore» sotto «l’obiettivo dichiarato» di «questi giudici
certamente meritevoli e coraggiosi ma anche ambiziosi di potere e di gloria»,
dai quali si sente trattenuto «in violazioni di leggi al solo scopo di farmi
rivelare chissà quali segreti segreti», per «scalzare ciascuno di noi dal nostro
ambiente rendendoci inaffidabili in qualche modo pubblico». È la medesima
lacerazione che prova ora a comprendere anche Gherardo Colombo, uno dei pm di
Cagliari in quei mesi, quando nella prefazione ragiona di cosa «accada
usualmente» a una persona arrestata: «Cagliari si sente perseguitato, io credo,
anche perché non può sapere come procedono le indagini, non sa cosa si nasconde
dietro le domande, si ritiene vessato e non può vedere che le indagini seguono
tempi e modi dipendenti da una serie di variabili a lui sconosciute. Due mondi
che non comunicano. La difficoltà sta qui: nell’unire in maniera razionale e
umana queste due diverse esigenze, queste due facce del processo penale». Voleva
pagare, dice il figlio, «ma senza coinvolgere altri»: intento incompatibile con
il compito dei magistrati di disvelare le ulteriori illegalità intuite in Eni.
Cresce così, nota il figlio, una «guerra di nervi» nella quale il padre, «per 31
lunghissimi giorni non più interrogato, quando altri imputati rilasciavano nuove
dichiarazioni, le confermava ma non era mai proattivo». Fino a maturare la
percezione soggettiva di non «sentirmela più di sopportare ancora a lungo (...)
minacce infamanti, promesse denegate, vita da canile». E fino all’episodio,
rievocato senza enfasi nel libro, degli arresti domiciliari nel filone Eni-Sai
prima promessi e poi (secondo il racconto degli avvocati) negati nel parere del
pm De Pasquale al gip Grigo, di cui Cagliari non attenderà la decisione («Anche
questa volta ci è andata male e non capisco di preciso perché (…). Non vorrei
diventare uno dei pochi capri espiatori»), accennandone alla moglie in una
lettera da non aprire però subito: «È ormai molto tempo che penso a questa come
l’unica risposta possibile» a «questa tortura della prigione per costringermi a
confessare l’impossibile». Presagio che nel libro, per la prima volta, il
cappellano don Luigi Melesi ricollega a un’uscita improvvisa di Cagliari in
giugno: «Ci vuole un gesto forte. Se si suicida un detenuto a San Vittore fa un
clamore passeggero, ma se si suicidano in dieci cambia il sistema carcerario».
ECCO LA
STORIA DI UN BUSINESS EREDITATO DAI FIGLI DI PAPA' GABRIELE.
Scrive il 13 giugno 1992 "La Repubblica". Eurotecnica nasce nel lontano agosto
del 1962 per opera di un gruppo di ingegneri chimici usciti qualche anno prima
dall' Eni. Vi troviamo Osvaldo Sacco, Augusto Panciera e Gabriele Cagliari,
tutti e tre intorno ai quarant' anni, vogliosi di muoversi in proprio al di
fuori della logica dell'ente di Stato. E successo ne devono avere avuto
parecchio, se quella società, partita trent' anni fa con un capitale di pochi
milioni di lire, oggi ne conta per dodici miliardi. Raccontano gli amici di
Cagliari, socialista quasi dalla nascita, che la quota del futuro presidente
dell'Eni, arrivato per ultimo nel gruppo, fosse del 15 per cento circa. Invano
però se ne cerca traccia al giorno d' oggi: presidente della holding è infatti
Panciera, i consiglieri di amministrazione sono il già citato Sacco e poi
personaggi nuovi: il kuweitiano Hamdan Deep Moussa, il lussemburghese Jean
Claude Wolter, Giuseppe Panciera, che della società è il responsabile
amministrativo, e poi Stefano Cagliari, nato nel 1957, figlio di Gabriele. Il
giovane Cagliari diventa consigliere di Eurotecnica il 29 luglio del 1991,
appena due mesi dopo l'aumento di capitale, e con l'inizio dell'anno nuovo entra
nel comitato esecutivo. Quasi tutti gli stessi personaggi si ritrovano anche
nella consociata Eurotecnica Contractors and Engineering, il cui capitale, di
200 milioni al momento della fondazione nel marzo del 1982 (c' erano in qualità
di soci fondatori i soliti Cagliari, Sacco e Panciera) arriva oggi a dieci
miliardi. Ma oltre a loro e a Oscar Chiari, Liborio Satariano, Adalberto
Bestetti, Claudio Gatti e a Stefano Cagliari troviamo nel consiglio anche
l'altro figlio del presidente dell'Eni, Silvano Cagliari, nato nel 1962. Stefano
entra in questa società nell' aprile del 1989, Silvano due anni dopo, nel 1991.
E' chiara dunque la presenza della famiglia Cagliari nel capitale di
Eurotecnica, che nei primi anni della sua esistenza opera ai margini del sistema
delle PPSS: qualcosa a Terni, qualcos'altro al nord, in genere si tratta di
contratti modesti. Poi, nel 1980 avviene un fatto strano. Gabriele Cagliari
rientra nel sistema Eni. Lo troviamo prima all' Anic. Poi nel 1983 Gianni De
Michelis lo vuole come membro della giunta dell'Eni in rappresentanza del
partito del garofano. Ottiene due mandati consecutivi ma nel 1989, all' epoca
dei fatti (contratto per Ravenna e inizio dei lavori del tubo d' oro) non pensa
di poter arrivare ai vertici dell'Eni. Al massimo spera di diventare presidente
di Enimont, la joint-venture tra Eni e Montedison che sta già sperimentando i
primi contrasti. Ma l'appoggio dell'accoppiata socialista De Michelis Martelli
gli consente di superare la diffidenza di Bettino Craxi e di arrivare all'
ultimo piano.
Davigo e i
detenuti dimenticati.
"Sono qui da oltre quattro mesi, illegittimamente trattenuto". Sono le parole ai
familiari di Gabriele Cagliari, prima di suicidarsi in carcere nel 1993, scrive
Vittorio Sgarbi il 10 marzo 2017. "La criminalizzazione di comportamenti che
sono stati di tutti, degli stessi magistrati, anche a Milano, ha messo fuori
gioco soltanto alcuni di noi, abbandonandoci alla gogna e al rancore
dell’opinione pubblica. Ci trattano come non-persone, come cani ricacciati ogni
volta al canile. Sono qui da oltre quattro mesi, illegittimamente trattenuto".
Sono le parole ai familiari di Gabriele Cagliari, prima di suicidarsi in carcere
nel 1993, "trattenuto" dagli amici di Piercamillo Davigo che, ora, con
disgustoso cinismo, si assume la responsabilità di quel crimine non riconoscendo
eccessi nell’uso della misura cautelare, se non nelle scarcerazioni (sic!).
Cagliari se lo erano dimenticato. Come mi disse, all’epoca, il gip di Mani
pulite, Italo Ghitti, il vero reato di quei magistrati è di "corruzione di
immagine".
Vittorio
Sgarbi condannato a pagare 60 mila euro ai pm del pool di Mani Pulite,
scrive il 21 Maggio 2015 "Libero Quotidiano". Dopo vent'anni di processi
attraverso tutti i gradi di giudizio, la Cassazione ha condannato Vittorio
Sgarbi a pagare un risarcimento di 60 mila euro a tre ex pubblici ministero del
pool di Mani pulite Piercamillo Davigo, Gherardo Colombo e Francesco Greco. La
vicenda è nata nel 1994, quando Sgarbi era fresco deputato di Forza Italia e
conduttore in tv di Sgarbi quotidiani. In quel periodo il critico d'arte aveva
definito dalle pagine de Il Giornale e Avvenire "assassini" i magistrati, dopo i
suicidi di Raul Gardini e Gabriele Cagliari. Sgarbi aveva aggiunto che i tre pm:
"avevano fatto morire delle persone" e aveva definito il pool: "Associazione a
delinquere con libertà di uccidere". La sentenza - Sgarbi era stato già
condannato in appello nel 2011. Nella sentenza i giudici avevano scritto che:
"neanche la più benevola concezione del limite della continenza verbale potrebbe
mai giungere ad ammettere che tali espressioni non violino quel limite". La
sfuriata ventennale di Sgarbi gli costerà 60 mila euro, cifra contestata dall'ex
parlamentare, ma secondo i giudici non è un cifra "esorbitante" considerando "il
lavoro svolto" dai tre magistrati offesi, "la gravità degli addebiti loro mossi
e l'impatto sociale di affermazioni così drastiche". La responsabilità -
Inascoltate anche le proteste di Sgarbi che non aveva accettato di essere
condannato in solido da solo, senza il coinvolgimento degli editori che avevano
pubblicato le sue parole. Secondo il critico, dovevano essere i giornalisti a
"verificare la violazione del limite di continenza verbale". Ma la sua richiesta
è arrivata solo nove anni dopo l'inizio del procedimento giudiziario.
Il senso de
La Repubblica per “l’informazione completa”.
Gli SMS di Di
Maio e la “memoria” di Davigo per Mani Pulite: chi ricorda come morì Gabriele
Cagliari? Scrive Fuori dal Coro Fabio Cammalleri il 18 Febbraio 2017 su "La Voce
di New York". Le proteste del quotidiano La Repubblica, per le invettive del
M5S, in margine alla questione SMS dell’On. Di Maio, vorrebbero proporre
l’immagine di un presidio di libertà, ora sottoposto a minaccia. Ma, come si
dice, chi semina vento... Il caso dei suicidi di Mani Pulite.
Breve
premessa. In questi ultimi giorni, sta correndo violenta una polemica fra il M5S
e Repubblica, in seguito alla nota vicenda degli SMS scritti e ricevuti dall’On.
Di Maio. Ne era oggetto Raffaele Marra, già Vice-capo di Gabinetto del Sindaco
di Roma, Virginia Raggi, in atto in custodia carceraria per corruzione ed altro.
“Marra è uno dei miei”, avrebbe scritto Di Maio a Raggi, secondo Repubblica; no,
replica Di Maio, il testo era: “sui miei, il Movimento fa accertamenti ogni
mese”, quindi “L’importante è non trovare nulla”. Come a dire: “anche sui miei”,
perciò anche su Marra, che pure non lo è. Aveva ragione il M5S. Repubblica ha
provato a metterci una pezza, affermando, in una nota, che “un responsabile di
turno ha modificato una frase del testo on line”. Insomma, ora abbiamo anche il
giornalista “a sua insaputa”. Ne sono seguite reazioni violente e minacciose
(“killeraggio”), non inconsuete da parte di M5S. Ma l’insinuazione e la
parzialità travisante, caratteri costitutivi della nota maison giornalistica,
sono essi violenza al sommo grado. E sono stati l’abbecedario di un
avvelenamento violento che ha corrotto la coscienza critica di vari milioni di
italiani, per almeno un paio di generazioni: e di cui M5S costituisce solo
un’espressione epigonale. Sicchè questo, fra giornale “colto” e movimento
“incolto”, appare solo un dissidio fra maestro e allievo. E, giusto oggi, ne
abbiamo un altro clamoroso esempio. Fine della premessa. C’è un video,
infatti, presentato sulla prima pagina di Repubblica. Vi si può sentire il
dott. Piercamillo Davigo, che ricorda, nel 25° anniversario, Mani Pulite. Dura
7’ e 19’’, ed è un monologo. Mi preme soffermarmi brevemente su due sue
proposizioni, connesse.
La prima, in
termini così perentori, non è molto usuale, ed è resa al minuto 5’:02’’: “nessun
nostro detenuto si è suicidato, nessuno… questa è una della varie bugie che sono
state alimentate”. Ne ricordo solo uno. Nella notte fra l’8 e il 9 Marzo 1993
Gabriele Cagliari, Presidente dell’ENI, fu tratto in arresto. Era stato ordinato
dal G.i.p. Italo Ghitti, su richiesta del Pool. Era accusato di corruzione e di
violazione della Legge sul finanziamento dei partiti. Ammise, già all’inizio del
suo primo interrogatorio, tutti i fatti posti a fondamento dell’ordinanza di
custodia cautelare. Lo stesso giorno, si dimise da Presidente dell’Ente. Dal
momento che la confessione era stata completa e spontanea, l’avvocato di
Cagliari ne chiese la liberazione, o, in via subordinata, gli arresti
domiciliari. Gherardo Colombo condusse il primo interrogatorio. L’11 Marzo,
durante un secondo interrogatorio, Cagliari descrisse i negoziati che erano
intercorsi, sul gas naturale, tra l’Algeria e una azienda dell’Eni, che aveva
pagato un mediatore. L’episodio non gli era stato contestato ed era appena
presente ai magistrati. Ciònonostante, il Pubblico Ministero espresse parere
sfavorevole alla remissione in libertà, e il Giudice Ghitti in effetti la negò.
Il 16 Marzo fu ancora interrogato da Colombo; a questo punto, interviene Di
Pietro. Cagliari aveva fornito spiegazioni particolareggiate sul finanziamento
dei partiti politici da parte dell’ENI; e, pur non volendo in un primo momento
accusare altri, poi cedette: identificando il mediatore di questi pagamenti:
Francesco Pacini Battaglia, banchiere, il cui ruolo era stato, fino a quel
momento, completamente ignorato. Dopo questo interrogatorio, l’avvocato di
Cagliari presentò un’altra richiesta di remissione in libertà. Ancora rigetto.
Al 9 Giugno 1993, aveva già trascorso più di tre mesi nella sua cella, piena di
detenuti. E, per quel “titolo” (la singola contestazione), i termini della
custodia cautelare erano scaduti. Tuttavia, non ne era seguita la remissione in
libertà, sia perchè il Gip Ghitti aveva emesso un’altra ordinanza di custodia
cautelare in carcere; sia perché, il 26 Maggio, un altro magistrato del Pool, il
dott. Fabio De Pasquale, aveva formulato un ulteriore richiesta custodiale:
accolta da un altro Gip, il dott. Grigo, e fondata su un’ipotesi di illecita
gestione dei contratti di assicurazione/vita dei dipendenti ENI. Per Cagliari,
era allora cominciato un nuovo conteggio trimestrale, salva la revoca. Nel
frattempo aveva compiuto 67 anni, e gli era morta la giovane nuora. Gli era
stato comunicato che non si sarebbe potuto recare ai funerali, a meno che non
avesse accettato l’umiliazione di partecipare ai funerali in ceppi, e sotto
scorta armata.
Il 17 Giugno,
Ghitti dispose gli arresti domiciliari per la sua seconda ordinanza. Ma rimaneva
“in piedi” l’altra ordinanza di custodia in carcere, quella emessa dal giudice
Maurizio Grigo. Il dott. De Pasquale, che ne aveva chiesto l’emissione indagando
su ENI/SAI, era infatti tornato ad interrogare Cagliari: cercava quel nome, che
allora non venne, ed espresse parere negativo: il Gip rigetta ancora. Il 15
Luglio, “l’indagato” chiese di essere interrogato di nuovo. Non accadeva da
quasi un mese; sembrava che i magistrati, dal 17 Giugno, si fossero dimenticati
di lui. Arriva De Pasquale. Cominciano alle 5:30 del pomeriggio. Distrutto da
una lunga detenzione, Cagliari aveva ora deciso di “arricchire” la sua
confessione. Tuttavia, avrebbe rischiato di contraddire le sue precedenti
dichiarazioni, sia nella loro dinamica interna, sia nel rapporto con le altre
acquisizioni investigative. In questo contesto caotico, finalmente, Craxi fu
menzionato. Quasi che Cagliari avesse voluto mandare un segnale: si stava
piegando ad accusare altri, solo per ottenere la libertà. Sembrava funzionasse,
però. De Pasquale, con un commento piuttosto vibrante, apparve soddisfatto; a
verbale rimase questa più asciutta dichiarazione: “La devo mandare a casa, anche
se l’ultima parte non mi convince. Così c’è l’ha fatta a guadagnare la sua
libertà”. L’interrogatorio si era concluso tardi, erano le 08:40. Così
l’avvocato di Cagliari, confidando nell’annunciato parere positivo, il giorno
successivo presentò l’istanza di scarcerazione (da L’Espresso, 1 Agosto 1993,
pag. 52; di Chiara Beria D’Argentine e Leo Sisti). La mattina ancora dopo,
l’avvocato di Cagliari, lesse il parere del PM su un giornale: ma era negativo.
Domenica 19, Cagliari, da cinque mesi recluso, seppe. Nel frattempo De Pasquale
era andato nella nativa Sicilia, per un periodo di vacanza.
La mattina del
20, lunedì, il giovane avvocato Luigi Gianzi, dello studio legale che difendeva
Cagliari, varca la sala colloqui di San Vittore. Portava i due libri che “il
detenuto” aveva chiesto. Attese per venti minuti. Chiese agli agenti di custodia
di controllare. Per altri dieci minuti, ancora niente. Ma Gianzi non era
preoccupato: Cagliari poteva essere in infermeria. Alle 10:15, si presentò il
capo-turno preposto alla sala-colloqui, e gli disse semplicemente: “Mi segua”.
Lo condusse dal Direttore del carcere, che lo informò. Probabilmente quella
stessa mattina, Cagliari era andato nel bagno della cella, quindi, annodandosi
un sacchetto di plastica in testa, si era ucciso soffocandosi.
La seconda
proposizione che Davigo consegna a quel video, invece, è una sorta di costante,
e si può udire al minuto 5’:10’’: “…dicevano che noi mettevamo la gente in
carcere per farla parlare, non è vero… è vera però una cosa: che quando
parlavano li mettevamo fuori, perché chi parla, chi collabora, diventa inidoneo
a commettere questi reati” . Probabilmente nella notte fra il 19 e il 20,
Gabriele Cagliari aveva scritto una lettera alla moglie: “…La criminalizzazione
di comportamenti che sono stati di tutti, degli stessi magistrati… ha messo
fuori gioco soltanto alcuni di noi, abbandonandoci alla gogna e al rancore
dell’opinione pubblica. La mano pesante, squilibrata e ingiusta dei giudici ha
fatto il resto. Ci trattano veramente come non-persone, […] L’obiettivo di
questi magistrati, quelli della Procura di Milano […] è quello di costringere
ciascuno di noi a rompere, definitivamente e irrevocabilmente, con quello che
loro chiamano il nostro “ambiente”. Ciascuno di noi,… deve adottare un
atteggiamento di “collaborazione”, che consiste in tradimenti e delazioni… i
magistrati considerano il carcere nient’altro che uno strumento di lavoro, di
tortura psicologica… Siamo cani in un canile, dal quale ogni procuratore può
prelevarci per fare la sua propria esercitazione e dimostrare che è più bravo o
più severo di quello che aveva fatto un’analoga esercitazione alcuni giorni
prima, o alcune ore prima… Stanno distruggendo le basi di fondo e la stessa
cultura del diritto: stanno percorrendo irrevocabilmente la strada che porta al
loro stato autoritario… Io non ci voglio essere”. Tre giorni dopo Cagliari,
com’è noto, anche Raul Gardini fece la sua scelta. Non era detenuto;
probabilmente temeva di diventarlo. Due diverse ispezioni ministeriale hanno
escluso responsabilità disciplinari in capo ai magistrati. Peraltro, il suicidio
rimane un mistero assoluto. E tale dovrebbe essere considerato sempre. Solo che
il 24 luglio, Repubblica titolò: “Sangue sul Regime”. L’insinuazione mai sazia,
che si fa violenza, orrenda maledizione: e siamo tornati al punto di partenza.
Tuttavia, che Davigo oggi insista col suo racconto, “nessun nostro detenuto si è
suicidato, nessuno…”, sembrando negare persino quanto costituisce materia
formale e indiscutibile, la detenzione e il procedimento, non finisce di
stupire. Invece, non riesce a stupire che quel giornale glielo lasci dire, senza
uno schizzo di nota a margine. Forse verrà un tempo in cui
certo cotè intellettuale ritrovi la via della decenza. Ma fino a quel momento,
di fronte al sempre più insistito sciamare di bocche che digrignano, di volti
che schiumano, di verità retrattili, sarebbe meglio che taluni, certe pose da
vittima della venticinquesima ora, neppure tentassero di assumerle. Perché i
nostri nonni dicevano: chi semina vento…
GABRIELE
CAGLIARI. Il caso del presidente Eni suicida in carcere: la sua morte non
convince a distanza di 23 anni
(Il Labirinto, oggi 2 giugno 2016). Gabriele Cagliari, presidente Eni morto
suicida in carcere nel 1993. La sua storia di "in-giustizia" al centro della
nuova puntata del programma di Rete 4, Il Labirinto, scrive il 2 giugno 2016 "Il
Sussidiario". La morte di Gabriele Cagliari sarà al centro della nuova puntata
de "Il Labirinto - Storie di ordinaria in-giustizia”, il nuovo programma della
seconda serata di Rete 4 condotto da Carmelo Abbate ed in onda stasera 2 giugno.
Il caso di Gabriele Cagliari fu destinato a fare molto scalpore nei primi anni
'90, mettendo in discussione l'uso della custodia cautelare come strumento
adottato dalla magistratura. Cagliari fu nominato presidente dell'ENI nel 1989
su indicazione del PSI e morì suicida in carcere quattro anni dopo sebbene la
sua morte fu intrisa di alcuni aspetti che restano ancora oggi un mistero. Siamo
negli anni di Tangentopoli quando la Procura di Milano richiese l'arresto
di Gabriele Cagliari con l'accusa di aver autorizzato il pagamento di tangenti
in favore di una commessa alla Nuovo Pignone, società del gruppo del quale era
presidente. Sebbene fosse stato definito una persona perbene da tutti e lontano
dalle accuse che gli furono mosse, gli inquirenti milanesi furono convinti del
contrario. Cagliari rimase rinchiuso in una cella di San Vittore e trattenuto
nella condizione di carcerazione preventiva per quattro mesi prima di quel 20
luglio 1993, quando fu trovato senza vita nelle docce del carcere. Secondo la
ricostruzione dei fatti il presidente dell'Eni si sarebbe ucciso soffocandosi
con un sacchetto di plastica e il suo suicidio sarebbe stato preannunciato da
una lettera scritta alla famiglia circa due settimane prima nella quale
giustificava il gesto puntando il dito contro i magistrati e dando l'addio a
tutti. La versione fornita dagli inquirenti, tuttavia, portò con sé una serie di
polemiche ma soprattutto dubbi sulle reali dinamiche della morte di Gabriele
Cagliari. Il suo gesto di estrema disperazione, seppur comprensibile, fu seguito
da una serie di circostanze poco chiare, a partire dai risultati dell'autopsia
che sottolineò come sul suo corpo ci fossero contusioni difficilmente
riconducibili alla dinamica del suicidio. Secondo quanto riferito da alcuni
testimoni (tra agenti penitenziari e altri detenuti del medesimo carcere),
inoltre, pare che il sacchetto utilizzato da Cagliari per togliersi la vita
fosse ancora gonfio al momento del suo ritrovamento. A destare ulteriori dubbi,
infine, anche la stessa lettera inviata ai parenti e che giustificava il
suicidio. A distanza di quasi 23 anni, dunque, la sua morte ancora non convince
del tutto, riaccendendo il dibattito su un caso di “in-giustizia” che all’epoca
destò molto clamore.
Per questo mio padre Gabriele Cagliari decise di uccidersi.
Stefano Cagliari è il figlio dell’ex presidente dell’Eni Gabriele Cagliari,
aveva 35 anni quando suo padre, accusato di avere autorizzato il pagamento di
tangenti, venne arrestato e, dopo 134 giorni nel carcere di San Vittore, la
mattina del 20 luglio decise di suicidarsi, scrive Giovanni M. Jacobazzi il 18
Aprile 2018 su "Il Dubbio". Stefano Cagliari è il figlio dell’ex presidente
dell’Eni Gabriele Cagliari, aveva 35 anni quando suo padre, accusato di avere
autorizzato il pagamento di tangenti per fare aggiudicare una commessa alla
Nuovo Pignone, venne arrestato il 9 marzo 1993 su ordine della Procura di
Milano. Dopo 134 giorni trascorsi nel carcere milanese di San Vittore, la
mattina del 20 luglio, Gabriele Cagliari decise di suicidarsi infilando la testa
in un sacchetto di plastica. Due giorni prima si era sottoposto ad un ennesimo
interrogatorio, ammettendo gli addebiti, davanti al pm Fabio De Pasquale,
titolare del filone d’inchiesta sulle tangenti Eni-Sai. Secondo il legale di
Cagliari, al termine dell’interrogatorio, il pm aveva promesso di mandarlo ai
domiciliari. In realtà il giorno stesso aveva dato parere negativo alla
scarcerazione ed era partito per le vacanze estive. Fu il colpo di grazie per
Cagliari che, stanco e malato, scelse di farla finita per sempre. Durante la sua
permanenza in carcere, l’ex presidente dell’Eni scrisse una serie di lettere
alla moglie, ai figli e agli amici per spiegare che non poteva più sopportare il
trattamento disumano riservatogli dai magistrati. «Secondo questi magistrati, a
ognuno di noi deve dunque essere precluso ogni futuro, quindi la vita, anche in
quello che loro chiamano il nostro ambiente. La vita, dicevo, perché il suo
ambiente, per ognuno, è la vita: la famiglia, gli amici, i colleghi, le
conoscenze locali e internazionali, gli interessi sui quali loro e i loro
complici intendono mettere le mani. Già molti sostengono, infatti, che agli
inquisiti come me dovrà essere interdetta ogni possibilità di lavoro non solo
nell’Amministrazione Pubblica o parapubblica, ma anche nelle Amministrazioni
delle aziende private, come si fa a volte per i falliti. Si vuole insomma creare
una massa di morti civili, disperati e perseguitati, proprio come sta facendo
l’altro complice infame della Magistratura che è il sistema carcerario. La
convinzione che mi sono fatto è che i Magistrati considerano il carcere
nient’altro che uno strumento di lavoro, di tortura psicologica, dove le
pratiche possono venire a maturazione, o ammuffire, indifferentemente, anche se
si tratta della pelle della gente. Il carcere non è altro che un serraglio per
animali senza teste né anima. […] Come dicevo, siamo cani in un canile dal quale
ogni Procuratore può prelevarci per fare la propria esercitazione e dimostrare
che è più bravo o più severo di quello che aveva fatto un’analoga esercitazione
alcuni giorni prima o alcune ore prima. […] Stanno distruggendo le basi di fondo
e la stessa cultura del diritto, stanno percorrendo irrevocabilmente la strada
che porta al loro Stato autoritario, al loro regime della totale asocialità. Io
non ci voglio essere». Le lettere di Cagliari sono tremendamente attuali e
mettono in luce come molto poco sia cambiato in questo quarto di secolo in tema
di custodia cautelare, strapotere della magistratura, gogna mediatica, stato
delle carceri. Stefano Cagliari, architetto, attualmente è un imprenditore nel
settore dell’energia con interessi nel ramo immobiliare e nella finanza, ha
voluto raccoglierle in un libro, “Storia di mio padre”, curato dalla saggista
Costanza Rizzacasa d’Orsogna ed edito da Longanesi. Oltre a ciò ha creato il
sito gabrielecagliari.it dove sono liberamente consultabili i verbali degli
interrogatori di suo padre. «Ritengo che ciò sia un dovere civile da parte mia,
affinché chi ha vissuto quegli anni ripensi a quanto accaduto e dica ai suoi
figli cosa è successo», afferma Stefano Cagliari. In questi venticinque anni ha
rilasciato pochissime interviste. Questa è una di quelle. Troppo grande il
dolore. Nel 1993, oltre al padre, Stefano perse la moglie 37enne, colpita da un
tumore, e il fratello minore Silvano, morto di Aids. Dopo un lungo e faticoso
lavoro su stesso, Stefano Cagliari ha deciso di riabilitare la figura del padre
e accendere una luce su un periodo buio della storia del Paese.
Architetto, cosa ha provato nel rileggere dopo 25 anni queste
lettere?
«Riprendere in mano la storia di mio
padre è stata un’operazione molto dolorosa».
Le lettere di suo padre offrono una visione tremendamente lucida
del sistema giustizia italiano.
«Mio padre pensava che con Mani pulite
la magistratura stesse facendo un colpo di Stato, aprendo la strada a un regime
poliziesco».
Il regime poliziesco non c’è, però la magistratura è diventata
potentissima…
«In quegli anni la magistratura diede
un colpo fortissimo alla politica. E quando un potere perde importanza, altri
prendono il suo posto. Fino agli anni 80 la politica gestiva anche la
magistratura. Da allora non fu più così».
Come nasce Mani pulite?
«È difficile pensare che tutto nasca
all’improvviso nel 1992, dopo oltre trent’anni di gestione di un sistema,
oliatissimo, basato sul rapporto Dc- Psi».
E allora?
«La magistratura divenne molto
aggressiva in quanto appoggiata dalla piazza. Il Paese soffriva una situazione
difficilissima dove il debito avevo superato il Pil e la Lira era stata
svalutata del 25%. E poi una serie di concause».
Tipo?
«Il Psi dava fastidio a molti,
soprattutto agli Stati Uniti. Il “salotto” buono dell’economia era cambiato. E
molti imprenditori cercavano spazio.
A proposito di imprenditori, uno di questi, Silvio Berlusconi
alle fine del 1993 decise di fondare Forza Italia.
«Lo scopo primario di Berlusconi fu
quello di difendere se stesso e le aziende dalle inchieste che, inizialmente,
aveva appoggiato con le sue televisioni. Berlusconi capì per primo che gli
italiani erano stanchi di questi arresti continui».
E la sinistra sconfitta reagì in maniera violenta.
«Sì. Ci fu uno scontro di potere
fortissimo che è durato vent’anni. Dove Berlusconi ha cercato in tutti i modi di
limitare il potere della magistratura».
Ma non c’è riuscito.
«Ha agito in modo troppo scoperto.
Forse ha ragione Piercamillo Davigo quando dice che Matteo Renzi, su questo
aspetto, è stato più bravo».
Per suo padre i magistrati avevano una missioni “salvifica” della
società.
«Gherardo Colombo, uno dei magistrati
che indagò mio padre, ha scritto la prefazione del libro. E lui il primo ad
affermare che la magistratura non può eliminare i fenomeni corruttivi con la
sola repressione. Il problema è di tipo culturale».
Non tutti la pensano come Colombo. Da parte di molti c’è la
richiesta di nuove pene e maggiore carcere.
«Questa è una logica molto
superficiale. Come scrisse mio padre, “il carcere è un moltiplicatore di
malavita”».
Cosa non funziona in questo Paese?
«Ci sono troppe regole, che si
sovrappongono e si contraddicono. Oltre a favorire la corruzione, la conseguenza
è che il burocrate cerca sempre di proteggersi avendo paura di cosa possa
accadere. Il Paese è completamente ingessato».
Come funzionava il sistema delle tangenti in quegli anni?
«Tutte le grandi aziende pagavano i
partiti che allora avevano costi altissimi. Chi non pagava era fuori dalle
stanze del potere. Le regole erano queste. Se dopo quindici giorni non avevi
capito come fare, qualcuno veniva a spiegartelo».
I partiti avevano un peso fortissimo?
«Certamente. Oltre ai soldi, volevano
influenzare le scelte strategiche delle aziende. Ricordo che mio padre, pur
essendo socialista, litigava spesso con Bettino Craxi».
Quando ha capito suo padre che il vento stava cambiando?
«Mio padre capì subito cosa stava
succedendo. Parlo del conflitto fra poteri. Da uomo Eni, cerco di salvare dalla
tempesta, soprattutto quella mediatica, l’azienda. Penso, ad esempio, al filone
sulle tangenti pagate all’Algeria. “Appena viene fuori una informazione del
genere, questi rompono subito”, diceva».
Per avere le commesse era necessario pagare tangenti?
«Il discorso è complesso. Pensiamo
all’estero: le aziende italiane avevano, e hanno, competitor di alto livello,
penso ai francesi, agli inglesi. In certi Paesi i rapporti si decidono in base
alla qualità delle relazioni e alla fiducia reciproca. Siamo certi che Eni oggi,
oltre a pagare tangenti, non paghi anche le milizie che difendono militarmente i
pozzi? E come spendono i miliziani questi soldi? Questo è il mondo. Se lo si
affronta con la visione del burocrate non si fa molta strada».
Bisogna fare “squadra” nell’interesse del Paese?
«La magistratura applica la legge ma
non sempre fa l’interesse del Paese. Ma, ripeto, il problema è essenzialmente
culturale. Questo Paese sta in piedi grazie alle aziende che esportano. Non
grazie ad uno Stato che spreme tutto il possibile e ai burocrati ottusi.
Rischiamo di fare la fine degli abitanti dell’isola di Pasqua che, dopo aver
tagliato tutti gli alberi, si sono estinti».
Ha mai pensato di fare politica?
«Sono rimasto molto scioccato da quanto
è successo. E ho sempre temuto che la figura di mio padre potesse essere
strumentalizzata. Comunque nessuno mi ha mai chiesto nulla».
Non crede agli imprenditori prestati alla politica?
«L’imprenditore è una persona capace di
gestire le aziende. Un decisionista. La politica è mediazione, equilibrio, penso
servano altre caratteristiche. Poi bisogna rimanere sempre con i piedi per
terra. Il potere è una droga».
RAOUL
GARDINI E GABRIELE CAGLIARI DUE FALSI SUICIDI MASSOMAFIOSI RIMASTI IMPUNITI,
scrive "Avvocati Senza Frontiere il 30 novembre 2010 riprendendo Giorgio
Bongiovanni su Antimafia Duemila e L’Espresso del 10/8/2006. Il 20 luglio 1993,
il presidente dell’ENI Gabriele Cagliari, primo gruppo siderurgico italiano,
viene trovato morto per soffocamento, in circostanze misteriose e mai chiarite
dalla Procura di Milano, con un sacchetto di plastica infilato in testa e legato
al collo con una stringa da scarpe, nei bagni di San Vittore, dov’era andato per
farsi la doccia. Il 23 luglio 1993, tre giorni dopo la morte di Cagliari, alle
sette del mattino, il maggiordomo di Palazzo Belgioioso trova riverso sul
letto, Raoul Gardini, ras della chimica italiana e patron del
gruppo Ferruzzi-Montedison, il quale si sarebbe anche lui suicidato in
circostanze misteriose, e mai chiarite dalla Procura di Milano, sparandosi un
colpo di pistola con una Walter Pkk, stranamente trovata sulla sponda opposta di
dove si trovava il corpo inanimato dell’imprenditore ravennate fulminato da un
unico proiettile alla tempia. Due misteriosi falsi suicidi da collegarsi alle
attività criminali delle massomafie che controllano l’economia e l’alta finanza,
riciclando i capitali della mafia, derivanti dal narcotraffico, come avevano
intuito Falcone e Borsellino, prima di venire trucidati su ordine di quei
“poteri esterni” che governano nell’ombra il Paese da oltre 150 anni, mettendo a
tacere chiunque interferisce o si oppone ai loro progetti. Il (finto) suicidio
di Cagliari si è cercato farci credere sino ad oggi sia da imputare allo
scandalo che aveva travolto i vertici dell’ENI, per una maxi tangente di 17
miliardi, in buona parte versati a quasi tutti i partiti politici a conclusione
di un accordo esclusivo tra l’ENI e la società assicuratrice SAI di Salvatore
Ligresti (grazie alla cui megatangente si era riusciti a far fuori l’INA). Ma
nella versione ufficiale secondo cui Cagliari non avrebbe retto allo scandalo
che lo aveva coinvolto e al prolungarsi della carcerazione sono rimasti in pochi
a crederci, forse neanche gli stessi magistrati di Milano. Se è pur vero che
Cagliari sperava di essere a breve scarcerato, come aveva lasciato trapelare il
P.M. Fabio De Pasquale, è anche vero che, proprio in quei giorni, il 19 luglio,
era stato arrestato Salvatore Ligresti, che aveva reso una versione dei fatti
contrastante rispetto a quella forse più credibile fornita dal presidente
dell’Eni, che avrebbe potuto iniziare a vuotare il sacco (anzichè infilarselo in
testa…) e risultare assai scomodo a quei poteri occulti che hanno ordinato di
trucidare anche gli stessi giudici Falcone e Borsellino che stavano indagando
proprio sui rapporti tra mafia, economia legale, istituzioni e massoneria. In
quest’ottica appare inverosimile che Cagliari abbia deciso repentinamente di
togliersi la vita, quando ormai sapeva di potere uscire dal carcere, per di più
con modalità talmente atroci e da manuale di criminologia. E’ più probabile
invece che sia stato indotto da menti subdole e raffinate ad inscenare
l’intenzione di suicidarsi per anticipare l’ordine di scarcerazione, inviando
lettere disperate alla moglie, come fanno spesso taluni detenuti per fare più o
meno consapevolmente pressione sui giudici. Certamente la delusione per il
ritardo nella scarcerazione, dovuto all’arresto di Ligresti e al rischio di
inquinamento delle prove, può avere provocato nel presidente dell’ENI una
profonda prostrazione, ma non tale da indurlo ad uscire così repentinamente
dalla scena, cosa che giovava sicuramente a vantaggio solo di chi poteva temere
sue nuove rivelazioni. Ed, infatti, appena settantadue ore dopo, ecco il secondo
(finto) suicidio eccellente, anzi eccellentissimo del suo grande antagonista
nella vicenda Enimont. Quello del patron della chimica italiana Raoul Gardini,
con cui veniva tappata per sempre la bocca a un altro scomodo protagonista di
quel perverso connubio tra mafia, alta finanza, politica e massoneria, che aveva
deciso di collaborare, raccontando tutto ai magistrati di “mani pulite”. La
discesa di Raoul Gardini era cominciata l’anno prima, nel 1991 quando estromesso
dalla gestione della Ferruzzi gli erano subentrati il cognato Carlo Sama e
l’amministratore Giuseppe Garofano. La mattina del finto suicidio avrebbe dovuto
incontrare i magistrati di “mani pulite” per definire la sua situazione: c’era
nell’aria un ordine di cattura, ma lui sperava di evitarlo mostrandosi disposto
a una piena collaborazione. A preoccuparlo c’era stato l’arresto di Giuseppe
Garofano, avvenuto due giorni prima, il 24. Al centro delle accuse nei confronti
suoi e della Ferruzzi la “enorme” tangente Enimont, di circa tre miliardi
versati alla DC di Forlani. Una storia che Garofano conosceva benissimo. Secondo
la versione ufficiale, alle sette di mattina, Gardini ha già fatto la doccia, è
ancora in accappatoio quando gli portano i giornali, il cappuccino e un
croissant: ed è proprio mentre si accinge a fare colazione che l’occhio gli cade
su un titolo di prima pagina di “Repubblica”: “Tangenti Garofano accusa
Gardini”. L’imprenditore ravvenate Ras della chimica italiana e coraggioso uomo
di mare che aveva superato ben altre difficoltà e venti contrari a quel punto
avrebbe capito che è finita e aprendo il cassetto del comodino vicino al letto
si sarebbe sparato un colpo mortale alla testa. Gardini magnate dell’industria e
della finanza che aveva anche sponsorizzato il Moro di Venezia all’American Cup
non lascia testamento o lettere, fatta eccezione di un biglietto lasciato lì in
bella vista con scritto sopra un semplice “grazie”. Ma si scoprì poi che
risaliva al Natale precedente ed era la risposta a un regalo che aveva ricevuto
dalla moglie Irina…Anche a questo secondo plateale “suicidio”, frettolosamente
inscenato solo poche ore prima che Raoul Gardini potesse rendere le sue
confessioni, sono rimasti a crederci i soli magistrati di Milano, che
altrettanto frettolosamente hanno archiviato uno dei più scottanti casi della
storia dell’alta finanza italiana e del suo rapporto con la mafia. E, forse,
anche sè stessi…In concomitanza muoiono infatti anche “mani pulite” e le
speranze degli italiani di svoltare pagina.
L’ombra delle
massomafie sulla morte di Raoul Gardini riapre l’inchiesta sul suicidio. A
distanza di oltre 13 anni dall’archiviazione dell’intera operazione denominata
“mani pulite”, voluta dai poteri forti e dalle massomafie, ecco il colpo di
scena che sembra riaprire il caso dei falsi suicidi dei due tra i maggiori
protagonisti della Tangentopoli finanziaria italiana e dei rapporti collusivi
tra Stato e mafia. Nell’agosto 2006, dopo le indagini sui legami tra la
Calcestruzzi S.p.A. e la mafia palermitana, la Procura di Caltanissetta chiede
alla Dia di riesaminare il caso, come già riferito anche dalla stampa: “I
pubblici ministeri hanno ordinato agli investigatori di ripartire da zero, senza
trascurare nulla”. Alla base delle nuove indagini, “la convinzione dei pm che
sia stata Cosa Nostra a determinare la scomparsa del “Contadino” che aveva
sfidato la finanza e la politica…”. (E, aggiungiamo noi: “la Massoneria”,
N.d.r.). Ci sarebbero stati almeno due elementi della scena del crimine che non
convincevano appieno gli inquirenti dell’ipotesi suicidio, riferiscono le
cronache dell’epoca. Così, fu chiesta una nuova perizia balistica perché, come
rivelato da L’espresso, citando fonti giudiziarie, “la pistola esplose due
colpi, una modalità insolita per un suicidio, tanto più che nessuno sentì le
detonazioni e solo diversi minuti dopo il corpo venne trovato in un lago di
sangue”. La Procura di Caltanissetta prese in considerazione anche il biglietto
lasciato da Gardini ai familiari con la scritta “Grazie”: “Secondo un esperto –
scrive il settimanale – poteva essere stato scritto anche mesi prima”.
L’inchiesta della Procura di Caltanissetta si ricollega alle ipotesi già
vagliate da una vecchia indagine della Procura di Palermo, ribattezzata “Sistemi
criminali”, secondo la quale “dietro le stragi del 1992-93 ci sarebbe stata la
volontà di Cosa Nostra di impedire ogni inchiesta sul monopolio degli appalti“.
Ora però, i magistrati nisseni avrebbero potuto disporre di fatti nuovi, a
partire dagli sviluppi nella ricostruzione dei rapporti tra i Buscemi, padrini
palermitani di Passo di Rigano, vicini a Totò Riina, e i Gardini, per cui il gip
di Caltanissetta Giovanbattista Tona, su richiesta della Procura, fece scattare
alcuni ordini di custodia nei confronti dei gestori di una cava nissena e di due
dipendenti della società Calcestruzzi, poi assorbita nel gruppo Italcementi. Più
recentemente sono venute alla luce le clamorose deposizioni rilasciate da Luigi
Ilardo, un pentito infiltrato che già nel gennaio 1994 aveva inascoltatamente
denunciato i legami del Gotha di Cosa nostra con Marcello Dell’Utri, Salvatore
Ligresti, Raul Gardini e altri famosi imprenditori del suo entourage, dei quali
taluni verranno poi condannati per “concorso esterno in associazione mafiosa”.
Ma Ilardo non si ferma qui, denuncia anche un patto politico-elettorale con il
nascente partito di Forza Italia, facendo i nomi di influenti politici, tra
cui, oltre a Dell’Utri, quello dell’attuale Ministro della Difesa, Ignazio La
Russa e di suo fratello Vincenzo, che secondo tali rivelazioni e fonti
giudiziarie “legherebbero la famiglia La Russa e la famiglia Ligresti a Cosa
nostra”. Noi non sappiamo se tali accuse siano fondate, ma è cosa certa che dal
1994 ad oggi ogni verità falsa o vera che sia, ci è stata subdolamente
celata e non è stata svolta alcuna indagine. Ciò mentre il povero Ilardo
veniva tradito e ucciso dallo Stato che stava servendo, proprio poco dopo aver
rivelato ai Ros dei Carabinieri, dove si trovava l’ ”introvabile” covo del
superlatitante Bernardo Provenzano, che oltre a non venire arrestato nè
attenzionato, sarà lasciato indisturbatamente libero di frequentare e agire,
mandando pizzini a destra e a manca, per ben sei anni successivi alle
informative ai Ros e all’uccisione di Luigi Ilardo. Il caso di Luigi Ilardo che
in pochi mesi aveva fatto decapitare le famiglie mafiose di tutta la Sicilia
orientale, legate alla fazione più cruenta di Totò Riina, è quindi emblematico
del patto scellerato tra istituzioni e massomafie, ovvero del fatto che Stato e
mafia siano ormai divenute da oltre 40 anni una “Cosa sola”. Alla luce di tutto
ciò chiediamo quindi al Procuratore Nazionale Antimafia Grasso come mai a
distanza di 18 anni ancora oggi nessuno ha ancora scoperto la verità sul duplice
“omicidio-suicidio” di Gabriele Cagliari e Raoul Gardini e sulla catena di morti
sospette e stragi che hanno insanguinato l’Italia, riaprendo la pista della
Duomo connection di Falcone e Borsellino?
GARDINI E I
PADRINI. A riguardo, riprendendo alcuni stralci di un articolo de L’Espresso,
ricordiamo che pochi giorni dopo le rivelazioni di Leonardo Messina, primo
mafioso a pentirsi dopo la strage di Capaci, che accettò di collaborare con il
pm Paolo Borsellino, collegando gli investimenti e le attività di Cosa nostra
con quelli dell’alta finanza italiana e del sistema dei partiti, quest’ultimo
venne frettolosamente trucidato. Infatti, in quell’interrogatorio Messina,
piccolo boss dalle rivelazioni sconvolgenti sulla rete planetaria di Cosa
nostra, disse senza mezzi termini: “Totò Riina i suoi soldi li tiene nella
calcestruzzi”. All’inizio venne verbalizzato con la ‘c’ minuscola, come se si
trattasse di una qualunque fabbrica di cemento, ma l’uomo d’onore precisò
subito: “Intendo dire la Calcestruzzi spa”. Ossia il colosso delle opere
pubbliche, leader italiano del settore posseduto dall’ancora più potente
famiglia Ferruzzi ma, secondo quel mafioso della provincia nissena, controllato
in realtà dal padrino più feroce. Borsellino rimase colpito da quelle parole:
all’indomani dell’uccisione di Giovanni Falcone aveva riaperto il dossier del
Ros sul monopolio degli appalti. Una radiografia dell’intreccio tra cave e
cantieri che costituisce il polmone di Cosa nostra: permette di costruire
relazioni con i politici e con la borghesia dei professionisti, di creare posti
di lavoro e marcare il dominio del territorio. E guadagnare somme sempre più
grandi. “Ma se ci sono tante persone che possono riciclare qualche miliardo di
lire”, dichiarò Borsellino all’indomani dell’interrogatorio di Messina, “quando
bisogna investire centinaia di miliardi ci sono pochi disposti a farlo.
Imprenditori importanti, di cui i mafiosi non si fidano ma non possono nemmeno
fare a meno. È uno dei fronti su cui stiamo lavorando”. Il magistrato siciliano
non ebbe il tempo di andare avanti: 19 giorni dopo fu spazzato via
dall’autobomba di via d’Amelio. Un anno più tardi, anche Gardini uscì di scena.
Due morti che, secondo la Procura di Caltanissetta, sono direttamente collegate.
Per questo i magistrati nisseni riaprirono l’inchiesta sul suicidio di Gardini,
a cui la moglie Idina Ferruzzi, non ha mai creduto, ripartendo da un’ipotesi,
già percorsa invano con un’indagine ribattezzata ‘Sistemi criminali’ e chiusa
con l’archiviazione: “dietro le stragi del 1992-93 ci sarebbe stata la volontà
di Cosa nostra di impedire ogni inchiesta sul monopolio degli appalti”.
Ora,
proseguiva L’Espresso, nel 2006, “i pm di Caltanissetta dispongono di fatti
nuovi, alcuni ancora segreti, a partire dagli sviluppi nella ricostruzione dei
rapporti con i Buscemi, padrini di Passo di Rigano: il feudo di Salvatore
Inzerillo, a loro affidato da Totò Riina per la fedeltà dimostrata in guerra e
in affari…”. “Già dieci anni fa si era scoperto che il Gruppo Gardini e i
Buscemi erano sostanzialmente soci: ciascuno controllava il 50 per cento
della Finsavi, creata per fare affari nell’isola. Poi nel ’97 la Compart, nata
dal crollo della Ferruzzi, vende tutto a Italcementi. In Sicilia, però, secondo
le indagini, le mani della mafia restano avvinghiate alla Calcestruzzi. Poco
dopo finiscono in carcere il capomafia di Riesi, Salvatore Paterna, impiegato
della Calcestruzzi Spa; Giuseppe Ferraro, proprietario della cava Billiemi e
Giuseppe Giovanni Laurino, detto ù Gracciato, responsabile locale
dell’azienda…”. Possono personaggi così provinciali custodire segreti che hanno
sconvolto il Gotha della finanza italiana? Alcuni dei più importanti pentiti
nell’ultimo decennio, tra loro Giovanni Brusca e Angelo Siino, hanno
sottolineato come la questione del calcestruzzo fosse strategica per i
corleonesi.
Anche Falcone
e Borsellino si sarebbero mossi sulla stessa traccia. Nella richiesta di
archiviazione dell’inchiesta ‘Sistemi criminali’ i pm scrivono: “Già le loro
indagini nel 1991 avevano aperto scenari inquietanti e se fossero state svolte
nella loro completezza e tempestività, inquadrandole in un preciso contesto
temporale, ambientale e politico avrebbero avuto un impatto dirompente sul
sistema economico e politico italiano ancor prima o contestualmente a
Tangentopoli”. In ballo c’erano investimenti miliardari e relazioni fondamentali
per il potere mafioso, che andavano difese a tutti i costi. Dopo le bombe che
hanno eliminato i due migliori magistrati della storia del ns. Paese, pare che
altre fossero pronte per l’ex P.M. Di Pietro, come rivelato dal pentito Maurizio
Avola e a posteriori dallo stesso Di Pietro. Fino alla tarda serata del 23
luglio 1993, poco prima dell’inscenato suicidio, Gardini era deciso a
presentarsi ai magistrati di mani pulite per rispondere alle accuse mossegli
sulla megatangente Enimont e le relazioni tra il Gruppo Ferruzzi e il sistema
dei partiti. Cosa che, all’epoca, riferirono i suoi stessi avvocati, con i quali
“fino a poche ore prima aveva discusso della deposizione, mostrando la
determinazione di sempre”. La mattina dopo, invece, Gardini viene trovato morto.
Possibile, si interrogano i magistrati nisseni, che le pressioni di Cosa nostra
abbiano pesato su questo gesto? Possibile che si sia trattato di un omicidio? I
pm, prosegue L’Espresso, senza che sia mai stata data alcuna concreta risposta,
chiedono alla Dia di usare ogni strumento per non lasciare dubbi. E di
approfondire ogni possibile legame anche con la bomba di Milano, esplosa
all’indomani dei funerali in via Palestro. Secondo gli atti del processo, gli
attentatori sbagliarono bersaglio di alcune centinaia di metri. E Palazzo
Belgioioso, residenza di Gardini, era poco lontano. “Tanti fantasmi siciliani”,
a cui Sergio Cusani, fiduciario del sistema dei partiti, non ha mai dato
stranamente credito, seppure fossero molto concreti e capaci di seminare morte:
“La Calcestruzzi godeva di una autonomia assoluta perché Lorenzo Panzavolta
l’aveva creata e la gestiva come un autocrate”, ha spiegato in un’intervista: “A
un certo punto, dopo un attentato, saltò fuori il nome di questo Buscemi.
Gardini fu molto seccato da questa storia e all’interno del gruppo si aprì
un’inchiesta. Cusani ricorda che Panzavolta presentò Buscemi “come un manager
dell’azienda comprata in Sicilia”. E descrive Gardini turbato, tanto da pensare
di liberarsi dell’azienda: “Mi disse: ‘Vendo la Calcestruzzi e così vendo anche
Panzavolta’”. Ma, conclude il settimanale L’Espresso: “Era qualcosa che Gardini
poteva fare? Si poteva dire di no ai soci palermitani? E si poteva licenziare
Panzavolta, l’ex comandante partigiano romagnolo che teneva i rapporti tra
Ferruzzi e Pci, ma soprattutto gestiva i grandi appalti nazionali della famiglia
di Ravenna? Da: “Gardini e padrini”, L’Espresso del 10/8/2006
Lettera aperta
al C.S.M. e alla Procura di Palermo sulle bugie e i silenzi di Cusani. Agli
interrogativi dei magistrati nisseni e del settimanale L’Espresso a distanza di
oltre 5 anni la DDA non ha ancora risposto e neppure il C.S.M. e la Procura di
Palermo alla lettera aperta del giornalista di Antimafia 2000, Antonio
Bongiovanni, di cui pubblichiamo alcuni stralci, onde consentire ai lettori di
comprendere come siano andate le cose e quanto ci sia ancora da scoprire dietro
ai falsi suicidi di Gabriele Cagliari e Raoul Gardini, ovvero dietro ai torbidi
rapporti tra alta finanza, mafia, sistema dei partiti, massoneria e capacità di
condizionamento dell’attività giudiziaria. “Vorrei richiamare la vostra
attenzione sulla notizia apparsa lo scorso 23 novembre sul Corriere della sera
riguardante le informazioni rilasciate dal collaboratore di giustizia Angelo
Siino relative alla collusione tra cooperative rosse e mafie in relazione al
suicidio del ’93 di Raul Gardini. Le dichiarazioni del pentito circa le cause
della morte del finanziere imputano la totale responsabilità del fatto alla
mafia. Ciò contrasta con la tendenziosa smentita di Cusani che,
ricordiamo, nell’ambito dell’inchiesta “Mani Pulite” fu condannato, per
corruzione, a 4 anni di carcere. In qualità di giornalista mi permetto quindi di
intervenire, focalizzando alcuni fatti rilevanti, per poter meglio chiarire la
posizione di Sergio Cusani, del gruppo Ferruzzi – Gardini e del loro legame con
i fratelli Buscemi di Cosa Nostra. Come abbiamo già pubblicato nel numero di
maggio della rivista ANTIMAFIA Duemila, riportiamo integralmente le affermazioni
inquietanti del direttore dello SCO, Alessandro Pansa, inerenti le cause della
morte del Gardini: “Si grandi interessi economici in una realtà criminale come
Cosa Nostra hanno come esigenza assoluta elementi di mediazione, di coloro cioè
che mettono in contatto il criminale con il mondo economico. Se guardiamo al
territorio nazionale, ad esempio, la Sicilia scopriamo che i collegamenti fra i
livelli più bassi a quelli più elevati che si sono stabiliti tra il mondo
economico e il mondo criminale sono stati quelli della politica. Nel momento in
cui le inchieste del passato sono state mirate ad individuare questa relazione
tra politica e mafia, senza considerare che il ruolo della politica era un ruolo
intermedio, strumentale, non era lo scopo finale, si scopre forse anche il
perché alcune inchieste sono fallite e il livello economico non è stato
interamente perseguito, perché ancora oggi noi non ci siamo spiegati bene perché
Calvi si è suicidato o è stato ammazzato, perché Sindona si è suicidato o è
stato ammazzato e forse oggi sorge anche il dubbio di altri personaggi come
Raoul Gardini che si è suicidato o è morto perché è morto” (tali affermazioni
sono registrate in una documentazione audio, a disposizione della Magistratura).
Riscontri importantissimi emergono dalle inchieste del P.M. della DDA di
Palermo, Dott.ssa Franca Imbergamo, sui rapporti tra il gruppo Ferruzzi –
Gardini della Spa in Sicilia e i fratelli Buscemi, capi di Cosa Nostra per il
mandamento di Passo di Rigano – Boccadifalco di Palermo. Di particolare
interesse è l’inchiesta riguardante la perizia legale fatta su alcune di queste
società e il loro forte coinvolgimento con i Buscemi. La prima dichiarazione in
assoluto fu quella del Dott. Falcone che nell 1989/’90 disse che “la mafia era
entrata in borsa”, in coincidenza con l’ingresso, appunto in borsa, del gruppo
Ferruzzi – Gardini. La conferma che Falcone fece riferimento a queste due
organizzazioni ci arriva proprio dai suoi amici, detentori delle sue confidenze.
Gli stessi elementi emergono in due requisitorie: quella del PM Luca Tescaroli
per la strage di Capaci, che comprende le testimonianze di Salvatore Cancemi,
Giovanni Brusca e di altri collaboratori di giustizia, e quella dei P.M. La
Palma e Nino Di Matteo per quanto riguarda il processo Borsellino. Concludendo,
è ormai provato che i fratelli Buscemi (ai quali il Tribunale ha sequestrato
centinaia di miliardi di capitali in beni immobili) collaboravano con il gruppo
Ferruzzi – Gardini tramite Lorenzo Panzavolta. A dimostrazione di ciò che emerge
dalle indagini della magistratura palermitana, risultano false e in cattiva fede
le smentite dell’ex detenuto Sergio Cusani delle deposizioni del pentito Angelo
Siino. Auspichiamo che i magistrati della DDA di Palermo, in particolare il
procuratore Grasso, chiedano di interrogare Sergio Cusani e Lorenzo Panzavolta,
come persone informate sui fatti, sulla questione degli affari della Ferruzzi –
Gardini in Sicilia, per cercare di scoprire la verità sulle stragi che nel
’92/’93 hanno insanguinato l’Italia”. Da 10 anni, aggiungiamo noi, oggi, questi
auspici e interrogativi devono ancora trovare risposta, malgrado le buone
intenzioni del Procuratore Grasso che se ne va in giro per Tv a mostrare il
volto gentile ma impotente del potere giudiziario (n.d.r.). Sant’Elpidio a Mare,
lì 30 novembre 2000. In Fede: Giorgio Bongiovanni Antimafia Duemila.
Gardini e la telefonata misteriosa. «Eliminarlo è stato facile».
Mesi dopo il suicidio alla polizia arrivò una intercettazione inquietante che
tirava in ballo l'imprenditore e il figlio Ivan, scrive Alessandro Cicognani il
22/07/2018 su "corriereromagna.it. Domani saranno 25 anni esatti. Il 23 luglio,
il giorno del Patrono di Ravenna, la mattina in cui Raul Gardini estrasse una
Walter PPK dal suo comodino, la puntò verso se stesso e mise fine a una vita da
leader. Per il “corsaro” della chimica, che aveva sfidato il salotto buono
dell’imprenditoria italiana e la politica tutta, quel 23 luglio di venticinque
anni fa non era affatto un giorno come tutti gli altri. Due appuntamenti si
trovavano nella sua agenda. Nella tarda mattinata avrebbe preso parte ai
funerali di Gabriele Cagliari, l’allora presidente dell’Eni che tre giorni prima
si era suicidato con un sacchetto in testa nel carcere di San Vittore a Milano.
Una morte violenta quella del numero uno dell’Ente nazionale idrocarburi, ma di
protesta. Un grido contro il pool di Mani Pulite e la misura del carcere
preventivo, utilizzato per far confessare le menti delle tangenti alla politica
che i magistrati Di Pietro, Davigo, Colombo e Greco stavano cercando.
La morte. A metà pomeriggio, in una caserma milanese, l’imprenditore ravennate
sarebbe invece dovuto comparire proprio davanti ai pm, per il primo
interrogatorio su quella che verrà poi definita la madre di tutte le tangenti:
il caso Enimont. Ma a quei due appuntamenti, già lo sappiamo, Raul Gardini non
andrà mai. Il suo corpo senza vita, dicono le indagini di allora, venne trovato
verso le 8.30 dal maggiordomo di palazzo Belgioioso, che subito svegliò il
figlio Ivan per dirgli dell’accaduto. Da qui in poi fu quasi solo confusione. Un
rimbalzarsi di colpe che ancora oggi alcuni ritengano sia esplicativo di un
suicidio quanto meno “misterioso”. I barellieri che portarono via il corpo di
Gardini ritenendo che fosse ancora vivo, ma assicurarono agli inquirenti di non
aver toccato la pistola. Maggiordomo e segretaria che diedero orari contrastanti
sulla vicenda. La polizia che addirittura venne mandata nel posto sbagliato.
L’inquietante intercettazione. La morte di Raul Gardini venne archiviata dopo
due anni come suicidio. Questa è la verità giudiziaria e non c’è motivo per
metterla in discussione. Tuttavia oggi il Corriere Romagna è in grado di dare
conto di un’intercettazione fortuita fino ad ora sconosciuta. È il 9 febbraio
del 1994. L’imprenditore ravennate è morto da quasi sette mesi e il figlio Ivan
ha preso il suo posto alla guida della Gardini spa. Una casalinga di Padova,
L.A., alza la cornetta del telefono di casa per fare una chiamata. Da mesi sta
segnalando alla società telefonica di avere un problema con la linea, dato che
spesso le sue telefonate si bloccano e sente delle interferenze con altre
chiamate. Quello che sente quella mattina è però da brividi e la fa scattare in
piedi per dirigersi in questura. Una donna e due uomini stanno parlando, quando
a un certo punto la donna afferma: «Eliminare Gardini è stato facile, per il
figlio sarà un gioco da ragazzi». Domanda a cui uno dei due uomini risponde: «È
già tutto pronto». Non è ovviamente chiaro se il senso di quel “eliminare” sia
da attribuirsi a un contesto imprenditoriale o addirittura fisico.
Sentendo quei cognomi la donna capisce la gravità e corre alla polizia per
denunciare il fatto. L.A. è deceduta nel 2007, ma la figlia ricorda benissimo
quella telefonata. «Mia madre parlò poche volte a noi figli di questo episodio,
perché si rendeva conto della gravità di quanto avesse sentito. Ricordo che era
un periodo in cui, purtroppo, quando usavamo il telefono sentivamo delle
interferenze. Ma, chissà perché, dopo che mia madre fece quella denuncia ci
sistemarono subito il problema».
Ad oggi non è ancora chiaro se siano state fatte indagini su quella
interferenza, il cui contenuto se fosse vero potrebbe riscrivere un pezzo
importante della storia d’Italia. La questura di Ravenna, come risulta da una
nota di servizio di quei giorni, tuttavia la ritenne abbastanza credibile da
organizzare in tempi strettissimi un’intensificazione dei controlli fuori dalle
abitazioni di Ivan Gardini. A questo si aggiunge un altro elemento inedito,
raccontato dal capo delle guardie di sicurezza di Gardini, l’amico Leo Porcari.
Si tratta delle telecamere di video sorveglianza che vennero fatte installare in
tutto Palazzo Belgioioso. «Le installò una ditta di Venezia che le aveva messe
anche a Cà Dario – racconta Porcari –, ma guarda caso quella mattina erano state
spente. Perché?». La domanda forse non troverà mai risposta.
Raul Gardini, chi si suicida con due colpi?
Scrive il 23 luglio 2018 su "Il Fatto Quotidiano". Matteo
Cavezzali, Giornalista. Venticinque anni fa moriva Raul Gardini. Archiviata come
suicidio, la sua morte sancì la fine di un’epoca. Era il 23 luglio 1993, quella
mattina avrebbe dovuto testimoniare a Di Pietro e al pool di Mani Pulite sul più
grave scandalo di corruzione mai avvenuto in Italia: “la madre di tutte le
tangenti”, al centro di Tangentopoli. Ma a quell’incontro Gardini non arrivò
mai. Quando la polizia arrivò sul luogo della sua morte non c’era più niente. Il
corpo era scomparso, anche le lenzuola del letto. Rimaneva solo un materasso
intriso di sangue, e una pistola, posata sul comodino da cui mancavano due
proiettili. Chi si suicida con due colpi? Pensarono in molti. Chi guadagnò
qualcosa da quella morte? Da quel silenzio? Molte persone. Troppe. Facciamo un
passo indietro. Nel luglio 1993 da poco più di tre anni era caduto il muro di
Berlino, il comunismo aveva cessato di esistere come orizzonte politico.
L’Italia era stata il paese del blocco occidentale in cui il partito comunista
era più forte, e aveva addirittura rischiato di finire al governo. Ma ormai il
“pericolo rosso” non faceva più paura, nemmeno a Washington. I sistemi di
“protezione dal comunismo” si allentarono, e questo favorì il nascere
dell’inchiesta Mani Pulite, e gli permise di manifestarsi con tutta la sua forza
devastante. In pochi mesi Tangentopoli fece scomparire il sistema politico che
aveva governato l’Italia dalla fine della Seconda guerra mondiale fino a quel
momento. La Democrazia cristiana implose, il primo presidente
socialista, Bettino Craxi, fu costretto a fuggire e nascondersi in Tunisia. I
sistemi di potere economico e massonico, allarmati da quel sisma, si misero a
lavorare nell’ombra per non perdere terreno. La mafia intanto metteva le bombe,
uccideva e terrorizzava, perché aveva paura di rimanere senza più appoggi nello
Stato. In mezzo a tutto questo c’era un uomo, uno dei più potenti e ricchi
imprenditori del paese: Raul Gardini, che rimase stritolato in questo terribile
gioco di potere. Morì improvvisamente, il “Re di Ravenna”, il cui impero andava
dagli USA alla Russia passando per il Sud America, e con sé portò molti misteri
che rimarranno per sempre senza nome e senza volto. Partendo da questa vicenda
ho scritto “Icarus. Ascesa e caduta di Raul Gardini”, appena pubblicato da
minimum fax. Credo che, dopo 25 anni, sia giunto il momento di raccontare questa
storia da un altro punto di vista. Eccone un piccolo estratto. «Ci sono mille
modi di raccontare una storia. Soprattutto una storia che ha contorni sfocati e
molti punti poco chiari. Una storia torbida in cui colpevoli e vittime hanno la
stessa faccia. Chi racconta una storia decide i ruoli e assegna le parti. Ho
sentito parlare della vicenda di Gardini da decine di persone, e ognuno
raccontava una storia completamente diversa. Colpevole o vittima? Inebriato dal
potere o incastrato da un complotto? Visionario o pazzo? Sognatore o assetato di
denaro? A Ravenna tutto è un mosaico, ma a differenza di quelli bizantini, che
visti da lontano tratteggiano volti di imperatori e santi, questo mosaico è
molto più ambiguo. Ci sono dentro sia imperatori che santi, ma è difficile,
quasi impossibile, identificarli. A Sant’Apollinare Nuovo, la basilica di culto
ariano fatta costruire tra il V e il VI secolo da Teodorico, re degli Ostrogoti,
è rappresentato il palazzo di Teodorico con la sua corte. Quando nel 540, dopo
la morte di Teodorico, i bizantini riconquistarono Ravenna, non distrussero la
chiesa, troppo bella per essere data alle fiamme, ma la convertirono al culto
cattolico. Cancellarono dalla città tutti i segni dei precedenti dominatori.
Tolsero Teodorico e i suoi uomini dal mosaico, tessera dopo tessera,
sostituendoli con tasselli neri. Però l’operazione fu fatta in velocità, in
maniera grossolana. Così, ancora oggi, se si guarda bene tra le colonne di quel
palazzo deserto, si possono vedere spuntare una mano, un braccio, un’ombra. È
ciò che rimane di quello che era e che si è voluto dimenticare. Senza però
riuscirci completamente».
L'INTERVISTA di Federica Angelini del 21 luglio 2018 su "Ravennaedintorni.it".
Tra narrazione e indagine, la parabola di Raul Gardini e di un’epoca. In
libreria Matteo Cavezzali con Icarus, a metà tra romanzo e inchiesta: «È stato
un momento di passaggio, in cui la città è stata capitale per poi tornare di
colpo invisibile». È in libreria dal 5 luglio il primo libro di Matteo
Cavezzali, classe 1983, per noi innanzitutto uno storico collaboratore,
diventato negli ultimi anni anche l’apprezzato direttore artistico della
rassegna “Il tempo ritrovato” e del festival “ScrittuRa”, l’uomo insomma che sta
portando in città le firme nazionali e internazionali del mondo editoriale. E
ora si trova per la prima volta in veste di scrittore, con un libro, Icarus, che
sta a metà tra la cronaca e la fiction, con cenni autobiografici. Su un tema
destinato a suscitare molta attenzione, sicuramente in città, ma non solo: la
vicenda di Raul Gardini, a 25 anni dalla morte avvenuta il 23 luglio 1993.
L’editore è Minimum Fax, combattiva casa editrice romana nota per lo
straordinario catalogo e la qualità della proposta. Non potevamo che
approfittarne per intervistarlo, anche perché, premessa necessaria, il libro è
un interessante mix di registri, orchestrato in modo da creare suspense senza
rinunciare alla profondità dell’analisi, a tratti anche molto divertente,
decisamente appassionante. E oltre a raccontare la parabola di un uomo, comunque
la si pensi, fuori dall’ordinario, soprattutto ricostruisce il clima di un’epoca
di passaggio cruciale.
Matteo, quale urgenza ti ha spinto a scrivere un libro su Raul Gardini?
«È una storia che mi ha sempre affascinato, credo che delle vicende che sono
successe a Ravenna negli ultimi anni, dal Dopoguerra a oggi, sia quella che ha
colpito l’immaginario di tutti, una parabola fulminante che ha portato la città
agli apici del mondo per poi farla risparire dalle mappe, dopo la sua morte».
Su Gardini sono state però già scritte tante cose in questi venticinque anni…
«Sì, soprattutto cose saggistiche, mancava invece una narrazione romanzesca
della vicenda. Mi sembrava che si fosse cercato sempre di afferrare qualcosa che
però non era afferrabile con gli strumenti della cronaca».
Il tuo libro è di fatto un ibrido, in effetti, dove c’è una parte di inchiesta
che ricostruisce fatti, alternata a parti (in corsivo nel testo) dove invece sei
tu a immaginare dialoghi, incontri, situazioni. Un mix a cui non siamo troppo
abituati da queste parti, come ci hai lavorato?
«Da molto tempo volevo fare qualcosa su Gardini, ma non sapevo da che parte
prendere questa storia, perché è una vicenda con buchi e zone buie in cui non si
sa cosa sia successo, ma senza i quali la storia non fila, non torna. Allora ho
pensato di colmarli con il romanzo inventando alcuni passaggi che potessero
rendere comprensibile questa storia. E ho anche deciso che dentro dovevano
starci tutti i punti di vista, anche i pezzi dissonanti tra loro, in modo da
permettere al lettore di farsi un suo percorso e una sua idea. In Italia
operazioni così non sono molto frequenti, ma per esempio in Sudamerica con il
“realismo magico” la narrativa sta raccontando tante verità mai venute a galla,
come quella dei desaparecidos».
Tra i misteri naturalmente che avvolgono la vita di Gardini c’è quello sulla
morte. C’è chi non ha mai creduto all’ipotesi del suicidio. Nel libro ne parli
diffusamente ma non sembri prendere posizione. Anche se emerge chiaramente che
l’indagine è stata per lo meno affrettata…
«Quando è arrivata la polizia non c’era più niente, neanche il cadavere. E
oggetti come l’arma del delitto erano stati spostati. Come si fa a fare
un’indagine? Ed è stata sicuramente chiusa in tempi molto rapidi. Evidentemente
c’era la fretta di non creare un caso che potesse bloccare le altre inchieste».
Tu metti quella di Gardini in fila con altre quattro morti…
«Sì, in una serie di cinque morti collegate in quegli anni, tutti o suicidi che
non erano tali o morti naturali che non sembravano naturali. Di questi cinque
almeno di tre siamo quasi sicuri che fu una messa in scena. Volevo tenere aperte
tutte le piste su come potrebbe essersi svolta quella mattinata e una cosa è
sicura, da quella stanza sono passate molte persone quella mattina, che hanno
preso documenti».
Siamo all’epoca in piena tangentopoli, Gardini doveva essere proprio quel giorno
ascoltato da Di Pietro…
«Sì, si è trattato di un passaggio storico per il nostro paese e credo che sia
una vicenda che valga la pena riscoprire perché in quel momento tutte le trame
peggiori e i complotti sono giunti al pettine».
A un certo punto si ipotizza che tutto avvenga perché crollato il muro di
Berlino non ci sia più timore che i comunisti vadano al potere. Credi davvero
nello zampino della Cia?
«Secondo me non può essere un caso che tutto avvenga proprio in quel momento. Un
sistema finisce nel momento in cui non serve più».
Dopo Mani Pulite andò al potere Berlusconi. Come sarebbe stata l’Italia se
invece Gardini fosse sceso in campo?
«Gardini ha anticipato l’antipolitica: lui detestava i politici e per questo
molti lo amavano. Riusciva a fare cose nonostante la politica, se fosse sceso in
campo lui non è difficile immaginare che avrebbe preso molti voti e forse,
chissà, avrebbe puntato sull’innovazione. Avrebbe anche avuto uno sguardo
internazionale che i politici di oggi non hanno. Certo avrebbe anche lui avuto
un notevole conflitto di interessi…».
Eppure, come provi a ricostruire, lui è considerato colpevole di aver pagato
quella che fu definita la madre di tutte le tangenti. Come è possibile che anche
qui in città, più passa il tempo e più assistiamo a un processo quasi di
beatificazione?
«Allora Di Pietro era un idolo popolare, oggi che Di Pietro è finito in
disgrazia, non c’è più quel conflitto e per la città resta solo la parte
migliore di Gardini. Però a livello narrativo e forse celebrativo credo che per
rendere giustizia a una figura bisogna ricordare anche gli aspetti negativi, per
evitare di creare santini che hanno poco a che fare con ciò che è stato».
Tu per esempio ricordi sentenze che vedono Cosa Nostra coinvolta nella
Calcestruzzi, il ruolo dell’Opus Dei nello smistare le tangenti e arrivi a
ipotizzare addirittura un’affiliazione di Gardini alla massoneria, pur senza
convinzione…
«Era un momento in cui si era capito che sarebbe cambiato l’equilibrio di poteri
e tutte le forze volevano riposizionarsi, sono momenti pericolosi nessuno si
sente al sicuro e quindi è facile che persone scompaiano e muoiono. Diciamo che
a Ravenna la massoneria ha sempre avuto un ruolo determinante nella vita
pubblica e un’influenza nazionale forte e non è impossibile che un personaggio
di grande rilievo non sia stato avvicinato da questa realtà. Paolo Mondani,
giornalista di Report, mi ha fatto notare che c’erano alcuni elementi in tutta
la vicenda che portò alla morte di Gardini che sembravano segnali rivolti a un
pubblico di affiliati. E quindi ho immaginato che questo contatto fosse
avvenuto. Ma mi sono anche fatto l’idea che Raul Gardini fosse un uomo molto
solitario, che difficilmente faceva cose con altri, era uno che si metteva in
relazione con i poteri che avrebbero potuto aiutarlo o danneggiarlo, ma senza
perdere la propria indipendenza. E questo del resto l’ha portato alla fine
tragica».
Una fine tragica e misteriosa è stata anche quella di Serafino Ferruzzi, suocero
di Gardini, colui che davvero costruì dal nulla un impero.
«Sì, le analogie con quella di Mattei, di cui condivideva molte idee, sono
evidenti. Forse si è capito davvero che impero fosse il suo solo alla sua morte,
perché Serafino Ferruzzi era l’opposto di Gardini. Non rilasciava interviste,
non amava la visibilità. Forse Raul invece aveva così bisogno di apparire anche
per dimostrare di meritare quel ruolo che gli era capitato improvvisamente».
In comune hanno però avuto la scelta di mantenere a Ravenna il cuore dei loro
imperi.
«Sì, ma secondo me per ragioni diverse. Ferruzzi era un uomo all’antica che
teneva alle sue abitudini, voleva dormire nel suo letto. Gardini invece forse
amava come qui la città girasse attorno a lui, di fatto».
Nel libro racconti anche il tuo lavoro di indagine. Dove speravi di arrivare e
non sei arrivato?
«Sicuramente nel fatto di non essere riuscito a intervistare alcuni testimoni.
Panzavolta, per esempio (della Calcestruzzi Spa, ndr), che fu fermato
dall’avvocato. E soprattutto la moglie, Idina. Credo abbia preferito non
incontrarmi da un lato per il dolore di una esperienza che è stata per lei
devastante, dall’altra forse c’è anche il timore di ritirare fuori questioni che
possono creare problemi e vecchi fantasmi».
Tra i momenti di alleggerimento del libro ci sono i camei autobiografici, in
fondo avevi 10 anni quando Gardini morì.
«Il senso di quegli inserti è far capire che anche l’ultimo dei ravennati è
stato toccato da quei macro avvenimenti, non basta ignorarli perché non ti
riguardino».
Raul Gardini. Era un raider, fu travolto da poteri più forti di
lui. Ravenna vada oltre il rimpianto, scrive Roberta
Emiliani Giovedì 19 Luglio 2018 su "Cervianotizie.it. Intervista allo storico
Andrea Baravelli sulla vicenda e sulla figura di Raul Gardini in rapporto a
Ravenna, a 25 anni dalla morte. Sono trascorsi venticinque anni dalla morte di
Raul Gardini, ma il mito di questo imprenditore che ha posto fine ai suoi giorni
nello stesso giorno del patrono della sua città, il 23 luglio 1993, a Ravenna è
ancora intatto. Per chi l’ha conosciuto ma anche per molti che hanno
semplicemente seguito le sue vicende da lontano, Raul Gardini è stato un
imprenditore di successo, pieno d’intuizioni, oltre che un personaggio che ha
dato lustro alla città. In questi giorni in cui Ravenna si appresta a ricordare
l’anniversario di quella morte tragica e per molti versi ancora piena di
misteri, abbiamo cercato di rileggere la vicenda di Raul Gardini in una chiave
un po’ diversa, non celebrativa, cercando di mettere in luce luci e ombre della
sua figura, con le sue varie sfaccettature, con uno storico, il professor Andrea
Baravelli. Baravelli e il collega Alessandro Luparini, fra l'altro, hanno
ricostruito in un libro sull’esperienza di sindaco di Pier Paolo D’Attorre negli
anni immediatamente successivi alla morte di Gardini e al crack del Gruppo
Ferruzzi. Incontriamo il professor Baravelli in un afoso pomeriggio nel bar
pasticceria che si affaccia sui portici di Piazza San Francesco. Proprio a due
passi da qui, nella basilica che dà il nome alla piazza, 25 anni fa si svolsero
i funerali di Raul Gardini. Allora la piazza e il portico erano gremiti di
persone: accorsero in migliaia per l’ultimo saluto a Raul.
“Quando si parla di Raul Gardini - esordisce il professor Baravelli - si finisce
sempre per oscillare tra un mito iperpositivo e la decontestualizzazione, come
se tutto si riducesse a Ravenna, come se non esistesse altro fuori dai nostri
confini. In realtà la storia di quegli anni ci racconta qualcosa di diverso
anche su Ravenna”.
Proviamo a raccontarla allora questa storia.
“Gardini fu un raider (lo chiamavano il Corsaro, ndr), una persona che rischiò
tantissimo sapendo che si stava mettendo contro il sistema. Lui ha avuto un
grande successo, che alla fine ha pagato caro. Perché, come per tutti i raider,
o la va o la spacca. Gardini, a un certo punto, si trovò con un’esposizione
spaventosa nei confronti delle banche e chiese alla politica di dargli una mano
per risolvere il problema”.
Una delle tesi che hanno contribuito alla costruzione del mito positivo di
Gardini è che lui sia stato fagocitato dal sistema dei partiti, cioè che sia
stato una vittima di questo sistema.
“Io non la vedo così: dal momento che decide di addentrarsi in certe dinamiche
di potere, Gardini non può non essere consapevole delle regole del gioco.
Gardini non è stato un imprenditore sconfitto dalla politica, ma un raider che,
come ho detto, ha rischiato tantissimo consapevole di quelle che erano le regole
in quel momento. Non riesce però a rapportarsi ad esse, tanto che ad un certo
punto chiede alla politica di salvarlo. Ma la politica nel 1991 e 1992 è una
politica ormai debole, che non può proteggerlo come avrebbe potuto fare in un
altro momento, o non può piegare le regole economiche come aveva fatto per altri
solo pochi anni prima. Qui sta forse l’errore di prospettiva finale di Gardini.
Negli anni Novanta si consuma la fase finale della destrutturazione
dell’autorevolezza dei partiti che continuano ancora ad esistere come forma, ad
andare avanti per un decennio, ma ormai la credibilità l’hanno persa”.
Gardini non è solo rimasto nel cuore di molti ravennati, ci sono personaggi
importanti della vita economica e culturale italiana che hanno avuto un rapporto
importante di stima e affetto con lui.
“Gardini è stata una persona indubbiamente di grande fascino, un imprenditore
con molte qualità. Aveva un progetto industriale intelligente ma che poteva
avverarsi solo se si avverava anche il progetto finanziario. Gardini, secondo
me, è uno dei primi imprenditori che capisce l’importanza della comunicazione.
Prima di lui c’è solo Berlusconi in Italia che ha la capacità di legare la sua
vita privata alla costruzione del personaggio. Con una differenza: Berlusconi
riesce ad ottenere quello di cui ha bisogno in un momento in cui la politica può
ancora difenderlo, ma soprattutto ha ben chiaro il fatto che un imprenditore
moderno, se non ha una grande tradizione di famiglia alle spalle, deve essere un
personaggio pubblico. Gardini questo lo ha capito. Io vedo nell’ostentazione
delle sue origini, nell’aver portato a Ravenna e in altre città della Romagna la
redazione del Messaggero, nel suo impegno per fare tornare grande il volley
ravennate, la costruzione della sua diversità. C’è una logica di comunicazione
interna, tutta proiettata su Ravenna. Ricordo in quegli anni la forte presenza e
anche l’invadenza, sul piano locale, di Gardini, del suo Gruppo e degli
industriali, che in quel momento si raccontavano anche come potere alternativo
al potere politico della città. C’è a Ravenna un imprenditore con idee
originali, che non si mischia agli altri imprenditori, ha il suo elicottero
privato che lo porta su e giù… Questa la narrazione. Sì, secondo me c’è una
scelta comunicativa molto moderna da parte di Gardini da questo punto di vista”.
Se lei come storico volesse scrivere un libro su Raul Gardini, da dove
partirebbe?
“Partirei proprio da qui, da Ravenna e dal mito di Gardini. A me Gardini
interessa ancor più che come imprenditore, per questa sua capacità di creare un
mito che resiste nel tempo, il mito di un personaggio che in un territorio come
quello ravennate finisce per diventare il genius loci”.
Un mito che, dicevamo, è ancora vivissimo.
“Certo. Se uno pensa ad un ravennate famoso dice Gardini, non ti viene in mente
nessun altro. A me piacerebbe indagare i meccanismi della costruzione di quel
mito, quando Gardini era ancora in vita e poi la sua trasformazione nel corso
degli anni. Il mito di Gardini è qualcosa di molto ravennate, ma da Ravenna non
c’è l’eco. Fuori dalla nostra percezione, Gardini è uno dei protagonisti di Mani
pulite. Più famoso di Cusani, diverso da Chiesa, ma viene percepito come un
protagonista della vicenda di Mani pulite. Punto. Non è altra cosa. Questo
dovrebbe farci pensare”.
Continuando in questa chiave di lettura per molti ravennati l’era Gardini ha
rappresentato il massimo, il punto più alto per la nostra città. Ravenna era
capitale e adesso è tornata palude.
“No, no, non è così. È la nostra percezione di ravennati di essere stati una
capitale in quel momento. La favola di Gardini è una favola che nasce nella
prima metà degli anni Ottanta e finisce nei primi anni Novanta. Questi sono
anche gli anni di massimo splendore della tv commerciale. Sono gli anni di
Dallas se vogliamo prendere un archetipo di quella tv. Il momento d’oro della
parabola di Raul Gardini coincide con il periodo più prospero degli anni
Ottanta, un momento in cui il nostro Paese si illude di aver messo da parte gli
anni Settanta e la crisi. Ricorda quando Craxi diceva che avevamo superato
l’Inghilterra come potenza industriale? Dal 1984 al 1989 l’Italia è un paese che
sembra lanciatissimo. A questo si aggiunge la presenza di Gardini a Ravenna:
l’idea che i ravennati si fanno è quella di Raul Gardini portatore di grande
ricchezza”.
Invece, secondo lei non è così.
“Anzi, nel momento cui tutto è finito ha tolto molto e quando finisce il sogno
ti senti perduto ancora di più. A questo proposito ricordo le parole molto dure
dell’allora sindaco Pier Paolo D’Attorre, parole che furono accolte malissimo da
gran parte dei ravennati”.
Parole che molti non hanno ancora digerito.
“D’Attorre scrive in quelle settimane in maniera molto lucida relativamente al
fatto che alla comunità ravennate serve una sferzata di orgoglio, serve qualcuno
che dica: ce la faremo egualmente e non finisce nulla”.
In particolare la famosa frase di D’Attorre “Ravenna non è in ginocchio” venne
letta come l’incapacità di riconoscere la gravità del momento, fu interpretata
quasi come un “atto di lesa maestà”.
“Invece Pier Paolo D’Attorre aveva perfettamente ragione. Da grande storico
economico qual era, avendo svolto studi approfonditi sul territorio, sapeva
benissimo che il tessuto economico ravennate era solo in minima parte Gardini.
All’epoca c’era un sistema cooperativo forte, c’era ancora un’industria chimica
che reggeva. C’erano insomma le possibilità di poter superare quel momento di
difficoltà provocato dal crollo del Gruppo Ferruzzi. Però l’esortazione di
D’Attorre a reagire fu sentita come uno schiaffo, fu vissuta come l’incapacità
di provare empatia nei confronti di un dolore terrificante che l’intera comunità
ravennate stava provando. Un conto però è provare empatia per l’uomo. Un conto
inquadrare il personaggio storicamente per quello che è stato e ha fatto”.
Approfondiamo questo aspetto.
“Ho letto un libro di Claudio Martelli, molto bello, molto franco. Martelli
scrive che il progetto di Gardini era in realtà un ottimo progetto. L’idea di
una Montedison capace di sviluppare un percorso di chimica di eccellenza
mettendo in un angolo l’Eni che aveva un altro core-business, l'idea di
strapparne il 40 per cento per riportarlo all’interno della galassia Montedison
era un ottimo progetto. Dopodiché è lo stesso Martelli che dice che Gardini non
fa i conti con il fatto che l’Eni è un’impresa di Stato ed ha la politica pronta
a difenderla con le unghie e con i denti. Gardini non poteva non esserne
consapevole. Il grande imprenditore si deve rendere conto che non sta dando
l’assalto alla borsa di Chicago. Quante volte Gardini dice: abbiamo conquistato
la borsa di Chicago. Un conto è fare la grande impresa in un mercato come quello
americano. Un’altra cosa è cercare di fare lo stesso in una situazione come
quella italiana, che ha ben altre regole. La mia sensazione è che la debolezza
imprenditoriale di Gardini sia stata quella di sottovalutare la forza di
interdizione che il sistema economico e politico che faceva riferimento
all’industria di Stato aveva la capacità ancora di produrre. E dal momento che
Gardini non riesce a raggiungere il suo scopo, arriva la tragedia. Lui deve
uscire da una situazione in cui non riesce a rastrellare quel 40 per cento, in
cui non riesce a diventare la chimica sono io, come disse”.
Sulla vicenda Enimont s’innesca quella che è stata ribattezzata la madre di
tutte le tangenti.
“Che negli anni Ottanta l’utilizzo delle tangenti fosse generalizzato questo lo
sappiamo, non è solo senso comune. Una cosa però è la tangente generalizzata che
opera su settori privati, una cosa è la tangente che riguarda l’industria di
Stato. In quest’ultimo caso non sono soltanto soldi che devi pagare ai politici,
ma la tangente è anche legata alla funzionalità che quel settore ha ai fini
della politica. Mi spiego: Gardini non avrebbe mai potuto pensare in quelle
condizioni di potersi portare via un pezzo dell’economia di Stato solo pagando.
Quella parte dell’economia di Stato era anche potere”.
Gardini, Cuccia, Mediobanca.
“Quando si parla del rapporto di Gardini con Mediobanca quest’ultima sembra
sempre un po’ come la Spectre, ma in realtà Mediobanca è il capitalismo
italiano. Mediobanca è stata dalla metà degli anni Cinquanta fino al Duemila il
simbolo del capitalismo italiano che è stato o un capitalismo di Stato, fintanto
che è esistita l’IRI, oppure un capitalismo familiare, con le grandi famiglie
che usavano Mediobanca come uno strumento di controllo del mercato finanziario.
Alla fine Gardini viene travolto da quelli che sono poteri più forti di lui,
perché Mediobanca e Cuccia hanno cinquant’anni di potere relazionale sulle
spalle”.
Mistero è il termine più usato, per non dire più abusato quando si parla della
tragica vicenda di Raul Gardini. Il mistero, è tesi piuttosto diffusa, avvolge
il suo suicidio come quelli di Cagliari e di Sergio Castellari.
“Come storico io mi occupo soprattutto degli anni Settanta e di terrorismo e
anche quando si affrontano quelle pagine della storia del nostro Paese si è
costruito un genere complottistico, per cui tutto ciò che non rientra in uno
schema, tutti i buchi di una ricostruzione vengono utilizzati come prova di una
manchevolezza e vengono riorganizzati in una ricostruzione appunto di tipo
complottistico. Questo è avvenuto, secondo me, anche nella vicenda di Gardini.
Su questo versante io sono sempre molto scettico: mi devi dimostrare, atti
giudiziari alla mano, che le inchieste sono state fatte con la volontà di non
arrivare alla verità. In particolare sul fatto che Gardini possa essersi
suicidato oppure no: lui era in attesa di alcuni documenti che, a suo parere,
avrebbero dovuto in un qualche modo giustificare la sua condotta. Il giorno dopo
avrebbe dovuto recarsi da Di Pietro. Quei documenti non gli arrivano: non mi
sembra così improbabile che l’eventualità di presentarsi a Di Pietro senza quei
documenti e di uscire dagli uffici della Procura di Milano in manette possa
avere indotto un uomo come Gardini a quella tragica decisione. Io sono convinto
che adesso, dopo 15, 20 anni di devastazione dell’immagine pubblica, se un
politico o un manager venisse portato via in manette dall’ufficio di un
magistrato non si suiciderebbe, almeno questa è la mia convinzione. All’epoca
invece era un brutto colpo da un punto di vista psicologico per uno come
Gardini, cioè un imprenditore che si è costruito un’immagine da vincente.
Comprendo benissimo che chi gli era vicino faccia fatica a credere al suo
suicidio, ma a me non sembra così improbabile”.
Torniamo a Ravenna: cos’hanno veramente rappresentato gli anni di Gardini per la
nostra città? E che cosa è rimasto?
“Secondo me hanno rappresentato un momento di grande euforia collettiva: è stato
un po’ come vincere i mondiali di calcio. Ravenna in realtà non è cambiata
rispetto a com’era in quegli anni. La presenza di Gardini e la sua morte hanno
funzionato dagli anni Novanta in poi come una sorta di giustificazione per
un’inerzia che è tale da sempre. L’imprenditoria privata c’è a Ravenna: si vede?
Ha mai avuto un ruolo pubblico, è stata in grado di uscire fuori dal piccolo
recinto della provincia? Il periodo d’oro di Gardini è stata una parentesi e poi
dopo ha funzionato in negativo. Il ricordo nostalgico di Gardini, di quegli anni
di grandeur, alla fine è stato un male per Ravenna perché ha giustificato il
fatto che si può rimanere così, nell’aurea mediocritas. Uscire dalla mediocrità
significa mettersi di fronte a rischi che non vuoi correre, oppure esci dai
confini territoriali come ha fatto la Cmc. Se vuoi essere un grande player devi
trasformarti in un grosso soggetto globale. Ma siamo un territorio che non ha
una grande tradizione industriale. Cosa è rimasto di Gardini a Ravenna? Del
rimpianto, certo, ma dopo 25 anni sarebbe il caso di andare oltre questo
rimpianto”. A cura di Roberta Emiliani
Il Moro di Venezia: la barca più amata dagli italiani.
Vi abbiamo chiesto di indicarci in un sondaggio online quale fosse per voi la
barca mito della storia della vela: non avete avuto dubbi. Il Moro di Venezia, a
25 anni dalle sue imprese, scalda ancora gli animi. Vi raccontiamo, con l'aiuto
di due "moristi" di eccezione (Dudi Coletti e Max Procopio) di come il sogno del
“Comandante” Raul Gardini divenne quello di un paese intero: e di come nei bar,
nel 1992, si parlasse di bompressi invece che di calcio, scrive il 21 ottobre
2017 La Redazione di "giornaledellavela.com". Non avete avuto dubbi. Non c’è
Azzurra né Luna Rossa che tenga. Il Moro di Venezia, a 25 anni dalla storica
vittoria della Louis Vuitton Cup di San Diego e dalla finalissima di Coppa
contro America3, è la barca che vi suscita le emozioni più grandi. E che avete
eletto come “più mitica di tutte” nel sondaggio che vi abbiamo proposto sul
nostro sito. Mentiremmo se dicessimo che il risultato ci ha sorpresi. La saga
del Moro è ancora vivissima nel nostro cuore. Grazie a Raul Gardini,
l’imprenditore romagnolo il cui sogno (quello di strappare la “vecchia brocca”
agli americani) divenne quello di tutti gli italiani. Che si scoprirono
all’improvviso velisti, che mandarono i propri figli alle scuole di vela, che
sostituirono nei loro discorsi da bar gol e traversoni con bompressi e
strambate. Grazie al gruppo affiatato e competente che il Comandante (uno dei
soprannomi affibbiati al tycoon ravennate) seppe creare e che, al giorno d’oggi,
influenza la vela mondiale in ogni sua branca: velai (Guido Cavalazzi, Davide
Innocenti), progettisti e tecnici (German Frers, Claudio Maletto, Roberto
Biscontini, Giovanni Belgrano solo per citarne alcuni), regatanti (Paul Cayard,
Andrea Mura, Cico Rapetti, Lorenzo Mazza, Tommaso Chieffi), dirigenti (Enrico
Chieffi, Marco Cornacchia), professionisti del mare (Max Procopio, Dudi
Coletti). Grazie alle barche gloriose che portano questo nome sulla poppa, otto
per la precisione (tre maxi e cinque IACC – International America’s Cup Class),
che ancora oggi navigano sparse per i mari del mondo. “Al giorno d’oggi i miti
rimangono in piedi per poco tempo, fagocitati dal turbine del web e dei social”,
ci ha raccontato Max Procopio, che sul Moro fu imbarcato come grinder, “allora
non fu così. Il Moro di Venezia rimase nell’immaginario collettivo a lungo, come
a lungo restò sulle pagine dei giornali, italiani ed esteri”. Il contesto
storico era propizio: la prosperità, i soldi che giravano, la convinzione che
l’Italia fosse la “settima potenza” del mondo. E un uomo che incarnava lo
spirito dei tempi, Raul Gardini, visionario e abituato a rischiare. Come a
livello imprenditoriale (si distinse per uno “stile” fatto di colpi di genio,
acquisizioni, monopoli, che trasformarono il gruppo agricolo di Serafino
Ferruzzi, suo genero, in un impero industriale, la Montedison), così nella vela.
“Quando parlavi con lui”, rivela Procopio, “tutto ti sembrava semplice, anche la
più impossibile delle imprese”. Era un buon velista, il ravennate: dalle prime
piccole derive in gioventù era passato ai Finn, poi all’altura su barche
progettate da Dick Carter: l’11 metri Blu Optimist, l’Orca43, di 13 metri e
mezzo, con cui vinse il Campionato del Mediterraneo 1971, il 15 metri Naif in
lamellare con cui prese parte all’Admiral’s Cup del 1973. Poi l’incontro con
Frers, all’epoca assistente dello studio Sparkman & Stephens, che seguì la
progettazione del primo maxi in legno lamellare che avrebbe portato quel nome
mitico, il Moro di Venezia: era il regalo di Serafino a lui e al cognato Arturo
Ferruzzi per i loro risultati a livello imprenditoriale. Era il 1975. La grande
saga del Moro era appena iniziata. Dopo la morte di Serafino Ferruzzi, per un
incidente aereo, nel 1979, gli eredi affidarono a Gardini il futuro dell’azienda
e il Comandante iniziò la sua ascesa. Intanto, nel 1983, un altro Maxi
affiancava il gioiello di Frers, Il Moro di Venezia II. Proprio nell’anno in cui
l’Avvocato Agnelli aveva fatto il grande passo, promuovendo la prima sfida
italiana di Coppa America, Azzurra, che giunse alle semifinali della Louis
Vuitton e fece conoscere la vela nel nostro paese. Non possiamo sapere con
precisione quando si accese il “lumino” nella testa di Gardini, ma sicuramente
un momento chiave è il 1984, quando la figlia Eleonora, in vacanza a Porto
Cervo, assiste alla Sardinia Cup e all’impresa di un giovane americano, Paul
Cayard, che arrivato in fretta e furia per sostituire al timone Lorenzo
Bortolotti su Nitissima, 50 piedi di Nello Mazzaferro, stravince la regata.
Gardini volle conoscerlo per testarne il talento, l’occasione fu a Palma di
Maiorca in regata sul Moro di Venezia II. Si piacquero: dal 1984 al 1992, Cayard
fu a bordo di quasi tutte le barche di Gardini, il quale non ebbe dubbi quando
si trattò di scegliere lo skipper per la campagna di Coppa. Paul Pierre Cayard,
classe 1959, da San Francisco. Ottimo helmsman, starista di livello, ma
soprattutto forte di un talento gestionale che spingerà Gardini a
commissionargli anche il difficilissimo incarico di general manager
dell’operazione. Ma il problema della nazionalità? Secondo il Deed of Gift, il
regolamento della Coppa, la barca avrebbe dovuto timonarla un italiano. Per
Gardini, abbiamo detto, nulla era impossibile: Cayard, dopo aver firmato un
contratto da 200 milioni di lire l’anno (“guadagno come un giocatore medio di
NBA, confessò all’equipaggio una volta”, racconta Procopio) prese la residenza a
Milano. Adesso bisognava occuparsi delle barche e del team, dopo che nel
novembre del 1988 la sfida, sottoscritta dalla Compagnia della Vela di Venezia,
era stata consegnata a San Diego. Per le prime, con un’operazione da cinquanta
miliardi, venne fondato a Marghera, davanti ai capannoni Montedison il cantiere
Tencara, in cui confluirono le aziende della holding capitanata da Gardini con
il loro know-how. Un polo di eccellenza tecnologica, che avrebbe fatto capire
agli americani e al mondo intero che l’Italia non era soltanto il paese di
pizza, spaghetti e mandolino. Le selezioni dell’equipaggio furono dure: “La
filosofia di Raul, riguardo all’equipaggio”, spiega Procopio, “era quella di
creare un gruppo di persone solido, senza che ci fossero troppi ‘galli nel
pollaio’. Le selezioni del team partirono a Venezia a bordo dei Maxi di Gardini
nel 1989-90: Cayard si fece aiutare dai fratelli Chieffi. Era una vita dura,
fatta di sacrifici: molti gettarono la spugna”. Intanto, con una cerimonia
sontuosa nel cuore di Venezia, a marzo del 1990 venne varato il primo Moro di
Venezia IACC e iniziarono i test. L’entourage si spostò a giugno a Puerto
Portals, a Palma di Maiorca, dove le condizioni meteo avrebbero dovuto
rispecchiare meglio quelle di San Diego. Ad agosto arrivò anche Il Moro di
Venezia II, mentre il 19 dicembre del 1990 la base operativa si spostò a San
Diego. Dove ad aprile del ’91 arrivò anche Il Moro di Venezia III, fresco di
varo, con cui il team vinse a maggio il Campionato del Mondo classe Coppa
America. A giugno fu la volta del Moro IV, utilizzato solo come barca prova,
mentre a dicembre toccò l’acqua Il Moro V (ITA-25), la barca più competitiva con
cui il sindacato di Gardini avrebbe preso parte alla Louis Vuitton Cup.
“Vivevamo in un clima di spionaggio costante a San Diego: gli elicotteri
solcavano i cieli per fotografare dall’alto le barche degli avversari. Io ero
anche addetto alla camera oscura perché mi dilettavo di fotografia, passavo le
notti a sviluppare le foto di Carlo Borlenghi, ingaggiato come “spia” oltre che
come fotografo”, ricorda Procopio. E mentre Il Moro conquistava i Round Robin
(le fasi eliminatorie della regata), si capì che lo spionaggio serviva.
Soprattutto nella finale di Louis Vuitton contro Team New Zealand di Rod Davis e
Michael Fay: Il Moro era sotto di 3-1 ma grazie alle foto di Borlenghi si riuscì
a dimostrare che i neozelandesi stavano utilizzando il bompresso come punto di
mura del gennaker, una soluzione non consentita dal regolamento. Il loro quarto
punto venne annullato, i kiwi accusarono il colpo e i ragazzi di Gardini
conquistarono la Louis Vuitton vincendo 5-3. Quella che andò in scena dal 9 al
16 maggio del 1992, probabilmente, è la parte più nota della storia. Da un lato
Il Moro di Venezia V, che in patria aveva risvegliato la voglia di vela
italiana, grazie anche alle dirette di Telemontecarlo e ai commenti di
Cino Ricci. Dall’altro il miliardario Bill Koch e Buddy Melges, a bordo di
quello squalo bianco chiamato America3. Una barca più brutta del Moro, ma più
veloce: “Siamo arrivati in finale carichi di speranza”, ricorda Dudi Coletti,
all’epoca trimmer, “ma abbiamo visto fin da subito che non ci sarebbe stata
storia: loro avevano più passo, la barca con aria leggera era più performante,
anche perché il regolamento permetteva loro di cambiare le appendici a seconda
del vento che avrebbero incontrato. Anche quando vincemmo l’unica prova, quella
del momentaneo 1-1, lo facemmo a gomitate, per 3 secondi soltanto, grazie
all’intuizione di Cayard di mollare lo spi e lasciarlo cadere in avanti
all’arrivo”. Quattro a uno. Gardini aveva perso, ma riuscì, da grande
comunicatore, a tramutare la sconfitta in vittoria. In Italia, al rientro,
organizzò una festa a Ravenna, poi a Venezia, dove l’equipaggio, a bordo dei
Maxi di Gardini, venne osannato dalla città intera. Era nato il mito del Moro di
Venezia. Sopravvive ancora oggi.
Che fine hanno fatto i ragazzi del Moro di Venezia?
Scrive il 15 luglio 2018 La Redazione di "giornaledellavela.com". Vi abbiamo
raccontato la storia del Moro di Venezia, la barca più amata dagli italiani il
cui mito sopravvive ancora oggi. Grazie al gruppo affiatato e competente
che Raul Gardini seppe creare e che, al giorno d’oggi, influenza la vela
mondiale in ogni sua branca: velai (Guido Cavalazzi, Davide Innocenti),
progettisti e tecnici (German Frers, Claudio Maletto, Roberto Biscontini,
Giovanni Belgrano solo per citarne alcuni), regatanti (Paul Cayard, Andrea Mura,
Cico Rapetti, Lorenzo Mazza, Tommaso Chieffi), dirigenti (Enrico Chieffi, Marco
Cornacchia), professionisti del mare (Max Procopio, Dudi Coletti). Qua sotto vi
raccontiamo cosa stanno combinando, oggi, alcuni dei “ragazzi del Moro”.
COSA COMBINANO DIECI RAGAZZI DEL MORO AL GIORNO D’OGGI
Cico Rapetti. L’uomo dell’albero Francesco Rapetti continua a regatare ad
altissimi livelli sui Maxi: è stato il primo italiano a vincere la Coppa con
Alinghi (nel 2003, oltre che nel 2007) ed era a bordo di Luna Rossa nel
1999-2000.
Tommaso Chieffi. Con 27 titoli iridati vinti è uno dei velisti più forti al
mondo. Dopo l’esperienza del Moro come stratega, in Coppa è stato su Oracle nel
2003, su +39 per un breve periodo nel 2005 e su Shosholoza nel 2007. Nel
2005-06, ha vinto la Volvo Ocean Race con Abn Amro I. Ora è l’uomo chiave su My
Song, il maxi di Pigi Loro Piana.
Max Procopio. Max Procopio, grinder del genoa sul Moro, ha imparato il suo
mestiere attuale proprio durante la sua esperienza nel gruppo di Gardini: ora è
uno stimato professionista della comunicazione e con la sua Marine Partners ha
clienti in tutto il mondo: team sportivi, produttori, porti ed eventi nautici.
Dudi Coletti. Duilio Coletti (per gli amici Dudi), dopo l’esperienza del Moro
(in qualità di trimmer), ha deciso di aprire una scuola di vela a Riva di
Traiano (Sailing Roma) dove in tantissimi sono passati diventando grandi velisti
e appassionati di mare. Per 12 anni è stato poi al comando di barche da 24 a 30
metri, organizzando viaggi e crociere in tutto il mondo. Adesso ritornerà a
dirigere la scuola di vela.
Claudio Maletto. Claudio Maletto, dopo l’esordio in Coppa con il team del Moro,
ha continuato a progettare barche di successo da regata e crociera (Grand
Soleil). Ha firmato con Peterson lo scafo di Luna Rossa del 2000, il “silver
bullet” che ci fece sognare vincendo la Louis Vuitton.
Paul Cayard. Di recente lo abbiamo intervistato mentre era imbarcato sul J70
italiano Calvi Network: Cayard, reso celebre da Gardini, dopo il Moro ha
continuato a regatare ai massimi livelli, sia in altura che in Coppa (nel ’95 al
timone di Star & Stripes, nel 2000 di America One). Quando può, balza a bordo
della Star, la sua barca preferita.
Guido Cavalazzi. Dopo aver disegnato le vele per Il Moro (le prime della storia
in carbonio!), Cavalazzi venne assunto dagli americani nel 1995 (Young America),
poi ingaggiato da Bertelli, con Luna Rossa, dal 2000 al 2007. Vanta, in qualità
di velaio North Sails, svariati titoli mondiali e una Admiral’s Cup. Ora si
occupa di vele d’epoca.
Andrea Mura. Il randista del Moro è al giorno d’oggi uno dei velisti oceanici
più famosi di Italia: dopo la Coppa del 1992 fu assorbito dalla sua attività di
velaio, poi scoprì la navigazione in solitario. Dal 2007, sul suo Open 50 Vento
di Sardegna, se ne è tolte di soddisfazioni, vincendo Route du Rhum,
Quebec-Saint Malo, Twostar e due Ostar in tempo reale.
Enrico Chieffi. Quattro anni dopo la sua esperienza di tattico e navigatore sul
Moro, il fratello di Tommaso ha vinto il mondiale Star e ha partecipato alle
Olimpiadi di Atlanta. Adesso è vice presidente del prestigioso cantiere Nautor’s
Swan.
Giovanni Belgrano. Belgrano è uno degli ingegneri strutturisti nautici più
quotati al mondo: dopo l’esperienza sul Moro nel gruppo di progettazione, è
stato con Luna Rossa nella campagna del 2000. Contattato dai kiwi, si è
trasferito ad Auckland con la famiglia per mettersi al servizio di Team New
Zealand.
Gherardo Colombo: “La fine di Gardini aprì gli occhi di tutti sul
sistema tangenti”. L'ex magistrato di Mani Pulite, a
25 anni dalla morte del manager, racconta: “Tanti non ricordano più eppure la
conoscenza è la base della democrazia”, scrive Piero Colaprico su "La
Repubblica" il 22 luglio 2018. Dottor Gherardo Colombo, 25 anni fa è un quarto
di secolo, ma sembra un'era geologica, visti i cambiamenti successivi. Il 23
luglio 1993 Raul Gardini, il Pirata, uno degli uomini più ricchi d'Europa, si
spara e un titolo di giornale è "L'Enimont uccide ancora". Ricorda quella
mattina? "Ricordo, anche se si tratta di eventi così traumatici che non sempre
la memoria li registra appieno. Il peso di tragedie simili in qualche misura ti
induc..
Estratto dell’articolo di Piero Colaprico per "la Repubblica".
Dottor Gherardo Colombo, 25 anni fa è un quarto di secolo, ma sembra un'era
geologica, visti i cambiamenti successivi. Il 23 luglio 1993 Raul Gardini, il
Pirata, uno degli uomini più ricchi d' Europa, si spara e un titolo di giornale
è "L' Enimont uccide ancora". Ricorda quella mattina?
«(…) Raul Gardini aveva dormito a casa sua, in via Belgioioso, era libero ed era
previsto per la mattina che Antonio Di Pietro lo interrogasse. Quando ci arriva
la notizia del suicidio, ci troviamo tutti noi del pool Mani Pulite nell'
ufficio o di Borrelli, o di D' Ambrosio, non ricordo. Erano passati pochi giorni
da quando ero andato a San Vittore, in cella, dov' era stato trovato morto
Gabriele Cagliari, la figura di riferimento dell'Eni. (…) Erano giorni davvero
tragici e drammatici, ed anche preoccupanti: un paio di mesi prima era scoppiata
una bomba a Firenze, il 27 luglio sarebbe esplosa l'autobomba di Cosa Nostra in
via Palestro, cinque persone uccise sia nel primo che nel secondo attentato. Ero
in questa stanza, quando ho sentito il fragore dell'esplosione».
Il giorno della morte di Gardini, noi cronisti vediamo Di Pietro camminare a
testa bassa e lei che dice: "Guardateli a vista, avete capito, a vista". Dopo
capimmo che si riferiva agli altri arrestati, a Carlo Sama, il cognato di
Gardini, o al finanziere Sergio Cusani.
«Recentemente Sergio Cusani ed io siamo stati invitati a parlare di Tangentopoli
in una scuola, e Sergio ha ricordato che aveva delle difficoltà a sottrarsi alla
vista degli agenti anche quando andava in bagno, gli dicevano: "Ci spiace, il
dottor Colombo ha ordinato così". Raggiunsero poi un compromesso, e Cusani
ottenne un minimo di riservatezza».
E che cosa temevate?
«Temevamo che qualcun altro facesse lo stesso. Era insopportabile il senso di
vuoto che questi eventi lasciavano. E ti veniva da pensare ai familiari, al loro
dolore. Cercavi di prevenire. Io, nello stesso tempo, ero invaso dagli
interrogativi sul perché di quei gesti».
Nell' obitorio di Lambrate si trovarono le due salme, di Cagliari per la
cremazione e di Gardini per andare a Ravenna, una accanto all' altra. In quei
giorni Giorgio Bocca scriveva: "Suonano le campane a morto per i ladri e i
corrotti della prima Repubblica".
«Era emerso con chiarezza il sistema della corruzione. Ovunque ti girassi,
trovavi tangenti: per la metropolitana, gli autobus, le strade, i tram, la
Malpensa. Quando l'anno prima m' ero occupato dell'Ipab, avevo scoperto che in
quel consiglio d' amministrazione tutti, messi lì dai partiti, prendevano soldi.
Erano esclusi solo quelli di Democrazia proletaria e del Movimento sociale, non
so se per questioni morali o perché non contavano nulla. Ad alti livelli la
corruzione era un vero e proprio sistema anche perché era connessa rigorosamente
con il finanziamento illecito ai partiti; intendo dire che i soldi della
corruzione finivano per buona parte nelle casse dei partiti. Sono state
coinvolte nelle indagini tutte le imprese di primaria importanza e i vertici dei
partiti. Quel che abbiamo scoperto è, o meglio era, sotto gli occhi di tutti».
Era in che senso?
«Oggi in tanti non ricordano molto, e in tanti non sono in grado di ricordare,
perché non c' erano ancora e nessuno ha raccontato loro quel che avvenne; o
meglio molti hanno scritto di quel che avvenne, ma chi ha la responsabilità di
tramandare una memoria storica, anche nel contesto istituzionale, raramente lo
fa. Del resto succede così un po' per tutto, cambiano le generazioni e si perde
il passato. Mi è capitato di parlare in licei in cui i ragazzi attribuiscono la
strage di Piazza Fontana alle Brigate Rosse, oppure ignorano completamente la
strage di Brescia a Piazza della Loggia». (…)
Beh, abbiamo fatto un'inchiesta tra gli universitari di Milano, tra Statale e
Cattolica era una risicata minoranza a conoscere la parola "Tangentopoli".
«(…) Dopo tredici anni di indagini e processi sulla corruzione - tanto è durata
Mani Pulite - e dopo due anni come giudice in Cassazione, nel 2007 mi sono
dimesso, perché sono convinto che se si vuol contribuire a far sì che le regole
vengano osservate è necessario occuparsi di educazione. Bisogna andare nelle
scuole per comprendere insieme il senso delle regole che, come le nostre, si
basano sulla messa al bando della discriminazione, perché a ciascuno di noi - e
quindi anche a lei e a me - siano garantite opportunità pari a quelle degli
altri. Senso delle regole che, per tornare al tema della corruzione, dovrebbe
indicare il modo di interpretare la funzione pubblica. Non per interesse
individuale o di parte, ma per l'interesse di tutti».
SUICIDI E LACRIME SU MANI PULITE,
scrive Bernardo Valli l'1 agosto 1993 su "La Repubblica". Le lacrime dei
pubblici ministeri sono rare. Quelle di Francesco Greco, la mattina di venerdì
ventitré luglio, erano nascoste dietro occhiali scuri, ma secondo i cronisti non
c' erano dubbi: il pm Greco piangeva. Anche il pm Di Pietro era sconvolto. Al
punto che deambulava nel corridoio della procura strisciando una spalla contro
il muro, quasi avesse perduto l'equilibrio. Gherardo Colombo, il pm
intellettuale, era stordito, non tanto però da dimenticare gli indagati
dell'Enimont: diceva a un ufficiale della Finanza di guardarli a vista, di non
perderli d' occhio. Potevano infatti svignarsela, nel dramma provocato dal
suicidio di Raul Gardini. Gardini si era appena sparato alla tempia in Palazzo
Belgioioso. Settantadue ore prima, a San Vittore, Gabriele Cagliari aveva
infilato la testa in un sacchetto di plastica. Recupero queste immagini della
cronaca recente perché compongono il ritratto della procura milanese in un
momento cruciale. Quel ventitré luglio, prima delle dieci, i pubblici ministeri
di Mani Pulite sono sotto il trauma della morte voluta di Gardini, aggiuntasi a
quella di Cagliari come una seconda mazzata. In quella prima mattina si tocca il
punto in cui le emozioni possono cambiare il corso delle vicende umane: possono
frenarle, deviarle, o addirittura farle arretrare. E' insomma un momento di
verità. Alle dieci, quando al Policlinico di viale Francesco Sforza Raul Gardini
è già cadavere da più di mezz' ora, i pubblici ministeri in preda a lacrime e
tormenti entrano nell' ampio ufficio del procuratore capo Borrelli. Ne escono
pochi minuti dopo e i cronisti notano che Di Pietro ha ripreso l'andatura
normale e che il pianto non contrae più la faccia di Greco. L' inchiesta
continua, senza ritardi, gli arresti decisi prima del suicidio di Gardini sono
mantenuti, saranno eseguiti di lì a poco, nell'ambito della stessa famiglia
Ferruzzi in lutto. Greco e Di Pietro, rinfrancati, raggiungono il luogo del
suicidio in piazza Belgioioso per le indagini d' uso. Un napoletano che non
esagera nei gesti Non che prima i toni fossero da commedia leggera, ci sono
stati altri suicidi e altri atti di terrorismo, ma con i fatti di fine luglio i
colori di Mani Pulite diventano da tragedia. Mentre le tinte si incupiscono e le
emozioni possono appunto piegare, diluire sia pure per un attimo l'azione della
giustizia, le schiene dei pubblici ministeri si raddrizzano e i loro occhi si
asciugano subito nell' ufficio del procuratore capo Borrelli. Semmai affiorano
indugi, Borrelli li tronca. Anche una semplice esitazione in quel momento
risulterebbe un cedimento. Un ripensamento discrezionale. Dunque, niente pausa
di lutto. Non penso proprio che in quel giorno di emozioni lo sguardo di
Francesco Saverio Borrelli si sia inumidito o che lui abbia barcollato sotto
l'impatto di quei suicidi. Ignoro i suoi sentimenti, quelli intimi che gli
appartengono, non so quanto sia duro o tenero il suo cuore: nella forma il
procuratore è un napoletano che certo non esagera nei gesti. La mattina del
ventitré è stato temperato anche nelle parole. Quelle che ha pronunciato in
pubblico erano essenziali per la sua funzione e al tempo stesso non prive di
attenzione per i morti. Riassumevano il personaggio: "... anche per il rispetto
dovuto alla scelta di chi ha voluto rinunciare alla vita è nostro dovere...
percorrere con la massima celerità la via che porterà al chiarimento totale...".
E con la massima celerità, senza intervalli emotivi, discrezionali, sono
scattati gli arresti e sono proseguiti gli interrogatori, gli uni e gli altri
tendenti ad illuminare l'affare Enimont, segnato da un "triplice marchio di
morte". In quest' ultima lapidaria espressione il procuratore ha incluso i tre
suicidi (compreso quello incerto di Castellari). Nel dramma un testimone
sensibile alla storia patria poteva rilevare comportamenti non frequenti nella
vita nazionale: i magistrati e per la verità anche gli indagati, accusatori e
accusati, per dovere o per orgoglio o per disperazione, hanno svolto in quei
giorni i loro ruoli sino in fondo: come in una società che fa sul serio: in cui
si paga con la vita e non si sfugge alle responsabilità. La tragedia ha invaso
la commedia dell'arte. Una tragedia con i volti dei protagonisti scoperti. Le
stragi senza le facce degli assassini, le auto-bomba, rientrano nell' altra
nostra lunga storia di viltà. In un diverso e ignobile album di famiglia. Ho
incontrato Borrelli nel vasto ufficio al palazzo di giustizia: luogo da cui
esercita un potere senza precedenti per un magistrato. E forse senza pari oggi
nel paese, se non altro per le conseguenze delle sue iniziative giudiziarie. La
contenuta cortesia del procuratore è stata più volta illustrata. La sua immagine
la riflette abbastanza bene. Le descrizioni sono ormai superflue. Borrelli ha
senz' altro fatto la tara degli elogi che gli vengono indirizzati. Lo spero.
Sfogliando gli scritti che gli sono stati dedicati negli ultimi mesi ho trovato
piaggerie tali da far arrossire un uomo di vistosa presunzione. Raggiungono o
addirittura superano le adulazioni un tempo rivolte a Bettino Craxi, l' ex
padrone di Milano al quale lui, Borrelli, ha fatto recapitare un elevato numero
di avvisi di garanzia. Se quelle lusinghe gli dessero alla testa sarebbe un bel
guaio con tutta l'autorità che la situazione gli attribuisce. Borrelli dice di
essere timido. Non è sempre una garanzia. La timidezza, quando era giovane
magistrato, l'avrebbe dissuaso dal diventare pubblico ministero. Un pm deve
infatti parlare in pubblico e avere le qualità di un investigatore. Anche molto
più tardi, dopo i cinquant' anni (oggi ne ha sessantatré), ha esitato ad
abbandonare il ruolo di presidente della terza Corte d' Assise quando gli è
stato suggerito di diventare aggiunto nella procura milanese di cui è adesso il
capo. Se non avesse superato le perplessità giovanili forse la cronaca nazionale
non sarebbe la stessa. Un procuratore con un altro temperamento le avrebbe
imposto ritmi differenti. Borrelli non è più un giudice da una decina d' anni,
come non lo è Di Pietro, né lo sono Davigo, Colombo, Dell' Osso, D' Ambrosio e
gli altri sostituti e aggiunti, anche se la gente continua a chiamarli così: i
giudici. Questo confonde le idee. Perché un pm è un'altra cosa. Oltre alla
timidezza, Borrelli aveva davanti a sé - sempre a suo avviso - un secondo
ostacolo che rendeva difficile il passaggio, la conversione al pubblico
ministero. Lui è un uomo di riflessione, di problemi, come è appunto un giudice.
Mentre un pm, un procuratore, è un uomo d' azione. Il primo, il giudice, nella
travagliata attesa di prendere una decisione è immerso nei dubbi. Il secondo, il
pm, deve avere invece una linea precisa e deve perseguirla indipendentemente dai
dubbi: il suo compito è di rafforzare, sostenere, razionalizzare l'impostazione
dell'accusa: lui non è tenuto ad evere la certezza matematica di poter centrare
l'obiettivo. Nel rispetto dei diritti dell'individuo, deve agire col fiuto e il
gusto del rischio tipico del giocatore. Nei cromosomi le tracce di un poliziotto
Ho tracciato questo sommario ritratto del pubblico ministero, magistrato
investigatore, con espressioni rubate a Borrelli. Il quale, perlomeno nell'
aspetto, è rimasto un giudice. Benché nei suoi cromosomi ci siano le tracce di
un bisnonno poliziotto nella Napoli dei Borboni. Bisnonno diventato poi giudice
conciliatore in un comune vesuviano. Da allora nella famiglia non ci sono stati
che magistrati: il nonno, il padre, lui Francesco Saverio, il figlio. Se
sottolineo in lui il giudice, l'uomo più adatto a risolvere problemi che a
svolgere indagini, più riflessivo che intuitivo, non significa che vedo nel suo
esatto opposto, in Porfirij Petrovic, il tipico magistrato investigatore.
Porfirij Petrovic è il pm (Dostoevskij dice giudice istruttore, ma io lo vedo
come il nostro pm) che interroga Raskolnikov in Delitto e Castigo: è grassoccio
e rotondetto. E parla sempre, parla, parla, un fiume di parole, e strizza gli
occhi umidi e ammicca, cerca di stabilire una losca quasi oscena complicità con
l'indagato, con la vittima, per poi incastrarlo. Il vizio impenitente di
estrarre dai romanzi personaggi celebri e di affiancarli a quelli della realtà a
volte serve. Altre è fastidioso. I pm della squadra Borrelli hanno ben poco in
comune con Porfirij Petrovic. Al quale il suo creatore dà toni grotteschi,
perché così vuole rappresentare il principio intellettuale e investigativo della
mente umana. Mentre il tono tragico spetta al delitto. La realtà milanese
corrisponde a un'altra morale. Ci ritorno. Mi trovavo nell' ufficio di
Piercamillo Davigo, uno dei sostituti, quando è entrato Antonio Di Pietro. Per
riflesso ho pensato al titolo di una sua biografia, a un libro delle edizioni
paoline: "Il giudice terremoto - l'uomo della speranza": in cui si racconta di
suo nonno Giovannino e di sua nonna Pazienza, ed anche della masseria molisana
natale, della stalla, delle mucche, delle pecore, del seminario e di Elsa il
primo amore. Evoco dentro di me quel libro delle edizioni paoline senza ironia,
mentre stringo rapidamente la sua mano, larga come un badile. Poi lui si
allontana nel corridoio della procura. Penso alla biografia di Di Pietro come a
un pozzo di energie, a una miniera di elementi naturali che si trovano in
profondità, dopo tanti strati di antichi e sofisticati vizi e virtù. Una forza
che si è affinata, affiancando umanità, esperienza, computer e passione del
segugio. Lanciata in una situazione politica senza intralci, come in una
prateria senza steccati, quella forza composita dà un pubblico ministero di
intuizioni fulminanti. Così le definisce Borrelli. L' apparente semplicità del
personaggio contribuisce a renderlo popolare. Il simbolo di una società stanca,
in questo momento, delle proprie ambiguità. Perlomeno di quelle dei potenti
decaduti. Le lettere dal carcere di Cagliari Le lettere dal carcere di Cagliari
non possono essere dimenticate, conducono ad alcune considerazioni. E' senz'
altro negativo, troppo vecchio stile, il pm minaccioso. Quello che cerca o
cercava di spaventare l'indagato. Meglio quello che sa mettere a suo agio
l'interlocutore. Ma un eccessivo coinvolgimento del pm presenta dei rischi: può
trascinare l'accusato pentito a dire quel che pensa che il magistrato si aspetta
da lui; e il magistrato a credere tutto quel che gli viene detto. Un rapporto
passionale come può accadere tra il confessore e il penitente. Un rapporto
angoscioso, su cui pesa il dosaggio del carcere preventivo, su cui può giocare
il pm, sia pure sotto il controllo del gip, il giudice delle indagini
preliminari. Di Pietro crede nel rito cattolico della confessione e rifiuta con
veemenza di essere preso per un prete che suscita tormenti nell' anima del
peccatore indagato. Ricavo queste sue reazioni da frasi pronunciate in seguito a
uno dei primi suicidi di Tangentopoli, che lo sconvolse. Quello dell'anziano
socialista di Lodi Renato Amorese. L' eccesso di zelo di un pm non è comunque
poi tanto raro, e si carica facilmente di veleni psicologici. Il suicidio di
Cagliari ne è un esempio. Piercamillo Davigo è un quarantenne. Pensa che nella
classificazione medievale clero-mercante-soldato il magistrato corrisponderebbe
al primo, al clero. In quella induista sarebbe il bramino-filosofo. Il sostituto
Davigo si considera, lui, un sacerdote? La sua affermazione non va interpretata
in questo modo: in quella gerarchia platonica il magistrato in sostanza non è il
denaro e neppure le armi. Davigo è un lombardo - piemontese. In politica mi
dicono sia un liberale. Nel senso liberal. Non ha lo spirito dell'inquisitore.
Ha piuttosto uno spiccato senso logico che innestato sulle intuizioni
dell'investigatore dà filo da torcere a indagati e difensori. Davigo mi sembra
in egual misura sofisticato e passionale. Ha lavorato con Alessandrini e con
Galli, uccisi dai terroristi. Se li ricorda, ricorda che sono morti per
garantire la continuità dello Stato, dello Stato corpo delle leggi. Non c' è
paese in cui lo Stato venga interpellato polemicamente con tanta frequenza: cosa
fa lo Stato? dov' è? cosa vuole? perché non funziona? ma esiste? perché ci
svena? è cieco, vuoto, inerte, esoso, disattento, ingiusto, freddo,
necessario... Anche questa procura milanese è una faccia dello Stato. Lo è più
che mai. E' parte essenziale di una delle sue rare istituzioni che funzionano.
Anzi, l'unica, per questo è quasi onnipotente. E i pm Di Pietro e Davigo ne sono
due volti. Un altro è Pierluigi Dell' Osso. Dell'Osso fa parte della procura
milanese ed anche della superprocura nazionale. Era pubblico ministero al
processo per la bancarotta dell'Ambrosiano. Quando sono uscito dal suo ufficio
era da tempo passata l'ora di cena e un uomo della sua scorta mi ha guidato,
come in un labirinto, verso la sola uscita dal palazzo di giustizia ancora
aperta. Dell' Osso è rimasto a lavorare nella stanza dove fa spicco una croce.
Più come decorazione, mi è sembrato, che come segno religioso. Oppure ha le due
funzioni. A differenza di un giudice civile, al quale si chiede una grande
umiltà, un pm remissivo non rende. Va rispettato il suo carattere. Vanno
stimolati e al tempo stesso disciplinati i suoi slanci. Borrelli si comporta
così con aggiunti e sostituti. Gerardo D' Ambrosio è descritto come un
investigatore nato. Ha condotto l'indagine sulla strage di piazza Fontana e
sulla morte di Pinelli. E' uno dei pilastri portanti della procura. Gherardo
Colombo si considera un notaio della giustizia. L'ha perlomeno detto a dei
colleghi francesi lasciandoli scettici. Con quei magistrati d' oltralpe, durante
una tavola rotonda, Colombo ha affrontato un argomento chiave e controverso:
l'obbligo costituzionale dell'azione penale che condurrebbe per mano i
magistrati italiani, rendendoli immuni dai condizionamenti politici e sociali.
Come mai allora Mani Pulite è stata più una conseguenza che la causa di un dato
momento politico? C' è sempre qualcosa di politico nell' esercizio della
giurisdizione, anche se non ci sono intenzioni politiche. Borrelli è il
difensore e l'allenatore della squadra dei pm milanesi. Li protegge, li stimola,
coordina il loro lavoro. E poiché quei pubblici ministeri conducono inchieste da
cui dipende in buona parte l'immediato avvenire del paese, la sua autorità è
rilevante. Quel 23 luglio, nel suo ufficio, davanti ai pm in preda a lacrime e
tormenti ha dato ancora una volta prova della sua influenza e della sua
determinazione. Nella sua procura sono allineate centinaia di confessioni fatte
alla presenza di avvocati, quindi incontestabili domani, durante i processi: e
in quelle deposizioni c' è la storia del vecchio regime. Francesco Saverio
Borrelli ha nelle mani il destino di una buona parte della classe politica ed
economica italiana. Insomma quel signore di contenuta cortesia è destinato a
pesare nella storia patria. Col suo garbo non dimentica di ricordare che lui
rappresenta la pars destruens. Ad altri di essere la pars construens. I pubblici
ministeri non hanno il compito di rifare una società. Lui lo sa come magistrato
che ha conservato il carattere del giudice, personaggio immerso nei problemi,
nei dubbi, e non trincerato nelle certezze dell'investigatore che possono essere
effimere. Una nazione con tante culture Tiro le somme del viaggio. L' ho
cominciato nel profondo Sud e ad ogni tappa ho trovato la conferma di quanto il
paese sia più un continente che una nazione. Nel senso che vi convivono tante
culture. Ed è nell' ambito di queste diverse culture che avviene la rivoluzione
legale. Là, in Sicilia, cerca di gettare le basi reali di uno Stato sinora
rimasto formale; altrove, in Calabria, tenta di far rispettare la legge in un
far west mediterraneo; a Napoli si sforza di stabilire le regole indispensabili
in una metropoli civile; e qui, nel Nord, ha avviato un' operazione affinché l'
economia di mercato non sia gestita da politici e industriali con criteri
mafiosi, in definitiva affinché il capitalismo sia animato attraverso il gioco
della libera concorrenza e non con la corruzione e la concussione. La società
civile, un po' per codardia un po' per saggezza, un po' perché non c'era nessun
altro, ha affidato ai magistrati la regia di questo aggiornamento democratico
che talvolta assume toni e ritmi da rivoluzione non più tanto soft. Per quel che
ne so è, nella storia, la prima rivoluzione dei pubblici ministeri.
Dopo 20 anni Di Pietro è senza pudore: «Avrei potuto salvarlo».
Mani Pulite riscritta per autoassolversi. L'ex pm: "Avrei dovuto arrestarlo e
lui avrebbe parlato delle mazzette al Pci", scrive Stefano Zurlo, Lunedì
22/07/2013, su "Il Giornale". La ferita brucia ancora. Vent'anni fa Antonio Di
Pietro, allora l'invincibile Napoleone di Mani pulite, si fermò sulla porta di
Botteghe Oscure e il filo delle tangenti rosse si spezzò con i suoi misteri. Per
questo, forse per trovare una spiegazione che in realtà spiega solo in parte,
l'ex pm racconta che il suicidio di Raul Gardini, avvenuto il 23 luglio '93 a
Milano, fu un colpo mortale per quell'indagine. «La sua morte - racconta Di
Pietro ad Aldo Cazzullo in un colloquio pubblicato ieri dal Corriere della Sera
- fu per me un coitus interruptus». Il dipietrese s'imbarbarisce ancora di più
al cospetto di chi non c'è più, ma non è questo il punto. È che l'ormai ex
leader dell'Italia dei Valori si autoassolve a buon mercato e non analizza con
la dovuta brutalità il fallimento di un'inchiesta che andò a sbattere contro
tanti ostacoli. Compresa l'emarginazione del pm Tiziana Parenti, titolare di
quel filone. E non s'infranse solo sulla tragedia di piazza Belgioioso. Di
Pietro, come è nel suo stile, semplifica e fornisce un quadro in cui lui e il
Pool non hanno alcuna responsabilità, diretta o indiretta, per quel fiasco.
Tutto finì invece con quei colpi di pistola: «Quel 23 luglio Gardini avrebbe
dovuto raccontarmi tutto: a chi aveva consegnato il miliardo di lire che aveva
portato a Botteghe Oscure, sede del Pci; chi erano i giornalisti economici
corrotti, oltre a quelli già rivelati da Sama; e chi erano i beneficiari del
grosso della tangente Enimont, messo al sicuro nello Ior». E ancora, a proposito
di quel miliardo su cui tanto si è polemizzato in questi anni, specifica: «Il
suo autista Leo Porcari mi aveva raccontato di averlo lasciato all'ingresso del
quartier generale comunista, ma non aveva saputo dirmi in quale ufficio era
salito, se al secondo o al quarto piano: me lo sarei fatto dire da Gardini». Il
messaggio che arriva è chiaro: lui ha fatto tutto quel che poteva per scoprire i
destinatari di quel contributo illegale, sulla cui esistenza non c'è il minimo
dubbio, ma quel 23 luglio cambiò la storia di Mani pulite e in qualche modo
quella d'Italia e diventa una data spartiacque, come il 25 luglio 43. Vengono i
brividi, ma questa ricostruzione non può essere accettata acriticamente e
dovrebbero essere rivisti gli errori, e le incertezze dell'altrove insuperabile
Pool sulla strada del vecchio Pci. Non si può scaricare su chi non c'è più la
responsabilità di non aver scoperchiato quella Tangentopoli. Di Pietro invece se
la cava così, rammaricandosi solo di non aver fatto ammanettare il signore della
chimica italiana la sera prima, quando i carabinieri lo avvisarono che Gardini
era a casa, in piazza Belgioioso. «M avevo dato la mia parola agli avvocati che
lui sarebbe arrivato in procura con le sue gambe, il mattino dopo». Quello
fatale. «E dissi di lasciar perdere. Se l'avessi fatto arrestare subito sarebbe
ancora qui con noi. Io Gardini lo potevo salvare». La storia non si fa con i se.
E quella delle tangenti rosse è finita prima ancora di cominciare.
LA MAXI TANGENTE ENIMONT. SE CARLO SAMA COMINCIA A PARLARE.
Scrive Cristiano Mais il 15 luglio 2018 su "La Voce delle Voci". Dalle sue
ricche piantagioni in Paraguay, dopo un quarto di secolo racconta le sua verità
sulla madre di tutte le tangenti, Enimont, Carlo Sama, che sposò una delle
figlie, Alessandra, dell’ex imperatore del grano, Serafino Ferruzzi. Una delle
pagine più sconvolgenti di Tangentopoli, per la morte – “suicidio?” – di Raul
Gardini, patròn del gruppo e marito di un’altra rampolla di casa
Ferruzzi, Idina. La mattina stessa che avrebbe dovuto verbalizzare davanti al pm
di ferro, Antonio Di Pietro, preferì spararsi una rivoltellata in testa. Un po’
come fece il capo Eni Gabriele Cagliari, che scelse un sacchetto intorno alla
testa piuttosto che affrontare la gogna giudiziaria. Un paginone del Corriere
della Sera griffato Stefano Lorenzetto, torna su quei buchi neri, su quelle
vicende che ancora ammorbano la storia italiana e rappresentano un’autentica
macchia nella giustizia (sic) di casa nostra. Titolo del pezzo: “Io, mio cognato
Gardini e il colpo di pistola 25 anni fa”. Scrive Lorenzetto: “Il protagonista
del processo Enimont, inchiodato dal pm Antonio Di Pietro per aver pagato ‘la
madre di tutte le tangenti’ e riabilitato di recente dal tribunale di
sorveglianza di Bologna, vive tra Montecarlo e il Sudamerica”. Beato lui.
Novello Hemingway, narra Sama: “Nel bosco mi sono costruito una casa di legno
(progettino firmato Fuksas?, ndr) su un albero a 20 metri da terra, ma confesso
che non ci ho ancora dormito… Ho paura dei giaguari: quelli si arrampicano”. E
quelli di Tangentopoli gli facevano il solletico? Da una rimembranza all’altra.
“Avevamo il monopolio mondiale del propilene. Ma bisognava investire centinaia
di miliardi in ricerca. La Shellera pronta. Avremmo riportato a casa i pozzi
petroliferi in Adriatico. E l’Edison. L’advisor dell’operazione era Romano
Prodi, affiancato da Claudio Costamagna, attuale presidente della Cassa Depositi
e Prestiti”. Arieccoli. “Perchè a 60 anni Gardini si uccise?”, chiede
Lorenzetto. “Non certo per disonore: non aveva fatto nulla. Temeva di finire
come Gabriele Cagliari. 134 giorni nel canile. Quando il presidente dell’Eni si
suicidò in cella, Raul mi telefonò: ‘E’ morto da eroe’. Pensava solo a quello,
all’arresto. Di Pietro lo teneva sulla graticola. Non si lavora una vita per
finire in ginocchio da chi ti accusa”. Nel libro “Corruzione ad Alta Velocità”
firmato vent’anni fa da Ferdinando Imposimato e Sandro Provvisionato, si parla
ovviamente della maxi tangente Enimont e dei protagonisti dell’affaire. Ecco un
paio di stralci. Il primo fa riferimento ad una sigla acchiappa lavori &
tangenti, TPL, un vero e proprio scrigno. “In questo intreccio di mazzette resta
centrale la figura di Francesco Pacini Battaglia, il quale avrebbe reso
possibile la costituzione di fondi neri societari all’estero, nel tentativo di
rendere invisibili i beneficiari di quel denaro. Tutto questo – lo ricordiamo –
lo scopriranno i magistrati di Perugia”. Ecco l’interrogativo clou: “Ma perchè,
pur incappando, cinque anni prima, negli affari sporchi della Tpl, Antonio Di
Pietro, e con lui Gherado Colombo, non erano riusciti a venire a capo di nulla?
Eppure sempre nel 1993, interrogato dai magistrati del pool di Milano, il
finanziere Sergio Cragnotti, all’epoca amministratore delegato di Enimont e buon
amico di Raul Gardini, aveva raccontato di aver ricevuto dalla Tpl 5 miliardi di
lire, soldi poi bonificati da Pacini Battaglia. 2 miliardi – aveva riferito
Cragnotti – li aveva tenuti per sé, 2 erano finiti a Gardini e l’ultimo a Necci
(allora presidente dell’Enimont) e Pacini Battaglia”. Passiamo al secondo
stralcio con le parole di Imposimato, un vero e propro j’accuse: “Sono andato a
rileggere l’elenco dei nomi dei principali imputati del processo Enimont: non
nascondo che un brivido mi ha attraversato la schiena. Alcuni di quegli imputati
come Gabriele Cagliari furono letteralmente torturati psicologicamente e tenuti
in carcere fino alla morte. Per sucidio. Altri, come Raul Gardini, furono
minacciati senza pietà di arresto fino alla morte. Per suicido. Altri ancora – è
il caso di Cragnotti e Pacini Battaglia – il carcere lo hanno visto appena (il
primo) o, almeno a Milano, non l’hanno mai visto (il secondo)”. E’ la giustizia,
bellezze. E non ha caso mai da aggiungere qualcosa di più corposo, da Montecarlo
a dalla capannuccia in Paraguay, l’altro uomo (oltre Francesco Pacini Battaglia)
di tutti i segreti Enimont, Carlo Sama?
Raul Gardini, spuntano le carte segrete.
Le lettere ad Andreotti e a Gabriele Cagliari. La lite con Craxi.
L’agenda riservata. E la prima richiesta d’arresto che avrebbe potuto evitare il
suicidio. Dopo 25 anni, ecco i documenti inediti dell’ex re della chimica che si
uccise nel luglio 1993, fra Tangentopoli, stragi di mafia e misteri italiani,
scrivono Paolo Biondani ed Alessandro Cicognani il 23 luglio 2018 su
"L'Espresso". Raul Gardini e Gabriele Cagliari. I loro nomi sono rimasti
accostati, nel libro nero di Tangentopoli, dalla tragica fine. Due uomini di
vertice dell’industria italiana, privata e pubblica, si tolgono la vita uno dopo
l’altro, nel luglio 1993. Entrambi schiacciati dal peso di accuse che stanno
facendo crollare l’intero sistema politico ed economico. La cosiddetta Prima
Repubblica muore in quella torrida estate di 25 anni fa, tra crisi del debito
pubblico, inchieste su enormi casi di corruzione, stragi di mafia con troppi
misteri. E quelle morti eccellenti, traumatiche, proprio al culmine delle
indagini milanesi sull’Eni e sul gruppo Ferruzzi-Montedison. Due suicidi in tre
giorni (Cagliari il 20 luglio, Gardini il 23) che scuotono l’Italia. E listano a
lutto uno snodo cruciale della nostra storia, che oggi si può ripercorrere, per
capirne di più, grazie a nuovi documenti scoperti da L’Espresso. Come una prima
richiesta d’arresto di Gardini, rimasta ineseguita, che avrebbe potuto salvarlo.
O una lettera personale di Gardini proprio a Cagliari, che documenta la stima e
il rispetto che univa i due capi-azienda anche nei mesi dello scontro
sull’affare Enimont: l’alleanza tra Eni e Montedison poi naufragata in un mare
di tangenti. «Caro Cagliari», gli scrive Gardini, di suo pugno, l’otto febbraio
1990, in questa missiva finora inedita, «voglio avere con lei il rapporto che ho
con le persone che stimo... Io ragiono sempre di quello che si può fare al
meglio e per durare nel tempo. Voglio bene alla gente e se non è impossibile do
una mano anche quando posso fare molto male. Mi piace credere che gli uomini
sono fatti così: tutti. Ogni tanto ne incontro uno e mi volto per andare con lui
volentieri. Cordialità». Mani Pulite è il nome dell’indagine che in meno di tre
anni, dal febbraio 1992 al dicembre 1994, ha scoperchiato decenni di corruzione
in Italia. Il bilancio finale è un pezzo di storia: oltre 1.200 condanne
definitive per tangenti e reati collegati. Nata a Milano da una bustarella in un
ospizio, già nei primi mesi l’inchiesta si allarga, da un arresto all’altro, da
una confessione all’altra, fino a coinvolgere centinaia di imprenditori,
politici e burocrati. Dagli appalti locali, i magistrati risalgono agli affari
nazionali, ai parlamentari, ministri e leader dei partiti di governo. La lotta
alla corruzione ha un fortissimo sostegno popolare, gli imprenditori fanno la
coda per confessare. Nel 1993 Mani Pulite arriva ai vertici dell’economia: anche
i grandi gruppi industriali pagano tangenti, con fondi neri nascosti all’estero.
I flussi più imponenti escono dalle casse dell’Eni, l’azienda statale del gas e
petrolio, e del gruppo Ferruzzi-Montedison, il colosso privato
dell’agroalimentare e della chimica. Il 20 luglio 1993 Gabriele Cagliari,
presidente dell’Eni, si uccide nel carcere di San Vittore, dove era detenuto
dall’8 marzo. Tre giorni dopo si spara Raul Gardini, nel suo palazzo di Milano.
Per quel 23 luglio il suo primo impegno, annotato in un’agenda finora rimasta
riservata, erano proprio i funerali di Cagliari. Lo stesso giorno era segnato un
altro appuntamento: un interrogatorio con Antonio Di Pietro, allora pm simbolo
di Mani Pulite. Luogo fissato: una caserma. Anche se Gardini si aspettava un
ordine di carcerazione. Lo shock dei due suicidi incrina, per la prima volta, il
consenso di massa per Mani Pulite. Dalle tv di Berlusconi, che è ancora solo
imprenditore, partono i primi violentissimi attacchi ai magistrati. Il 27 luglio
a Milano irrompe la mafia stragista: un’autobomba uccide cinque persone in via
Palestro, mentre altri attentati devastano due chiese di Roma. Cosa Nostra fa
terrorismo politico. Strategia della tensione. Il premier Ciampi, capo di un
governo tecnico, colpito da un misterioso blackout a Palazzo Chigi, arriva a
temere un golpe. Al procuratore aggiunto Gerardo D’Ambrosio sembra di rivivere i
giorni neri di Piazza Fontana. Su quei fatti carichi di storia, dolore e
tensione, oggi i documenti offrono qualche certezza. E svelano più di un
segreto. Se il suicidio di Cagliari è una disperata protesta contro la
disumanità del carcere, come scrive il figlio Stefano nel recente libro “Storia
di mio padre”, la morte di Gardini ha un’altra trama. Il suo difensore, Marco De
Luca, che fu l’ultimo a incontrarlo, non ha dubbi sul suicidio, ma non se lo
spiega: «Quella sera, con Giovanni Maria Flick, siamo rimasti con Gardini fino
alle 23. Lui sapeva che stava per essere arrestato, era uscita la notizia delle
confessioni del presidente del gruppo, Giuseppe Garofano. Prima di vederci
Gardini era preoccupato, temeva che si scaricasse ogni colpa su di lui. Gli
abbiamo spiegato che da una persona come Garofano non doveva temere falsità:
aveva solo confermato le accuse che Gardini si aspettava. E cioè il sistema dei
fondi neri gestito da Berlini. Anche sul carcere, l’abbiamo rassicurato. Gli
abbiamo detto che avevamo parlato con Di Pietro, quando non poteva più smentire
di aver chiesto l’arresto. E che il pm si era impegnato a interrogarlo in una
caserma, con lealtà, evitandogli il carcere». Di qui l’appunto nell’agenda. Ma
allora perché si è ucciso? «Me lo sono chiesto per anni», risponde De Luca.
«Quella sera era molto logorato. Però sapeva che non sarebbe neppure entrato in
carcere. Oggi penso che abbia voluto proteggere la sua storia di imprenditore. E
la sua famiglia. Non poteva accettare di tornare a Ravenna con il marchio di
corruttore. Si è tolto di mezzo perché la sua famiglia fosse lasciata in pace».
Al tribunale di Milano L’Espresso ha trovato quegli atti fatali. I pm chiedono
l’arresto la sera del 21 luglio. Il giudice Italo Ghitti firma l’ordinanza due
giorni dopo, alle 9.15. Gardini si è già ucciso da un’ora. Tra le carte, però,
spuntano anche documenti inediti: c’è una prima richiesta di arrestare Gardini,
firmata dai pm Di Pietro, Davigo e Greco, che risale al 5 luglio. Cinque giorni
dopo, il giudice respinge l’arresto, per cui tutto resta segreto. Quella prima
richiesta riguarda già il «sistema Berlini»: fondi esteri «fino a un miliardo di
dollari». I primi a parlarne, però, erano due dirigenti che non gestivano quei
soldi. Quindi il giudice Ghitti nega l’arresto per insufficienza di indizi. Ora
è più chiaro perché Di Pietro, su Gardini, ripete da sempre che «se avessimo
potuto arrestarlo, si sarebbe salvato». Dal 10 luglio, dopo il primo no del
giudice, i pm raccolgono molte più prove. Come le confessioni di Garofano e
altri dieci indagati, tra cui Lorenzo Panzavolta, il boss della Calcestruzzi. La
nuova richiesta viene accolta, ma per Gardini è tardi. Il caso dell’arresto
negato lascia sbalordito l’avvocato De Luca: «Non ne sapevo niente». A chiudere
il quadro ora emerge anche un memoriale sequestrato nel palazzo di Milano dopo
il suicidio: dieci pagine scritte al computer (o dettate) in prima persona da
Gardini. La sua ammissione che le società offshore gestite da «B», cioè Berlini,
erano arrivate a gestire fondi neri «per circa mille miliardi di lire». Il
memoriale è diviso in capitoli che corrispondono ai capi d’accusa dell’ordine
d’arresto del 23 luglio: Gardini, insomma, era pronto a confessare. «Non ho mai
visto quel memoriale, ma gli avevo chiesto di prepararlo», conferma De Luca. Il
23 luglio finiscono agli arresti gli altri accusati. Berlini è il primo ad
ammettere di aver gestito «fino a un miliardo di dollari» in Svizzera. E di aver
mandato denaro in Italia anche per pagare politici «già dalle elezioni del
1987». In carcere, poi, è il manager Carlo Sama a vuotare il sacco su Enimont:
nel 1992, dopo la rottura con Gardini, il gruppo ha versato «circa 150 miliardi
di lire», attraverso Sergio Cusani, ai partiti di governo e a decine di
parlamentari. La sentenza definitiva condanna Sama e gli altri imputati anche
per la prima ondata di tangenti del ‘90-’91. In cambio, fu l’Eni a versare al
gruppo Ferruzzi, per il 40 per cento di Enimont, 2.805 miliardi di lire: una
cifra che lo stesso Gardini, sentito come testimone a Roma il 17 febbraio 1993,
definì «sicuramente eccessiva, maggiore del valore reale di circa 600 miliardi».
Al cambio di oggi, insomma, le tangenti (circa 75 milioni di euro) hanno
garantito ai privati almeno 300 milioni in più di soldi pubblici. Il quadruplo.
Archiviata Tangentopoli, Gardini viene dimenticato dall’Italia che conta. Solo
nella sua amata Ravenna amici e conoscenti ricordano ancora il corsaro
dell’economia, il vero erede del fondatore dell’impero Serafino Ferruzzi. Ai
tempi d’oro, però, i potenti facevano la fila per vedere Gardini. Nelle agende
trovate dall’Espresso sono annotati tutti i suoi incontri dal 1987 al 1991.
Decine di imprenditori, politici, banchieri. Tra centinaia di appuntamenti,
spiccano i nomi di Gianni Agnelli, Enrico Cuccia, il banchiere d’affari
Rothschild. Tra i finanzieri, i più assidui sono Gianni Varasi e Jean Marc
Vernes, che lo aiutarono a scalare Enimont. Tra i politici, i socialisti Claudio
Martelli e Gianni De Michelis, ma anche Craxi, con cui litiga su Enimont:
Bettino telefona, Gardini si nega. E pochi mesi dopo scrive una lettera
riservata all’allora premier Giulio Andreotti, con una sfacciata allusione ai
vizi della sua Dc. «Caro presidente Andreotti, mi ha confortato sentir dire che
dobbiamo aspirare a una chimica aperta alla competizione mondiale. Si può ancora
fare... È indispensabile in questa società che sia forte il senso dell’orgoglio
e della virtù, dimenticando il vergognoso passato... Tutti, meno i ladri, lo
aspettano con ansia». Gardini frequenta anche le persone che governeranno
l’Italia dopo Tangentopoli. Con Berlusconi parla solo di affari, come la Standa.
Con Romano Prodi, ex presidente dell’Iri, si contano centinaia di telefonate e
incontri. «Parlavamo dell’Italia e di come stava cambiando il mondo», racconta
oggi Prodi, «e mi raccontava dei suoi progetti. Era un romagnolo vero, con tutti
i pregi e i difetti che questo comporta. Gardini era un outsider negli Stati
Uniti per l’alimentare e in Italia per la chimica. Picchi e cadute si devono al
suo carattere: non teneva conto degli equilibri, dell’establishment. Sui
carburanti alternativi, non è che la storia gli abbia dato torto. Ma allora non
andava bene e lasciò un gruppo smembrato. Quando si suicidò provai un grande
dolore: per me era un amico». Ai funerali fu Prodi ad accompagnare la vedova,
Idina Ferruzzi, nella chiesa di San Francesco a Ravenna.
TANGENTOPOLI. GARDINI, CAGLIARI, CUSANI, SAMA. MA CHI HA PAURA DI
WALTER ARMANINI? Scrive il 24 luglio 2018 Andrea
Cinquegrani su "La Voce delle Voci". Paginate e paginate, in questi giorni, sui
media di casa nostra a proposito dei morti eccellenti (o di chi l’ha scansata
per miracolo) di Tangentopoli. Le storie dell’ex numero dell’Eni Gabriele
Cagliari, quella del capo dell’impero Ferruzzi Raul Gardini. Quelle di chi è
riuscita a farla franca pur dopo anni di galera, come Sergio Cusani e Carlo
Sama. Mancano all’appello, incredibile ma vero, i nomi di chi la galera non l’ha
vista neanche per un minuto, o al massimo per poche ore. Come Sergio Cragnotti,
l’ex patròn della Lazio calcio che di Enimont sapeva un pozzo di cose.
Pierfrancesco Pacini Battaglia. Nel montaggio in alto Walter Ammannii, Gabriele
Cagliari e Raul Gardini. Sullo sfondo Di Pietro, Colombo e Davigo. E
soprattutto Chicchi Pacini Battaglia, “l‘uomo a un passo da Dio”, come lo
dipinse il pm, Antonio Di Pietro, durissimo con i suoi imputati, una pantera in
toga: e invece in quell’occasione trasformatosi in un innocente agnellino.
Miracoli delle prodezze legali di un avvocato arrivato apposta dal Sud, alle sue
prime cause penali, Sergio Lucibello? Il quale nel pedigree aveva, oltre ad una
faticata laurea, soprattutto una gemma: l’amicizia con un pm che contava,
allora, a Milano, il vero capo del pool, la pantera nera Di Pietro. Super
Chicchi Battaglia sapeva tutto della madre di tutte le tangenti, Enimont, e del
maxi affari degli anni ’90 fino a tutt’oggi, l’Alta Velocità. Italo-svizzero,
depositario anche di tutti i segreti della più accorsata banca
svizzera, Karfinco, crocevia di tangenti a molti zeri. Poi molto legato al
faccendiere napoletano Eugenio Buontempo, cognato del luogotenente di Gianfranco
Fini, Italo Bocchino: e l’affiatato tandem Battaglia–Buontempo riuscì a dragare
– non si sa a quale titolo – i misteriosi fondali di Ustica dove giaceva il
relitto dell’Itavia. E ad addestrare piloti libici. Un groviglio di misteri.
GALERA MAI PER L’UOMO DI TUTTI I SEGRETI. Le cronistorie del palazzo di
giustizia di Milano raccontano che Chicchi Pacini Battaglia non passò neanche
mezz’ora in gattabuia, neanche il tempo di una sigaretta e un caffè dietro le
sbarre. Come mai nessuna inchiesta in Italia è mai riuscita a capire il perchè
di quella libertà per un faccendiere a conoscenza di tutti i segreti, sotto il
profilo economico, finanziario e non solo (perchè alla Tav si collegano anche
business mafiosi, sui quali avevano già acceso i riflettori Falcone e
Borsellino?) Boh. Ne hanno scritto, vent’anni fa, Ferdinando Imposimato e Sandro
Provvisionato, in “Corruzione ad Alta Velocità”, che conteneva notizie – è il
caso di dirlo – bomba. Su omissioni, collusioni, connection. Eppure niente,
neanche un tric trac. Il silenzio più totale dei media, il glaciale muro di
gomma della magistratura. Oggi la Repubblica di Mario Calabresi fa addirittura
il bis. Un paginone di Piero Colaprico dedicato alle rimembranze umane e
giudiziarie dell’intellettuale del pool di Milano, Gherardo Colombo, e poi un
fondo di Gianluca Di Feo su “Il Mistero di Raul Gardini”. Parla da solo già
titolo di Colaprico che riferisce le parole del pm che oggi dedica tutte le sue
energie ad insegnare educazione civica nelle scuole: “La fine di Gardini aprì
gli occhi di tutti sul sistema tangenti”. Ma c’era bisogno di quella tragedia
per capirlo? Non c’erano centinaia di altri segnali grossi come una casa? Non
c’erano state – per dirne una – le ricerche più che approfondite di Giovanni
Falcone e Piero Borsellino sulle mani della mafia piantate ormai da anni anche
sulla Calcestruzzi, il colosso riconducibile ai Ferruzzi e nel quale erano
penetrate le cosche? Nessuno ricorda più le profetiche parole di Falcone quando
a fine anni Ottanta (se non ricordo male nel 1989, quasi trent’anni fa, non
ieri) che “La Mafia è entrata in Borsa!”, con esplicito riferimento
alla Calcestruzzi che aveva fatto il suo ingresso in piazza Affari? Per non
parlare delle migliaia di riciclaggi già a fine anni ’80 in centro nord Italia
nei settori dei tempo libero, della distribuzione, dei servizi? E anche
all’estero? Oggi Maestro Colombo viene a raccontarci di “responsabilità di
tramandare una memoria storica”. Ma ci faccia il piacere, avrebbe detto il
mitico Totò.
ANCHE QUELL’UOMO “DOVEVA MORIRE”. C’è una storia che nessuno oggi ricorda,
pochissimi in passato hanno mai voluto rammentare. Forse perchè dà fastidio. E
la dice lunga su tanti metodi adottati in quegli anni che allora facevano
sperare (sic) in un mondo più Giusto & Possibile. La storia è quella di Walter
Giulio Armanini, che il pool di Milano – Di Pietro e Colombo in testa – era
straconvinto fosse il vero, unico depositario dei segreti di Bettino Craxi & C..
La loro ossessione era quella di scoprire il ‘tesoro’. Quel bottino che con ogni
probabilità era già anni prima volato via sotto il vigile sguardo di Claudio
Martelli, il delfino di Bettino Craxi, con la collaborazione di una ‘zarina’ di
segreti & conti correnti, Winnie Kolbrunner. E molte strade portavano, guarda
caso, ai conti cifrati elevetici, come ha più volte raccontato lo
scrittore-investigatore Jean Zigler, autore di “La Svizzera lava più bianco”. E
quei denari spesso e volentieri transitavano anche via Karfinco. Ma per Di
Pietro e Colombo la mela marcia era Armanini, uno che amava la bella vita e le
belle donne, conosceva bene l’ex sindaco di Milano e cugino di Craxi Paolo
Pillitteri. Armanini doveva confessare. Andava spremuto come un limone.
La Voce a dicembre 1996 andò ad Orvieto, incontrò e intervistò per un paio di
volte Armanini. Questo il titolo: “Stasera Pago io” – sottotitolo: “Cinque anni
e sette mesi di galera. E’ la sentenza definitiva che Armanini, docente di
Economia alla Bocconi, ex barricadero del ’68, sta scontando per Tangentopoli.
In questa intervista vuota per la prima vuota il sacco. E parla, tra l’altro, di
‘torture’ inflittegli da Colombo e Di Pietro. Fino al mancato suicidio sul
lungomare di Napoli. Proprio mentre ad Orvieto rientra l’inquisito Giancarlo
Parretti. E lo stesso Armanini viene colpito da un attacco cardiaco”. Fu
l’ultima intervista, quella di Armanini. Il quale dopo alcuni mesi morirà per un
secondo attacco cardiaco. Riproduciamo per intero quell’intervista,
scannerizzando le pagine della Voce di gennaio 1997. Ma eccone un breve
assaggio: “Volevano che parlassi di Pillitteri. Certo, dissi, eravamo molto
amici. E così una sera il secondino verso mezzanotte mi annuncia che devono
‘appoggiarmi’ un detenututo. Era un nero in astinenza da eroina che appena
entrato mi vomita addosso e sulla branda. Roba da impazzire. Il giorno dopo
arriva Gherardo Colombo e vuol sapere di Pillitteri. Qualche tempo dopo un nuovo
appoggio: un altro extracomunitario in crisi d’astinenza che mi afferra per il
collo e per poco m’ammazza. Vengo salvato a stento dalla guardia carceraria. Due
giorni dopo torna Colombo: cosa faceva lei con Pillitteri? In quei giorni, dal
19 maggio al 29 giugno ho avuto un preifarto, ho perso due diottrie ad un occhio
e sangue dall’orecchio. E dire che ero riuscito a superare le perquisizioni
anali d’ingresso”.
Storie di 5 anni prima. Avrebbe terminato di scontare la pena di lì a pochi
mesi, che stava trascorrendo ai domiciliari ad Orvieto, svolgendo anche un
lavoretto in un piccolo laboratorio artigiano.
Carlo Sama: «Il suicidio di mio cognato Raul Gardini? Un
sacrilegio. Ora coltivo soia in Sudamerica». La maxi
tangente Enimont, la condanna, la nuova vita. «Raul era straordinario. Fu il
primo a parlare di auto elettrica, biomasse, energie alternative. Era avanti su
tutto», scrive Stefano Lorenzetto il 13 luglio 2018 su "Il Corriere della Sera".
La sua nuova vita è costata a Carlo Sama un occhio della testa. Il destro. «In
Paraguay ho avuto il distacco della retina mentre aprivo una strada nella tenuta
di famiglia, dentro la più vasta foresta pluviale atlantica del pianeta
posseduta da un privato. Sarebbe bastato farmela suturare là con il laser.
Invece ho aspettato 20 giorni perché volevo ricoverarmi in una clinica europea.
Risultato: 14 inutili interventi chirurgici fra Londra, Roma e Miami. Ed eccomi
qua, orbo veggente come Gabriele D’Annunzio». Il protagonista del processo
Enimont, inchiodato dal pm Antonio Di Pietro per aver pagato «la madre di tutte
le tangenti» e riabilitato di recente dal tribunale di sorveglianza di Bologna,
vive fra Montecarlo e il Sudamerica. «Nel bosco mi sono costruito una casa di
legno su un albero, a 20 metri da terra, ma confesso che non ci ho ancora
dormito. Ho paura dei giaguari: quelli s’arrampicano». Eppure nella sua Ravenna
lo considerano l’amico del giaguaro che tradì il proprio mentore, il cognato
Raul Gardini. «Il passato è storia. Fa parte di noi. Pensi al povero Ubaldo Lay:
bravo attore, ma alla fine tutti se lo ricordano solo come il tenente Sheridan
con l’impermeabile». L’accusa gli pesa, e ancor più adesso, a 25 anni dal colpo
di pistola alla testa con cui il 23 luglio 1993 l’arrembante magnate del gruppo
Ferruzzi-Montedison si uccise nel Palazzo Belgioioso di Milano. «Tra la mia
famiglia e Gardini, scelsi la mia famiglia». Cioè la moglie Alessandra Ferruzzi,
che, come i fratelli Franca e Arturo, non condivideva la successione decisa da
Raul, marito della sorella Idina, la primogenita del fondatore Serafino
Ferruzzi. Era il 1991. Gardini fu liquidato con 505 miliardi di lire. «Quello
che nessuno sa, è che l’anno dopo ritornammo a parlarci».
Chi fece il primo passo?
«Io. Ci vedemmo in Svizzera. Ruppi il ghiaccio con una battuta: Raul, non ci
divertiamo più se non stiamo insieme».
Stare insieme per fare che cosa?
«Avevamo il monopolio mondiale del polipropilene. Ma bisognava investire
centinaia di miliardi in ricerca. La Shell era pronta. Avremmo riportato a casa
i pozzi petroliferi in Adriatico. E la Edison. L’advisor dell’operazione era
Romano Prodi, affiancato da Claudio Costamagna, attuale presidente della Cassa
depositi e prestiti. Il principio era banale: rimettere tutto assieme. Dissi a
Raul: facciamo un atto di compravendita della Ferruzzi per una lira, poi a bocce
ferme sarai tu, da padre di famiglia, a valutarne il vero valore».
Come reagì?
«La proposta gli piacque molto. Ma non se ne fece nulla, perché commise un
errore: cercò l’avallo di Mediobanca, cioè di Enrico Cuccia».
E che cosa accadde?
«Le azioni furono svalutate da 1.250 a 5 lire. La Ferruzzi fu oggetto di un
trapianto d’organo, con le sue quote di mercato immesse in corpi malati. Sa di
che parlo? Eravamo primi al mondo anche nelle proteine e nelle lecitine di soia,
nelle penicilline; primi in Europa nello zucchero, negli amidi e derivati, nei
semi oleosi, nei mangimi, negli oli di marca; primi in Italia nel calcestruzzo e
nelle assicurazioni danni e secondi nell’elettricità».
Che uomo era Raul Gardini?
«Straordinario. Aveva una visione così chiara del mercato che si dimenticava dei
tempi. Voleva che le cose fossero fatte per ieri. Fu il primo a parlare di auto
elettrica, biomasse, energie alternative. Il mondo era il nostro giardino di
casa. Fosse ancora vivo, oggi costringerebbe l’Italia a ridiscutere Maastricht,
le quote, tutto».
Perché a 60 anni si uccise?
«Non certo per disonore: non aveva fatto nulla. Temeva di finire come Gabriele
Cagliari, 134 giorni nel canile. Quando il presidente dell’Eni si suicidò in
cella, Raul mi telefonò: “È morto da eroe”. Pensava solo a quello, all’arresto.
Di Pietro lo teneva sulla graticola. Non si lavora una vita per finire in
ginocchio da chi ti accusa. Mi hanno raccontato un’orribile storia di guerra sui
topi».
Quale storia?
«I soldati catturavano una dozzina di topi e li tenevano a digiuno in gabbia.
L’unico che sopravviveva, dopo aver divorato gli altri, veniva liberato perché
desse la caccia ai suoi simili nelle trincee».
Gli innocenti non temono il carcere.
«Efrem Campese, capo della sicurezza di Montedison, gli aveva parlato di dieci
buste gialle con l’intestazione “F” e di un colonnello della Finanza chiamato da
Roma per recapitarle. I destinatari potevano essere Fiat o Ferruzzi. Si figuri
se Raul ebbe dubbi. L’avviso di garanzia equivaleva a una condanna».
Lei ebbe 146 imputazioni, mi pare.
«Più o meno. Assolto da tutte, a parte il finanziamento illecito ai partiti e
l’inevitabile falso in bilancio».
Fu arrestato il giorno del suicidio.
«Sì. Mi trovavo a Lugano. Telefonai a Palazzo Belgioioso. Rispose Renata
Cervotti, la segretaria di Raul. Lo stavano soccorrendo. Non morì subito».
Aleggiano misteri sulla tragedia?
«No, fu tutto lineare. Il comandante che affonda con la sua nave».
Fu dunque un gesto eroico?
«Rispetto la sua decisione e non esprimo giudizi. Sarebbe fargli torto».
È vero che la vedova ha abbracciato la vita religiosa?
«Idina è una donna meravigliosa, come lo era il marito. Oggi non sta bene. La
storia dei Ferruzzi non la conosce nessuno. Sono l’unico a poter dire d’aver
visto la luna e l’altra faccia della luna. Serafino era un genio, ha segnato il
secolo scorso. Il giorno in cui arrivò alla Borsa di Chicago, si fermarono per
rispetto le contrattazioni: era entrato Mister Soia, il trader che faceva il
mercato».
Ma che bisogno aveva Enimont di versare tangenti ai partiti?
«Nessuno. Si pagava perché non rompessero le balle. Non mi pareva un peccato.
Magari una scemata. Ma la politica costa tanto, sa? Non trovo anormale aiutarla.
Si doveva fare alla luce del sole».
Foraggiavate tutti?
«Nella migliore tradizione. Avevano stabilito le percentuali. I partiti dalle
mani pulite? Qualcuno svolgeva il lavoro sporco anche per conto loro».
Severino Citaristi, tesoriere della Dc, mi raccontò di quando il segretario
Arnaldo Forlani lo spedì da lei per ritirare una busta con dentro 2 miliardi e
850 milioni di lire in Cct, circostanza che poi mi fu confermata dallo stesso
Forlani.
«In piazza del Gesù ci andai poche volte. E non chiesi mai nulla a Forlani».
Che mi dice della valigia con 1 miliardo di lire consegnata al Pci?
«Bisognerebbe poterlo chiedere a Raul. La portò lui alle Botteghe Oscure».
Centinaia di miliardi in Cct transitarono dallo Ior, la banca della Santa Sede.
«Sono assolutamente consapevole di questo. Ma non fui io a smistarli».
Però il vescovo Donato De Bonis, segretario dello Ior, celebrò le sue nozze
nella parrocchia vaticana di Sant’Anna.
«Un caro amico. Aprì il fondo San Serafino per attività di beneficenza in onore
del padre di mia moglie. Ogni anno ci versavo la mia gratifica natalizia».
Stefano Bartezzaghi, figlio del Bartezzaghi della «Settimana Enigmistica», la
definì «vantaggiosamente inappariscente» e le imputò la «tendenza a strafare».
(Ride). «Giudichi lei. Ho interesse ad apparire sul Corriere della Sera?».
Di che cosa si occupa adesso?
«Mi sarebbe piaciuto cimentarmi nello sport, come mi aveva consigliato Bettino
Craxi, magari alla presidenza del Coni. Invece sono rimasto fedele all’antico
amore: la terra. Mi occupo di Agropeco, 12.000 ettari fra Paraguay e Brasile,
vicino alle cascate dell’Iguazú, e di Las Cabezas, 18.000 ettari a Entre Rios,
in Argentina. Produco dalla soia all’eucalipto. E allevo 12.000 capi di bestiame
razza Hereford. Ho brevettato un mangime contenente il 5 per cento di stevia,
un’erba dolcificante che funge da antibiotico naturale. In campagna rido da
solo, come i matti».
Investe ancora nel nostro Paese?
«Beh, no, che domande! L’ultimo affare fu la cessione di un’immobile a Roma,
diventato il J.K. Place luxury hotel».
Le restano l’Es Ram resort e il ristorante Chezz Gerdi, a Formentera. Tra gli
ospiti, Veronica Lario con figli e nipoti, Piero Chiambretti, Paolo Bonolis,
Raoul Bova.
«Chiuso il primo, venduto il secondo. Mai ospitato Bonolis. Però ci venivano
Kate Moss e una figlia di Mick Jagger».
Silvio Berlusconi era suo amico.
«Lo è ancora, lo sarà sempre. Fu l’unico a telefonarmi il giorno dell’arresto. E
pensare che avrebbe dovuto odiarmi: con Telemontecarlo gli fregavo la
pubblicità».
Chi altro le è rimasto vicino?
«Luca Cordero di Montezemolo, Carlo Rossella, Luigi Bisignani. E Sergio Cusani.
Il mese scorso si è fatto 400 chilometri, Milano-Bossolasco e ritorno, per stare
mezz’ora con le stampelle al matrimonio di Francesco, il mio secondogenito».
Come vede l’Italia a trazione pentastellata-leghista?
«Tutto quello che porta al cambiamento, lo vedo bene. Pensi che Gardini già
negli anni Ottanta voleva risolvere il problema degli immigrati. Fece
predisporre da Marco Fortis, docente della Cattolica proveniente dalla Nomisma
di Prodi, un progetto per rendere coltivabile la fascia mediterranea del
Maghreb. Dall’Africa non sarebbe più partito nessuno. Se solo avessimo potuto
continuare...». (Si commuove). «Il lavoro era il nostro gioco, la nostra
vacanza. È stato commesso un sacrilegio».
Secondo lei i partiti si finanziano ancora in modo illecito?
«Mi pare di sì. Ma non ho i riscontri».
Allora da che cosa lo deduce?
«Dall’odore».
Il re della
soia? È l’ex di Tangentopoli.
Ecco il tesoro offshore di Carlo Sama. Nei Panama Papers spunta l’ex manager
Ferruzzi-Montedison: condannato per lo scandalo Enimont, oggi è un big
dell’agricoltura in Paraguay. Dove la sua nomina a console onorario diventa un
caso: i suoi avvocati tentano un blitz in un giornale per bloccare le notizie. E
nelle intercettazioni torna anche Sergio Cusani, scrivono Paolo Biondani e Leo
Sisti il 17 luglio 2018 su "L'Espresso". «Exigen che no se publique», vietato
pubblicare. Con questo titolo Abc Color, uno dei giornali più letti del
Paraguay, denuncia, il 23 giugno scorso, che due avvocati sono piombati in
redazione nel tentativo, fallito, di censurare una notizia. Il cliente dei due
legali è un ricco signore italiano che controlla una fortuna in Paraguay, ma non
tollera di vedersi collegare a una società offshore svelata dai Panama Papers.
Il suo nome è Carlo Sama. Il giornale scopre che ha ottenuto la carica di
console onorario del Paraguay, quindi chiama L’Espresso per sapere chi sia. La
risposta è facile: è un big di Tangentopoli. Sama è il manager del gruppo
Ferruzzi-Montedison che nel luglio 1993, dopo il suicidio di Raul Gardini, ha
confessato «la madre di tutte le tangenti»: 157 miliardi di lire (ai valori
odierni, 136 milioni di euro) versati fino al 1992 a decine di politici italiani
di tutti i partiti di governo dell’epoca. Nell’autunno ’93 lo stesso Sama ha
confermato di aver versato 200 milioni di lire anche alla Lega di Umberto Bossi,
poi condannato ma tuttora senatore del partito di Matteo Salvini. Ai cronisti
del Paraguay, i due legali intimano di non nominare nemmeno la società Agropeco,
presieduta dallo stesso Sama, minacciando azioni legali. A quel punto Abc Color
chiede le carte di Mani Pulite: da Milano arrivano le confessioni di Sama e la
sentenza definitiva che nel 1998 lo ha condannato a tre anni di reclusione.
Quindi il giornale scrive tutto: offshore e passato del «console». Nominare la
società Agropeco in Paraguay vuol dire toccare una delle potenze agroindustriali
del Paese, che affonda le radici nell’impero fondato tra Ravenna e Sudamerica da
Serafino Ferruzzi, il padre di Alessandra, moglie di Carlo Sama, e di Idina, la
vedova di Raul Gardini. Oggi Agropeco possiede 16 mila ettari di terreni:
colture di soia e allevamenti di bovini per «una carne mas natural». Sama ha
definito il Paraguay «un paradiso per gli investitori stranieri». E qui ha
trovato amici potenti, come Don Juan Etudes Afara, vicepresidente del Paese fino
allo scorso aprile, e il presidente in carica, Horacio Cartes, che nel novembre
2016 l’ha nominato console onorario a Montecarlo. Dove Sama ha da anni la
residenza legale, con la famiglia, in Boulevard d’Italie. L’Espresso ha
esaminato decine di atti che confermano il ritorno di Sama nel pianeta offshore,
con nuovi particolari. La società si chiama Miung Development Sa, ha sede a
Panama ed è stata costituita il 2 gennaio 2008. I titolari sono anonimi: il
capitale nominale di 10 mila dollari appartiene a chi ha in mano un certificato
azionario «al portatore». In Italia l’anonimato è vietato dal 1990. A Panama
invece neppure lo studio Mossack Fonseca, che amministra la offshore, sa i nomi
degli azionisti. Le carte però svelano chi controlla i soldi: il 31 marzo 2008
la neonata società panamense nomina due «procuratori» con pieni poteri di
«vendere o acquistare beni in qualunque parte del mondo»: Carlo Sama e
Alessandra Ferruzzi. A tenere i rapporti con Panama, all’inizio, è una
funzionaria di Ginevra della banca Hsbc. Nel 2011, dopo lo scandalo della lista
Falciani, la Miung cambia agente: alla banca svizzera subentra una società di
Montecarlo, Cogefi Sam, che ha sede in Boulevard d’Italie 27, a pochi metri da
casa Sama. Della Miung si occupa, da allora, il funzionario Alberto Faraldo
Talmon. Tra il 2016 e il 2017 la situazione precipita. A Genova viene arrestato
un dirigente chiave della Cogefi, A.ngelo B.onanata: è accusato di aver nascosto
all’estero oltre 90 milioni di euro prestati dalla banca Carige alla famiglia Orsero. E il 10 marzo Talmon comunica a Mossack Fonseca di voler trasferire la
Miung, «al più presto possibile», in un altro studio di Panama, Pardini &
Asociados. Undici giorni dopo, Mossack Fonseca gli chiede di rispettare le norme
anti-riciclaggio varate dopo i Panama Papers: l’agente di Montecarlo deve
indicare «il beneficiario» della offshore e chiarire «l’origine dei fondi».
Intanto a Panama scoprono che il «procuratore» della Miung è stato condannato
per Enimont. A quel punto Talmon spedisce il passaporto di Sama, ma chiede di
annullare la procura. E il 4 aprile 2017 manda un’email di fuoco: «L’unica
attività della Miung è possedere immobili a Monaco. Tutto qui: nessun conto
bancario. Quanto al signor Sama, sono storie vecchie e ora è tutto finito! La
società va trasferita oggi. Altrimenti avvieremo un’azione legale contro il
vostro studio». Per Mossack Fonseca il rapporto si chiude qui. E la Miung passa
allo studio Pardini. Ora, per replicare ai Panama Papers, Carlo Sama ha comprato
una pagina di pubblicità su Abc Color, dove definisce «infamie» gli articoli
sulla Miung. Spiega che al processo Enimont è stato condannato per finanziamento
illecito dei partiti, non per corruzione. Precisa che i giudici di Bologna gli
hanno concesso la cosiddetta «riabilitazione», che cancella le pene accessorie
di una condanna ormai scontata. E pubblica un certificato legale di Montecarlo,
trasmesso in Paraguay, dove si legge che «Carlo Sama non ha alcun precedente
penale». Sama non è l’unico reduce di Tangentopoli che è tornato agli affari.
Una serie di intercettazioni del 2014, depositate a Milano nel processo
Eni-Nigeria, documentano incontri e telefonate tra Sergio Cusani, lo stesso Sama
e l’ex faccendiere craxiano Ferdinando Mach di Palmstein. Il progetto era di
comprare una società di appalti petroliferi di Ravenna, partecipata dal gruppo
statale Saipem, per rivenderla a un miliardario nigeriano, chiamato in codice
«Kk» o «lo scuro». Un aggancio curato da Vincenzo Armanna, l’ex manager dell’Eni
ora imputato per le tangenti in Nigeria, che sognava di dividersi una mediazione
del cinque per cento. L’affare è saltato perché il ricchissimo imprenditore
africano non si è fidato degli italiani.
Da Calvi a
Castellari fino a Gardini strani suicidi e morti "sospette".
Nella storia italiana tante le morti sospette di personaggi scomodi, scrive il
18 Giugno 2016 "Il Tempo". Gesto estremo volontario o omicidio «mascherato»?
L’interrogativo sulla morte di David Rossi, rilanciato con forza dal video del
New York Post e dalle polemiche che ne sono seguite, non è un quesito inedito
nella storia d’Italia. Anzi. I suicidi sospetti, purtroppo, sono stati
tutt’altro che una rarità negli ultimi trent’anni. Tra i casi più famosi,
certamente, quello del banchiere Roberto Calvi. Implicato nel crack del Banco
Ambrosiano, viene trovato impiccato a Londra, sotto il Ponte dei Frati Neri sul
Tamigi, il 18 giugno 1982. Una morte subito derubricata dalle autorità inglesi
in semplice suicidio; ma invece un omicidio per zittire una voce scomoda,
secondo familiari e conoscenti. Che, nel 2010, si sono visti confermare la
propria tesi da una sentenza della Corte d’assise d’Appello di Roma, in cui si
legge chiaramente che «Roberto Calvi è stato ammazzato, non si è ucciso». Ancora
più eclatanti le incongruenze emerse dalle indagini sulla tragica fine di Sergio
Castellari, ex commissario di polizia diventato in seguito direttore generale
degli affari economici del ministero delle Partecipazioni statali, poi
consulente Eni e implicato anche in Sapri Brocher ed Efim. L’uomo scompare il 18
febbraio 1993, e dopo qualche giorno i suoi familiari ricevono lettere in cui
Castellari annuncia i suoi propositi suicidi. Il suo corpo viene trovato una
settimana dopo, nella zona di Monte Corvino, il volto irriconoscibile: manca
mezza calotta cranica, portata via da un colpo d’arma da fuoco. Ma il proiettile
non viene mai trovato, e la pistola con cui si sarebbe sparato è riposta nella
fondina. Il corpo dell’uomo è più corto – di una decina di centimetri –
dell’altezza nota del Castellari, e tra le gambe del cadavere viene trovato un
sigaro, con tracce di saliva appartenenti a un’altra persona. L’estate dello
stesso anno – è il 20 luglio del 1993 – tocca a Gabriele Cagliari, presidente
Eni, coinvolto nella vicenda Enimont. Arrestato a marzo dello stesso anno, viene
trovato morto sul pavimento del bagno annesso alla cella. Il suo capo è
ricoperto da una busta di plastica legata intorno al collo. Ma sul suo viso
vengono ritrovate ecchimosi che fanno pensare a una mano esterna. Tre giorni
dopo, Raul Gardini si spara con un colpo di pistola alla tempia mentre è disteso
sul letto. Nella stanza, però, non si ritrovano residui di polvere da sparo. La
pistola con cui si dovrebbe essere sparato viene ritrovata appoggiata sulla
scrivania a diversi metri dal letto, priva di impronte. Nemmeno quelle del
suicida. Nel 1995 muore in circostanze misteriose, poi ricondotte dalla Procura
a un suicidio, Mario Ferraro, 46 anni, tenente colonnello del Sismi. La moglie
lo trova impiccato al bagno, nella loro casa dell’Eur, e una lettera dello
stesso Ferraro che parla del suo timore di essere ucciso. Ma il caso è
archiviato come l’estremo gesto in seguito alla morte della figlia, avvenuta
però 8 anni prima. Stessa sorte per il caso di suicidio di Adamo Bove, 42 anni,
ex poliziotto e responsabile della security governance di Telecom Italia.
Intorno alle ore 12 del 20 luglio 2006, il dirigente parcheggia l’auto a lato
della strada e si è getta dal cavalcavia di via Cilea, nel quartiere del Vomero,
Napoli. Dopo un volo di una ventina di metri, si schianta su una carreggiata
della tangenziale e muore sul colpo. Il dirigente - che era indagato per
violazione della privacy per aver «spiato» alcune persone attraverso una rete
informatica e coinvolto, pare, anche nel «Laziogate» – non aveva mai manifestato
intenti suicidi. Non sono nemmeno stati trovati messaggi scritti lasciati ai
parenti o agli amici, alimentando così la tesi – mai dimostrata – dell’omicidio
o quanto meno del suicidio istigato. Nella lunga lista dei suicidi sospetti c’è
anche Renzo Rocca direttore dell'ufficio per la Ricerca economica e industriale
del Sifar per conto del quale finanziò l'istituto Alberto Pollio. Fu trovato
morto nel suo ufficio, con un colpo di pistola alla tempia, poco prima di essere
interrogato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del
giugno-luglio 1964. La prova del guanto di paraffina non mostrò tracce di
polvere da sparo sulle mani di Rocca, tuttavia il caso fu chiuso come suicidio.
Ci fu una maledetta fretta di archiviare la morte per suicidio anche di Omar
Pace, colonnello della Guardia di finanza in forza alla Direzione investigativa
antimafia che si tolse la vita nel suo ufficio sparandosi alla tempia e che
avrebbe dovuto testimoniare il giorno dopo al processo di Reggio Calabria nel
quale era imputato l’ex ministro Claudio Scajola per aver favorito la latitanza
dell’imprenditore Amedeo Matacena. Era il 4 aprile 2002 quando, invece, i
carabinieri di Tivoli trovarono il corpo senza vita di Michele Landi nella sua
casa di Guidonia Montecelio, a una trentina di chilometri da Roma. Landi era
tecnico informatico, era stato consulente di Umberto Rapetto, tenente colonnello
della Fiamme Gialle, e del pubblico ministero di Palermo Lorenzo Matassa. Nelle
loro prime dichiarazioni, entrambi esclusero l’ipotesi del suicidio. Matassa
pensò a un omicidio maturato in ambienti ben precisi: «Penso ai servizi segreti,
quelli che hanno cercato di dare un segnale a chi sta lavorando sull’omicidio
del professore Marco Biagi». Nel 2001 si sparò un colpo alla tempia, tre giorni
dopo una perquisizione, il responsabile della sicurezza dell’Hotel «Hilton» di
via Cadlolo. E qualche mese prima, un suo collaboratore, dipendente di un
istituto di vigilanza distaccato all’albergo di Monte Mario, si era tolto la
vita nello stesso modo. Alla moglie, prima di farsi saltare le cervella, l’uomo
aveva parlato di una sorta di memoriale che stava scrivendo e che riguardava il
suo lavoro. Un altro mistero insomma. E non sarebbe stato un suicidio collettivo
quello di Gesuino Mastio, 34 anni di Ovodda (Nuoro), della moglie Federica
Torelli, 26 anni, e del figlio Alessandro di 6 anni, rinvenuti cadaveri a bordo
di una "Mini Innocenti" in una strada di campagna presso Chianciano Terme, in
provincia di Siena. Lo disse il padre, Salvatore Mastio rompendo il silenzio sui
tragici avvenimenti che sconvolsero la famiglia dopo l'arresto del figlio
Agostino, 41 anni, coinvolto e «pentito» nel sequestro dell'imprenditore
bresciano Giuseppe Soffiantini. Infine c’è una serie di morti sospette e di
testimoni scomparsi dopo la strage di Ustica che il giudice Rosario Priore
definì: «Una casistica inquietante. Troppe morti improvvise». Ma allo stato mai
nessuna correlazione è stata provata.
DEVASTATI DA MANI PULITE.
C'è chi si sa difendere, ma non ha il potere di cambiare le
cose...
De Luca “scatenato” a La7: accuse ai magistrati messinesi,
scrive il 26 novembre 2017 la Redazione di "Messina oggi". Il conduttore Massimo
Giletti ha faticato a contenere Cateno De Luca, ospite alla trasmissione in onda
su La7, dal titolo “Non è l’Arena”. Il parlamentare messinese è stato ospite
nella seconda parte della trasmissione, durante la quale si è parlato del suo
“strano” arresto, avvenuto dopo tre giorni dal voto dello scorso 5 novembre.
Come si ricorderà, De Luca è stato poi scarcerato dal Tribunale della Libertà,
dopo che due giorni prima era arrivata anche l’assoluzione per il cosiddetto
“Sacco di Fiumedinisi”. De Luca ha ribadito concetti già noti davanti a migliaia
di italiani, ovvero che nel Palazzo di Giustizia messinese vi è una mano nera.
Lo ha detto anche il legale di De Luca, Carlo Taormina, il quale ha riferito di
altri esposti depositati per fare luce sulla vicenda. “Mafia della magistratura”
ha ribadito il deputato neo eletto, davanti alle telecamere scatenando le
vibranti reazioni del conduttore che ha preso le distanze, e di Antonio Di
Pietro, in collegamento da Milano. A fare la parte dei disturbatori il trio
Costamagna-Parenzo-Davi, che hanno tentato di inchiodare De Luca sulla base di
notiziole trovate in rete, senza avere contezza di ciò di cui si parlava. Come
del resto spesso avviene in questi “show” televisivi dove gli opinionisti
parlano anche del “sesso degli angeli”. De Luca in chiusura di trasmissione ha
svelato comunque un particolare che non era noto: ovvero che alcuni magistrati
del Tribunale di Messina hanno parenti che lavorano nel mondo della Formazione.
“Quando Genovese ha detto no a qualche magistrato per lui sono iniziati i
problemi”.
DE LUCA: "UNO DEI FIGLI DEL PROCURATORE GENERALE ERA PROPRIO LÌ".
Cateno De Luca scatenato da Giletti: “Figli di magistrati assunti nella
formazione professionale”, scrive Matteo Scirè il 27 novembre 2017 su "Il
Sicilia". Ha attaccato frontalmente la magistratura di Messina per l’inchiesta
che lo ha travolto già all’indomani del voto per le elezioni regionali. E’
scatenato Cateno De Luca davanti alle telecamere di “Non è l’Arena”, il
programma di Massimo Giletti andato in onda ieri pomeriggio su La7. Quando il
presentatore gli ha chiesto il perchè Nello Musumeci ha difeso Genovese e non
lui, De Luca ha perso la calma, accusando un pezzo della magistratura dello
Stretto di aver sistemato i figli negli enti della formazione professionale
gestiti dalla politica e finanziati dalla Regione. “A Messina ci sono magistrati
e pubblici ministeri che hanno i figli assunti nella formazione professionale –
ha gridato – dove si entra per raccomandazione, per contiguità politica. E’ una
delle lotte che ho fatto quando ero in Parlamento, dove si bruciavano 500
milioni di euro l’anno”. Secondo De Luca, le indagini che lo hanno portato agli
arresti sarebbero una rappresaglia portata avanti in particolare da un
giudice. “Uno dei figli del procuratore generale era proprio lì – ha detto – e
quando io l’ho beccato tra le varie indagini che abbiamo fatto stava tentando
anche di sistemarlo nel Ciapi, un ente regionale. Questo me l’ha fatta pagare e
ha fatto due denunce e tra facendo la terza”. Non si è fatta attendere la
replica dell’Associazione Nazionale Magistrati, che con una nota
stigmatizza “con forza e fermo disappunto i gravi attacchi e le incresciose
strumentalizzazioni, posti in essere da tempo e senza soluzione di continuità,
dal neoeletto rappresentante delle istituzioni siciliane, Cateno De Luca, ai
danni della funzione giudiziaria e, indiscriminatamente, ai danni dei magistrati
messinesi titolari o assegnatari dei procedimenti che lo riguardano”. L’Anm
esprime “solidarietà e vicinanza alla magistratura messinese, vittima di queste
aggressioni, la quale continuerà ad esercitare le proprie funzioni in silenzio,
soggetta solo alla legge, libera, con rigore e serenità”.
Tra De Luca e il procuratore Barbaro è scontro aperto,
intervengono i legali del deputato, scrive il 28
novembre 2017 "Messina Ora". Vincenzo Barbaro, procuratore generale di Messina,
ha preannunciato, è intervenuto sulla Gazzetta del sud, dopo l’intervento
del deputato regionale Cateno De Luca che ha ingaggiato una lotta personale con
la magistratura messinese, iniziata subito dopo la restrizione ai domiciliari
per la vicenda Caf Fenapi. In seguito a un riferimento al “procuratore
generale”, chiamato in causa da De Luca nel corso dell’intervista “Non è
l’Arena” di Giletti, a cui è seguita anche una nota dell’Associazione Nazionale
Magistrati, Barbaro ha dichiarato: “Non intendo replicare, né sui giornali né in
televisione, ai signori De Luca e Taormina, poiché ci penseranno i miei legali
nelle competenti sedi”, annunciando di fatto una querela. A Barbaro hanno
risposto gli avvocati del deputato, Carlo Taormina e Tommaso Micalizzi, i quali
precisano che “in nessuna occasione di tipo mediatico è stato fatto il nome
dell’alto magistrato da parte dei difensori dell’On. Cateno De Luca, i quali,
pur nell’ambito di un serrato confronto dialettico, hanno sempre serbato
comportamenti corretti e di rispetto nei suoi confronti”. “Le aggressioni
giudiziarie sofferte dal Cateno De Luca – prosegue la nota – sono il frutto di
un complesso organizzato di iniziative provenienti da un sistema massonico e
mafioso su cui si fonda il noto verminaio messinese. I nominativi sono stati già
resi all’Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria, attraverso denunzie presentate
dall’On. De Luca, presso la quale, chiunque, ed a maggior ragione il Procuratore
Barbaro, potrà recarsi per averne compiuta conoscenza. I difensori dell’On.
Cateno De Luca intendono contestualmente evidenziare, che, ad oggi, tutte le
circostanze, ricostruzioni, dietrologie e argomentazioni messe a disposizione
della difesa da parte del parlamentare siciliano per contrastare le accuse
formulate a suo danno, si sono dimostrate veritiere. Per questa ragione essi
sono stati e saranno sempre al suo fianco onde supportare la sua azione
giudiziaria, in ambito penale e di risarcimento danni, nei confronti di
chiunque, magistrato o cittadino comune, attenti alla sua onorabilità, tentando
di metterne in discussione onestà, moralità e competenza”, concludono i legali,
che annunciano una conferenza stampa, prevista il 12 dicembre nella Chiesa
sconsacrata di Santa Maria Alemanna, durante la quale verranno illustrate le
iniziative che De Luca ha intrapreso “contro il sistema massonico mafioso
imperante a Messina”.
Messina: avvocati De Luca, "mano nera" in uffici giudiziari
città, scrive "Adnkronos" il 24 Novembre 2017
riportato da "Il Dubbio". “L’assoluzione di Cateno De Luca da tutti i reati
contestatigli in relazione al cosiddetto ‘Sacco di Fiumedinisi’ e l’azzeramento
di tutti i reati e di tutte le misure cautelari personali e reali da due organi
giurisdizionali nello stesso Tribunale, il giudice delle indagini […]
“L’assoluzione di Cateno De Luca da tutti i reati contestatigli in relazione al
cosiddetto ‘Sacco di Fiumedinisi’ e l’azzeramento di tutti i reati e di tutte le
misure cautelari personali e reali da due organi giurisdizionali nello stesso
Tribunale, il giudice delle indagini preliminari e il Tribunale della Libertà,
dimostrano senza il minino dubbio che una ‘mano nera’ si aggira negli uffici
giudiziari di Messina, la quale da tempo ha deciso che l’opera antimafia e
antimassonica del deputato siciliano debba essere fermata”. Lo dicono gli
avvocati Carlo Taormina e Tommaso Micalizzi, difensori del deputato regionale
dell’Udc, Cateno De Luca, arrestato per evasione fiscale e scarcerato nei giorni
scorsi. “Bisogna dare atto alla magistratura illuminata di quel Tribunale –
proseguono i legali – di aver avuto il coraggio di elevare barricate di onestà
contro questi inverecondi attacchi perpetrati verso un uomo delle istituzioni
che ha il torto di fare politica solo con la buona amministrazione e che ha
avuto l’ardire di volersi impegnare per la ripulitura del verminaio messinese
che abbraccia centri di potere, università e uffici giudiziari”.
L’arrestocrazia e il potere del “Coro antimafia”,
scrive Piero Sansonetti l'11 Novembre 2017 su "Il Dubbio". Dal caso De Luca al
caso Spada, quando l’arresto mediatico e a furor di popolo conta più le regole
del diritto. E chi dissente è considerato un complice dei farabutti. Ieri
pomeriggio Cateno De Luca è stato assolto per la quattrodicesima volta. Niente
concussione, nessun reato. A casa? No, resta agli arresti perché dopo 15 accuse,
15 processi e 15 assoluzioni, martedì scorso era arrivata la 16ima accusa. E ci
vorrà ancora un po’ prima che sia assolto di nuovo. Stavolta l’accusa è evasione
fiscale. Non sua, della sua azienda. Cateno De Luca è un deputato regionale
siciliano. Era stato eletto martedì. Lo hanno ammanettato 24 ore dopo. L’altro
ieri sera invece era stato fermato Roberto Spada. Stiamo aspettando la conferma
del suo arresto. Lui è in una cella a Regina Coeli. Roberto Spada è quel signore
di Ostia che martedì ha colpito con una testata – fratturandogli il naso – un
giornalista della Rai che gli stava facendo delle domande che a lui sembravano
inopportune e fastidiose. È giusto arrestare Spada? È stato giusto arrestare
Cateno De Luca? A favore dell’arresto ci sono i giornalisti, gran parte delle
forze politiche, una bella fetta di opinione pubblica. Diciamo: il “Coro”. Più
precisamente il celebre “Coro antimafia”. Che ama la retorica più del diritto.
Contro l’arresto c’è la legge e la tradizione consolidate.
Prendiamo il caso di Spada. La legge dice che è ammesso l’arresto preventivo di
una persona solo se il reato per il quale è accusata è punibile con una pena
massima superiore ai cinque anni. Spada è accusato di lesioni lievi (perché la
prognosi per il giornalista è di 20 giorni) e la pena massima è di un anno e
mezzo. Dunque mancano le condizioni per la custodia cautelare. Siccome però il
“Coro” la pretende, si sta studiando uno stratagemma per aggirare l’ostacolo.
Pare che lo stratagemma sarà quello di dare l’aggravante della modalità mafiosa.
E così scopriremo che c’è testata e testata. Ci sono le testate mafiose e le
testate semplici. Poi verrà il concorso in testata mafiosa e il concorso esterno
in testata mafiosa.
Mercoledì invece, dopo l’arresto di Cateno De Luca, non c’erano state grandi
discussioni. Tutti – quasi tutti – contenti. Sebbene l’arresto per evasione
fiscale sia rarissimo. Ci sono tanti nomi famosi che sono stati accusati in
questi anni di evasione fiscale per milioni di euro. Alcuni poi sono stati
condannati, alcuni assolti. Da Valentino Rossi, a Tomba, a Pavarotti a Dolce e
Gabbana, a Raul Bova e tantissimi altri. Di nessuno però è stato chiesto,
ovviamente, l’arresto preventivo. Perché? Perché nessuno di loro era stato
eletto deputato e dunque non c’era nessun bisogno di arrestarlo. L’arresto,
molto spesso, specie nei casi che più fanno notizia sui giornali, dipende ormai
esclusivamente da ragioni politiche. E il povero Cateno ha pagato cara
l’elezione. I Pm non hanno resistito alla tentazione di saltare sulla ribalta
della politica siciliana. Comunque qui in Italia ogni volta che qualcuno finisce
dentro c’è un gran tripudio. L’idea che ormai si sta affermando, a sinistra e a
destra, è che l’atto salvifico, in politica, sia l’arresto. Mi pare che più che
in democrazia viviamo ormai in una sorta di “Arresto-Crazia”. E che la nuova
aristo-crazia che governa l’arresto-crazia sia costituita da magistrati e
giornalisti. Classe eletta. Casta suprema. Gli altri sono colpevoli in attesa
di punizione. Poi magari ci si lamenta un po’ quando arrestano i tuoi. Ma non è
niente quel lamento in confronto alla gioia per l’arresto di un avversario. Il
centrodestra per esempio un po’ ha protestato per l’arresto pretestuoso di
Cateno De Luca. Il giorno prima però aveva chiesto che fosse sospesa una fiction
in Rai perché parlava di un sindaco di sinistra raggiunto da avviso di garanzia
per favoreggiamento dell’immigrazione. Il garantismo moderno è così. Fuori gli
amici ed ergastolo per gli avversari. Del resto la sinistra che aveva difeso il
sindaco dei migranti ha battuto le mani per l’arresto di Cateno. L’altro ieri
intanto è stato minacciato l’avvocato che difende il ragazzo rom accusato di
avere stuprato due ragazzini. L’idea è quella: “se difendi un presunto
stupratore sei un mascalzone. Il diritto di difesa è una trovata farabutta. Se
uno è uno stupratore è uno stupratore e non serve nessun avvocato e nessunissima
prova: condanna, galera, pena certa, buttare la chiave”. Giorni fa, a Pisa, era
stato aggredito l’avvocato di una ragazza accusata di omicidio colposo (poi, per
fortuna, gli aggressori hanno chiesto scusa). Il clima è questo, nell’opinione
pubblica, perché questo clima è stato creato dai politici, che sperano di
lucrare qualche voto, e dai giornali che un po’ pensano di lucrare qualche
copia, un po’, purtroppo, sono scritti da giornalisti con doti intellettuali non
eccezionali. E se provi a dire queste cose ti dicono che sei un complice anche
tu, che stai con quelli che evadono le tasse, che stai con quelli che danno le
testate. Il fatto che magari stai semplicemente col diritto, anche perché il
diritto aiuta i deboli mentre il clima di linciaggio, il forcaiolismo, la
ricerca continua di punizione e gogna aiutano solo il potere, beh, questa non è
nemmeno presa inconsiderazione come ipotesi. Tempo fa abbiamo pubblicato su
questo giornale “La Colonna Infame” di Manzoni. Scritta circa due secoli fa. Due
secoli fa? Beh, sembra ieri…
P. S. Ho letto che Saviano ha detto che Ostia ormai è come Corleone. Corleone è
la capitale della mafia. A Corleone operavano personaggi del calibro di Luciano
Liggio, Totò Riina, Bernardo Provenzano. Corleone è stato il punto di partenza
almeno di un migliaio di omicidi. Tra le vittime magistrati, poliziotti, leader
politici, sindacalisti, avvocati. Paragonare Ostia a Corleone è sintono o di
discreta ignoranza o di poca buonafede. Ed è un po’ offensivo per le vittime di
mafia.
P. S. 2. Il giornalista Piervincenzi, quello colpito con la testata da Spada, ha
rilasciato una intervista davvero bella. Nella quale tra l’altro, spiega di non
essere stato affatto contento nel sapere dell’arresto di Spada. Dice che lui in
genere non è contento quando arrestano la gente. Davvero complimenti a
Piervincenzi. Io credo che se ci fossero in giro almeno una cinquantina di
giornalisti con la sua onestà intellettuale e con la sua sensibilità, il
giornalismo italiano sarebbe una cosa sera. Purtroppo non ce ne sono.
Poi, c'è chi ha avuto per 20 anni il potere di cambiare le
cose...promettendo ai quattro venti di farlo, ma che non ha saputo difendere se
stesso, nè gli altri che diceva di rappresentare.
Berlusconi, gli orologi della Procura spaccano il minuto,
scrive Errico Novi il 25 Novembre 2017 su "Il Dubbio". Ruby ter, la procura di
Torino: «Processate l’ex premier». I sondaggi? Tutto bene grazie. L’alleanza?
Funziona. Il ricorso a Strasburgo? Ci sono tutte le premesse perché venga
accolto. Cosa manca per completare il solito quadretto preelettorale di Silvio
Berlusconi? Il rinvio a giudizio, of course. Ieri è stato chiesto, con
puntualità svizzera più che piemontese, dalla pm di Torino Laura Longo, che
procede nei confronti dell’ex premier per uno dei 7 fascicoli in cui si è
sminuzzato il cosiddetto Ruby ter. Nel caso specifico (definire ingarbugliata la
vicenda processuale è un eufemismo) si tratta del filone in cui il Cavaliere è
indagato con la 32enne Roberta Bonasia. Si tratta di un’ex infermiera poi
divenuta soubrette, che all’epoca delle feste organizzate ad Arcore sarebbe
stata “additata” da altre giovani come la «preferita», o addirittura la
fidanzata dello stesso Berlusconi. Lei, Bonasia, è accusata di aver reso false
dichiarazioni nell’ambito dei primi due procedimenti della saga “Ruby”. In
quella che, delle prime due puntate, lo riguardava personalmente, Berlusconi è
stato definitivamente assolto. A Torino l’ex presidente del Consiglio è sotto
inchiesta per corruzione in atti giudiziari, la stessa ipotesi di reato avanzata
a suo carico negli altri 6 filoni. Uno dei quali, il principale, rimasto sempre
a Milano, in realtà è già a dibattimento. Nella capitale di tutte le indagini a
suo carico, quella morale del Paese appunto, il Cav infatti è stato rinviato a
giudizio lo scorso 27 gennaio, insieme con altre 23 persone (tra loro, e qui
come si vede la geografia processuale si complica, anche una parlamentare, Maria
Rosaria Rossi, e Carlo Rossella).
IL FILONE PIEMONTESE. Cosa è successo a Torino? Che la Procura ha ricevuto gli
atti dopo lo spacchettamento chiesto (al gup di Milano) e ottenuto dalla difesa
di Berlusconi nell’aprile 2016. Giacché la competenza del relativo capo
d’imputazione – gli 80mila euro che il Cavaliere avrebbe versato a Bonasia – era
appunto a Torino, la stessa Procura del capoluogo piemontese ha rimesso le mani
sul materiale inizialmente raccolto dai colleghi lombardi. Ha messo sotto
inchiesta Berlusconi e Bonasia all’inizio di quest’anno, e ieri appunto ha
depositato la richiesta. Ora si attende che venga vissata l’udienza preliminare.
Il legale che, insieme con il professor Franco Coppi, difende l’ex premier in
questa schizofrenica storia, Federico Cecconi, spiega: «Non mi è ancora stato
notificato alcun atto». Gli avvocati di Bonasia, Maurizio Milan e Giulia
Tebaldi, si limitano a dire che la loro assistita «ha sempre contestato l’accusa
nei suoi confronti, continuerà a farlo». E soprattutto, che «non ha mai
testimoniato il falso». Quanto alle somme fattele pervenire dall’ex premier,
aggiungono i legali, si tratta di «denaro che le fu versato come aiuto dopo le
disavventure cagionate da quella vicenda». In attesa di capire come finirà a
Torino la vera domanda è: quanto durerà il bombardamento? Difficile prevederlo.
Probabile in ogni caso che partano raffiche violente. Vediamo perché.
GLI ALTRI 6 RIVOLI. Quella di Torino è solo una delle 7 spie rosse destinate nei
prossimi mesi ad accendersi con intermittenza. Delle altre 6, una come detto è
già in fase di dibattimento al Tribunale di Milano, ma altri tre filoni
d’indagine sono tornati sempre nel capoluogo lombardo, nelle mani della solita
Procura da cui tutto è nato. Sono i procedimenti inizialmente smistati a Monza,
Treviso e Pescara, che poi i pm milanesi sono riusciti a farsi riassegnare,
giacché alle ragazze coinvolte in ciascuno dei tronconi sarebbero continuati ad
arrivare benefìci di varia natura anche in tempi recenti. I nomi delle giovani
(anche se gli anni passano persino per loro) coinvolte sono i soliti: Aris
Espinosa, Elisa Toti, Giovanna Rigato, Miriam Loddo. Proprio dopodomani, lunedì,
si celebrerà l’udienza preliminare, davanti al gup di Milano Maria Vicidomini,
relativa alle accuse in cui Berlusconi compare insieme con le prime tre delle
quattro ragazze di cui sopra. Potrebbe dunque partire subito un altro colpo, un
altro rinvio a giudizio. In nessun caso i pm si sono sognati di optare per una
richiesta d’archiviazione. Ci sarà insomma una replica a brevissimo. Nell’attesa
che vada in scena, e che sia allestito anche il palco in cui si vedrà Berlusconi
indagato con Loddo, le udienze del filone principale sono sospese, ma
riprenderanno il 29 gennaio 2018, eventualmente con l’accorpamento dei due
tronconcini rientrati a Milano, qualora anche in questi ci fossero rinvii a
giudizio. Poi potrebbero svegliarsi i fascicoli di Siena (lì l’ex presidente del
Consiglio è indagato con un pianista, Danilo Maeiani) e Roma (dove a condividere
lo status di imputato è il cantante Mariano Apicella).
LA SAGA DI KARIMA. Una geografia complicatissima. Che sembra una batteria di
fuochi sapientemente preparata. Le botte esplodono a tempo, a breve o media
distanza, ma in modo che lo spettacolo possa durare a lungo. Certo è che dopo
diversi mesi di calma piatta, sorte (?) vuole che tutto riprenda proprio ora che
persino Eugenio Scalfari dice di voler votare per Berlusconi. Si potrebbe dire
che l’inseguimento continua. È infinito. Vede da anni i magistrati milanesi
tentare di braccare il tre volte Capo del governo. Nel caso della saga
giudiziaria intitolata a Ruby Rubacuori, al secolo Karima El Marough, si
persegue un reato di corruzione in atti giudiziari che sarebbe stato finalizzato
a ottenere il silenzio dei teste rispetto all’unico vero possibile reato- fine
attribuibile a Berlusconi: quello di aver intrattenuto rapporti sessuali con la
stessa Ruby nonostante sapesse che la ragazza era all’epoca minorenne. Il
paradosso è che per tale reato- fine Berlusconi è stato assolto con sentenza
passata in giudicato. Si è accertato, con il giudizio in Cassazione, che l’ex
premier non era consapevole dell’anagrafe di Karima. È come se i pm volessero
dimostrare che anche la Suprema corte si sarebbe sbagliata. Una vertigine
giudiziaria che si affaccia dritta dritta sulle urne da cui Berlusconi dovrebbe
uscire vincitore.
Tempismo un po’ sfacciato, scrive Piero
Sansonetti il 25 Novembre 2017 su "Il Dubbio". Il grado di attenzione verso
Berlusconi è direttamente proporzionale al peso politico che egli esercita nelle
varie fasi della sua carriera politica. Zacchete. I tempi son stati calcolati
con grande precisione. La campagna elettorale per le politiche ormai è aperta. I
giornali, le tv – tutti i giornali e le Tv – dicono che Berlusconi è tornato
protagonista, che ha ripreso la guida del centrodestra, che sta guadagnando
consensi, che è al centro della scena. Zacchete. C’è sempre una procura pronta
ad agire. Stavolta è toccato a Torino. Alla Procura di Torino gli orologi
funzionano benissimo, spaccano il minuto. Ieri mattina l’Ansa ha battuto la
notizia della richiesta di rinvio a giudizio di Berlusconi Silvio, per il
cosiddetto Ruby ter. I processi per il caso Ruby (rapporti non chiari tra l’ex
premier e una ragazza) finora sono tre (più alcuni minori). Il tempismo della
procura di Torino stavolta è un po’ sfacciato. Probabilmente, se anche il terzo
va in malora, se ne aprirà un quarto, raggiungendo così il record dei processi-
Moro (strage di via Fani, sequestro del presidente della Dc e sua esecuzione).
Il Ruby quater potrebbe rendersi necessario se la prossima legislatura, come
molti immaginano, dovesse durare poco, per mancanza di maggioranza, e se si
tornasse a votare entro il 2018. Allora un Ruby quater potrebbe essere
indispensabile. Guardate che non sto affatto facendo ironia. Sono serissimo: la
mia è una cronaca dei fatti accompagnata da qualche facile previsione. È vero
naturalmente che esiste una parte maggioritaria della magistratura, molto seria,
che fa molto seriamente il proprio lavoro (giudicare i delitti, accertarli,
eventualmente punirli con saggezza ed equilibrio). Ma esiste altrettanto
indubitabilmente un pezzo di magistratura, forse piccolo ma in grado di coprire
tutto il territorio nazionale, che ritiene invece che il proprio compito sia
quello di impedire alla politica di svolgere il suo ruolo: nella certezza che
politica e corruzione siano due sinonimi. Questa parte della magistratura è
politicamente trasversale. Comprende giudici di sinistra, di destra e grillini.
E colpisce destra, sinistra e 5 Stelle. Basta guardare il caso Messina, dove in
meno di un mese sono stati presi di mira e colpiti ben cinque candidati alle
elezioni, dei quali quattro eletti e uno primo dei non eletti, appartenenti a
tutti e tre gli schieramenti politici. Ed è stata posta una ipoteca seria sulla
possibilità di formare una giunta regionale con la maggioranza decretata dagli
elettori. Spesso, l’obiettivo di alcuni giudici è quello: decidere gli equilibri
politici, modificando quelli stabiliti dall’elettorato. Anche perché lo stesso
elettorato, per quanto anonimo, siccome vota, è sospettabile, molto sospettabile
di voto di scambio, e dunque non è una fonte legittima del potere. La
trasversalità della magistratura in guerra con la politica (e con il sistema
democratico) non toglie nulla alla attenzione del tutto particolare che viene
comunque riservata a Silvio Berlusconi. Il grado dell’attenzione verso
Berlusconi è direttamente proporzionale al peso politico che egli esercita nelle
varie fasi della sua carriera politica. Negli ultimi anni il cavaliere, dopo la
batosta dell’esclusione dal Senato, si era un po’ ritirato in seconda fila, e la
magistratura si era messa tranquilla. Gli ultimi sondaggi hanno fatto suonare il
campanello di allarme (“torna Berlusconi!! Torna Berlusconi!!), e ieri è partito
il nuovo attacco. Sempre ieri si è conclusa la vicenda del senatore Piero
Ajello. Il quale ha vissuto sette anni d’inferno perché due mafiosi pentiti lo
avevano accusato di voto di scambio e la Procura di Catanzaro aveva dato retta i
due mafiosi. I giudici poi hanno accertato che le accuse erano false e Aiello è
stato assolto più volte, ieri, definitivamente, dalla Corte di Cassazione. Ha
commentato così: «Finalmente posso ricominciare il mio lavoro». All’epoca la
Procura aveva chiesto il suo arresto. Non si è conclusa, invece, ma è appena
iniziata, – proprio ieri, nelle stesse ore dell’assoluzione di Ajello e della
richiesta di processo per il cavaliere – la vicenda del sindaco di Mantova che è
stato accusato dai Pm di avere concesso dei finanziamenti a una associazione
chiedendo in cambio sesso alla amministratrice di questa associazione. Il
sindaco dice che è tutto falso. Ma quello che è più curioso è che anche la
vittima della presunta concussione dice che è tutto falso. Non basta: si va
avanti. Chissà se anche questa vicenda durerà sette anni. O chissà se, nel
frattempo, la politica si convincerà che bisogna trovare il coraggio per dare un
alt a questo stillicidio che inquina la lotta politica, la degrada, e
indebolisce il prestigio della magistratura.
Fusaro: “Di
Pietro dietro le quinte ha avuto un malore ed è crollato a terra dopo la nostra
discussione”, scrive "Il Fatto Quotidiano" il 20 ottobre 2017. “Finita la
trasmissione "L’aria che Tira", il signor Di Pietro dietro le quinte si
è infuriato e ha continuato a inveire e sbraitare contro il sottoscritto, il
quale con olimpica compostezza ha ribadito fermamente che Mani Pulite fu un
colpo di Stato. Purtroppo poi si è accasciato a terra perché ha avuto un
malore”. E’ il racconto che ai microfoni de La Zanzara (Radio24) fa il
filosofo Diego Fusaro, dopo lo scontro agguerrito che lo ha visto protagonista
con l’ex leader dell’Idv a L’Aria che Tira, su La7. “Spero che ora Di Pietro
stia meglio” – continua – “Da quel che ho visto, è caduto a terra e lo staff
della trasmissione lo ha soccorso e portato via in un’altra stanza. Mi è stato
chiesto cortesemente di allontanarmi, perché, qualora mi avesse rivisto, avrebbe
avuto una ricaduta. Ci hanno dovuto separare durante la discussione, perché Di
Pietro stava per mettermi le mani addosso. Io invece ho mantenuto una
compostezza atarassica degna di Epicuro e degli dei olimpici”.
Diego
Fusaro: “Mani Pulite fu un Colpo di Stato”. Dice bene, ma motiva male.
Il filosofo durante una trasmissione in tv fa arrabbiare Antonio Di Pietro,
dicendo ciò che storicamente è ormai scontato, scrive Fabio Cammalleri il 23
Ottobre 2017 su "La Voce di New York". Ha ragione Diego Fusaro mentre l'ex
magistrato Antonio Di Pietro, nel suo opporsi ad interpretazioni che colgono il
profilo extracostituzionale di Mani Pulite, non può continuare a invocare
l’argomento giuridico-penale. Ma il limite dell'analisi del filosofo milanese
(tutta colpa del “capitalismo selvaggio americano”), lascia sottotraccia il
centro della questione: l’uomo e la sua libertà. Qualche giorno fa, Diego
Fusaro, noto saggista, docente di Filosofia nell’Istituto Alti Studi Strategici
e Politici (IASSP) di Milano (si presenta, con ineffabile dismisura, anche come
“allievo indipendente di Hegel e di Marx”), nel corso della trasmissione “L’aria
che tira”, ha affermato: “Mani Pulite fu un colpo di Stato”. Era presente
Antonio Di Pietro, che è andato in escandescenze, senza tuttavia spiegare perché
quell’affermazione sarebbe stata infondata. L’ex magistrato si è limitato a
registrare il puro fatto che esistevano i reati perseguiti. Offrendo, però, una
risposta solo apparente.
In primo
luogo, perché molte accuse mosse dal “Pool” di Milano condussero ad assoluzioni
in dibattimento: su 4.520 persone sottoposte ad indagine, 3.200 furono rinviate
a giudizio; 1.281, condannate - 965 per patteggiamento - e 1.111, assolte. 1320
casi furono trasmessi ad altre Autorità Giudiziarie. A Milano, circa 1 su due
era non colpevole.
In secondo
luogo, perchè quando si dubita (non solo da oggi, e non solo da Fusaro, come
vedremo) che l’Operazione Mani Pulite abbia avuto una portata, e un significato,
extragiudiziari, non si nega il teorico sostrato giuridico-penale del suo
oggetto (i reati). Si nega che un tale sostrato possa essere inteso solo in
termini atomistici. Cioè, considerando i reati, veri o presunti, ad uno ad uno;
e non invece, nel complesso degli effetti determinati dalle indagini e dai
processi.
Gli effetti
complessivi, a ben vedere, non furono negati nemmeno dagli stessi protagonisti
della vicenda. Il dott. Giulio Catelani, al tempo Procuratore Generale di
Milano, il 9 Maggio 1993, al quotidiano Il Giorno, dichiarò: “La nostra è una
rivoluzione legale e saggia, che dura da poco più di un anno. Ricordatevi che
quella francese è iniziata nel 1789 ma è finita solo nel 1794”. Già saggezza e
legittimità, riferite ad una “rivoluzione dei giudici”, apparivano qualità
imbonitrici; ma nel giro di un “Ricordatevi”, la loro ambiguità si risolveva nel
fanatismo e nella nequizia del “Terrore” parigino, evocato a conferire decisiva
sostanza a quell’irrefrenato compiacimento. Il paradigma rivoluzionario, anzi,
connesso alla “robe” (toga, in francese), finiva col suggellare l’assenza di
ogni moto democratico e socio-economico: crudamente inneggiando al precedente
del boia, viatico solo di approdi cruenti ed elitari. Perciò, Di Pietro, per
entrambe queste ragioni, nel suo opporsi ad interpretazioni che colgono il
profilo extracostituzionale di Mani Pulite, non può fondatamente invocare
l’argomento giuridico-penale. Si tratta di vedere se, a partire dal dato
pacifico che non fu scolastica “scoperta di reati”, sia plausibile, nei termini
proposti da Fusaro, quella urticante espressione: “Colpo di Stato”. Egli afferma
di aver già chiarito la sua critica ne “Il Futuro è nostro” (Bompiani 2014); e,
comunque, ancora nell’Aprile del 2015, precisava: “…fu un vero e proprio colpo
di Stato, che rese possibile l’abbandono del welfare State e di quelle forme
politiche che, pur corrottissime, ancora ponevano in primo piano la comunità
umana e i suoi bisogni concreti…”; “Occorreva attuare la cosiddetta “rivoluzione
liberista”, per consentire l’avvento del “…capitalismo selvaggio americano senza
diritti e garanzie”. Ponendo, in questo modo, una spiegazione di matrice
marxistica (“marxiana”, tiene, anzi, a precisare): grandi movimenti di capitale,
piccole pedine. Matrice, peraltro, nemmeno originale.
Nel 1995, il
Prof. Gianfranco La Grassa, docente di Economia Politica a Pisa e a Venezia,
che, pur attraverso successive evoluzioni, non ha mai disconosciuto il suo
“marxismo critico”, contribuì ad un volume collettaneo (“Il teatro dell’assurdo.
Cronaca e storia dei recenti avvenimenti italiani.”), e scrisse: “Questi uomini
(e partiti) non sono stati perseguiti per fini di giustizia, ma solo per motivi
politici di trapasso d’epoca, di distruzione del Welfare State all’italiana…”.
Il filosofo
Costanzo Preve (amico e maestro di Fusaro), in passato, anche coautore di un
saggio con lo stesso La Grassa (oggi, sono invece in dissidio teorico), nel 2011
dichiarò: “Alcuni anni fa mi trovai a Milano in un dibattito pubblico con
Gherardo Colombo… In sua presenza esposi… la mia tesi storico-politica… a mio
avviso Mani Pulite… di fatto, era stato un colpo di Stato giudiziario
extraparlamentare, che aveva distrutto una prima repubblica italiana, certamente
corrotta, ma anche assistenziale e proporzionalistica… Avrei anche potuto
parlare turco. Il cortese Colombo non contrappose una sua lettura storica
alternativa alla mia, ma parlò di “obbligatorietà dell’azione penale”… Ora, io
non mettevo assolutamente in discussione che i reati di corruzione e di
concussione richiedono l’obbligatorietà dell’azione penale… desideravo che il
tema non venisse soltanto discusso in modo giudiziario, ma storico. Ma fu come
passare dal turco al mongolo parlato e stretto”. Secondo Preve, Mani Pulite
avrebbe preparato il terreno ad un “personale politico” al servizio
del “…capitale finanziario e dell’impero militare americano”. Tutto questo, per
dire che la locuzione “Colpo di stato”, riferita a Mani Pulite, nel campo
variamente marxista, non è inedita, e nemmeno recente. Il limite di queste
analisi è che procedono per categorie causali così vaste (“Il capitale
finanziario americano”, Preve; “il capitalismo selvaggio americano”, Fusaro), da
lasciare erroneamente in sottotraccia il centro della questione: l’uomo, uno per
volta, e la sua libertà. Peraltro, anche considerando “il capitale finanziario”
un fattore primario nelle cose del mondo, non sarebbe stato inevitabile
accantonare l’individuo e l’avvento di un Potere Neoinquisitorio: che è, e
rimane, “l’effetto fondamentale” di Mani Pulite.
Nel 1999,
infatti, Luther Blisset Project, pseudonimo collettivo di un gruppo di
intellettuali underground, (Der Spiegel, nel 1997, scrisse che ne era parte
essenziale Umberto Eco, ma l’ipotesi non è mai stata riconosciuta, o
dimostrata), divenuto molto famoso con il romanzo “Q”, in un ricco saggio,
intitolato “Nemici dello Stato, Criminali, ‘mostri’ e leggi speciali nella
società del controllo” (Derive Approdi, 1999), a proposito di Mani Pulite,
osservavano: “Personalmente, noi ci accorgiamo che le cose non sono come
sembrano quando Sergio Cusani e Bettino Craxi nominano come difensori due noti
‘avvocati compagni’, entrambi veterani dei processi politici anni ‘70-‘80,
rispettivamente Giuliano Spazzali ed Enzo Lo Giudice.”. E pur riproponendo una
filigrana di tipo “capitalistico” (“…regolamento di conti… tra diverse sezioni
di capitale… vedi l’esempio di Mani Pulite…”), però, aggiungevano: “Mani Pulite
è l’apice del giustizialismo, dello strapotere dei Pm, della praesumptio culpae,
dell’abuso della carcerazione preventiva, della trasformazione dei magistrati in
eroi-giustizieri popolari, immacolati e impavidi.” Che è, ragionevolmente, un
riportare l’analisi dal cielo alla terra. Qui, alla fine, prevalse una “forza
logica di gravità”: a dispetto del pur citato criterio “categoriale” e
universalistico.
Indefesso
difensore, “da sinistra”, della libertà dell’uomo in carne ed ossa, è Frank
Cimini: storico giornalista critico de Il Mattino, oggi anima del blog
giustiziami.it., declina un giudizio più circoscritto e comprensibile: “Mani
Pulite fu un regolamento di conti all’interno della classe dirigente di un
paese, con la scusa della “lotta alla corruzione”. E, con tragica ironia, la
mette riassuntivamente così: “Beato chi cerca giustizia, perchè sarà
giustiziato”. Ed è proprio questo il guasto da cui non si dovrebbe mai
distogliere lo sguardo; quello di uno stabile e incontrollabile abuso sulle
libertà delle persona. Come pare faccia invece anche Fusaro: proprio laddove
intenderebbe rilanciare, e giustamente, la questione della “natura
giuridico-politica” di Mani Pulite. Sguardo che non hanno distolto altri e
autorevoli critici. Mauro Mellini, avvocato di esemplare dirittura, già Deputato
radicale e componente laico del CSM, con un’opera di indiscutibile nerbo critico
(“Il golpe dei giudici”, 1994, Spirali-Viel); o, negli Stati Uniti, Stanton H.
Burnett e Luca Mantovani, con “The Italian Guillotine. Operation Clean Hands and
the overthrow of Italy’s First Republic” (Rowman&Littlefield, 1998; che, sin dal
titolo, riconobbe giusto risalto al “modello originario”). Distogliendo lo
sguardo si rischia di dimenticare questo: “Se si creano situazioni di emergenza
nelle quali diviene indispensabile comprimere i diritti individuali, per
ripristinarel’ordinamento giuridico, allora, nell’interesse comune, sono
favorevole alle restrizioni di diritti individuali” (Francesco Saverio Borrelli,
Micromega 4/1995). Diritti individuali. Di ciascuno. Restrizioni. Si rischia di
dimenticare il lascito di Mani Pulite: regressivo nelle parole e nelle persone.
I suoi eredi. Il suo futuro.
Cosa resta del patto tra pm e giornali 25 anni dopo Tangentopoli.
Parlano gli "eretici" di Mani Pulite Cimini, Sansonetti e Facci,
scrive Nicola Imberti il 18 Febbraio 2017 su "Il Foglio". “La vera separazione
delle carriere che la politica dovrebbe fare è quella tra giornalisti e
magistrati inquirenti”. Frank Cimini pronuncia la frase con leggerezza, a mo’ di
battuta. Confermando la capacità, che in tanti gli riconoscono, di dire sempre
quello che pensa. Soprattutto quando si tratta di magistrati. Per gli
etichettatori seriali è una “voce fuori dal coro”. Fin da quando, dopo aver
fatto il ferroviere e il giornalista praticante del Manifesto, entrò per la
prima volta al Palazzo di Giustizia di Milano, alla fine degli anni Settanta.
Poi, nel 1992, l’inizio di Tangentopoli. Da cronista del Mattino Cimini racconta
ciò che sta accadendo. Anche quello che gli altri sembrano non vedere. Anni dopo
ci sarà chi scriverà di un patto tra magistrati e giornalisti. Informazioni
selezionate e distribuite accuratamente alla stampa, telefonate tra i vertici
dei principali quotidiani per decidere la linea, articoli che colpivano con
precisione chirurgica. “In realtà – spiega al Foglio – questo meccanismo che
lega inquirenti e mezzi di informazione c’è sempre stato. Soprattutto nella fase
delle indagini preliminari in cui il pm è il signore assoluto. Durante
Tangentopoli ci fu uno scambio. Gli editori dei “giornaloni” si schierarono e
ottennero l’impunità. Fu un do ut des”. Insomma, per Cimini, non c’era bisogno
di sottoscrivere accordi, tutto si svolse quasi “naturalmente”. Meno “naturale”
fu invece il potere che i magistrati si trovarono a gestire: “Dopo che la
politica aveva affidato il compito di risolvere il problema del terrorismo, nel
1992 decisero di “presentare il conto”. Vedendo che la politica era debole,
decisero di scardinarla. Così diventarono un potere che nessuno è più riuscito
ad arginare”.
Eppure guardando a ieri e a oggi, è difficile non cogliere delle analogie, un
paradigma che si ripete. Soprattutto quando si parla di inchieste giudiziarie
che finiscono centellinate sulle pagine dei giornali. “E’ vero – dice Piero
Sansonetti – il paradigma è lo stesso, ma c’è una differenza sostanziale”.
Sansonetti, che adesso dirige Il Dubbio, nel 1992 era all’Unità, ed è stato uno
dei primi a raccontare di quel “pool” di giornalisti e direttori che, in maniera
coordinata, pubblicava le notizie fornite dai pm di Milano. “Quel patto non è
mai stato sciolto. Ma a quell’epoca c’era un disegno politico molto preciso. Il
pool di Milano si sentiva investito di un compito etico, quello di purificare la
società e lo stato. L’obiettivo era demolire la democrazia dei partiti. Che
infatti da allora non è più esistita, mentre la magistratura ha conquistato un
potere politico abnorme che nessuno ha più messo in discussione”. “Oggi –
aggiunge – non vedo un disegno preciso. Certo, il meccanismo è lo stesso. Prenda
il caso Raggi. Si vìola il segreto d’ufficio, i quotidiani pubblicano le stesse
notizie con gli stessi titoli, ma qual è il disegno? Mi sembra difficile
sostenere che la magistratura voglia colpire i grillini. Piuttosto direi che si
tratta di gruppi singoli che puntano a garantirsi il proprio potere. A mostrare
la loro forza. E comunque resta una domanda: perché davanti a violazioni palesi
del segreto d’ufficio non ci sono mai indagini?”.
Filippo Facci, altro giornalista “eretico” di quella stagione nonché autore di
un libro dal titolo “Di Pietro. La storia vera”, non vede un parallelismo tra
passato e presente: “Quello che accadde con Tangentopoli è un fatto mai accaduto
prima. C’era un pool di giornalisti che comprendeva tutti e la distribuzione era
equanime. Non solo, alcuni cronisti erano apertamente schierati e il loro
comportamento aveva dei fini istruttori. Perché i materiali, le carte, i nomi
che venivano forniti servivano per favorire il pellegrinaggio in procura dei
protagonisti di quelle inchieste. Prima di allora c’erano degli schieramenti: ad
esempio il Corriere con il Giornale, Repubblica con l’Unità. Ma servivano più
che altro per coprirsi in maniera minima su alcune notizie”. E poi c’era il
contesto. “Il 95 per cento dell’opinione pubblica era schierato. Anche allora
c’era la crisi economica – sottolinea – ma si pensò che il malcontento potesse
essere canalizzato e che la colpa definitiva potesse essere attribuita ai
tangentari. Oggi no. C’è una tale indolenza. Le vicende della Raggi, ad esempio,
sono imbarazzanti sia perché insopportabilmente faziose, sia perché i grillini
reagiscono in maniera scomposta riproponendo, quasi 50 anni dopo, campagne
contro un altro Calabresi. Ma non ci vedo né un particolare protagonismo dei pm,
né la volontà di renderli protagonisti. Mi pare più una forma di gratificazione.
Un compiacimento, un mantenere alta l’attenzione mediatica attorno a inchieste
che ci rendono protagonisti”.
Quelle trame Davigo-Grillo per estromettere Berlusconi.
Tre incontri con l'ex pm per ideare l'emendamento che vieterebbe al Cavaliere di
rimanere capo politico, scrive Giampiero Timossi, Domenica 1/10/2017, su "Il
Giornale". Piercamillo Davigo è un uomo d'ingegno e infatti non perde occasione
per ricordare: «I magistrati non possono far politica, non la sanno fare». Solo
che poi dimentica quello che dice a verbale e ascolta la voce del suo Io
interiore. È un quarto di secolo che uno degli eroi del pool di Mani Pulite
continua a far politica. Lasciata la guida dell'Associazione Nazionale
Magistrati e tornato in Cassazione, Davigo corre da un convegno all'altro, passa
dalla festa del Fatto Quotidiano (dove ovviamente ribadisce il concetto che i
magistrati non sanno fare politica), quindi incontra il leader del movimento che
gli piace di più, i Cinque Stelle di Beppe Grillo. «Tre incontri nelle ultime
tre settimane», trapela dall'entourage grillino. Tre incontri per mettere
definitivamente a punto la regola «ammazza-Berlusconi». Un emendamento al
rispolverato Rosatellum che dice: «Chi è incandidabile non potrà essere il capo
politico di una coalizione». Così l'insidia Berlusconi sembra neutralizzata con
un emendamento ad personam, alla faccia della decisione della Grande Chambre
della Corte dei diritti dell'uomo, che si dovrebbe pronunciare entro il 22
novembre sul ricorso presentato dai legali dell'ex premier. L'ultima variante in
commercio dell'«ammazza-Berlusconi» arriva da un'idea nata qualche settimana fa
e ha iniziato a prendere forma quando sono uscite le regole, tutte nuove, per
trovare il candidato premier. C'era il palese tentativo, ovviamente riuscito, di
«blindare» l'elezione dell'indagato Di Maio. Ma c'era anche dell'altro, perché
il nuovo testo sentenziava: chi vincerà la consultazione on-line diventerà
subito nuovo capo del partito. Una definizione in apparenza quasi anacronistica,
per alcuni vuota di un vero significato e capace solo di irritare la fronda
grillina contraria all'ascesa di Di Maio. Storie, ora quella precisazione rende
ancor più chiaro il progetto nato dalla coppia Davigo-Grillo: «sostituire» il
capo politico del M5s. Perché, in base all'emendamento presentato due giorni fa,
anche il comico genovese non potrebbe guidare il Movimento. Impossibile per chi,
come lui, è stato condannato in via definitiva. Lo ha già fatto? Vero, ma ora
non più, così come in passato Grillo non era stato candidato, per non violare
apertamente i paletti della legge Severino. Adesso, con il solito tempismo, il
leader comico ha lanciato la «rivoluzione d'ottobre», vuol far sapere che tutto
il potere è nella mani di «Giggino», mentre lui farà ancora una volta un passo
di lato, per poi sostenere commosso «che non lascerà mai», ma cercando in verità
di smarcarsi. Ed è tutto uno smarcarsi, giusto per restare sempre in campo, ma
nelle posizioni ogni volta più congeniali alle proprie aspirazioni politiche.
Vale per Grillo, certo. Ma potrebbe anche valere per Davigo. Lui, o chi per lui,
aveva cullato il sogno che qualcuno lo investisse dell'ingrato compito di
diventare il candidato premier a Cinque Stelle. Il gioco sarebbe valso la
candela: anche se un magistrato non sa fare politica potrebbe sempre imparare,
soprattutto se in palio c'è la possibilità di governare l'Italia. Solo che
nessuno ha chiesto alla toga di diventare premier, perché era già tutto
apparecchiato per servire Di Maio. Pazienza, resterebbe viva l'ipotesi di una
futura nomina a ministro di Giustizia, magari dirottando il collega Nino Di
Matteo all'Interno. Ipotesi, per ora. Perché tra tanti concorrenti, alla fine
Davigo potrebbe spiccare il volo. Diventando per i Cinque Stelle il candidato
ideale per la presidenza della Repubblica. Passando da Tangentopoli al
Quirinale, grazie a una marcia lunga 25 anni. E un percorso alternativo davvero
ingegnoso.
POLITICA DELLA PAURA, scrive il
3-10-2017 “L’Avanti". “Un consenso che si fonda sulla paura delle manette”:
parte da qui la proposta socialista per l’istituzione urgente di una commissione
di inchiesta parlamentare attorno agli effetti dell’inchiesta giudiziaria “Mani
Pulite” sulle elezioni politiche del 1994 e sul sistema politico italiano degli
anni successivi. L’iniziativa è nata in seguito alle dichiarazioni dall’ex
magistrato Antonio Di Pietro, rilasciate ad alcuni organi di informazione. “Ho
fatto una politica sulla paura” – ha detto Di Pietro, già leader del movimento
politico Italia dei Valori. “La paura delle manette, l’idea che “sono tutti
criminali”, la paura che chi non la pensa come me sia un delinquente. Poi alla
fine, oggi come oggi, avviandomi verso la terza età, mi sono accorto che bisogna
rispettare anche le idee degli altri”. E ancora: “Ho fatto l’inchiesta Mani
Pulite, e con l’inchiesta Mani Pulite si è distrutto tutto ciò che era la
cosiddetta Prima Repubblica: il male, e ce n’era tanto con la corruzione, ma
anche le idee, perché sono nati i cosiddetti partiti personali”. La proposta di
legge è stata presentata dal Psi in entrambi i rami del Parlamento e porta la
prima firma del deputato Oreste Pastorelli alla Camera e del senatore Enrico
Buemi a Palazzo Madama. “Vogliamo fare chiarezza sul comportamento di un
magistrato – afferma Nencini nella conferenza di presentazione della proposta –
che dichiara vent’anni dopo: “Abbiamo raggiunto il consenso grazie alla paura
delle manette’. Siccome questo non è uno stato inquisitorio, ma uno stato di
diritto, vogliamo capire cosa si nasconde dietro a ciò che dichiara un ex
magistrato”. Il segretario del Psi precisa che “non si tratta di legare la
commissione d’inchiesta a questo o quel partito. Non chiediamo di indagare su
tangentopoli, di cui non ci interessa nulla, chiediamo che la commissione lavori
per capire cosa c’è dietro” alle parole di Di Pietro: “È stato applicato il
diritto o la paura delle manette? Vogliamo chiarezza su questo punto”. “Di
Pietro – dice ancora Nencini – ha parlato di ‘politica della paura e delle
manette: parole da Stato inquisitorio, non da Stato di diritto, termini lontani
da una giustizia giusta. Con una commissione d’inchiesta vogliamo sapere se i
metodi utilizzati siano stati generalmente quelli ricordati da Di Pietro e se i
diritti della difesa siano stati lesi o garantiti. Di Pietro renda ancora più
esplicita la sua dichiarazione di cui riconosciamo il coraggio: con politica
della paura e delle manette a chi si riferisce? Al clima generale del tempo o
dietro la frase ci sono nomi e persone precise che sono state arrestate ed
escluse dalla politica? Serve un secondo atto di coraggio, Di Pietro riempia di
contenuti queste parole”. Per Nencini ormai esiste la “giusta distanza storica
per cercare la verità oggettiva. Vogliamo ripristinare la verità storica e
crediamo che la strada maestra per far luce sia quella parlamentare”. Si
tratterebbe di una commissione d’inchiesta bicamerale, composta da 20 deputati e
20 senatori, con un rappresentante per ciascun gruppo presente in Parlamento. La
durata della commissione è prevista di sei mesi. “Vogliamo – aggiunge Enrico
Buemi- che sia ristabilita una verità storica a prescindere dalle sentenze.
Quello insomma di verificare lo stato di diritto in un Paese democratico é un
dovere. Occorre capire se si è agito in nome della legge o se si sono usati
altri percorsi”. “Non é nostro obiettivo quello di individuare responsabilità
personali, non è questo il punto. L’obiettivo è la ricerca delle verità. Una
verità storica prescindendo dalle sentenze che ormai sono passate in giudicato”.
La commissione dovrà occuparsi anche di un altro punto. “Quello della pressione
mediatica che è scesa in campo con tutto il peso di cui disponevano i mass
media”. Pia Locatelli, vicepresidente dell’Internazionale socialista e
capogruppo Psi alla Camera, ricorda Moroni “che perse la vita oppure i danni
arrecati a Del Turco e Mastella. Di Pietro fa un revisionismo di comodo. È
lapalissiano che voglia candidarsi. D’Alema ha riabilitato Bettino Craxi con
parole degnissime, ma in ritardo di qualche lustro”. Per Oreste Pastorelli “il
tema interesserà l’intera politica. Non deve essere un argomento dei socialisti,
ma della politica in generale. E dopo le parole di uno degli attori principali
di quel periodo ci siamo sentiti in dovere di chiedere l’istituzione di una
commissione per far emergere la verità”.
Nencini: «Paura e manette, ora la politica indaghi su
Tangentopoli», scrive Giulia Merlo il 4 Ottobre 2017
su "Il Dubbio". Dopo le “confessioni” di Antonio Di Pietro, i socialisti
chiedono una commissione d’inchiesta: «Mani pulite ha distrutto i partiti del
‘900». Una commissione d’inchiesta parlamentare sul Tangentopoli, per chiarire
gli effetti dell’inchiesta sulle elezioni del 1994. La proposta, presentata alla
Camera dal Partito socialista, «nasce dalle dichiarazioni del leader del pool,
Antonio Di Pietro, il quale alcuni giorni fa ha dichiarato: “Abbiamo costruito
il consenso sulla paura delle manette”», ha spiegato Riccardo Nencini,
segretario socialista e viceministro dei Trasporti.
I socialisti chiedono una commissione d’inchiesta su
Tangentopoli. La vendetta è un piatto che va servito freddo?
«Non c’entra nulla. Guardi, avrei
trovato gravi le parole di Di Pietro anche se militassi in un partito diverso.
Si tratta di dichiarazioni che suscitano reazioni al di là dell’appartenenza
politica: quando un ex magistrato, riferendosi alla sua attività negli anni in
cui vestiva la toga, mette insieme «consenso» e «paura delle manette», crea un
connubio proprio degli stati inquisitori e totalitari. A lei non sembra
pericoloso, in uno Stato di diritto? A questo bisogna pensare, indipendentemente
dall’appartenenza politica dei singoli».
E quale mandato dovrebbe avere la commissione d’inchiesta?
«La commissione dovrà fare anzitutto
chiarezza. Già ne 1992 e negli anni successivi si mise in dubbio la tecnica con
cui venne portata avanti l’inchiesta di Mani Pulite, e ora quei dubbi trovano
conferma nelle parole del massimo protagonista di quel periodo. Di più, le sue
ammissione aprono il campo a ulteriori domande».
Per esempio?
«Per esempio bisogna chiarire se il
sistema utilizzato nelle indagini e nell’inchiesta sia stato corretto e se i
diritti della difesa siano stati lesi o meno. Se, come ha detto Di Pietro, è la
paura delle manette che crea il consenso per proseguire l’indagine, in cosa si
sostanzia questa paura delle manette? Di Pietro dovrebbe essere più chiaro: c’è
un riferimento specifico, dietro le sue parole? La mia non è una illazione
politica ma una riflessione a partire da ciò che ha dichiarato un magistrato
importante, nell’interesse dello Stato».
Lei immagina che si sia trattato di una linea di condotta
generalizzata nella magistratura dell’epoca?
«Io mi chiedo e vorrei chiedere a Di
Pietro se quello che ha descritto era una fenomeno che riguardava soltanto lui.
Dopo questa prima ammissione di verità, anche coraggiosa da parte sua, ne
dovrebbe seguire una più specifica: lui sostiene che si costituì il consenso
sulla paura delle manette, e allora dovrebbe fare nomi, cognomi, episodi…»
Il giudizio è pesante e rischia di cadere sull’intera categoria
della magistratura.
«Senta, conosco ottimi magistrati e so
benissimo che non tutti la pensano come Di Pietro. Si tratta, però, di
dichiarazioni pubbliche mai smentite e in un paese civile si ha il dovere di
chiedere di più, soprattutto vista la rilevanza avuta da Tangentopoli nella
storia del Paese».
Che effetti ha provocato Tangentopoli per la politica italiana?
«Intanto ha consentito l’anticipazione
di alcuni fatti: l’Italia è stato il primo Paese a sperimentare la politica
dell’uomo solo al comando, dopo la distruzione dei partiti. Il fenomeno è
apparso anche altrove, negli anni successivi, ma lì i partiti sono rimasti,
anche se hanno cambiato caratteristiche e organizzazione. Da noi, invece, Mani
Pulite ha imposto un’accelerazione al fenomeno della distruzione dei partiti di
stampo novecentesco, dovuta non a un cambiamento sociale ma all’intervento della
magistratura».
Eppure, riprendendo le parole di Di Pietro, di quale «consenso»
aveva mai bisogno la magistratura, per condurre quell’inchiesta?
«E’ esattamente questo il punto da
chiarire: proprio perché la magistratura non ha bisogno di consenso il fatto è
grave. Un’indagine non si parametra sul consenso che esternamente si riceve,
eppure nel 1992-‘ 93 Di Pietro ha ritenuto che il consenso fosse necessario per
procedere a tappe forzate in un’indagine di cui ben conosciamo gli esiti. Non
solo, rimane aberrante il binomio manette consenso, che poco ha a che vedere con
l’esercizio della giustizia ma adombra l’inquietante sensazione di un potere
giudiziario che punta a volersi sostituire al potere politico».
A 25 anni da Tangentopoli, in questi mesi si sta allungando la
lista di politici assolti dopo inchieste molto enfatizzate sulla stampa. La
politica ha ora buone ragioni per rifarsi sulla magistratura?
«No, io non credo che la politica viva
un senso di rivalsa. Rilevo però, citando solo due casi, che l’inchiesta su
Mastella provocò la caduta del governo Prodi, mentre il caso Orsoni ha azzerato
il comune della città di Venezia. Tutto questo mi fortifica nelle mie
convinzioni: la necessità della separazione delle carriere tra giudice e pm e
della responsabilità civile dei magistrati».
Tornando alla commissione d’inchiesta, lei crede che troverà
consenso tra i suoi colleghi in Parlamento?
«Ma certo, io spero che i colleghi mi
diano il sostegno. Immagino che siano preoccupati quanto me se un ex magistrato,
riferendosi alla sua precedente attività in toga, si esprime nei termini usati
da Di Pietro. Oggi presenteremo la proposta di legge alla Camera, poi lo faremo
al Senato e speriamo sia calendarizzata. Se così non fosse, ci rivolgeremo al
ministro della Giustizia, Andrea Orlando».
Di Pietro confessa: "Ho fatto politica sulla paura delle
manette". Il mea culpa dell'ex magistrato, che ammette
di aver considerato "un criminale" chiunque non la pensasse come lui. La feroce
(tardiva) autocritica del paladino di Mani Pulite, scrive Valerio Valentini l'8
Settembre 2017 su "Il Foglio". A dire certe cose di Antonio Di Pietro – tipo
che l'ex pm ha costruito il consenso politico sulla paura delle manette,
demonizzando qualsiasi avversario politico e dipingendo un'intera classe
dirigente come una masnada di criminali – si rischiava di passare subito per
biechi antidipietristi difensori di tangentisti e corrotti. Almeno fino ad oggi.
Perché ora, a dire certe cose di Antonio Di Pietro, è proprio l'ex magistrato.
La confessione, o se preferite il mea culpa, arriva durante un collegamento
video con lo studio di “L'Aria che tira estate”, trasmissione condotta da David
Parenzo su La7. Mancano pochi minuti a mezzogiorno, e il dibattito in studio si
trascina, un po' stancamente, sulla propaganda di alcuni partiti che speculano
sull'infondato timore della diffusione di malattie letali legate all'arrivo dei
migranti, quando Di Pietro coglie l'occasione per ammettere le proprie “colpe”.
“Se si cerca il consenso con la paura, lo si può ottenere a 3 giorni, a
un'elezione, ma poi si va a casa. Io ne sono testimone, ché ho fatto una
politica sulla paura e ne ho pagate le conseguenze”. Sgomento e incredulità tra
gli ospiti, ma solo per un attimo. Poi subito scatta l'applauso, con Parenzo che
chiede all'ex leader dell'Italia dei Valori di chiarire meglio il significato
delle sue dichiarazioni: “In che senso, paura?”. Risponde Di Pietro: “La paura
delle manette, la paura del, diciamo così, “sono tutti criminali”, la paura che
chi non la pensa come me è un delinquente e quant'altro. Poi alla fine, oggi
come oggi, avviandomi verso la terza età, mi rendo conto che bisogna rispettare
anche le idee degli altri”. Lo stupore per questa inattesa, feroce autocritica,
è enorme. Tanto che sia l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, sia la deputata
berlusconiana Laura Ravetto insieme alla collega renziana Simona Malpezzi,
restano indecisi su come reagire. Il primo a parlare è Luigi Crespi, ex
sondaggista di fiducia del Cav, che soddisfatto afferma: “Questo è un pezzo di
storia”. Cui si aggiunge, subito dopo, anche un passaggio su Tangentopoli: “Io
porto con me una conseguenza. Ho fatto l'inchiesta Mani Pulite, con cui si è
distrutta l'intera Prima Repubblica: il male, e ce n'era tanto con la
corruzione, ma anche le idee. Ed è così che sono nati i cosiddetti partiti
personali: Di Pietro, Bossi, Berlusconi e quant'altro. Ovvero partiti che hanno
al massimo il tempo della persona”. A qualcuno, certo, potrà forse apparire
tardivo, questo radicale ripensamento. A qualcuno perfino sospetto, arrivando a
pochi giorni di distanza dall'annuncio semiserio dello stesso Di Pietro su un
suo eventuale ritorno in politica – magari tra le schiere dei bersaniani di Mdp.
Intanto, comunque, la deposizione può essere messa agli atti. Poi si vedrà.
A 25 anni dalla morte di Moroni non c'è bisogno di Di Pietro per
capire i danni di Mani Pulite. L'ex pm avrebbe fatto
autocritica sull'inchiesta. Ma se proprio vuole, promuova la separazione delle
carriere o magari spieghi come certo uso dell’odio sia divenuto moneta corrente
per le giovani generazioni, scrive Fabio Cammaleri il 27 Settembre 2017 su "Il
Foglio". La notizia sembra questa: che Antonio Di Pietro avrebbe svolto
un’autocritica su Mani Pulite. Più in particolare, ha affermato di aver capito,
a 67 anni, che “...ho fatto una politica sulla paura...la paura delle
manette...la paura del, diciamo così, ‘sono tutti criminali’, la paura che chi
non la pensa come me sia un delinquente”. E poi aggiungendo: “...con l’inchiesta
Mani Pulite, si è distrutto tutto ciò che era la cosiddetta Prima Repubblica: il
male, e ce n’era tanto con la corruzione, ma anche le idee, perché sono nati i
cosiddetti partiti personali”. Mani Pulite, e la sua critica storico-sistemica
accompagnano alcuni, pochi, convinti dubbiosi, da molti anni: perciò, per
costoro, nessuno stupore. Critica ai suoi presupposti: la deliberata
indistinzione fra piano individuale, il delitto; e piano generale, il
finanziamento dei partiti di massa in un contesto internazionale parabellico.
Critica, soprattutto, al suo svolgimento, che è diventato la sua più durevole
conseguenza: la strumentale soppressione, per deformazione, del processo penale.
E senza processo penale, non ci può essere democrazia, ovviamente. E’ ovvio che
la “Rivoluzione Italiana” sia stato questo. E nemmeno stupisce l’allocuzione del
Nostro: che di uscite apparentemente sorprendenti, e irrelate le une alle altre,
ha costellato il suo profilo pubblico. Le parole su una qualsivoglia causa (qui,
Mani Pulite) svaniscono nell’irrisorio, quando non ricevano nerbo e autorità da
un’azione sulle conseguenze (qui, lo svuotamento democratico della Repubblica
Italiana). Caso vuole che in questi giorni sia venuto il XXV anniversario di un
certo fatto. Così ci capiamo. Fu invece un fatto esplicativo, quello: non solo
per lo specifico modo in cui cadde sulla vita civile della comunità nazionale.
Ma perché svelò un Catone Uticense del nostro tempo: che seppe fissare,
lucidamente, la portata di Mani Pulite sulla democrazia italiana. In corso
d’opera. Con orgoglio tragico levò la sua voce contro quegli infausti fasti,
intessendo la sua parola di umana verità, di suprema verità. A capo chino,
volgiamoci alla sua memoria: “...quando la parola è flessibile, non resta che il
gesto. Mi auguro solo che questo possa contribuire a una riflessione più seria e
più giusta, a scelte e decisioni di una democrazia matura che deve tutelarsi. Mi
auguro soprattutto che possa servire a evitare che altri, nelle mie stesse
condizioni, abbiano a patire le sofferenze morali che ho vissuto in queste
settimane, a evitare processi sommari (in piazza o in televisione), che
trasformano un’informazione di garanzia in una preventiva sentenza di condanna.
Con stima. Sergio Moroni”. Era il 2 Settembre di venticinque anni fa. Scriveva
al Presidente della Camera, Giorgio Napolitano. Il “gesto”, come si ricorderà,
prese la forma di un colpo di carabina con cui il deputato socialista si uccise:
“l’atto conclusivo di porre fine alla mia vita”, nelle sue parole. Fu trovato la
sera, riverso nella cantina della sua casa di Brescia. Aveva 45 anni. Venne
affermato che poteva averlo fatto per la vergogna. Oppure perché aveva un
tumore. Il tumore fu smentito il giorno dopo dal fratello, con mesta nettezza.
Sulla vergogna, su chi e perché, se ne potrebbe ancora discutere. Giustappunto.
Era Segretario regionale lombardo del Partito, e membro della Direzione
Nazionale. Poco prima aveva ricevuto due avvisi di garanzia, per “tangenti”,
come recava il “gergo originario” di Mani Pulite. Ancora nessun atto d’indagine
nei suoi confronti: allora occorreva l’autorizzazione a procedere. A quel modo,
la concesse lui: poiché aveva esordito scrivendo, in un empito di tragico
sarcasmo, che “l’atto conclusivo” serviva, in primo luogo, a “lasciare il mio
seggio in Parlamento”. Nell’Ottobre dell’anno dopo, anche la democrazia
parlamentare compiva il suo “atto conclusivo”: firmando una resa senza
condizioni. Con la Legge costituzionale n. 3 del 29 Ottobre 1993, fu abrogata
l’autorizzazione a procedere. Tuttavia, la tragedia fu più sfumata: perché quei
Deputati e Senatori non disposero di un bene proprio, ma delle libertà
costituzionali della Repubblica e, in relazione diretta, di ogni suo cittadino;
da quel giorno in poi, e in un crescendo tuttora in atto, divenuto suddito di un
Apparato burocratico sovraordinato ad ogni altra istituzione. Da quel Settembre
1992, molto diritto è passato al macero; molte vite si sono spente. E Sergio
Moroni l’aveva previsto. “E’ indubbio che stiamo vivendo un cambiamento radicale
sul modo di essere nel nostro Paese, della sua democrazia, delle istituzioni che
ne sono espressione.” Era leale, Sergio Moroni: “Mi rendo conto che spesso non è
facile la distinzione tra quanti hanno accettato di adeguarsi a procedure
legalmente scorrette in una logica di partito, e quanti invece ne hanno fatto
strumento di interessi personali. Rimane comunque la necessità di
distinguere...”. Per deliberata scelta di taluni, è noto, non si volle
distinguere. Si scelsero le monetine contundenti, autentica effigie fondativa di
quella svolta autoritaria: “Non credo che questo nostro Paese costruirà il
futuro che merita coltivando un clima da ‘pogrom’ nei confronti della classe
politica...”. No. Infatti. Nel crescente disprezzo verso quanti coltivarono e
coltivano la necessità di distinguere, il Paese, nelle turbe, come dalle
cattedre dell’Apparato, da allora, si è dato a ricostruire il suo passato più
buio: per la convivenza civile, per la conoscenza, per la libertà personale. E
non c’era davvero bisogno di Antonio Di Pietro per scoprirlo. Se proprio vuole,
promuova la separazione delle carriere, fra magistrati che accusano e magistrati
che giudicano; o spieghi come, secondo lui (ricordando fatti, persone, luoghi,
atti, però), certe centrali di propaganda sono sorte, come e perché si sono
alimentate; come certo uso dell’odio sia divenuto moneta corrente per le giovani
generazioni; come il Parlamento sia divenuta un’istituzione non più libera; e
altro ancora, che più o meno ogni coscienza libera sa essere materia per il
“Libro Proibito” della Seconda Repubblica. Oppure, confidi nell’oblìo.
Devastati da Mani Pulite. Non ha
sconfitto la corruzione, ha alimentato il populismo e ha legittimato la
moralizzazione pubblica per via giudiziaria. Eccola l’eredità di Tangentopoli,
scrive Giovanni Fiandaca il 30 Marzo 2017 su "Il Foglio”. Che vi sia, a un
quarto di secolo ormai di distanza, l’esigenza di una approfondita rivisitazione
storico-critica della cosiddetta rivoluzione giudiziaria di Mani Pulite, presumo
che non siamo in pochi a pensarlo. E’ vero che il venticinquesimo “anniversario”
ha già sollecitato qualche rievocazione giornalistica, ma siamo ancora lontani
dall’avere aperto quella discussione pubblica vera, finalmente emancipata da
ipocrisie moralistiche e pudori politicamente corretti, che sarebbe necessario
una buona volta avviare. Non soltanto per comprendere meglio quel che avvenne
allora, ma anche per verificare se alcune persistenti patologie possano ancora
essere fatte risalire a quel recente passato. Tra queste patologie, alludo in
particolare a quella perdurante nevrosi politico-istituzionale che continua a
provocare conflitti tra politica e magistratura: e fa sì che la stessa politica
odierna subisca forti condizionamenti da un’azione giudiziaria che tende a
tutt’oggi a realizzare invasioni di campo in ambiti politicamente rilevanti e,
nello stesso tempo, a esercitare un controllo di legalità di fatto esorbitante
da quegli spazi fisiologici che dovrebbero in teoria spettare al potere
giudiziario. Un bilancio per comprendere quel che avvenne allora e verificare
quali patologie possano essere fatte risalire a quel recente passato. Non
intendo procedere a una revisione critica della contabilità giudiziaria
(rapporti numerici tra indagati, incarcerati, scarcerati, prosciolti, condannati
o assolti ecc.) riportata di recente in più di un intervento rievocativo.
Rinviando ad una verifica già effettuata su queste colonne (cfr. l’articolo di
Maurizio Crippa del 17 febbraio scorso), escluderei infatti che a orientare la
rivisitazione di Mani pulite possa essere soltanto un approccio di tipo
quantitativo circoscritto al concreto esito delle indagini e dei processi
celebrati in quel periodo. Il discorso è più ampio e complesso, dal momento che
ben trascende la conta ragionieristica delle condanne e riguarda piuttosto,
com’è facile intuire, due questioni di fondo assai spinose: l’una concernente i
rapporti sistemici tra giustizia e politica; l’altra relativa ai limiti di
compatibilità tra una guerra a tutto campo alla corruzione e un pur equilibrato
rispetto dei principi del garantismo penale. L’affossamento per via giudiziaria
del precedente sistema basato sui partiti nati dalla Resistenza, non è stato
soltanto un terremoto politico: è stato anche un trauma costituzionale, e ciò
per il motivo evidente che la criminalizzazione di quasi un intero asseto
politico-governativo esula dalle funzioni tipiche della giurisdizione penale.
Ora, questa traumatica rottura dell’equilibrio tra i poteri avrebbe potuto
trovare una ragione giustificatrice, beninteso secondo una unilaterale logica
utilitaristica di risultato (altro è il discorso guardando da una prospettive
più ampia, comprensiva di tutti i valori, principi ed equilibri anche
costituzionali in giuoco), ad una condizione: a condizione cioè che la macchina
da guerra repressiva riuscisse davvero a sortire come effetto una durevole
sconfitta della corruzione pubblica. Cosa che però, come tutti sappiamo, non è
invece avvenuta. E lo riconoscono apertamente persino magistrati protagonisti di
allora, come Piercamillo Davigo il quale, invero, non si stanca di denunciare
che la corruzione è andata estendendosi in maniera più capillare ed è andata via
via assumendo forme nuove. Viene spontaneo, allora, chiedersi: valeva la pena
che la repressione penale spazzasse via un ceto politico che, riguardato col
“senno di poi” – e tanto più se messo a confronto con le poco felici
performances almeno di alcuni dei protagonisti delle stagioni politiche
successive – , ci appare forse meno incapace e indegno di quanto in quel momento
non sembrasse? E valeva altresì la pena che la repressione, per di più,
assumesse maniere così drastiche da perdere di vista che la lotta alla
corruzione non avrebbe potuto in ogni caso giustificare un utilizzo più che
disinvolto di carcerazioni preventive finalizzate alla collaborazione
giudiziaria né, a maggior ragione, logiche inquisitorie suscettibili di
accrescere il rischio (forse non sempre astratto) di reazioni suicidiarie?
Secondo una stima recente relativa al periodo 1992-1994, i suicidi di persone
coinvolte dalle indagini ammonterebbero al numero tutt’altro che irrilevante di
32! Il frutto di quell'epoca, oggi, è un'azione giudiziaria che tende a
realizzare invasioni di campo in ambiti politicamente rilevanti. Gli ostinati
difensori di Mani Pulite potrebbero, nonostante tutto, obiettare che la
rivoluzione giudiziaria fu oggettivamente necessitata tanto nel suo ambito di
estensione, quanto nelle sue risolute modalità di attuazione. Ma solo una
ingenuità puerile o un pregiudizio favorevole contiguo al fanatismo possono
indurre a crederlo davvero: in realtà, quanto e come intervenire la macchina
giudiziaria non può mai deciderlo da se stessa, in modo automatico e
impersonale; lo decidono, con ampia discrezionalità di fatto se non di diritto,
i magistrati in carne ed ossa competenti a farla funzionare. Ciò è tanto più
vero di fronte ad una impresa giudiziaria priva di precedenti come quella
milanese: questa inusitata impresa non avrebbe, in effetti, potuto vedere la
luce se il pool di pubblici ministeri non si fosse intenzionalmente accollata la
missione di ripulire la vita pubblica e moralizzare la politica al fine di
promuovere un ricambio della classe dirigente, credendo di assolvere così una
sorta di mandato popolare neppure tanto tacito. E, infatti, i giudici
ricevettero un esplicito ed entusiastico sostegno da parte di una opinione
pubblica politicamente trasversale e di quasi tutto il sistema mediatico: per
cui essi finirono col sentirsi legittimati a portare avanti questa vasta azione
repressiva, più che in forza di un astratto obbligo legale, dalla diffusa
richiesta popolare di fare piazza pulita della partitocrazia corrotta. Che
all’origine di Mani Pulite vi fu (e non poteva non esserci) un complesso
intreccio di fattori oggettivi di contesto e di protagonismo soggettivo sul
versante magistratuale è del resto un assunto che trova conferma anche in alcune
significative testimonianze di quella fase storica, così come riportate in
qualche saggio ricostruttivo apparso in questo venticinquennio. Leggendo ad
esempio la storia di Tangentopoli scritta da Marco Damilano (Laterza 2012), ci
si imbatte in questo emblematico giudizio di un osservatore privilegiato come il
noto imprenditore Carlo De Benedetti: “Una combinazione di protagonismo dei
giudici e di un vaso ormai troppo pieno” (dove è chiaro che per vaso troppo
pieno è da intendere una grave situazioni di crisi a più livelli). Orbene,
proprio questo forte attivismo giudiziario, in funzione miratamente
antagonistica rispetto al sistema partitico di allora, ha determinato non
soltanto una esposizione politica della procura milanese eccedente i
contraccolpi oggettivamente destabilizzanti che le indagini sulle vicende
corruttive avrebbero comunque prodotto sulla tenuta dei partiti di governo: si è
invero assistito a una sovraesposizione politica che ha finito con l’assumere la
caratteristica aggiuntiva di un paradigmatico populismo giudiziario. Intendendo
per tale, appunto, la forma di manifestazione del populismo penale sul piano
specifico della giurisdizione: fenomeno che ricorre tutte le volte in cui il
magistrato pretende, anche grazie a una frequente esibizione mediatica, di
assurgere ad autentico rappresentante o interprete dei veri interessi e delle
aspettative di giustizia dei cittadini, e ciò in una logica di
concorrenza-supplenza e in alcuni casi di aperta contrapposizione rispetto al
potere politico ufficiale. Non è un caso, allora, che questa figura di
magistrato-tribuno, oltre ad impersonare di fatto un ruolo ibrido di attore
giudiziario-politico-mediatico, finisca col cedere alla tentazione di entrare in
politica e talvolta col dare persino vita a movimenti anti-sistema di impronta
personale: le esemplificazioni sono così note che possiamo qui fare a meno di
esplicitarle. Il frutto di quell’epoca, oggi, è un’azione giudiziaria che tende
a realizzare invasioni di campo in ambiti politicamente rilevanti. Sembra,
dunque, abbastanza plausibile sostenere che Mani Pulite abbia avuto ricadute
politiche ad amplissimo raggio che vanno al di là del colpo di grazia inferto al
tradizionale sistema partitocratico: una magistratura consapevolmente operante
come strumento di rivincita della società civile contro i partiti corrotti e i
metodi utilizzati, in particolare, da un accusatore-tribuno del popolo come
Antonio Di Pietro diedero infatti – come ha ad esempio apertamente riconosciuto
Romano Prodi nel contesto di un libro-intervista su politica e democrazia
(Laterza 2015) – un fortissimo impulso alla “stagione di un populismo senza
freni”. Se ciò è vero, e se si condivide la convinzione che il populismo
politico (comunque declinato: di destra, di sinistra o anche di destra-sinistra
miste) non rappresenti una risposta intelligente ed efficace alla crisi della
democrazia, prima di auspicare nuove rivoluzioni giudiziarie modello Mani Pulite
bisognerebbe riflettere in maniera ponderata sul rischio che una giustizia
penale caricata di missioni palingenetiche produca, alla fine, più danni che
vantaggi. Segnalare questo rischio equivale a dare un giudizio negativo su
un’impresa giudiziaria che è stata invece tante volte elogiata? Un consuntivo a
venticinque anni di distanza, per quanto più distaccato e meno emotivo, non può
non risentire (oltre che di pudori politicamente corretti) dell’orientamento
politico-culturale e della sensibilità personale di chi giudica. Ma non è privo
di significato che abbiano avuto ripensamenti anche alcuni di quelli che furono
allora aperti sostenitori della rivoluzione giudiziaria, come ad esempio Piero
Ottone: “In realtà, un po’ mi ricredo. Penso adesso, a tanti anni di distanza,
che la pulizia improvvisa, la moralità imposta da un giorno all’altro, creava
altri problemi (…). La lunga stagione di procedimenti giudiziari ha prodotto
altri guai: se si eliminavano certi malanni se ne producevano altri. Infatti:
molti magistrati ne hanno tratto una sensazione di onnipotenza, sono sbandati
per altri versi” (citazione tratta dal libro di memorie Novanta, Longanesi
2014). Comunque la si pensi, certo è che Mani Pulite, oltre a non avere
sconfitto la corruzione, ha contribuito anche per successiva emulazione ad
alimentare tendenze ad un esercizio politicamente mirato dell’azione giudiziaria
che da un lato hanno più volte continuato a produrre perniciose sovrapposizioni
tra giustizia e politica e, dall’altro, hanno finito col determinare nei
cittadini una progressiva caduta di fiducia rispetto all’imparzialità del potere
giudiziario: secondo recenti sondaggi, infatti, la stragrande maggioranza (il 69
per cento) ritiene che alcuni settori della magistratura perseguano obiettivi
politici, mentre all’epoca del pool milanese a confidare nei giudici era l’83
per cento delle persone (cfr. i dati riportati da Goffredo Buccini nel Corriere
della sera del 22 marzo scorso). Se queste percentuali sono attendibili, risulta
in realtà avvalorata la preoccupazione che l’uso politico della giustizia
rappresenti – non meno del populismo nelle sue variegate forme – un pericolo
mortale per la democrazia: perché ingenera l’illusione (che può risultare, a sua
vota, deresponsabilizzante per la classe politica) che il rinnovamento politico
e la moralizzazione pubblica possano essere perseguiti per via giudiziaria; e
perché, per altro verso, assoggetta anche l’azione giudiziaria alla logica e ai
metodi della contesa politica, così rinnegando l’imparzialità della magistratura
quale principio-cardine di una democrazia degna di questo nome.
La contabilità di Mani pulite non dimostra la corruzione, ma il
fallimento della rivoluzione per via giudiziaria-populista.
L'operazione fu condotta come una gigantesca retata della buoncostume, impostata
su reati e fattispecie di reati spesso ambigui, forzati, creati di sana pianta,
scrive Maurizio Crippa il 20 Febbraio 2017 su "Il Foglio". Armarsi di
pallottoliere è probabilmente il modo più congruo per affrontare il
venticinquesimo “anniversario” di Mani pulite, schivando un certo schifo per le
cose che si leggono oggi e senza dover ripercorrere tutta quanta la storia di
questo giornale (rileggete Novantatré di Mattia Feltri, la ricostruzione giorno
per giorno di quell’anno scritta nel 2003 per il Foglio, basta). Aiuta nella
contabilità Repubblica, che ieri faceva “lezione” coi numeri: “Ben 4.520 persone
vennero indagate nel solo filone milanese di Mani pulite”. Bisogna prendere sul
serio queste cifre, quelle del “pool”. Su 4.520 iscritti nel registro degli
indagati, derivarono 3.200 richieste di rinvio a giudizio (1.320 atti trasmessi
ad altre autorità giudiziarie). Delle 3.200 persone giudicate a Milano: 620
condanne e patteggiamenti del gip, 635 proscioglimenti del gip (+15). Delle
1.322 persone rinviate a giudizio: 661 condanne, 476 assoluzioni. (Nel 2003
c’erano ancora 117 casi pendenti: la rapidità dell’indagine-lampo). Dunque in
totale, su 4.520 persone finite nelle onnipotenti mani del pool, e su 3.200
rinviati a giudizio, le condanne sono 1.281 (965 per patteggiamento) e 1.111 le
assoluzioni e proscioglimenti. Meno della metà dei processati è stata
condannata, quasi altrettanto assolta. Significa che più del 50 per cento di
quei processi e di quegli arresti (“noi incarceriamo la gente per farla parlare.
La scarceriamo dopo che ha parlato”, proclamò Francesco Saverio Borrelli),
potevano non essere fatti, o non andavano fatti. Se valutasse il tasso di
produttività del pool, e di efficienza negli esiti processuali,
l’amministrazione dello stato avrebbe di che lagnarsi. Questo permette di dire
due cose, fuori dalle polemiche e dalle retoriche. Quando oggi un ex magistrato
del pool come Piercamillo Davigo – e alcuni altri con lui, tra cui certi
bonapartisti ex cronisti di procura – sostiene che il fallimento di Mani pulite
consiste nel fatto che la corruzione non è stata debellata, anzi è aumentata
(“non si vergognano più”, è l’estremizzazione di Davigo), dice una cosa
oggettivamente falsa. Non si poteva debellare la corruzione di un “sistema” con
quei mezzi, cioè forzando le procedure e impedendo manu militari al sistema di
riformarsi. Il fallimento dell’operazione – e dell’ideologia giudiziaria – di
Mani pulite risiede nel fatto che fu condotta come una gigantesca retata della
buoncostume, impostata su reati e fattispecie di reati spesso ambigui, forzati,
creati di sana pianta (la “dazione ambientale” sembrò assumere la concretezza di
una mela rubata dal cesto). E questo, oltre alle ingiuste accuse e detenzioni, e
alle conseguenze politiche prodotte (“il nostro obiettivo non è rappresentato da
singole persone, ma da un sistema che cerchiamo di ripulire”, Italo Ghitti), ha
impedito di individuare i veri reati (c’erano). La seconda cosa è che il
fallimento di Mani pulite è soprattutto il fallimento delle false aspettative
messianiche suscitate nell’opinione pubblica da forzature mediatiche e politiche
miopi o di marca populista. I danni li vediamo ancora oggi. A questa contabilità
andrebbero aggiunti i troppi suicidi, 32 tra il 1992 e il 1994 (“si vede che c’è
ancora qualcuno che per la vergogna si uccide”, Gerardo D’Ambrosio su Sergio
Moroni). Ma il pallottoliere lo teniamo nel cassetto, per la prossima occasione.
Tangentopoli, così i pm salvarono il Pci,
scrive Fabrizio Cicchitto l'1 Marzo 2017, su "Il Dubbio". Tutti i
partiti prendevano finanziamenti “aggiuntivi”, ma, a differenza del Psi,
Botteghe Oscure fu salvata. Si distrusse una intera classe politica. Prima vinse
Berlusconi, poi fu fatto fuori anche lui. E oggi trionfa il populismo. L’Italia,
nel ’ 92-’ 94, fu teatro di un’autentica rivoluzione- eversione che eliminò
dalla scena per via mediatico-giudiziaria ben 5 partiti politici “storici”,
salvando però il Pci. Lo strumento di questa rivoluzione- eversione fu la
“sentenza anticipata”: quando un avviso di garanzia, urlato da giornali e
televisioni, colpiva i dirigenti di quei partiti essi erano già condannati agli
occhi dell’opinione pubblica. Qualora il pool di Mani Pulite avesse agito con
la stessa determinazione e violenza negli anni 40 e 50 di quella messa in
evidenza nel ’ 92-’ 94, allora De Gasperi, Nenni, Togliatti sarebbero stati
incriminati e Valletta e Enrico Mattei sarebbero stati arrestati. Il
finanziamento irregolare dei partiti e la collusione fra questi, i grandi gruppi
pubblici e privati e relative associazioni (in primis Fiat, Iri, Eni,
Montecatini, Edison, Assolombarda, Cooperative rosse, ecc.) data da allora. In
più c’era un fortissimo finanziamento internazionale: la Dc era finanziata anche
dalla Cia, e il Pci in modo così massiccio dal Kgb che le risorse ad esso
destinate erano più di tutte quelle messe in bilancio per gli altri partiti e
movimenti. In una prima fase, la Fiat finanziava tutti i partiti “anticomunisti”
poi coinvolse in qualche modo anche il Pci quando realizzò i suoi impianti in
Urss. Per Enrico Mattei i partiti erano come dei taxi, per cui finanziava tutti,
dall’Msi, alla Dc, al Pci, e perfino la scissione del Psiup dal Psi, e fondò
anche una corrente di riferimento nella Dc con Albertino Marcora, partigiano
cattolico e grande leader politico: quella corrente fu la sinistra di Base che
ha avuto un ruolo assai importante nella Dc e nella storia della Repubblica.
Fino agli anni 80 questi sistemi di finanziamento irregolare procedettero
“separati” vista la divisione del mondo in due blocchi, poi ebbero dei punti in
comune: nell’Enel ( attraverso il consigliere d’amministrazione Giovanni
Battista Zorzoli prima titolare di Elettro General), nell’Eni ( la rendita
petrolifera di matrice sovietica) e specialmente in Italstat ( dove veniva
realizzata la ripartizione degli appalti pubblici con la rotazione “pilotata”
fra le grandi imprese edili, pubbliche e private, con una quota fra il 20% e il
30% assegnata alle cooperative rosse). Per molti aspetti quello del Pci era il
finanziamento irregolare a più ampio spettro, perché andava dal massiccio
finanziamento sovietico al commercio estero con i Paesi dell’est, alle
cooperative rosse, al rapporto con gli imprenditori privati realizzato a livello
locale. Emblematici di tutto ciò sono le citazioni da tre testi: un brano tratto
dal libro di Gianni Cervetti L’oro di Mosca ( pp. 126- 134), un altro tratto dal
libro di Guido Crainz Il paese reale ( Donzelli, p. 33), il terzo estratto è da
una sentenza della magistratura di Milano sulla vicenda della metropolitana.
Così ha scritto Gianni Cervetti: «Nacque, credo allora, l’espressione
“amministrazione straordinaria”, anzi “politica dell’amministrazione
straordinaria”, che stava appunto a indicare un’attività concreta (nomina sunt
substantia rerum) anche se piuttosto confusa e differenziata. A ben vedere,
poteva essere suddivisa in due parti. Una consisteva nel reperire qualche mezzo
finanziario per il centro e le organizzazioni periferiche facendo leva su
relazioni con ambienti facoltosi nella maniera sostanzialmente occulta cui prima
ho accennato. In genere non si compivano atti specifici contro le leggi o che
violavano norme amministrative precise, ma si accettavano o ricercavano
finanziamenti provenienti da imprenditori non più soltanto vagamente facoltosi,
ma disposti a devolvere al partito una parte dei loro profitti in cambio di un
sostegno a una loro determinata attività economica. Tuttavia, in sistemi
democratici, o pluripartitici, o a dialettiche reali – siano essi sistemi
moderni o antichi, riguardanti tutto il popolo o una sola classe – pare
incontestabile che in ogni partito coesistano i due tipi di finanziamento ed
esista, dunque, quello aggiuntivo. Naturalmente – lo ripetiamo – di
quest’ultimo, come del resto del primo, mutano i caratteri, le forme ed i
contenuti a seconda dei partiti e dei periodi: anzi mutano i rapporti
quantitativi dell’uno con l’altro, ma appunto quello aggiuntivo esiste in
maniera costante. Comunque sia non c’è epoca, paese, partito che non abbia
usufruito di fondi per i finanziamenti aggiuntivi. Sostenere il contrario
significa voler guardare a fenomeni storici e politici in maniera superficiale e
ingenua, o viceversa, insincera e ipocrita. Il problema, ripetiamo, lo abbiamo
preso alla larga, e si potrebbe allora obiettare che aggiuntivo non corrisponda
esattamente, e ancora, a illecito. Intanto, però, abbiamo dimostrato che il
finanziamento aggiuntivo è storicamente dato e oggettivamente ineluttabile». Il
fatto che anche il Pci, sviluppando la «politica dell’amministrazione
straordinaria», accettava o ricercava finanziamenti provenienti da imprenditori
«non più soltanto vagamente facoltosi ma disposti a devolvere al partito una
parte dei loro profitti in cambio di un sostegno a una loro determinata attività
economica» mette in evidenza che anche «nel caso del Pci il reato di
finanziamento irregolare poteva sfociare in quello di abuso in atti d’ufficio o
in corruzione o in concussione». Così ha scritto lo storico Guido Crainz: «È uno
squarcio illuminante il confronto che si svolge nella direzione del Pci nel
1974, quando è all’esame del parlamento la legge sul finanziamento pubblico ai
partiti. La discussione prende l’avvio dalla “esistenza di un fenomeno enorme di
corruzione dei partiti di governo” ma affronta al tempo stesso con grande
preoccupazione il pur periferico affiorare di “imbarazzi o compromissioni venute
al nostro partito da certe pratiche”. L’approvazione della legge è
esplicitamente giustificata con la necessità di garantirsi “una duplice
autonomia…: autonomia internazionale ma anche da condizionamenti di carattere
interno…. Non possiamo nasconderci fra noi il peso di condizionamenti subiti
anche ai fini della nostra linea di sviluppo economico e, per giunta, per
qualcosa di estremamente meschino” (intervento di Giorgio Napolitano alla
riunione della direzione del 3 giugno 1974)». «Nel dibattito non mancano
ammissioni di rilievo. “Molte entrate straordinarie”, dice ad esempio il
segretario regionale della Lombardia Quercioli, “derivano da attività malsane.
Nelle amministrazioni pubbliche prendiamo soldi per far passare certe cose. In
questi passaggi qualcuno resta con le mani sporche e qualche elemento di
degenerazione poi finisce per toccare anche il nostro partito” (intervento di
Elio Quercioli nella riunione della direzione del 1° febbraio 1973). È possibile
cogliere in diversi interventi quasi un allarmato senso di impotenza di fronte
al generale dilagare del fenomeno: di qui la decisione di utilizzare la legge
per porre fine a ogni coinvolgimento del partito. Si deve sapere, dice armando
Cossutta, “che in alcune regioni ci sono entrate che non sono lecite
legittimamente, moralmente, politicamente. Questo sarà il modo per liberare il
partito da certe mediazioni. Non chiudere gli occhi di fronte alla realtà ma far
intendere agli altri che certe operazioni noi non le accetteremo più in alcun
modo. Punto di riferimento deve essere l’interesse della collettività e faremo
scandalo politico e una battaglia contro queste cose assai più di prima”
(intervento di Armando Cossutta alla direzione del 3 giugno 1974). È
illuminante, questa sofferta discussione del 1974. Rivela rovelli veri e al
tempo stesso processi cui il partito non è più interamente estraneo». La
sentenza del tribunale di Milano del 1996 sulle tangenti della Metropolitana è
molto precisa: «Va subito fissato un primo punto fermo: a livello di federazione
milanese, l’intero partito, e non soltanto alcune sue componenti interne, venne
direttamente coinvolto nel sistema degli appalti Mm, quanto meno da circa il
1987». Per il tribunale «risulta dunque pacifico che il Pci- Pds dal 1987 sino
al febbraio 1992 ricevette quale percentuale del 18,75 per cento sul totale
delle tangenti Mm una somma non inferiore ai 3 miliardi» raccolti da Carnevale e
da Soave, non solo per la corrente migliorista ma anche per il partito.
Carnevale coinvolse anche il segretario della federazione milanese, Cappellini,
berlingueriano di stretta osservanza: «Fu Cappellini, segretario cittadino
dell’epoca, ad affidarmi per conto del partito l’incarico che in precedenza
aveva svolto Soave». La regola interna era quella che «dei tre terzi delle
tangenti raccolte (2 miliardi e 100 milioni in quel periodo solo per il sistema
Mm), due terzi dovevano andare agli “occhettiani”, cioè a Cappellini, un terzo
ai miglioristi di Cervetti».
Alla luce di tutto ciò è del tutto evidente che Berlinguer quando aprì la
questione morale e parlò del Pci come di un “partito diverso” o non sapeva nulla
del finanziamento del Pci oppure, per dirla in modo eufemistico, si espresse in
modo mistificato e propagandistico. Orbene questo sistema dal quale ricevevano
reciproco vantaggio sia i partiti, sia le imprese, e che coinvolgeva tutto e
tutti, risultò antieconomico da quando l’Italia aderì al trattato di Maastricht
e quindi tutti i gruppi imprenditoriali furono costretti a fare i conti con il
mercato e con la concorrenza. Esistevano tutti i termini per una grande
operazione consociativa, magari accompagnata da un’amnistia che superasse il
sistema di Tangentopoli. L’amnistia ci fu nel 1989, ma servì solo a “salvare” il
Pci dalle conseguenze giudiziarie del finanziamento sovietico, il più irregolare
di tutti, perché proveniva addirittura da un paese contrapposto alle alleanze
internazionali dell’Italia. Per altro verso, Achille Occhetto, quando ancora non
era chiaro l’orientamento unilaterale della procura di Milano, nel maggio del ’
92, si recò nuovamente alla Bolognina per “chiedere scusa” agli italiani.
Occhetto invece non doveva preoccuparsi eccessivamente. Il circo mediatico-
giudiziario composto da due pool, quello dei pm di Milano e dal pool dei
direttori, dei redattori capo e dei cronisti giudiziari di quattro giornali (Il
Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica, l’Unità) mirava contro il Caf,
cioè concentrò i suoi colpi in primis contro il Psi di Craxi, poi contro il
centro- destra della Dc, quindi, di rimbalzo, contro il Psdi, il Pri, il Pli.
Colpì anche i quadri intermedi del Pci- Pds, molte cooperative rosse, ma salvò
il gruppo dirigente del Pci-Pds e quello della sinistra Dc. La prova di ciò sta
nel modo con cui fu trattato il caso Gardini: è accertato che Gardini portò
circa 1 miliardo, d’intesa con Sama e Cusani, alla sede del Pci avendo un
appuntamento con Occhetto e D’Alema. Suicidatosi Gardini, Cusani e Sama sono
stati condannati per corruzione: il corrotto era dentro la sede di via delle
Botteghe Oscure, ma non è mai stato identificato. Ha osservato a questo
proposito Di Pietro: «Ecco, questo è l’unico caso in cui io arrivo alla porta di
Botteghe oscure. Anzi, arrivo fino all’ascensore che porta ai piani alti…
abbiamo provato di certo che Gardini effettivamente un miliardo lo ha dato;
abbiamo provato di certo che l’ha portato alla sede di Botteghe oscure; abbiamo
provato di certo che in quel periodo aveva motivo di pagare tangenti a tutti i
partiti, perché c’era in ballo un decreto sulla defiscalizzazione della
compravendita Enimont a cui teneva moltissimo». Di Pietro aggiunse: «Non è che
potevo incriminare il signor nome: partito, cognome: comunista». Giustamente
l’erede di quel partito, il Pds, lo elesse nel Mugello.
Al processo Enimont il presidente del tribunale neanche accettò di sentire
Occhetto e D’Alema come testimoni. Analoga linea fu seguita nei confronti del
gruppo dirigente della sinistra Dc: Marcello Pagani, ex coordinatore della
sinistra democristiana, e di un circolo che ad essa faceva riferimento, fu
condannato, avendo ricevuto soldi Enimont in quanto agiva, recita testualmente,
la sentenza «per conto dell’onorevole Bodrato e degli altri parlamentari della
sinistra Dc» ma essi potevano non sapere. Quella fu la grande discriminante
attraverso la quale il circo mediatico- giudiziario spezzò il sistema politico,
ne distrusse una parte e ne salvò un’altra: Craxi, il centrodestra della Dc
(Forlani, Gava, Pomicino e altri), Altissimo, Giorgio la Malfa, Pietro Longo,
non potevano non sapere, il gruppo dirigente del Pci- Pds e quello della
sinistra Dc potevano non sapere.
È evidente che dietro tutto ciò c’era un progetto politico, quello di far sì
che, venendo meno la divisione in due blocchi, il gruppo dirigente del Pds,
magari con l’aiuto della sinistra Dc, finalmente conquistasse il potere. Il pool
di Milano non poteva prevedere che, avendo distrutto tutta l’area di centro e di
centro- sinistra del sistema politico, quel vuoto sarebbe stato riempito da quel
Silvio Berlusconi che, pur essendo un imprenditore amico di Craxi, era stato
risparmiato dal pool di Mani Pulite perché durante gli anni ’ 92-’ 94 aveva
messo a disposizione della procura le sue televisioni. Non appena (fino al 1993)
il pool di Milano si rese conto che Berlusconi stava “scendendo in politica”,
ecco che subito cominciò contro di lui il bombardamento giudiziario che si
concluse con la sentenza del 2013. Ma anche il modo con cui fu trattato il
rapporto del pool con i grandi gruppi finanziari editoriali Fiat e Cir, fu del
tutto atipico e al di fuori di una normale prassi giudiziaria. Per tutta una
fase ci fu uno scontro durissimo tra la Fiat e la magistratura, accentuato dal
fatto che a Torino il procuratore Maddalena agiva di testa sua. Poi si arrivò
alla “pax” realizzata attraverso due “confessioni” circostanziate, attraverso le
quali la Fiat e la Cir appunto “confessarono” di aver pagato tangenti perché
concussi da quei “malvagi” dei politici. Così il 29 settembre del 1992 Cesare
Romiti andò a recitare un mea culpa dal cardinale Martino: «Come cittadini e
come imprenditori non ci si può non vergognare, di fronte alla società, per
quanto è successo. E io sono il primo a farlo. Io sono stato personalmente
scosso da questi avvenimenti. No, non ho paura di dirlo. E di fronte al cardinal
Martini, la più alta carica religiosa e morale di Milano, non potevo non
parlarne». Qui interveniva l’autoassoluzione. Infatti, secondo Romiti, la
responsabilità era della classe politica che «ha preteso da cittadini e imprese
i pagamenti di “compensi” per atti molto spesso dovuti».
Possiamo quindi dire che l’Italia, unico paese dell’Occidente, nel ’ 92-’ 94 fu
teatro di un’autentica rivoluzione- eversione che eliminò dalla scena per via
mediatico- giudiziaria ben 5 partiti politici “storici”. Lo strumento di questa
rivoluzione- eversione fu la “sentenza anticipata”: quando un avviso di
garanzia, urlato da giornali e televisioni, colpiva i dirigenti di quei partiti
essi erano già condannati agli occhi dell’opinione pubblica, con una conseguente
perdita di consensi. Il fatto che, a 10 anni di distanza, una parte di quei
dirigenti fu assolta non servì certo a recuperare i consensi politicoelettorali
perduti. La conseguenza di tutto ciò sono state due: una perdita crescente di
prestigio di tutti i partiti, anche di quelli che furono “salvati” dal pool, una
parcellizzazione della corruzione tramutatasi da sistemica a reticolare ( una
miriade di reti composte da singoli imprenditori, singoli burocrati, singoli
uomini politici), l’esistenza di un unico sistema di potere sopravvissuto,
quello del Pci- Pds, che a sua volta ha prodotto altre vicende, dal tentativo di
scalata dell’Unipol alla Bnl, alla crisi del Mps. Di qui la conseguente
affermazione di movimenti populisti e di un partito protestatario la cui guida è
concentrata nelle mani di due persone, il crescente discredito del parlamento
sottoposto a un bombardamento giudiziario realizzato anche da chi (vedi Renzi)
pensa in questo modo di poter intercettare a suo vantaggio la deriva
dell’antipolitica. Ma è una operazione del tutto velleitaria, perché le persone
preferiscono la versione originale del populismo e non le imitazioni. Perdipiù i
grillini, cavalcando la guerra alla “casta” – inventata da due giornalisti
del Corriere della Sera e sostenuta da un grande battage pubblicitario –
cavalcano di fatto la manovra diversiva posta in essere da banchieri e manager,
proprietari dei grandi giornali, per deviare l’attenzione dalle loro
spropositate retribuzioni e liquidazioni: i circa 100 mila euro annui dei
parlamentari servono a far dimenticare i 2- 3 milioni di euro che il più
straccione dei banchieri guadagna comunque, anche se porta alla rovina i
correntisti della sua banca. Di tutto ciò traiamo la conseguenza che il peggio
deve ancora arrivare.
Bobo Craxi e Di Pietro si trovano insieme nel medesimo partito.
Il figlio dell'ex segretario socialista e l'ex pm simbolo di Mani Pulite si
ritrovano entrambi ad aderire ad Mdp. Ma Craxi avverte: "Se è così, vado a
casa", scrive Luca Romano, Mercoledì 4/10/2017, su "Il Giornale".
Craxi contro Di Pietro: sembra un remake del 1992 ma siamo nel 2017 e il primo
non è Bettino ma suo figlio Bobo, secondogenito dell'ex presidente del
Consiglio. Eppure il figlio dell'ex segretario socialista non ha mai smesso di
scontrarsi con l'ex pm simbolo di Mani Pulite e poi leader dell'Italia dei
Valori, per motivi anche troppo evidenti. Tuttavia questa volta il motivo dello
scontro è particolarmente singolare: Craxi e Di Pietro rischiano infatti di
trovarsi nel medesimo partito. Per buffo che possa sembrare, infatti, entrambi
hanno manifestato l'intenzione di aderire ad Mdp, la formazione di sinistra nata
da una scissione dal Pd che comprende Roberto Speranza, Arturo Scotto ed Enrico
Rossi. Si tratta naturalmente di una pura coincidenza, giacché nessuno dei due
avrebbe mai avuto l'intenzione di andare a "coabitare" con l'altro sotto il
medesimo tetto politico. Secondo il Corriere entrambi vi sono stati attirati da
un antico rapporto di simpatia con Massimo D'Alema, a cui tutti e due sono
legati, per motivi differenti, da vincoli di riconoscenza. Il figlio di Bettino
si è presentato alla festa di Mdp a Napoli, mentre Di Pietro annuncia
soddisfatto di sentire nella formazione di Speranza e Bersani "la stessa aria
che si respirava nell'Ulivo". Al momento di scoprire la coincidenza, però,
l'imbarazzo è stato palpabile. Per Craxi piuttosto di convivere "sarebbe meglio
rimanere a casa", mentre Di Pietro è più serafico: pur non avendo mai avuto
parole tenere verso il figlio del suo storico avversario ora liquida il tutto
con calma olimpica. "Problemi suoi": Tonino non cede di un passo.
Lo strano caso di Di Pietro e Bobo Craxi: si ritrovano nello
stesso partito. Entrambi aderiscono a Mdp, non senza
qualche imbarazzo. Il figlio di Bettino: «Se è così, allora dovrò stare a casa».
L’ex magistrato: «Problemi suoi. E mi dispiace per lui, non ho intenzione di
candidarmi alla carica di governatore in Molise», scrive Maria Teresa Meli il 3
ottobre 2017 su “Il Corriere della Sera”. Finora c’erano stati i partiti a
separarli, anche quando avevano militato nella stessa coalizione. E così avevano
potuto continuare a parlare male l’uno dell’altro. Ma adesso le cose sono
cambiate. Bobo Craxi, figlio di Bettino, classe 1964, e Antonio Di Pietro,
grande accusatore dello scomparso leader socialista, dividono lo stesso tetto
politico: entrambi hanno deciso di aderire a Mdp, il movimento nato dalla
scissione del Pd. Hanno passato gli anni, anzi, i decenni, a darsi addosso. Bobo
diceva dell’ex magistrato: «Si vede che è un uomo meschino». E Di Pietro
ricambiava la cortesia senza pensarci troppo: «Tale padre tale figlio»,
affermava con aria sprezzante. Da allora è passato un po’ di tempo. Craxi si è
ingrigito, l’ex pm ha perso più di un capello, entrambi hanno acquistato qualche
chilo in più, ma le tensioni restano inalterate. I due non si piacciono e non si
amano. E non potrebbe essere altrimenti, visto che Bobo ancora si commuove se
vede scorrere le immagini del processo Enimont, con il padre alla sbarra e Di
Pietro in toga che lo interroga. Eppure la sorte ha voluto che, girovagando di
partito in partito nell’arcipelago frastagliato che sta a sinistra del Pd, si
ritrovassero insieme. Galeotto è stato D’Alema. Craxi è suo grande estimatore:
gli è riconoscente perché, quando era al governo, cercò di far rientrare il
padre in patria. Anche Di Pietro ha un debito di gratitudine: deve a D’Alema il
seggio nel Mugello. Perciò prima l’uno (l’ex magistrato) e poi l’altro hanno
annunciato la loro volontà di aderire a Mdp. Lo hanno fatto con tanto di
dichiarazione formale. Di più: Craxi è andato anche alla festa degli
scissionisti a Napoli per incontrare una delegazione composta da Arturo Scotto,
Roberto Speranza ed Enrico Rossi. Ovviamente Di Pietro non sapeva delle
intenzioni di Bobo e viceversa. Situazione imbarazzante per entrambi, non c’è
che dire. Soprattutto per Craxi, perché gli ex socialisti non è che abbiano peso
bene questa comune militanza politica. E adesso Bobo spera che Di Pietro non
stia facendo sul serio: «Forse vuole solo un posto di governatore in Molise...».
Ma quando gli si fa presente che così non è, che l’ex magistrato non è
interessato a guidare la sua regione e che, piuttosto, intende fare politica
attivamente dentro Mdp ha un sussulto. Seguito da un mesto mormorìo: «Se Di
Pietro aderisce veramente, allora per me è meglio stare a casa». Di Pietro,
invece, non fa una piega. Assiso su un divanetto di Montecitorio l’ex pm, ex
ministro, ex deputato ed ex leader dell’Italia dei Valori sta conversando fitto
fitto con Antonello Falomi, un passato da occhettiano, un presente da
sindacalista di tutti i parlamentari che non vogliono veder dileguarsi i loro
vitalizi. «Stiamo difendendo la casta», ridacchia Di Pietro. Poi, al nome Craxi
sfodera un cipiglio di quelli che incutono timore. Ma appurato che si tratta del
figlio e non del padre si rilassa: «Problemi suoi. Io ho aderito a Mdp perché
qui respiro la stessa aria che respiravo nell’Ulivo. E mi dispiace per lui, non
ho intenzione di candidarmi in Molise». Per il 19 novembre è prevista la grande
costituente degli scissionisti del Pd. Per allora Bobo dovrà prendere una
decisione: stare a casa o convivere con il “nemico”.
Bobo Craxi, Di Pietro tecnicamente pentito. Ha detto cose
clamorose su Mani Pulite, scrive l'Ansa il 4 ottobre
2017. "Non faccio parte di Mdp e credo che neanche Di Pietro ne faccia parte. La
vicenda di Di Pietro, un magistrato prestato alla politica, è molto diversa
dalla mia. Ultimamente è stato consulente della Lega; si è riavvicinato al M5S,
respinto credo, ora si dice interessato a questa vicenda. Non so cosa c'entri
lui con la storia della sinistra. Negli ultimi tempi ha detto cose clamorose sul
ruolo di Mani pulite mentre io e i miei compagni non cambiamo il nostro giudizio
su Mani Pulite: tecnicamente Di Pietro è un pentito". Sono le parole di Bobo
Craxi ai microfoni di Fuori Gioco - Rai Radio1. Intervenuto in collegamento da
Barcellona ha aggiunto poi sulla vicenda catalana: "Si finirà per andare ad
elezioni e così si misureranno le forze in campo".
L’unico errore giudiziario è l’innocente. Davigo spiega con
chiarezza perché siamo tutti potenziali colpevoli,
scrive il 28 Gennaio 2017 "Il Foglio". Nel giorno dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario, il presidente dell’Anm Piercamillo Davigo ha tenuto una lezione di
diritto da incorniciare: gli errori giudiziari non esistono. Non nel senso che
non ce ne sono stati l’anno passato – solo nel 2016 lo stato ha speso 42 milioni
per risarcirli – ma nel senso che non esistono proprio. Quelli per cui lo stato
paga non sono errori giudiziari: sono accidenti. Davigo spiega che si confondono
due cose, gli errori giudiziari e l’ingiusta detenzione. Gli errori giudiziari
sono quando viene condannato un colpevole, ma “il giudice non è presente quando
viene commesso il reato, sa le cose che gli raccontano. Se si scopre dopo che un
teste ha mentito, non lo può sapere”. L’ingiusta detenzione avviene quando si
arresta una persona sulla base di alcune dichiarazioni e indizi “ma se poi nel
processo un testimone cambia versione perché viene minacciato, l’arrestato viene
liberato e pure risarcito”. Per il Consiglio d’Europa in Italia c’è bisogno di
mettere limiti alla politicizzazione nella magistratura. Seguendo il
ragionamento, gli errori giudiziari non sarebbero errori e le ingiuste
detenzioni non sarebbero tali. Anzi, sarebbero la prova che il sistema funziona
benone. Questo non vuol dire, però, che non ci siano errori in assoluto, c’è una
fattispecie sottovalutata: “Quando viene assolto un colpevole”. E qui Davigo,
con formidabile guizzo d’ingegno, demolisce l’intera struttura della giustizia:
ogni innocente assolto, in realtà, è un potenziale colpevole, un errore
giudiziario. Azzardiamo una soluzione: far pagare un risarcimento a ogni persona
che esce da un processo senza condanne. E col ricavato, creare un fondo per le
vittime della malagiustizia: i magistrati che sbagliano perché tratti in errore
da testimoni falsi.
Anche gli innocenti sono colpevoli. Davigo e il rovescio dello
stato di diritto. Anche a "Porta a Porta" il
presidente dell’Anm insiste nel dire che gli unici errori giudiziari sono le
assoluzioni, e la vittima in questi casi è solo il magistrato, scrive Luciano
Capone il 2 Febbraio 2017 su "Il Foglio". Ascoltare Piercamillo Davigo è sempre
istruttivo, soprattutto per la sua spiccata inclinazione alla chiarezza: “Sia il
vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno”, ama dire citando il
Vangelo. L’avevamo lasciato, nel giorno dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario, che teorizzava l’inesistenza dell’errore giudiziario. Nel giorno
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, il presidente dell’Associazione
nazionale magistrati (Anm) spiegava in televisione, da Corrado Formigli a
“Piazza pulita”, che quando un innocente viene condannato non è colpa dei
magistrati: “Il giudice non è presente quando viene commesso il reato, sa le
cose che gli raccontano. Se si scopre dopo che un teste ha mentito, non lo può
sapere. E’ stato ingannato”. La vera vittima dell’errore giudiziario è quindi il
magistrato, fuorviato e ingannato dai testimoni. Ieri sera Davigo, ospite di
Bruno Vespa a “Porta a porta” per parlare dei 42 milioni di euro per
risarcimenti giudiziari nel 2016 (648 milioni dal ’92), ha allargato il campo
della sua visione alle ingiuste detenzioni: come gli errori giudiziari non sono
errori, così le ingiuste detenzioni non sono ingiuste (in pratica l’unico errore
sembra quello di pagare le vittime). Gli errori della giustizia ci costano 42
milioni di euro. Ma per Davigo i magistrati sbagliano poco (per fortuna). Nel
2016 lo Stato ha dovuto sborsare oltre 40 milioni di euro. La maggior parte a
causa di "ingiuste detenzioni". Spiega Davigo che tutti questi risarcimenti a
persone incarcerate e poi assolte avvengono perché nel nostro sistema “le prove
assunte nelle indagini preliminari di regola non vale nel processo”. C’è questo
problema del dibattimento e di dover ripetere le testimonianze rilasciate agli
inquirenti davanti a un giudice. Quindi succede che una persona viene arrestata
sulla base di prove schiaccianti, come le accuse di tre testi, “dopodiché questi
testi magari minacciati dicono che si sono sbagliati. Le loro indicazioni non
possono essere più utilizzate. È un innocente messo in carcere – si chiede
retoricamente Davigo – o è un colpevole che l’ha fatta franca?”. Ovviamente la
seconda, da cui si capisce che gli unici errori giudiziari sono le assoluzioni.
Le ingiuste detenzioni sono quindi quelle in cui una persona ha subìto un
provvedimento di custodia cautelare e poi è stato assolto, “il che – dice Davigo
– non significa che siano tutti innocenti, anzi”. Esiste quindi, per il
presidente dell’Anm una presunzione di colpevolezza che va anche oltre
l’assoluzione definitiva. A questo punto, più che fare processi per sanzionare i
colpevoli di qualche reato, sarebbe più logico processare tutti per rilasciare
alla fine patenti d’innocenza (magari temporanee, da rinnovare ogni tot anni).
Quando però Vespa racconta casi di malagiustizia come quello di Giuseppe
Gulotta, per 36 anni in carcere da innocente con l’accusa di essere un
assassino, il presidente dell’Anm dice che non si tratta di un errore dei
magistrati perché “quel caso clamoroso è stato frutto di tortura da parte delle
forze di polizia. Il giudice non sa che sono stati torturati”. È stato
ingannato. La giustificazione di Davigo però in teoria cozzerebbe con la sua
intenzione di far valere nel processo le dichiarazioni rilasciate agli
inquirenti (in quel caso sarebbero proprio quelle estorte attraverso la tortura,
come dice lo stesso Davigo), che è uno strumento per non ingannare il giudice.
In sintesi se una persona viene assolta non è innocente e se viene condannata
ingiustamente il giudice non è colpevole. Le interviste di Davigo sono molto
interessanti perché ci ricordano sempre che esiste il rovescio della medaglia,
in questo caso il rovescio dello stato di diritto.
Davigo non fa politica, ma il teletribuno.
Il numero uno dell'Anm moltiplica le sue apparizioni in tv e si
fa intervistare anche dal blog di Beppe Grillo. Obiettivo: spiegare che i
politici sono corrotti, scrive il 9 Marzo 2017 "Il Foglio". I magistrati? Tutti
cattivi politici. Parola di Piercamillo Davigo. Il presidente dell'Anm lo va
ripetendo da settimane. E c'è da credergli visto che lui, a differenza di molti
dei colleghi del fantasmagorico pool di Mani Pulite, si è sempre tenuto ben
lontano da candidature e partiti. E così, oltre a diventare il numero uno dei
magistrati italiani, è anche diventato il perfetto ospite televisivo. Sempre
pronto a spiegare a tutti, soprattutto ai politici, quello che dovrebbero fare e
come dovrebbero farlo. Nelle ultime due settimane Davigo ha partecipato a Otto e
mezzo (22 febbraio), Quante storie (23 febbraio), Un giorno da pecora (24
febbraio), DiMartedì (28 febbraio), #Cartabianca (7 marzo), Agorà (8 marzo), La
Gabbia (8 marzo). Non solo, giusto oggi ha concesso un'intervista al
portavoce-senatore del M5S Nicola Morra che è stata pubblicata sul Sacro Blog.
Si dirà ma in occasione del venticinquesimo anniversario di Tangentopoli chi
volete che invitino? Chi meglio di lui può spiegare, parole testuali affidare
alla penna di Morra, che "negli ultimi 25 anni la classe politica, per quanto
riguarda in particolare le indagini e i processi in tema di corruzione si è data
molto da fare, non per stroncare la corruzione ma per stroncare le indagini e i
processi, facendo leggi che impedivano le indagini e azzeravano le prove
acquisite e creavano enormi difficoltà". Insomma nonostante il ruolino di marcia
da politico navigato che passa con disinvoltura da un programma all'altro, dalla
radio alla tv, dalla Rai a La7, Davigo politica non fa (anche se c'è chi lo
vedrebbe bene come candidato M5s). E proprio per questo può permettersi di dare
lezioni. Perché i magistrati sono tutti cattivi politici, ma ottimi ospiti
televisivi.
Chi guarda il dito, chi la Luna e chi Woodcock,
scrive Alessandro Sallusti, Mercoledì 4/10/2017, su "Il Giornale". La richiesta
di non luogo a procedere nei confronti del pm John Henry Woodcock e della sua
compagna Federica Sciarelli per la fuga di notizie sul caso Consip ha fatto
scattare gli squilli di tromba dei fedelissimi della procura napoletana. Ecco la
prova scrive Marco Travaglio a nome dei soci che il complotto contro Renzi
(padre e figlio) era una bufala: «Ora chiedete scusa e andate tutti a
nascondervi», chiosa nel suo articolo il direttore de Il Fatto Quotidiano. In
carriera ho visto tanti tentativi di manipolare i fatti a proprio piacimento, ma
questo raggiunge vette fino ad ora mai raggiunte. Che non ci sarebbero state
prove evidenti sul fatto che fosse stata la manina di Woodcock a fare uscire
dagli uffici carte riservate lo davo da subito per scontato. Parliamo di un
reato praticamente indimostrabile, tendendo ad escludere che un magistrato pur
fesso che sia - veicoli documenti per posta elettronica od ordinaria. Che il
fatto sia avvenuto è certo, manca solo il nome del colpevole. Se parlassimo del
direttore di un giornale, la condanna del pm sarebbe automatica, perché noi come
in tutte le professioni - a differenza dei magistrati, purtroppo rispondiamo in
solido di omesso controllo sull'operato dei nostri collaboratori. Ma la
manipolazione principale della ditta Travaglio sta nel voler far credere che il
«complotto» sia la fuga di notizie e non il loro contenuto. Si dice che quando
il saggio indica la Luna, lo stolto guarda il dito. In questo caso il dito è la
divulgazione illegale, la Luna sono i falsi accertati dell'inchiesta condotta da
Woodcock, falsi che riguardando il padre dell'allora presidente del Consiglio e
che se non fossero stati smascherati in tempo avrebbero potuto innescare una
crisi politica e istituzionale. Nessuna scusa, quindi. Semmai è imbarazzante che
la magistratura non sia stata capace di dare un nome a un servitore dello Stato
infedele. Del resto, come noto, cane non mangia cane, e il risultato è che un pm
sotto la cui regia è stata avviata un'inchiesta con false intercettazioni e
false ricostruzioni sulla famiglia del presidente del Consiglio continuerà a
fare il suo lavoro. Se qualcuno deve «andare a nascondersi» e «vergognarsi»,
quel qualcuno non siamo di certo noi che teniamo ben fisso lo sguardo sulla
Luna.
Giustizia, Lavia vs Davigo: “Chi risarcisce Penati?”. “C’è onore
nel prendere la prescrizione?”, scrive Gisella Ruccia
il 4 ottobre 2017 su "Il Fatto Quotidiano". Scontro rovente a Dimartedì (La7)
tra il magistrato Piercamillo Davigo e Mario Lavia, vicedirettore di
Democratica, il quotidiano digitale del Pd renziano. Il dibattito è incentrato
sulla politica e sulla magistratura, della quale Lavia rileva “un’anomalia”
perdurante da 25 anni: “Nell’era del berlusconismo il dottor Davigo e il pool di
Mani Pulite sono state un soggetto politico, tanto è vero che alcuni di loro
sono scesi direttamente in politica. E questa è un’anomalia che va corretta:
bisogna ritornare a una situazione in cui la politica fa la politica e la
magistratura fa liberamente la magistratura senza interferire nei processi
politici, cosa che purtroppo è successa spesso”. Davigo replica: “I magistrati
si candidano perché c’è qualcuno che li candida. Questo fatto che i magistrati
fanno politica è una vergogna, ma c’è qualcuno che concorre con loro nella
vergogna”. “Non è una vergogna, è un’anomalia”, minimizza il giornalista. “E’
una vergogna invece – ribadisce Davigo – perché i magistrati non devono fare
politica secondo me. In secondo luogo, se i politici dicono di voler aspettare
le sentenze, vuol dire che le decisioni politiche su chi deve fare il ministro o
il parlamentare le prende il giudice. E questo è sbagliato. Decidano prima per
conto loro. Il più delle volte non lo fanno perché non ne hanno la forza e hanno
bisogno di un pretesto”. “Non è che siamo in Venezuela. Cioè non è che tutti i
politici e i ministri si affidano a un giudice”, obietta Lavia. E il magistrato
non ci sta: “Non ho mai detto niente del genere e non mi faccia dire cose che
non ho detto. So distinguere i ladri dai non ladri. Faccio questo di mestiere”.
Lavia ribatte: “Ci sono alcuni casi in cui degli innocenti sono stati messi alla
gogna dalla magistratura, sono caduti dei governi, e mi riferisco al
caso Mastella, ma anche al proscioglimento di Ottaviano Del Turco per
associazione a delinquere, al caso Tempa Rossa, a Errani, a Penati”. “Non ho
capito perché Penati. Ha preso la prescrizione. Di che cosa stiamo parlando?”,
controbatte il magistrato. “E’ stato assolto l’altro giorno, la prescrizione era
per un’altra cosa – puntualizza Lavia – Come lo risarcisce?”. “Risarcire che
cosa? – replica Davigo – Uno che ha preso la prescrizione definitiva? Sarà pure
un’altra cosa, ma siccome l’articolo 54 della Costituzione dice che i cittadini
a cui sono affidate le pubbliche funzioni devono adempiere a esse con disciplina
e onore, allora le chiedo: c’è onore nel prendere la prescrizione?”
A Davigo bisogna dire una cosa. Chi è senza peccato scagli la prima pietra,
specialmente se i magistrati diventano tali in virtù di un concorso truccato.
Poi bisogna dire che essere prosciolto per prescrizione non è un sentenza di
assoluzione, né di condanna. E' un giudizio interrotto per tempo scaduto. E la
colpa della mancata pronuncia è tutta della magistratura che porta oltre i tempi
ragionevoli la durata dei processi.
Essere indagati non è la fine del mondo. Lezioni dai casi
Woodcock e Albamonte, scrive Giuseppe De Filippi il 23
Settembre 2017 su “Il Foglio". Al direttore - Associazione nazionale magistrati
e indagati. Al direttore - Leggo che il pm Albamonte, capo dell’Anm, è accusato
di falso e abuso d’ufficio. Non mi pare ci sia nessun magistrato che ha chiesto
le sue dimissioni. Che sorpresa, eh?
Luca Martini: Eugenio Albamonte è un magistrato distante anni luce da Henry John
Woodcock ma sia Albamonte sia Woodcock in questa fase sono portatori di un
messaggio involontariamente rivoluzionario per la magistratura. Entrambi
indagano nell’ambito di un’inchiesta in cui sono a loro volta indagati. Woodcock
nell’ambito del caso Consip. Albamonte nell’ambito del caso Occhionero.
Involontariamente – e magnificamente – le storie di Albamonte e Woodcock
potrebbero diventare un manifesto del garantismo. Se per un magistrato non va
applicato il teorema Davigo – “non esistono innocenti, ma solo colpevoli che non
sono stati ancora scoperti” – non si capisce come possa quel teorema essere
applicato da ora in poi ad altre categorie di cittadini. Sarà certamente
d’accordo con noi Luigi Di Maio, candidato premier del movimento 5 clic
nonostante un’iscrizione nel registro degli indagati. Pop corn per tutti.
Scontro D'Amico-Davigo: "Meglio un corrotto che lo Stato rotto".
Scontro a Di Martedì tra Ilaria D'Amico e Piercamillo Davigo. Il pm: "Onestà
precondizione per la carica pubblica". La D'Amico: "Meglio un corrotto che lo
Stato rotto", scrive Claudio Cartaldo, Mercoledì 4/10/2017, su "Il Giornale".
Scontro tra Ilaria D'Amico e Piercamillo Davigo a Di Martedì condotto da
Giovanni Floris su La7 del 3 ottobre 2017. La conduttrice di Sky e il magistrato
hanno avuto un acceso dibattito sull'onestà di chi si candida ad una carica
pubblica. "Io credo che l'onestà debba essere una precondizione per qualsiasi
carica pubblica, poi uno deve essere anche bravo", dice Davigo strappando
l'applauso del pubblico. La moglie di Buffon non ci sta e decide di rispondere
per le righe. Con una frase che però sui social viene già considerata una mezza
gaffe. "Il dato dell'onestà dovrebbe essere un dato acquisito nel momento in cui
si accede alla cosa pubblica. Se si dimostra disonestà dovrebbero esserci degli
strumenti dati alla magistratura per non avvicinarsi più alla cosa pubblica".
Poi nel mezzo dell'applauso del pubblico aggiunge, scusandosi per "essere
realista": "Io non sono più purista come un tempo, meglio sopportare
qualche corrotto che avere uno Stato rotto".
Ilaria D'Amico vs Piercamillo Davigo: video, la giornalista Sky a
Di Martedì replica “meglio politico corrotto che uno stato rotto”, al magistrato
che aveva detto, "onestà prima di tutto", scrive il 4
ottobre 2017 Niccolò Magnani su "Il Sussidiario". Il dilemma è da almeno
Tangentopoli che agita la politica italiana: meglio un politico onesto o uno
capace? E proprio dall’epoca di Mani Pulite spunta il magistrato Piercamillo
Davigo - protagonista insieme al Pool di Milano durante Tangentopoli - che ieri
sera durante Di Martedì su La7 ha litigato in maniera forte con Ilaria D’Amico,
la bella giornalista Sky e moglie di Gigi Buffon, non la prima volta in veste
“politica” invitata sul canale di Urbano Cairo. Il punto del contendere è
proprio il rapporto tra capacità e onestà, dalle rivendicazioni di Movimento 5
Stelle ai populisti fino ai casi eclatanti di Consip e altri scandali interni
alla politica. «L’essere onesto è la condizione prioritaria per ricoprire
qualsiasi carica pubblica. Se un politico è bravo e disonesto è addirittura
ancora più pericoloso. Dunque meglio l’onestà, prima di tutto». A quel punto,
mentre in studio stavano per prendere parola Massimo Cacciari e Massimo
Giannini, la giornalista Sky interviene e replica “piccata” a Davigo,
premettendo di voler essere per una volta più realista di “purista”: «Mi
dispiace essere realista: sopportare qualche corrotto è meglio che avere lo
Stato rotto. Io non sono più purista come un tempo». Apriti cielo,
immediatamente lo studio si ribella contro la D’Amico per aver subodorato, tra
le righe, una miglior convenienza nell’aver qualche politico corrotto che però
fa funzionare meglio lo Stato, piuttosto che avere una Amministrazione Pubblica
magari onestissima ma incapace di far funzionare per davvero le cose.
L’indignazione di Davigo - giustizialista come da sempre - viene accompagnata
dal commento di Cacciari, che in maniera più approfondita (e cogliendo forse il
vero nodo della disputa, ndr) prova a rispondere alla D’Amico, per nulla
concorde con lei. «Non è che sia meglio o peggio. Dal punto di vista politico,
il problema essenziale è la corruzione dello Stato, che, come una macchina
rotta, è incapace di muoversi velocemente. La magistratura non può nulla, ma può
solo perseguire reati. E se i politici commettono reati, la magistratura li
persegue. Qualche volta sbaglia, qualche volta ha ragione, ma il problema non è
la magistratura. E’ evidente che è del tutto impotente coi suoi mezzi a impedire
alcunché di ciò che avviene in questo Paese, tanto è vero che dopo 25 anni c’è
ancora Berlusconi come leader indiscusso e come potenziale padre nobile del
futuro primo ministro». Il punto infatti non risiede nel meglio o peggio della
politica onesta incapace o corrotta ma capace: in un Paese “ideale” la speranza
è avere il meglio di tutto, ma per essere realisti forse non servirebbe
“puntare” sui corrotti, ma su quelle buone realtà che ci sono e funzionano senza
violare la legge. La giornalista di Sky ha poi spiegato meglio il suo concerto,
affermando come «quello che veramente paralizza il Paese è la totale incapacità
di fare il politico. Siamo in un periodo in cui gli scandali politici ci sono
ancora ma in maniera minore, e secondo me il vero punto “nuovo” risiede nella
incapacità di gestire le emergenze di cui soffre l’Italia». E poi ancora, una
D’Amico scatenata: «ma vi sembra normale che la Sicilia e la Sardegna non siano
valorizzate quanto, senza togliere nulla, alle Canarie? Bisogna imparare a
valorizzare meglio il bene che abbiamo», chiosa la giornalista di Sky Sport.
Impreparati, incompetenti, immaturi: il ceto politico non è mai
stato così ignorante. Non si è mai visto un ceto
politico così ignorante. Laureati compresi. Colpa della scuola? O di una
selezione al contrario? La democrazia rischia di non funzionare se conferisce
responsabilità di comando a persone palesemente impreparate, scrive Raffaele
Simone il 27 settembre 2017 su "L'Espresso". Anche se la legge elettorale ancora
non c’è, le elezioni si avvicinano e gli aspiranti riscaldano i muscoli. Tra i
più tenaci candidati a capo del governo ce n’è uno giovanissimo (31 anni appena
compiuti), facondo, con cipiglio, determinato e ubiquo, ma non ugualmente solido
in quel che un tempo si chiamava “bagaglio culturale”. Dalla sua bocca escono
senza freno riferimenti storici e geografici sballati, congiuntivi strampalati,
marchiani errori di fatto, slogan e progetti cervellotici (recentissimi l’Italia
come smart nation e la citazione dell’inefficiente governo Rajoy come suo
modello), anche quando si muove in quella che dovrebb’essere la sua specialità,
cioè quel mix indistinto di nozioni e fatterelli politico-storico-economici che
forma la cultura del politico di fila. Inoltre, Luigi Di Maio (è di lui che
parlo) non è laureato. Si è avvicinato al fatale diploma, ma per qualche motivo
non lo ha raggiunto. Nulla di male, intendiamoci: pare che in quel mondo la
laurea non sia più necessaria, neanche per le cariche importanti. Nel governo
Gentiloni più di un ministero è presidiato da non laureati e non laureate:
istruzione e salute, lavoro e giustizia. Se questa non è forse la “prevalenza
del cretino” preconizzata da Fruttero e Lucentini, è di certo la prevalenza
dell’ignorante. Infatti la legislatura attuale ha una percentuale di laureati
tra le più basse della storia: di poco sopra il 68 per cento, un dato che mette
tristezza a confronto col 91 per cento del primo Parlamento repubblicano…
Qualche settimana fa la Repubblica ha offerto lo sfondo a questo spettacolo,
mostrando con tanto di tabelle che la riforma universitaria detta “del 3+2”,
testardamente voluta nel 2000 dai non rimpianti ministri Berlinguer e Zecchino
al grido di “l’Europa ce lo chiede!”, è stata un fiasco. I laureati sono pochi,
non solo nel ceto politico ma nel paese, in calo perfino rispetto a quelli del
2000, ultimo anno prima della riforma. L’età media del laureato italiano è
superiore ai 27 anni e la laurea triennale non serve (salvo che per gli
infermieri) a nulla. I giovani che concludono il ciclo di 5 anni (il “3 + 2”)
sono addirittura meno del totale di quelli che vent’anni fa si laureavano coi
vecchi ordinamenti (durata degli studi 4, 5 o 6 anni). Per giunta, per
completare la laurea triennale ci vogliono 4,9 anni, per quella quinquennale più
di 7,4! Quindi, l’obiettivo principale della riforma, che era quello di
aumentare il tasso di laureati, è mancato. Le cause? Certamente non sono quelle
che ha suggerito, nel suo intervento a Cernobbio agli inizi di settembre, la non
laureata ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli: la colpa dei pochi laureati,
ha suggerito (lei ex sindacalista!), è delle «famiglie a basso reddito», che non
trovano più buoni motivi per spingere i figli a laurearsi. Non ha pensato, non
avendolo frequentato, che invece è tutto il sistema universitario che andrebbe,
come le case abusive, abbattuto e riprogettato. Quindi, se il paese è conciato
così, come possiamo pretendere che il personale politico sia meglio? Ma non è
finita. Un altro guaio, più serio, sta nel fatto che il ceto politico attuale, e
ancor più (si suppone) quello che gli subentrerà al prossimo turno, ha un record
unico nella storia d’Italia, di quelli che fanno venire i brividi: i suoi
componenti, avendo un’età media di 45,8 anni (nati dunque attorno al 1970), sono
il primo campione in grandezza naturale di una fase speciale della nostra
scuola, che solo ora comincia a mostrare davvero di cosa è capace. Perché dico
che la scuola che hanno frequentato è speciale? Perché è quella in cui, per la
prima volta, hanno convissuto due generazioni di persone preparate male o per
niente: da una parte, gli insegnanti nati attorno al 1950, formati nella
scassatissima scuola post-1968; dall’altra, quella degli alunni a cui dagli anni
Ottanta i device digitali prima e poi gli smartphone hanno cotto il cervello sin
dall’infanzia. I primi sono cresciuti in una scuola costruita attorno al
cadavere dell’autorità (culturale e di ogni altro tipo) e della disciplina e
all’insofferenza verso gli studi seri e al fastidio verso il passato; i secondi
sono nati in un mondo in cui lo studio e la cultura in genere (vocabolario
italiano incluso) contano meno di un viaggio a Santorini o di una notte in
discoteca. Prodotta da una scuola come questa, era forse inevitabile che la
classe politica che governa oggi il paese fosse non solo una delle più ignoranti
e incompetenti della storia della Repubblica, ma anche delle più sorde a temi
come la preparazione specifica, la lungimiranza, la ricerca e il pensiero
astratto, per non parlare della mentalità scientifica. La loro ignoranza è
diventata ormai un tema da spot e da imitazioni alla Crozza. I due fattori
(scarsità di studi, provenienza da una scuola deteriorata), mescolati tra loro,
producono la seguente sintesi: non si è mai visto un ceto politico così
incompetente, ignorante e immaturo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti,
nelle parole, le opere e le omissioni. Si dirà, come al solito, che il grande
Max Weber lo aveva profetizzato già nel famoso saggio sulla Politica come
professione (1919): «lo Stato moderno, creato dalla Rivoluzione» spiega «mette
il potere nelle mani di dilettanti assoluti […] e vorrebbe utilizzare i
funzionari dotati di preparazione specialistica solo come braccia operative per
compiti esecutivi». Ma il povero Max non poteva prevedere le novità cool dei
nostri tempi: per dirne una, la rabbiosa spinta che il movimento di Beppe Grillo
avrebbe dato alla prevalenza dell’incompetente.
Il caso di Virginia Raggi, per esempio, è da trattato di sociologia politica.
Pronuncia carinamente l’inglese, ma è un’icona fulgente dell’incompetenza e
dell’improvvisazione. Lo mostra, tra le mille cose, il suo incessante fare e
disfare alla ricerca di assessori, alti funzionari e dirigenti per le
partecipate: li raccatta dalle più varie parti d’Italia, senza distinguere tra
accademici e gestori di night, li licenzia di punto in bianco, non vede che la
città affonda nella monnezza e nell’incuria e intanto, svagata e placida,
esibisce al popolo sfinito la più granitica certezza del radioso futuro della
Capitale. Max Weber non avrebbe mai immaginato neppure che i destini della
Capitale potessero esser telegovernati da un paio di signori che nessuno ha
eletto, o che una deputata, che nella vita faceva la ragioniera, sarebbe
arrivata a spiegare col forte caldo la lieve ripresa estiva del Pil. Gli
incompetenti si sono procurati ulteriore spazio sfruttando senza ritegno il
tormentone del rinnovamento di generazione, che, partito dall’Italia, ha
contagiato quasi tutt’Europa. Esser giovane in politica è ormai un titolo di
merito di per sé, indipendentemente dal modo in cui la giovinezza è stata spesa,
anche se i vecchi sanno bene che la giovinezza garantisce con sicurezza assoluta
solo una cosa: l’inesperienza, una delle facce dell’incompetenza.
La cosa è talmente ovvia che nel 2008 la ministra Marianna Madia, eletta in
parlamento ventiseienne, non ancora laureata, dichiarò che la sola cosa che
portava in dote era la sua “inesperienza” (sic). La lista che ho appena fatto
non contiene solo piccoli fatti di cronaca. Se si guarda bene, è una lista di
problemi, perché suscita due domande gravi e serie. La prima è: a cosa dobbiamo,
specialmente in Italia, quest’avanzata di persone che, oltre che giovanissime,
sono anche I-I-I (“incompetenti, ignoranti e immaturi”)? È la massa dei somari
che prende il potere, per una sorta di tardivo sanculottismo culturale? Sono le
“famiglie di basso reddito” della Fedeli, ormai convinte che i figli, invece che
farli studiare e lavorare, è meglio spingerli in politica? Oppure è l’avanzata
di un ceto del tutto nuovo, quello dell’uomo-massa, di cui José Ortega y Gasset
(in La ribellione delle masse) descriveva preoccupato l’emergere?
«L’uomo-massa si sente perfetto» diceva Ortega y Gasset, aggiungendo che «oggi è
la volgarità intellettuale che esercita il suo imperio sulla vita pubblica». «La
massa, quando agisce da sola, lo fa soltanto in una maniera, perché non ne
conosce altre: lincia». È una battutaccia da conservatore? Oppure la dura
metafora distillata da un’intelligenza preveggente? Comunque la pensiate, queste
parole non sono state scritte oggi, ma nel 1930. Forse l’avanzata della
«volgarità intellettuale» era in corso da tempo e, per qualche motivo, non ce ne
siamo accorti.
La seconda domanda seria è la seguente: la democrazia può funzionare ancora se
conferisce responsabilità di comando a persone dichiaratamente I-I-I? Forse in
astratto sì, se è vero che (come pensava Hans Kelsen) la democrazia è «il regime
che non ha capi», nel senso che chiunque può diventare capo. In un regime del
genere, quindi, chiunque, anche se del tutto I-I-I e appena pubere, può dare un
contributo al paese. Napoleone salì al vertice della Francia a 29 anni e
Emmanuel Macron (suo remoto emulo, dileggiato dagli oppositori col nomignolo di
Giove o, appunto, di Napoleone) è presidente della Repubblica a 39. Nessuno di
loro aveva mai comandato le armate francesi o governato la Repubblica. Ma
ammetterete senza difficoltà che tra loro e Luigi Di Maio (e tanti suoi colleghi
e colleghe con le stesse proprietà, del suo e di altri partiti) qualche
differenza c’è.
Giustizia divina. Dalla legge 40 alle adozioni gay, così i
giudici creano una nuova etica, scrive il 9 Marzo 2017
"Il Foglio". Il Tribunale dei minori di Firenze ha disposto la trascrizione in
Italia dei provvedimenti emessi da una Corte britannica riconoscendo l’adozione
di due bambini da parte di una coppia gay. È la prima volta che accade in
Italia. I fratellini sono stati adottati dai due uomini, cittadini italiani, nel
Regno Unito, dove risiedono da anni: “Per la prima volta viene riconosciuta in
Italia l’adozione di minori all’estero da parte di una coppia di uomini”, fa
sapere Rete Lenford, l’Avvocatura per i diritti Lgbt a cui si sono rivolti i due
uomini. La magistratura ha assunto un nuovo ruolo chiave: laddove la natura non
riconosce un diritto, che da naturale deve diventare positivo, e laddove neppure
la politica vuole intervenire, ci pensano i magistrati. Lo abbiamo visto in
tante sentenze che hanno letteralmente smantellato la legge 40, una buona legge
sulla fecondazione artificiale, facendo entrare per la porta del diritto anche
ciò che la legislazione vietava espressamente (maternità surrogata, eterologa,
diagnosi eugenetica). Lo stesso vale per le “nuove famiglie”, famiglie omo si
intende. È l’etica per via giudiziaria. Già la Consulta e la Cassazione avevano
riconosciuto l’unione omosessuale come “formazione sociale”. Lo scorso gennaio,
il primo presidente di Cassazione, Giovanni Canzio, aveva parlato delle adozioni
da parte delle coppie gay: “La Corte non può e non intende sottrarsi al dovere
di apprestare tutela ai diritti fondamentali della persona”. Ormai sono loro, le
toghe, i grandi ultimi moralizzatori che fanno e disfanno i principi non
negoziabili. Visto che il Parlamento della “casta corrotta” perde tempo, spetta
ai magistrati sanare anche questa “emergenza democratica”, riconoscendo le
famiglie gay. Li abbiamo visti, i magistrati, impartire lezioni di etica dopo
Tangentopoli, chiamati nelle università, nei talk-show, nei convegni. Dentro le
aule giudiziarie impartiscono pure lezioni di bioetica. Rete Lenford, decisiva
in questa sentenza, ha organizzato convegni con Magistratura Democratica dal
titolo “La Costituzione e la discriminazione matrimoniale delle persone gay e
lesbiche e delle loro famiglie”. Chiamatela giustizia divina.
LA REPUBBLICA GIUDIZIARIA, ASPETTANDO LA TERZA REPUBBLICA.
«Il compito della magistratura? Sottomettere la politica»,
scrive Piero Sansonetti il 6 Settembre 2017, su "Il Dubbio". Ho letto con molto
interesse – e qualche apprensione… – il resoconto stenografico degli interventi
del procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, e del sostituto
procuratore della Dna (Direzione nazionale antimafia) Nino Di Matteo,
pronunciati qualche giorno fa alla festa del Fatto Quotidiano, in Versilia. Li
ha pubblicati ieri proprio il Fatto considerandoli, giustamente, documenti di
grande interesse giornalistico e politico. Potrei scrivere per molte pagine,
commentandoli. Mi limito invece a pochissime critiche e soprattutto a una
osservazione (alla quale, contravvenendo a tutte le regole del giornalismo,
arriverò alla fine di questo articolo) che mi pare essenziale. Essenziale per
capire l’Italia di oggi, per decifrare il dibattito pubblico, e per intuire a
quali pericoli sia esposta la democrazia. Innanzitutto voglio subito notare che
sebbene il Fatto pubblichi i due interventi, intervallando brani dell’uno e
brani dell’altro, quasi fossero un unico discorso, si nota invece una
differenza, almeno nei modi di esposizione, molto netta. Roberto Scarpinato dà
l’impressione di avere una conoscenza approfondita dei fatti e anche della
storia (italiana e internazionale) nella quale vanno inquadrati. Nino Di Matteo
sembra invece soprattutto travolto da una indubbia passione civile, che però lo
porta a scarsa prudenza, sia dal punto di vista formale sia nella ricostruzione
storica. La tesi di fondo dei due interventi però è un’unica tesi. La riassumo
in cinque punti. Primo, la mafia nel 1992, dopo la caduta del muro di Berlino,
decise di intervenire nella politica italiana perché terrorizzata dall’idea che
– finite le ideologie e i veti, e il famoso fattore K che escludeva i comunisti
dal governo – potesse prendere il potere una coalizione composta da sinistra
democristiana (ex zaccagniniana) ed ex Pci, all’epoca Pds. «Condannare i
criminali? No, il compito della magistratura è sottomettere la politica».
Secondo punto, in questa ottica, dopo le stragi del 1993, si svolse una
trattativa tra lo Stato e la mafia e questa trattativa, pare di capire,
coinvolse essenzialmente elementi dell’ex sinistra dc (Mancino, Mannino, forse
De Mita) e dell’ex Pci (Giorgio Napolitano). Terzo punto, è stato proprio
Giorgio Napolitano a delegittimare il processo sulla trattativa tra Stato e
mafia che si sta spegnendo a Palermo tra assoluzioni e prove mancate: e la
cattiva sorte di quel processo è da imputare non a una cattiva impostazione
delle indagini e delle tesi di accusa, ma all’intervento dell’allora capo dello
Stato. Quarto, la mafia da allora ha cambiato pelle, ha rinunciato ad usare la
violenza e l’omicidio per condurre la sua strategia, e questo la rende ancora
più pericolosa, perché riesce a crescere semplicemente usando lo strumento della
corruzione e addirittura, in certe occasioni, senza neppure commettere reati
formali. Il quinto punto lo accenno appena, perché ci torniamo alla fine – è il
punto chiave – riguarda il compito e la missione della magistratura.
Naturalmente i primi quattro punti sono in forte contraddizione l’uno con
l’altro. Ad esempio non si capisce come facesse la mafia, quando ha iniziato
l’attacco allo Stato (che Scarpinato e Di Matteo datano con l’uccisione di Salvo
Lima del marzo 1992), a prevedere il crollo del potere politico italiano, che
allora era ancora saldamente nelle mani del pentapartito, e non certo del Pci,
che viveva un nerissimo periodo di crisi. Nessun analista politico previde
Tangentopoli (neppure dopo l’arresto di Mario Chiesa) che esplose clamorosamente
dopo l’uccisione di Falcone, né tanto- meno le conseguenze di Tangentopoli,
eppure l’attacco della mafia iniziò prima di Tangentopoli. E non si capisce
molto bene neanche perché la mafia uccidesse Lima ( destra Dc), e poi Falcone (
che era legato ai socialisti di Craxi) se voleva colpire la sinistra Dc e l’ex
Pci, che di Lima e Falcone erano nemici; né si capisce perché furono Napolitano
e Mancino ( ex Pci e sinistra dc) ad aiutare la mafia che era terrorizzata – se
capiamo bene – perché temeva che Napolitano e Mancino andassero al potere…Fin
qui, diciamo con un po’ di gentilezza, è solo un bel pasticcio, che certo non si
regge in piedi come atto d’accusa. Né giudiziario, né politico, né tantomeno
storico. E si capisce bene perché il processo Stato- mafia stia finendo a
catafascio. Scarpinato e Di Matteo da questo punto di vista hanno avuto la
fortuna di parlare, in Versilia, ad una platea amica che non aveva nessuna
voglia di fare obiezioni (così come, in genere, non ne ha quasi mai il
giornalismo giudiziario, e non solo, italiano). Ma il punto che mi interessa
trattare è il quinto. L’idea di magistratura che – temo – va affermandosi in un
pezzo di magistratura. Cito alcuni brani, testuali, di Di Matteo, che sono
davvero molto istruttivi. In un crescendo. «Oggi si sta nuovamente (sottinteso,
la politica, ndr) mettendo in discussione l’ergastolo, l’ergastolo ostativo,
cioè l’impossibilità, per i condannati per mafia, di godere dei benefici. Si sta
cominciando a mettere in discussione, attraverso anche, purtroppo, un sempre più
diffuso lassismo nell’applicazione, l’istituto del 41 bis, il carcere duro
(….)». E più avanti: «I fatti sono fatti, anche quando vengono giudicati in
sentenze come non sufficienti per condannare qualcuno… Adesso la partita è
questa: vogliamo una magistratura che si accontenti di perseguire in maniera
efficace i criminali comuni (…) o possiamo ancora aspettarci che l’azione della
magistratura si diriga anche nel controllare il modo in cui il potere viene
esercitato in Italia? Questa è una partita decisiva per la nostra democrazia».
La prima parte di questo ragionamento è solo la richiesta di poteri speciali,
non nuova, tipica del pensiero reazionario (e non solo) da molti anni. In realtà
i magistrati prudenti sanno benissimo che il 41 bis è carcere duro (e dunque è
in contrasto aperto e clamoroso con la nostra Costituzione) ma stanno attenti a
non usare mai quella definizione. Quando, intervistando qualche magistrato, ho
provato a dire che il 41 bis è carcere duro, sono sempre stato contestato e
rimproverato aspramente: «Non è carcere duro – mi hanno detto ogni volta – è
solo una forma diversa di detenzione…». Di Matteo, lo dicevo all’inizio, è
trascinato dalla sua passione civile (che poi è la sua caratteristica migliore)
e non bada a queste sottigliezze, dice pane al pane, e carcere duro al carcere
duro. Non so se conosce l’articolo 27 della Costituzione, probabilmente lo
conosce ma non lo condivide e non lo considera vincolante. Così come non
considera vincolante l’esibizione delle prove per affermare una verità, e
questo, da parte di un rappresentante della magistratura, è un pochino
preoccupante. Quel che però più colpisce è la seconda parte del ragionamento. E
cioè le frasi che proclamano in modo inequivocabile che il compito della
magistratura è mettere sotto controllo la politica (sottometterla, controllarla,
dominarla, indirizzarla), cancellando la tradizionale divisione dei poteri
prevista negli stati liberali, e non può ridursi invece a una semplice attività
di giudizio e di punizione dei crimini. E’ probabile che siano pochi i
magistrati che commettono la leggerezza di dichiarare in modo così chiaro ed
esplicito la loro idea di giustizia, del tutto contraria non solo alla
Costituzione ma ai principi essenziali del diritto; però è altrettanto probabile
che il dottor Di Matteo non sia il solo a pensarla in questo modo. E siccome è
anche probabile che esista una vasta parte del mondo politico, soprattutto tra i
partiti populisti, ma anche nella sinistra, che non disdegna le idee di Di
Matteo, e siccome non è affatto impossibile che questi partiti vincano le
prossime elezioni, mi chiedo se esista, in Italia, il rischio di una vera e
propria svolta autoritaria, e antidemocratica, come quella auspicata da Di
Matteo – non so se anche da Scarpinato – o se esita invece una tale solidità
delle istituzioni e dell’impianto costituzionale da metterci al sicuro da questi
pericoli.
Davigo:
“Renzi è confuso. Per cacciare un politico basta la sua difesa”.
Il magistrato - “Il leader Pd mi dà del khomeinista, ma è per andare in cella
che servono le sentenze. Per andare a casa, bastano certe autodifese indecenti”.
Intervista di Marco Travaglio del 16 luglio 2017 su "Il Fatto Quotidiano".
Piercamillo
Davigo, l’uscita della sua corrente Autonomia e Indipendenza dalla giunta
dell’Associazione magistrati continua a far discutere. Il presidente dell’Anm
Eugenio Albamonte della corrente Area e il leader di Unicost Antonio Sangermano
la accusano di “populismo giudiziario”.
«Ridicolo.
È la stessa accusa che mi hanno sempre mosso i peggiori politici e giornali. Ora
vedo che la usano anche alcuni colleghi. La prendo come una medaglia alla mia
indipendenza. Io indico la luna e questi guardano il dito».
Quale
sarebbe la luna?
«Le
nomine lottizzate, poco trasparenti e incomprensibili di magistrati negli
incarichi giudiziari direttivi e semidirettivi da parte del Csm, che sconcertano
buona parte dei nostri colleghi, oltre ai settori più avveduti dell’opinione
pubblica. E la risposta qual è? Che io le denuncio per guadagnare voti con la
mia componente associativa. Ma santo cielo, se mi dicono così significa che lo
sanno anche loro che molti magistrati la pensano come me. O credono che la loro
base sia formata da un branco di idioti?»
Qual è oggi
il rischio più grave per la magistratura italiana?
«Quello
del carrierismo e quello del conformismo verso il potere politico, che il Csm
dovrebbe arginare, non incentivare. Le nomine dei dirigenti degli uffici
requirenti e giudicanti dovrebbero rispondere a criteri più chiari e stringenti
e avvenire con procedure più trasparenti e comprensibili. Chi concorre a un
incarico deve presentare un’auto-relazione, che poi viene confrontata con quelle
degli altri per la scelta finale del Csm. Ecco, queste relazioni devono essere
online, a disposizione di tutti. Per un’esigenza profilattica: così uno evita di
tessere lodi infondate o esagerate di se stesso; chi vota per lui risponderà
della sua scelta a tutta la magistratura e ai cittadini; e tutti capiranno se il
Csm ha scelto il più bravo oppure no. Non c’è privacy che tenga. Oggi purtroppo
non è così, il che provoca una crescente disaffezione dei magistrati verso il
loro organo di autogoverno: io vengo accusato di colpire il Csm, mentre voglio
difenderlo, aiutandolo a evitare errori».
Lei
contesta la lottizzazione correntizia delle nomine “a pacchetto”. Perché?
«Se
si decide contemporaneamente su un mazzo di incarichi da riempire, senza
trasparenza né criteri stringenti, il rischio è che non si scelga il migliore
per ogni posto, ma che si segua la logica dell’“uno a me, uno a te, uno a
lui”. Mettano tutto online: a parole sono tutti d’accordo, perché non lo fanno?
Un collega mi ha detto: “Ormai ci stupiamo se ogni tanto il Csm nomina uno
bravo”. E purtroppo sono in molti a pensarlo. Ma si può andare avanti così?»
Voi avete
contestato le nomine dell’ex assessore della giunta siciliana di Lombardo,
Giovanni Ilarda, a Pg di Trento, e l’indicazione dell’ex deputato Pd Lanfranco
Tenaglia a presidente del Tribunale di Pordenone.
«Ci
siamo sentiti presi in giro. La giunta unitaria dell’Anm si era data un
programma, che comprendeva il monitoraggio delle nomine direttive e
semidirettive del Csm, per verificare il rispetto delle regole. Dopo durissime
discussioni, abbiamo creato questo gruppo di lavoro. E c’era un’intesa sui
“fuori ruolo” che arrivano dai ministeri: almeno un anno di pausa, prima che
possano concorrere a incarichi direttivi. Inoltre il Comitato direttivo centrale
dell’Anm approvò una richiesta al Parlamento per stabilire che chi rientra da
un’esperienza politica non abbia funzioni giurisdizionali. Su questi punti quasi
tutte le correnti dell’Anm, a cominciare da Area, avevano posizioni
intransigentissime. Ma se poi chiediamo al Csm di attenersi, per coerenza, a
questi criteri nelle sue nomine, cominciano i distinguo, le resistenze, e si
continua a fare come se niente fosse. Addirittura si fa saltare la fila ai
“fuori ruolo” di ritorno, che passano davanti a quelli che hanno sempre tenuto
la toga in spalla. Ma con quale credibilità? Ecco: se non mi fido di chi gioca
con me, non gioco più».
Non è
strano che il favorito al Csm per fare il capo della Procura di Napoli sia
Giovanni Melillo, capo di gabinetto uscente del ministro Orlando?
«Non
voglio parlare dei casi singoli, ma dei princìpi: se abbiamo ritenuto che i
“fuori ruolo” per un anno non possano diventare dirigenti di uffici giudiziari,
quella nomina violerebbe questo principio. È una cosa ovvia: persino gli
ambasciatori, che non hanno doveri di indipendenza, dopo un certo periodo
all’estero devono rientrare in Italia per il cosiddetto “bagno”: altrimenti
diventano cittadini stranieri. A maggior ragione questo deve valere per i
magistrati che vengono cooptati dai politici per incarichi ministeriali: badi
bene, non scelti per concorso, ma per rapporti fiduciari di natura politica.
Prima di tornare in incarichi giudiziari delicati, devono respirare di nuovo
l’aria della cultura della giurisdizione, per essere e anche per apparire di
nuovo “indipendenti da ogni altro potere”: come prescrive la Costituzione.
Altrimenti si dà un segnale devastante ai magistrati».
Quale?
«Che
vale di più stare fuori ruolo, in posti più prestigiosi e meno stressanti, che
non fare i giudici o i pm sotto montagne di fascicoli, spesso sull’orlo del
tracollo psicofisico, ed esposti a rischi disciplinari per ritardi fisiologici o
errori formali».
Ieri
Sangermano, sul Giornale, trova gravissima la frase che le viene attribuita,
secondo cui: “Non esistono politici innocenti, ma solo colpevoli su cui non sono
state raccolte le prove”.
«Sì,
è la stessa che mi attribuisce anche Renzi nel suo ultimo libro: sorprendente
questa assonanza, non trova? Evidentemente i due hanno le stesse fonti, o
leggono la stessa pessima stampa. In realtà io parlavo di un processo specifico:
quello di Mani Pulite sulla linea 3 della metropolitana milanese, dove si
dimostrò fino in Cassazione che tutte le imprese consorziate versavano la loro
quota di tangenti all’impresa capofila, che poi versava l’intera mazzetta al
cassiere unico della politica, che poi la distribuiva pro quota a ogni
rappresentante dei partiti, di maggioranza e di opposizione. È colpa mia se poi
sono stati tutti condannati? È il solito giochino che una volta facevano solo
certi politici e certi giornalacci: prendere una frase e isolarla dal contesto
per buttartela addosso. Un giorno il capitano di una nave scoprì che il primo
ufficiale di guardia era ubriaco e lo scrisse nel giornale di bordo. Quello, per
vendicarsi, scrisse a sua volta: “Oggi il comandante non era ubriaco”. Era la
verità, ma quella frase, estrapolata dal contesto, sembrò un atto di accusa,
come a dire che tutte le altre volte il comandante era ubriaco. Ecco, questi
fanno così. Sono ridicoli».
Renzi
scrive anche che lei non sa cos’è il garantismo, non conosce Cesare Beccaria. Le
rinfaccia una frase di Giovanni Falcone contro i “khomeinisti” della “cultura
del sospetto”. E le rammenta che, per decidere se uno è colpevole o innocente,
bisogna attendere la sentenza definitiva.
«Deve
avere le idee molto confuse. Io, come tutti i magistrati, non mi sognerei mai di
condannare qualcuno sapendolo innocente, perché sono stato educato alla cultura
della prova. Noi magistrati esistiamo proprio per distinguere fra colpevoli e
innocenti. Ma sappiamo anche che non sono le sentenze che debbono selezionare la
classe dirigente e politica: è la politica che deve fare le sue valutazioni
autonome sul materiale giudiziario e decidere se certe condotte già dimostrate
in fase di indagine, a prescindere dalla rilevanza penale, sono compatibili o
meno con la “disciplina” e “l’onore” richiesti dall’art. 54 della Costituzione a
chi ricopre pubbliche funzioni. Per mandare in carcere qualcuno a espiare la
pena, ci vuole la condanna definitiva. Ma per mandarlo a casa, a volte non c’è
bisogno nemmeno della condanna di primo grado. Anzi, non c’è neppure bisogno
dell’accusa: basta la sua difesa».
Addirittura?
«Certo.
Certi politici si difendono in modo talmente vergognoso che andrebbero mandati a
casa solo per quello. Prenda quel dirigente di una Asl lombarda accusato di
mafia (e poi condannato) che, quando emersero le sue intercettazioni, si difese
dicendo: “Io fin da ragazzo mi diverto a sembrare un mafioso”. C’è bisogno della
condanna, per cacciarlo? Ecco: se i politici facessero pulizia al loro interno
quando vengono a sapere cose del genere, le nostre indagini e sentenze non
creerebbero alcuna tensione fra giustizia e politica, perché noi processeremmo
solo degli “ex”. Invece se li tengono tutti fino alla condanna definitiva, e
spesso anche dopo».
Sangermano
dice pure che la legge Severino non poteva essere applicata “retroattivamente” a
Berlusconi per espellerlo dal Senato.
«Sono
allibito. Non c’è stata alcuna applicazione retroattiva. La decadenza da
parlamentare prevista dalla Severino non è una sanzione penale, ma un requisito
di onorabilità: se la legge dice che i condannati a certe pene per certi reati
non possono andare o restare in Parlamento, vale per tutti i condannati, per
reati commessi sia prima sia dopo la legge».
Renzi però
scrive che prima di entrare in politica né lui né la sua famiglia avevano mai
subito indagini, mentre dopo sì. E che un ex deputato di Forza Italia l’aveva
avvertito dopo la sconfitta referendaria: “Ora partirà l’attacco delle procure
ai renziani”. E subito arrivò l’inchiesta Consip.
«A
parte il fatto che l’inchiesta mi pare sia partita diversi mesi prima, questo lo
diceva già Berlusconi, con la medesima attendibilità. Ma poi bisogna intendersi:
è ovvio che, quando assumi una carica pubblica, sei più esposto di un passante
al rischio di indagini giudiziarie. Nel senso che diventi pubblico ufficiale, o
incaricato di pubblico servizio, funzioni che ti prescrivono una serie di regole
in più di quelle previste per un privato, e ti espongono anche al rischio di
essere denunciato dai cittadini per i tuoi atti. Se invece Renzi vuol dire che
per chiunque vada al governo, o perda le elezioni, scatta il complotto
giudiziario, dice cose insensate».
Lei ha mai
avuto offerte ministeriali?
«Quella
che sanno tutti: nel 1994 Ignazio La Russa mi voleva ministro della Giustizia
nel primo governo Berlusconi. Risposi “no grazie”. Poi non si azzardò mai più
nessuno: o sto antipatico a tutti, oppure tutti mi ritengono politicamente
inaffidabile. In ogni caso, me ne vanto».
Ultimamente
la volevano i Cinque Stelle.
«Nessuna
proposta formale. E, a scanso di equivoci, al loro recente convegno alla Camera
ho ribadito che i giudici non dovrebbero mai fare politica, anche se sarebbe
assurdo vietarlo per legge (nelle democrazie serie lo si proibisce ai
pregiudicati, non ai magistrati). Però un protagonista di Tangentopoli,
condannato in via definitiva, ha dichiarato che, se vincono i 5Stelle,
Mattarella non darà mai l’incarico a Di Maio, ergo il M5S indicherà me come
premier, e sarà la fine. A parte il fatto che è fantascienza, mi inorgoglisce
che un pregiudicato pensi questo di me…»
Perché i
magistrati non devono fare politica?
«Perché
non sono capaci, della qual cosa esistono evidenze empiriche. Ha mai visto uno
che ha fatto a lungo il magistrato diventare un grande statista? I politici
sono, o dovrebbero essere, scelti (cioè eletti) col criterio della
rappresentanza. I professionisti, con quello della competenza, tant’è che
nessuno si farebbe operare da un chirurgo che passa per bravo solo perchè è
stato eletto dal popolo. Noi magistrati siamo un’altra cosa: abbiamo le
guarentigie di indipendenza proprio per potercene infischiare delle critiche
dell’opinione pubblica: come potremmo gestire il consenso, se non l’abbiamo mai
fatto prima in vita nostra?»
La prova
empirica sarebbe la produzione legislativa delle commissioni Giustizia e del
ministero della Giustizia, infarciti di magistrati (oltreché di avvocati)?
«Anche.
Roba da mettersi le mani nei capelli. Da anni si dice alle procure che, non
potendo smaltire tutti i fascicoli, devono privilegiare quelli per reati più
gravi e poi, a scalare, tutti gli altri. Ma ora, nella riforma penale Orlando
che entra in vigore il 3 agosto, c’è l’avocazione obbligatoria da parte delle
Procure generali per tutti i fascicoli che i pm non hanno chiuso con una
richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione entro 3 mesi dalla scadenza
dei termini. Solo che le Procure generali hanno organici molto più ridotti di
quelli delle Procure…»
E allora?
«E
allora come fanno a smaltire per tempo i fascicoli che non sono riusciti a
evadere nemmeno le Procure? I Pg applicheranno nei propri uffici i pm delle
Procure per farsi aiutare. Cioè: prima dici ai pm di dare la precedenza a certi
fascicoli, poi gli fai levare quelli che non han fatto in tempo a smaltire, e
infine li chiami a smaltire quelli che gli hai fatto levare. Ma si può andare
avanti così? È l’idea balzana che si risolvano i problemi dando degli ordini,
peraltro inapplicabili, come le gride manzoniane del governatore Ferrer. Tipo
quando Renzi annunciò una legge per fare durare i processi non più di un anno. E
perché – risposi io – non sei mesi? O due settimane? Poi c’è l’obbrobrio delle
pensioni».
Quale?
«Il
decreto del governo Renzi che ha anticipato il nostro pensionamento dai 75 ai 70
anni e ha lasciato repentinamente scoperti 500 incarichi direttivi, portando i
vuoti di organico a quota 1200. Siccome, da quando viene bandito un concorso per
nuovi magistrati a quando questi entrano in servizio dopo la nomina e il
tirocinio, passano 4 anni, noi dell’Anm abbiamo detto: prima reclutate i
giovani, poi mandate a casa i vecchi. Conservo la lettera del ministro Orlando
che, a nome del governo, si impegnava con l’Anm a prorogare il pensionamento di
tutti i magistrati a 72 anni fino alla completa copertura dell’organico. Impegno
poi incredibilmente disatteso. Alla Camera, il ministro ha spiegato che
l’impegno l’aveva assunto il governo Renzi e ora il governo era cambiato. Pensi
se lo stesso discorso l’avesse fatto sui titoli di Stato il ministro
dell’Economia e delle Finanze: gli impegni non valgono più perché è cambiato il
governo. Sarebbe saltata l’economia italiana su tutti i mercati internazionali».
Rimpiange i
governi Berlusconi?
«Diciamo
che il centrosinistra non li fa rimpiangere, però ha fatto più danni. Il
centrodestra faceva leggi terribili, che fortunatamente perlopiù non
funzionavano, o venivano dichiarate incostituzionali dalla Consulta, o sortivano
effetti opposti a quelli sperati. Ma allora almeno il centrosinistra votava
contro, protestava, chiamava la gente in piazza. Ora che quello che non era
riuscito a fare il centrodestra lo fa il centrosinistra, il centrodestra glielo
vota e quasi nessuno protesta».
Ora il
governo di centrosinistra si dibatte fra gli annunci di linea dura
sull’immigrazione e lo Ius soli.
«Se
avessero disciplinato per tempo l’immigrazione, con la politica dei visti per i
Paesi e le posizioni che servivano alla nostra economia (mai sentito proteste
per le domestiche filippine), non ci troveremmo a questo punto. Per anni non si
sono concessi i visti a nessuno, costringendo i migranti a entrare
clandestinamente in Italia. Così poi sono arrivate le sanatorie indiscriminate,
che generano aspettative di nuovi colpi di spugna, come i condoni edilizi e
fiscali. E ora il fenomeno appare incontrollato, anche perché le annunciate
espulsioni degli irregolari sono solo sulla carta: non si fanno perché mancano
sempre i soldi. Si lasciano incancrenire i problemi e poi li si scaricano sui
cittadini. E anche sui magistrati, con reati inutili come quello di
clandestinità. Che ancora non è stato abolito, anche non risolve nulla, anzi
complica le indagini sugli scafisti: non possiamo più sentire i migranti come
testimoni, con l’obbligo di dire la verità, ma dobbiamo ascoltarli come
indagati, con la facoltà di mentire e di non rispondere».
Lei ripete
spesso che l’Anac di Raffaele Cantone serve a poco: non crede nella prevenzione
anticorruzione?
«Non
credo che la corruzione si combatta con questo tipo di prevenzione, che previene
poco o nulla. I problemi si prevengono conoscendoli, e la corruzione si conosce
solo facendo le indagini, gli arresti e i processi, non controllando la
regolarità delle pratiche amministrative e burocratiche. L’esperienza insegna
che, quando uno vuole delinquere, sta molto attento a curare la forma per
lasciare tutte le carte a posto».
Com’è oggi
la magistratura rispetto a 25 anni fa, cioè al tempo di Mani Pulite?
«Molto
più genuflessa e intimidita di allora. La situazione complessiva creata dalla
classe politica ha avuto l’effetto di spaventare e piegare molti magistrati. Tra
carichi di lavoro massacranti, sanzioni disciplinari durissime per vizi formali
e ritardi naturali, leggi penali e regole processuali cambiate per mandare in
fumo i processi ai colletti bianchi, attacchi politici e mediatici, nomine non
trasparenti, hanno creato un ordine giudiziario sempre meno forte, sereno e
indipendente e sempre più affetto dal carrierismo e dalla tentazione di cercare
santi protettori. Cioè sempre più conformista verso chi comanda».
Davvero non
si sente un khomeinista?
«Si
figuri. Ho sempre fatto il magistrato allo stesso modo e sono stato attaccato da
tutte le parti. Mi han dato ora del comunista, ora del fascista, del servo della
Cia e dei servizi segreti, adesso pure del populista e del grillino. Il che, per
me, significa essere imparziale. Lo scrisse Piero Calamandrei a proposito del
giudice Aurelio Sansoni, bollato di “pretore rosso” perché nel 1922 faceva
rispettare la legge dalle camicie nere: se non sei disposto a servire una
fazione, devi rassegnarti all’accusa di essere al servizio della fazione
contraria. E dire che, da giovane, quando abbaiavo ai ladri, mi battevano le
mani. Poi, salendo il livello dei ladri, ogni volta che abbaiavo hanno
cominciato a prendermi a calci».
Quella
frase di Davigo che lo inchioda da 25 anni.
Dei politici
disse: "Solo colpevoli non ancora scoperti". Ora si smarca, ma ha consegnato
l'Italia ai giustizialisti, scrive Stefano Zurlo, Lunedì 17/07/2017, su "Il
Giornale". Ci sono persone che diventano proverbi. Piercamillo Davigo, uno dei
più celebri magistrati tricolori, potrebbe essere raccontato attraverso due
massime che hanno fatto il giro del mondo: «Rivolteremo l'Italia come un
calzino» e l'altra, altrettanto dirompente, «non esistono politici innocenti ma
colpevoli su cui non sono state raccolte le prove». O, per dirla con modi
spicci, non ci sono innocenti ma colpevoli non ancora scoperti. Queste due
«filastrocche», scandite ai tempi gloriosi di Mani pulite quando Davigo militava
nel Pool, sono diventate negli anni inni semiufficiali del giustizialismo
all'italiana. Veri e propri mantra ripetuti a occhi chiusi, quasi in trance, da
generazioni di girotondini, grillini, manettari. Del resto, dopo un quarto di
secolo in prima linea, Davigo è sempre lo stesso. Intransigente, quasi
apocalittico, durissimo nei confronti del potere che pure ha molto da farsi
perdonare e spesso ha fatto di tutto per dargli ragione. Passi per lo stivale
formato calzino. Stupisce invece che ora l'ex presidente dell'Associazione
nazionale magistrati cerchi di smarcarsi dall'altro concetto, diventato
evidentemente troppo ingombrante. Non può negare di averlo pensato e compresso
come un sandwich dentro uno slogan, e ci mancherebbe, ma prova a circoscriverlo,
a collocarlo in un angolo della cronaca dove non appaia per quello che è:
eccessivo, fuori misura, buono per quella cultura del sospetto che ha avvelenato
i pozzi per una lunga stagione. Dunque Davigo non può smentire ma prende le
distanze da se stesso in una chilometrica intervista apparsa ieri sul Fatto
quotidiano a firma del direttore Marco Travaglio. Travaglio ricorda all'ex pm
che quelle parole sono state contestate persino da uno dei leader dell'Anm,
Antonio Sangermano, in un colloquio con Luca Fazzo sul Giornale. Davigo ne
approfitta per spargere un po' di sale, alla sua maniera: «Sì, è la stessa»
frase «che mi attribuisce anche Renzi nel suo ultimo libro: sorprendente questa
assonanza, non trova? I due hanno le stesse fonti o leggono la stessa pessima
stampa». Così, dopo aver messo insieme e maltrattato a freddo il Giornale e l'ex
premier, il giudice arriva finalmente al punto: «In realtà io parlavo di un
processo specifico: quello di Mani pulite sulla linea 3 della metropolitana
milanese, dove si dimostrò fino in Cassazione che tutte le imprese consorziate
versavano la loro quota di tangenti all'impresa capofila, che poi versava
l'intera mazzetta al cassiere unico della politica, che poi la distribuiva pro
quota a ogni rappresentante dei partiti di maggioranza e di opposizione». È
quello il fondale da cui partì il viaggio di quella fortunatissima affermazione.
«È colpa mia - tira le fila il giudice - se poi tutti sono stati condannati?»
Siamo alle solite. Davigo s'improvvisa filologo di se stesso, s'immerge nel
proprio passato, come aveva fatto pure a Porta a Porta piazzando la solita
didascalia sul «contesto specifico» sotto quel frammento di storia della
magistratura tricolore, salvo poi ricordare con una punta di compiacimento che
erano tutti colpevoli, dal primo all'ultimo. Davigo ha più di un merito: ha
condotto brillantemente indagini difficilissime e oggi guida senza peli sulla
lingua, come è nel suo stile, la battaglia contro il male dei mali della
corporazione in toga: la lottizzazione degli incarichi. Ma è anche il campione
di quella mentalità manichea che ha trasformato l'Italia in una riserva di
caccia per magistrati e investigatori. Con errori gravissimi, ricadute
devastanti sulla nostra economia, l'indebolimento complessivo di quel potere
politico che lui continua a combattere. E la scoperta infine del contrario
esatto di quel che lui va predicando da sempre: esistono colpevoli che invece
erano innocenti per davvero. Ma hanno avuto vita e carriera rovinate per sempre.
Se Davigo
sa dei reati e non denuncia.
L'attacco della toga, scrive Alessandro Sallusti, Lunedì 17/07/2017, su "Il
Giornale". Piercamillo Davigo, il magistrato giustiziere, in una lunga
intervista concessa al Fatto Quotidiano bolla come «pessima stampa» e
«giornalacci» i giornali - cioè noi - che lo hanno criticato per le sue
posizioni integraliste, compresa quella per cui «un imputato assolto non è
innocente ma un colpevole che l'ha fatta franca» e che gli «errori giudiziari
non esistono». Se leggesse più spesso certi «giornalacci», Davigo prenderebbe
coscienza di quante persone, famiglie e aziende sono state rovinate, quante
reputazioni sono state distrutte e patrimoni azzerati da abbagli di suoi
colleghi, convinti come lui di essere degli dei. E leggerebbe storie di casi
psichiatrici, di miserie umane e professionali che vedono coinvolti magistrati
ai quali, ciò nonostante e a differenza di quanto accade in altre categorie,
viene permesso di rimanere in servizio come se nulla fosse. Niente, a Davigo la
libera stampa e le opinioni contrarie alle sue fanno schifo. La parola
«giornalacci» ricorda il fascismo in modo molto più pericoloso di quelle
(«ordine e disciplina») affisse nel suo stabilimento di Chioggia dal bagnino
nostalgico. Con la differenza che uno (il bagnino) è indagato, l'altro (Davigo)
è un possibile candidato premier dei grillini. Detto ciò, questo «giornalaccio»
avrebbe qualche domanda da fare a Davigo che riguarda il passaggio della stessa
intervista a Il Fatto in cui lui si lamenta di «nomine lottizzate, poco
trasparenti, senza criteri e incomprensibili di magistrati da parte del Csm».
Che ne sappia, nella pubblica amministrazione questo sospetto costituisce un
indizio di reato sufficiente ad aprire una inchiesta, come è capitato ad esempio
per le nomine fatte dal sindaco di Roma Virginia Raggi. E allora domanderei a
Davigo: come mai non è corso in procura a denunciare queste gravi «opacità»?
Perché da magistrato a conoscenza di una possibile notizia di reato non applica
«l'obbligatorietà dell'azione penale» invocata in altri campi? Perché l'azione
giudiziaria a tutela del rigore morale e procedurale (la famosa trasparenza)
esercitata nei confronti della classe politica e delle sue lobby i giudici non
la applicano su se stessi? Insomma, ci può spiegare, dottor Davigo, perché i
suoi colleghi possono fare nomine opache e noi tutti no, altrimenti ci
arrestate? Mi perdoni, ma i «giornalacci» servono anche a fare queste domande e
a pensare che se lei non passa dalle parole ai fatti in realtà è complice
(moralmente e penalmente) dello schifo che finge di denunciare.
Chi fa le leggi davvero? IL METODO WOODCOCK E LE STORTURE
DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. La politica si è
lasciata influenzare da una magistratura che vuole coniugare l’allarme-mafia con
l’allarme-corruzione, scrive Giovanni Fiandaca l'11 Luglio 2017 su "Il Foglio".
Recenti vicende, giudiziarie e parlamentari, convergono nel sollecitare qualche
considerazione sull’attuale modo d’atteggiarsi dei rapporti tra politica,
magistratura e sistema mediatico. A ben vedere, emergono in proposito sia
elementi di continuità, sia segnali di potenziale discontinuità invero già messi
in evidenza da Claudio Cerasa in un articolo del 5 luglio che prendeva spunto da
due casi senz’altro sintomatici, e che perciò vale la pena riprendere: da un
lato, le indagini della procura romana sul pubblico ministero napoletano
Woodcock nell’ambito della nota vicenda Consip; dall’altro, il dibattito
occasionato dall’approvazione in Senato della riforma del codice antimafia.
L'indagine romana sul pm Woodcock e due culture magistratuali in
conflitto "oggettivamente incompatibili". Cominciando dal primo caso, non è
superfluo ribadire la novità – anche simbolica – di una procura che,
nell’indagare sui metodi di un’altra procura, intende far luce anche sul
possibile ruolo attivo avuto dal pm inquirente rispetto alla diffusione di
notizie riservate alla stampa. Come spiegare questa inedita volontà di scovare i
responsabili di un fenomeno così diffuso e tollerato come la fuga di notizie?
Nei primi commenti, sono state avanzate anche ipotesi più o meno dietrologiche
alludenti a possibili fattori politici di condizionamento, o a dinamiche
conflittuali interne alle procure di Roma e Napoli. Ma non sono mancate ipotesi
esplicative più impegnative a livello addirittura sistemico, come ad esempio
quella – prospettata da Carlo Bonini su Repubblica dello scorso 28 giugno – che
fa leva sulla contrapposizione tra “due culture della giurisdizione agli
antipodi”, rispettivamente rappresentate da un modello-Pignatone rispettoso
della più rigorosa legalità processuale, e da un modello-Woodcock invece assai
disinvolto nella raccolta delle prove, nell’utilizzazione della polizia
giudiziaria e nello sfruttamento mediatico delle indagini: queste due culture
magistratuali in conflitto (argomenta sempre Bonini), mentre nel ventennio
dell’emergenza berlusconiana sarebbero state costrette a convivere per una sorta
di stato di necessità politico-istituzionale di fronte ai rischi di deriva
democratica e alla “manomissione sistematica delle regole del processo”,
nell’attuale situazione politica disordinata, priva di padroni e di bussola,
risulterebbero “oggettivamente e semplicemente incompatibili”. A prescindere dal
suo merito intrinseco, una spiegazione come questa presuppone l’idea che gli
orientamenti della prassi giudiziaria risentano sensibilmente, al di là dei
principi e delle regole di diritto, del quadro politico generale e delle
mutevoli valutazioni di necessità od opportunità che di volta in volta vi si
riconnettono. Questa convinzione – peraltro diffusa anche a prescindere dagli
schieramenti – sembra per un verso realistica, ma entra in contraddizione con
alcuni postulati che per altro verso stanno, o dovrebbero stare a cuore ai
moltissimi difensori (almeno a parole!) dello Stato democratico di diritto:
com’è intuibile, si tratta dei principi della divisione dei poteri e del vincolo
dei giudici alla sola legge, i quali dovrebbero garantire la tendenziale
autonomia della funzione giudiziaria dalla politica. Se così è, l’enfatizzare –
come fanno Bonini e i molti che opinano nello stesso senso – la tesi che la
legalità processuale costituisce una variabile dipendente dal carattere
emergenziale o meno della situazione politica contingente, finisce di fatto con
l’avallare quella subordinazione della giustizia alle esigenze della politica
che in linea teorica si dovrebbe invece scongiurare.
Stiamo assistendo davvero a una reazione alla giustizia mediatica, alla cultura
del sospetto e al protagonismo dei magistrati-star? Proponendo nell’articolo che
abbiamo richiamato all’inizio una chiave di lettura nella sostanza analoga ma
meno complicata, e – direi – di segno senz’altro ottimistico, Claudio Cerasa dal
canto suo ravvisa nell’indagine romana sul pm Woodcock l’attesa reazione –
finalmente dall’interno stesso della magistratura – alla giustizia mediatica,
alla cultura del sospetto e al protagonismo dei magistrati-star. Il che, a suo
giudizio, farebbe il paio con le reazioni critiche di significato equivalente
manifestate (oltre che da alcuni giuristi accademici) da una parte qualificata
della magistratura contro l’estensione legislativa della confisca preventiva
antimafia ai reati di corruzione: estensione caldeggiata invece, e non a caso,
da altra parte della magistratura specie antimafia e, con particolare enfasi, da
quella celebre schiera di magistrati di orientamento giustizialista-populista
ostinata nel reclamare una indifferenziata assimilazione normativa tra mafia e
corruzione, nel presupposto drammatizzante – ma in realtà finora indimostrato –
che i due fenomeni ormai ampiamente convergano. In effetti, anche a mio avviso
la modifica del codice antimafia assume rilievo non soltanto per diagnosticare
gli atteggiamenti e orientamenti in atto rinvenibili all’interno della
magistratura, ma anche per comprendere attraverso quali modalità e percorsi le
forze politiche di maggioranza oggi concepiscono le riforme penali da portare
avanti.
La politica vuole dare ai cittadini un segnale politico di rafforzamento della
lotta al presunto mix mafia-corruzione. Premesso che la politica è sempre meno
in grado di fare da sola nel progettare riforme, e ciò vale anche per il settore
penale, la domanda è questa: da quale fonte essa ha originariamente attinto il
suggerimento di rendere applicabile la confisca allargata antimafia al soggetto
indiziato anche di un solo reato contro la pubblica amministrazione? In realtà,
è stata la Commissione parlamentare antimafia ad avere per prima – se ben
ricordiamo – questa idea, recependola proprio da quella nota parte della
magistratura antimafia che suole privilegiare, più che l’osservanza dei principi
giuridici di fondo e l’equilibrio tra efficacia repressiva e garanzie, una
logica sostanzialistica di risultato nella lotta a tutto campo alla criminalità.
Che poi le proposte di legge ispirate a questo punitivismo grezzo e onnivoro,
comunque potenzialmente redditizio oggi in termini di consenso elettorale,
risultino confuse e approssimative, o per di più in contrasto con i princìpi
costituzionali e con i princìpi di garanzia elaborati dalla Corte europea di
Strasburgo, pazienza! Secondo i politici che ne sono fautori, e i magistrati
favorevoli all’estremismo repressivo, la nuova norma sulla confisca antimafia ai
corrotti necessiterebbe infatti di essere definitivamente approvata in ogni
caso, anche se difettosa e a rischio di incostituzionalità: proprio per dare ai
cittadini un segnale politico di rafforzamento della lotta al presunto mix
mafia-corruzione e per dotare quei magistrati che ne hanno fatto appositamente
richiesta di un un’arma in più nella loro attività di contrasto. E, di fronte
all’obiezione che potrebbe trattarsi di un’arma spuntata appunto perché mal
costruita e di dubbia legittimità, non sono mancate da parte di politici
pro-riforma, come lo stesso guardasigilli Orlando, o ad esempio di un magistrato
antimafia (oggi consigliere Csm) come Antonio Ardituro reazioni volte a
minimizzare il problema, in base a questa comune e ottimistica convinzione (cfr.
le rispettive interviste a Repubblica del 7 e dell’8 luglio): che cioè spetta in
ogni caso alla Cassazione, ed eventualmente alla Corte costituzionale, fornire a
posteriori l’interpretazione più precisa e corretta delle novità normative
approvate dal Parlamento, specie quando queste risultano formulate in maniera
generica o approssimativa, e appaiono perciò – aggiungiamo noi – simili a
prodotti semilavorati o a semplici linee-guida che spetta inevitabilmente ai
giudici specificare. Ma ci si accorge che, delegando di fatto sempre più alla
Cassazione il compito di dare un volto e un significato definiti e
giuridicamente legittimi a quelle nuove norme che la parte oltranzista della
magistratura d’accusa richiede, e che il ceto politico dal canto suo non riesce
a formulare in maniera puntuale e ineccepibile, si assiste alla morte del
modello di ordinamento consacrato nella nostra Carta costituzionale perché – in
definitiva – è il potere giudiziario che finisce, così, con l’esercitare nella
sostanza la vera funzione legiferante?
Se il potere giudiziario finisce con l'esercitare la vera funzione legiferante
si assiste alla morte del nostro modello costituzionale. Ma il caso
dell’estensione della confisca antimafia assume un rilievo emblematico
nell’evidenziare le distorsioni (anche costituzionali) dell’attuale politica
penale per una ragione ulteriore, già accennata: i politici favorevoli a questa
riforma hanno cioè deciso di far propria una richiesta proveniente dalla
corrente estremista dei magistrati antimafia, ma non condivisa da altri
esponenti del mondo della magistratura non meno autorevoli ed esperti in materia
di crimine organizzato e di contrasto della corruzione. Se così è, la politica –
priva, ribadiamo, di conoscenze e competenze proprie per prendere partito con
autonoma capacità critica – si è lasciata influenzare non da una magistratura
unanime, ma da quella parte di essa più propensa a coniugare l’allarme-mafia con
l’allarme-corruzione, senza che peraltro a tutt’oggi si disponga di rigorosi
riscontri empirici circa il livello di reale fondatezza di questo allarme
congiunto: così stando le cose, le forze di maggioranza hanno dunque finito con
l’accordare una sorta di preferenza fideistica al pregiudiziale estremismo
drammatizzante di alcuni magistrati-star, ignorando o sottovalutando l’esistenza
di non poche e autorevoli voci critiche all’interno di quei settori della
magistratura che hanno, forse, avuto il torto – in verosimile omaggio a esigenze
di riserbo e di rispetto della autonomia del Parlamento – di non opporsi sin
dall’inizio in forma pubblica agli orientamenti dei colleghi di opinione
opposta. Proprio in considerazione della corriva disponibilità delle attuali
forze politiche di governo a recepire in particolare le indicazioni e le
richieste provenienti dai settori più estremisti e mediaticamente esposti del
mondo giudiziario, sarebbe necessario che d’ora in avanti al dibattito pubblico
in materia di giustizia penale la magistratura partecipasse attivamente dando
voce a tutte le posizioni presenti al suo interno. E sarebbe altresì
indispensabile, in vista di un miglioramento qualitativo della politica penale,
che il ceto politico nel suo insieme acquisisse almeno i fondamenti basilari di
una cultura penalistica all’altezza delle sfide del tempo presente e, prima di
deliberare, si confrontasse criticamente con gli esperti di ogni tendenza e
provenienza.
L'ILLUSIONE DI CHI PENSA CHE SI POSSA OTTENERE GARANTISMO SENZA TOCCARE I PM.
Tra Woody Allen e l'avvocato romano dei nazisti, scrive Guido Vitiello l'8
Luglio 2017 su "Il Foglio". "Sarò giustiziato domattina alle sei. Dovevo
andarmene alle cinque, ma ho un avvocato in gamba: ho ottenuto clemenza”. Così
Woody Allen nelle prime battute di “Amore e guerra”, film su un giovane russo
condannato alla fucilazione dai francesi per aver tentato di assassinare
Napoleone. E in effetti, se hai cospirato contro l’imperatore e ti sei
intrufolato a corte con una pistola, per giunta travestito da diplomatico
spagnolo, un avvocato che ti guadagna un’ora di vita in più è uno che sa fare il
suo mestiere. Conoscete parabola più comica e più disperata, e dunque più
inscalfibilmente vera, per illuminare la misera cosa a cui può ridursi il
diritto di difesa quando tutte le armi sono in pugno all’accusa? Io forse ne
conosco una. Me l’ha raccontata anni fa Mauro Mellini, avvocato ed ex
parlamentare radicale, rammaricandosi che nessuno ne avesse fatto un film, tra i
tanti ambientati nella Roma occupata. E’ la storia di un ometto strambo,
impazzito e ridotto in miseria dopo che il patrimonio della moglie, una ricca
ereditiera tedesca, era stato confiscato dal governo del kaiser durante la
Grande guerra. Mellini lo conobbe negli anni Cinquanta: “Era un avvocato, ma si
era ridotto a vivere come un barbone, dormendo nei vagoni letto alla stazione
Termini. Durante l’occupazione nazista, conoscendo benissimo il tedesco, si
presentò a fare il difensore davanti al Tribunale di guerra installato all’Hotel
Flora in via Veneto. Qualcuno raccontava che avesse fatto delle dotte arringhe
per chiedere che i suoi (si fa per dire) difesi fossero fucilati nel petto
anziché nella schiena. Tanto i ‘clienti’ il tedesco non lo capivano”. Ecco, mi
disse Mellini, questa è la storia da tenere a mente tutte le volte che si sente
invocare, in condizioni come le nostre, più garantismo: “Voler porre la
questione del garantismo davanti a tribunali obbedienti alla logica del partito
dei magistrati equivale, più o meno, a prodigarsi in arringhe come quelle
compitamente pronunziate dal poveretto”. Beccarsi una pallottola nel petto: se
non proprio a questo, a poco più si riducono le aspirazioni di qualche
benintenzionato. Di disarmare il plotone non se ne parla neppure più, anzi negli
ultimi mesi si sta facendo di tutto per rifornire il suo arsenale. Finita la
chiassosa e inconcludente stagione berlusconiana, riprende piede tra i migliori
– ed è tutto dire: perché i peggiori neppure ci pensano – una pericolosa
illusione: l’idea che si possa ottenere qualcosa di “garantista” senza toccare i
poteri abnormi dei pubblici ministeri. Mi ricordano quelle madri
compassionevoli, mogli di uomini irascibili, che vanno in segreto nella stanza
del figlio punito ingiustamente o con troppo rigore, e lì lo consolano e
all’occorrenza lo medicano; ma che mai si sognerebbero di far la voce grossa
contro il marito. A ripensarci, l’esponente più nobile di questa illusione è
stato proprio Stefano Rodotà; che negli anni Ottanta si prodigò per la causa del
detenuto Giuliano Naria, ma capeggiò anche il fronte del no al referendum
Tortora, convinto che fosse una manovra di gruppi politici corrotti per
attentare all’autonomia della magistratura; e che coerentemente, qualche lustro
più tardi, da un lato tutelava la privacy dei cittadini e dall’altro le mani
libere degli intercettatori, arringando il popolo viola e altre cattive
compagnie contro la “legge bavaglio”. Illusione, beninteso, e non doppiezza.
L’illusione di poter negoziare qualcosa di meglio di una pallottola in petto.
Ricordatevi del povero Fornaretto, ma anche dell’ometto strambo di Mellini.
Adesso basta con la politica succube dei pm,
scrive Matteo Renzi, Domenica 09/07/2017, su "Il Giornale". Ultimo punto,
negativo: le vicende giudiziarie, gli scandali, i processi, le polemiche. Non
giriamoci attorno. Veniamo da venticinque anni di subalternità culturale della
politica rispetto alla magistratura. E la colpa è dei politici, non dei giudici.
Da Mani pulite in poi appunto un quarto di secolo fa la politica si è come
ripiegata. Impaurita. Si è affermata la presunzione di colpevolezza, anziché
d'innocenza. Si è accettata l'equazione folle per la quale un avviso di garanzia
comporta le dimissioni del politico. Il che è incostituzionale, illogico,
immorale. Vi sono due approcci completamente sbagliati a questo tema. Da un lato
quello del centrodestra al governo per dieci anni, che, partendo dalle critiche
generali al sistema della magistratura, arrivava a fare norme spesso incentrate
sui propri interessi piuttosto che sulle reali necessità del mondo giudiziario
leggi ad personam, che producevano nell'opinione pubblica e nel dibattito
politico l'effetto opposto; dall'altro lato quello antiberlusconiano, che
brandiva l'arma giudiziaria come strumento per mandare a casa l'allora premier,
in nome di un principio comprensibile dal punto di vista etico ma
controproducente dal punto di vista politico. Io ho sempre detto che volevo
vedere Berlusconi fuori dalla politica non a causa delle sue vicende
giudiziarie, ma perché sconfitto alle elezioni. Mi piace l'idea di mandare a
casa gli avversari, non di mandarli in carcere. Quando però qualcuno dei nostri
ha ricevuto richieste di interrogatori o avvisi di garanzia, nessuno ha evocato
il legittimo impedimento o richiesto norme ad hoc: noi abbiamo detto, sempre,
che stavamo dalla parte dei giudici. Ecco perché nel delicato rapporto
giustizia-politica abbiamo compiuto una inversione a U, arrivando a rovesciare
il paradigma. Tra le svolte che rivendico al mio governo c'è quella di andare in
aula e dire ad alta voce e con forza: per noi un sottosegretario che riceve un
avviso di garanzia non deve dimettersi automaticamente. Se ha motivi di
opportunità politiche, che sia o meno indagato, allora fa bene a dimettersi. Ma
non può essere scontato che lo faccia. Contemporaneamente, abbiamo fatto di
tutto per accelerare i processi, assunto finalmente nuovo personale nei
tribunali, implementato la digitalizzazione. Non ci siamo chiusi a riccio contro
la giustizia, ma abbiamo rispettato la separazione dei ruoli collaborando
attivamente in modo che i tempi dei processi si abbreviassero. Anche perché la
grande maggioranza dei magistrati italiani è composta da professionisti
impeccabili, formati in modo molto serio e dotati di competenze e preparazione.
Poi ci sono le eccezioni, è ovvio: poche persone obnubilate dal rancore
personale che collezionano indagini flop e che provano a salvare la propria
immagine attraverso un uso spasmodico della comunicazione e del rapporto
privilegiato con alcuni giornalisti. È vero che il sistema di autogoverno che si
sviluppa intorno al Csm potrebbe funzionare meglio: c'è qualcosa che non torna
in Italia se le correnti, che sono state esautorate nella vita dei partiti,
rimangono decisive per la carriera dei magistrati. Ma è anche vero che ci sono
alcune professionalità straordinarie nel mondo togato che ci hanno consentito di
ottenere come sistema-paese successi anche a livello internazionale. Tuttavia
c'è un vezzo culturale che per me è vizio sostanziale nell'atteggiamento di
alcuni magistrati. Me ne rendo conto in Sala verde di Palazzo Chigi quando
incontro l'Associazione nazionale magistrati guidata dal suo presidente,
Piercamillo Davigo. E dopo i giudici pretendo di incontrare allo stesso modo
anche gli avvocati, perché la giustizia non la esercitano soltanto i magistrati
ma tutti i professionisti del diritto. L'incontro con Davigo e la sua
delegazione parte con molta freddezza ma si mantiene civile e cortese nei toni;
però la sostanza concettuale che Davigo ribadisce ma che in realtà ha più volte
già espresso in tutti i luoghi, in tutti i libri, in tutte le interviste è che
«un cittadino assolto non è detto che sia innocente, ma solo un imputato di cui
non si è dimostrata la colpevolezza». Questo principio per me è un monstrum
giuridico, un'assurdità costituzionale e filosofica. E mi spiace che il capo di
tutti i giudici la pensi così. Ci sono secoli di civiltà giuridica che cozzano
contro la convinzione di Davigo e contro una cultura che seppellisce l'approccio
del Beccaria e i principi costituzionali ispirati a un rigoroso garantismo. Io
non ho mai ricevuto nemmeno un avviso di garanzia in tredici anni di politica.
Non parlo dunque per un fatto personale, ma per convinzione: non accetterò mai
l'assunto per cui non esistono cittadini innocenti, ma solo colpevoli non ancora
scoperti. Perché questa è barbarie, non giustizia. «La cultura del sospetto non
è l'anticamera della verità: la cultura del sospetto è l'anticamera del
khomeinismo», diceva Giovanni Falcone. Per me sono parole che andrebbero
scolpite in ogni tribunale accanto all'espressione «La legge è uguale per
tutti». Il 5 dicembre, giorno successivo alla sconfitta referendaria, un volto
noto nei dibattiti televisivi della politica quale Guido Crosetto, già
sottosegretario alla Difesa e parlamentare del centrodestra, pubblica un tweet
molto polemico: «Se conosco bene questo paese, nel giro di qualche settimana
partirà l'attacco delle procure ai renziani doc. È uno schema classico e
collaudato». Dopo tre mesi e dopo l'avviso di garanzia al ministro Lotti per
presunta rivelazione di segreto d'ufficio e l'avviso di garanzia a mio padre per
«concorso esterno in traffico di influenze», mi chiama Crosetto e mi fa notare
la sua singolare profezia. Io però non credo ai complotti. Lo dico in tutte le
sedi, in tutte le salse. Se c'è un'indagine non si grida allo scandalo, si
chiede di andare a processo. Ci siamo già passati, a vari livelli. Mio padre
riceve un avviso di garanzia il primo della sua vita alla tenera età di
sessantatré anni, sei mesi dopo che io sono diventato primo ministro. Tutti i
giornali nazionali mettono la notizia in prima pagina, alcuni internazionali
hanno quantomeno un trafiletto, e almeno tre leader stranieri mi chiedono se
sono preoccupato. Vado in tv e dico chiaramente che io voglio bene a mio padre,
che sono sicuro che sia pulito, ma che nella mia veste di uomo delle istituzioni
sono dalla parte dei giudici: per due volte il rappresentante dell'accusa
chiederà l'archiviazione, che dopo due anni finalmente è arrivata. Nulla, non
aveva fatto niente. Quindici giorni prima di un referendum sulle trivellazioni
petrolifere scoppia un (presunto) scandalo in Basilicata con apertura di un
fascicolo impegnativo e la richiesta di interrogare ben quattro membri su sedici
del Consiglio dei ministri, uno dei quali il sottosegretario De Vincenti viene
convocato come persona informata sui fatti, neanche a farlo apposta, nello
stesso momento in cui deve svolgersi il Consiglio dei ministri. Forse che il
sottosegretario che per legge è chiamato a verbalizzare le riunioni di Consiglio
invocherà il legittimo impedimento? Non sia mai. Noi vogliamo consentire il
corso dei processi, non accampiamo alcuna scusa per ostacolare le indagini: il
professor De Vincenti viene invitato a lasciare il Consiglio dei ministri e a
farsi interrogare immediatamente. Fatto sta che per una settimana questa notizia
apre tutti i giornali e i notiziari ma poi un mese dopo, passato il referendum
tutto finisce nel dimenticatoio e si scopre che l'inchiesta sul governo che
aveva «le mani sporche di petrolio e denaro» non porta a nessuna sentenza
passata in giudicato.
«È dal ’92 che in Italia comandano i magistrati».
Intervista di Errico Novi del 30 Marzo 2017 su "Il Dubbio". Intervista al
filosofo ed ex europarlamentare del Pci: «Siamo una repubblica giudiziaria, se
ne esce solo con le riforme e la separazione delle carriere». «Eccome si
potrebbe mai negare che oggi l’Italia è una Repubblica giudiziaria? Che in
Italia i magistrati hanno il potere? E che per ribaltare la situazione ci
vorrebbe una classe politica autorevole, capace, tra l’altro, di non
compromettersi con storie di ordinaria corruzione, che una classe politica così
non si vede e che siamo quindi in un vicolo cieco?». Il tono di Biagio de
Giovanni sa essere lucidamente analitico ma anche, se necessario,
inevitabilmente esasperato. Il filosofo ed ex europarlamentare del Pci vede con
chiarezza la gravità della situazione e condivide in gran parte il discorso
fatto due giorni fa da Luciano Violante, che in una lectio magistralis alla
Scuola superiore Sant’Anna di Pisa ha detto «stiamo entrando in una società
giudiziaria». L’ex presidente della Camera individua un punto di deragliamento:
la legge elettorale del 2005, il porcellum, che ha sterilizzato i rapporti tra
eletti ed elettori, con i primi «chiusi nella cerchia del capo anziché aperti
alla relazione con i cittadini». Da qui a un sistema in cui «il codice penale è
la nuova Magna Charta dell’etica pubblica» il passo è stato brevissimo.
È così, professor de Giovanni? È il sistema di voto con le liste
bloccate ad aver aperto la strada alla società giudiziaria?
«Io farei partire le cose da un momento
decisamente anteriore: le inchieste giudiziarie dei primi anni Novanta. In quel
passaggio si è assistito a un fatto che non ha riscontri nelle altre democrazie
occidentali: l’annientamento di un intero sistema politico. È lì che i rapporti
tra politica e magistratura si spostano e da quel momento la situazione non è
stata più ribaltata. Il nostro sistema è stato distrutto da Mani pulite e non è
più rinato».
Da Tangentopoli ad oggi non c’è soluzione di continuità?
«Non c’è nel senso che l’equilibrio,
appunto, non è stato più ripristinato. Poi non c’è dubbio che alle vicende dei
primi anni Novanta si aggiungano altri elementi. Ed è verissimo che tutto quanto
può accentuare il distacco tra eletto ed elettore favorisce il diffondersi di
una critica radicale alla politica e il dilagare dell’antipolitica. C’è un
attacco violento che di fatto punta alla fine della democrazia rappresentativa».
In questo c’è una deriva autoritaria?
«Intanto penso si possa dire che qui
non si tratta di aggiustare un sistema elettorale: la propaganda antipolitica
spinge per l’abbandono della democrazia rappresentativa in favore della
cosiddetta democrazia diretta, che si realizzerebbe attraverso la rete».
Com’è possibile che vinca un’opzione del genere?
«Non possiamo sottovalutare un altro
fattore che genera sfiducia nella rappresentanza politica classica: lo
spostamento delle decisioni. Se la società non coincide più con lo Stato
nazionale ma oltrepassa i confini, acquisisce una dimensione indeterminata se
non globale, e se gran parte delle decisioni sono prese al di là dei confini
nazionali, è chiaro che le società si sentono meno rappresentate politicamente.
Cosa può decidere, ormai, un Parlamento nazionale? Al massimo può enfatizzare un
aspetto del governo anziché un altro, ma le scelte di fondo vengono prese
altrove. E questo ovviamente crea un terreno favorevolissimo per chi sostiene
che la democrazia rappresentativa non serva più a nulla, non sia in grado di
rappresentare gli elettori e che perciò bisogna aprire alla democrazia diretta».
La purezza opposta dai cinquestelle al resto della politica
immondo e corrotto costituisce una forma di fascismo?
«I fenomeni non tornano mai uguali e io
non allargherei troppo la consistenza storica di categorie come il fascismo.
Certo, la critica violenta alla democrazia rappresentativa finisce per
rivolgersi in concreto al Parlamento, e questa modalità è stata caratteristica
di determinati movimenti di destra del Novecento. Intendiamoci: nessuno pensa
che in Italia stia per arrivare il fascismo, e poi c’è la cornice dell’Europa
che costituisce comunque una garanzia».
Siamo al sicuro, allora.
«Ma siamo anche in una situazione in
cui la critica al Parlamento e al parlamentarismo ci mette un attimo a generare
una dinamica pubblica confusa in cui emotività e parole d’ordine prevalgono
sulla competenza, sulle soluzioni equilibrate. E non è che tra questo e le
emozioni di massa di cui parlava Gustave Le Bon più di un secolo fa ci sia tanta
differenza».
Il grado di preparazione medio dei parlamentari non fa certo da
argine a questa deriva.
«E qui ci risiamo con la distruzione
del sistema avvenuta a inizio anni Novanta e a cui non si è ancora posto rimedio».
In questa situazione c’è anche un cedimento rassegnato
all’invadenza della magistratura? Il Pd per esempio paga un eccesso di vicinanza
ai giudici praticato dai suoi “precursori”?
«Non c’è alcun dubbio che tutte le
forze politiche siano in ginocchio davanti alla magistratura, chi sostenendola e
chi subendola. Sarebbe urgente una vera riforma di sistema: separare le
carriere, fermare l’osceno viavai tra la toga e i partiti, superare
l’obbligatorietà dell’azione penale. Se non si fa questo non se ne esce: ora la
magistratura ha il potere in Italia. L’Italia è una Repubblica giudiziaria. Mi
sembra di non essere solo, in quest’analisi: perfino l’equilibratissimo Sabino
Cassese, nel suo ultimo lavoro, scrive che lo squilibrio tra politica e
magistratura è diventato un fatto patologico. Ma poiché ci vorrebbe una classe
politica autorevole per ribaltare tutto questo, si ha la netta impressione di
essere in un vicolo cieco».
Da Roma a
New York, i 222 magistrati prestati ai «palazzi» del governo.
Un universo di
toghe distaccate alla diretta dipendenza dei ministri, nella presidenza del
Consiglio, nell’ambasciata di Washington, all’Onu o al Quirinale. Brunetta
chiede l’elenco dei giudici «fuori ruolo», scrive Dino Martirano il 20 marzo
2017 su “Il Corriere della Sera”. Sotto la punta dell’iceberg — i pochi
magistrati eletti in Parlamento oppure chiamati al governo — c’è un universo di
toghe fuori ruolo. Si tratta di magistrati distaccati nei palazzi del governo
«alla diretta dipendenza» dei ministri, nella presidenza del Consiglio,
nell’ambasciata di Washington, all’Onu a New York, in Marocco e in Albania per
il «collegamento» con la giustizia locale, al Quirinale, alla Corte
costituzionale, nelle commissioni parlamentari, alle Corti di Strasburgo, nelle
Autorità di controllo, nelle strutture della Ue, di Eulex, di Eurojust, di
Europol e dell’Olaf. Comunque, il gruppone dei magistrati che hanno abbandonato
temporaneamente il ruolo presta servizio al ministero della Giustizia e al Csm,
come impone la legge. Si restringe, invece, la pattuglia degli eletti con la
toga negli enti locali: Michele Emiliano (ex pm), governatore della Puglia, una
magistrata assessore in Sicilia e poco altro. Nel giorno in cui la Camera avvia,
con la relazione di Walter Verini (Pd), la discussione sulla legge Palma
approvata tre anni fa dal Senato — il testo varato per stringere i bulloni delle
«porte girevoli» che mettono in comunicazione i ruoli della magistratura e il
mandato politico o fiduciario del governo — il capogruppo di Forza Italia,
Renato Brunetta, ha chiesto al Csm l’elenco dei magistrati fuori ruolo. I numeri
e i nomi che saranno forniti a Brunetta dal vicepresidente del Csm, Giovanni
Legnini, vengono aggiornati nello «schedario elettronico» curato dal Consiglio:
nell’elenco appaiono i nomi di ben 818 toghe che dalla fine degli anni 80 (la
ministra Anna Finocchiaro, del Pd, è in aspettativa dall’88) hanno smesso
temporaneamente di fare il giudice o il pm. Al netto dei rientri, ora sarebbero
222 i magistrati fuori ruolo: 196 distribuiti tra i ministeri, il Parlamento, il
Csm (16), la Scuola della magistratura, le istituzioni internazionali, il
Quirinale (3), la Corte costituzionale (23). Altri 16 sono i togati del Csm
eletti dalla magistratura ordinaria; 6 sono gli eletti in Parlamento (c’è anche
la parlamentare europea Caterina Chinnici del Pd), 2 sottosegretari del governo
Gentiloni (Cosimo Ferri e Domenico Manzione), il governatore Michele Emiliano e
una magistrata in aspettativa perché ha raggiunto il marito all’estero.
Nell’elenco del Csm (prima della periodica revisione avvenuta ieri sera)
emergevano alcune posizioni datate: quella dell’ex deputato di Forza Italia
Alfonso Papa, arrestato e condannato in primo grado a Napoli, che risulta «in
aspettativa per mandato parlamentare». Non è aggiornata anche la posizione di
Stefano Dambruoso, oggi questore della Camera eletto in Scelta civica nel 2013,
che è in «aspettativa per elezioni politiche». Aggiornata, invece, la casella di
Giovanni Melillo, capo di gabinetto del Guardasigilli Andrea Orlando, che dal 15
marzo 2017 è alla Procura generale presso la Corte d’Appello di Roma. A questo
universo sommerso, conferma il relatore della legge Walter Verini (Pd), vanno
applicate le regole già vigenti per i togati del Csm: cioè, un anno di
«congelamento» a fine mandato prima di poter ottenere una promozione con un
incarico direttivo o semi direttivo. Il problema sono i magistrati chiamati
direttamente dal governo a svolgere il ruolo di capo di gabinetto, capo
dell’ufficio legislativo, consulente o esperto giuridico in una ambasciata; ma
anche le toghe elette in Parlamento sono sottoposte a un periodo di decantazione
alla fine del mandato: pure i 5 anni di «purgatorio» necessari per poter
ottenere una promozione (deliberati dal Senato) ora sono ridotti a 3 nel testo
giunto in aula alla Camera. Per il quale, il sottosegretario alla Giustizia
Gennaro Migliore (Pd), prevede tempi rapidi di approvazione alla Camera. Anche
se poi il ddl dovrà tonare al Senato.
Edward Luttwak il 18 marzo 2017 su “Libero Quotidiano”: "Perché i giudici
sono la malattia dell'Italia". Babbo Renzi, Luca Lotti e Consip. L'inchiesta
di cui si è discusso nell'ultimo mese, il caso che in un qualche modo fa tremare
il governo e mina il futuro di Matteo Renzi, l'ex premier che pare essere
l'obiettivo di questa "caccia grossa" dei magistrati. E un parere, duro,
sull'intera vicenda piove da Edward Luttwak, il politologo americano
intervistato da Il Foglio, il quale spiega senza troppi giri di parole che "il
rapporto tra giustizia e politica è un antico grattacapo nel vostro paese. Agli
inizi degli anni Novanta Mani pulite usò metodi bruschi, ai limiti della legge,
per combattere la corruzione dilagante nella classe politica - ricorda -. Questa
esperienza, per certi versi traumatica, ha generato uno squilibrio tra
i poteri con un esecutivo debole e una magistratura strapotente. La politica si
è spogliata di prerogative e immunità, la magistratura ha esteso il proprio
raggio d’azione. Il risultato è una democrazia malata". Dopo la lunga
introduzione con gli occhi rivolti al passato, Luttwak passa al presente.
All'ultimo "blitz" delle toghe. "Il filone politico del Consip-gate mi sembra
fragile. Quale sarebbe la smoking gun? C’è un manager che accusa e un ministro
che respinge le accuse. Si tira in ballo il padre dell’ex premier, un escamotage
impiegato in diverse democrature latinoamericane: quando si vuole delegittimare
un politico - ricorda Luttwak - si coinvolge pretestuosamente un familiare. Il
traffico di influenze è una fattispecie fumosa, non tipizzata e priva di
specificità, che accresce a dismisura la discrezionalità del magistrato". Anche
Luttwak, dunque, critica il reato contestato a Tiziano Renzi, i cui confini
appaiono assai lacunosi. Ma l'attacco di Luttwak ai giudici non è ancora finito.
"Le porte girevoli - rimarca il politologo - sono un fattore inquinante che lede
l’indipendenza della magistratura. Non c’è da stupirsi per il Consip-gate:
l’idea di una strumentalità politica connessa all'esercizio dell’azione
giudiziaria è accettata nell'opinione comune. Ho operato in decine di paesi ma
solo in Italia il mio nome è finito sui giornali per intercettazioni telefoniche
nell'ambito di un’inchiesta in cui non ero neppure indagato". E ancora, l'accusa
ai media: "La verità è che esiste un vasto clima d’impunità testimoniato dalla
disinvoltura con cui certi giornali violano quotidianamente il segreto
istruttorio. Nel paese dove l’azione penale è obbligatoria nessun magistrato
apre un fascicolo", conclude.
Emiliano: non mi dimetto da magistrato neanche morto,
scrive Il Quotidiano di Puglia (Brindisi) il 14 marzo 2017. Etichetta come
«nulla lucente» la kermesse renziana del Lingotto di Torino, getta l’ombra delle
«intimidazioni politiche» sul gioco di incastri, alleanze e posizionamenti
congressuali nel Pd e rintuzza a muso duro le “invasioni di campo” sul suo
futuro: «La magistratura? Io non mi dimetto neanche morto, non c’è ragione per
consegnarmi al ricatto di chi mi vuole trasformare in un professionista della
politica», dice Michele Emiliano. Questione spinosa e latente da 13 anni, da
quando cioè il candidato alla segreteria nazionale del Pd ha temporaneamente
dismesso la toga di pm per tuffarsi sulla scena politica. Questione, ora,
ritornata prepotentemente alla ribalta, anche perché davanti al Csm giace un
procedimento disciplinare circa la presunta incompatibilità tra carriera
politica e status in magistratura (dal 2004 Emiliano è in aspettativa, senza
percepire stipendio). «Non c’è nessuna ragione per cui uno debba dimettersi dal
suo lavoro per candidarsi, è pazzesco che un magistrato sia incompatibile con la
politica, questa è la teoria di Davigo (il presidente dell’Anm, che è
terrorizzato e considera la politica una suburra in cui c’è il rischio di
contaminarsi». Al momento refrattario per scelta e strategia a convention
oceaniche, il governatore pugliese sta sciorinando il suo piano congressuale in
altro modo: presidio dei media nazionali e assemblee sui territori.
Da Scalfaro a De Magistris: tanti i magistrati entrati in
politica. De Magistris, che si candiderà per le
prossime elezioni europee con l'Italia dei Valori, è l'ultimo dei molti
ex-magistrati folgorati sulla via parlamentare. Alcuni di loro hanno anche
ricoperto incarichi politici tra i più alti dello Stato. Ecco l'elenco dei più
noti, scrive "Panorama". "Una scelta di vita, non tornerò indietro", dice l'ex
pm di Catanzaro Luigi De Magistris spiegando perché si candiderà per le prossime
elezioni europee con l'Italia dei Valori. E mentre il vicepresidente del Csm,
Nicola Mancino, commenta: "I magistrati che scelgono la politica non dovrebbero
più tornare in magistratura", è lungo l'elenco degli ex-magistrati che hanno
scelto di fare il salto e in politica: sia a sinistra (molti) sia a destra
(alcuni). Ricoprendo anche incarichi politici tra i più alti dello Stato. Tra i
più famosi Oscar Luigi Scalfaro, magistrato solo dal 1942 al 1946, che iniziò la
sua carriera politica nel 1946 come membro dell'Assemblea Costituente, per poi
essere eletto in Parlamento dal 1948 al 1992, anno in cui è prima presidente
della Camera, per due mesi, e poi presidente della Repubblica. Altri nomi
eccellenti: Luciano Violante , magistrato fino al 1979 quando diventa deputato
per il Pci e poi presidente della Camera; Franco Frattini , ex magistrato
amministrativo diventato vicesegretario alla presidenza del Consiglio nel 1993 e
poi ministro degli Esteri e commissario Ue; Antonio Di Pietro , ex pm di "Mani
pulite", che lasciò la toga nel 1994 in diretta tv per diventare poi ministro
dei Lavori pubblici nel Governo Prodi, senatore dell'Ulivo e infine fondatore
dell'Italia dei valori; Gerardo D'Ambrosio eletto per Ds quando era già in
pensione, dopo una prestigiosa carriera giudiziaria che lo ha visto protagonista
delle inchieste sulla strage di piazza Fontana, sul Banco Ambrosiano, fino al
pool 'mani pulite e all'incarico di procuratore capo di Milano. Ma i nomi da
citare sono tantissimi, dall'andreottiano Claudio Vitalone recentemente
scomparso a Enrico Ferri, il ministro dei lavori pubblici famoso per il limite
dei 110 all'ora e segretario Psdi; dal pretore d'assalto Gianfranco
Amendola (eletto per i Verdi) a Ferdinando Imposimato (eletto in varie liste di
sinistra); da Tiziana Parenti , passata dal pool di "Mani pulite" a Forza Italia
e diventata presidente della commissione Antimafia, a Felice Casson , che dalle
indagini su Gladio è passato alla candidatura a sindaco di Venezia e poi
all'elezione in Parlamento nelle liste dei Ds prima e del Pd poi, ad Adriano
Sansa, eletto sindaco di Genova e poi rientrato in magistratura. L'elenco
completo sarebbe troppo lungo, ma non si può fare a meno di nominare Francesco
Nitto Palma, eletto in Forza Italia e sottosegretario all'Interno; Anna
Finocchiaro, capogruppo del Pd in Senato; Giuseppe Ayala, eletto senatore Ds e
poi tornato in magistratura come consigliere alla Corte d'appello di
L'Aquila; Alfredo Mantovano, parlamentare di An e sottosegretario all'Interno.
Anche i giudici contestano: «Basta giudici in politica»,
scrive Errico Novi il 19 Marzo 2017 su "Il Dubbio". Dopo il caso Minzolini, che
fu condannato da un ex parlamentare, torna in primo piano il dibattito sui pm in
politica. Slegare il caso Minzolini da quello dei magistrati in politica?
Impossibile. Anzi il voto che ha impedito la decadenza del senatore costringe lo
stesso Pd a scongelare la legge sulla candidabilità delle toghe, ibernata da 3
anni a Montecitorio. E soprattutto è la stessa magistratura a scuotersi per
vicende come quelle di Giannicola Sinisi, il giudice ed ex deputato che ha
condannato l’avversario Minzolini, o di Michele Emiliano, che da pm in
aspettativa vuol fare il segretario di partito. L’ultima, pesante presa di
posizione è quella di Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia: «Non ho
nulla contro i magistrati che scelgono la politica ma non dovrebbero più tornare
all’attività giurisdizionale, una volta cessati dal mandato», dice. Una
richiesta pesante che va ben oltre il ddl atteso per lunedì nell’aula di
Montecitorio. Lì si prevede che un magistrato non possa candidarsi nel distretto
in cui ha esercitato le funzioni negli ultimi 5 anni. Una volta finito il
mandato di parlamentare – o di premier, ministro, assessore o consigliere nelle
amministrazioni locali – il giudice è ricollocato in Cassazione, se ne ha i
requisiti, altrimenti in distretto diver- so da quello in cui è stato eletto.
Non è certo la barriera invalicabile prospettata da Roberti. Nell’intervista a
Tv2000 che andrà in onda oggi, il superprocuratore dice che a fine mandato «si
dovrebbe essere assegnati in ruoli della pubblica amministrazione diversi da
quelli di giudice o pm». Il Csm lo suggeriva in una delibera dell’estate 2015,
ignorata dal Parlamento. Carlo Nordio lo ha ripetuto in interviste e nei suoi
editoriali sul Messaggero. C’è chi come Gherardo Colombo prefigura una soluzione
light come quella di Montecitorio ma, in un’intervista a Repubblica, chiarisce:
«Io, se mai avessi deciso di entrare in politica, prima di candidarmi mi sarei
dimesso». La schiera di chi è per soluzioni drastiche è ben presidiata. Annovera
anche il presidente dell’Anm Piercamillo Davigo, che le porte girevoli tra
magistratura e partiti non le tollera proprio. Chi come Gianrico Carofiglio ha
da tempo smesso la toga è altrettanto netto. La magistratura più avvertita non
vuole farsi più prendere in castagna. Magari da casi come quello di Minzolini,
dietro cui si nascondeva in realtà l’incredibile parabola del giudice ed ex
deputato che lo aveva impallinato.
Giustizia: Roberti (procuratore antimafia), “magistrati in
politica non tornino indietro”, scrive il 17 marzo
2017, "Agensir". “Non ho nulla contro i magistrati che scelgono di passare in
politica, ma dovrebbero non tornare più nell’attività giurisdizionale una volta
finita la vita politica, tornando nel settore pubblico e nella pubblica
amministrazione, con ruoli diversi da quelli di giudice o pubblico ministero”.
Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, in un’intervista
a “Soul”, il programma-intervista di Tv2000 condotto da Monica Mondo in onda
sabato 18 marzo alle ore 12.15 e alle 20.45 in occasione anche della Giornata
per le vittime della mafia che si celebra il 21 marzo. “Non scenderei mai in
politica – ha rivelato Roberti – non ho mai pensato a farlo. Ho molto rispetto
per la politica, è la più nobile delle attività umane quando è volta al bene
comune e dei cittadini. Quando ha interessi personali, di gruppo o di lobby,
invece, è la più bassa. La gente ha questa percezione, ma ho conosciuto tanti
esponenti politici che sono persone veramente intenzionate a ben operare
nell’interesse dei cittadini. Spesso prevalgono le logiche dei partiti, di
gruppo, di appartenenza o quelle mafiose. Questo inquina la vita politica, come
quella civile, l’economia e il mondo delle professioni. Bisogna combattere
contro tutto questo”. “Bisogna distinguere caso per caso – ha sottolineato
Roberti – le situazioni di sovrapposizione tra legge e giustizia. I magistrati
hanno giurato fedeltà alla Costituzione: siamo chiamati a tutelare i diritti di
tutti i cittadini che è l’essenza dell’attività giurisdizionale. I magistrati
non si sostituiscono al legislatore, ma cercano di raccogliere la domanda di
giustizia che proviene dai cittadini. Credo che in un rapporto di reciproca e
leale collaborazione i magistrati devono anche dare indicazioni al legislatore,
quando non interviene a dovere prima, senza fare qualcosa di creativo ma in una
interpretazione estensiva non spinta da ideologie”.
Intervista a Carlo Nordio: “Pm e politica? La legge si fa in un
giorno”. Intervista di Errico Novi il del 21 gennaio
2017 su "Il Dubbio". Il magistrato Carlo Nordio commenta il ritardo accumulato
dal Parlamento sulla norma che dovrebbe limitare le candidature dei giudici,
reclamata dal Consiglio d’Europa.
«Disegno preordinato contro la magistratura? No, non è l’idea che mi sono fatto.
Non è che ci vogliono affossare: vedo solo incapacità di comprendere i problemi
della giustizia e sostanziale indifferenza». Carlo Nordio è disincantato, non
scorge perfide macchinazioni, non cede al dietrologismo neppure ora che la
mancata estensione della proroga lo mette a un millimetro dalla pensione,
prevista il 6 febbraio e a questo punto, per lui, quasi inevitabile.
Semplicemente diffida della capacità del legislatore «in materia di codice
penale come di trattamento di noi magistrati». Aggiunto a Venezia, svolge
funzioni di capo perché il 1° gennaio è già andato in pensione il procuratore
Luigi Delpino: dopo una brillante carriera di inquirente assapora il gusto un
po’ agrodolce di una funzione direttiva da svolgere per altre due settimane
appena.
«Ma il pensionamento arriva per me a un età giusta. Il problema non è personale
ma ordinamentale: senza la proroga sono già andati in pensione 100 magistrati a
gennaio, ancora di più si congederanno nei prossimi mesi, si tratta di uno
tsunami senza precedenti per i vertici degli uffici, del tutto insensato: non si
risparmia una lira, i magistrati anziani al massimo della carriera percepiscono
una pensione identica all’ultimo stipendio. Almeno una parte di noi andrà
sostituita, le nuove assunzioni hanno un costo e poi non è che si entra in
servizio il giorno dopo aver vinto il concorso…».
Il suo scetticismo riguarda anche le regole sull’attività
politica dei giudici: reclamate l’altro ieri dal Gruppo anti– corruzione ( Gr.
e. co.) del Consiglio d’Europa.
«Quella che giace ora in Parlamento si può approvare in mezza giornata».
È ferma da quasi tre anni.
«Partiamo dal richiamo di Strasburgo.
Tra richieste di trasparenza sul reddito dei giudici e di controlli sulla
gestione dei fascicoli, si adombra lo spettro di magistrati corruttibili o
almeno pesantemente condizionabili. E questo, me lo lasci dire, non ha senso.
Alla magistratura italiana si possono cointestare tante cose, ma a parte casi
rarissimi non è la corruzione il problema. Casomai lo sono certe scelte
improprie come quella di fare politica.
La proposta di legge è passata al Senato ed è ferma a
Montecitorio da quasi tre anni, come ha ricordato il laico del Csm Zanettin.
«Premessa: resto convinto che ai
magistrati l’attività politica vada impedita persino quando sono ormai in
pensione. Diventa un problema a maggior ragione quando si tratta di inquirenti
che hanno condotto inchieste ad altro coefficiente politico: la loro attività
può finire per essere letta come un preordinato disegno per prepararsi una
cuccia calda prima di andare a riposo. E poi c’è un’altra ragione, più sottile
ma altrettanto importante.
Quale?
«Un magistrato che magari si è
guadagnato una certa fama con la propria attività, se entra in politica finisce
per sfruttare quell’immagine alterando così la par condicio con gli altri
candidati.
È un’ammissione che le fa onore.
«Non ho problemi a riconoscerlo perché
lo verifico di persona: mi capita cioè di essere fermato per strada e di
sentirmi dire ‘ ah, è stato proprio bravo con quell’inchiesta sul Mose,
dovrebbero fare tutti come lei…’. Vero o falso che sia, ho fatto semplicemente
il mio dovere e non credo che da questo sia giusto ricavare vantaggio.
Il Csm suggerisce di impedire il rientro in magistratura a chi è
stato in Parlamento.
«Certo che non dovrebbe rientrare.
L’unico problema è che per limitare l’ingresso in politica o il ritorno alle
funzioni giurisdizionali credo serva almeno inserire in Costituzione una riserva
di legge. Con la Carta vigente si rischia di violare il principio di uguaglianza».
La legge ferma a Montecitorio si limita a vietare per due anni
l’esercizio della funzione di magistrato nello stesso collegio dove si era stati
eletti.
«E per una norma del genere non serve
ritoccare la Costituzione: la si approva in mezza giornata».
Ma i deputati della commissione Giustizia dicono: abbiamo
accantonato quel testo perché nel frattempo abbiamo cambiato il codice
antimafia, le norme sulle confische, le pene per il caporalato e tanto altro
ancora.
«Ho presieduto una commissione per la
riforma del codice penale: parliamo di strutture complesse e organiche, ed è
sempre un errore modificarle in modo frazionato, o le si rende sempre più
instabili. Il nostro codice porta ancora le firme di Mussolini e Vittorio
Emanuele III, su materie come la disponibilità del diritto alla vita è
tipicamente fascista. Meriterebbe di essere cambiato radicalmente, non di volta
in volta con l’eliminazione di discriminanti sui diritti di difesa, con nuove
aggravanti, nuovi reati o nuove pene».
E invece questo si è fatto.
«Se uno apre il codice trova più frasi
in corsivo che in grassetto, vuol dire che soppressioni e aggiunte superano la
norma originale: così la certezza del diritto va a ramengo. Ai politici d’altra
parte interessa finire sui giornali con le leggine ad hoc, che assecondano
l’emotività del momento, come per l’omicidio stradale».
D’accordo, si è esagerato che l’introduzione di nuovi reati, ma
se per regolare almeno un po’ l’attività politica di voi giudici basta mezza
giornata, perché non lo hanno fatto? Avevano timore di mettersi contro di voi?
«Questo è di gran lunga il governo che
ci ha maltrattato di più. Altre volte abbiamo subito aggressioni, ma da quelle è
più facile difendersi. Stavolta siamo stati semplicemente presi in giro, e
almeno su questo sono d’accordo con Davigo. Parlo delle norme sui trasferimenti
come di quelle sulle pensioni».
Condivide la decisione dell’Anm di disertare la cerimonia in
Cassazione?
«Sì, la risposta dell’Anm è stata la
migliore, sono sempre stato contrario allo sciopero e d’altra parte un segnale
forte andava dato: non partecipare alle inaugurazioni è la cosa più giusta».
Due giorni prima Davigo vedrà Orlando.
«L’incontro del 24 rischia di essere
una barzelletta: nell’occasione precedente c’era anche il presidente del
Consiglio e agli impegni presi non è seguito nulla, stavolta c’è solo il
ministro che è sempre lo stesso. Non vedo l’utilità ma chissà, spero si rendano
conto dell’errore sulle pensioni».
Va a finire che la proroga arriva il giorno dopo che si sarà
dovuto congedare lei.
«Eh già, ma vede, siamo preparati a
tutto. Avremmo preferito ci fosse risparmiato un trattamento che non usano
neppure le persone maleducate nei confronti delle colf. So solo che Venezia
resterà nelle mani di un aggiunto costretto a fare il lavoro di tre persone, e
che ci vorrà un anno per nominare un nuovo capo. Qui e in tanti altri uffici, e
nessuno ha spiegato che senso abbia tutto questo».
Lo strano senso di Davigo per la politica.
Il numero uno della Anm critica Michele Emiliano: "I magistrati
non devono mai fare politica". Ma lui, pur non iscritto ad alcun partito, sono
anni che la fa, scrive Ermes Antonucci su “Il Foglio” il 2 Marzo 2017. “Sono
dell’opinione che i magistrati non debbano fare politica mai”. A dirlo, in
maniera molto tranchant, è stato il presidente dell’Associazione nazionale
magistrati, Piercamillo Davigo, intervenendo martedì sera alla
trasmissione DiMartedì su La7. Il riferimento era al caso che sta coinvolgendo
il governatore pugliese Michele Emiliano, frutto prevedibile dell’anomalo
groviglio tutto italiano tra magistratura e politica, dove nella stessa persona
(Emiliano) troviamo riunite le figure di magistrato, di candidato alle primarie
di un partito politico (il Pd) e di testimone di un processo in cui è coinvolto
il padre dell’ex presidente del Consiglio (vicenda Consip). Dunque, parlando del
caso Emiliano, Davigo ha sbarrato la strada a ogni sconfinamento della
magistratura in politica. E lo ha fatto non celando un certo senso di
superiorità, come se i magistrati oggi possano fare politica solo se iscritti a
un partito e come se lui spesso non avesse svolto attività sostanzialmente
qualificabile come “politica”. Ci pare, infatti, che il presidente dell’Anm, pur
non essendo iscritto a un partito, la politica – in senso lato e in forme
diverse da quelle partitiche – la faccia da un pezzo. Non è politica dire, come
ha fatto Davigo due minuti prima di lanciare il proclama anti-Emiliano, che la
rottamazione delle cartelle esattoriali alla quale starebbe pensando il governo,
nella sua piena autonomia di scelta di politica economica, “è una vergogna”? Non
è politica negoziare per mesi con il governo per convincerlo a cambiare la legge
sul pensionamento dei magistrati, tanto da minacciare il blocco delle aule di
giustizia e disertando l’inaugurazione dell’anno giudiziario? Non è politica
invocare l’introduzione per la lotta alla corruzione di “alcune norme che
valgono per i mafiosi” (13 febbraio)? Non è politica chiedere di anticipare a
prima del referendum costituzionale la discussione parlamentare sulla riforma
penale (8 novembre)? Non è politica dire che “le nostre leggi sono fatte apposta
per poter salvare i colletti bianchi” (7 novembre)? Non è politica dire che “se
la riforma della giustizia viene approvata così com’è con un voto di fiducia per
noi non va bene, aggrava i problemi e non li risolve”, se cambia “possiamo
discutere” (2 ottobre)? Non è politica affermare che “la riforma della giustizia
è inutile, se non dannosa” (25 settembre)? Non è politica dichiarare che “le
leggi che aumentano le pene senza sapere a chi darle sono inutili” (19 giugno)?
Non è politica dire che “è inutile la legge su chi segnala i reati nella
Pubblica amministrazione” (17 giugno)? O descrivere il nuovo codice degli
appalti come “tutta roba che non serve a niente” (10 giugno)? O affermare di
“non vedere la necessità di una legge sulle intercettazioni” (20 aprile)? O
sostenere che non serve una riforma della disciplina sulle intercettazioni
perché “basta aumentare le pene per la diffamazione, il resto è superfluo” (10
aprile)? Non rappresenta uno sconfinamento nella politica per un magistrato
dichiarare pubblicamente, pochi giorni dopo essere stato eletto alla guida
dell’Anm, che a distanza di oltre due decenni da Mani pulite “i politici
continuano a rubare, ma non si vergognano più” (21 aprile)? La verità è che un
magistrato può fare politica in tanti modi e l’iscrizione a un partito è solo la
via di sconfinamento più evidente. In fondo, non erano iscritti a partiti i
magistrati della corrente di Magistratura democratica che diversi mesi prima del
referendum costituzionale decidevano di aderire e cavalcare pubblicamente la
campagna per il “No”, con tanto di manifesto in cui veniva definita come
“autoritaria” la riforma voluta dal governo Renzi. Ciò vuol dire che un
magistrato non può in alcun modo intervenire pubblicamente per fornire la
propria opinione su tematiche di interesse generale? Nessuno sta dicendo questo.
L’ex procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio ha indossato la toga per
quarant’anni, commentando spesso – e nell’ultimo periodo con buona frequenza,
tanto da diventare quasi “editorialista” di un giornale nazionale – i fatti e le
questioni di attualità (dal terrorismo alle forme di repressione penale), ma lo
ha fatto sempre con la discrezione e la sobrietà che il rilievo pubblico della
funzione di magistrato dovrebbe imporre. E senza mai mostrare simpatie o
iscriversi a questo o quel partito, ma anzi ribadendo fino all’ultimo – anche
nell’intervista al nostro giornale pubblicata lo scorso 7 febbraio – la sua
assoluta contrarietà a ingressi in politica da parte dei magistrati persino dopo
il loro pensionamento. È comprensibile, va ammesso, che una simile riflessione
sull’esigenza di un atteggiamento di self restraint da parte dei magistrati,
fatichi ad affermarsi nel nostro paese. Dopotutto, sono passate quasi
inosservate le dichiarazioni espresse dalla deputata-magistrata Donatella
Ferranti nei confronti dello stesso Emiliano (“Scelga: o il partito o la toga”),
lei che non solo è una toga eletta con il Pd, ma presiede la commissione
Giustizia della Camera. Quella chiamata, invano, ad esaminare da due anni una
proposta di legge sulla candidabilità e l’eleggibilità dei magistrati in
occasione delle elezioni politiche.
Chi critica l’ingiustizia dei giudici in politica,
scrive Sabato 11 marzo 2017 Aldo Grasso su "Il Corriere della Sera". Diceva
Piero Calamandrei: «Quando per la porta della magistratura entra la politica, la
giustizia esce dalla finestra». Sante parole. Donatella Ferranti, presidente
della commissione Giustizia, bacchetta a dovere il governatore Michele Emiliano:
«È un caso limite. Per un magistrato un conto è partecipare attivamente alla
vita politica, mettendosi ovviamente in aspettativa. Altro è non solo iscriversi
a un partito, ma entrare nella sua direzione, al punto da candidarsi alla
guida». Difficile darle torto. C’è un però. Anche la Ferranti è magistrato.
Prima al Csm ai tempi di Rognoni e Mancino e poi il salto in politica nel 2008:
capolista Pd nel collegio Lazio 2. Non sono pochi i magistrati in aspettativa
che siedono al Parlamento: Felice Casson, Anna Finocchiaro, Doris Lo Moro,
Stefano Dambruoso, Cosimo Ferri, Domenico Manzione… In aspettativa, ma con
avanzamenti di carriera! Una vera ingiustizia. La Costituzione all’articolo 51
garantisce l’elettorato passivo a tutti i cittadini, anche ai magistrati, ma
prevede, all’articolo 98, che la legge limiti per le toghe, come per i militari,
le forze dell’ordine, i diplomatici (di mio aggiungerei i giornalisti),
l’iscrizione a un partito. Si può, certo, ma poi uno cambia mansione. Per certe
professioni occorre essere e apparire al di sopra delle parti. E qui sta la
fatale distinzione fra ciò che è legale e ciò che è legittimo. Si può imporre la
legge, ma non la prudenza.
Mattarella a giovani toghe: "Non smarrire mai senso del limite".
Il Presidente della Repubblica al Quirinale per la cerimonia con i 610 giudici
ordinari in tirocinio, alla presenza del vicepresidente del Csm Giovanni Legnini
e del ministro della Giustizia Andrea Orlando, scrive il 6 febbraio 2017 "La
Repubblica". "Anch'io ho svolto il ruolo di giudice costituzionale e ho avuto
modo di constatare il valore del confronto e della dialettica. Eppure in quegli
anni ho sentito anche la tensione di dover rendere giustizia. Non fatevi
condizionare da nulla se non dall'applicazione della legge. Neppure da quel
sottile senso di solennità che deriva da questo ambito in cui operiamo. Occorre
non smarrire mai il senso dei propri limiti particolarmente di quelli
istituzionali". Così, a braccio, il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella al Quirinale per la cerimonia con i 610 magistrati ordinari in
tirocinio, alla presenza del vicepresidente del Csm Giovanni Legnini e del
ministro della Giustizia Andrea Orlando. Mattarella, rivolgendosi alle giovani
toghe, ha sottolineato come sia "un'esortazione che rivolgo innanzi tutto a me
stesso perché in questo salone così solenne tutto esprime un senso di
autorevolezza e, operando in questo ambiente, occorre non smarrire mai il senso
dei propri limiti, particolarmente di quelli istituzionali. Nel corso della
vostra carriera ogni tanto, se vi è possibile, cercate di rammentare questo mio
sommesso suggerimento". "I magistrati hanno un compito molto importante" dice il
capo dello Stato ricordando la sua esperienza di giudice costituzionale, "ho
apprezzato fortemente la grande, fondamentale utilità del confronto dei punti di
vista e della dialettica delle opinioni: fa conseguire un arricchimento
progressivo". Il Presidente spiega che "l'equilibrio nell'esercizio della
funzione giudiziaria consiste nel sapere evitare il duplice rischio di
applicazioni meccanicistiche delle norme o di letture arbitrariamente 'creative'
delle stesse". "Equilibrio, ragionevolezza, misura, riserbo sono virtù che, al
pari della preparazione professionale, devono guidare l'agire del magistrato in
ogni sua decisione. Lo spirito critico verso le proprie posizioni e l'arte del
dubbio, l'utilità del dubbio, sorreggono sempre una decisione giusta - spiega
Mattarella - frutto di un consapevole bilanciamento tra i diversi valori
tutelati dalla Costituzione". La magistratura, nella nostra recente storia, sono
ancora le sue parole, "ha dimostrato di avere tutti gli strumenti per garantire
il riconoscimento dei diritti, senza condizionamenti. È un bene che sia sempre
più orgogliosa della sua funzione insostituibile, ma anche consapevole della
grande responsabilità che grava sulla sua azione". La giustizia, rileva il capo
dello Stato, "è una risorsa fondamentale, ancor più per un Paese integrato nella
comunità internazionale. È un servizio che contribuisce a garantire l'ordinato
sviluppo civile e sociale". Secondo Mattarella, proprio al fine di assicurare la
più efficace tutela dei diritti "al magistrato è garantita autonomia e
indipendenza nelle sue decisioni che, per essere credibili, devono essere
sorrette da una solida preparazione, frutto di un assiduo impegno
professionale". In questo modo, conclude il Presidente, "evitando di correre il
rischio dell'arbitrio si tutela al meglio l'autonomia e l'indipendenza della
magistratura".
Parlamento in attesa di giudizio. Così il destino di una
legislatura è nelle mani delle sentenze, scrive
Michele Ainis il 22 gennaio 2017 su "L'Espresso". Chi comanda a Roma? Dipende
dalle vendemmie, dalle annate. Nel 2011 comandava il capo dello Stato
(Napolitano); nel 2014 il presidente del Consiglio (Renzi); nel 2017, a quanto
pare, comanda la Consulta. L’11 gennaio, negando il referendum sui
licenziamenti, ha allungato la vita della legislatura; il 24 gennaio, decidendo
sull’Italicum, può stabilirne i funerali. Nel frattempo ogni sentenza genera un
clima di suspense, s’iscrive in un giallo aperto a ogni finale; mentre la
politica attende trattenendo il fiato, inerte, come paralizzata. Il vuoto
d’iniziative sulla legge elettorale ne è la prova più eloquente. Ma è normale
quest’alone d’incertezza sulle pronunce giudiziarie? In qualche misura, sì: il
diritto non è una scienza esatta, altrimenti non ammetterebbe appelli e
contrappelli. Oltremisura, no: un conto è la discrezionalità degli organi
politici, un conto è il capriccio degli organi giurisdizionali. Quando i
tribunali si sostituiscono invece ai Parlamenti, quando ne insidiano il primato,
si manifesta un pericolo che può ben essere letale per le democrazie: il governo
dei giudici, «government by judiciary». Quest’espressione risale all’alba del
secolo passato, sull’una e sull’altra sponda dell’Atlantico. Venne coniata nel
1914 dal Chief justice della Corte suprema del North Carolina, per denunciare i
rischi del controllo giudiziario sulla costituzionalità delle leggi («una
perversione della Costituzione»); in Europa fu esportata da un libro francese
del 1921. Da allora in poi s’aprì una storia di baruffe, di colpi incrociati.
Memorabile il conflitto che oppose il presidente Roosevelt alla Corte suprema
degli Stati Uniti, durante gli anni Trenta, quando quest’ultima respinse alcune
tra le riforme più significative del New Deal. Anche in Italia, però, non sono
state rose e fiori. Non per nulla la Consulta rischiò d’essere abortita già in
Assemblea costituente, per la veemente opposizione di Togliatti; ma la Dc difese
con tenacia la creatura, salvo pentirsene alla prima occasione. Era il 1956,
l’anno di “Lascia o raddoppia?”; la Corte costituzionale esordiva nel nostro
ordinamento, sia pure con 8 anni di ritardo rispetto alla Costituzione; e calò
subito la scure su alcune norme poliziesche ospitate nel testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza. Da qui l’ira di Tambroni, ministro democristiano
dell’Interno; peraltro imitato perfino dal papa, Pio XII. Nei decenni successivi
la protesta si è trasformata non di rado in rissa, in insulto, in improperio.
Per esempio da parte di Pannella: «Corte Beretta» (1981), «strumento del regime»
(1985), «suprema cupola della mafiosità partitocratica» (2004). Da parte di
Berlusconi, con il suo ritornello sulla «Corte comunista». Da governatori
regionali come Formigoni (nel 1997 dipinse la Consulta come un «organo
partigiano, ulivista, anzi della parte peggiore e più retriva dell’Ulivo»). O
anche da ministri come Guido Carli, che nel 1990 mise alla berlina le sentenze
costituzionali «di spesa», presentando il conto dinanzi all’opinione pubblica:
53 mila miliardi in un decennio, quasi un quarto dell’intero deficit dell’epoca.
D’altronde due anni prima, nel 1988, un’accusa analoga era risuonata per bocca
di chi l’aveva preceduto al ministero del Tesoro. Il suo nome? Giuliano Amato,
che adesso siede proprio alla Consulta. La vita è una giostra, come no. Ma su
quella giostra i giudici costituzionali non si limitano a incassare calci e
ceffoni dai politici; talvolta li restituiscono, aggiungendo qualche grammo di
curaro. Come fece, per esempio, il presidente Granata, in una conferenza stampa
del febbraio 1999: la Consulta aveva riscritto le norme sui pentiti, sollevando
critiche e dissensi; lui reagì con parole di fuoco al fuoco sparato dal Palazzo.
O come fece, con toni ancora più furenti, il giudice Romano Vaccarella. Nel
maggio 2007 si dimise, puntando l’indice contro tre ministri (Chiti, Mastella,
Pecoraro Scanio) e un sottosegretario (Naccarato). La loro colpa? Pressioni
sull’inammissibilità del referendum elettorale, uno dei tanti su cui la Corte
costituzionale si è trovata a giudicare in questi anni. Secondo Vaccarella,
insomma, nell’occasione il controllato cercò di controllare il proprio
controllore. In Italia può succedere, ma può anche succedere il contrario. Ossia
che l’arbitro diventi giocatore, che una sentenza prenda il posto della legge.
Specie se la legge latita per l’impotenza o per la negligenza dei politici. È il
caso della stepchild adoption: negata dal Parlamento, concessa dalla Cassazione
(sentenza n. 12962 del 2016). Ma già nel 1975 furono i giudici ordinari a
codificare il diritto alla privacy (la legge intervenne soltanto nel 1996). E
sempre i giudici, ben prima dei politici, nel 1988 offrirono tutela al
convivente more uxorio. Una Repubblica male ordinata reca più danni d’una
tirannia, diceva nel Cinquecento Donato Giannotti. È esattamente questo il morbo
che intossica la nostra vita pubblica; e la Consulta, da parte sua, non è
affatto vaccinata. Altrimenti non si spiegherebbero certe iniziative, certe
scelte politiche travestite da responsi oracolari. Come il rinvio dell’udienza
sull’Italicum: era fissata al 4 ottobre, ma un paio di settimane prima (il 19
settembre) sbucò un comunicato di rinvio, senza uno straccio di motivazione.
Anche se la motivazione trapelava fra le righe: il referendum costituzionale di
dicembre, guai a sovrapporre l’una e l’altra decisione. Così adesso, a
referendum consumato (e fallito), la politica riprende il centro della scena. Ma
è politica giudiziaria, è sentenza costituzionale, l’unica forma di politica che
resta ancora in auge.
Prontuario post-democratico per il Paese dove è vietato votare,
scrive Tommaso Cerno il 23 gennaio 2017 su "L'Espresso". Siamo l’unico Stato
occidentale senza una legge che consenta le urne. E la Consulta ha il dovere di
indicarci una via d’uscita: ma è normale? L’Espresso, dopo il flop elettorale di
Matteo Renzi al referendum e la straripante vittoria dei No (non dico del No,
perché le sfaccettature erano molte), titolò facendo il verso alla storica frase
attribuita a Ernesto Che Guevara: “Hasta elezioni siempre!” Significa,
letteralmente: “Sempre fino alle elezioni!”. In quel frangente, qualche
cerchiobottista e qualche spaventato esponente del Pd ridotto com’è ridotto, ci
criticò dicendo che non avevamo a cuore la democrazia rappresentativa, quella
dei Padri, per intenderci, perché adesso c’era da fare un governo
tecnico-politico, c’era da pensare un nome, c’era da riflettere sul senso di
responsabilità e sulle scadenze, sul G7 di Taormina e via elencando. Insomma,
c’era da prendere tempo. Tutto giusto e tutto vero. Salvo per un dettaglio che,
soprattutto dopo avere pontificato per mesi sulla Costituzione e il suo valore
simbolico prima ancora che materiale, dopo avere tirato in ballo i partigiani e
la memoria delle dittature, pesa come un macigno sull’Italia furbetta che cerca
una strada per recuperare elettorato e credibilità politica. E non è nemmeno
questione di vitalizio, come vanno molti ripetendo per strappare un applauso qua
e là. Certo c’è del vero nell’onorevole ingordigia di prebende, basta guardare
lo storico delle legislature. Ma, in questo caso, per un liberale, c’è in gioco
qualcosa di più profondo, su cui vale la pena fare una riflessione. Detta in
poche parole: è vero che in Italia, paese democratico (dove cioè governa il
popolo attraverso una delega) la Costituzione non prevede che si vada al voto
dopo un No al referendum, essendoci una maggioranza parlamentare che sostiene un
governo. Ma è altrettanto vero che mai i padri costituenti si sarebbero
immaginati un Paese dove, all’improvviso, è vietato votare. Non vi è cioè una
legge elettorale in vigore. Ora mi domando se questo sia normale. Pur senza
arrivare al modello americano, alle prese con il passaggio Obama-Trump, che ha
fissato in Costituzione tanto la legge elettorale quanto la data delle elezioni
(si sa già oggi con certezza in che giorno si voterà fra quattro, otto, dodici,
sedici anni), il caos italiano ci porta a essere privati a tempo, ma nella
sostanza, di un diritto delle democrazie. Eppure il diritto - per essere tale -
deve essere “di tutti” e “sempre”. Altrimenti si classifica come privilegio.
Deve cioè vivere sia quando serve esercitarlo, sia quando non è necessario.
Qualcuno dirà: di leggi non ne abbiamo una, ma tre. Inutili, però. C’è
l’Italicum giudicato dalla Consulta che - in ogni caso - si sarebbe potuto
applicare a una sola Camera, vista la sicumera di chi lo presentò e approvò,
all’epoca convinti che l’abolizione del Senato (poi bocciata dagli italiani)
fosse scritta nelle stelle. Ne abbiamo un’altra, abrogata da quest’ultima, l’ex
Porcellum poi Consultellum, che non potrebbe essere usata in caso di emergenza
come estintore democratico. Ne abbiamo poi una terza, sepolta nella Seconda
repubblica, il Mattarellum, che per curiosa coincidenza porta oggi il nome del
Capo dello Stato garante della Carta. Ma nemmeno essa esiste nella realtà. Per
questo, la settimana che si apre è fondamentale. Dobbiamo mettere fine a questa
anomalia, ben più grave del rapporto deficit-Pil sforato, ben più perniciosa per
il nucleo caldo della convivenza democratica di quanto possa essere la modifica
(più o meno riuscita) del Senato della Repubblica. Sappiamo che Non basterà la
sentenza. Non basterà in se stessa e non basterà al parlamento avido di mettere
le mani sulla materia elettorale, in quanto meccanismo diabolico capace di
perpetuare o meno le poltrone di Montecitorio e di Palazzo Madama. Ma
l’importante è che l’Italia comprenda che le regole del voto sono una priorità
democratica. E si smetta di ripetere che abbiamo altre urgenze. È ovvio che
lottare contro la disoccupazione e la criminalità, rispondere all’emergenza
immigrazione, prevenire i disastri naturali con politiche urbanistiche è il
compito concreto di uno Stato moderno. Ma solo dentro una democrazia compiuta,
sana e matura, libera da legacci, questo Stato può trovare la forza (e la
credibilità) di presentarsi al popolo per fare delle proposte. Uno Stato che al
contrario considera il diritto di voto una questione secondaria non può farlo.
Per sua stessa natura insalubre. Perché riduce la delega popolare a pura
formalità.
L'Italicum e la Consulta, quella piccola corte sempre più
potente. La decisione sulla legge elettorale la
prenderà un conclave silente e paludato. Che vive di riti e rifiuta la
trasparenza. Ma conta sempre di più, nel vuoto del Parlamento, scrive Denise
Pardo il 24 gennaio 2017 su "L'Espresso". L’archivio è previsto persino dal
regolamento, ma chi avrebbe avuto il potere si è ben guardato dal costituirlo.
Non c’è traccia dell’attività della Corte Costituzionale. «Coperta dall’oblio
eterno in ossequio a una sbagliata concezione del segreto» ha scritto il giudice
emerito Sabino Cassese, «la Corte ha deciso di cancellare i documenti della sua
storia. Nessuno dei più segreti atti di Stato è mai rimasto coperto per sempre
dal segreto». Una prassi che non esiste in nessun’altra Corte al mondo, il
contrario di quella Suprema americana, inno alla trasparenza. Il sontuoso
palazzo della Consulta, secoli fa di proprietà pontificia rimesso a nuovo un
attimo dopo il tramonto dei Borgia, resta inespugnabile all’esterno. Ma, nessun
altro luogo in questo momento è più centrale. E più misterioso. In uno scenario
globale dove tutto si svela, la Corte costituzionale continua a rimanere un
enigma. Il papa ha un account Twitter, il Quirinale anche, persino
l’ultranovantenne regina d’Inghilterra non si è sottratta. Ma la Corte non
informa. Se trapela qualcosa è un oltraggio. Al massimo materializza un laconico
comunicato stampa firmato «dal Palazzo della Consulta» a opera forse di un
Belfagor del posto, ossessiva custode della delicatezza del ruolo. E delle
implicazioni e possibili chine di pressioni politiche, ben conscia che davanti a
lei si staglia l’ombra del Quirinale, con il monito presidenziale di un ex
giudice costituzionale, Sergio Mattarella, il primo a aver attraversato la
strada. C’è la fitta nebbia del potere intorno ai riti, ai ritmi, alle segrete
stanze, alle posizioni dei suoi giudici, giuristi, magistrati, politici, spesso
quirinabili, come Cassese, Conso, Amato, riuniti nella sala del consiglio, un
tavolo ovale, i microfoni neri, gli affreschi alle pareti. Pochi alieni a quel
mondo hanno varcato il portone. Molti hanno scritto dei privilegi, gli stipendi,
le auto blu, gli autisti, l’immunità, il costo del funzionamento oltre 60
milioni di euro all’anno. Se ne conoscono i componenti e anche i patimenti ogni
volta che vanno scelti e nominati, 31 sedute e altrettante votazioni un anno fa
per assegnare dal Parlamento tre posti vacanti da mesi. Per il Pd il
costituzionalista Augusto Barbera, massimo esperto di leggi elettorali, non un
fan del Mattarellum; per i Cinque Stelle il suo collega Franco Modugno, e per
Area Popolare Giulio Prosperetti, giuslavorista e giudice della Corte d’Appello
della Città del Vaticano. Con una politica sempre più debole, incapace di dare
risposte e certezze, la Corte è diventata l’unico topos risolutivo. Nel Palazzo
che protegge e ripara, i tredici giudici, dovrebbero essere quindici, un trio di
cinquine nominate dal Colle, dal Parlamento e dalle alte magistrature,
abbigliati due-tre volte l’anno come una pièce in costume, Giuliano Amato con i
volants della camicia e la toga d’ordinanza è da dipinto di Goya, hanno studiato
la costituzionalità delle leggi più importanti degli ultimi anni (ogni norma può
essere rimessa alla Corte), gli ultimi governi hanno dato molto lavoro,
Berlusconi in testa. E ora il segno della futura governance del Paese spetta di
nuovo alla Corte con il responso più atteso di quel che resta
dell’amministrazione Renzi: la costituzionalità dell’Italicum, relatore il
giurista Nicolò Zanon, ex laico del Csm, vicino al Pdl, anche consultato dall’ex
Cavaliere per un parere pro veritate. Il 24 gennaio il giorno x, data di
partenza in un senso o nell’altro della legge elettorale di una sconosciuta
nuova era politica. I giudici hanno l’obbligo della discrezione, ha ricordato
questa settimana incupito il presidente emerito Gustavo Zagrebelski dopo che
sulla sentenza clou dell’11 gennaio, quella sul Jobs Act, ancora il governo
Renzi sulla graticola, chiusa con un no al referendum della Cgil sull’articolo
18, un sì per quelli su voucher e appalti, sono scappati all’esterno particolari
scandalosi. Per esempio che la relatrice Silvana Sciarra, giuslavorista di
Firenze indicata dal Pd, seguace, secondo alcuni colleghi più moderati, più di
Maurizio Landini che del suo vero maestro Gino Giugni, avrebbe voluto allargare
la consultazione referendaria anche all’articolo 18. Posizione contraria a
quella di Amato, il vincitore del confronto, in campo con Prosperetti e Mario
Rosario Morelli, magistrato della Corte di Cassazione, i relatori degli altri
due referendum. Sui giornali è uscita anche la conta dei voti, otto a cinque,
una proporzione di contrari troppo alta per la media tacitamente consentita
perché «il punto essenziale per capire il lavoro della Corte è il principio di
collegialità», ha specificato una volta la vice presidente Marta Cartabia,
allieva del presidente emerito Valerio Onida, scelta da Giorgio Napolitano (come
Amato, Daria De Pretis e il presidente Paolo Grossi) segnalata a un certo punto
perfino come quirinabile. E così stimata da provocare uno sconquasso dopo la
nomina a vice presidente che sarebbe spettata a due giudici ben più anziani.
Tanto che ora, pazienza per il regolamento, i vice presidenti sono dovuti
diventare tre, oltre a lei, Giorgio Lattanzi, presidente di sezione della Corte
di Cassazione e Aldo Carosi, consigliere dalla Corte dei Conti. In realtà, la
promozione era propedeutica alla poltrona più alta della Corte secondo un brain
storming di Napolitano e Cassese uno dei pochi giudici a rifiutare lui la
presidenza arrivata di diritto per anzianità di nomina ma di brevità di durata
rispetto alla naturale scadenza. Dettaglio che non turba tutti, visto che il
circolo dei presidenti emeriti è affollatissimo da chi ha accettato di
presiedere soltanto per poche settimane: un mese e 14 giorni Vincenzo
Caianiello, tre mesi e due giorni Giuliano Vassalli, tre mesi e 4 giorni
Giovanni Maria Flick, tre mesi e dieci giorni Giuseppe Tesauro, battezzati nello
slang della Corte i “balneari”. Con i suoi legni dorati, i damaschi di seta, i
lampadari dalle cento luci, i corridoi silenziosi, la Consulta ha un clima da
conclave. Per le cerimonie i commessi aiutano la vestizione, la toga nera
rassettata a Diana De Petris, ex potente rettore dell’università di Trento, il
collare dorato da posizionare a regola d’arte al presidente Paolo Grossi,
professore di Storia del diritto italiano, stimatissimo anche se, per segnalare
lo snobismo giuridico dell’ambientino, alcuni costituzionalisti puri non
dimenticano l’argomento della sua tesi discussa nel 1955, secondo le biografie,
sul regime giuridico delle abbazie benedettine nell’Alto Medioevo italiano. Per
Cassese la Corte è un misto tra un convento e un collegio di studenti. Nel 2015
ha osato l’inosabile scrivendo “Dentro la corte”, diario sulla sua esperienza di
giudice, intento apprezzato e normale nelle aule di Yale, meno alla Consulta.
Senza citare nemmeno un nome ha memorizzato i nove anni «incandescenti» segnati
da sentenze storiche. Sul tavolo della Camera di consiglio, tra pennichelle,
bigliettini che passano da un giudice all’altro, giudici che hanno studiato e
altri meno diligenti, sono stati esaminati il lodo Alfano, l’ammissibilità dei
referendum sulla legge elettorale, il caso delle intercettazioni al Presidente
della Repubblica, la costituzionalità del Porcellum. Ma anche leggi che segnano
pesantemente la vita privata delle persone, com’è stato il via libera alla
fecondazione eterologa o le udienze pubbliche sulla “Rettificazione giudiziale
di attribuzione di sesso” o persino la “Mancata depenalizzazione dell’ingiuria
tra i militari”. I giudici si danno subito del tu e si chiamano per nome. In
Camera di consiglio il “vicino di banco”, soprannominato così come alla scuola
materna, del primo giorno rimane lo stesso per nove anni. La Corte diventa un
gruppo. I padroni del diritto sono molto competitivi sulla qualità giuridica
delle argomentazioni e meno esigenti sul menù che trovano alla buvette
all’ultimo piano del palazzo mentre il secondo è riservato solo ai loro uffici.
L’obiettivo è favorire la comunicazione lontano da occhi indiscreti quando
durante “la settimana bianca”, che non è dedicata al pattinaggio su ghiaccio, ma
è quella senza sedute pubbliche e di consiglio, si studia, ci si confronta in
incontri a due, massimo a tre. Secondo le fonti, anonime perché terrorizzate,
non c’è affiliazione automatica tra i giudici di nomina parlamentare, tra i
giuristi o i magistrati. Valerio Onida, invece, stando a Milano nella “settimana
bianca” percepiva al suo ritorno che i romani si erano scambiati idee e punti di
vista. La prima donna nominata alla Corte è stata Fernanda Contri, poi Maria
Rita Saulle. Per lungo tempo, la Cartabia è stata l’unica in mezzo a soli
colleghi maschi, solo dopo sono arrivate Sciarra e De Petris. «La Corte non è
tra gli organi più solleciti a realizzare la parità di genere», ha ammesso
Amato. «Ora su 15 giudici tre sono donne. E sono fiducioso perché c’è stato
anche un momento in cui se ne vedeva una sola circondata da quattordici maschi
come non capitò nemmeno a Biancaneve perché i nani erano sette, esattamente la
metà». Adesso, via via che la data del responso sull’Italicum si avvicina,
l’atmosfera si surriscalda e la Corte entra nel mirino di chi teme la
contaminazione politica, il condizionamento (difficile dimenticare, l’episodio,
rivelato dall’Espresso, del giudice Luigi Mazzella a cena con Silvio Berlusconi
al tempo del lodo Alfano, eccezione non commentabile). Ritornano a galla annosi
interrogativi. In un paese in cui si cambia legge elettorale quanto i premier è
giusto ricorrere ogni volta alla Corte? Poi, si domanda qualcuno, è stata una
scelta tecnica o politica aspettare il 24 gennaio allontanando così le elezioni
anticipate? Forse è arrivato anche il momento di costituire un archivio, magari
prendendo esempio dal Conseil constitutionnel francese che dopo venticinque anni
rende pubblici i suoi verbali, evitando misteri e arcani. Molti anni fa in
America Bob Woodward, quello del Watergate, e Scott Armstrong hanno pubblicato
un memorabile libro sulla Corte suprema, titolo «The Brethren» i confratelli.
Chissà cosa scriverebbero della Consulta.
“Ma quale pensione! A noi magistrati piace il potere…”.
Intervista a Guido Salvini, giudice al Tribunale di Milano che interviene nella
polemica tra l’Anm e il ministro Orlando, scrive Giovanni M. Jacobazzi il 2
febbraio 2017 su "Il Dubbio". Abbiamo chiesto al dottor Guido Salvini,
attualmente giudice del Tribunale di Milano, la sua opinione su alcuni temi che
in questi giorni stanno facendo molto discutere. Non ultima, la rinnovata
polemica sulla modifica delle prescrizione del reato.
Consigliere, l’Associazione nazionale magistrati ha disertato
l’inaugurazione dell’Anno giudiziario per protesta contro il governo che non ha
portato a 72 anni il pensionamento dei magistrati. Cosa pensa di questa scelta?
«Anche a me il pensionamento a 72 anni
sembra una via di mezzo ragionevole tra i 70 e i 75, ma da qui sino a minacciare
anche uno sciopero contro il governo ne passa. Giudico l’enfasi di questa
protesta un caso di falsa coscienza, di quelli in cui non si vuole riconoscere
nemmeno dinanzi a sé stessi le ragioni di un comportamento e lo si riempie con
qualcosa di non vero».
Si spieghi meglio.
«La magistratura è l’unica categoria di
lavoratori che chiede con insistenza di lavorare più a lungo. E la strenua
opposizione dei magistrati all’abbassamento dell’età della pensione mi convince
poco, forse non riguarda che marginalmente l’attenzione per i cittadini. Più
semplicemente esprime lo sgomento per l’accorciarsi del tempo del proprio
prestigio e potere personale. Negli anni il potere della magistratura si è molto
espanso, tocca tutti i campi della società, come ha ricordato anche il ministro
Orlando, e le aspettative dei singoli sono la conseguenza di questa espansione.
In questo senso parlo di falsa coscienza».
Lei partecipa di solito all’inaugurazione dell’Anno giudiziario?
«No, l’inaugurazione dell’Anno
giudiziario mi sembra una cerimonia ormai superata, anche sul piano estetico:
quelle toghe d’ermellino rosse credo suscitino più che interesse un senso di
lontananza, sembra un anti- co conclave, qualcosa che per il cittadino
assomiglia più ad un rito che a un momento di servizio in suo favore».
Andrebbe abolita la cerimonia?
«Basterebbe un incontro meno paludato e
più asciutto, solo con qualche relazione, magari in una sala del Consiglio
comunale o in un altro luogo più aperto alla città».
Tornando alle pensioni quindi per lei la mancata posticipazione
non è una catastrofe per la giustizia?
«Non credo, anche perché quando si
parla di giudici che mancano si evita sempre di considerare le decine e decine
di magistrati che, anche da moltissimi anni, non svolgono le funzioni
giurisdizionali, perché sono collocati fuori ruolo in incarichi ministeriali,
politici, internazionali spesso superflui e per i quali basterebbe di norma un
buon funzionario».
Come spiega questa corsa al “fuori ruolo”?
«Questo avviene perché incarichi di
questo genere sono un prestigio per i prescelti e, per la categoria, una delle
porte girevoli tra politica e giustizia, porte che non dovrebbero esistere o
essere ridotte al minimo».
In effetti ci sono magistrati che svolgono compiti che nulla
hanno a che vedere con la giurisdizione…
«Infatti. Non si parla mai, quasi
nessuno lo sa, delle centinaia di magistrati che svolgono funzioni
giurisdizionali ridotte perché fanno parte delle numerose strutture di supporto
che il Csm ha voluto: è il caso dei magistrati segretari del Consiglio, di
coloro che fanno parte delle Commissioni organizzative, delle Commissioni per
l’informatica, delle Commissioni scientifiche. Anche qui basterebbe a seconda
dei casi un buon tecnico, un funzionario o uno studioso e negli altri gli
incarichi non dovrebbero ridurre le presenze in udienza».
Possiamo dire che far parte di questo mondo parallelo alla
giurisdizione serva a far carriera?
«La partecipazione a queste strutture,
in cui si entra per cooptazione, è quasi sempre un passaggio obbligato per
ottenere poi dallo stesso Csm gli agognati posti direttivi».
Cambiamo argomento. Diritto all’informazione e processo
mediatico, un valore e un disvalore che secondo lei dovrebbero essere meglio
bilanciati?
«La giustizia spettacolo e gli show in
televisione che partono già all’inizio dell’indagine e rischiano di
condizionarne gli sviluppi sono un problema tutto italiano. Non credo che negli
altri Paesi europei dopo ogni delitto eclatante si assista in televisione
a processi paralleli con opinioni senza alcun freno. Chi vi partecipa è complice
di questa stortura. A parte questo, un problema ormai irrisolvibile, si dibatte
da anni sui limiti reciproci tra giustizia e informazione».
È pessimista, a riguardo?
«Il problema è complesso ma credo che
vi sia un punto essenziale: nessuno, grande o piccolo, antipatico o simpatico
che sia, deve avere notizia per la prima volta dalla stampa di una sua
iscrizione nel registro notizie di reato, di una proroga indagini, di una
intercettazione, di un atto che lo riguarda».
Come si potrebbe fare?
«Non dovrebbe esserne consentita la
pubblicazione sino ad un momento preciso, non troppo avanti rispetto alla
notizia, ma ben definito. Quello in cui l’interessato, indagato o testimone,
abbia avuto la possibilità davanti a un magistrato di dare la sua versione su
ciò di cui è accusato o su quanto stanno dicendo di lui. Una soluzione civile
che dovrebbe essere studiata anche con l’aiuto dell’Ordine dei giornalisti, il
quale non credo debba essere contento che i suoi scritti funzionano da semplici
postini».
Un’ultima domanda. Cosa ne pensa del dibattito sulla
prescrizione?
«Non bisogna dimenticare che vi sono
due piani e che anche se si allunga la prescrizione rimane il problema della
ragionevole durata dei processi, questione spesso offuscata dalla prima. Si può
allungare la prescrizione per certi reati anche a 15 anni, ma se il processo di
primo grado si celebra dopo 7 o 8 anni chi viene condannato e soprattutto chi
viene assolto è sottoposto ad un meccanismo che non può riconoscere come una
giustizia accettabile. L’esigenza non è solo quella di allungare la prescrizione
ma anche di avvicinare i processi, altrimenti il processo stesso diventa una
pena aggiuntiva anche per l’innocente».
L'intoccabile "irresponsabilità" dei magistrati.
Il ministero della Giustizia: in due anni 115 citazioni, una sola condanna
finora in appello. Intanto gli errori giudiziari dal 1992 ci costano 691
milioni, scrive Maurizio Tortorella il 23 gennaio 2017 su Panorama. Il ministro
della Famiglia, Enrico Costa, ha reso noti i costi esorbitanti che la giustizia
italiana si trova a pagare per risarcire gli errori giudiziari e le ingiuste
detenzioni. Soltanto nel 2016, ha rivelato Costa, sono stati spesi per queste
due voci 42,1 milioni di euro. Il computo totale dal 1992 al 2016 è di 648,3
milioni di euro per le ingiuste detenzioni e di altri 43,4 milioni per errori
giudiziari. La polemica di Costa, che ieri ha dichiarato "dovremmo dibattere
meno di età pensionabile dei magistrati e più di queste profonde lesioni della
libertà personale", riaccende inevitabilmente il faro sul tema, più che annoso,
della responsabilità civile delle toghe. Quando nel febbraio 2015 il Parlamento
varò la legge 18, che modificava la norme sulle responsabilità civile dei
magistrati, quella riforma venne trionfalmente presentata dall'allora presidente
del Consiglio Matteo Renzi come una mezza rivoluzione, l'intervento che avrebbe
finalmente sbloccato l'anomalia italiana dell'assenza di sanzioni per i danni
causati da una toga, e insieme la norma che avrebbe rimediato all'inganno
legislativo rappresentato dalla legge Vassalli del 1988, che aveva tradito il
voto popolare rappresentato da una schiacciante maggioranza di consensi al
referendum popolare proposto dai radicali. Va ricordato, infatti, che la Legge
Vassali era stata così pienamente ed eccessivamente garantista, nei confronti
dei magistrati, che dal 1989 e fino a tutto il 2014 gli italiani avevano
presentato in tutto 410 citazioni per responsabilità civile. Se si considera che
in quei 26 anni soltanto i procedimenti penali aperti sono stati all'incirca 52
milioni, le citazioni presentate rappresentano appena lo 0,0008% del totale. Ma
gli italiani avevano piena ragione di essere scettici: le loro citazioni ammesse
al vaglio dell'autorità giudiziaria furono appena 35, nemmeno una su dieci. E
quelle che vennero reputate degne di essere accolte furono in tutto sette.
Sette, in 26 lunghissimi anni. Nelle settimane precedenti all'entrata in vigore
della riforma del febbraio 2015, l'Associazione nazionale magistrati manifestò
tali spropositate reazioni ("questo è un attacco mortale alla nostra
autonomia"), che il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, promise avrebbe
messo in piedi un sistema per controllare che la riforma non straripasse in
eccessi puntivi nei confronti della categoria. «Faremo un tagliando», garantì
Orlando. Vale la pena di ricordare sommessamente che due anni fa, ascoltate le
grida di giubilo da una parte, e le terrorizzate lamentele
dall'altra, Panorama sostenne che i magistrati non avevano nulla da temere e che
i politici non avevano nulla da festeggiare, perché nulla in realtà sarebbe
cambiato. Ora siamo arrivati a un primo redde rationem. Eccessi puntivi?
Autonomia uccisa? Risate. A distanza di due anni, purtroppo, i dati danno
ragione al pessimismo di Panorama. Perché è vero che (udite, udite!) sono
aumentate le azioni di responsabilità per "dolo o colpa grave" nei riguardi dei
magistrati, ma il numero delle condanne resta del tutto "insignificante". Il
ministero della Giustizia, dopo i controlli eseguiti in omaggio alla promessa di
Orlando, rivela con evidente soddisfazione che "non si è, finora, verificato il
temuto aumento esponenziale del contenzioso". Ed è proprio il governo a
utilizzare l'aggettivo "insignificante" per descrivere il numero delle condanne:
nemmeno una in tutto il 2015; e una sola condanna d'appello nel 2016.
Dall'entrata in vigore della legge, infatti, è vero che gli esposti sono più che
raddoppiati, passando da 35 (nel 2014) a 70 nel 2015 e a 80 del 2016. Ma la
quota di condanne - tutte non definitive, perché finora parliamo di sentenze di
Corte d'appello e nessuna vicenda è ancora arrivata al giudizio finale - è pari
allo 0,01%. Insomma, la riforma della responsabilità civile si è risolta in una
farsa, forse in un inganno anche peggiore rispetto a quella che era stata varata
nel 1988. I magistrati dell'Anm possono quindi riposare in pace: l'autonomia
della categoria non ha subito alcun attacco, tantomeno l'assalto mortale che
temevano due anni fa. Le toghe restano pienamente, irriducibilmente
"irresponsabili".
Magistrati premiati con stipendi più alti. Anche quelli che
sbagliano tanto, scrive Annalisa Chirico, Martedì
24/01/2017 su "Il Giornale". Ci sono dei numeri che, considerati isolatamente,
non destano sorpresa, ma accostati gli uni agli altri fanno una certa
impressione. La Ragioneria dello Stato ci informa che in dieci anni la
retribuzione media per chi lavora alla presidenza del Consiglio è cresciuta del
45 percento, per i diplomatici del 37 percento, per chi indossa una toga del
28,4. In particolare, rispetto al 2005 la remunerazione dei magistrati è
aumentata, in media, di otre 30mila euro toccando quota 138.481 euro. Com'è
noto, gli stipendi dei magistrati non dipendono dal numero di sentenze prodotte
o di ore trascorse in ufficio, la produttività non c'entra nulla, i loro salari
sono il risultato di automatismi previsti dalla legge. Sulle colonne di
Repubblica compaiono i dati aggiornati relativi ai risarcimenti che lo stato
versa nei casi di ingiusta detenzione ed errore giudiziario. Si apprende che dal
1992 a oggi il ministero dell'Economia ha sborsato 648 milioni di euro per il
carcere ingiustamente inflitto agli innocenti, e 43 milioni per gli errori di pm
e giudici nell'interpretazione di fatti e norme. Se guardiamo soltanto allo
scorso anno, scopriamo che lo Stato - vale a dire noi contribuenti - ha pagato
dieci milioni di euro per risarcire le persone danneggiate da un errore
giudiziario ad opera degli stessi magistrati i cui stipendi nel frattempo sono
aumentati progressivamente. Ammontano invece a trenta milioni gli indennizzi
corrisposti alle vittime di arresti preventivi sproporzionati e ingiusti. In
altre parole, in questi anni sono aumentate le spese per le vittime e
contestualmente si sono gonfiati i salari degli autori degli errori. Vale la
pena notare che mentre i casi di errore giudiziario acclarati nel 2016 sono in
tutto sei (con cifre esorbitanti come i sei milioni e mezzo in un singolo caso a
Reggio Calabria), gli episodi di detenzioni ingiuste che hanno dato luogo al
risarcimento sono quasi settecento. Viene da chiedersi se qualche sanzione sia
stata comminata nei confronti dei magistrati che hanno sbagliato, travisato una
prova, richiesto o autorizzato l'arresto, poi annullato, di una persona
innocente. Sono domande tanto più urgenti alla vigilia dell'inaugurazione
dell'anno giudiziario. Se l'appuntamento annuale non vorrà ridursi a una rituale
sfilata di ermellini ed establishment, sarà bene che i vertici della
magistratura affrontino, senza infingimenti, la stridente anomalia di stipendi
che aumentano al pari dei risarcimenti per errori e arresti facili. Colpisce che
a far emergere i dati sull'entità dei risarcimenti sia stato Enrico Costa,
avvocato appassionato e ministro della Famiglia e degli Affari regionali. «Se
dibattessimo meno di età pensionabile dei magistrati e più di queste profonde
lesioni della libertà personale, non sarebbe male», ha commentato Costa nelle
stesse ore in cui il ministro della Giustizia in carica, Andrea Orlando,
prosegue lungo la via del tenace dialogo con il numero uno dell'Anm Piercamillo
Davigo. Chissà se, tra un discorso e un altro, tra una lamentazione corporativa
e un'altra, il vertice del sindacato delle toghe formulerà una riflessione sul
paradosso di stipendi e indennizzi. Qualcuno dovrebbe chiedergliene conto.
Corruzione, il Consiglio d'Europa all'Italia: "Roma limiti i
giudici in politica". Il Gruppo di stati
anticorruzione (Greco) rende pubblico un rapporto con dodici raccomandazioni
rivolte al nostro Paese, tra cui anche regolare i "conflitti di interessi" dei
politici e salvaguardare l'integrità delle commissioni tributarie, scrive il 19
gennaio 2017 "La Repubblica". Limitare la partecipazione dei magistrati alla
politica. E regolare con norme più stringenti i "conflitti di interessi" dei
deputati. Sono due delle dodici raccomandazioni che il Gruppo di stati contro la
corruzione (Greco), organo del Consiglio d'Europa, ha rivolto all'Italia in un
rapporto dedicato al nostro Paese, approvato il 21 ottobre 2016 ma reso noto
solo oggi. Magistrati. E allora per prima cosa Roma deve introdurre leggi che
pongano limiti più stringenti per la partecipazione dei magistrati alla
politica, e mettere fine alla possibilità per i giudici di mantenere il loro
incarico se vengono eletti o nominati per posizioni negli enti locali. "È chiaro
che la legislazione italiana contiene diverse lacune e contraddizioni a tale
riguardo, che sollevano dubbi dal punto di vista della separazione dei poteri e
della necessaria indipendenza e imparzialità dei giudici" recita il dossier di
Greco. L'organismo afferma che pur "riconoscendo l'indiscutibile reputazione,
professionalità e impegno dei singoli magistrati" è suo compito "segnalare
l'effetto negativo che qualsiasi presunta politicizzazione della professione può
avere sulla percezione che i cittadini hanno dell'indipendenza dell'intera
magistratura". Parlamentari. Quanto ai politici, invece, bisogna che l'Italia
introduca norme "chiare e applicabili" per regolare "la spinosa questione" del
conflitto d'interessi dei parlamentari. Perché, si legge ancora nel rapporto,
"questa situazione insoddisfacente si traduce in un processo piuttosto difficile
di verifica delle possibili cause di ineleggibilità e incompatibilità, che
rischia di compromettere l'efficacia dell'intero sistema". Secondo gli esperti,
infatti, "le regole esistenti sono difficili da applicare" e questo "va a
scapito della complessiva trasparenza e efficienza del sistema". Nel documento
si sottolinea che "l'alto numero di leggi e disposizioni, i relativi emendamenti
e una generale mancanza di consolidamento e razionalizzazione delle norme,
conduce a un quadro confuso del conflitto d'interessi". Questo "crea problemi
per l'applicazione delle regole esistenti e anche della loro comprensione".
Tribunali fiscali. Il Consiglio d'Europa accende un faro anche sui tribunali
fiscali, sottolineando la necessità di applicare più misure e strumenti per
assicurare l'integrità dei membri delle commissioni tributarie, anche a causa
"degli scandali in cui recentemente sono stati coinvolti i componenti non
appartenenti alla magistratura", dice ancora il rapporto. Greco raccomanda
dunque di adottare "misure appropriate per migliorare il controllo sulla
professionalità e l'integrità dei componenti delle commissioni tributarie, con
l'introduzione di un sistema di valutazione periodico e corsi di formazione
regolari anche su questioni etiche e sulla prevenzione della corruzione".
Prescrizione. Greco non manca poi di evidenziare "l'allarmante" numero dei
processi penali non conclusi a causa della prescrizione. Nonostante vengano
riconosciuti gli sforzi italiani - come l'introduzione di sanzioni più dure,
l'ampliamento delle definizioni dei reati, l'istituzione dell'autorità nazionale
anticorruzione - tuttavia vi sono ancora diverse questioni da risolvere, tra cui
"il problema dei tempi di prescrizione dei reati". Una "seria preoccupazione"
già espressa nei rapporti precedenti, per "l'impatto negativo sui casi di
corruzione". Il gruppo d'esperti che ha valutato l'Italia "si rammarica che una
riforma di una questione così cruciale non sia stata ancora attuata".
Il regime di Orlando o il regime di Davigo?
Scrive Piero Sansonetti l'1 Febbraio 2017. C’è una stampa di regime che
fiancheggia il ministro Orlando nella sua crociata contro la magistratura? Lo
sostiene il giornale ufficioso dei Pm – Il Fatto Quotidiano – nell’editoriale
del direttore, pubblicato ieri in prima pagina. Prima di tutto bisognerebbe
capire bene cosa si intende per regime. Il “regime Gentiloni”? O addirittura il
“regime Orlando”? Non credo che ci voglia moltissima fantasia per capire che in
Italia, in questo momento, il rischio politico è il caos e l’ingovernabilità,
non certo il regime. Ci sono almeno tre schieramenti in corsa per vincere le
elezioni politiche (con pari possibilità). E’ il regime del ministro Orlando o
di Davigo e dei maestri dell’Etica? Epoi ci sono un bel gruppetto di partiti e
sottopartiti che cercano un loro spazio, voci di scissioni, di riaggregazioni,
eccetera. Non succedeva esattamente così né nell’Italia di Mussolini né nella
Russia di Breznev. In genere nei regimi c’è una sola lista elettorale che è in
grado di vincere le elezioni (se ci sono le elezioni), non è legale
l’opposizione. Ma allora perché il Fatto, e il suo “vate”, il dottor Davigo, si
ostinano a parlare di regime? Credo che ci siano due ragioni.
La prima è la necessità di difendere una richiesta corporativa dell’Anm
(l’associazione magistrati guidata da Davigo) e cioè l’aumento dell’età della
pensione. Richiesta praticamente indifendibile davanti all’opinione pubblica.
La seconda è una ragione di potere. Se ci fate caso, è quasi sempre così:
quando, in democrazia, si parla di regime, chi ne parla serba in qualche angolo
del suo animo una sua propria aspirazione al regime. O comunque a un forte
aumento del proprio potere. C’è un settore importante – anche se forse non
maggioritario, ma egemone – della magistratura, che si è convinto della
necessità di aumentare il proprio potere. Non è detto che questo desiderio sia
originato semplicemente da ambizioni personali o da fini oscuri; anzi, molto
probabilmente dipende in larghissima parte da un altro fattore: la convinzione
che la società sia corrotta e che sia corrotto lo Stato, e che dunque occorra
una drastica azione di pulizia, e che questa azione non possa essere condotta in
un regime fortemente democratico e di equilibrio di poteri, ma solo in presenza
di un soggetto forte – e cioè la magistratura – che possa agire indisturbato,
che possa far prevalere il sospetto sul diritto, che non debba rispondere a
nessuno. E’ una specie di pulsione autoritaria originata da una spinta etica. E
non è detto che l’aspetto più pericoloso di questo fenomeno sia l’aspetto
autoritario: forse è proprio l’aspirazione all’etica, che in alcuni casi diventa
la culla del fondamentalismo e dell’integralismo.
Nel caso specifico, Davigo e Travaglio contestano al ministro Orlando di volersi
scegliere lui i giudici che gli fanno comodo. Fingendo di non sapere che nessun
Pm e nessun giudice e nessun procuratore o presidente di nessun luogo o grado
della magistratura è nominato dal governo, né in alcun modo il governo, o il
ministro o chi per lui può influenzarne o pretenderne la nomina. In questo caso
la polemica di Davigo e Travaglio è esplicitamente contro il Presidente della
Cassazione, Giovanni Canzio. Per quale ragione? Canzio è un interprete molto
rigoroso del diritto e un difensore dello Stato di diritto, e dunque –
comprensibilmente e legittimamente – non sta molto simpatico a Davigo e
Travaglio, che hanno un’idea diversa di giustizia, abbastanza lontana dallo
Stato di diritto. Ma chi lo ha nominato Canzio? Il Consiglio superiore della
magistratura. E da chi è composto questo consiglio superiore? Lo abbiamo già
detto nei giorni scorsi: per i due terzi da magistrati scelti dagli altri
magistrati secondo le indicazioni (per la verità un po’ partitocratiche o
correnti– cratiche) dell’Anm, cioè del cosiddetto partito dei Pm guidato da
Davigo. Sulla nomina di Canzio il governo ha avuto un peso pari a zero, l’Anm un
peso enorme.
Diciamo che il governo, e Orlando, per ragioni di opportunità e per non lasciare
la Cassazione senza una guida, quando è stato varato il provvedimento sulle
pensioni a 70 anni per i magistrati (che ha fatto infuriare molti magistrati che
in pensione non ci vogliono andare), ha concesso una proroga (non di un
decennio: di un anno!) alle massime cariche in modo da non provocare traumi. Una
proroga ai magistrati nominati dal Csm e scelti dall’Anm! E questa sarebbe
l’ingerenza? E così si metterebbe in discussione l’autonomia della magistratura?
Ma avete una idea vaga di quale sia il potere dei governi, rispetto alla
magistratura, negli altri paesi occidentali, dalla Francia agli Stati Uniti?
Dieci volte superiore al potere dell’esecutivo in Italia. E allora di quale
regime e di quali giornali di regime, si parla? Beh, forse qualche giornale di
regime c’è, se posso fare un paradosso. In qualunque altro paese, dove la stampa
è critica e autonoma, una sollevazione corporativa e scombiccherata come quella
di Davigo e di una parte dell’Anm per ‘ sto fatto delle pensioni, sarebbe stata
massacrata di critiche e di ironia, su tutti gli organi di informazione. Qui da
noi silenzio. Perché la stampa, in larghissima parte, è subordinata alla
magistratura e non osa criticarla o metterla in burla. Tutto qui. (E tuttavia,
anche in questo caso, se parliamo di regime lo facciamo per puro spirito
polemico).
P. S. Nello stesso articolo del “Fatto” del quale riferivamo, c’era un altro
elemento interessante. Si diceva che per mettere in prigione, in Italia, tutti
quelli che se lo meriterebbero, altro che le attuali carceri, “non basterebbero
gli stadi! “. Oddio: Gli stadi? Come faceva Pinochet? Gli sarà scappata,
d’accordo, però certe espressioni, quando scappano…
Orlando: «La magistratura ha in pugno le nostre vite»,
scrive Errico Novi il 19 gennaio 2017 su "Il Dubbio". Nel suo intervento sullo
stato della giustizia, il ministro rivendica l’importanza delle ispezioni sui
magistrati. È una relazione ricca di traguardi raggiunti e obiettivi ancora da
cogliere, quella che il guardasigilli Andrea Orlando ha proposto ieri alle
Camere sullo stato della giustizia. Ma è anche l’occasione per riaffermare
alcuni aspetti decisivi del sistema, a cominciare dall’enorme peso della
magistratura. «La nostra azione è stata rivolta a garantire che i controllori
siano sottoposti ad altri controllori rispondenti soltanto alla legge, nella
piena garanzia del principio di separazione dei poteri», ha affermato il
ministro nei due rami del Parlamento a proposito dell’attività ispettiva di via
Arenula, «e questa vigilanza deve essere tanto più stringente, tempestiva ed
efficace in quanto riguarda poteri in grado di incidere in modo fortissimo e
talvolta persino irreparabile sulla vita dei cittadini». Andrea Orlando affronta
per prima l’aula del Senato. È lì di fatto che apre l’anno giudiziario,
considerato che la relazione al Parlamento letta in mattinata a Palazzo Madama e
poi a Montecitorio, è il primo atto delle inaugurazioni. L’assemblea presieduta
da Pietro Grasso è d’altronde croce e delizia per il guardasigilli, luogo di
confronti «proficui» ma anche di fatale paralisi del ddl penale. E se tra le
obiezioni dell’emiciclo c’è anche un «difetto di franchezza» rilevato da
Corradino Mineo, che pure apprezza complessivamente il ministro, va detto che
Orlando dosa toni secchi e abili perifrasi anche quando parla del peso della
magistratura. Quando cioè all’inizio della sua relazione ne segnala l’immenso
potere e la necessità di controllarlo: «La nostra azione è stata rivolta a
garantire che i controllori siano sottoposti ad altri controllori rispondenti
soltanto alla legge, nella piena garanzia del principio di separazione», dice il
ministro, «e questa vigilanza deve essere tanto più stringente, tempestiva ed
efficace in quanto riguarda poteri in grado di incidere in modo fortissimo e
talvolta persino irreparabile sulla vita dei cittadini». È un passaggio che si
intreccia con ripetuti richiami al populismo penale, all’eccessivo numero di
reati e alla demagogia con cui se ne invocano sempre di nuovi. La cifra del
garantismo e della ricerca di un equilibrio che faccia argine allo strapotere
giudiziario, segna quella che potrebbe essere l’ultima relazione di Orlando da
ministro della Giustizia. Non solo perché non è detto che la legislatura arrivi
fino a gennaio 2018, ma anche perché il leader dei “giovani turchi”, in qualche
accenno, lascia trapelare l’aspirazione a occuparsi di giustizia anche in senso
lato, la necessità di «agire perché non sia fortemente diseguale la ricchezza
della nazione», come dice alla fine delle sue comunicazioni. Obiettivi da
aspirante segretario del Pd più che da guardasigilli. Non a caso, a proposito
del ddl penale, di cui invoca di nuovo l’approvazione in Senato, afferma che se
diverrà legge, determinerà «un passo di qualità che consentirà, al prossimo
ministro della Giustizia, di fare una relazione in cui molti problemi possano
essere considerati alle spalle». Sui magistrati e la necessità di non
tralasciare la vigilanza sul loro operato, il ministro torna più volte, sia
nella relazione sia nelle repliche agli interventi in Aula. Quando parla di
controllori si riferisce in particolare al sistema delle ispezioni, condotte
«senza ricerca di sensazionalismo» e accompagnate da un «monitoraggio
statistico» sulle «performance degli uffici». Sarebbe bene che «il Csm voglia
sempre più affidarsi a simili criteri» nella scelta dei capi degli uffici, «che
deve procedere senz’altro con maggiore speditezza». E dovrebbero essere più
celeri, sostiene Orlando, anche «le pronunce disciplinari» che lo stesso
Coniglio superiore è chiamato a emettere sulla base dell’attività ispettiva di
via Arenula: «Spesso arrivano troppo tempo dopo che è stato segnalato
l’illecito». A proposito di responsabilità civile, il guardasigilli allude a un
possibile effetto deterrenza, invisibile nelle statistiche a quasi due anni
dall’approvazione della riforma: «Ora i magistrati sanno che in caso di
negligenza inescusabile sono sottoposti a valutazione di merito come qualunque
altro cittadino». Ma alla magistratura come a tutti gli altri soggetti chiamati
ad assicurare il servizio giustizia, Orlando rivolge il suo ringraziamento. Lo
fa anche nei confronti dell’avvocatura, che «credo possa salutare con
soddisfazione il completamento dell’attuazione della riforma forense». Agli
avvocati il ministro assicura anche di voler portare fino in fondo l’impegno per
assicurare compensi decorosi pur in un quadro ormai privato da anni delle
tariffe minime: «Ho già mandato un disegno di legge a Palazzo Chigi sul tema
dell’equo compenso: lo ritengo un elemento caratterizzante dell’attività di
governo. C’è ormai una sperequazione inaccettabile nel rapporto tra professioni
e grandi soggetti finanziari ed economici». Ci sono, dice senza mezzi termini il
guardasigilli, delle «compressioni dell’autonomia del professionista dettati da
posizioni dominanti che credo siano da contrastare». Nell’intervento a più
riprese del ministro c’è spazio per la difesa degli interventi compiuti sul
carcere, dei riscontri anche internazionali alla deflazione del contenzioso sia
penale che civile e al diffondersi delle soluzioni alternative al processo (i
passaggi salienti sono riportati in altro servizio, nda) . E non manca l’impegno
a portare al traguardo progetti di legge come la delega sul fallimentare e la
riforma civile, entrambi necessari per «dare sistematicità all’intervento
realizzato finora per via amministrativa e con strumenti normativi diffusi». Ma
è inevitabile che Orlando, soprattutto a Palazzo Madama, insista sui contenuti
del ddl penale: ricorda che il testo sulla prescrizione è «un compromesso
positivo», e che la delega sulle intercettazioni «è necessaria nonostante le
circolari delle Procure vadano nella direzione auspicata: non si può essere
esposti al rischio di usi impropri solo perché nella città dove si vive il capo
dell’ufficio non ha dato le stesse istruzioni». Nella replica non manca di
rispondere sui nodi sollevati dall’Anm con l’annunciata protesta contro il
decreto Cassazione: «Sui termini per i trasferimenti siamo venuti incontro alle
richieste e abbiamo posticipato l’applicazione del nuovo regime quadriennale.
Sulle pensioni, la reazione mi pare eccessiva: è l’unico punto che resta e ora
c’è un presidente del Consiglio diverso». Il che conferma l’impressione che
alcune scelte compiute con Renzi premier siano state concepite a Palazzo Chigi
più che a via Arenula.
Se il totalitarismo è giudiziario,
scrive Pierluigi Battista il 15 gennaio 2017 su "Il Corriere della Sera". A Roma
non si sa dove e quando e come potranno essere collocate le bancarelle dei libri
(che ci sono da sempre, e sono un meraviglioso momento di sosta) perché lo deve
stabilire la magistratura. Nel Texas la Apple è stata messa sotto accusa
giudiziaria perché un automobilista, usando FaceTime mentre era alla guida,
aveva violentemente urtato un’altra macchina provocando la morte di una bambina
che era a bordo. La colpa è di aver inventato la app per le videochiamate senza
la funzione che la disattiva nei veicoli in movimento. Cioè la colpa non è solo
del deficiente criminale che fa videochiamate mentre guida, ma della società che
non ha previsto l’esistenza di un deficiente criminale che guarda dentro al
telefonino ammazzando la gente con la macchina che guida. Intanto in Italia si
stabilisce che le leggi elettorali non le fa il Parlamento ma la Corte
Costituzionale. La quale Corte Costituzionale aveva già deliberato su importanti
provvedimenti di politica economica del governo, come l’intervento sulle
pensioni. Con l’approvazione della legge sulle unioni civili, pare non abbia
molta importanza la disciplina della stepchild adoption perché valuteranno i
magistrati caso per caso. E del resto, l’assenza di una legge sul testamento
biologico demanda alla magistratura anche l’ultima parola sui temi decisivi come
la vita e la morte. La magistratura francese può decidere se a un intellettuale
è permesso di sottolineare i pericoli dell’islamismo politico senza essere
portato in tribunale come «islamofobo». In Italia la magistratura può disporre
il sequestro giudiziario, con conseguenze economiche notevolissime, della
centrale termoelettrica di Vado Ligure mentre in un’altra regione un’altra
centrale identica può continuare a lavorare con gli stessi livelli di
inquinamento accertati dalle autorità sanitarie e ambientali. Cosa ci dice
questa macedonia di casi tanto diversi tra loro? Cosa hanno in comune tutti
questi episodi? Hanno in comune in tutto il mondo lo strapotere della dimensione
giudiziaria su ogni altro aspetto della vita pubblica. La «giuridicizzazione»
radicale e totale dei rapporti sociali, politici, economici, antropologici in
cui si imbatte l’umanità. L’idea che l’ultima parola spetti sempre a un’autorità
giudiziaria. In Italia e ovunque. Vi sentite tranquilli nel mondo del
totalitarismo giudiziario?
Toghe alla
guerra dei privilegi: disertano l'anno giudiziario.
Anm contro il
governo: protesta per pensioni e trasferimenti. Ma è scontro tra le varie
correnti, scrive Anna Maria Greco, Domenica 15/01/2017, su "Il Giornale". L'Anm
accusa il governo di non aver rispettato gli impegni e per protesta diserterà la
cerimonia d'apertura dell'anno giudiziario, il 26 gennaio in Cassazione. Per la
prima volta il «sindacato» dei magistrati non sarà dunque presente tra gli
ermellini nell'Aula magna del Palazzaccio di Roma, luogo finora non investito
dai venti di contestazione perché il dissenso si esprimeva solo alle
inaugurazioni nelle Corti d'appello. Due elementi, nel corso della riunione di
ieri del Comitato Direttivo Centrale, hanno fatto decidere l'associazione delle
toghe a rompere la tradizione: pensioni e trasferimenti dei magistrati. Il
Guardasigilli Andrea Orlando si dice disponibile a discutere, ma ormai è tardi.
«La Giunta aveva condotto con il governo e con il ministro della Giustizia -
spiega il presidente dell'Anm, Piercamillo Davigo - una trattativa per
ricondurre l'età pensionabile, anche se in via transitoria, a 72 anni e a
riportare il vincolo di permanenza dei magistrati di prima nomina da 4 a 3 anni.
Gli impegni non sono stati rispettati, nonostante la dichiarata continuità del
governo attuale con quello precedente». Si riferisce al fatto che è ristretta ad
un pugno di alti magistrati l'ultima proroga per allontanare l'età della
pensione, che l'ex premier Matteo Renzi ha portato per tutti da 75 a 72 anni. E
il suo governo aveva assicurato che almeno sui giovani di prima nomina non
sarebbe pesato l'allungamento da 3 a 4 anni del periodo minimo di permanenza in
un ufficio prima di chiedere un trasferimento, ma non è andata così. Nella base
delle toghe monta un grande scontento, le correnti fanno a gara per raccogliere
le lamentele e ad infervorare ancor più il dibattito ci sono le elezioni al Csm
del 2018 che si avvicinano. Il direttivo dell'Anm è stato già convocato per il
18 febbraio, per valutare altre iniziative prima della conversione in legge del
Milleproroghe. C'è chi preme per lo sciopero, ma finora Davigo ha tenuto insieme
i gruppi. Non senza danni, però, e proprio nella stessa corrente nata attorno al
nome dell'ex star di Mani pulite, Autonomia&Indipendenza. Ieri, infatti, c'è
stato un duro scontro nella riunione tra Davigo e il coordinatore di A&I, che
insisteva sullo sciopero bianco. Lo aveva proposto anche Magistratura
indipendente, l'altra corrente moderata, ma poi ha accettato il compromesso per
consentire un accordo con le correnti di centro, Unicost e di sinistra, Area.
Davigo ha lavorato per mantenere l'unità della magistratura, ma a Pepe la
protesta in Cassazione non bastava. Voleva che A&I uscisse con un suo documento
chiedendo lo sciopero bianco e rompendo di fatto l'unanimità. Il presidente
dell'Anm alla fine si è imposto, nell'associazione e nella sua corrente, ma poi
ha lasciato la seduta prima della fine, molto irritato dallo scontro con il suo
secondo, al vicepresidente di Area Luca Poniz. Anche perché sembra che le liti
con Pepe siano frequenti. La notizia è anche questa, dunque: la neonata corrente
A&I rischia di implodere, per contrasti interni, proprio mentre Davigo si
appresta a concludere ad aprile il suo anno di presidenza dell'Anm.
Pensioni e
trasferimenti, toghe infuriate: il gesto estremo dei magistrati,
scrive “Libero Quotidiano" il 14 gennaio 2017. L’Associazione nazionale
magistrati diserterà la cerimonia, fissata per il 26 gennaio, di inaugurazione
dell’anno giudiziario in Cassazione. È la forma di protesta, approvata
all’unanimità dal direttivo del sindacato delle toghe, adottata dall’Anm per il
"mancato rispetto degli accordi" da parte del Governo sui correttivi, chiesti
dai magistrati, al decreto sulla proroga dei pensionamenti solo per alcuni (tra
cui il presidente e il pg della Suprema Corte, Gianni Canzio e Pasquale Ciccolo)
e sulla legittimazione ai trasferimenti. I rappresentanti dell’Anm
parteciperanno invece alle inaugurazioni dell’Anno giudiziario nelle Corti
d’appello sabato 28 gennaio. Si tratta della prima volta che viene attuata una
protesta delle toghe durante la cerimonia in Cassazione, dove i vertici dell’Anm
non svolgono di regola un intervento ma sono presenti tra gli ospiti nell’Aula
magna di Palazzaccio. Negli anni passati, invece, iniziative di protesta si
erano svolte durante le inaugurazioni nelle Corti d’appello. Il 26 gennaio,
inoltre, il sindacato delle toghe predisporrà un documento che sarà anche
illustrato ai giornalisti con una conferenza stampa e che sarà letto dai
rappresentanti delle sezioni distrettuali dell’Anm durante le cerimonie nelle
Corti d’appello. Sabato 28 gennaio, la Giunta centrale del sindacato delle toghe
parteciperà a una delle inaugurazioni in Corte d’appello, presumibilmente la
stessa a cui prenderà parte il ministro della Giustizia Andrea Orlando. Il
direttivo dell’Associazione nazionale magistrati tornerà a riunirsi il 18
febbraio: in quella sede, discuterà ancora di eventuali iniziative di protesta,
anche alla luce degli sviluppi dell’iter di conversione in legge del decreto
Milleproroghe, a cui il Governo dovrebbe presentare un emendamento per
modificare le norme in materia di legittimazione ai trasferimenti per le toghe.
Il Pm Gratteri: «E' pronta la rivoluzione giudiziaria»,
scrive Piero Sansonetti l'8 novembre 2016 su "Il Dubbio". Il
compito della magistratura è quello di accertare i reati e perseguirli, o è
invece quello di combattere alcune battaglie politiche? Nel luglio del 1948, a
Roma, in piazza Esedra, si tenne una gigantesca manifestazione comunista.
Avevano sparato a Togliatti, che era in fin di vita, e i militanti del Pci erano
furiosi. Sul palco salì per il comizio Edoardo D'Onofrio, dirigente amatissimo,
stalinista di ferro, alle spalle 10 anni nelle carcere fasciste. La gente
cominciò a gridare: «Edo, dacci il là!». Volevano dire: dai un segnale e noi
iniziamo l'insurrezione. D'Onofrio però aveva ricevuto un ordine preciso da
Luigi Longo, il vice di Togliatti: «Niente rivoluzione». E allora rispose alla
folla, scandendo le parole: «Non è questo il momento storico». La rivoluzione
non ci fu, non ci fu la guerra civile (anche se ci furono violenze, scontri
morti e arresti). Togliatti si salvò e la democrazia uscì salva e forte. Beh,
colpisce il fatto che il Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri (che pure non
dà per niente l'impressione di essere comunista) abbia usato esattamente la
stessa espressione: «Ho in testa una rivoluzione sul sistema giudiziario, ma non
è ancora il momento storico». Naturalmente Edo d'Onofrio aveva ben chiaro che
prima o poi la rivoluzione si sarebbe fatta. Poi invece, qualche anno dopo, nel
1956, ci fu la destalinizzazione, e Togliatti lo emarginò. Chissà come andrà a
finire, invece, con Nico Gratteri...Il Procuratore di Catanzaro ha annunciato la
rivoluzione (e il suo rinvio) nel corso di una intervista rilasciata a Lucio
Musolino del "Fatto Quotidiano". È una intervista che inizia con una frase non
nuovissima (per Gratteri) ma sempre abbastanza sorprendente. La trascrivo:
«L'articolato di legge che abbiamo elaborato per aggredire maggiormente
corruzione e mafie è nei cassetti del Parlamento, ma al momento nessuna forza
politica lo ha preso in considerazione». Di che "articolato" si tratta? Gratteri
spiega che si tratta di un vero e proprio disegno di legge, che prevede la
modifica di circa 850 articoli tra codice penale, codice di procedura penale e
ordinamento penitenziario. A occhio croce la riforma riguarda almeno la metà
dell'intero impianto legislativo che riguarda il diritto penale, visto che il
codice penale e il codice di procedura, sommati, contengono attualmente circa
1500 articoli, dei quali però non più di 8 o 900 sono quelli davvero importanti.
Di conseguenza Gratteri ci dice una cosa molto semplice: la sua commissione ha
preparato una riforma radicale della giustizia. Noi non sappiamo bene cosa
intenda Gratteri per rivoluzione giudiziaria, né per "momento opportuno". Certo
sono espressioni molto preoccupanti, specialmente se pronunciate da un
magistrato così potente, così famoso, così importante. Però sappiamo qualcosa
sullo Stato di diritto e sulla separazione dei poteri. E allora ci vengono
alcune domande, alle quali, magari, qualche autorità potrebbe anche rispondere.
La prima domanda è questa: elaborare un articolato di legge non è compito che
spetta al potere legislativo? La stessa Costituzione non prevede una separazione
netta tra potere legislativo e potere giudiziario? E allora, è cosa normale che
un magistrato elabori i disegni di legge? (A me sembra un po' come se si
chiamassero i deputati a fare le sentenze, o almeno a dirigere le indagini
preliminari sui delitti....). La seconda domanda è più spigolosa. La riassumo
così: il compito della magistratura è quello di accertare i reati e perseguirli,
o è invece quello di combattere alcune battaglie politiche? Gratteri parla della
sua intenzione di "aggredire corruzione e mafie", ma è giusto che un magistrato
si ponga l'obiettivo di combattere fenomeni sociali negativi? Non è forse, il
compito di aggredire corruzione e mafia, un compito che spetta alla politica -
sul piano dell'azione legislativa e culturale - e alla polizia sul piano
militare? Non sono domande provocatorie, né sofismi: si tratta di capire quale
sia l'orientamento politico e costituzionale prevalente nelle classi dirigenti
italiane. Se bisogna gratterizzare la magistratura, e anche il Parlamento, sarà
inevitabile porre mano, seriamente, alla Costituzione. Non con la piccola
riforma Boschi, ma con un rivolgimento profondo, che cambi la natura dello Stato
di diritto e ne riduca fortemente i confini. Vogliamo istituire una repubblica
giudiziaria, che sostituisca la Repubblica parlamentare? Discutiamone, se
volete, però bisogna avere il coraggio di dire le cose chiare, non basta sperare
in quella riforma della "Costituzione materiale" che, in realtà, è già
largamente in corso.
Aspettando la Terza Repubblica. Il
saggio di Agostino Giovagnoli «La Repubblica degli italiani 1946-2016» (Laterza)
ripercorre la storia dell’Italia postbellica: il vero «partito della nazione» è
stato la Dc, scrive Andrea Riccardi il 20 ottobre 2016 su "Il Corriere della
Sera". La Repubblica ha settant’anni. Non c’è festa però, anzi — osserva lo
storico Agostino Giovagnoli — tra gli italiani «è diffusa l’insoddisfazione».
Soprattutto per il presente, ma anche per il passato repubblicano, considerato,
per i suoi errori e scelte sbagliate, all’origine dei problemi dell’oggi. Il
debito pubblico appare il monumento degli errori del passato, che pesa sul
futuro. Una storia sbagliata, che non si ama ricordare. Anche perché non è
facile farlo, complessa com’è, con tanti attori e combinazioni: cangiante ma,
alla fine, con una stabilità di fondo. È quanto emerge dal ricco volume di
Giovagnoli, La Repubblica degli italiani 1946-2016, edito da Laterza, che spazia
da De Gasperi «padre della Repubblica» fino al big bang del sistema tra il 1992
e il 1994, alla Seconda Repubblica e a quello che considera l’attuale passaggio
a un nuovo assetto. È una storia, per tanti aspetti, bella e avvincente: non
solo un succedersi di governi fragili né un gioco di alchimie politiche. Leggere
questo volume riconcilia con la nostra storia appassionandoci a essa: gli
italiani sono cresciuti sotto tanti punti di vista. Anche la disaffezione dalla
politica o la protesta sono il frutto di un processo storico per cui gli
abitanti della penisola sono divenuti pienamente cittadini. Non è una storia
sprecata o solo una trama di errori. I primi decenni sono quelli
della Repubblica dei partiti, per usare l’espressione di Pietro Scoppola: si
passa dalla nazionalizzazione fascista delle masse alla partecipazione politica
ed emotiva al destino della nazione attraverso i partiti. In questo quadro si
staglia la Dc, «partito della nazione» (Alcide De Gasperi è il primo a usare
l’espressione): il perno di un sistema di alleanze con un particolare rapporto
con lo Stato. La classe dirigente democristiana, pur nella rapida successione
dei governi, costituisce il presidio della stabilità e della continuità delle
politiche nazionali e internazionali. La tensione, con ostacoli e battute di
arresto, è allargare l’area di governo fino alla solidarietà nazionale con il
Pci. Questo si accompagna a due aspetti rilevanti della Prima Repubblica: da una
parte le ideologie e il dibattito delle idee che permeano la politica e,
dall’altra, il radicamento capillare nella società e la mobilitazione degli
italiani alla politica. In questo processo, Giovagnoli mette in luce il ruolo
della Chiesa, l’istituzione più radicata nel Paese, preoccupata del pericolo
comunista e sostenitrice della Dc. La svolta del Vaticano II scompone il solido
blocco Chiesa-Dc. «Il mondo è cambiato» — scrive l’autore in un denso capitolo
dedicato agli anni Ottanta. «Dalla società agli individui»: è un processo lungo
(dal Sessantotto alla globalizzazione) che mette in discussione identità
organiche e strutture che erano l’architettura della politica. Gli italiani
cambiano prima della politica, tanto che questa, con la caduta del Muro e la
globalizzazione, viene travolta. Sono il discredito dei partiti e la protesta a
travolgerla, quasi una corrente carsica destinata più volte a riemergere e
guadagnare consenso sino a oggi. La domanda è se siano ingredienti bastevoli a
creare un’alternativa. Metà della Repubblica degli italiani è dedicata alla
Seconda Repubblica: «È tramontato, in particolare, il rapporto tra élites e
masse, mediato dai partiti…». Si disarticolano gli «universi politico-culturali»
che, per quasi mezzo secolo, sono stati i pilastri della democrazia: quello
comunista, laico-socialista, cattolico. Quest’ultimo, con il tramonto della Dc,
è destinato a giocare un ruolo con la Cei del cardinale Camillo Ruini per il
rapporto con Silvio Berlusconi e per l’affermazione del ruolo etico-culturale
della Chiesa. Il bipolarismo non ricuce la «persistente frammentarietà» della
politica e porta a «un sistema politico iperconflittuale». Se la Prima
Repubblica, alla luce della storia e nonostante i problemi, non è un «buco nero»
per Giovagnoli, i due decenni successivi sono quasi un interludio. Così crede
l’autore, che dedica pagine acute in una prospettiva storica (tra i primi) a
Berlusconi come un misto di antipolitica, di vecchia politica e d’interessi
anche disparati: il decennio berlusconiano, poi, dal 2001 al 2011, parte nel
clima dello scontro di civiltà dopo l’11 settembre 2001 e si solidifica nel
«bipolarismo etico» del Paese. Nonostante i governi guidati da Romano Prodi
abbiano inciso per varie decisioni e ancoraggio all’Europa, gli anni della
Seconda Repubblica sono dominati dal clima impresso da Berlusconi, anche per chi
gli si oppone. La lunga storia repubblicana, però, non è smarrita. In un certo
senso parla dal Quirinale che, con gli anni Novanta, diventa un’istituzione
cardine della democrazia, perdendo quel carattere notarile e cerimoniale che
l’aveva in parte caratterizzato. Oscar Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio
Napolitano: tre storie personali diverse, ma tutte radicate nella cultura
politica repubblicana, come si vede dai loro richiami e impulsi. Ma non solo:
«Si deve a questi tre presidenti della Repubblica un impegno per contrastare il
ripiegamento provincialistico della società italiana». La Seconda Repubblica ha
rappresentato più una fase di assestamento che il raggiungimento di un nuovo
equilibrio. Agostino Giovagnoli è convinto che questa storia, quella della Prima
e della Seconda Repubblica, non debba essere consegnata però a una damnatio
memoriae: senza conoscerla e senza sentirla come nostra, non si capiscono i
problemi attuali, ci si abbandona a semplificazioni emotive. Per Giovagnoli, dal
2011 siamo oltre il secondo tempo della Repubblica. Il governo Monti è stato una
rottura e una ricollocazione europea dell’Italia. Con Renzi, «molti aspetti
dell’assetto bipolare, prevalsi per un ventennio, sono… definitivamente
tramontati». Sorge, sul crinale del settantennio repubblicano, nonostante le
difficoltà, una voglia di estroversione italiana nel mondo globale, anche se
assediata da problemi e disaffezioni. La domanda è se si possa già parlare di
una Terza Repubblica, anche con un nuovo assetto costituzionale.
Ma quale repubblica parlamentare? La nostra è una repubblica
giudiziaria, scrive il 19 ottobre 2016 Francesco
Damato su "Il Dubbio". Da 24 anni il Parlamento si è piegato al potere togato.
Da quando Scalfaro decise che per formare il governo si doveva consultare il
Procuratore di Milano...È un vero spreco di energie quello che si sta facendo
nella campagna referendaria in difesa della Repubblica parlamentare voluta dai
costituenti e minacciata, secondo gli avversari di Matteo Renzi, dalla sua
riforma. Che farebbe diventare la Repubblica "oligarchica", ha sentenziato il
presidente emerito della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky fra la
sorpresa e le proteste di Eugenio Scalfari, convinto che l'oligarchia, intesa
però solo come "classe dirigente", sia compatibile con la democrazia. In fondo -
si potrebbe dire seguendo il ragionamento filologico di Scalfari - anche il
Parlamento è oligarchico, poco importa se composto di quasi 1000 esponenti, come
oggi, o di 730, come avverrebbe con l'approvazione della riforma. Alternativa
all'oligarchia, sempre secondo il ragionamento di Scalfari, sarebbe la
dittatura, non la Repubblica parlamentare che i critici di sinistra della
riforma sentono minacciata. I critici di destra invece, preferendo la Repubblica
presidenziale, ritengono che nella Costituzione riformata da Renzi rimanga
ancora troppa Repubblica parlamentare, in cui i poteri del capo dello Stato e
del presidente del Consiglio rimangono invariati. Eppure questi stessi critici
di destra, convergendo con quelli di sinistra, accusano Renzi di avere voluto e
portato a casa col cosiddetto Italicum una legge elettorale su misura delle sue
ambizioni di potere: una legge peraltro ch'egli non difende più con
l'ostinazione di qualche mese fa, disponendosi a cambiarla, ma anche prevedendo
che potrebbe essere modificata da interventi della Corte Costituzionale, com'è
accaduto alla legge precedente voluta dal centrodestra. Ma sono proprio sicuri,
a sinistra e a destra, di vivere ancora in una Repubblica parlamentare,
rispettivamente, da difendere o da superare? Né da una parte né dall'altra
sembrano essersi resi conto che da almeno 24 anni, come documenteremo, viviamo
in una Repubblica giudiziaria. Eppure a destra, almeno dalle parti di Silvio
Berlusconi, è sistematico il richiamo al ruolo smisurato assunto dalla
magistratura, alla quale la politica si arrende sistematicamente, anche dopo
essersi proposta, come con Renzi appena approdato a Palazzo Chigi, di
riprendersi il proprio "primato". Il fresco rinvio a dopo il referendum del 4
dicembre della riforma del processo penale dopo le proteste dell'associazione
nazionale dei magistrati parla da solo. Non è soltanto la "società" ad essere
diventata "giudiziaria", come ha lamentato l'ex presidente della Camera Luciano
Violante commentando le recenti assoluzioni, nei tribunali, di troppi politici
condannati invece nei processi mediatici avviati con gli avvisi di garanzia.
Purtroppo è la Repubblica, con le istituzioni di vario livello, ad essere
diventata giudiziaria, senza che la sinistra e la destra, alternatesi al governo
o addirittura associatesi nelle cosiddette larghe intese, abbiano saputo o
addirittura voluto porvi rimedio. Il primo passaggio dalla Repubblica
parlamentare a quella giudiziaria risale al 1992, quando i magistrati di Milano
impegnati nelle indagini sul finanziamento illegale dei partiti protestarono
contro l'ipotesi di una commissione d'inchiesta parlamentare, appunto, su quel
fenomeno generalizzato. Il Parlamento vi rinunciò, dopo avere indagato su tutto:
dalle banane alla mafia, da Sindona alla P2, dalla costruzione dell'aeroporto di
Fiumicino ai soccorsi nell'Irpinia terremotata. Il secondo passaggio lo
indicherei nella decisione di Oscar Luigi Scalfaro, fresco di insediamento al
Quirinale, sempre nel 1992, di estendere al capo della Procura della Repubblica
di Milano le consultazioni per la formazione del primo governo dopo il rinnovo
del Parlamento. Seguì l'anno dopo il rifiuto, sempre di Scalfaro, peraltro ex
magistrato, di firmare un decreto legge approvato dal primo governo di Giuliano
Amato, e contestato dal capo della Procura milanese, sempre lui, per la
cosiddetta "uscita politica", e non solo giudiziaria, da Tangentopoli. Eppure
quel decreto legge era stato varato in una lunghissima riunione del Consiglio
dei Ministri, più volte interrotta per consultazioni fra gli uffici di Palazzo
Chigi e del Quirinale sugli articoli via via esaminati. E sul provvedimento uscì
la mattina dopo un commento positivo di Eugenio Scalfari, prima che arrivassero
il pronunciamento della Procura ambrosiana e l'annuncio del rifiuto del capo
dello Stato di firmare. Il 1993 fu anche l'anno della modifica a tamburo
battente dell'articolo 68 della Costituzione per togliere dalle immunità
parlamentari la richiesta delle "autorizzazioni a procedere" nelle indagini. Ma
già degli indagati eccellenti come Giulio Andreotti, intimiditi dagli umori di
quella che Violante chiamerebbe "la società giudiziaria", avevano votato a
scrutinio palese a favore dei processi a loro carico. Su Bettino Craxi erano
state già buttate monetine, accendini, ombrelli in piazza, e i ministri del
Pds-ex Pci erano usciti dal governo di Carlo Azeglio Ciampi per protesta contro
la Camera -ripeto, contro la Camera, e quindi contro il Parlamento- per avare
concesso a scrutinio segreto non tutte ma solo alcune delle autorizzazioni a
procedere chieste da varie Procure contro il leader socialista. Un cappio infine
era già stato sventolato nell'aula di Montecitorio dai leghisti, che si
sentivano gli interpreti più autentici delle toghe. La musica non migliorò, anzi
peggiorò decisamente l'anno dopo col primo governo del pur garantista Silvio
Berlusconi. Che esordì offrendo il Viminale ad Antonio Di Pietro, il magistrato
simbolo allora delle indagini sui politici. Poi il Cavaliere si arrese ai
leghisti, sempre loro, presenti nel suo governo col ministro dell'Interno
Roberto Maroni e arresisi a loro volta alla protesta corale, con minacce di
dimissioni, dei magistrati della Procura milanese, sempre loro, contro un
decreto legge che limitava il ricorso alle manette durante le indagini
preliminari. Eppure a quel decreto Scalfaro aveva fornito la propria firma senza
fare storie. Ed erano seguite alcune scarcerazioni. Le proteste della Procura
ambrosiana fecero scoprire a Maroni, pur avvocato, parti del provvedimento che
aveva sottoscritto, per sua penosa ammissione, senza rendersene conto. Il
decreto fu lasciato decadere, senza peraltro che Berlusconi riuscisse dopo pochi
mesi ad evitare la caduta del suo governo per mano proprio della Lega sul
terreno già allora scivoloso della riforma delle pensioni, anche se è ancora
opinione diffusa che la causa della crisi fosse stata un avviso giudiziario a
comparire per corruzione: avviso anticipato dal Corriere della Sera e notificato
al presidente del Consiglio mentre faceva col sindaco di Napoli Antonio
Bassolino, che ha rievocato recentemente la vicenda in una intervista a Il
Dubbio, gli onori di casa ai partecipanti ad una conferenza delle Nazioni Unite
sulla lotta alla criminalità organizzata. Per assistere a qualche serio, per
quanto insufficiente, tentativo di liberare la Repubblica parlamentare
dall'assedio giudiziario si sono dovuti aspettare gli anni di Giorgio Napolitano
al Quirinale, dopo che la Procura di Palermo ne aveva clamorosamente violato la
riservatezza garantitagli dalla Costituzione intercettandolo al telefono, sia
pure "accidentalmente", con Nicola Macino, allora indagato e oggi imputato di
falsa testimonianza nel processo in corso da più di tre anni sulle presunte
trattative fra lo Stato e la mafia della stagione stragista. Poi la Procura
resistette alla richiesta di distruggere le intercettazioni, peraltro ritenute
irrilevanti ai fini processuali dagli stessi inquirenti, senza passare per
un'udienza che ne avrebbe potuto compromettere la segretezza. Il buon
Napolitano, per non lasciare compromesse ai suoi successori - come tenne a
spiegare con un comunicato- le prerogative del presidente della Repubblica,
anch'esse minacciate da un esercizio invasivo delle funzioni giudiziarie,
dovette clamorosamente ricorrere alla Corte Costituzionale. Che gli diede
ragione. Ma una rondine, si sa, non fa primavera. Napolitano è ormai un
presidente emerito. E il suo successore è già alle prese con l'ipotesi di
rendere testimonianza pure lui a quello stesso processo, la cui sola durata è
un'enormità. Il riscatto della Repubblica parlamentare dagli assedi giudiziari,
altro che dai presunti assalti di Renzi, deve ancora venire. Non è un caso che
il presidente del Consiglio abbia deciso di portarsi appresso alla Casa Bianca,
per la cena di commiato dal presidente uscente degli Stati Uniti, anche il
magistrato Raffaele Cantone, che come capo dell'Autorità anticorruzione è stato
considerato fra le personalità più rappresentative dell'Italia, accanto a
Roberto Benigni, Paolo Sorrentino, lo stilista Giorgio Armani la sindaca di
Lampedusa Giusi Nicolini, la campionessa paralimpica Bebe Vio, la direttrice del
Cern di Ginevra, Fabiola Gianotti, e l'architetta Paola Antonelli, del Museo
internazionale dell'arte moderna.
RICORDANDO BETTINO CRAXI.
Giornalista horizontal…, scrive Piero
Sansonetti il 5 gennaio 2017 su "Il Dubbio". Panegirici per Davigo, interviste
senza domande, anche il bravo Massimo Gramellini si piega alla cupola del
giustizialismo. Bisogna sparare a zero sui politici, ma l’ossequio al giudice è
un atto dovuto. Sul “Corriere della Sera” è apparso un articolo di Massimo
Gramellini intitolato “Davigo vertical”. È una tipica espressione
spagnola, l’hombre vertical, molto lusinghiera, che indica l’uomo tutto d’un
pezzo, coerente, serio, incorruttibile. Mi è venuto da chiedermi cosa sarebbe
successo se sul “Corriere della Sera” fosse apparso un articolo altrettanto
adorante, e firmato da una delle firme più prestigiose del giornale, rivolto
all’esaltazione di qualche leader politico. Renzi, magari, o Berlusconi, o
Alfano, o Salvini o – al limite – Grillo. Oppure se un panegirico di stile
gramelliniano fosse stato pronunciato in Tv, dedicato a un uomo di governo.
Sarebbe successa l’iradiddio e il malcapitato adoratore avrebbe capito in un
batter d’occhio di essere giunto a fine carriera. Giornalismo horizontal.
L’ossequio al giudice è sempre ammesso. Gramellini invece è solo all’inizio di
una carriera che sarà – ve lo garantisco – di grande, grande successo. Qual è la
differenza tra Davigo e – poniamo – Gentiloni? Come mai se osanni Gentiloni sei
degno di disprezzo e se osanni Davigo sei un giornalista coraggioso? A occhio
non c’è nessuna differenza tra i due: Davigo e Gentiloni sono rappresentanti del
potere, e dunque – vorrebbe una versione forse un po’ antica della deontologia
professionale giornalistica – dovrebbero sempre essere osservati con occhio
critico dai giornalisti, tenuti a distanza, non celebrati. In realtà uno dei due
è molto più potente dell’altro. Davigo ha assunto un ruolo di comando nella
magistratura, fino al vertice dell’associazione magistrati, è un giudice di
Cassazione, ha un ascolto altissimo nei giornali e nelle Tv, ha a disposizione
persino un partito politico, e cioè i 5 Stelle, cosa che – paradossalmente –
Gentiloni neanche si sogna. Davigo decide sulla politica della giustizia molto
più di Gentiloni, è in grado di guidare campagne di opinione che possono
bloccare qualunque provvedimento del governo. E infatti ha bloccato la riforma-
Orlando. Del resto lo ha detto lui stesso, proprio l’altro giorno, all’assemblea
del suo partito di riferimento (i 5 Stelle): «Non entro in politica perché ho
molta più forza se resto fuori». Davigo orienta la magistratura e anche la
politica, e se lui chiede più carcere ottiene più carcere. Influenza le sentenze
dei suoi colleghi e frena i provvedimenti di clemenza. Intimidisce i tribunali
di sorveglianza. Probabilmente Gentiloni sarebbe favorevole all’amnistia o a una
riforma garantista del codice penale. Non può, ha le mani legate da un potere
molto più grande del suo. La risposta alla domanda sul “diritto di ossequio” è
esattamente questa. L’ossequio andrebbe evitato, ma se proprio va reso allora
conviene renderlo al più forte. Il potere politico da anni è in verticale
caduta, e non è strettamente necessario rendergli omaggio. Il potere di un pezzo
di magistratura è in esponenziale crescita, sta allargandosi attraverso una
nuova ferrea alleanza con la stampa e pezzi della Tv, ed è molto pericoloso
opporsi. Un tipo come Davigo – dicono che sia anche permaloso – va tenuto nel
giusto conto. Talvolta, non c’è niente di male: anche i giornalisti possono
accettare di diventare hombre orizontal. Il bello è che ci sono alcuni giornali
che ogni tanto pubblicano le classifiche dei giornalisti subalterni. Il Fatto
Quotidiano, per esempio, li chiama i “lecca lecca”. State pure certi che non
metterà Gramellini nell’elenco. Né metterà lo stesso Travaglio, che l’altro
giorno, intervistando il Pm palermitano Di Matteo, è riuscito a fare una sola
domanda, formulata più o meno così: “Lei ha già risposto a tutte le domande che
avrei voluto farle, prima ancora che io gliele facessi…”. Esempio sfrontato di
giornalista guascone che non guarda in faccia all’intervistato. Del resto poco
prima dell’intervista a Di Matteo, e nella stessa sede (gli stati generali sulla
giustizia tenuti mercoledì scorso a Roma dal movimento 5 Stelle) una giornalista
di Repubblica aveva dichiarato candidamente: «Non posso non unirmi, anche se non
dovrei, all’ovazione per Davigo». Almeno lei ha aggiunto, sottovoce, quelle
quattro paroline: «anche se non dovrei…». Naturalmente non ha nessun senso
parlare di giornalismo di regime. Come non aveva senso farlo qualche anno fa,
quando imperava Berlusconi, non lo ha neppure ora che impera Grillo. Però per
chi fa il giornalista è giusto fare qualche attenzione al fenomeno. Il
giornalismo italiano si sta piegando sempre di più alla cupola del
giustizialismo. Gli spazi per i liberali e i garantisti sono diventati stretti
stretti. Non è il caso di piangersi addosso, però non c’è ragione per
nasconderlo.
25 anni fa
la congiura che lo escluse da palazzo Chigi.
Con una fuga
di notizie infilzarono Craxi, scrive Francesco Damato il 10 giugno 2017 su "Il
Dubbio". Dopo la strage di Capaci e l’elezione in 48 ore di Oscar Luigi Scalfaro
al Quirinale, dove per quindici votazioni avevano inutilmente tentato di
arrivare, con candidature formali o sotterranee, Arnaldo Forlani, Giulio
Andreotti e persino il presidente uscente e dimissionario Francesco Cossiga,
nulla fu più uguale sul piano politico. Terminato di comporre il suo staff al
Quirinale il 4 giugno con la nomina del generale Paolo Scaramucci a consigliere
militare, Scalfaro predispose le consultazioni per la formazione del nuovo
governo: quello di esordio della legislatura nata con le elezioni del 5 e 6
aprile. Ma la prima sfilata delle delegazioni dei partiti davanti al capo dello
Stato terminò il 10 giugno senza altro risultato che la constatazione di un
clima politico irrespirabile, con veti e controveti all’interno e all’esterno
della maggioranza uscente composta da democristiani, socialisti,
socialdemoratici e liberali. Era una maggioranza peraltro troppo risicata per
fronteggiare una difficile situazione economica e un’ancora più difficile
situazione politica nel contesto delle indagini giudiziarie in corso a Milano su
Tangentopoli. Scalfaro non riuscì a venirne a capo neppure moltiplicando le sue
preghiere alla Madonna di Lourdes, dove peraltro si era proposto prima della
imprevista elezione a capo dello Stato di recarsi in pellegrinaggio. Si scusò
della rinuncia esortando gli organizzatori del viaggio a pregare anche perché
lui venisse illuminato. In attesa di un secondo giro di consultazioni formali,
il presidente della Repubblica vide o sentì privatamente un’infinità di amici,
fra i quali i ministri uscenti dell’Interno e della Giustizia: il democristiano
Enzo Scotti e il socialista Claudio Martelli, invitati insieme al Quirinale
formalmente per discutere di un provvedimento in gestazione per intensificare la
lotta alla mafia dopo la strage di Capaci. Ma il discorso scivolò subito sul
tema della formazione del governo. Vuoi su sollecitazione di Scalfaro, come poi
avrebbe raccontato Martelli, vuoi di iniziativa dei due ministri, il capo dello
Stato ricavò l’impressione, a torto o a ragione, che fossero entrambi convinti
di potere insieme tentare la formazione di un governo di decantazione,
scambiandosi i ruoli di presidente e vice presidente, capace di guadagnarsi se
non l’appoggio, almeno la benevola opposizione del Pds- ex Pci guidato da
Achille Occhetto. Informato, non si è mai ben capito se dallo stesso Scalfaro,
col quale aveva allora eccellenti rapporti, tanto da averne sostenuto con la
solita baldanza l’elezione prima a presidente della Camera e poi a capo dello
Stato, Marco Pannella confidò la cosa a Bettino Craxi. Che – convinto di avere
ancora buone carte da giocare per tornare a Palazzo Chigi, da dove riteneva di
essere stato allontanato malamente da Ciriaco De Mita nel 1987, con la storia di
una staffetta con Andreotti prima promessa per l’ultimo anno della legislatura e
poi negata – a sentire Pannella cadde dalle nuvole. Ma di brutto, perché se la
prese subito con Martelli, essendo ancora convinto che Scalfaro gli fosse leale,
come lo era stato al Ministero dell’Interno nei quattro anni di governo da lui
presieduto: tanto leale non solo da avere rifiutato di prestarsi a fare il
governo elettorale offertogli da De Mita, come ho già ricordato qui, ma anche da
avere cercato e trovato una decina d’anni prima negli archivi del Viminale un
documento da tutti negato in precedenza, ma utile alla difesa dei socialisti
finiti sotto processo a Milano per gli attacchi ai pubblici ministeri che
avevano indagato per l’assassinio di Walter Tobagi. Era un’informativa dei
servizi segreti che nel 1980 aveva inutilmente segnalato il pericolo di un
imminente agguato mortale delle brigate rosse al famoso giornalista del Corriere
della Sera, peraltro amico personale del leader socialista. Notizia di
quell’informativa era stata data personalmente a Craxi all’indomani
dell’uccisione del povero Walter dal generale dei Carabinieri Carlo Alberto
dalla Chiesa. Craxi girò la confidenza di Pannella sull’incontro di Scotti e
Martelli con Scalfaro al segretario della Dc Arnaldo Forlani, facendo cadere
dalle nuvole pure lui. Ed entrambi si ripromisero di punire, diciamo così, i due
giovani aspiranti alla guida del nuovo governo o non confermandoli ai loro posti
o lasciandoli proprio fuori. Ma né l’uno né l’altro ebbero poi la voglia di
raccontare come fossero veramente andate le cose, dopo molti anni, ai magistrati
di Palermo che li interrogarono sulle presunte trattative fra lo Stato e la
mafia della stagione stragista. Essi diedero agli inquirenti l’impressione di
essere stati sacrificati perché contrari a quelle trattative, contribuendo così
all’impianto accusatorio del processo contro mafiosi, generali e uomini politici
ancora in corso a Palermo. Ma da cui è stato già assolto, avendo scelto il rito
abbreviato, l’ex ministro democristiano Calogero Mannino, che pure era stato
accusato di essere stato addirittura il promotore della trattativa per
scongiurare una minaccia della mafia alla sua vita.
Non ci fu
tuttavia soltanto l’incidente o l’equivoco della coppia Scotti- Martelli durante
le consultazioni informali di Scalfaro per la formazione del nuovo governo. Ci
fu anche, fra l’altro, una rovinosa fuga di notizie sui documenti pervenuti
dalla Procura di Milano alla Camera, e assegnati subito alla giunta delle
cosiddette autorizzazioni a procedere per Tangentopoli sul conto degli ex
sindaci di Milano Paolo Pillitteri e Carlo Tognoli, entrambi socialisti. Il
“verde”, ed ex direttore del Manifesto, Mauro Paissan fu indicato, a torto o a
ragione, come fonte di quella fuga con interpretazioni troppo estensive di
alcune parti dei fascicoli, da cui avrebbe ricavato, come esponente
dell’apposita giunta di Montecitorio, l’impressione di un coinvolgimento anche
di Craxi nelle indagini chiamate Mani pulite. Ricordo ancora nitidamente quella
giornata in cui le agenzie avevano inondato le redazioni dei giornali di lanci a
dir poco allarmanti sulla posizione giudiziaria del segretario socialista ancora
in corsa per il ritorno a Palazzo Chigi. Nelle prime ore del pomeriggio,
tornando a piedi da casa alla redazione del Giorno, di cui ero direttore,
incrociai per caso in Piazza della Scala Antonio Di Pietro, il magistrato ormai
simbolo di quell’inchiesta che stava demolendo la cosiddetta prima Repubblica.
Allontanata la scorta con un cenno di mano, “Tonino” mi disse che nelle carte
partite da Milano per la Camera non c’erano elementi contro Craxi, di cui lui
parlava volgendo lo sguardo verso la Galleria, cioè verso gli uffici milanesi
del segretario del Psi. E mi preannunciò un comunicato della Procura, che in
effetti fu diffuso dopo qualche ora per precisare che nulla risultava “allo
stato” delle indagini contro Craxi. Il quale tuttavia il giorno dopo si trovò su
tutte le prime pagine dei giornali ugualmente come uno ormai compromesso
nell’inchiesta. Non ricordo se l’ho già riferito ai lettori del Dubbio in altre
circostanze riferendo del biennio “terribile” 1992- 93, ma il clima nei
giornali, ormai di tutte le tendenze, era tale che la sera di quel giorno mi
telefonò l’amico Ugo Intini, portavoce di Craxi, per chiedermi come avessi
deciso di uscire con la prima pagina del Giorno. Alla confidenza che sarei
uscito col titolo sul comunicato di smentita diffuso dalla Procura, che ai miei
occhi costituiva l’unica notizia certa della giornata rispetto a tutte le voci
col condizionale diffuse dalle agenzie, Ugo mi chiese se poteva consigliare al
comune amico Roberto Villetti, direttore dell’Avanti, di chiamarmi. Cosa che
Villetti fece subito, ma non per consultarsi, come si aspettava il povero
Intini, bensì per dissentire fermamente dal modo garantista in cui avevo deciso
di titolare. Rimasi francamente di stucco. Neppure Scalfaro al Quirinale dovette
rimanere convinto del comunicato della Procura milanese se volle parlarne
direttamente col capo Francesco Saverio Borrelli, peraltro figlio di un suo
vecchio collega ed amico. L’impressione che ne ricavò l’uomo del Colle fu di
paura di mandare a Palazzo Chigi un “amico” – quale ancora egli considerava il
suo ex presidente del Consiglio – destinato prima o dopo ad essere davvero
coinvolto nelle indagini, come avvenne a fine anno con i primi avvisi di
garanzia, e poi anche con richieste di arresto. Lo stesso Craxi mi raccontò di
essersi sentito dire da Scalfaro all’incirca così: “Tu sai quanto ti stimi e ti
voglia bene, ma è opportuno, anche nel tuo interesse, che tu faccia un passo
indietro in questo momento. Dimmi tu stesso il nome di un socialista al quale io
possa dare l’incarico”. E il 10 giugno, nel secondo ed ultimo giro di
consultazioni, Craxi maturò la decisione del doloroso passo indietro. Che
annunciò personalmente all’uscita dall’ufficio del capo dello Stato dicendo di
avergli indicato “in un ordine non solo alfabetico” Giuliano Amato, già ministro
con De Mita e suo sottosegretario a Palazzo Chigi, Gianni De Michelis e Claudio
Martelli. La delegazione della Democrazia Cristiana, ricevuta per ultima, non
ebbe così neppure la possibilità di proporre Craxi, contro la cui destinazione
si erano già espressi nel partito alcuni esponenti, fra i quali De Mita,
convinti che Palazzo Chigi spettasse ancora alla Dc, nonostante il ritorno di un
democristiano al Quirinale dopo il movimentato settennato di Cossiga.
Pertanto fu
Amato l’uomo al quale Scalfaro diede l’incarico, che fu espletato con una certa
difficoltà, avendo impiegato il nuovo presidente del Consiglio una decina di
giorni, sino al 28 giugno, per la definizione del programma e soprattutto della
lista. Dove Scotti risultò spostato dal Viminale alla Farnesina, che formalmente
era una promozione, da lui però rifiutata perché Forlani aveva deciso di
sperimentare dentro la Dc la incompatibilità fra le cariche di ministro e di
deputato o senatore. Scotti reclamò inutilmente una deroga per conservare il
mandato parlamentare, che alla fine preferì alla guida della diplomazia
italiana. Martelli invece entrò nella lista all’ultimo momento, dopo essere
andato da Craxi, su suggerimento dello stesso Amato, per chiedergli di essere
confermato al Ministero della Giustizia, come poi mi avrebbe raccontato lo
stesso Craxi, per portare a termine il lavoro svolto col povero Giovanni
Falcone, suo prezioso collaboratore sino alla morte – e che morte – come
direttore degli affari penali del dicastero di via Arenula. E Craxi acconsentì,
parendogli – mi disse – “una richiesta umanamente ragionevole”, lungi forse
dall’immaginare che Martelli fosse destinato pure lui dopo qualche mese ad
essere investito da Tangentopoli e costretto alle dimissioni. Comunque, Martelli
fu l’ultimo ministro e il primo governo di Amato l’ultimo sul quale il leader
socialista riuscì a dire la sua, perché di fatto in quel mese di giugno di 25
anni fa al falconicidio col sangue, preceduto dall’ostracismo in vita
praticatogli da tanti colleghi, seguì il craxicidio senza sangue.
I rapporti di
Craxi con Scalfaro rimasero buoni ancora per poco. Col procedere delle indagini
e del linciaggio politico da cui pochi lo difesero, neppure quando subì il
famoso lancio di monetine e insulti davanti all’albergo romano dove abitava, e
donde usciva per andare ad una trasmissione televisiva dopo essere scampato a
scrutinio segreto ad alcune, le più gravi, delle autorizzazioni a procedere
chieste contro di lui dalla magistratura, il leader socialista si fece del
presidente della Repubblica l’idea da lui stesso espressa in una serie di
litografie raffiguranti falsi “extraterrestri”: finti inconsapevoli del
finanziamento generalmente illegale della politica e delle forzature con le
quali la magistratura aveva deciso di trattarlo. Oltre a Scalfaro, furono
definiti extraterrestri anche Achille Occhetto, Eugenio Scalfari, Giorgio
Napolitano e l’ormai compianto Giovanni Spadolini, la cui foto fu sostituita con
un manifesto bianco listato a lutto. Craxi stesso mi raccontò nel suo rifugio di
Hammamet di avere scritto più volte al presidente della Repubblica, anche come
presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, contro gli eccessi che
stavano compiendo i magistrati, ma di non avere mai ricevuto una risposta, né
diretta né indiretta. Il Quirinale non lo considerò più degno di riconoscimento
alcuno. Ci vollero del resto la morte di Craxi e l’arrivo sul colle più alto di
Roma di Giorgio Napolitano perché un presidente della Repubblica parlasse di lui
riconoscendone il servizio politico reso al Paese e lamentando, fra le solite
proteste dei manettari in servizio permanente effettivo, irriducibili anche di
fronte alla morte, “la severità senza uguali” con cui era stato trattato dalla
magistratura. Proprio alla magistratura, vantando di averne fatto parte,
Scalfaro nel suo discorso di insediamento, pronunciato il 28 maggio a
Montecitorio, davanti alle Camere in seduta congiunta con la partecipazione dei
delegati regionali, aveva chiesto “energia, serenità e perseveranza” parlando
della “questione morale”. Di energia e perseveranza sicuramente i magistrati si
dimostrarono capaci nei mesi e negli anni successivi. Di serenità, francamente,
un po’ meno, nella sostanziale e incresciosa disattenzione proprio di chi
l’aveva reclamata insediandosi al vertice dello Stato sull’onda peraltro di una
strage neppure citata per luogo e per nomi nel discorso alle Camere, essendosi
Scalfaro limitato a parlare di una “criminalità aggressiva e sanguinaria”, forse
aiutata anche da qualche mano straniera. Di cui nessuno, a dire il vero, aveva
avuto sentore a Capaci e dintorni.
Di Pietro
inflessibile: «Totò Riina? Merita di finire i suoi giorni in carcere».
A
Cartabianca il duello con l’ex collega del pool Mani pulite Gherardo Colombo,
scrive l'8 giugno 2017 "Primo Piano Molise”. Solo poche ore prima a Cartabianca
su Rai3 Antonio Di Pietro aveva scandito e quasi urlato: «Riina ancora poche
settimane fa andava in dibattimento, è capace di intendere e di volere e deve
stare in galera per quello che ha fatto». Ieri mattina l’Ansa ha battuto questo
lancio: «Totò Riina è collegato in videoconferenza dal carcere di Parma con il
tribunale di Firenze dove poco fa si è aperta l’udienza per il processo davanti
alla Corte d’Assise d’Appello di Firenze per la strage del treno 904. Il boss,
che segue l’udienza disteso su una barella, è imputato come mandante della
strage che il 23 dicembre 1984 causò 16 morti e 260 feriti sul convoglio
Napoli-Milano…». Nel programma di Bianca Berlinguer il duello fra Di Pietro e il
suo ex collega nel pool di Mani Pulite Gherardo Colombo sul caso che sta
infiammando il dibattito in Italia. Su ricorso dei difensori del boss di Cosa
Nostra, che sta scontando l’ergastolo a Parma in regime di 41 bis, la Cassazione
ha stabilito che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna dovrà riesaminare la
richiesta di scarcerazione per motivi di salute. Dovrà rimotivare il diniego
espresso con l’ordinanza impugnata, fin qui gli ermellini. Anzi, non proprio.
Perché i supremi giudici hanno riaffermato alcuni principi nella massima: il
diritto a una morte dignitosa e il fatto che le condizioni di salute del capo
dei capi gli impediscono di comandare ancora. In dettaglio, ferma restando
l’altissima pericolosità del boss e del suo indiscusso spessore criminale, per i
giudici ermellini il provvedimento non chiarisce come tale pericolosità possa e
debba considerarsi “attuale” in considerazione della sopravvenuta precarietà
delle condizioni di salute e del più generale stato di decadimento fisico di
Riina. Su Rai3 Colombo ha evidenziato l’aspetto dell’umanità della pena,
principio cardine non solo della Costituzione ma anche dalla Carta universale
dei diritti dell’uomo, e della dignità. Principi per la cui applicabilità non si
può fare distinzione in base al caso concreto, ha evidenziato. Sulla
pericolosità sociale effettiva, il primo match con Di Pietro. Da valutare per
Colombo, come pure lo stato di salute. «Che c’azzecca», ha replicato invece Di
Pietro, secondo il quale la pericolosità sociale va appurata in caso di misure
cautelari e non di pene definitive. «È tanto tempo che fai altro – la stoccata
di Colombo – e magari non lo ricordi, ma l’articolo 147 del codice di procedura
penale dice che è consentita l’esecuzione differita della pena quando una
persona si trovi in gravi condizioni di salute. Le regole sono regole, se
facciamo finta che non ci siano quando non ci piacciono…». È consentita, la
replica dell’ex ministro molisano, ma «non è necessaria di fronte a un criminale
di tale spessore». E poi Riina «non si è pentito, non ha chiesto perdona, non
intende tornare indietro su quello che ha fatto, è una persona che merita di
finire dignitosamente in un ospedale, in una struttura carceraria diversa da
Parma». Di Pietro, inoltre, non crede al fatto che non sia più pericoloso. «Fino
a un anno fa è stata ripresa la sua voce che minacciava ancora. Ed allora è bene
che finisca lì i suoi giorni. Una cosa è la dignità, altra cosa è rimetterlo in
libertà per la dignità. Anche Provenzano è morto in carcere». Anche nel pool
discutevano così? Di Pietro: «Le posso assicurare di sì con Davigo che si
metteva in mezzo e dava torto a tutti e due…». Chi ha vinto il duello? Di
Pietro: 64% contro il 36 di consenso per le posizioni di Colombo.
Colombo vs
Di Pietro, tornano i «Ragazzi irresistibili» di Mani Pulite.
Mentre Sky
trasmette la serie 1993, a Cartabianca i due ex pm che di quella stagione sono i
simboli duellano su Riina come in una sitcom di successo. Raitre potrebbe
puntare su di loro per elaborare il lutto di Gazebo, scrive Lia Celi l'8 giugno
2017 su "Lettera 43". Ai tempi di Hegel la Storia si presentava prima come
tragedia poi come farsa. Ai tempi di Sky e Netflix, la scelta di generi in cui
la Storia può presentarsi è molto più ampia, specchio di un pubblico ben più
esigente e raffinato. Recentemente, per esempio, la Storia si è presentata in
tivù prima come serie drammatica e poi come sitcom: nel giro di pochi giorni
abbiamo visto su Sky Atlantic 1993, lo sceneggiato che rievoca gli eventi
dell’annus horribilis delle stragi mafiose e della discesa in campo di
Berlusconi e, a Cartabianca su Raitre, la reunion della coppia Antonio Di
Pietro-Gherardo Colombo, i dioscuri togati del pool Mani Pulite evocato in 1993,
impegnati in quello che speriamo sia solo il promo di una serie comico-brillante
in programma per la prossima stagione. Lo spunto è preso di peso dai Ragazzi
irresistibili, un classico della commedia portato sugli schermi da Walter
Matthau e George Burns: due vecchi colleghi-rivali sulla scena, incanutiti e
spelacchiati, si ritrovano in uno studio televisivo per riproporre il vecchio
sketch dei due giudici. Ed è subito scontro di caratteri, Colombo bisbetico e
rancoroso come Matthau e Di Pietro finto-condiscendente come Burns. Il tema era
la sorte di Totò Riina dopo la sentenza della Cassazione sul suo diritto a una
morte dignitosa. Colombo, dopo avere scaldato i motori brontolando con Bianca
Berlinguer per il ritardo nel collegamento, ha bisticciato con l’ex compagno di
Pool: lui, austero e garantista, citava la Costituzione che prescrive umanità e
dignità nel trattamento dei detenuti, mentre Di Pietro dietro il sorriso placido
è ancora il babau con le manette in tasca che 25 anni fa teneva sulla scrivania
del suo ufficio Delitto e castigo per intimidire gli indagati. Scintille e
frecciate, ma tempi comici perfetti, con Bianca Berlinguer nel ruolo di spalla e
il pubblico con i lucciconi nel rivedere insieme i supereroi senza macchia e
senza paura della sua giovinezza, anche in versione vecchietti stizzosi. Dopo la
fuga di Gazebo, Raitre ha un disperato bisogno di idee per nuovi programmi, di
format stimolanti e di qualità in grado di ricondurre all’ovile generalista il
gregge di spettatori disperso fra mille canali: una sitcom con Di
Pietro-Colombo-Berlinguer farebbe uno share che Zoro se lo sogna. Per non
parlare di Cartabianca.
Gherardo e
Tonino, il pensatore e il poliziotto,
scrive Paolo Delgado l'8 giugno 2017 su "Il Dubbio". Un solo pool (Mani Pulite),
due concezioni opposte della giustizia: riflessivo, schivo e un po’ nell’ombra
il primo, impulsivo, istrionico e pittoresco il secondo. Quando il pool Mani
pulite era la squadra più popolare e amata d’Italia Antonio Di Pietro e Gherardo
Colombo ne incarnavano le polarità opposte. Impulsivo, istrionico e pittoresco
il primo, riflessivo, schivo e un po’ nell’ombra il secondo. Solo a vederli
passare nei corridoi del palazzo di giustizia di Milano, seguiti da una ressa di
cronisti senza precedenti, si coglievano al volo i segni delle diverse
biografie. Da una parte l’ex ragazzo di Montenero di Bisaccia emigrato in
Germania, poi poliziotto, approdato infine in una magistratura ancora marcata da
una precisa impronta di classe, che lo considerava quasi un intruso. Dall’altro
il ragazzo di buona famiglia di Briosco, con alle spalle il percorso canonico:
liceo classico, laurea in Giurisprudenza alla Cattolica, cursus honorum in
magistratura. Di Pietro, con la sua inflessione dialettale che aveva saputo
rovesciare trasformando una potenziale debolezza in marchio personale, sembrava
un alto funzionario di polizia. Colombo, spesso in maglietta, sempre spettinato,
una specie di eterno studente. Ma non di quelli sprovveduti. Quando nella
primavera del 1992 il procuratore Borrelli decise di affiancarlo a Di Pietro
nell’interrogatorio di Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, aveva
già alle spalle un’inchiesta di quelle che fanno storia: la P2 e il delitto
Ambrosoli. Chiesa era il capo di una fune che i magistrati milanesi avrebbero
seguito sino ad addentrarsi nel labirinto di Tangentopoli. Se nel pool c’erano
divisioni nessuno se ne accorse. Ma la differenza di approccio era lo stesso
chiara. Di Pietro era un mastino che dava la caccia ai presunti colpevoli usando
ogni mezzo, inclusa una notevole astuzia, ma senza preoccuparsi troppo di
scandagliare il fenomeno in profondità. Colombo già alla fine del ‘ 92 aveva
capito che di un fenomeno così esteso e pervasivo non sarebbe stato possibile
venirne davvero a capo solo con gli arresti e i processi. Fu lui a insistere per
la proposta di ‘ soluzione politica’ avanzata poi dall’intero pool: una sorta di
condono in cambio dell’ammissione di responsabilità. Sarebbe stata un modo per
far emergere anche tutto quel versante del sistema delle tangenti che, come
avrebbe poi ammesso lo stesso Di Pietro, rimase sostanzialmente impunito, il
fronte non dei corrotti ma dei corruttori. Vent’anni dopo, tracciando un
bilancio, Colombo era più che mai convinto che quelle indagini non fossero
servite a molto «dal punto di vista giudiziario» e che anzi fossero state
«paradossalmente un danno». Mani Pulite, a suo parere, era stata sì fondamentale
ma su un altro fronte, quello dell’informazione, perché aveva messo a nudo e
reso noto al Paese l’esistenza di un vero e proprio sistema. Dopo Tangentopoli
Colombo ha continuato per oltre un decennio a investigare sulla corruzione. Si è
occupato del processo Imi/ Sir, del lodo Mondadori e dell’intervento di Previti
in quella vicenda, affrontata corrompendo i giudici. Nel 2005 è diventato
Consigliere presso la Cassazione ma meno di due anni dopo, con quasi 15 anni di
anticipo sulla pensione, ha scelto di lasciare la magistratura. Forse lo avrebbe
fatto anche prima se non avesse scelto di aspettare l’esito di tutti i casi in
cui era stato coinvolto, o per procedimenti disciplinari o per imputazioni
varie. Ne è uscito sempre assolto e anzi uno di questi processi, la causa per
calunnia intentata contro Licio Gelli, gli ha fruttato un cospicuo risarcimento
in oro da parte dell’ex venerabile subito devoluto alle nonne argentine di Plaza
de Mayo e ai familiari delle vittime della strage di Bologna. Colombo ha
lasciato la toga, non ha dimenticato i nodi della Giustizia. Ha continuato a
occuparsene scrivendo libri, incontrando gli studenti di innumerevoli scuole, e
il tema è rimasto al centro delle sue riflessioni anche quando è diventato
presidente della Garzanti e poi membro del cda Rai. Perché il giudice Colombo, a
differenza di troppi altri magistrati, non ha mai inteso la giustizia solo come
un’eterna caccia al colpevole. Si è interrogato invece sulla funzione della
pena, sulla cultura diffusa che vede nella pena una sorta di vendetta. Le
conclusioni a cui è arrivato sono radicali: «Ero uno che mandava le persone in
prigione convinto che fosse utile. Ma da oltre 15 anni ho iniziato un percorso
che mi porta a ritenere errata quella convinzione. I penitenziari sono
inefficaci, se non dannosi per la società. Anziché aumentare la sicurezza, la
diminuiscono». Alla concezione attuale della giustizia, che considera
«retributiva», basata cioè sul retribuire i danneggiati con la sofferenza di chi
ha provocato il danno, suggerisce di sostituire una visione invece «riparativa»,
fondata sul compensare la vittima e allo stesso tempo sul rendere il colpevole
cosciente della propria responsabilità. Idee che, nell’Italia quale emerge dalle
reazioni alla sentenza della Cassazione su Riina, devono sembrare più o meno
come deliri. La differenza emersa nel corso di Cartabianca tra lui e l’ex
compagno di pool Di Pietro a proposito dell’eventuale concezione dei domiciliari
a Riina non è tra due diverse idee del rispetto delle garanzie e tanto meno tra
buonismo e severità ma tra due concezioni della giustizia. In termini etici e
forse ancora di più di efficacia reale.
Filippo Facci
per Libero Quotidiano l'8 giugno 2017. Che cosa li teneva insieme, all'epoca?
Magari la scena l'avete vista, l'altra sera: Antonio Di Pietro e Gherardo
Colombo che battibeccano in tv a "Cartabianca" su Raitre (l'argomento non conta)
con Di Pietro a ricordare che in realtà "litigavano anche allora" (durante Mani
pulite) e che a fare da paciere era uno come Piercamillo Davigo, figurarsi.
Bene, come non intravederci una metafora di Mani pulite? Meglio: come non
chiedersi che cosa unisse personaggi così diversi, se non una cieca
determinazione nel puntare l'avversario attraverso quelle guerre lampo che
Francesco Saverio Borrelli, il capo della procura, definiva "Blitzkrieg"?
Avversario che, dapprima, poteva essere Craxi e il Psi, poi l'intera Dc che si
sciolse assieme ai vecchi partiti, poi imprenditori selezionati modello Gardini,
infine e soprattutto Silvio Berlusconi. Lo schema può sembrare tirato per i
capelli, ma a vedere quei due tizi canuti e spazientiti che bisticciavano,
l'altra sera, veniva proprio da chiederselo: potrebbero mai lavorare insieme,
due così? Che cosa potrebbe unirli? Che cosa li teneva insieme? La risposta
risiede nella più formidabile coalizione che l'Italia del Dopoguerra possa
ricordare: quella contro Berlusconi. Per il resto, agli albori di Mani pulite,
nel 1992, il primo ad avere dubbi su Di Pietro fu proprio Gherardo Colombo,
archetipo dell'intellettuale appartenente a una sinistra esistenziale in cui i
migliori dovessero sbaragliare prima o poi i peggiori. Era, lui, quello dello
scandalo dei fondi neri Iri e della P2, svagato, i jeans stinti, la Lacoste, le
scarpe da vela consumate, la pipa e poi le sigarette, il circolo Società civile,
oltre a una fisiologica repulsione per i magistrati traffichini e invischiati
col potere: chiaro che Di Pietro non gli piaceva. All'alba di Mani pulite,
Colombo non voleva saperne di Di Pietro, no: il molisano aveva la fama che aveva
e comunque sperava che gli potessero affiancare Piercamillo Davigo, che aveva
già conosciuto. Borrelli, dapprima, preferì Colombo anche per controllare meglio
Di Pietro, per quanto Colombo, appunto, si fosse mostrato perplesso. Di Pietro
aveva ricambiato i dubbi, peraltro. Ma Davigo, tempo un paio di mesi, arriverà
lo stesso, e troveranno un accordo come Di Pietro annoterà in un suo libro: «Io
andavo da Davigo o da Colombo e segnalavo un'operazione che mi puzzava. "Vedi
che cosa è successo qui? Questo secondo me è un reato di porcata... Cari Davigo
e Colombo, dicevo, cavoli vostri, entro domattina trovate una soluzione che dal
punto di vista giuridico non faccia una piega, perchè devo procedere"». Voglio
metterlo dentro: il modo trovatelo voi. Sta di fatto che Colombo potè occuparsi
in prevalenza di quelle rogatorie internazionali che tanto l' appassionavano, ma
non solo: il suo ruolo sarà essenziale nello stilare la legislazione materiale
di Mani pulite, quel rito ambrosiano fatto di carcere facile, libertà per chi
confessa e incolpa altri, patteggiamenti come regola, verbali utilizzati come
fonti di prova, benedizione di un nuovo Codice ormai ridotto a brandelli e
contro il quale, non a caso, sia lui che Davigo dapprima si erano detti
contrari. Insomma, si divisero i ruoli. Davigo, finché furono previste, perdette
tutto il suo tempo a stilare richieste di autorizzazione a procedere per
parlamentari. Quando il Parlamento tentò di varare il decreto Biondi per
limitare le carcerazioni (estate 1994) Colombo fu in prima fila nel redigere il
documento che poi Di Pietro, il testimonial ufficiale del gruppo, lesse davanti
alle telecamere. Poi finì come finì: la sinistra venne recepita come "salvata",
la missione salvifica dei magistrati milanesi si riversò a collo di bottiglia
verso quel Silvio Berlusconi verso cui tanti italiani (molti più del previsto)
avevano deciso di riporre nuove speranze. Per dirla con Di Pietro: l'acqua non
arrivò più al mulino. E l'acqua era il carcere, l'uso smodato del carcere come
strumento d' indagine. Mani pulite finì: e i caratteri, le velleità e le
differenze tornarono a stagliarsi. Di Pietro col suo giro politico dell'oca, le
sue ambiguità che in breve gli bruciarono quasi tutti i consensi. Colombo e
Davigo a ricominciare da dov' erano rimasti, ma dall' alto di un potere togato
incredibilmente accresciuto. Le carriere si divisero. Solo l'avversario rimase
identico.
Storia
dell’amnistia da Togliatti ai giorni di Tangentopoli,
scrive Massimo Lensi il 14 Aprile 2017 su "Il Dubbio". La chiedevano i Papi, ci
aiutò a uscire dal fascismo, Marco Pannella ne ha fatto per anni il suo campo di
battaglia, ma dopo Mani Pulite è scomparsa dall’orizzonte politico e culturale
italiano. A Pasqua si terrà a Roma la Quinta marcia per l’Amnistia, organizzata
dal Partito Radicale. Marco Pannella coniò un’efficace espressione per spiegare
l’importanza della clemenza. Egli la invocava per la Repubblica, per rientrare
nella legalità e porre fine alle violazioni della Costituzione nella gestione
del sistema penitenziario, nella durata dei processi, nell’utilizzo della
prescrizione nascosta conseguente all’applicazione discrezionale
dell’obbligatorietà dell’azione penale da parte dei magistrati. “Amnistia per la
Repubblica” era lo slogan di Pannella. La storia dei provvedimenti di clemenza
di un Paese racconta, infatti, più cose di quanto si possa immaginare.
L’amnistia e l’indulto – a volte anche il provvedimento di grazia – sono atti
politici a tutto tondo. La clemenza porta sempre con sé un’attenzione
particolare ai rapporti tra Stato e magistratura, tra esecuzione della pena e
reinserimento sociale, tra eventi di particolare rilievo e opinione pubblica, ed
è accompagnata sempre da una tendenza a un particolare intento di riscrittura
della storia, riscontrabile nei dispositivi legislativi: accertare la verità,
farla dimenticare o renderla del tutto illeggibile. Stéphane Gacon nel suo libro
“L’Amnistie” (2002) classificava la clemenza di Stato in tre tipologie
differenti: l’amnistia perdono, atto di generosità tipico dei regimi totalitari;
l’amnistia- rifondazione, che interviene per riunificare un Paese diviso;
l’amnistia- riconciliazione che segue la fine dei regimi dittatoriali. L’Italia
repubblicana ha concesso una trentina di provvedimenti di clemenza, tra amnistie
e indulti. L’ultima amnistia è del 1990, mentre nel 2006 fu approvato l’ultimo
indulto. Terminate le drammatiche vicende politiche e militari che portarono
alla caduta del regime fascista, lo strumento dell’amnistia fu utilizzato tra il
1944 e il 1948 per vanificare la vigenza della normativa penale del regime,
il codice Rocco, nei confronti dei delitti politici commessi durante la
Resistenza, o nel periodo successivo. E’ interessante notare come, all’epoca, il
tentativo del legislatore fu di chiudere con il periodo dittatoriale e la sua
legislazione penale, al fine di far nascere lo stato “nuovo” e far sì che questo
trovasse in sé la propria legittimità giuridica e non nelle leggi dello Stato
precedente. Un tentativo che, però, rimase tale. Per Piero Calamandrei, infatti,
mancò sul terreno giuridico della forma “lo stabile riconoscimento della nuova
legalità uscita dalla Rivoluzione”. Ed è altrettanto vero che i provvedimenti di
amnistia di quel periodo ebbero in comune una natura delegittimante nei
confronti della Resistenza, in quanto le azioni commesse durante la lotta
antifascista vennero considerate alla stregua di reati comuni, anche se motivati
da eccezionali contingenze. Si restava a tutti gli effetti all’interno del
recinto dell’art. 8 del codice penale, che definisce come delitto politico:
“ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto
politico del cittadino. È altresì considerato politico il delitto comune
determinato in tutto o in parte da motivi politici”. Il decreto presidenziale n.
4/ 1946, conosciuto con il nome di “amnistia Togliatti”, all’epoca guardasigilli
della Repubblica, tentò di consegnare all’oblio non solo i reati connessi
all’attività partigiana, ma anche i reati legati alla collaborazione con
l’esercito tedesco di occupazione, pur con numerose eccezioni e sollevando
numerose polemiche. L’uomo dalla stilografica con l’inchiostro verde (cioè
Togliatti) scommise sul futuro per mettere fine a un possibile ciclo di rese dei
conti, ma fu accusato, in nome della sua proverbiale “doppiezza”, di aver aperto
le porte del carcere ai fascisti e ai repubblichini imprigionati subito dopo la
Liberazione. Sta di fatto che, forse anche a causa di un’interpretazione
distorta del testo del decreto (scritto, invero, con un linguaggio giuridico
assai poco limpido), tra i 7061 amnistiati, 153 erano partigiani, e 6.908
fascisti. Negli anni ’ 50 e ’ 60 i provvedimenti di clemenza furono nove, di cui
cinque strettamente connessi sia a fatti politici legati alla scia lunga del
dopo- guerra, sia ai movimenti della fine degli anni ’60, con l’attribuzione di
reati commessi in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche e
sindacali (amnistia del ’ 68). Tutti e cinque questi provvedimenti comportarono
la concessione sia di amnistia, sia di indulto. Il primo fu nel 1953 (7.833
amnistiati) e l’ultimo nel 1970 (11.961 amnistiati); gli altri furono concessi
nel 1959 (7.084 amnistiati), nel 1966 (11.982 amnistiati) e nel 1968 (315
amnistiati). Dopo il 1970 non ci furono più amnistie per fatti politici.
L’amnistia del ’ 68 fu particolarmente importante perché ebbe come oggetto
esclusivamente reati politici e sociali. Il senatore Tristano Codignola del
Partito Socialista nel presentare il provvedimento al Senato disse: “Appare
quindi evidente che, nell’interesse stesso della democrazia, nell’accezione
aperta e progressiva voluta dalla nostra Costituzione, occorre procedere di pari
passo alla realizzazione di profonde riforme strutturali e alla creazione di un
clima maggiormente democratico ed antiautoritario nel Paese”. Con l’amnistia del
’ 68, si chiuse finalmente il ciclo legato alla guerra di Liberazione, si aprì
però il capitolo che precedette gli anni di piombo. E per la prima volta nel
1970 fecero capolino nell’amnistia il riferimento ai reati in materia tributaria
e nell’indulto il riferimento a reati in materia di dogane, di imposta di
fabbricazione e di monopolio. La giovane Italia del primo dopo- guerra diventava
maggiorenne e i reati comuni, al posto di quelli politici, iniziarono a
catturare sempre più l’attenzione del legislatore: un’attenzione che, come
vedremo, costerà cara. Nel 1982 e 1983 furono approvati due provvedimenti di
sola amnistia ed esclusivamente per reati finanziari. Il clima iniziò a farsi
pesante e il parlamento venne accusato di difendere corrotti e concussi tanto
che, dopo qualche anno, il 6 marzo del 1992, il Parlamento operò una revisione
costituzionale modificando profondamente la ratio dell’articolo 79 della
Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto. Nel testo voluto
dai Padri Costituenti amnistia e indulto erano concessi dal Presidente della
Repubblica, previa legge di delegazione da parte delle Camere, approvata a
maggioranza semplice. La modifica introdotta nel 1992 fece sì che questi
provvedimenti di clemenza potessero essere concessi solo con una legge
deliberata in ogni articolo e nella votazione finale dalla maggioranza dei due
terzi dei componenti di ciascuna Camera. L’innalzamento del quorum necessario
all’approvazione del provvedimento fu deciso sull’onda dell’emotività suscitata
nella piazza dallo scandalo di “Mani Pulite” per evitare il ripetersi di
amnistie “concesse a cuor leggero”. Erano i tempi del lancio delle monetine
davanti all’Hotel Raphael e la piazza esigeva una svolta nel rispetto della
penalità. Fu in quel periodo che prese il via una prima trasformazione dei
modelli istituzionali che lentamente portò al trasferimento dei sistemi di
controllo sociale dalle forme di protezione a quelle della punizione. La grande
crisi economica degli anni successivi portò a compimento questa operazione di
trasformazione. L’insicurezza sociale che ne è scaturita si è, infatti, rivolta
al sistema penale, nella forma dell’esercizio delle funzioni repressive. Il
numero dei reati inseriti del codice penale ha continuato a crescere insieme
alla domanda di penalità, portando in pochi anni a raddoppiare il numero di
detenuti delle carceri italiane: dai 30mila degli anni Novanta ai quasi 60mila
dei nostri giorni. Il mutamento delle relazioni sociali e di potere e il
tramonto di un certo tipo di welfare hanno condannato qualsiasi progetto di
amnistia in fondo al cassetto delle priorità. Le carceri italiane hanno così
cominciato a conoscere il sistematico sovraffollamento e i trattamenti inumani e
degradanti riservati alla popolazione detenuta. A ben vedere, quindi, la
richiesta di amnistia (e indulto) sostenuta con forza dal Partito Radicale non è
per un provvedimento clemenza. Quella che si chiede non è la amnistia- amnesia;
è, invece, la richiesta di una amnistia politica per porre fine al
sovraffollamento cronico e inumano delle nostre carceri e alla intollerabile
lentezza dei processi, che hanno fatto meritare allo stato italiano plurime
condanne dalle Corti europee. In altre parole, un’amnistia per porre le radici
di una Giustizia (più) Giusta.
"I conti
con Craxi", colloqui inediti con l'ultimo Bettino.
La giornalista Paola Sacchi ha raccolto in un libro le conversazioni informali
tenute con l'ex premier a fine Anni 90. Lettera 43 ne anticipa un estratto il 21
marzo 2017. Conversazioni informali, raccolte a fine Anni 90 per una intervista
che non sarà mai pubblicata. Da una parte Bettino Craxi, dall'altra Paola
Sacchi, allora giovane firma dell'Unità. Di quei colloqui inediti ora la
giornalista ha fatto un libro, I conti con Craxi (Male edizioni, prefazione di
Stefania Craxi, 2017). Lettera43.it ne anticipa di seguito l'introduzione.
Bettino Craxi è tornato di moda. Se ne riparla, se ne riscrive sempre più
frequentemente. Per tentare di avviare qualche timida e un po’ imbarazzata
riabilitazione (termine che lui non amerebbe) o per «condannarlo» ancora e
ancora, a 25 anni da Mani pulite. Ma è un fatto che l’Italia si trovi sempre più
a fare i conti politici e storici con la figura di Craxi, la cui ombra si
allunga ogni volta da Hammamet, per un verso o per l’altro, incombendo sulla
nostra politica. Sta cadendo davvero il muro del tabù di «Bettino» e almeno per
il ventennale della sua drammatica morte lontano dall’Italia ci sarà «Via Craxi»
nella sua Milano? Qualcosa sembra si sia incominciato a muovere. Prima ancora
che dal calvario giudiziario, la sua fine fu decretata sul piano politico dalla
prevalente area catto-comunista che a sinistra mise fuori dai giochi il Psi
craxiano. Certo, Craxi, come tutti i leader politici, e tutti gli esseri umani,
commise anche errori, come lui stesso, del resto, ammise nello storico discorso
del 3 luglio 1992. Così sfidò, lasciandola ammutolita, l’intera classe
dirigente: «Buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. Non
credo che ci sia nessuno in quest’aula, responsabile politico di organizzazioni
importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a
quanto affermo: presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo
spergiuro». Nessuno si alzò. Alla fine rimase lui, con la sua impressionante
sfilza di condanne a oltre vent’anni, di fatto agli occhi degli italiani l’unico
«colpevole». Percepito però in parti crescenti dell’opinione pubblica come il
capro espiatorio. Questo libro riporta il bilancio, che Craxi fece ad Hammamet,
a quattr’occhi con me, una giornalista ex comunista, in diversi informali
colloqui nelle estati dal 1997 al 1999, della sua vicenda politica, a cominciare
dalla svolta che impresse al Psi agonizzante, quando ne divenne segretario, fino
a quel duello a sinistra con il Pci che terminò con l’eliminazione del Psi e del
suo leader. Una fine politica sulla quale trovò terreno fertile lo tsunami
giudiziario. Un epilogo violento, a proposito del quale chiesi a Craxi se anche
lui avesse qualche responsabilità sul piano della strategia politica. Osai anche
fargli la fatidica domanda nella quale riportavo, pur certo senza avallarla,
l’accusa che lo feriva di più e cioè quella sui presunti arricchimenti
personali. Cosa definita falsa dallo stesso giudice Gerardo D’Ambrosio, tra i
protagonisti del pool di «Mani pulite». Questo libro non ha alcuna pretesa di
essere un saggio sulla mancata unità a sinistra. Ma racconta come Craxi rivedeva
da Hammamet la sua parabola politica in quei colloqui, in gran parte raccolti
nell’intervista postuma pubblicata quattro anni fa in due parti da Panorama.it
(versione online del news magazine diretto da Giorgio Mulè). Ci sono anche
giudizi da preveggente su dove sarebbe andato a parare il nostro Paese. A me
disse secco: «Finirete in miseria…». E in forma più compiuta ecco in sintesi il
giudizio sull’ingresso in Europa, riportato nel volume Io parlo e continuerò a
parlare (Mondadori) curato da Andrea Spiri: «Senza una nuova trattativa e nuove
condizioni sarà un inferno e non il paradiso terrestre». In questo libro riporto
anche spaccati della vita dei suoi giorni da esiliato. Sul duello a sinistra la
storia ha dato ragione a Craxi. Ma lui creando la vera sinistra moderna e
innovatrice, quella di «Meriti e bisogni», ha avuto un po’ come il destino
beffardo di un giornalista che ha fatto troppo in anticipo uno storico scoop di
cui hanno cercato poi di impossessarsi i concorrenti, spacciandolo per proprio.
I concorrenti agguerritissimi furono i comunisti che poi, in una infinita e
macchinosa sequela di trasformazioni di nomi e di simboli, cercarono di
presentarsi come socialisti al posto di Craxi. E si allearono con la sinistra
della Dc, cassando il Psi. Ostracizzato, disonorato in Patria, laggiù, in
Africa, incominciò lentamente a morire. Ragionava da statista, ma si percepiva
benissimo quale profondo, indicibile dolore lo attanagliasse. C’era un odio nei
confronti di «Bettino» che talvolta rasentava la ferocia. Da ex giornalista
dell’Unità ho ancora nelle orecchie l’eco di certi applausi alle riunioni di
redazione con i quali si accompagnava la pioggia di avvisi di garanzia a colui
che veniva chiamato in modo ironico «il compagno», per dire che lui «compagno»
non era. Ma che appunto secondo il loro modo di vedere questa patente la
potevano avere solo i comunisti. Lo stesso ex premier inglese Tony Blair,
tuttavia, per il decennale della morte dell’ex premier e leader socialista,
onestamente riconobbe di aver tratto dall’elaborazione craxiana molti spunti per
il suo New Labour. Se Craxi è tornato ora di moda, non era, invece, per niente
di moda andare negli anni del suo esilio ad incontrarlo ad Hammamet.
Ostracizzato, disonorato in Patria, laggiù, in Africa, incominciò lentamente a
morire. Ragionava da statista, sempre preoccupato per le sorti della sua Italia
lontana, da politico a tutto tondo, quale era sempre stato. Ma si percepiva
benissimo, tra le sue celebri pause, quale profondo, indicibile dolore lo
attanagliasse. Ce ne è voluto per abbattere quel gigante alto un metro e
novanta, l’anticomunista, della sinistra moderna, in jeans, con i quali si
presentò in tutta fretta nel 1979 al Quirinale, per ricevere il primo mandato
esplorativo da presidente del Consiglio. Fu poi nel 1983 che per la prima volta
i post-fascisti del Msi furono ammessi alle consultazioni. Francesco Damato, ex
direttore del Giorno, previde che il governo Craxi non avrebbe ballato una sola
estate. Ce ne è voluto per affondare l’uomo che, come ricorda una sua compagna
di scuola (Adesso Craxi di Italo Pietra, Rizzoli 1990) «aveva qualcosa di
singolare nel muovere gli occhi: era una specie di lentezza e qualcosa di
imponente». Lo stesso carisma aveva conservato quando con le dita laterali dei
piedi in parte amputate, a causa del diabete, si presentava sulla terrazza
dell’Hotel Sheraton. A dispetto di come lo descriveva la vulgata giustizialista,
Craxi, che come tutte le persone schiette aveva un carattere deciso e diretto,
non accomodante, era di modi signorili, eleganti, contraddistinti da grande
attenzione per l’umanità che gli si presentava davanti. La sera prima che me ne
andassi, purtroppo senza l’intervista, a fine agosto del 1997, mi mandò
dall’autista Marcello in dono una serie di litografie e serigrafie con le quali
esprimeva la sua vena artistica. In una di queste era raffigurato il suo
passaporto di rappresentante personale del segretario dell’Onu per la pace e lo
sviluppo. Il suo rapporto sul debito del terzo mondo fu approvato dall’assemblea
generale della Nazioni Unite. Il suo pensiero costante sulla necessità del
dialogo nel Mediterraneo era il filo rosso di altre sue opere artistiche. Altre
erano dedicate al Cile e al ricordo dell’amicizia con il presidente Allende. Ce
ne era una dal titolo Adios General sulla caduta del dittatore Pinochet. Nel ’73
Craxi, vicesegretario del Psi, a pochi giorni dal golpe militare, rischiò la
vita avventurandosi con una sparuta delegazione sulla tomba di Allende. Fu
l’unico che osò farlo. I «carabineros», come ricorda Stefania Craxi in un
articolo su Il Giornale di qualche mese fa, gli intimarono: «Un paso mas y
tiro». Nei ragionamenti andava sempre al sodo. E lo faceva non solo sulla
politica ma un po’ su tutti gli argomenti. Quando Lady Diana morì nella notte
del 31 agosto ’97, prima di partire da Hammamet telefonai a Craxi per salutarlo
e ringraziarlo delle litografie. Non mi fece neppure finire e, non avendo ancora
visto la tv, mi chiese a bruciapelo interrompendomi: «…sì, sì ma si è capita la
dinamica dell’incidente?». Andò dritto a quella che è ancora rimasta la domanda
delle domande sull’ultima sera di Lady D, che aveva conosciuto da presidente del
Consiglio. E affettuoso commentò: «Povera figlia…». Ripensando all’imponente
curriculum politico e istituzionale dello statista Craxi, che fu anche
vicepresidente dell’Internazionale socialista, provai, parlandoci a quattr’occhi
nei giorni dell’esilio, un sentimento di doloroso imbarazzo come italiana. Quel
gigante, anche sul piano politico, vestito con la sahariana a una delle mie
prime domande sulla sua storia mi rispose spiazzandomi: «Sai, ci penso e ripenso
e a volte quasi mi chiedo: ma ero io quello?». Lo stesso sentimento di doloroso
imbarazzo come italiana lo riprovo scrivendo di lui e di quei giorni. Perché non
si «uccidono» così gli statisti.
Il medico di Bettino Craxi: "Vi racconto la sua morte".
L'ex presidente del consiglio è deceduto a Tunisi il 19 gennaio 2000 a causa di
un arresto cardiaco, scrive Marta Proietti, Venerdì 20/01/2017, su "Il
Giornale". Dalle pagine di Libero, Melania Rizzoli, la prima a vedere Bettino
Craxi morto, racconta quei momenti. "È morto! È mortoo.... La voce singhiozzante
di Scilla, moglie di Bobo Craxi, mi arriva al telefono verso le 18 per
annunciarmi la morte di Bettino. Lei è stravolta, mi dice che il suocero era
stato trovato senza vita nel suo letto nella casa di Hammamet e mi informava
che, essendo loro due a Roma, si stavano organizzando per raggiungerlo quella
sera stessa, chiedendomi di partire insieme". Il medico personale di Craxi,
nonché amica di famiglia, racconta che, al momento della morte dell'ex
presidente del consiglio, nella dimora tunisina c'erano solo due persone di
servizio e la figlia Stefania, mentre la moglie Anna era un aereo diretto a
Parigi per un breve soggiorno di tre giorni. "Scilla mi comunicò anche che Bobo
non voleva far uscire subito la notizia della morte del padre perché sua madre
in quel momento si trovava sul volo Air France, ignara della tragedia avvenuta,
e che stava cercando di contattare Angela, un'amica di famiglia residente a
Parigi, perché si recasse all'aeroporto De Gaulle per accogliere al gate Anna,
informarla a voce dell'accaduto e accompagnarla indietro nel suo triste viaggio
di ritorno a Tunisi". Melania racconta gli ultimi istanti di vita di Craxi:
"Quel pomeriggio Bettino aveva salutato la moglie in partenza, per poi andare a
riposare nella sua stanza verso le 14.30, e quando alle 17.30 il cameriere, non
vedendolo uscire, aveva bussato alla sua porta con il vassoio del thé alla
menta, non ricevendo alcuna risposta, era entrato trovandolo senza vita sul
letto. Bettino era morto circa due ore prima, in solitudine, probabilmente
accusando un malore, poiché aveva il pappagallo sul letto, e lui era riverso su
un fianco, come in procinto di scendere dal letto, ma era stato colpito da
un arresto cardiaco fulminante, che gli aveva spezzato il fiato e la voce, e non
gli aveva dato scampo, né il tempo e la forza per chiamare e chiedere aiuto". La
figlia Stefania, che si trovava in casa, decise di non voler vedere il padre
morto e chiese fosse portato nella clinica dove era abitualmente curato, perché
era angosciata dal pensiero di vegliarlo da sola in casa nella notte imminente.
La sua richiesta fu accolta. Il desiderio della moglie Scilla di non divulgare
la notizia prima di aver avvertito la madre non fu invece rispettata: "La
notizia della morte di Bettino quel 19 gennaio comunque uscì quasi subito sulle
agenzie e sui telegiornali, mentre la moglie Anna si trovava ancora in volo, e
quella sera stessa, quando Bobo, Scilla e io arrivammo nella clinica dove lui
era stato portato, fummo i primi a vederlo morto". Continua il medico di
famiglia: "Lo trovammo al piano terra di un locale freddo e disadorno della
clinica tunisina, illuminato da una luce fioca, dove aleggiava il silenzio e
il fetore della morte, ricoverato in un loculo dove era stato infilato, adagiato
su una lettiga sudicia e arrugginita. Il suo corpo era stato lavato e avvolto in
un telo bianco che lo racchiudeva completamente come in un candido bozzolo, e
quando io ho aperto il lenzuolo a livello del volto, Bobo e Scilla scoppiarono a
piangere". L'immagine che si trovarono davanti fu struggente: "Bettino aveva gli
occhi chiusi e la bocca aperta - continua Melania - con evidenti macchie
ipostatiche di sangue rappreso sulla parte destra del volto. La mandibola non
gli era stata serrata subito dopo il decesso, in attesa del rigor mortis, come
si usa da noi, perché essendo la Tunisia un paese islamico non ha la cultura
cristiana della cura e della conservazione della salma, la quale di regola viene
seppellita entro il tramonto, nel giorno stesso del decesso, indipendentemente
dall'ora della morte, dopo essere stata lavata e custodita nuda in un lenzuolo
bianco, e deposta direttamente sotto terra. Quindi nelle strutture sanitarie
tunisine non esistono nemmeno le sale mortuarie né le celle frigorifere, se non
degli pseudo-obitori, dove vengono ricoverati solo i corpi da sottoporre a esami
autoptici giudiziari". In quelle condizioni il corpo non poteva essere esposto e
"quindi una volta rientrati nella casa di Hammamet, ormai a notte fonda,
cercammo di convincere Stefania e Anna, che nel frattempo era rientrata, a
riportare il corpo di Craxi nella sua casa, per sistemarlo nella grande sala del
biliardo ed esporlo al saluto degli amici che iniziavano ad arrivare, ottenendo
però un netto rifiuto. Nemmeno Anna, molto affranta e provata, in quel momento
desiderava vederlo da morto". Craxi rimase quindi nella clinica: "La mattina
successiva Bettino fu rivestito, nel locale della clinica dove si trovava, da
due infermieri tunisini con gli abiti loro consegnati, una camicia bianca, una
cravatta rossa con garofano ricamato, un completo blu e scarpe nere, mentre io
gli truccavo con fondotinta e pennelli il viso, nascondendo così le macchie
ipostatiche e facendo sparire dal suo volto il pallore cadaverico, e nel
frattempo gli infilavo le foto degli adorati nipoti in tasca, per poi vederlo
ricollocare sempre nel suo loculo, in attesa dell'arrivo della bara per il
funerale cattolico". Una volta sistemato, il corpo di Craxi fu riportato nella
casa tunisina "per essere esposto alle visite degli amici e conoscenti prima del
funerale, ma purtroppo il sarcofago arrivato era di una misura standard, ovvero
troppo corto e troppo stretto per le misure fisiche di Bettino, il cui corpo,
una volta deposto all'interno, appariva rannicchiato, con le ginocchia
leggermente piegate e costretto in modo evidente a livello delle braccia e delle
spalle". "Era però anche palese che non ci sarebbe stato il tempo per attendere
una nuova bara, e in quella insolita circostanza furono di aiuto gli assistenti
tunisini, che rimossero il corpo di Bettino appoggiandolo delicatamente su un
tavolo attiguo, svitarono ed estrassero dalla cassa mortuaria il rivestimento
interno zincato che rubava spazio, per poi rimettere dentro la fodera di raso
bianca e gli ornamenti funebri e reintrodurre la salma, che in tal modo appariva
più distesa e meno stretta, più presentabile, e che fu quindi velata da un telo
di tulle chiaro". Furono molte le persone che andarono a salutare l'ex
presidente del consiglio: Silvio Berlusconi con la moglie Veronica, il
presidente della Repubblica Francesco Cossiga, il presidente della Tunisia Ben
Alí, Claudio Martelli con Gianni De Michelis, Pierferdinando Casini, Ottaviano
Del Turco, il cognato Paolo Pillitteri con Rosilde, Cesare Previti con la moglie
Silvana, il finanziere Tarak BenAmmar, Maurizio Raggi, Silvano Larini e molti
altri parlamentari socialisti, oltre ad amici milanesi e romani di ogni genere.
Conclude Melania Rizzoli: "Bettino Craxi al momento della morte aveva 65 anni.
Per i suoi detrattori morì da criminale latitante, per i suoi estimatori morì in
esilio vittima di una giustizia politicizzata, ma certamente per molti italiani
Bettino Craxi è morto privato di quella dignità e quel rispetto che la sua
figura e la sua storia avrebbe meritato, soprattutto nel suo ultimo giorno di
vita o se credete nel giorno della sua morte. Da allora riposa nel cimitero
cristiano di Hammamet, in una tomba di marmo bianco rivolta verso l'Italia e con
sopra inciso un epitaffio che era anche il suo motto: La mia libertà equivale
alla mia vita.
Craxi: "Vi racconto com'è morto Bettino Craxi e come ho truccato
il suo volto", scrive Melania Rizzoli il 20 gennaio
2017. "«È morto! È mortoo...». La voce singhiozzante di Scilla, moglie di Bobo
Craxi, mi arriva al telefono verso le 18 per annunciarmi la morte di Bettino.
Lei è stravolta, mi dice che il suocero era stato trovato senza vita nel suo
letto nella casa di Hammamet e mi informava che, essendo loro due a Roma, si
stavano organizzando per raggiungerlo quella sera stessa, chiedendomi di partire
insieme. Io da molti anni ero amica di famiglia ed ero il medico personale di
Bettino nella capitale. In quel drammatico pomeriggio nella dimora tunisina,
oltre all' ex presidente del Consiglio, erano presenti solo due persone di
servizio e la figlia Stefania, poiché la moglie Anna era appena partita per
Parigi per curarsi in un breve viaggio di tre giorni, dopo il capodanno del
Millennium trascorso in casa in famiglia con marito, figli e nipoti. Scilla mi
comunicò anche che Bobo non voleva far uscire subito la notizia della morte del
padre perché sua madre in quel momento si trovava sul volo Air France, ignara
della tragedia avvenuta, e che stava cercando di contattare Angela, un'amica di
famiglia residente a Parigi, perché si recasse all'aeroporto De Gaulle per
accogliere al gate Anna, informarla a voce dell'accaduto e accompagnarla
indietro nel suo triste viaggio di ritorno a Tunisi. Quel pomeriggio Bettino
aveva salutato la moglie in partenza, per poi andare a riposare nella sua stanza
verso le 14.30, e quando alle 17.30 il cameriere, non vedendolo uscire, aveva
bussato alla sua porta con il vassoio del thé alla menta, non ricevendo alcuna
risposta, era entrato trovandolo senza vita sul letto. Bettino era morto circa
due ore prima, in solitudine, probabilmente accusando un malore, poiché aveva il
pappagallo sul letto, e lui era riverso su un fianco, come in procinto di
scendere dal letto, ma era stato colpito da un arresto cardiaco fulminante, che
gli aveva spezzato il fiato e la voce, e non gli aveva dato scampo, né il tempo
e la forza per chiamare e chiedere aiuto. La figlia Stefania, in lacrime e
comprensibilmente sconvolta, dopo aver convocato d'urgenza il medico tunisino
del padre, che non poté far altro che certificarne il decesso, chiese allo
stesso di trasferire il padre nella clinica dove era abitualmente curato, poiché
lei non voleva assolutamente vederlo morto ed era angosciata dal pensiero di
vegliarlo da sola in casa nella notte imminente. Il corpo di Craxi venne quindi
trasferito verso le 20 in ambulanza alla clinica "Le Violettes", la stessa dove,
appena tre mesi prima, era stato operato di nefrectomia destra per un tumore
maligno al rene dal professor Rigatti, giunto appositamente dall' Italia. La
notizia della morte di Bettino quel 19 gennaio comunque uscì quasi subito sulle
agenzie e sui telegiornali, mentre la moglie Anna si trovava ancora in volo, e
quella sera stessa, quando Bobo, Scilla e io arrivammo nella clinica dove lui
era stato portato, fummo i primi a vederlo morto. Lo trovammo al piano terra di
un locale freddo e disadorno della clinica tunisina, illuminato da una luce
fioca, dove aleggiava il silenzio e il fetore della morte, ricoverato in un
loculo dove era stato infilato, adagiato su una lettiga sudicia e arrugginita.
Il suo corpo era stato lavato e avvolto in un telo bianco che lo racchiudeva
completamente come in un candido bozzolo, e quando io ho aperto il lenzuolo a
livello del volto, Bobo e Scilla scoppiarono a piangere. Bettino aveva gli occhi
chiusi e la bocca aperta, con evidenti macchie ipostatiche di sangue rappreso
sulla parte destra del volto. La mandibola non gli era stata serrata subito dopo
il decesso, in attesa del rigor mortis, come si usa da noi, perché essendo la
Tunisia un Paese islamico non ha la cultura cristiana della cura e della
conservazione della salma, la quale di regola viene seppellita entro il
tramonto, nel giorno stesso del decesso, indipendentemente dall' ora della
morte, dopo essere stata lavata e custodita nuda in un lenzuolo bianco, e
deposta direttamente sotto terra. Quindi nelle strutture sanitarie tunisine non
esistono nemmeno le sale mortuarie né le celle frigorifere, se non degli
pseudo-obitori, dove vengono ricoverati solo i corpi da sottoporre a esami
autoptici giudiziari.
In quelle condizioni era chiaro che non sarebbe stato possibile esporre
pubblicamente Bettino, né per il luogo e nemmeno per la situazione della salma,
poiché non sarebbe stato dignitoso per lui e per le persone che sarebbero
arrivate a salutarlo farlo vedere così scomposto, e quindi una volta rientrati
nella casa di Hammamet, ormai a notte fonda, cercammo di convincere Stefania e
Anna, che nel frattempo era rientrata, a riportare il corpo di Craxi nella sua
casa, per sistemarlo nella grande sala del biliardo ed esporlo al saluto degli
amici che iniziavano ad arrivare, ottenendo però un netto rifiuto. Nemmeno Anna,
molto affranta e provata, in quel momento desiderava vederlo da morto. La
mattina successiva Bettino fu rivestito, nel locale della clinica dove si
trovava, da due infermieri tunisini con gli abiti loro consegnati, una camicia
bianca, una cravatta rossa con garofano ricamato, un completo blu e scarpe nere,
mentre io gli truccavo con fondotinta e pennelli il viso, nascondendo così le
macchie ipostatiche e facendo sparire dal suo volto il pallore cadaverico, e nel
frattempo gli infilavo le foto degli adorati nipoti in tasca, per poi vederlo
ricollocare sempre nel suo loculo, in attesa dell' arrivo della bara per il
funerale cattolico. In Tunisia, infatti, per i motivi sovraesposti, le bare non
vengono fabbricate, per cui la famiglia Craxi ne attendeva una dall'Italia,
offerta dall' amico Salvatore Ligresti, che sarebbe stata spedita al più presto
con il suo aereo personale, non senza difficoltà per farla entrare dal portello
e nel ristretto abitacolo del jet. La bara comunque arrivò il giorno successivo
a Tunisi, nel palazzo istituzionale messo a disposizione dal governo locale,
dove nel frattempo era stato trasferito il corpo di Craxi per essere esposto
alle visite degli amici e conoscenti prima del funerale, ma purtroppo il
sarcofago arrivato era di una misura standard, ovvero troppo corto e troppo
stretto per le misure fisiche di Bettino, il cui corpo, una volta deposto all'
interno, appariva rannicchiato, con le ginocchia leggermente piegate e costretto
in modo evidente a livello delle braccia e delle spalle. Era però anche palese
che non ci sarebbe stato il tempo per attendere una nuova bara, e in quella
insolita circostanza furono di aiuto gli assistenti tunisini, che rimossero il
corpo di Bettino appoggiandolo delicatamente su un tavolo attiguo, svitarono ed
estrassero dalla cassa mortuaria il rivestimento interno zincato che rubava
spazio, per poi rimettere dentro la fodera di raso bianca e gli ornamenti
funebri e reintrodurre la salma, che in tal modo appariva più distesa e meno
stretta, più presentabile, e che fu quindi velata da un telo di tulle chiaro. Da
quel momento fu permesso l'accesso ai visitatori che giunsero numerosi, tra i
quali si ricordano Silvio Berlusconi con la moglie Veronica, il presidente della
Repubblica Francesco Cossiga, il presidente della Tunisia Ben Alí, Claudio
Martelli con Gianni De Michelis, Pierferdinando Casini, Ottaviano Del Turco, il
cognato Paolo Pillitteri con Rosilde, Cesare Previti con la moglie Silvana, il
finanziere Tarak BenAmmar, Maurizio Raggi, Silvano Larini e molti altri
parlamentari socialisti, oltre ad amici milanesi e romani di ogni genere. La
camera ardente con la bara di Bettino Craxi, attorniata da un picchetto d'
onore, da ceri accesi, da bandiere italiane, tunisine e socialiste, e da
centinaia di garofani rossi, è rimasta aperta in quella sede per tutto il giorno
e tutta la notte, di fronte a un incessabile corteo di persone che arrivavano a
ogni ora per l' ultimo saluto e portavano le condoglianze ad Anna, che è rimasta
tutto il tempo in un angolo della grande sala, ricevendo l' affetto e il saluto
degli amici, lontana dalla vista del marito morto. La mattina successiva, poco
prima della cerimonia funebre celebrata nella cattedrale di Saint Louis di
Tunisi, il corpo di Bettino fu rimosso ancora dalla sua cassa di legno per poter
collocare nuovamente al suo posto la protezione zincata, e successivamente la
sua salma è stata reintrodotta nelle misure ristrette di quella bara italiana,
per poi essere chiusa con il coperchio e sigillata a fuoco definitivamente.
Bettino Craxi al momento della morte aveva 65 anni. Per i suoi detrattori morì
da criminale latitante, per i suoi estimatori morì in esilio vittima di una
giustizia politicizzata, ma certamente per molti italiani Bettino Craxi è morto
privato di quella dignità e quel rispetto che la sua figura e la sua storia
avrebbe meritato, soprattutto nel suo ultimo giorno di vita o se credete nel
giorno della sua morte. Da allora riposa nel cimitero cristiano di Hammamet, in
una tomba di marmo bianco rivolta verso l'Italia e con sopra inciso un epitaffio
che era anche il suo motto: «La mia libertà equivale alla mia vita»". Melania
Rizzoli
Parla la moglie di Craxi: «Bastava un salvacondotto per salvare
Bettino…», scrive Paola Sacchi il 21 gennaio su "Il
Dubbio". Gli ultimi giorni del leader socialista raccontati da Anna Maria
Moncini: “Sognava di tornare in Italia ma da uomo libero”. Il lungo tavolo
rettangolare nel patio della casa di Hammamet, praticamente l’ultimo ufficio
rimasto allo statista socialista in esilio Bettino Craxi, ora è completamente
sgombro. Non c’è più la montagna di carte, di libri, e di lettere di gente
comune ma anche di Francois Mitterand, di Felipe Gonzalez e Mario Soares, la
triade del socialismo mediterraneo. Spira un vento gelido in Tunisia, nei giorni
del diciassettesimo anniversario della scomparsa di Bettino, l’altro ieri
omaggiato sulla sua tomba anche dal ministro degli Esteri Angelino Alfano. Che
seppur leader del Nuovo Centrodestra è stato il primo esponente di alto rango di
un governo di centrosinistra a recarsi nel piccolo cimitero cristiano, luogo
simbolo della caduta della nostra Prima Repubblica. Stefania Craxi scherza con
amara e pungente ironia indicandomi la fontanella prima del patio: «Lo so, sarai
delusa, qui non c’è più la fontana di piazza Castello che secondo i giornali
italiani mio padre avrebbe rubato a Milano. Sai, l’abbiamo rispedita in Italia,
con un carico speciale…». I Craxi hanno sempre saputo affrontare con stile e
grande dignità una tragedia che non è solo la loro, ma una tragedia politica
italiana. Il tavolo del patio ora è vuoto e non c’è più neppure il gatto Nerino
che passava ore accoccolato sulle ginocchia dell’ex premier e leader socialista.
Mi racconta Anna Craxi, vedova di Bettino, facendo un rarissimo strappo al suo
noto riserbo: «Nerino è morto, poco tempo dopo la scomparsa di Bettino». Anna
Maria Moncini (questo il suo cognome da nubile), figlia di un ferroviere
socialista, la ex first lady italiana, forse la più discreta first lady di
sempre, ha scelto di vivere qui, di restare vicina alle spoglie di suo marito.
Aspira una sigaretta estratta da un pacchetto, elegantemente coperto da un
astuccio rosa argentato, e mi racconta: «Sono contenta di tutte le visite e i
riconoscimenti che ci sono stati per mio marito in questi anni. Iniziò
Napolitano che per il decennale mi mandò un fax in cui riconobbe che per Bettino
ci fu “una durezza senza uguali”, poi ieri (l’altro ieri ndr) è venuto anche
Alfano. Mi ha pure baciata…». Sorride. Ma poi Anna Craxi si ferma, la mente va
indietro agli anni (1994- 2000), trascorsi in questa casa (una villetta carina,
ma niente di lussuoso, niente rubinetti d’oro come fu comicamente scritto, se la
vogliamo prendere a ridere) da Craxi in esilio e confida: «Lui ha sperato fino
alla fine di poter tornare in Italia. Certo, da uomo libero, come lui ha sempre
detto. Ma intanto per farsi curare. Era gravemente malato. All’ultimo sperava
che almeno gli sospendessero la pena per potersi salvare…». Che, insomma, almeno
gli concedessero di poter tornare nel suo Paese per salvarsi la vita, senza due
carabinieri dietro la porta d’ospedale come la Procura di Milano, invece ordinò.
E Craxi, che sulla sua tomba ha fatto scrivere «La mia libertà equivale alla mia
vita», a quel punto decise per la prima volta di obbedire, come ha scritto il
direttore del Dubbio Piero Sansonetti, dicendo a se stesso: «Vogliono che muoia
e così sia». E però la sua memoria resta sempre più viva e scomoda per l’Italia.
Lui continua a restare il convitato di pietra della nostra politica, costretta
ogni anno a ricordarlo in occasione dell’anniversario della sua morte. E non
solo. Mi racconta la vedova Anna: «Pensa che abbiamo contato nel registro delle
presenze al cimitero una cosa come 20.000 firme con tanto di dedica all’anno, le
presenze però, dopo gli atti di terrorismo che hanno colpito la Tunisia, sono
calate negli ultimi due anni. Ma in questi giorni ho perfino trovato firme di
spagnoli, francesi, ma anche tedeschi. Quest’ultima un po’ una stranezza. Perché
fino alla Francia di Mitterand o alla Spagna di Gonzalez capisco… E comunque la
sua tomba continua ad essere sempre meta di pellegrinaggio». È una giornata
grigia e uggiosa, dall’Italia sono in arrivo militanti socialisti, amici,
simpatizzanti che ogni anno giungono qui per la ricorrenza della morte di Craxi,
di cui il ventennale ormai si avvicina. Come avrebbe passato la giornata di oggi
Bettino? Anna racconta lo schema dei giorni dell’esilio: «Lavorava sul tavolo
nel patio o quando faceva freddo nella stanza dei fax. Dipingeva vasi (celebri
quelli con la “lacrime” dei colori della nostra bandiera che simboleggiano
l’Italia che piange), faceva litografie, serigrafie, scriveva discorsi
(regolarmente cestinati nelle redazioni dei giornali italiani ndr), non stava
mai fermo. Bettino lavorava sempre. Scriveva fino alle 2 o alle 3 di notte. Nel
pomeriggio si recava nel centro di Hammamet al Caffè Moro alla Medina…». Dove
tutti andavano a omaggiare, anche per chiedergli consigli di vita, Monsieur Le
President. Dice Anna: «Lui era un uomo del popolo». Non c’è tassista, barista,
ambulante, commerciante della Medina che non abbia conosciuto «Monsieur Craxì»,
con l’accento francese sulla i. La sua presenza qui era motivo di orgoglio per
poveri e ricchi, per gente semplice e intellettuali e registi che in Tunisia
hanno le ville. Ma Bettino era amato soprattutto dai poveri, come la famiglia di
pescatori a Salloum dove lui si era fatto costruire un capanno, il suo secondo
“ufficio”, nell’esilio di Hammamet. «Il 19 gennaio al cimitero siamo sempre di
più», dice Anna Craxi. E Stefania: «Pensa che in questi giorni in Italia si
stanno facendo anche tante messe di commemorazione organizzate dai militanti
laici socialisti». Anna, l’altro ieri si è commossa quando la figlia Stefania le
ha fatto leggere il messaggio in cui Silvio Berlusconi, di cui la vedova Craxi
con il marito fu testimone di nozze, ricorda che i valori di Bettino erano i
suoi. «Purtroppo – dice Stefania, ex sottosegretario agli Esteri del governo
Berlusconi e presidente della Fondazione Craxi – sui social continuano a venire
attacchi soprattutto da sinistra, mentre mio padre viene trattato con rispetto
dalla destra missina». Lei, la tenace, indomita figlia di Bettino, è la vera
artefice del fatto che la memoria di Craxi è sempre viva e presente,
rappresentando per l’Italia un conto da regolare. Non solo ha intercettato
Alfano che veniva in Tunisia e lo ha invitato sulla tomba del padre, ma nei
giorni scorsi ha anche parlato con il sindaco (Pd) di Milano Beppe Sala, il
quale si è detto non contrario a dedicare a Craxi una via nella sua città,
quella via che finora gli è stata sempre negata. La speranza è che almeno per il
ventennale della scomparsa dello statista socialista quella via ci sia a Milano
e a Roma. Craxi, mentre passava i giorni dell’abbandono guardando il mare verso
l’Italia, come hanno ricordato Berlusconi e Alfano, ha insegnato all’Italia, del
resto, a guardare lontano. Ma iniziò di fatto a morire il giorno
dell’assoluzione di Giulio Andreotti. Quando felicissimo naturalmente per lo
statista Dc, suo alleato al governo, Bettino pensò: «Qui, l’unico delinquente
per gli italiani sono rimasto io». L’Italia ha certamente un grande conto da
regolare con lui.
Bettino Craxi, tangenti per miliardi a domicilio. Ecco perché fu
condannato. Nel 17esimo anniversario della morte del
segretario Psi, da latitante in Tunisia, si allarga la schiera di chi punta alla
riabilitazione o, quantomeno, a "riaprire la discussione". Da Alfano a Orlando a
Sala. Dal libro "Mani pulite" di Barbacetto, Gomez e Travaglio, ecco gli
elementi principali che hanno portato a una delle due sentenze definitive di
colpevolezza, quella per le tangenti della metropolitana milanese: "Sette-otto
miliardi finiti direttamente a lui", scrive "Il Fatto Quotidiano" il 20 gennaio
2017. Il ministro degli Esteri Angelino Alfano è volato ad
Hammamet per ricordare il diciassettesimo anniversario della morte di Bettino
Craxi. Il ministro della giustizia Andrea Orlando si dice favorevole a “riaprire
la discussione” sulla una “figura importante della sinistra”, pur ammettendone
“gli errori”. E il sindaco di Milano Giuseppe Sala, eletto nel centrosinistra,
apre alla possibilità di intitolargli una via, che potrebbe essere discussa già
lunedì 23 gennaio in consiglio comunale. Proprio mentre si susseguono inchieste
e processi per piccole e grandi corruzioni, mentre il numero uno dell’autorità
anti-tangenti Raffaele Cantone gira l’Italia per esortare una “rivoluzione
culturale” contro il malaffare, mentre si moltiplicano gli studi e i rapporti
internazionali su danni e distorsioni inflitti al sistema economico e politico,
si allarga la schiera di chi persegue la riabilitazione del segretario del
Partito socialista italiano morto da latitante in Tunisia il 19 gennaio 2000. In
quel momento, uno dei politici simbolo della Prima Repubblica aveva
collezionato due condanne definitive per 10 anni di reclusione (5 anni e 6 mesi
per la corruzione dell’Eni-Sai e 4 anni e 6 mesi per i finanziamenti illeciti
della Metropolitana milanese), più altre condanne provvisorie, in primo e in
secondo grado, per circa quindici anni (3 anni in appello per Enimont, 5 anni e
5 mesi in Tribunale per Enel, 5 anni e 9 mesi annullati con rinvio dalla
Cassazione per la bancarotta del Conto protezione); e poi due assoluzioni
(Cariplo e, a Roma, Intermetro) e una prescrizione (in appello per All Iberian).
Non basta. L’allora segretario del Psi e già presidente del consiglio aveva
ricevuto tre ordinanze di custodia cautelare, i cui procedimenti al momento
della morte non erano stati definiti: Enel, fondi neri Eni e fondi neri
Montedison. In questa corsa alla riabilitazione, è utile ricordare i fatti
specifici contestati allora a Craxi dai pm di Mani pulite e poi confermati in
via definitiva in Cassazione. Sul fronte dei finanziamenti illeciti della
Metropolitana milanese, ecco la ricostruzione della vicenda attraverso le parole
di Silvano Larini, architetto e reo confesso collettore di mazzette per conto
del segretario Psi, che il 7 febbraio 1993 mette fine alla sua latitanza e si
consegna alle autorità italiane, diventando così un pilastro dell’accusa al
leader Psi. Quello che segue è un estratto del libro Mani pulite, la vera
storia, di Gianni Barbacetto, Peter Gomez e Marco Travaglio (Editori riuniti
2002).
BETTINO CRAXI, LE TANGENTI MM E LE VALIGETTE DI SOLDI IN PIAZZA DUOMO. Il 7
febbraio, accompagnato dall’avvocato Bovio, Larini si consegna a Di Pietro, che
con il capitano Zuliani lo aspetta alla frontiera autostradale di Ventimiglia.
Dopo uno spuntino in un ristorante-pizzeria, viene accompagnato a Milano, nel
carcere di Opera. Vi trascorrerà quattro giorni, riempiendo decine di pagine di
verbali. L’architetto ammette le sue responsabilità. E racconta il suo ruolo di
«fattorino delle tangenti» che sgorgavano dal sistema della metropolitana
milanese: Dovevo ricevere il denaro che Carnevale o Prada mi consegnavano e
portarlo all’onorevole Craxi. Infatti, a partire dal 1987 e fino alla primavera
del 1991, ho avuto modo di ricevere dai predetti 7 o 8 miliardi complessivamente
e ogni volta (salvo in un paio d’occasioni in cui li ho consegnati direttamente
a Natali) li ho portati negli uffici dell’onorevole Craxi di piazza Duomo 19, a
Milano, depositandoli nella stanza a fianco della sua […]. Posavo la borsa o il
plico sul tavolo e la Enza [Tomaselli, la segretaria di Craxi] lo ritirava. Non
le ho mai detto nulla, alla consegna, perché era assolutamente scontato di che
cosa si trattasse […]. Ho raccolto 7-8 miliardi di tangenti sulla Metropolitana
e in buona parte sono finiti personalmente a Craxi. Portavo i soldi al quarto
piano di piazza Duomo 19. Ero io a confezionare il pacchetto, utilizzando buste
marroncine. A volta le posavo sul tavolo della segretaria, a volte le lasciavo
sul tavolo della camera di riposo di Bettino. Natali mi disse che da tempo le
imprese operanti nella metropolitana erano solite versare del denaro al sistema
dei partiti. Fino al 1987 – ricorda – al finanziamento occulto pensava
direttamente il presidente della Metropolitana milanese, Antonio Natali. Poi si
pose il problema di sostituirlo. «Motivi di opportunità – spiega Larini ai
magistrati – sconsigliavano al Psi di riproporlo, in quanto egli era stato
inquisito dall’autorità giudiziaria di Milano per fatti di concussione. Natali
fu eletto senatore e in tal modo fu “salvato” da un procedimento penale». Craxi
e Natali offrirono a Larini la carica di presidente della Mm, che però rifiutò.
«La scelta cadde allora su Claudio Dini», l’architetto che aveva lavorato nello
studio di Ignazio Gardella, ma che, a quanto racconta Larini, non era
considerato affidabile per la gestione delle tangenti: Natali non aveva molta
confidenza con lui e lo considerava un po’ bizzarro e pericoloso per il sistema,
dal punto di vista di riscossione del denaro. Mi spiego. Natali mi disse che da
tempo le imprese operanti nella metropolitana erano solite versare del denaro al
sistema dei partiti e in particolare alla Dc, al Psi, al Pri, al Pci e al Psdi.
Questo denaro veniva utilizzato in quegli anni dal Psi per il sostentamento
della federazione milanese, ma anche per la cassa nazionale del Psi,
all’occorrenza. Infatti ricordo che Balzamo in un’occasione mi diede atto che
era a lui pervenuta una parte del denaro proveniente dalle contribuzioni degli
imprenditori milanesi, dicendomi: «Meno male che sono arrivati i soldi di
Milano, perché altrimenti non potevamo pagare gli stipendi». Ero al corrente
della natura non regolare dei finanziamenti al mio partito. L’ho cominciato a
capire da quando portavo i pantaloni alla zuava! Così Natali chiese che fosse
Larini a occuparsi delle tangenti, al posto del «bizzarro» Dini: «Mi pregò di
essere io la persona che riceveva per conto del Psi il denaro proveniente dalle
imprese operanti negli appalti della Mm. Natali mi spiegò che alla materiale
raccolta del denaro nei confronti degli imprenditori provvedevano Prada Maurizio
[Dc] e Carnevale Mijno Luigi [Pci]». Ricevuto l’incarico da Natali, Larini si
rivolse direttamente all’amico segretario del Psi: Chiesi informazioni
all’onorevole Bettino Craxi su come comportarmi e costui mi disse: «Va bene,
occupatene». In altri termini, fu lo stesso Craxi a confermarmi l’incarico di
provvedere a raccogliere il denaro proveniente dalla Mm. […] Tutto ciò che
prendevo lo portavo sempre nell’ufficio dell’onorevole Craxi e non trattenevo
nulla per me. Era un servizio che io rendevo a Craxi per amicizia e per comune
militanza politica. Non tutti, fa capire Larini, erano cosí disinteressati e
corretti, e comunque sul giro delle tangenti aleggiava sempre il sospetto che
qualcuno ne approfittasse: Un giorno fui chiamato da Craxi il quale mi disse che
Balzamo gli aveva fatto presente che l’onorevole Citaristi, segretario
amministrativo della Dc, aveva disposto un’indagine interna nei confronti di
Prada, perché sospettava che non tutto il denaro finisse nelle casse della Dc.
Anche l’onorevole Craxi, verso la fine del 1989-inizio 1990, mi disse che pure
lui aveva saputo che in giro si diceva che le imprese pagavano il 20 per cento
del valore degli appalti, e che quindi io venivo «imbrogliato» da Prada e
Carnevale. Io spiegai che era impossibile che le imprese pagassero una
percentuale del genere, perché si sarebbero poste del tutto fuori mercato […].
In tale occasione pregai l’onorevole Craxi di sollevarmi da un incarico così
scomodo; egli mi disse: «Va bene». E, seppure con un anno di ritardo, alla fine
mi sostituì con l’onorevole Oreste Lodigiani [cioè con il segretario
amministrativo milanese del Psi]. Dopo la morte di Balzamo, venne fuori questo
foglietto. In quattro anni ha raccolto qualcosa come 186 miliardi”. Larini,
dunque, svela anche una parte dei veleni che intossicano i circuiti sotterranei
di Tangentopoli: poiché la raccolta era illegale, sui «cassieri» non era
possibile alcuna forma di controllo legale. Così tra i protagonisti del sistema
regnavano la sfiducia e il sospetto che qualcuno approfittasse della situazione,
facendo la «cresta» per sé. Cosa che, in diversi casi, è stata anche
giudiziariamente accertata. […] Quello stesso 17 dicembre [1993, al processo
contro Sergio Cusani per la maxitangente Enimont], subito dopo Forlani, tocca
anche a Bettino Craxi. Ma il suo interrogatorio è tutto un altro film. Un Di
Pietro insolitamente calmo e remissivo gli pone la fatidica domanda, se fosse al
corrente del finanziamento illegale ai partiti. Craxi si concede una delle sue
lunghe pause. Poi spiega: «Né la Montedison, né il gruppo Ferruzzi, né il dottor
Sama, né altri, né direttamente, né per interposta persona, a me personalmente
hanno mai dato una lira. Diversamente, sia il gruppo Ferruzzi, sia la Montedison
hanno versato contributi all’amministrazione del partito: da quando, non saprei,
ma certamente da molti anni e fino alle elezioni del 1992». Poi, però, ecco una
confessione in piena regola: «Ero comunque al corrente della natura non regolare
dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L’ho cominciato a capire da
quando portavo i pantaloni alla zuava!». Di Pietro sorride, raggiante: «C’è
qualcuno che, prima di lei, questa mattina, l’ha saputo solo qualche giorno fa».
Una piccola rivincita su Forlani. Craxi non solo ammette, ma consegna anche dei
documenti. E a un certo punto, con calcolata suspence, estrae di tasca un
bigliettino e sibila: «Dopo la morte di Vincenzo Balzamo, venne fuori questo
foglietto scritto a mano, in cui lui aveva fatto un appunto che si riferiva a un
quinquennio, con le entrate provenienti da società ed enti. Lui scrive che in
quattro anni ha raccolto qualcosa come 186 miliardi. Circa 50 miliardi
all’anno». Ovviamente non registrati, quindi fuorilegge. Ecco perché Di Pietro è
così pacato. Ecco perché non incalza: Craxi, con la sua brutale franchezza, si è
messo in trappola da solo. Migliore conferma alle accuse non ci poteva essere.
Chi si aspettava uno scontro al calor bianco rimane deluso. […] Craxi, in
seguito, fuori da un’aula di giustizia, racconterà a Bruno Vespa (nel libro Il
duello) che per fare politica poteva contare sugli aiuti di tanti amici. «Nel
senso che venivano da te e ti chiedevano di quanto avevi bisogno?», gli domanda
Vespa. «Ci mancherebbe altro – risponde Craxi. – Non si permettevano. Facevano
la fila come si fa dal dentista. Passavano dalla segretaria…». Tratto da Mani
pulite, la vera storia, di Gianni Barbacetto, Peter Gomez e Marco Travaglio
(Editori riuniti 2002)
Il 19 gennaio del 2000 moriva ad Hammamet il leader socialista
Bettino Craxi, scrive "TPI". Il 19 gennaio del 2000
moriva a Hammamet, in Tunisia, Bettino Craxi, figura di primo piano della
politica italiana durante la Prima repubblica.
Nato a Milano il 24 febbraio del 1934 in una famiglia di idee socialiste,
Benedetto (questo era il suo nome di battesimo) si avvicinò ben presto a questi
ideali, aderendo al Partito Socialista Italiano e partecipandovi fin dai tempi
dell'università, e già nel 1956, ad appena 22 anni, fu eletto consigliere
comunale a Sant'Angelo Lodigiano, e l'anno successivo entrò nel comitato
centrale del partito come esponente della corrente dell'allora segretario
socialista Pietro Nenni.
Nel 1968, quando il segretario del partito era Francesco De Martino, Craxi fu
eletto per la prima volta deputato, in rappresentanza della circoscrizione
Milano-Pavia.
Nel 1976 il PSI, che aveva appena causato la caduta del quarto governo toccò uno
dei suoi peggiori risultati elettorali di sempre arrivando sotto il 10 per cento
dei consensi. Questo fatto fu imputato all'atteggiamento, considerato troppo
accondiscendente verso il Partito Comunista Italiano (che, diversamente dal PSI,
era all'opposizione), del segretario De Martino, costretto alle dimissioni.
Il successivo congresso, svoltosi all'Hotel Midas di Roma, portò all'elezione di
Bettino Craxi a nuovo segretario. Da quel momento, la linea del partito cambiò e
questo favorì notevolmente l'ascesa politica dello stesso Craxi sulla scena
italiana. Il primo segretario iniziò a prendere le distanze dai comunisti (dai
quali già nel 1956 si era fortemente dissociato dopo l'invasione sovietica
dell'Ungheria), criticando il marxismo e il leninismo e ridimensionando il ruolo
della falce e martello nel simbolo del PSI, sostituita dal garofano rosso,
simbolo delle lotte socialiste di inizio Novecento. Craxi, per l'epoca, risultò
un politico molto innovativo nel porsi sulla scena nazionale. Diversamente da
molti suoi colleghi, era molto attento all'aspetto mediatico e alla cura della
propria immagine.
Nel 1983 Bettino Craxi fu a capo del suo primo governo, il primo guidato da un
esponente del PSI nella storia d'Italia, che divenne - per l'epoca - il più
lungo della storia d'Italia (è stato poi superato dal Berlusconi II e dal
Berlusconi IV). A sostenere questo governo era il cosiddetto "Pentapartito", la
coalizione formata da DC, PSI, PRI, PLI e PSDI.
Il governo fu molto attivo, si caratterizzò per una politica estera (il ministro
degli Esteri era Giulio Andreotti) che guardava a un ruolo fondamentale
dell'Italia nel Mediterraneo, arrivando anche allo scontro diplomatico con gli
Stati Uniti, come quello avvenuto con la crisi di Sigonella, per far valere
questa posizione. Il governo, inoltre, realizzò un nuovo Concordato con la
Chiesa Cattolica, e acutizzò la propria rottura con i comunisti con il taglio
della scala mobile, il meccanismo per cui i salari erano ancorati all'andamento
dei prezzi. Ma la rottura con il PCI fu ancora più palese nel 1984 quando, al
congresso di Verona, il segretario comunista Berlinguer fu fischiato dai
militanti socialisti. Successivamente Craxi disse che se quei fischi erano
indirizzati alla linea politica del PCI, lui non vi si era unito solo perché non
sapeva fischiare. Lo stesso anno Berlinguer morì, e i militanti comunisti
fischiarono Craxi al funerale del loro segretario.
Il governo Craxi I terminò nel 1986, ma venne dato un nuovo incarico allo stesso
Craxi che lo portò avanti fino al 1987.
Alle elezioni europee del 1989 il PSI di Craxi raggiunse il 14,78 per cento, il
massimo del periodo craxiano.
Con gli anni Novanta, e in particolar modo a partire dal 1992, il PSI - e con
esso il craxismo - subirono una grossa crisi. Nel mese di febbraio, l'esponente
socialista milanese Mario Chiesa viene infatti arrestato per aver intascato una
tangente. Ha l'inizio il cosiddetto scandalo di Tangentopoli che in breve tempo
arriverà a travolgere un'intera classe politica. In breve tempo numerosi
esponenti del mondo politico e statale vennero indagati e arrestati. In questo
clima, Craxi in parlamento pronunciò uno storico discorso: "Non credo che ci sia
nessuno in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti che
possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo:
presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro". Nessun
politico rispose all'appello di Craxi, il quale fu sempre più critico per il
clima di caccia alle streghe che stava nascendo sotto il vento delle indagini
della Procura di Milano che coinvolgevano sempre più esponenti del mondo
politico. "Hanno creato un clima infame", dichiarò in questo senso Craxi.
Tuttavia, tra il dicembre 1992 e il marzo 1993 anche il leader socialista fu
raggiunto da ben 11 avvisi di garanzia, fatto che lo portò a lasciare la
segreteria del PSI, dove fu sostituito dal sindacalista Giorgio Benvenuto, dal
momento che anche Claudio Martelli, considerato il delfino di Craxi, venne
indagato. Craxi, da quel momento, ammise in modo chiaro di aver avuto
responsabilità nel finanziamento illecito del PSI, definendolo uno strumento
usato da tutti i partiti al fine di mantenere le proprie strutture
organizzative, ma si definì innocente rispetto a chi lo accusava di corruzione o
di essersi arricchito personalmente attraverso strumenti illeciti.
Il 29 aprile 1993 la Camera dei deputati votò contro l'autorizzazione a
procedere nei confronti di Craxi, passaggio all'epoca necessario per portare
avanti misure cautelari verso un parlamentare. Il giorno seguente, numerose
manifestazioni e proteste ebbero luogo a Roma, di cui la più emblematica quanto
controversa fu il selvaggio lancio di monetine contro lo stesso leader
socialista mentre usciva dall'Hotel Raphael, la sua residenza romana.
Nel 1994 Craxi non fu ricandidato in parlamento, fatto che fece venire meno la
sua immunità parlamentare. Per evitare il rischio di fuga, le autorità gli
ritirarono il passaporto, ma ormai era tardi: con un gesto controverso, infatti,
il leader socialista aveva già lasciato l'Italia per raggiungere la sua casa di
Hammamet, in Tunisia, dove non avrebbe avuto problemi di estradizione. Da quel
momento, Craxi continuò a vivere nel paese nordafricano, considerato un esiliato
dai suoi sostenitori e un latitante dai suoi detrattori, fino alla sua morte,
avvenuta in seguito a una lunga malattia il 19 gennaio del 2000. Il presidente
del consiglio Massimo D'Alema propose i funerali di stato per Craxi, ma oltre ai
detrattori del leader PSI, anche la famiglia dell'ex premier si disse contraria,
dopo che lo stesso governo non gli aveva permesso il ritorno in Italia per
curarsi. La sua tomba, situata nel cimitero di Hammamet, è simbolicamente
rivolta verso l'Italia.
Bettino Craxi, l’esempio dell’Unità di Staino e lo strillo del
Fatto di Travaglio, scrive Francesco Damato su
"Formiche,net" il 20 gennaio 2017. Mentre nella Sala Zuccari di Palazzo
Giustiniani il presidente del Senato in persona, Pietro Grasso, presentava un
volume intitolato “Il libro dell’Incontro- Vittime e responsabili della lotta
armata a confronto”, realizzato a cura di padre Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e
Claudia Mazzucato, nella redazione del giornale italiano che si ritiene il
depositario assoluto della legalità, Il Fatto Quotidiano nato da una costola
dell’Unità dei tempi di Antonio Padellaro e di Marco Travaglio, che ne erano
usciti, o ne erano stati allontanati, si confezionava la prima pagina di oggi,
20 gennaio 2017, con l’apertura obbligata, naturalmente, sulla tragedia
dell’albergo abruzzese del Gran Sasso travolto da una valanga, e diventato tomba
di non si sa ancora quante vittime, mentre scrivo. Mi chiederete che c’entri – o
che c’azzecchi, direbbe Antonio Di Pietro – la presentazione di quel libro al
Senato e la prima pagina del Fatto Quotidiano con l’apertura sull’evento
obiettivamente più tragico della giornata. Non c’entra nulla, in effetti.
C’entra però il grosso titolo centrale, sotto l’immagine della tomba di neve.
Eccolo, tutto intero: “Rose rosse per te – Il leader del partito più inquisito
d’Italia omaggia lo spirito guida – Alfano, ministro della malavita, sulla tomba
del latitante Craxi – Ad Hammamet una cerimonia “in forma privata” ma con
fotografi e giornalisti – Per Angelino “è un dovere essere qui”. Pagato questo
prezzo, diciamo così, alla legalità offesa dalla presenza del ministro degli
Esteri della Repubblica d’Italia sulla tomba tunisina di Bettino Craxi nel
diciassettesimo anniversario della morte, accorsovi sia pure in una “forma
privata”, e perciò riduttiva, che spero, forse inutilmente, di vedere smentita
dall’interessato e pure dal presidente del Consiglio in persona, il conte Paolo
Gentiloni Silverj, che ho conosciuto e conosco come persona civile e a modo, non
come un giustizialista della peggiore risma, il giornale che gli avversari
definiscono, con i soliti e biasimevoli eccessi polemici, “di Beppe Grillo” o
“delle Procure”, ha aggiunto in corsivo, nella solita rubrichetta di prima
pagina chiamata non a caso “Cattiveria”, queste righe: “Il sindaco di
Milano, Giuseppe Sala: penso di dedicare qualcosa a Craxi. San Vittore dovrebbe
bastare”. Non vorrei mettere in imbarazzo più di tanto il mio amico Antonio
Padellaro, col quale cominciammo quasi contemporaneamente questo mestiere ben
più di 50 anni fa: lui all’agenzia Ansa, dove era un solerte cronista
parlamentare, e io al giornale romano del pomeriggio Momento Sera, dove già mi
occupavo di politica. Ma voglio pensare e sperare che ad Antonio, oggi “solo”
presidente della società editrice e collaboratore del quotidiano diretto invece
da Marco Travaglio, non siano granché piaciuti né quel titolo vistoso di mezza
pagina né quella “cattiveria”. Se poi mi vorrà smentire, pazienza. Vuol dire che
è purtroppo pure lui è cambiato troppo rispetto ai tempi, chiamiamoli così,
giovanili. E per colpa naturalmente dei tempi.
A Giorgio Napolitano, allora presidente della Repubblica, bastarono dieci anni
dalla morte di Bettino Craxi per avvertire il bisogno di toglierne la memoria
dalla gabbia nella quale erano riusciti a chiuderla, non essendo stato possibile
farlo con la persona, i magistrati che lo avevano condannato e i loro
gazzettieri sparsi nei tre quarti, ma forse anche di più, delle redazioni
giornalistiche. In una nobile lettera scritta alla vedova di Bettino, Anna,
naturalmente fra i borbottii e le pubbliche rimostranze dei giustizialisti in
servizio permanente effettivo, Napolitano volle e seppe ricordare anche i meriti
politici di Craxi, come leader di partito e capo di governo del suo e nostro
Paese. E delle sue vicende giudiziarie, in particolare del ruolo avuto nella
gestione del diffusissimo fenomeno del finanziamento illegale della politica,
spesso liquidato da inquirenti e giudici come un tutt’uno con la corruzione,
l’allora presidente della Repubblica volle riconoscere onestamente gli aspetti a
dir poco inquietanti per le toghe rilevando la “severità senza uguali” riservata
all’imputato. Se dieci anni bastarono a Napolitano, nella sua veste di uomo, di
militante della sinistra e di capo dello Stato per cercare di riequilibrare la
rappresentazione delinquenziale fatta troppo a lungo di Craxi anche dalle sue
parti politiche, diciassette anni evidentemente non sono bastati per indurre a
qualche riflessione finalmente umana i Travagli di turno. Che tristezza. A Craxi
si nega addirittura quello che, all’ombra di un libro, è stato concesso dal
presidente del Senato nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani ai terroristi
che insanguinarono il Paese negli anni di piombo. Si nega cioè il diritto al
rispetto, alla considerazione, alla pietà, alla comprensione: chiamatela come
volete. Si dice che molti di quegli assassini, al netto di chi è riuscito a
farla franca per l’omertà dei compagni finiti invece in galera, e usciti spesso
con anticipo grazie alla generosa applicazione delle norme che notoriamente si
applicano agli avversari e si interpretano per gli amici, hanno pagato i loro
“debiti giudiziari”. Il fatto che Craxi abbia pagato i suoi errori, che
certamente ci furono, addirittura con la vita, costretto a curarsi male, o meno
bene di quanto si sarebbe potuto fare in Italia, a causa di quella “severità
senza uguali” – per dirla con Napolitano – riservatagli dalla magistratura,
evidentemente non basta a lor signori giustizialisti.
Temo a questo punto che costerà cara ad un dirigente comunista come Umberto
Ranieri la scelta di scrivere per L’Unità, peraltro nuovamente a rischio di
liquidazione, nonostante i generosi sforzi di direzione compiuti dal buon Sergio
Staino, un articolo su Craxi, proprio nel diciassettesimo anniversario della
morte, richiamato in prima pagina con questo piccolo ma significativo titolo:
“La nostra storia – La difficile eredità di Craxi”. In quella “nostra storia”
c’è già abbastanza per apprezzare l’onestà di un comunista o post-comunista che
non a caso è cresciuto alla scuola di Giorgio Napolitano. “La nostra storia”
dovrebbe dire qualcosa anche al segretario del Pd Matteo Renzi, se veramente
vuole rappresentare, come ha detto nell’intervista recentemente rilasciata
a Repubblica tornando sulla scena politica, una sinistra che per essere moderna
deve decidersi a diventare davvero “garantista”. Cosa, questa, che dovrebbe
impedire all’ex presidente del Consiglio di tornare a parlare di Craxi, che lo
ha preceduto di decenni in tante visoni proprio della sinistra, come di un uomo
sprovvisto di “valore pedagogico”, per cui come sindaco di Firenze egli si
rifiutò di discutere della possibilità di dedicargli una via o un angolo della
città.
La difficile eredità di Craxi, scrive
Umberto Ranieri il 20 gennaio 2017 su “L’Unità. Da anni è in corso una
riflessione sull’opera del primo socialista presidente del Consiglio. Sono
trascorsi diciassette anni dalla morte di Bettino Craxi avvenuta in solitudine e
lontano dall’Italia. Da anni è in corso una riflessione sull’opera del primo
socialista presidente del Consiglio, dal 1983 al 1987. Un lavoro di ricerca
promosso da personalità politiche e da storici che ha messo capo alla
pubblicazione di studi e testimonianze, che si propone una valutazione equanime
e scevra da pregiudizi della vicenda politica di Craxi protagonista di un intero
periodo della storia nazionale, quello che dalla seconda metà degli anni
Settanta giunge alla crisi del sistema dei partiti che aveva retto per oltre un
quarantennio l’Italia. Il passato nella storia di un grande Paese va analizzato
con scrupolo e serietà e l’analisi non può essere sostituita da sentenze
sommarie e unilaterali.
Vi racconto chi ha ricordato Bettino Craxi ad Hammamet,
scrive Paola Sacchi su “Formiche.net” il 20 gennaio 2017. Poco dopo che il
Muezzin ha fatto la sua preghiera diffusa dagli altoparlanti e il sole di un
tramonto rosso fuoco si è tuffato nel mare di fronte alle lapidi bianche del
cimitero cristiano di Hammamet, l’Italia politica, per la prima volta
rappresentata dal ministro degli Esteri di un governo guidato da un premier di
centrosinistra, si reca a rendere omaggio alla tomba di Bettino Craxi. È
accaduto ieri 19 gennaio, giorno del diciassettesimo anniversario della
scomparsa dello statista socialista, lontano dall’Italia, negli infiniti giorni
dell’abbandono, ad Hammamet. Il tabù si rompe quando Angelino Alfano, che di
centrosinistra non è ma è il titolare della Farnesina e il leader del Nuovo
Centrodestra, alleato decisivo del Pd – di cui il capo del governo Paolo
Gentiloni è tra i fondatori – varca poco dopo le 18 l’ingresso del piccolo
cimitero, luogo simbolo della fine della nostra Prima Repubblica, sotto la
Medina, affacciato sul mare. Abbraccia, il ministro degli Esteri italiano, la
signora Anna, vedova di Bettino, e i figli dell’ex premier e leader del
Psi, Bobo e Stefania Craxi, ex sottosegretario agli Esteri del governo
Berlusconi, presidente della Fondazione dedicata alla memoria del padre. È stata
lei, Stefania, l’artefice della svolta. Come ha già dichiarato in un’intervista
a Il Corriere della sera, venuta a sapere della visita di Alfano in Tunisia lo
ha invitato a rendere omaggio alla tomba del padre, “con il quale dopo 17 anni
l’Italia deve fare i conti”. E “Alfano ha subito volentieri accettato,
prendendosi anche qualche attacco su Facebook”, racconta la Craxi
a Formiche.net. “Ciao Stefania, ciao Bobo, buonasera signora Anna, le devo
portare un messaggio del Presidente Essebsi (Capo di Stato tunisino ndr)”, così
esordisce al suo arrivo il ministro degli Esteri che si stringe alla famiglia
Craxi. Resta accanto a loro, commosso, per alcuni minuti in silenzio di fronte
alla lapide dove campeggia, per volontà dello statista socialista, la scritta:
“La libertà equivale alla mia vita”. Intorno i garofani rossi, simbolo del Psi
di Bettino. E tanti militanti ed ex dirigenti socialisti che ogni anno il 19
gennaio volano in Tunisia con la Fondazione Craxi. Al cimitero cristiano di
Hammamet, di fronte al quale c’è quello islamico, si erano già recati altri
ministri ed esponenti di governo come Renato Brunetta, Franco
Frattini e Maurizio Sacconi, però tutti rappresentanti degli esecutivi di Silvio
Berlusconi che ha sempre difeso la memoria del suo “amico Bettino”. E che anche
ieri ha inviato “a Stefania” un messaggio dove dice: “Sono con voi con il cuore.
È difficile pensare che siano passati diciassette anni da quando ci ha lasciati
e molti di più da quando un colpo di Stato lo ha privato del suo ruolo politico
e della possibilità di vivere da uomo libero nel suo Paese”. Berlusconi ricorda
che “la grandezza di Craxi è stata quella di porsi per primo il problema di un
profondo rinnovamento del sistema politico italiano, di una modernizzazione
indispensabile”. E ancora, scrive il leader di Forza Italia: “Craxi era un uomo
di sinistra che ha provato a dimostrare che esiste una sinistra senza soggezione
ai comunisti, senza nostalgie utopistiche, senza giustizialismo”. Stefania
ringrazia Berlusconi per “le belle parole e le significative riflessioni sulle
pagine oscure che portarono alla fine della Prima Repubblica, un vero e proprio
colpo di Stato, che ancora oggi inquina la vita politica e istituzionale del
nostro Paese”. Affrontarle “non è un mero esercizio storico, ma missione
necessaria per chi si pone il problema del domani”. Lo stesso concetto della
sfida di Craxi alla sinistra comunista, sottolineato da Berlusconi, lo ripete
Alfano, ex delfino del Cav, ex segretario nazionale del Pdl, il fondatore di Ncd
che poi abbandonò “Silvio” per proseguire sulla strada delle larghe intese con
il Pd. Chiede Formiche.net al ministro degli Esteri se la “svolta” della sua
visita a Hammamet possa significare l’inizio di una revisione da parte del Pd
di Matteo Renzi, suo principale alleato e azionista di maggioranza del governo
Gentiloni, del giudizio su Craxi, fino ad abbattere il muro della damnatio
memoriae a sinistra nei confronti dello statista socialista. Alfano così
risponde a Formiche.net: “Quando Craxi era primo ministro io ero alle scuole
medie, appartengo quindi a una generazione che si può permettere di esprimere un
giudizio sugli esiti della sua vicenda politica dal punto di vista delle sue
lungimiranti intuizioni. Che vanno dalle libertà religiose (rinnovo del
Concordato Stato-Chiesa ndr), alle vicende con l’Est dell’Europa, dove Craxi
difese i dissidenti sovietici, all’integrazione europea, a tutto quanto ha
caratterizzato la sua visione sul Medio Oriente e il Mediteranno, ma anche la
modernizzazione della nostre istituzioni statali e le sue scelte sulle questioni
economiche, come il decreto di S. Valentino sulla scala mobile. Ecco, queste
sono tutte cose che dimostrano che lui aveva visto lungo”. Prosegue Alfano, nel
colloquio con Fomiche.net: “Craxi aveva visto lungo sulla necessità di una
sinistra italiana riformatrice che non fosse sotto il cappello del Partito
comunista italiano. Quindi, sulle questioni di fondo, lui ebbe una direzione di
marcia che la Storia dimostrò poi essere vera”. Conclude il nostro ministro
degli Esteri: “Non esiste damnatio memoriae per coloro che hanno il
riconoscimento dalla Storia della correttezza delle proprie intuizioni”. Bobo
Craxi giudica il gesto di Alfano “nobile e coraggioso”. Osserva l’ex
sottosegretario agli Esteri del governo D’Alema: “È un gesto che impegna il
governo, perché il ministro degli Esteri è la punta di diamante di un esecutivo.
In Italia ormai è iniziata una revisione. Gli italiani rimpiangono gli statisti
della Prima Repubblica”. Racconta Anna Craxi a Formiche.net, facendo una raro
strappo al suo noto riserbo: “Non facciamo in tempo a mettere il registro delle
presenze davanti alla tomba che si riempie subito. Abbiamo registrato quasi
20.000 firme ogni anno, molti italiani scrivono: Bettino, con te non saremmo
messi così male. Ma io ho visto anche tante firme e frasi di turisti stranieri,
tedeschi, inglesi…”. Ora le presenze sono un po’ calate, dopo il terrorismo
internazionale che ha colpito la Tunisia e la continua a lambire. Spiega
Stefania: “Non dimenticheremo mai quello che la Tunisia ha fatto per mio padre e
per la mia famiglia. Oggi quel popolo che seppe dare una lezione di coraggio e
di libertà nel rispetto delle leggi e del diritto internazionale, vive una fase
difficile e travagliata della sua storia millenaria ed ha bisogno che l’Italia,
l’Europa e le istituzioni internazionali aiutino con la forza dei fatti e non
delle parole questa giovane democrazia, argine del caos libico”. Di questo hanno
parlato il presidente tunisino Caid Essebsi e il ministro Alfano. Che prima di
tornare in Italia ha sostato per un tè alla menta al Caffè del Moro, alla
Medina, accanto a Stefania e Bobo, sotto il ritratto di Craxi, vestito con la
sahariana degli anni dell’esilio. Sotto quel ritratto, che raffigura Craxi con
espressione addolorata e pensosa e lo sguardo rivolto al di là del mare, verso
l’Italia, c’era il tavolo di Bettino. Il convitato di pietra della nostra
politica. Con la sua memoria l’Italia, anche quella dei governi a maggioranza di
centrosinistra, come la visita di Alfano ha dimostrato, deve fare i conti.
L'attualità di Craxi e la memoria corta della sinistra.
Tante persone, tra cui molti giovani, a 16 anni di distanza si recano sulla
tomba di Craxi per deporre un garofano rosso. Tra questi, ancora una volta,
mancano gli esponenti di una sinistra vecchia e nuova che con la sua storia e
con la sua eredità politica non vuole proprio fare i conti, scrive Stefania
Craxi, Martedì 19/01/2016, su "Il Giornale". Ricorre oggi il sedicesimo
anniversario della scomparsa di Bettino Craxi, leader socialista ed antesignano
di una sinistra riformista e di governo. Come consuetudine la Fondazione a lui
intitolata organizzerà dal 22 al 24 gennaio gli eventi celebrativi in Tunisia,
ad Hammamet, che date le circostanze politiche internazionali avranno un
significato particolare. Non è solo un omaggio ad un uomo che ha sempre agito
nell'interesse del suo Paese ma si vuole ribadire la necessità di un impegno
italiano nella vasta area del Mediterraneo allargato come nelle intuizioni di
Craxi, la cui incessante opera di dialogo e mediazione rappresenta una speranza
ed una via d'uscita per i popoli che insistono nel Mare nostrum. Craxi capì con
grande lungimiranza che l'integrazione ed il dialogo avrebbero rappresentato la
grande questione del nostro tempo. Quando si prodigò per l'abbattimento del
debito dei Paesi del Terzo mondo lo fece perché capì che laddove prospera il
bisogno e la povertà attecchiscono gli estremismi. Craxi disse che in un mondo
in cui le disuguaglianze tra Nord e Sud del mondo sono ampie non vi potrà essere
pace e lo scontro tra culture sarà ineludibile. Se l'Europa, ed ancor di più
l'Italia, vogliono ancora dire con forza e credibilità la loro devono riprendere
con decisione la via del Mediterraneo facendosi promotori di un grande piano
Marshall per la costruzione di una vasta regione euro-mediterranea. La Tunisia,
che garantì a Craxi la sua libertà, che come egli ebbe a dire equivaleva alla
sua stessa vita, continua a rappresentare l'unico esperimento positivo nel
panorama delle «Primavere arabe» e sono ben chiare le ragioni per cui è
diventata un obiettivo sensibile. È quindi ben evidente l'attualità del pensiero
di Craxi. Spiace che se fosse stata seguita con la stessa tenacia la strada da
lui indicata ed intrapresa, tante tragedie e tanti conflitti dei nostri giorni
si sarebbero risparmiati. È con questo spirito che tante persone, tra cui molti
giovani, a 16 anni di distanza si recheranno sulla sua tomba a deporre un
garofano rosso. Tra questi, ancora una volta, mancheranno gli esponenti di una
sinistra vecchia e nuova che con la sua storia e con la sua eredità politica non
vuole proprio fare i conti.
Una via per Bettino. Dopo 17 anni Craxi può tornare a Milano.
Nell'anniversario delle morte il sindaco Sala si dice favorevole all'omaggio:
"Mi piacerebbe sentire cosa ne pensa la città". E il ricordo dell'ex leader
socialista riunisce Berlusconi e Alfano, scrive il 19 Gennaio 2017 "Il Foglio”.
19 gennaio 2000 - 19 gennaio 2017. Sono trascorsi 17 anni dalla morte, ad
Hammamet, di Bettino Craxi. Evidentemente pochi in un Paese come l'Italia. Pochi
per poter pensare che la memoria del leader Psi non riporti a galla le solite
polemiche. Ma mentre i "puri" continuano a lanciare monetine, altrove qualcosa
sembra cambiare. A Milano, ad esempio, il sindaco Giuseppe Sala, si è detto
disponibile a riaprire il dibattito sull'intitolazione di una via o di un luogo
della città a Craxi. Per ora nessuna decisione ma, ha spiegato, "sono favorevole
e mi piacerebbe sentire che cosa ne pensa la città. Vorrei riaprire un dibattito
per stabilire il più possibile la verità storica in riferimento ad un periodo
difficile per la storia italiana". In realtà non è la prima volta che si parla
di questa possibilità. Era già successo durante la giunta Moratti, nel 2009, ma
poi l'idea si era arenata. Non è l'unica novità di questo anniversario. Nel
celebrare Bettino Craxi anche Silvio Berlusconi e Angelino Alfano, a modo loro,
si sono ritrovati. Il ministro degli Esteri, primo di un governo di
centrosinistra dai tempi dei funerali del leader socialista, trovandosi in
Tunisia ha deciso di recarsi ad Hammamet dove, insieme alla moglie e ai figli di
Craxi ha deposto un mazzo di rose sulla tomba. "Non sono il primo a rendere
omaggio alla tomba di Bettino Craxi - ha detto -. Presidenti della Camera,
membri di governo sono stati qui. Oggi per me è stato un po' un piacere un po'
un dovere, trovandomi in Tunisia in visita ufficiale. Craxi da primo ministro e
da leader politico ci aveva visto lungo, in profondità e sulle grandi questioni
della modernizzazione ci aveva anche preso, come ad esempio sulla riforma
delle istituzioni dello Stato per renderle più moderne ed efficienti. Su ogni
questione su cui aveva gettato lo sguardo aveva indovinato la direzione". Silvio
Berlusconi ha invece inviato un messaggio: "Mi manca e ci manca è stato
un simbolo della dignità della politica. È difficile pensare che siano già
trascorsi 17 anni da quando ci ha lasciato e molti di più da quando un vero e
proprio 'colpo di Stato' lo ha privato del suo ruolo politico e della stessa
possibilità di vivere da uomo libero nel suo Paese. È difficile credere che sia
passato tanto tempo perché Bettino è presente, è attuale, è anche oggi un
protagonista del dibattito politico. Questo perché la grandezza di Bettino Craxi
è stata anche quella di saper guardare al di là delle contingenze, è stata
quella di porsi per primo il problema di un profondo rinnovamento del
sistema politico italiano, di una sua apertura, di una
modernizzazione indispensabile". Stefania Craxi, parlando con l'Agi, ha definito
la visita di Alfano "un atto di giustizia di cui sono grata al ministro, che
vorrei ringraziare, così come ringrazio Berlusconi che anche in questa occasione
non ha fatto mancare il sostegno alla mia famiglia, con un messaggio in cui
parla apertamente di 'colpo di Stato' che ha costretto Craxi all'esilio". La
figlia di Bettino ha voluto ringraziare anche Sala, che "con onestà
intellettuale ha riaperto il dibattito sull'omaggio doveroso che Milano dovrebbe
a un grande milanese".
Vittorio Sgarbi: “Craxi scopava Moana Pozzi che lo spiava”, scrive "Blitz
Quotidiano" l'11 gennaio 2017. “Bettino Craxi scopava con Moana Pozzi, che lo
spiava”: battuta o verità? Difficile capire dove finisca la provocazione e dove
inizi la rivelazione, se a parlare è Vittorio Sgarbi. Ma tant’è. Il critico
d’arte ferrarese è intervenuto all’ultima puntata di Matrix, il programma di
Canale 5 condotto da Nicola Porro, che aveva per oggetto lo spionaggio a Matteo
Renzi e Mario Draghi, a ministri e autorità, da parte dei due fratelli
Occhionero, Giulio e Francesca Maria. Sgarbi interviene parlando delle pornostar
spie. “Ma voi lo sapevate che la gola profonda che ha rivelato che Moana Pozzi
era una spia del KGB era Eva Henger?”, dice, parlando di una “rete di pornostar
che aspirano ad elevarsi al rango di Mata Hari”. E poi, quasi en passant:
“Bettino Craxi se la sc… e lei lo spiava”.
Ecco come Giorgio Dell’Arti racconta il rapporto tra Craxi e Moana Pozzi:
Conobbe Bettino Craxi a un cena: «Cominciò a farmi un sacco di complimenti (…)
Ero gratificata (…) Due giorni dopo mi telefonò… Uscimmo soli. Cenammo in
albergo e finimmo in camera. Lo feci per il carisma, non per altro. Allora non
era nemmeno presidente. A lui piacevano più i preliminari che la cosa in sé. Era
in adorazione per le donne, ti copriva di attenzioni, si preoccupava» [Moana
Pozzi –La filosofia di Moana 1991].
"Mi manca Bettino, vittima di un golpe". Ecco l'intervento che il Cav ha rivolto
ai famigliari dell'ex leader socialista. Silvio Berlusconi, Venerdì 20/01/2017,
su "Il Giornale". "Cara Stefania, cari amici, sono con voi con il cuore oggi a
ricordare Bettino Craxi nel 17^ anniversario della sua scomparsa. È difficile
pensare che siano già trascorsi 17 anni da quando ci ha lasciato e molti di più
da quando un vero e proprio «colpo di Stato» lo ha privato del suo ruolo
politico e della stessa possibilità di vivere da uomo libero nel suo Paese. È
difficile credere che sia passato tanto tempo perché Bettino è presente, è
attuale, è anche oggi un protagonista del dibattito politico. Questo perché la
grandezza di Bettino Craxi è stata anche quella di saper guardare al di là delle
contingenze, è stata quella di porsi per primo il problema di un profondo
rinnovamento del sistema politico italiano, di una sua apertura, di una
modernizzazione indispensabile. Non gli hanno permesso di realizzare il suo
progetto, e forse come tutti noi ha commesso degli errori, ma rimarrà a suo
onore nella storia il merito di averne intuito la necessità, e di aver avuto il
coraggio di provarci. Craxi era un uomo di sinistra, che ha provato a dimostrare
che esiste una sinistra possibile senza soggezione ai comunisti, senza nostalgie
utopistiche, senza giustizialismo, una sinistra capace di parlare il linguaggio
della modernizzazione e soprattutto della libertà. Questa sinistra non è mai
esistita in Italia, e non esiste neppure ora: coloro che hanno provato a
realizzarla sono stati spazzati via da quell'altra sinistra, quella
giustizialista e post-comunista, quella delle manette e degli insulti, delle
monetine e dei linciaggi mediatici. Solo chi è stato vittima di tutto questo può
capire il dramma di Bettino Craxi, ma anche la grandezza della sua
testimonianza: scelse la strada dell'esilio pur di non venire a patti con questo
apparato politico-mediatico-giudiziario che uccide la libertà e la democrazia.
La sua eredità politica, il socialismo riformatore, liberale, occidentale è una
delle parti migliori della tradizione politica del nostro Paese. La considero
parte integrante del progetto politico che ho creato quando ho fondato Forza
Italia, anche per impedire che l'Italia cadesse nelle mani della sinistra
post-comunista. Continuo a credere che questa tradizione politica riformista,
assieme a quella liberale e a quella cristiana, siano i fondamenti sui quali
costruire il futuro dell'Italia. Bettino Craxi è anche un simbolo della dignità
della politica. Per questo sono onorato ogni volta che il mio nome viene
accostato al suo, per quanto la cosa avvenga spesso con intenti polemici, come
qualche giornale ha fatto anche oggi. In effetti il nostro rapporto non
c'entrava molto con la politica, della quale allora non mi occupavo se non come
elettore: con Bettino e la sua famiglia nacquero un'amicizia e un affetto
personale che vanno al di là delle stesse opinioni politiche. Frequentandolo ho
imparato a stimarlo non solo come amico leale, ma come uomo generoso e
disinteressato esattamente il contrario di come lo ha dipinto certa stampa come
politico appassionato alle idee e disinteressato del potere. Posso anzi
testimoniare che negli anni in cui svolgevo l'attività di imprenditore, e
nonostante la grande confidenza personale, Craxi è stato uno dei pochissimi
politici a non sollecitare favori economici diretti o indiretti per sé e per il
suo partito. Anche per questo Bettino Craxi mi manca e ci manca. Anche per
questo vorrei essere con Voi, nella bellissima cornice di Hammamet, vorrei
tornare in quel piccolo e suggestivo cimitero sotto le mura e davanti al mare,
nel quale Bettino chiese di essere sepolto. Vorrei essere lì con Voi per rendere
ancora una volta omaggio a un amico, ad un uomo libero, ad uno statista. A tutti
voi, e in particolare ad Anna, a Stefania, a Bobo, a cui mi legano tanti
ricordi, e a tutti gli amici presenti rivolgo un saluto cordiale e un abbraccio
affettuoso.
Da anticraxiano vi dico: gli dobbiamo qualcosa,
scrive Piero Sansonetti il 19 gennaio 2017 su "Il Foglio". Il 19 gennaio del
2000 moriva esule in Tunisia. Lo hanno fatto passare per un brigante ma era uno
statista. Fu abbattuto da Mani Pulite: era rimasto l’unico a difendere
l’autonomia della politica. Da allora la politica ha perso autonomia. Il 19
gennaio del 2000, e cioè 17 anni fa, moriva Bettino Craxi. Aveva 65 anni, un
tumore al rene curato male, un cuore malandato, curato malissimo. Il cuore a un
certo punto si fermò. Non fu fatto molto per salvarlo. Non fu fatto niente,
dall’Italia. Craxi era nato a Milano ed è morto ad Hammamet, in Tunisia, esule.
Era stato segretario del partito socialista per quasi vent’anni e presidente del
Consiglio per più di tre. In Italia aveva subito condanne penali per
finanziamento illecito del suo partito e per corruzione. Quasi dieci anni di
carcere in tutto. Prima delle condanne si era trasferito in Tunisia. Se fosse
rientrato sarebbe morto in cella. Craxi ha sempre respinto l’accusa di
corruzione personale. Non c’erano prove. E non furono mai trovati i proventi. In
genere quando uno prende gigantesche tangenti e le mette in tasca, poi da
qualche parte questi soldi saltano fuori. In banca, in acquisti, in grandi
ville, motoscafi. Non furono mai trovati. I figli non li hanno mai visti. La
moglie neppure. Lui non li ha mai utilizzati. Non ha lasciato proprietà,
eredità, tesori. Craxi era un malfattore, o è stato invece uno statista
importante sconfitto da una gigantesca operazione giudiziaria? La seconda
ipotesi francamente è più probabile. La prima è quella più diffusa nell’opinione
pubblica, sostenuta con grande impegno da quasi tutta la stampa, difesa e spada
sguainata da gran parte della magistratura. Craxi era stato uno degli uomini più
importanti e potenti d’Italia, negli anni Ottanta, aveva goduto di grande
prestigio internazionale. Si era scontrato e aveva dialogato con Reagan, col
Vaticano, con Israele e i paesi Arabi, con Gorbaciov, con quasi tutti i leader
internazionali. Aveva sostenuto furiose battaglie con i comunisti in Italia, con
Berlinguer e Occhetto e D’Alema; e anche con la Dc, con De Mita, con Forlani,
epici gli scontri con Andreotti; con la Dc aveva collaborato per anni e
governato insieme. Bene, male? Poi ne discutiamo. Aveva anche firmato con la
Chiesa il nuovo concordato. Morì solo solo. Solo: abbandonato da tutti.
Stefania, sua figlia, racconta di quando la mamma la chiamò al telefono,
nell’autunno del ‘ 99, e le disse che Bettino era stato ricoverato a Tunisi, un
attacco di cuore. Lei era a Milano, si precipitò e poi cercò di muovere mari e
monti per fare curare il padre. Non si mossero i monti e il mare restò immobile.
Craxi fu curato all’ospedale militare di Tunisi. Stefania riuscì ad avere gli
esami clinici e li spedì a Milano, al San Raffaele, lì aveva degli amici. Le
risposero che c’era un tumore al rene e che andava operato subito, se no poteva
diffondersi. Invece passarono ancora due mesi, perché a Tunisi nessuno se la
sentiva di operarlo. Arrivò un chirurgo da Milano, operò Craxi in una sala
operatoria dove due infermieri tenevano in braccio la lampada per fare luce.
Portò via il rene, ma era tardi. Il tumore si era propagato, doveva essere
operato prima, si poteva salvare, ma non ci fu verso. In quei giorni drammatici
dell’ottobre 1999 Craxi era caduto in profonda depressione. Non c’è da stupirsi,
no? Parlava poco, non aveva forse voglia di curarsi. Era un uomo disperato:
indignato, disgustato e disperato. Stefania mi ha raccontato che lei non sapeva
a che santo votarsi: non conosceva persone potenti. Il Psi non esisteva più.
Chiamò Giuliano Ferrara e gli chiese di intervenire con D’Alema. Il giorno dopo
Ferrara gli disse che D’Alema faceva sapere che un salvacondotto per l’Italia
era impossibile, la Procura di Milano avrebbe immediatamente chiesto l’arresto e
il trasferimento in carcere. Stefania chiese a Ferrara se D’Alema potesse
intervenire sui francesi, i francesi sono sempre stati generosi con la
concessione dell’asilo politico. Era più che naturale che glielo concedessero.
Curarsi a Parigi dava qualche garanzia in più che curarsi all’ospedale militare
di Tunisi. Passarono solo 24 ore e Jospin, che era il presidente francese,
rilasciò una dichiarazione alle agenzie: «Bettino Craxi non è benvenuto in
Francia». Quella, più o meno, fu l’ultima parola della politica su Craxi. Fu la
parola decisiva dell’establishment italiano e internazionale. Craxi deve morire.
Il 19 gennaio Craxi – per una volta – obbedì e se andò all’altro mondo. E’
curioso che quasi vent’anni dopo la sua morte, e mentre cade il venticinquesimo
anniversario dell’inizio della stagione di Tangentopoli ( Mario Chiesa fu
arrestato il 17 febbraio del 1992, e da lì cominciò tutto, da quel giorno iniziò
la liquidazione della prima repubblica), qui in Italia nessuno mai abbia voluto
aprire una riflessione su cosa successe in quegli anni, sul perché Craxi fu
spinto all’esilio e alla morte, sul senso dell’inchiesta Mani Pulite, sul peso
della figura di Craxi nella storia della repubblica. Ci provò Giorgio
Napolitano, qualche anno fa. Ma nessuno gli diede retta. Vogliamo provarci?
Partendo dalla domanda essenziale: Statista o brigante. Forse sapete che Bettino
Craxi negli anni Ottanta scriveva dei corsivi sull’Avanti!, il giornale del suo
partito, firmandoli Ghino di Tacco. Ghino era un bandito gentiluomo vissuto
verso la metà del 1200 dalle parti di Siena, a Radicofani. Boccaccio parla di
lui come una brava persona. A Craxi non dispiaceva la qualifica di brigante.
Perché era un irregolare della politica. Uno che rompeva gli schemi, che non
amava il political correct. Però non fu un bandito e fu certamente uno statista.
Persino Gerardo D’Ambrosio, uno dei più feroci tra i Pm del pool che annientò
Craxi, qualche anno fa ha dichiarato: non gli interessava l’arricchimento, gli
interessava il potere politico. Già: Craxi amava in modo viscerale la
politica. La politica e la sua autonomia. Attenzione a questa parola di origine
greca: autonomia. Perché è una delle protagoniste assolute di questa storia.
Prima di parlarne però affrontiamo la questione giudiziaria. Era colpevole o
innocente? Sicuramente era colpevole di finanziamento illecito del suo partito.
Lo ha sempre ammesso. E prima di lasciare l’Italia lo proclamò in un famosissimo
discorso parlamentare, pronunciato in un aula di Montecitorio strapiena e
silente. Raccontò di come tutti i partiti si finanziavano illegalmente: tutti.
Anche quelli dell’opposizione, anche il Pci. Disse: se qualcuno vuole smentirmi
si alzi in piedi e presto la storia lo condannerà come spergiuro. Beh, non si
alzò nessuno. Il sistema politico in quegli anni – come adesso – era molto
costoso. E i partiti si finanziavano o facendo venire i soldi dall’estero o
prendendo tangenti. Pessima abitudine? Certo, pessima abitudine, ma è una cosa
molto, molto diversa dalla corruzione personale. E in genere il reato, che è
sempre personale e non collettivo, non era commesso direttamente dai capi dei
partiti, ma dagli amministratori: per Craxi invece valse la formula, del tutto
antigiuridica, “non poteva non sapere”. Craxi era colpevole. Nello stesso modo
nel quale erano stati colpevoli De Gasperi, Togliatti, Nenni, la Malfa, Moro,
Fanfani, Berlinguer, De Mita, Forlani… Sapete di qualcuno di loro condannato a
10 anni in cella e morto solo e vituperato in esilio? Ecco, qui sta
l’ingiustizia. Poi c’è il giudizio politico. Che è sempre molto discutibile.
Craxi si occupò di due cose. La prima era guidare la modernizzazione dell’Italia
che usciva dagli anni di ferro e di fuoco delle grandi conquiste operaie e
popolari, e anche della grande violenza, del terrorismo, e infine della crisi
economica e dell’inflazione. Craxi pensò a riforme politiche e sociali che
permettessero di stabilizzare il paese e di interrompere l’inflazione. La
seconda cosa della quale si preoccupò, strettamente legata alla prima, era la
necessità di salvare e di dare un ruolo alla sinistra in anni nei quali, dopo la
vittoria di Reagan e della Thatcher, il liberismo stava dilagando. Craxi cercò
di trovare uno spazio per la sinistra, senza opporsi al liberismo. Provò a
immaginare una sinistra che dall’interno della rivoluzione reaganiana ritrovava
una sua missione, attenuava le asprezze di Reagan e conciliava mercatismo e
stato sociale. Un po’ fu l’anticipatore di Blair e anche di Clinton (e anche di
Prodi, e D’Alema e Renzi…). Craxi operò negli anni precedenti alla caduta del
comunismo, ma si comportò come se la fine del comunismo fosse già avvenuta.
Questa forse è stata la sua intuizione più straordinaria. Ma andò sprecata.
Personalmente non ho mai condiviso quella sua impresa, e cioè il tentativo di
fondare un liberismo di sinistra. Così come, personalmente, continuo a pensare
che fu un errore tagliare la scala mobile, e che quell’errore di Craxi costa
ancora caro alla sinistra. Ma questa è la mia opinione, e va confrontata con la
storia reale, e non credo che sia facile avere certezze. Quel che certo è che
Craxi si misurò con questa impresa mostrando la statura dello statista, e non
cercando qualche voto, un po’ di consenso, o fortuna personale. Poi possiamo
discutere finché volete se fu un buono o un cattivo statista. Così come possiamo
farlo per De Gasperi, per Fanfani, per Moro. E qui arriviamo a quella parolina:
l’autonomia della politica. Solo in una società dove esiste l’autonomia della
politica è possibile che vivano ed operano gli statisti. Se l’autonomia non
esiste, allora i leader politici sono solo funzionari di altri poteri.
Dell’economia, della magistratura, della grande finanza, delle multinazionali…In
Italia l’autonomia della politica è morta e sepolta da tempo. L’ha sepolta
proprio l’inchiesta di Mani Pulite. C’erano, negli anni Settanta, tre leader,
più di tutti gli altri, che avevano chiarissimo il valore dell’autonomia. Uno
era Moro, uno era Berlinguer e il terzo, il più giovane, era Craxi. Alla fine
degli anni Ottanta Moro e Berlinguer erano morti. Era rimasto solo Craxi. Io
credo che fu essenzialmente per questa ragione che Craxi fu scelto come
bersaglio, come colosso da abbattere, e fu abbattuto. Lui era convinto che ci fu
un complotto. Sospettava che lo guidassero gli americani, ancora furiosi per lo
sgarbo che gli aveva fatto ai tempi di Sigonella, quando ordinò ai carabinieri
di circondare i Marines che volevano impedire la partenza di un aereo con a
bordo un esponente della lotta armata palestinese. I carabinieri spianarono i
mitra. Si sfiorò lo scontro armato. Alla fine, in piena notte, Reagan cedette e
l’aereo partì. Sì, certo, non gliela perdonò. Io non credo però che ci fu un
complotto. Non credo che c’entrassero gli americani. Penso che molte realtà
diverse (economia, editoria, magistratura) in modo distinto e indipendente, ma
in alleanza tra loro, pensarono che Tangentopoli fosse la grande occasione per
liquidare definitivamente l’autonomia della politica e per avviare una
gigantesca ripartizione del potere di stato. Per questo presero Craxi a simbolo
da demolire. Perché senza di lui l’autonomia della politica non aveva più
interpreti. Dal punto di vista giudiziario “mani pulite” ha avuto un risultato
incerto. Migliaia e migliaia di politici imputati, centinaia e centinaia
arrestati, circa un terzo di loro, poi, condannati, moltissimi invece assolti
(ma azzoppati e messi al margine della lotta politica), diversi suicidi, anche
illustrissimi come quelli dei presidenti dell’Eni e della Montedison. Dal punto
di vista politico invece l’operazione fu un successo. La redistribuzione del
potere fu realizzata. Alla stampa toccarono le briciole, anche perché nel
frattempo era sceso in campo Berlusconi. All’imprenditoria e alla grande finanza
andò la parte più grande del bottino, anche perché decise di collaborare
attivamente con i magistrati, e dunque fu risparmiata dalle inchieste. Quanto
alla magistratura, portò a casa parecchi risultati. Alcuni molto concreti: la
fine dell’immunità parlamentare, che poneva Camera e Senato in una condizione di
timore e di subalternità verso i Pm; la fine della possibilità di concedere
l’animista; la fine della discussione sulla separazione delle carriere, sulla
responsabilità civile, e in sostanza la fine della prospettiva di una riforma
della giustizia. Altri risultati furono più di prospettiva: l’enorme aumento
della popolarità, fino a permettere al Procuratore di Milano – in violazione di
qualunque etica professionale – di incitare il popolo alla rivolta contro la
politica (“resistere, resistere, resistere… ”) senza che nessuno osasse
contestarlo, anzi, tra gli applausi; il via libera all’abitudine
dell’interventismo delle Procure in grandi scelte politiche ( di alcune parlava
giorni fa Pierluigi Battista sul Corriere della Sera); l’enorme aumento del
potere di controllo sulla stampa e sulla Tv; la totale autonomia. Ora a me
restano due domande. La prima è questa: quanto è stata mutilata la nostra
democrazia da questi avvenimenti che hanno segnato tutto l’ultimo quarto di
secolo? E questa mutilazione è servita ad aumentare il tasso di moralità nella
vita pubblica, oppure non è servita a niente ed è stata, dunque, solo
una grandiosa e riuscita operazione di potere? E la seconda domanda è di tipo
storico, ma anche umano: è giusto che un paese, e il suo popolo, riempiano di
fango una figura eminente della propria storica democratica, come è stato Craxi,
solo per comodità, per codardia, per “patibolismo”, deturpando la verità vera,
rinunciando a sapere cosa è stato nella realtà il proprio passato? Io penso di
no. Da vecchio anticraxiano penso che dobbiamo qualcosa a Bettino Craxi.
FIGLI DI PUTIN...
“Figli di Putin”: di Marco Travaglio.
Mentre in Italia il Parlamento e i giornaloni discutono animatamente della piaga
dei giudici in politica, putribondi figuri che mettono in cattiva luce i
politici pregiudicati, all’estero dilaga la peste giustizialista: dalla Romania
al Brasile alla Russia, la gente scende in piazza addirittura contro la
corruzione e financo in difesa dei magistrati anticorruzione. Lo so, sono scene
orribili che non vorremmo mai vedere, noi che difendiamo orgogliosamente il
primato di Paese più corrotto d’Europa. Ma tant’è: non tutti hanno la nostra
fortuna. Noi, dal virus della legalità, siamo guariti già da un pezzo. Infatti
in questi giorni, 25 anni dopo Mani Pulite, è tutto un autodafé e un’autocritica
per quel clima plumbeo del 1992-’93, che a furor di popolo portava partiti e
movimenti di destra e di sinistra, ma anche giornali (come la Repubblica di
Scalfari e il Giornale di Montanelli) a organizzare manifestazioni, cortei e
fiaccolate contro i politici corrotti e in difesa dei pm di Mani Pulite. I quali
erano contesi a morsi e gomitate dai partiti, che li volevano ministri,
candidati al Parlamento, a sindaci o a incarichi istituzionali per esporli come
trofei e sventolarli come vessilli – scrive Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano
nell’editoriale di oggi 28 marzo 2017, dal titolo “Figli di Putin” –.
Nel ’94 Tiziana Parenti divenne deputato di Forza Italia e presidente della
commissione Antimafia, Di Pietro rifiutò l’offerta di Berlusconi e Previti di
fare il ministro dell’Interno, Davigo quella di Ignazio La Russa di diventare
ministro della Giustizia. Dopodiché “Tonino” lasciò la toga e nel ’95 respinse i
nuovi assalti sia di B. che lo voleva viceleader del centrodestra o capo dei
servizi segreti, di Casini e Buttiglione che lo invocavano come leader del
centro, di Fini e Tremaglia che lo sognavano alfiere della destra, e nel ’96
cedette all’offerta tecnica di Prodi che lo nominò ministro dei Lavori pubblici
e poi a quella politica di D’Alema che nel ’97 lo candidò al Mugello. All’epoca
pareva che il problema dell’Italia fosse quello della corruzione (stimata dal
Centro Einaudi in 10 miliardi di euro all’anno di costi aggiuntivi per le casse
dello Stato), cioè dei ladri, non di chi l’aveva scoperta e sanzionata, cioè le
guardie. Ora che è quasi decuplicata (chi dice 60, chi 80, chi 100 miliardi
all’anno), il problema sono i giudici, che non devono più metter piede in
Parlamento nemmeno per visitarlo, per non infastidire i delinquenti che vi
risiedono in pianta stabile. L’unica forza parlamentare significativa che si
sottrae a questa “narrazione”, a parte i sostenitori di Michele Emiliano, è il
Movimento 5 Stelle, che anzi corteggia alcuni noti pm per il suo eventuale
governo prossimo venturo.
Il che rende incomprensibile il silenzio pentastellato su quanto è accaduto
l’altroieri a Mosca, con l’arresto di ben 1030 manifestanti scesi nelle piazze
di Mosca e di una novantina di altre città russe al seguito della Fondazione
Anticorruzione del noto blogger Alexei Navalny, che intende candidarsi alle
Presidenziali del 2018 contro Vladimir Putin. E da mesi martella sui social la
sua campagna contro i malaffari del presidente-dittatore e del fido premier
Dmitrij Medvedev, entrambi ricchi sfondati con proprietà in mezzo mondo. Navalny
è stato arrestato e condannato su due piedi per manifestazione non autorizzata.
Un clamoroso autogol del Cremlino, che vieppiù lo legittima come candidato
anti-Putin, in un Paese dove chiunque osi presentarsi alle elezioni contro di
lui finisce regolarmente in galera. Il fatto poi che in tutta la Russia, dalla
Capitale a San Pietroburgo alle regioni più remote (Siberia, Urali, Estremo
Oriente) decine di migliaia di cittadini (nella sola Mosca erano 7 mila) abbiano
sfidato il niet del regime per manifestare pacificamente senza il permesso del
Cremlino, come non avveniva dagli anni 80 prima del crollo del muro di Berlino,
dimostra quanto farlocchi siano i risultati plebiscitari tanto delle elezioni
quanto dei sondaggi a favore di Putin. La reazione dell’Europa è stata, al
solito, molto flebile, a parte quella tedesca. Soliti fervorini della Mogherini
per l’Ue e del mogherino Alfano per l’Italia.
Matteo Salvini, immemore delle analogie tra la sua Lega (anzi, di quella di
Bossi) che 25 anni fa manifestava – autorizzata o meno – contro i Putin e
Medvedev della Prima Repubblica, rilascia dichiarazioni demenziali,
frettolosamente tradotte in dialetto padano dal cirillico: “È l’ennesima
montatura mediatica. La manifestazione non era autorizzata. Ho fatto una ricerca
sul personaggio in questione: un blogger anti-Putin, venduto come leader
dell’opposizione. Ma che secondo le stime avrebbe solo il 3%. Insomma, è uno dei
tanti che si oppone a Putin. Mi fa sorridere che Putin sia considerato un
dittatore. La Russia cresce più dell’Italia. Sei mesi fa ci sono state le
elezioni: ha votato il 48% dei russi ed è stato eletto democraticamente un
Parlamento”. Un concentrato di assurdità e illogicità. Ma Salvini ha appena
siglato un “piano di cooperazione” (economica?) col partito di Putin, che piace
molto anche a FI e a mezzo Pd per nobili ragioni affaristiche (se ne occupa
Antonio Padellaro a pagina 11).
Resta da capire perché i 5Stelle tacciano: le manifestazioni del movimento di
Navalny somigliano molto – per l’uso del web, per il tema corruzione, per le
decine di piazze collegate – ai V-Day che nel 2007-2008 tennero a battesimo i
M5S. Chi, se non i 5Stelle dovrebbe difendere la democrazia dal basso contro la
repressione dall’alto e pretendere dal governo e dal Parlamento italiani una
reazione energica contro il regime putiniano che reprime il dissenso, processa
gli oppositori, arresta i manifestanti, perseguita i gay, per non parlare dei
giornalisti critici che raramente hanno il privilegio di morire per cause
naturali. Invece tutti zitti e Mosca.
Alla tv vanno in onda i falsi eredi di Craxi, oggi alleati di una
destra produttrice di barbarie, scrive il 22 gennaio
2004 Arnaldo Sciarelli su “Europa Quotidiano”. Domenica sera a Telecamere il mio
antico compagno Gianni De Michelis ha affermato che è andato con Berlusconi
perché Craxi ha pagato ingiustamente e altri no, e per evitare che Rutelli
diventasse presidente del consiglio.
Premesso che sulla vicenda di Craxi sono da sempre d’accordo per motivi
obiettivi e culturali, vicenda che comunque non ha mai modificato il mio
comportamento ideologico e quindi socialista, con Rutelli presidente ci saremmo
almeno risparmiati la ridicolizzazione subita dal giornalismo mondiale per
avere oggi un presidente che si occupa prevalentemente, attraverso
leggi incomprensibili, di problemi amicali e familiari.
E quando Boselli ha chiesto a De Michelis, giustamente, come può un socialista
che si dichiara ancora tale, stare con leghisti ed ex fascisti, molti dei quali
sono ancora fascisti, e barbari ultraliberisti, vista la difficoltà di Gianni,
La Russa è intervenuto per affermare che i socialisti che stanno con l’Ulivo
sono «capponi» e che Craxi e il Psi sono stati uccisi dagli ex comunisti.
La Russa ha altresì affermato di non aver mai tirato le monetine a Craxi, di
non averne mai parlato male! Povero La Russa. Vista la vicinanza
dell’onorevole Speroni ha dimenticato il cappio della Lega, la presenza dei
Fini boys sotto la direzione del partito in via del Corso, per pareggiare
gli Occhetto boys del Raphael. Ha dimenticato le parole di Fini in
parlamento («Avete assolto un ladro») e la sua richiesta di intervento del capo
dello stato, e altre volgarità della destra, alle quali, purtroppo, si
aggiunsero anche volgarità di una parte della sinistra.
Del resto Davigo e Colombo rappresentavano questa collusione che, mutuando
antiche e comuni convinzioni dal passato, ha affrontato il problema della
corruzione politico-economica, esistente in qualunque paese del mondo, con
un piglio giustizialista che poteva essere evitato nell’interesse vero
della democrazia. E questo vale fondamentalmente per la sinistra perché la
sinistra storica di questo paese, compreso il Pci, il vero Pci, ha combattuto
per la libertà e la democrazia, per la Resistenza e per la Costituzione, e non
può, come mi ricordò un giorno Nilde Jotti nella sua modesta casa di Ansedonia,
dare la sensazione di usare la magistratura per finalità di potere. La Russa ha
anche dimenticato che Berlusconi voleva Di Pietro ministro, che Pera e Feltri
elogiavano Mani Pulite come il Msi e l’onorevole Fini.
È stato davvero uno spettacolo ridicolo al quale poi si è aggiunta, in Tunisia,
la difesa e la rivalutazione di Craxi da parte del senatore Pera il 19 gennaio,
nel quarto anniversario della morte di Bettino. E pensare a Bettino Craxi difeso
da Pera mi lascia perplesso, così come l’enfasi della destra su Saragat che
definì Pertini un eroe.
Io sono fra i pochi che quando Craxi è morto, con antichi compagni come Aniasi
ed Achilli, ha testimoniato su giornali nazionali il ricordo di tutte le
battaglie socialiste condotte insieme. Sinceramente pensare a Bettino Craxi,
figlio del socialista e antifascista, resistente a vita, avvocato Vittorio,
allievo prediletto di Nenni, diffusore dell’idea socialista nelle
sezioni milanesi fin dalla più tenera età, come collega di governo di Gasparri
e Bossi, di Cicchitto e Bondi, e mi fermo per carità di patria, mi viene
da ridere. Come tanti di noi, come due storici del nostro vecchio grande
partito, Tamburrano e Arfé, avrebbe scelto di stare a sinistra, nel solco della
sinistra storica, così come si stabilì nelle ultime riunioni di partito.
Nei confronti del Psi e di Craxi, Di Pietro vale Pera, come Fini, La Russa,
Bossi e altri personaggi del vecchio Pci, che cavalcarono l’ipotesi, immorale e
antigiuridica, dell’individuazione anticipata del colpevole. La storia, la
rivisitazione obiettiva dei fatti, la disparità dei trattamenti riservati da
alcuni magistrati, l’Europa ci condurranno, forse, alla verità. La storia di
Craxi è un problema dei socialisti, di quelli che a sinistra hanno sbagliato e
della famiglia Craxi. La destra, e intendo anche quella ultraliberista, che
per Craxi era produttrice di barbarie, non ha nulla a che vedere con il
pensiero di Craxi. Craxi non credo che accetterebbe la difesa di
questo agglomerato pseudopolitico di destra che, in sostanza, “sgoverna”
questo paese. Basta leggere i suoi interventi, le sue intuizioni, il suo agire,
da Rimini all’Ansaldo.
L’Internazionale, l’unità dei socialisti italiani ed europei, l’attenzione per
il mondo palestinese e arabo-mediterraneo, per le povertà emergenti del nostro
paese, per le povertà evidenti del nostro pianeta, non hanno nulla a che vedere
con qualunque destra. Craxi è rimasto fedele tutta la vita a «Ora e sempre
Resistenza», frase che gridavamo insieme nelle piazze d’Italia con i compagni
greci, spagnoli e portoghesi. Del resto era un fatto genetico. Spero che Bobo
Craxi e Gianni De Michelis lo ricordino, per evitarsi una trasfusione di
sangue verde-azzurronero.
Non esistono veri socialisti che appoggiano governi che si definiscono di
centrodestra. L’Internazionale socialista e il Pse, caro Gianni, quando verrai
eletto deputato europeo – cosa che ti auguro con amicizia e anche per porti un
dilemma – non credo saranno disponibili ad accettare te e il Nuovo Psi ancorati
a un governo di centrodestra. Io spero che tu sceglierai, come Bobo, con il
cuore in petto. Se poi Berlusconi, con Alleanza nazionale nel Ppe, si inventerà
uno pseudocentrosinistra alternativo al nostro, come ho già ipotizzato il
24 dicembre 2003 su queste colonne, la confusione sarà maggiore. Toccherà a noi
dimostrare che si tratta dell’ennesimo imbroglio realizzato dalla parte
conservatrice del Ppe, supportato dal Nuovo Psi e dal Partito repubblicano, per
motivi che non è difficile intuire. Mi risulta che anche il piccolissimo Psdi,
nel commemorare Saragat, ha affermato che i socialisti devono stare
nell’Internazionale, nel Pse e mai con la destra. Abbiamo già le affermazioni, i
pareri e le proposte ideologiche dell’onorevole Berlusconi, del senatore Pera,
dell’onorevole Castelli e dell’onorevole Bossi da subire, sulla nostra
Costituzione, sui magistrati, sull’antifascismo, sulla Resistenza, sulla libertà
della Padania, battaglia lunga e difficile, ma certamente vittoriosa per un
ministro di questa Repubblica! Ciampi fa quello che può, spiega, richiama,
afferma, controbatte. Speriamo bene. E Craxi si sarebbe alleato con questi
personaggi? Con il suo programma di governo, con la sua visione dell’Italia,
amata, perché no, in maniera garibaldina, dell’Europa, del pianeta, della vita
da spendere per gli ideali del socialismo riformista, nell’interesse
dell’umanità. Cerchiamo di essere seri! Aldo Sciarelli
Il primo traditore di Craxi fu suo figlio Bobo.
Accusa il Cavaliere di non essere stato un amico, ma quando scoppiò tangentopoli
disse: Non sono mai stato craxiano, scrive Filippo Facci, Lunedì 14/01/2008, su
"Il Giornale". Meriti la peggiore delle cattiverie, Bobo: la verità. Meriti ciò
che fedeli e amici di tuo padre, anzi del padre di tua sorella Stefania, si sono
ripetutamente e sommessamente ripetuti per anni, silenziosamente, scuotendo la
testa, consolandosi nella speranza che peggio, in fondo, tu non potessi dire né
fare. E invece sì, ci riesci ogni volta, ci riesci per la vergogna nostra: e
parlo senza timor di smentita di compagni e amici e ripeto familiari che Bettino
Craxi amava senza disperazione, com’era invece nel tuo caso. Ora ti sei
inventato questo, Bobo: che Silvio Berlusconi non andò ad Hammamet dal 1994 al
2000 e che dunque non fu un buon amico. «È evidente che ha tradito un rapporto».
Vien da rispondere che il rapporto intellettivo con tuo padre, tu, l’hai tradito
alla nascita, Bobo, ma sarebbe una battuta becera e degna di quell’Umberto
Cicconi, ex fotografo di tuo padre, che resta il tuo intellettuale di
riferimento. Niente battute, Bobo, la verità basta e avanza. Perché vedi, tu eri
il figlio con dei problemi, quello che avrebbe fatto sembrare un lavoratore
persino Claudio Martelli, il figlio da sopportare nonostante la sua arroganza
che faceva danni incommensurabili ogni qualvolta apriva bocca. Eri quello che
non aveva né ha mai lavorato in vita sua e che da solo non avrebbe sfondato in
politica neppure in dieci vite, il figlio che boicottava ogni giovane anima di
cui tuo padre, pardon il padre di tua sorella, amava circondarsi anche ad
Hammamet: nella speranza che qualcuno, certo non tu, potesse raccogliere il suo
testimone politico e comportarsi magari come un figlio. Ti fu perdonato tutto,
Bobo: persino quella volta che ti scappò quel «non mi sono mai considerato un
craxiano» dopo il primo avviso di garanzia spedito al tuo ex padre, nel dicembre
1992, quando stavi per tentare il salto del quaglione tra coloro che volevano
«restituire l’onore ai socialisti», ricordi? Ora però basta, Bobo, basta
davvero. Il Craxi perdente e zoppicante, la sera tardi, amava ripetere che tutto
avrebbe voluto, diceva, «tranne che essere riabilitato da coloro che mi hanno
ucciso». C’è chi, come tua sorella, ha incorniciato questa frase dietro la
scrivania: la stessa sorella che ormai ti definisce pubblicamente «una tragedia
familiare» che non è nazionale, per fortuna, solo per via della tua irrilevanza
politica. Hai bussato col cappello in mano dai lanciatori di monetine, hai fatto
bisboccia cogli odiatori professionali, con le iene che poi hanno tentato di
smangiucchiare ogni visione craxiana con due lustri di ritardo. In politica il
tradimento non esiste o quasi, Bobo: ma tu eri un figlio, perlomeno di sangue.
Non eri altro, non avevi altro. Da vent’anni davi aria alle parole col tuo
politichese vacuo e fatto di nulla: poi, per un collegio di lenticcchie, per il
posticino con lo stipendino e la pensioncina, hai svenduto a prezzi di saldo un
cognome che non ti appartiene più da tempo, perché l’hai regalato agli
scippatori del socialismo europeo, a coloro cui neppure una latitanza parve
bastare. Questi sono i tuoi compagni di strada, i traditori indicati da tuo
padre: ecco perché della tua biografia, Bobo, resterà l’esser nato come figlio
di Bettino Craxi e in secondo luogo il tuo esser passato con quelli che lui
giudicò i propri assassini, punto, amen, riposi in pace, pensavamo. E invece no.
Ancora parli. Parli di Berlusconi: con tutti gli sciacalli che pure ci furono
anche a destra, tu vai a parlare proprio di Berlusconi, vai a parlare dell’uomo
che per almeno dieci anni si cercò di associare al padre di tua sorella
perlomeno sotto il profilo dell’epilogo politico-giudiziario. Eppure tutto era
cominciato proprio nel periodo in cui Berlusconi già orecchiava la politica o a
esser precisi il consenso: il periodo in cui una percentuale di italiani che
sfiorava il 90 per cento voleva Craxi espressamente in galera, e insomma lo
odiava di un odio viscerale, liberatorio, risolutore. Ebbene, giusto all’acme di
questa passione civile (sera del 29 aprile, dopo alcune mancate autorizzazioni a
procedere contro Craxi) il Berlusconi già mentalmente politico non ebbe a
rifuggire le telecamere di Raitre, e così disse: sono venuto a trovare un amico
perché sono tanto contento per lui. Un gesto che molti che circondano Berlusconi
(oggi) non vollero o poterono permettersi (allora) ma che il futuro vincitore
delle elezioni avrebbe comunque pagato salato. E Berlusconi quel prezzo lo pagò,
ma è la ragione per cui non poté mai più permettersi di incontrare Craxi da
vivo: anche perché il primo a sconsigliarlo politicamente fu proprio Craxi, se
non lo sai. Andarono altri, ad Hammamet. Il padre di tua sorella li portava alla
Medina per una menta fresca e per un passaggio finto distratto nel cimitero
italiano dove avrebbe voluto essere sepolto, diceva. Berlusconi il cimitero l’ha
visto per la prima volta nel 2000, nel giorno dei funerali, quando disse che non
c’era nulla da dire. E tu ovviamente parlavi, Bobo.
Sul divorzio dai giudici AN si divide.
Visibilità. Ignazio La Russa la evoca, esprimendo un disagio comune ad altri
dirigenti di Alleanza nazionale che vorrebbero più chiaramente esposta la linea
del partito sulla giustizia. Il deputato, legato da rapporti di amicizia stretti
con il giudice Piercamillo Davigo, chiede che, ad elezioni consumate, Fini
convochi le truppe scelte e dia vita a un "riesame complessivo di tutta la
materia". Ripensamenti, messe a fuoco. Resiste dentro An uno zoccolo duro alla
Mirko Tremaglia, amico storico di Di Pietro ("Berlusconi tratta la giustizia
come fosse un venditore di tappeti nel suk; chi ha un conflitto di interessi
deve avere almeno il pudore di farsi da parte..."), ma affiorano sempre di più
posizioni 'divorziste' come quella dell' avvocato Giuseppe Valentino, un
senatore, membro della commissione Giustizia, solitamente poco esposto ai
riflettori, che ieri ha addirittura annunciato: "Le ingerenze sconcertanti cui
abbiamo assistito in questi giorni sostanzialmente vanificano l' apprezzamento
che Borrelli e la magistratura di Milano si sono conquistati nel passato per la
loro attività". Come dire: Mani pulite con noi ha chiuso (o quasi). Publio Fiori
è convinto che ormai, dentro il partito, gli equilibri siano cambiati: "L' anima
giustizialista era più legata al vecchio partitino d' assalto, ora la destra è
potenziale forza di governo". Domenica Gianfranco Fini aveva dettato la linea,
ironizzando sul "delirio di onnipotenza" di Borrelli e accusando i giudici di
Milano di volersi porre come "contropotere". Il giorno dopo, cioè ieri, tutti a
condividere a grandi linee, ma con qualche sfumatura di disagio. Dietro le
quinte, il problema di An è presto detto: sull' emittenza e la giustizia, i temi
cari a Berlusconi, il partito di Fini è costretto a giocare una difficile
partita con l'alleato che ha notoriamente obiettivi chiari. Francesco Storace è
stato invitato, da Forza Italia, ad abbassare i toni della sua polemica con la
Rai. Quanto alla giustizia, An tiene un basso profilo. Per alcuni, come La
Russa, troppo basso: "Andiamo a rimorchio degli eventi, abbiamo perso di smalto.
Prima eravamo protagonisti, adesso non più". Quando parlarne? Non subito.
Perché, come ammonisce La Russa, che pure non difende le ultime gesta del
procuratore capo di Milano ("Ha fatto un autogol"), "non si può fare di una
materia come la riforma della giustizia un tema da campagna elettorale". Si
riferisce a qualcuno? "A tutti", è la diplomatica risposta. Tant' è, l'ombra di
Berlusconi, protagonista del braccio di ferro con Borrelli, è dietro ogni
dichiarazione. Anche quelle, di stile anglosassone, di Gianni Alemanno che
chiede "più equilibrio" sui problemi della giustizia, condannando le
"primedonne" di Milano ma, contemporaneamente, ribadendo principi cari ad An
come "l'intoccabilità dell'obbligatorietà dell'azione penale". Publio Fiori fa
uno sforzo di equilibrio: "Non c' è dubbio che la situazione di Berlusconi
rappresenta un'anomalia. Ma la gente lo ha votato, nonostante sia un imputato. E
mi sembra meno anomalo lui di quei giudici che fanno gli arroganti". Alessandra
Longo, 22 aprile 1997 "La Repubblica”.
La Russa: «Così provai a convincere Davigo a fare il ministro».
Intervista di Rocco Vazzana del 27 Marzo 2017, su "Il Dubbio". La Russa racconta
i giorni convulsi del ’94: “A incaricarmi di trattare col pool fu Tatarella.
Organizzai anche il famoso incontro tra Di Pietro e Berlusconi”.
«È vero, ricevetti l’incarico di sondare se Davigo fosse interessato a entrare
al governo». Ignazio La Russa conferma l’aneddoto raccontato
a RepubblicaTv dall’x capo dell’Anm: «A me fu proposto di fare il ministro della
Giustizia per il primo governo Berlusconi. Me lo propose La Russa a nome, a suo
dire, di Fini». Tutto vero, dunque: a intavolare la trattativa con uno dei pm
più importanti di “Mani pulite” fu proprio l’onorevole – ex missino e avvocato –
La Russa. «Ma a chiedermi di trattare non fu Fini, come dice Davigo, ma Pinuccio
Tatarella. Era lui il mio vero capo e mi disse: “A questi qui dobbiamo
associarli all’opera di cambiamento, senza eccessi”».
Che significa associare «all’opera di cambiamento» i magistrati
del pool?
«Significa che Tatarella pensava che
Davigo fosse la persona giusta per essere associata al governo Berlusconi. Avevo
un ottimo rapporto professionale con Davigo, anche se non siamo mai andati a
cena insieme e non ci siamo mai frequentati fuori dalle aule di giustizia. Ci
vedevamo in Tribunale, anche nel suo ufficio, e parlavamo tanto, non solo di
diritto. Sempre in maniera amichevole ma formale. Erano altri tempi».
Volevate trattare per proteggere Berlusconi dalla procura di
Milano?
«La definirei più una captatio
benevolentiae. Tatarella parlava di “associazione al cambiamento”, ma è chiaro
che l’implicita contropartita fosse quella di convincere alcuni pm a desistere
da un atteggiamento preconcetto contro Berlusconi. Tanto che qualche tempo dopo
Pinuccio mi mandò in avanscoperta per fare una trattativa con il pool di Mani
Pulite. Il mio compito era chiedere ai pm cosa volessero in cambio di un
atteggiamento meno ostile nei confronti di Silvio Berlusconi».
E cosa le risposero?
«Questo non l’ho mai raccontato prima.
Mi dissero: “Lui venga qui, ammetta quello che c’è da ammettere, patteggiamo e
per noi è tutto chiuso”. Naturalmente questa soluzione neanche la proponemmo a
Berlusconi».
Chi, del pool, le diede questa risposta? Con chi si relazionava?
«Io mi relazionavo quasi sempre con
Davigo, poco con Di Pietro, con cui pure avevo un discreto rapporto ma non lo
ritenevo adatto a questo tipo di confronto. Consideravo la vera mente del pool,
la persona più intelligente, Davigo. A parte, ovviamente, il procuratore
Francesco Saverio Borrelli che era il loro capo».
Il compito di convincere Di Pietro a entrare nel governo
Berlusconi spettava a Mirko Tremaglia?
«Sì, ma dopo. Non ricordo se
quell’operazione fu tentata addirittura col secondo governo Berlusconi. Quello
di cui parlo io riguarda la fase precedente alla formazione del primo governo
Berlusconi. Le dirò di più, però. Ho avuto un ruolo decisivo anche per
organizzare il famoso incontro tra Di Pietro e il leader di Forza Italia
avvenuto a Roma, credo anche alla presenza di Previti. Fu sempre Tatarella a
chiedermi di intervenire. Mi chiamò e mi disse: “Sappiamo che Di Pietro è a Roma
e Berlusconi lo vuole incontrare. Scopri dov’è”. Io chiesi direttamente a Davigo
che mi indicò la caserma dei Carabinieri in cui si trovava. E lì lo
rintracciarono. Però secondo me è stato un errore, perché questa mossa mise in
allarme il resto del pool che raggiunse Di Pietro prima che parlasse con loro.
Infatti lo bloccarono».
Sempre nel 1994?
«Sì, sempre del 1994, prima della
nascita del governo».
Lei credeva che fosse davvero possibile trattare col pool o fu un
tentativo disperato?
«L’unico momento in cui ho sperato è
quando Davigo mi disse che si sarebbe preso 24 ore di tempo per riflettere sulla
nostra proposta di entrare al governo. Poi le 24 ore diventarono 48 allungando
l’attesa. Quando tornò mi riferì di aver parlato con Borrelli. La decisione era
stata presa. “Noi siamo guardalinee”, disse, “tra il primo e il secondo tempo
non possiamo cambiare casacca, non possiamo indossare la maglia dei giocatori di
una squadra”».
Quindi non ci fu un “no” secco, passarono prima due giorni…
«Sì, 48 ore. Ne parlò col procuratore
capo e poi disse di no. Ma ho mantenuto sempre una grande stima nei confronti
della sua intelligenza giuridica».
Chi era il meno disponibile alla trattativa tra i magistrati del
pool?
«Non lo so. Noi avevamo puntato sui due
– Davigo e Di Pietro – che consideravamo culturalmente avvicinabili perché non
di sinistra. Con gli altri due, D’Ambrosio e Colombo, sarebbe stato inutile.
Borrelli era proprio fuori gara invece».
Berlusconi sapeva della sua trattativa?
«Dell’azione su Di Pietro sicuramente,
ma di Davigo io non gliene ho mai parlato».
Glielo avrà riferito Tatarella…
«Conoscendo Tatarella, che era la
riservatezza fatta persona, credo che ne avrebbe parlato solo a cose avviate.
Può darsi che gli abbia detto qualcosa nell’attesa delle 48 ore».
Berlusconi era terrorizzato dal pool?
«Terrorizzato non lo so, ma Tatarella
aveva capito tante cose, aveva una visione politica. Non è un caso che sia stato
lui a convincere la Lega a fare il governo insieme a noi, ai fascisti».
MANI GOLPISTE.
“Il patto segreto di Tangentopoli tra Pool e Pds” di Ferdinando
Cionti. Ferdinando Cionti, avvocato, incaricato
dall’allora Presidente Craxi di verificare la legittimità dell’operato del Pool
Mani pulite, ricostruisce gli avvenimenti di quegli anni e giunge alla
conclusione che venne effettuato un vero e proprio colpo di Stato, con il quale
si modificarono i rapporti costituzionali tra magistratura e politica,
instaurando una egemonia della magistratura, tuttora vigente. L’intelligenza
dell’analisi e la sincera passione civile che animano queste pagine siano per i
lettori un’occasione per conoscere più approfonditamente i fatti e valutarli
sotto il profilo giuridico – oltre che politico, com’è avvenuto prevalentemente
finora – anche per inquadrare correttamente le vicende dei nostri giorni.
Ferdinando Cionti è avvocato a Milano ed è stato professore a contratto di
Diritto Industriale per il Management presso l’Università di Stato di Milano
Bicocca, facoltà di Economia, dipartimento di Diritto per l’economia. La sua
concezione del diritto è sintetizzata nel saggio "Per un ritorno alla certezza
del diritto", pubblicato su Libertates. Ha pubblicato numerosi saggi, tra cui
"La funzione del marchio" e "Sì Logo" (Giuffrè). Per LibertatesLibri è uscito
"Il colpo di Stato", presente nello Store di Libertates. Quale collaboratore
dell’ “Avanti”, ha seguito quotidianamente le vicende di Mani Pulite.
Le critiche sollevate dalla Magistratura alla Commissione Parlamentare
d'Inchiesta su Tangentopoli, sono compendiate in questa dichiarazione del
giudice milanese Claudio Castelli, vicepresidente dell'Associazione nazionale
magistrati, scrive Ferdinando Cionti. "Come associazione nazionale magistrati,
ci preoccupano invece alcuni passaggi della legge istitutiva, che rendono
concreto il rischio di uno sconfinamento istituzionale: la commissione su
Tangentopoli non può diventare una sorta di quarto grado di giudizio. Il
problema proprio questo: un'indagine politica strumentalizzata per delegittimare
la magistratura. Si tratta di critiche generate da veri e propri equivoci, che
vanno chiariti. Innanzitutto le conclusioni della Commissione Parlamentare
d'Inchiesta non potranno mai concretarsi in "una sorta di quarto grado di
giudizio", posto che in ogni caso le sentenze restano quelle che sono. Non che
la Commissione possa riformare o annullare questa o quella sentenza. Potrebbe,
per esempio, rilevare che le due sentenze definitive di condanna di Craxi sono
state emesse in applicazione di norme processuali riconosciute poi ingiuste,
tant' che si approvata la riforma costituzionale del giusto processo..."
Così nacque il patto segreto che legò i giudici e la sinistra.
Il saggio di Ferdinando Cionti spiega perché "Mani pulite" non toccò i leader
del Pds e quali furono le conseguenze, scrive Dario Fertilio, Venerdì
24/03/2017, su "Il Giornale". Colpo di Stato fu, e non solo giudiziario: la
matrice di Tangentopoli fu anche politica. Si basò, secondo Ferdinando Cionti,
sul patto d''acciaio fra il Pool di Mani Pulite e un partito dai molti nomi:
Pci/Pds/Ds/Pd. In un saggio precedente, Il colpo di Stato (edito da
LibertatesLibri, come quello che ora ne è il proseguimento, Il patto segreto di
Tangentopoli tra Pool e Pds, pagg. 230, euro 12), il giurista aveva smontato
l'ingranaggio dell'inchiesta condotta fra il '92 e l'anno successivo. Secondo la
sua analisi Borrelli, Di Pietro & C. erano responsabili di una serie di
illegalità, tra le quali ripetute violazioni dell'articolo 289 del codice penale
(attentato contro gli organi costituzionali). In particolare avevano fatto
cadere la nomina di Bettino Craxi a presidente del Consiglio: al vertice dello
Stato, Scalfaro, informato dai giudici di Mani Pulite, aveva preso atto delle
indagini segrete in corso e aveva ripiegato su Giuliano Amato. Ne conseguiva che
un pubblico ministero aveva condotto indagini illegittime contro Craxi,
interferendo nella nomina del Presidente del Consiglio, scavalcando l'esito
delle elezioni, il Parlamento, e limitando lo stesso potere del Presidente. Ma
in che senso le indagini del Pool erano state illegittime? Per molti motivi. La
scintilla dell'inchiesta, cioè l'arresto di Mario Chiesa per la vicenda delle
tangenti legate al Pio Albergo Trivulzio, era scoccata in seguito a una serie di
intercettazioni illegali. In pratica Di Pietro aveva «inventato» l'esistenza di
un reato per il quale è consentita l'intercettazione telefonica. Anche il
conferimento dell'inchiesta a Di Pietro era stata irregolare: lui stesso per
l'«operazione Chiesa» aveva concordato con la polizia giudiziaria una data in
cui era di turno, in modo da farsi assegnare il processo. Ancora, nei confronti
di Mario Chiesa, Di Pietro aveva dimenticato deliberatamente di depositare nei
tempi dovuti gli atti previsti per il rito direttissimo. Il che gli aveva
consentito di prolungare indefinitamente la detenzione, cuocendo Chiesa a fuoco
lento: le confessioni erano il risultato di una procedura illegale basata sullo
choc indotto da carcere e manette. Non basta: Di Pietro, dopo aver proceduto per
concussione al fine di condurre intercettazioni illegali, aveva ideato un altro
trucco, applicando alla sua inchiesta sulle tangenti la legge che riguarda le
rogatorie internazionali per il riciclaggio di denaro sporco proveniente dal
traffico di droga o armi. Così aveva scavalcato il ministro della Giustizia, che
avrebbe dovuto autorizzarlo, alterando i rapporti fra magistratura ed esecutivo.
Non basta? Si consideri allora che il Pool aveva inventato la «dazione
ambientale», un reato sociale e collettivo di corruzione, secondo il quale il
rischio di reiterazione dei reati è sempre possibile. Effetto: veniva fatto
capire all'indagato che la sua permanenza in carcere poteva durare all'infinito.
Un metodo infallibile per farlo passare dalla confessione dei propri reati alla
delazione di quelli altrui. Nel caso di Chiesa, aveva anche uno scopo politico:
far sì che alla fine venisse chiamato in causa Craxi, nemico pubblico numero uno
del partito dei giudici dal tempo del delitto Tobagi, e ancor più da quando il
Psi si era schierato a favore della responsabilità civile dei magistrati. Ma
soprattutto le indagini sull'odiato cinghialone erano avvenute in violazione
dell'articolo 335 del codice di procedura penale, segretamente, senza iscrivere
il suo nome nel modello 21, il registro in cui finiscono le notizie di reato con
nominativo conosciuto, e che prevedono al massimo sei mesi di indagini, in modo
da non chiedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare
Craxi. Di qui gli attacchi del Pool all'articolo 68 della Costituzione appunto
sulla autorizzazione a procedere (che aveva lo scopo di mantenere indipendenti i
poteri legislativo ed esecutivo dal giudiziario).
Ecco le conclusioni di Cionti: il Pool guidato dal procuratore Borrelli aveva
bisogno di un alleato per ottenere l'abolizione dell'immunità parlamentare e
sanare a posteriori i più gravi reati commessi. Questo alleato fu l'allora Pds,
mortalmente minacciato dal crollo dell'Urss, e disposto ad accordarsi con Craxi
pur di entrare nell'Internazionale socialista. Temendo che il suo disegno
egemonico ne venisse bloccato, il Pool offrì al partito di Occhetto la
distruzione di Craxi e del Psi, in modo che il Pds potesse prenderne il posto.
Ecco il motivo dell'annullamento all'ultimo momento, da parte dei
post-comunisti, del documento che avrebbe dovuto sancire nel 1992 «l'intesa fra
tutte le forze di progresso», cioè l'alleanza col Psi. Ecco perché l'inchiesta
riguardò solo esponenti marginali o miglioristi del Pds. E perché le migliaia di
manifestanti spontanei in favore di Mani Pulite e contro Craxi furono quasi
tutti militanti di quel partito. E come mai, in seguito ai segnali intermittenti
e inquietanti che aveva ricevuto dai giudici su quel che stava accadendo, ci
furono le improvvise dimissioni di Cossiga dal Quirinale. Su questo sfondo si
legge lo svuotamento della autorizzazione a procedere e la nascita del patto
d'acciaio fra sinistra e partito dei giudici, ormai inossidabile. Svuotamento di
fatto che diventava di diritto, con la riforma dell'articolo 68 della
Costituzione, resa possibile dall'incalzante iniziativa del Pds che pagava in
tal modo la sua salvezza; e, parallelamente, dalla pressione esercitata dal Pool
con le sue azioni giudiziarie nei confronti dei parlamentari della maggioranza,
in violazione proprio dell'articolo 68. Così cambiavano i rapporti tra i poteri
dello Stato, poiché parlamento e governo risultavano subordinati al potere
coercitivo della magistratura. E poiché il potere coercitivo è l'essenza della
sovranità, veniva attuato un vero e proprio colpo di Stato - conclude l'autore
del saggio - secondo l'articolo 287 del codice penale. Ferdinando Cionti a suo
tempo era stato incaricato da Craxi di verificare se la Procura di Milano, nei
giorni convulsi di Tangentopoli, avesse commesso illegalità. Oggi può dire
d'aver portato a termine quel compito.
Mani golpiste. Rileggere Tangentopoli
con il codice penale alla mano per scoprire che il colpo di stato ci fu. Un
libro sul Pool di Milano, scrive Dario Fertilio il 25 Gennaio 2015 su “Il
Foglio”. Nei confronti di Mario Chiesa il pm Di Pietro dimentica poi
deliberatamente di depositare nei tempi dovuti gli atti. Questo gli consente di
prolungare indefinitamente la detenzione. Mettiamo che tra il 17 febbraio del
1992 e il 29 ottobre dell’anno successivo si sia consumato in Italia un colpo di
stato, senza che nessuno (o quasi) se ne sia reso conto. Dietro le quinte,
nessuno zampino di servizi segreti né complotto di generali; al contrario, alla
luce del sole, un rumoroso tintinnare di manette agitate dai giudici di Mani
pulite. Mettiamo che Ferdinando Cionti, avvocato di cultura liberale, incaricato
dall’allora segretario socialista Bettino Craxi di verificare la legittimità
dell’operato del Pool di Milano, sia riuscito, firmando “Il colpo di Stato”
(LibertatesLibri, pp, 158, euro 10) a smontare meticolosamente, articolo per
articolo, l’ingranaggio giudiziario (con contorno politico e mediatico) su cui
si è retta l’inchiesta di Tangentopoli. Concediamo pure che l’autore non abbia
saputo né voluto spogliarsi di una antica passione garantista nel redigere il
suo atto d’accusa contro i giudici della procura di Milano che determinarono il
crollo della Prima Repubblica. Restano comunque i fatti elencati da Cionti, che
vengono prima delle interpretazioni e delle tesi politiche: ed è a essi che
occorre anzitutto dare udienza.
Con una premessa, che vale anche da conclusione: se colpo di stato a opera dei
giudici ci fu, come sostiene Cionti, deve essere possibile inquadrare penalmente
l’accaduto. Ed ecco: basta riferirsi agli articoli 287 e 289 del codice penale,
là dove stabiliscono rispettivamente: “Chiunque usurpa un potere politico ovvero
persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a
quindici anni”; e ancora, “è punito con la reclusione da uno a cinque anni,
qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti
diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente, al presidente
della Repubblica o al governo l’esercizio delle attribuzioni o prerogative
conferite dalla legge; alle assemblee legislative, alla Corte costituzionale o
alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni”.
Ma prima di passare alle radicali conclusioni cui giunge Cionti, basandole sui
due articoli appena citati, ecco i passi salienti della sua indagine, in cui
viene “smontata” pezzo per pezzo, e articolo per articolo, la macchina
giudiziaria messa in moto a suo tempo dai giudici di Mani pulite. La scintilla
dell’inchiesta, cioè l’arresto di Mario Chiesa per la vicenda delle tangenti
legate al Pio Albergo Trivulzio, scocca in seguito a una serie di
intercettazioni illegali. In pratica Di Pietro, giostrando fra gli articoli 266
del codice di procedura penale, e il 317 e 318 del codice penale, invece di
iscrivere nel registro la sola notizia di un reato di diffamazione, vi aggiunge
in base a un sospetto non provato quello di corruzione e addirittura di
concussione. In pratica “inventa” l’esistenza di un reato per il quale è
consentita l’intercettazione telefonica. Inoltre il conferimento dell’inchiesta
a Di Pietro avviene in modo illegittimo: in certo modo è come se il suo autore,
per poterne essere titolare, l’avesse assegnata a se stesso. Egli infatti
concorda con la polizia giudiziaria una data per l’“operazione Chiesa” in cui
lui sia di turno, in modo che il processo gli venga assegnato, evitando il
rischio che finisca a un altro sostituto. Ma questo è ancora il meno – benché
sia già una violazione del regolamento – perché Di Pietro determina
l’assegnazione dello stesso processo a un gip gradito, contro il disposto
dell’articolo 25 della Costituzione, che pone il divieto di sottrarre l’imputato
al suo giudice naturale. La tecnica messa in atto, in questo caso come nei
successivi di Mani pulite, consiste nell’intasare con fascicoli di scarso
rilievo l’ufficio del gip competente per turno, ma considerato meno malleabile,
facendo in modo che il fascicolo passi in eredità a quello favorevolmente
disposto (in quel caso Italo Ghitti). Nei confronti di Mario Chiesa il pm Di
Pietro dimentica poi deliberatamente (come ammetterà lui stesso successivamente
in un’intervista) di depositare nei tempi dovuti gli atti previsti per il rito
direttissimo. Questo gli consente di prolungare indefinitamente la detenzione,
cuocendo Chiesa a fuoco lento: le sue confessioni, per quanto rilevanti ai fini
dell’inchiesta, sono il risultato di una procedura illegale che si basa sullo
choc indotto dal carcere e dalle manette, con la prospettiva di una macchia
indelebile sull’immagine pubblica dell’inquisito.
Ancora: Di Pietro, dopo aver proceduto per concussione al fine di effettuare le
intercettazioni illegali, inventa un altro trucco o “giochino”: applica ai fini
della sua inchiesta sulle tangenti la legge che riguarda le rogatorie
internazionali per il riciclaggio di denaro sporco proveniente dal traffico di
droga o di armi. In questo modo, tra l’altro, scavalca le prerogative del
ministro della Difesa, che avrebbe dovuto autorizzarlo, alterando di fatto i
rapporti fra magistratura e potere esecutivo.
Viene poi creato dal Pool, attraverso l’invenzione della “dazione ambientale”,
un tipo di reato sociale e collettivo di corruzione, secondo il quale il rischio
di reiterazione dei reati, dell’inquinamento delle prove e della fuga, è sempre
possibile. Come dire che, essendo l’Italia in generale un paese di corrotti,
ognuno deve essere comunque trattato come tale. Effetto: viene fatto capire
all’indagato che la sua permanenza in carcere può durare all’infinito. Man mano
che si avvicinano i termini di scadenza, gli si fanno piovere addosso a
intervalli regolari nuovi ordini di custodia cautelare per reati simili a quello
originario, con nuove ondate di pubblico discredito e un impatto umano
devastante. E’ un metodo quasi infallibile che serve per far abbassare le difese
all’inquisito, inducendolo a passare dalla confessione dei propri reati alla
delazione riguardo a quelli altrui.
Nel caso di Chiesa, inoltre, il prolungarsi della detenzione assume anche uno
scopo politico: far sì che alla fine venga chiamato in causa Craxi, nemico
pubblico numero uno del “partito dei giudici” dal tempo del delitto Tobagi, e
ancor più da quando il Psi si è schierato a favore della responsabilità civile
dei magistrati. Ed è così, racconta l’autore, che si incomincia a indagare sul
conto del leader socialista, il cosiddetto “cinghialone”. Ma, in violazione
dell’articolo 335 del codice di procedura penale, lo si fa segretamente, senza
iscrivere il suo nome nel modello 21, il registro in cui finiscono le notizie di
reato con nominativo conosciuto, e che prevedono un termine di sei mesi per le
indagini. Si ricorre invece astutamente al modello 44, riservato ai casi in cui
l’identità dell’indagato è ignota: il termine dei sei mesi in questo caso non
c’è più e dunque è possibile procedere a tutto campo contro l’odiato Craxi.
Se non che Craxi era un parlamentare. E qui sale il livello politico della
sfida: iniziano cioè gli attacchi del Pool all’articolo 68 della Costituzione,
quello che allora stabiliva come: “Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento possa essere sottoposto a procedimento
penale”. Non si parlava di condanna, cioè, ma di “procedimento”: perché era
chiaro al legislatore, preoccupato di mantenere separati e indipendenti i poteri
legislativo ed esecutivo da quello giudiziario, come perseguire un politico ne
pregiudicasse irreparabilmente la carriera. Quindi, in attuazione del disposto
costituzionale, entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro degli indagati
il pubblico ministero avrebbe dovuto chiamare il parlamentare Craxi, chiedergli
spiegazioni e, se queste non fossero riuscite convincenti, rivolgersi al
Parlamento per l’autorizzazione a procedere. Questo non viene fatto, e i pm del
Pool continueranno a non farlo in futuro, di fatto violando l’articolo 68 della
Costituzione e mettendo la classe politica di fronte al fatto compiuto. Così il
Pool creerà i presupposti per la modifica, finché si incaricherà Borrelli di
chiederla pubblicamente.
Siamo al nocciolo della questione, e ormai apertamente su un terreno tutto
politico: la presa di posizione del “partito dei giudici”, combinata con
l’azione dei fiancheggiatori e lo stillicidio delle pubblicazioni su varie
riviste e giornali dei verbali riservati, ostacola e infine fa cadere la nomina
– proprio in quei momenti all’ordine del giorno – di Bettino Craxi a presidente
del Consiglio. Al vertice dello stato, Scalfaro, informato dal Pool, prendeva
atto delle indagini in corso su Craxi e ripiegava sul conferimento dell’incarico
a Giuliano Amato. Ed è qui dunque, con logica stringente, che Ferdinando Cionti
fa discendere la conclusione dalle premesse: un pubblico ministero – afferma –
ha effettuato indagini illegittime contro Craxi e se ne è avvalso per
intromettersi direttamente nella nomina del presidente del Consiglio. Dunque,
l’ha condizionata, esercitando un potere di fatto che scavalca l’esito delle
elezioni, il Parlamento, e limita lo stesso potere del presidente della
Repubblica nella sua maggiore espressione. Da qui l’attentato contro gli organi
costituzionali, secondo l’articolo 289 del codice penale. Un punto di non
ritorno, dal momento che si sarebbe dovuto modificare la Carta, e sanare a
posteriori il reato commesso, oppure andare incontro a una messa in stato di
accusa del Pool. Insomma, da un lato si continuava a disapplicare l’articolo 68,
dall’altro si chiedeva pubblicamente, per bocca di Borrelli, la riforma di
questa norma.
Il resto è storia nota. L’inchiesta su Tangentopoli procederà trionfalmente
senza più ostacoli: si arriverà a indagare 131 parlamentari soltanto a Milano,
mentre in tutto saranno 1.069 i politici coinvolti, di cui 205 deputati (un
terzo del totale). In un clima simile di caccia giustizialista alle streghe, che
l’autore definisce “rivoluzionario”, diventerà impossibile riconoscere
l’evidenza: come cioè tutti i partiti fossero coinvolti in una associazione a
delinquere basata su tangenti implicite e pressoché automatiche. Sicché non si
poteva parlare legittimamente di corruzione né di concussione, rendendo
inevitabile la famosa “soluzione politica” auspicata da Craxi, in modo da
evitare il crollo dell’intero sistema democratico. Ma il tentativo messo in atto
a questo fine dal ministro Giovanni Conso, che si proponeva di depenalizzare il
reato di finanziamento ai partiti, sarà immediatamente bloccato dalla durissima
reazione di Borrelli e dei suoi collaboratori, addirittura con una minaccia di
dimissioni collettive, fino a indurre il presidente Scalfaro a non firmare il
decreto. Si procederà invece in un’altra, opposta direzione, giungendo
nell’ottobre del 1993 ad abolire l’immunità parlamentare. Sotto la mannaia cadrà
intanto gran parte della Dc (non la sinistra, che confluirà poi nel Pds), l’ala
migliorista e garantista del Pci, e naturalmente l’intera leadership socialista.
Tutti i gruppi dirigenti, insomma, considerati “nemici” dal partito dei giudici.
In questo clima, mentre si indagano i 131 parlamentari soltanto a Milano –
ripetiamo: in tutto saranno 1.069 i politici coinvolti, ma i deputati
appartenevano quasi tutti alla maggioranza – si inquadra il voto quasi unanime
per l’abolizione dell’immunità parlamentare. Il Parlamento è in pratica sotto
ricatto, anche in considerazione del fatto che l’opposizione, pur di essere
risparmiata, è indotta ad allinearsi.
Fu presa del potere prima di fatto e poi ufficiale, insomma, riassume l’autore
de “Il colpo di Stato”. E venne realizzata mediante l’esercizio di una decisiva
facoltà di intimidazione e di veto; l’impresa di lì a poco sarebbe culminata nel
blocco della riforma con la quale avrebbe potuto essere finalmente avviata la
separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri. Finché, più tardi da
Hammamet, Craxi avrebbe parlato di “una certa mappa con dei confini interni: c’è
chi dev’essere protetto, chi deve essere tenuto a bagnomaria, e chi dev’essere
distrutto”.
Operazione chirurgica, conclude Ferdinando Cionti, finalizzata al “cambiamento”
dello stato. Un putsch, precisa, di tipo “bonapartista”, cioè basato sulla
legalizzazione a posteriori dell’evento rivoluzionario. Come Napoleone nel
famoso 18 brumaio del 1799 bloccò il Parlamento, e poi convocando i parlamentari
a lui fedeli ottenne la ratifica dei nuovi poteri a lui attribuiti, così la
magistratura nel ’93 indusse i parlamentari consenzienti a spingere per la
riforma, intimidendo e paralizzando gli altri. Che poi ne sia risultato un
potere “oligarchico” della magistratura, tuttora in vigore e contrario al primo
articolo della Costituzione fondata sulla sovranità popolare, può essere materia
di riflessione per chi si propone di cambiare le cose oggi o domani. Sempre
tenendo presente come il terribile potere del giudice, che dispone della vita
degli uomini, abbia posto da sempre il problema della sua delimitazione,
ovviamente senza lederne l’indipendenza. La soluzione adottata (soprattutto nei
paesi regolati dalla civil law anglosassone) è stata quella di distinguere
nettamente la titolarità dell’azione penale, esercitata dal potere esecutivo
mediante il suo “procuratore”, dal ruolo affidato al giudice e predeterminato
dalla legge, in modo che l’uno bilanci l’altro. Sicché, in quasi tutti i paesi,
vige la separazione del pubblico ministero – che esegue la legge promuovendo
l’azione penale – dal giudice, che interpreta la legge nel caso concreto,
pronunciando la sentenza. (Tranne che in Francia e in Bulgaria, dove però il
pubblico ministero è alle dirette dipendenze del ministro della Giustizia).
Come si sa, invece, in Italia giudice e pm fanno parte della medesima
corporazione, indipendente dal ministro della Giustizia e da qualsiasi altra
autorità di qualsiasi natura. Con la conseguenza che questa corporazione
gestisce l’intero monopolio della “violenza legittima” dello stato, l’essenza
stessa della sovranità. Forse non è ancora tempo, se mai lo sarà, di un’elezione
popolare e diretta di giudici e pm, come avviene in America. Ma questo potere
sovrano di una corporazione, priva di legittimazione popolare, dovrebbe trovare
un limite nella impossibilità di invadere il potere legislativo – democratico
perché eletto – grazie all’immunità parlamentare stabilita dall’art. 68 della
Costituzione nel testo originario. Una volta travolto quell’argine sotto i colpi
di Mani pulite, il potere giurisdizionale è diventato aristocratico, illimitato
e irresponsabile. Insomma, né il presidente della Repubblica né il presidente
del Consiglio possono sfiorarlo con un dito, mentre esso, alla fine, può
intervenire su entrambi.
La morale di questa vicenda? E’ sempre valida, anche al di là di Tangentopoli e
della stretta politica giudiziaria: è una fatale illusione credere di poter
combattere un crimine commettendone un altro.
TANGENTOPOLI. LE MANI SPORCHE DI MANI PULITE.
Davanti al carcere di San Vittore, il 15 febbraio 2017, dove venticinque anni fa
veniva portato Mario Chiesa, la firma di Repubblica Piero Colaprico racconta gli
inizi dell'inchiesta di Mani Pulite e la nascita del termine Tangentopoli. "Sono
stato il primo a usarlo, ancora prima del 1992. Mi ero ispirato alle storie di
Paperino, poi diventò il marchio di un'epoca".
Mani Pulite: 25 anni fa l'inizio delle indagini.
Con l'arresto di Mario Chiesa, manager del Pio Albergo Trivulzio colto ad
intascare una tangente, iniziava la fine della Prima Repubblica, scrive Edoardo
Frittoli il 17 febbraio 2017 su Panorama. Esattamente 25 anni fa
l'ingegner Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano lasciava
in manette l'ospedale dopo essere stato colto in flagranza di reato mentre
incassava una tangente da un dipendente dell'impresa di pulizie di Luca Magni,
che si era deciso a denunciarlo per le sempre più esigenti richieste economiche
in cambio dell'appalto per le pulizie nell'ospedale geriatrico. Da una tangente
di appena 7 milioni di lire ebbe origine l'inchiesta Mani Pulite, gestita dal
pool di magistrati milanesi che spazzerà via la Prima Repubblica. Ad aggravare
la posizione di Chiesa, portato nel carcere di San Vittore, sarà l'ex
moglie Laura Sala. Fu la donna infatti a denunciare ai magistrati Antonio di
Pietro, Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo l'esistenza di una somma ingente
di denaro frutto dell'attività di corruzione dell'ex marito nascosta in conti
svizzeri intestati ad una segretaria. A nulla valse il tentativo
di Bettino Craxi di isolare il PSI dai reati commessi dal proprio rappresentante
che era nato politicamente dai "vecchi" socialisti di De Martino e finito con
Pillitteri e Tognoli negli anni ruggenti della "Milano da bere". Poco dopo che
il leader socialista ebbe definito Mario Chiesa un "mariuolo", dal carcere il
presidente del Pio Albergo Trivulzio iniziò a parlare. Aveva innescato la miccia
di una bomba giudiziaria che avrebbe fatto deflagrare 40 anni di assetto
politico-amministrativo nato nell'Italia del dopoguerra, disintegrando i due
partiti chiave della Repubblica: la Democrazia Cristiana e il Partito
Socialista.
La stagione di Tangentopoli: 25 anni dopo, la lezione di Mani
pulite. Il 17 febbraio del 1992 l'arresto di Mario
Chiesa diede il via alla stagione che travolse la Prima Repubblica e cambiò la
storia d'Italia. Ma a distanza di un quarto di secolo bisogna riconoscere che il
Paese non ha saputo farne tesoro e il problema della corruzione è anche più
forte, scrive Gianluca De Feo il 16 febbraio 2017 su "La Repubblica". Accadde il
17 febbraio di 25 anni fa: l'arresto di Mario Chiesa diede inizio alla slavina
che ha travolto la Prima Repubblica. In due anni la storia d'Italia è cambiata:
sono scomparsi partiti antichi, leader politici e capitani d'industria hanno
lasciato la scena per sempre. Un'intera classe dirigente è finita sotto accusa:
ben 4520 persone sono state indagate nel solo filone milanese di Mani Pulite. Il
processo a Sergio Cusani trasmesso in diretta televisiva ha visto passare sul
banco degli imputati ex premier ed ex ministri: nella stessa giornata Bettino
Craxi e Arnaldo Forlani risposero alle domande di Antonio Di Pietro. E' una
stagione che si può comprendere solo con una lettura globale della corsa degli
eventi. Perché le inchieste milanesi si sono intrecciate con le stragi di mafia
e con una crisi economica profonda, che ha provocato la scomparsa di aziende
celebri e la svalutazione della lira, che ha spinto il governo Amato a prelevare
il 6 per mille dai conti correnti di tutti gli italiani. E' stata anche una
stagione di speranza, con la fiducia in un rinnovamento generazionale ed etico
della vita pubblica. Si sono imposti nuovi movimenti, da Forza Italia alla Lega,
e altri sono sorti dalle ceneri della tradizione democristiana e comunista. Ma
non sono state create leggi e strutture per impedire che le tangenti tornassero
a dilagare. Anzi, sono stati introdotti provvedimenti che invece di rendere più
giusti i processi hanno ingolfato la macchina della Giustizia, provocando la
dissoluzione di migliaia di inchieste per effetto della
prescrizione. Venticinque anni dopo, bisogna riconoscere che il Paese non ha
saputo fare tesoro di quella lezione e oggi il problema della corruzione è
addirittura più forte. Gli snodi sono gli stessi del 1992: il finanziamento
della politica non è trasparente, i partiti continuano a lottizzare società ed
enti pubblici. Certo, non esiste più quel sistema verticistico che applicava il
manuale Cencelli anche alla spartizione delle tangenti, definendo quote precise
a livello cittadino, provinciale, regionale e nazionale. Un sistema in cui - a
livello locale e nazionale - le indagini dimostrarono anche un ruolo del
Pci. Nel 2017 le segreterie dei partiti non sono più il cardine della gestione
dei finanziamenti illeciti. Adesso il mercato della corruzione è dominato da
consorterie trasversali, bande che legano gli interessi di politici e
imprenditori. E sempre più spesso le mafie si inseriscono in queste dinamiche,
offrendo bustarelle e mettendo a disposizione i loro capitali. E' il copione di
Mafia Capitale, è il modello criminale che minaccia il nostro futuro.
Cronaca di quel drammatico lunedì 17 febbraio 1992, quando Di
Pietro diede vita a “Mani pulite”. 17 febbraio 1992: «Mi disse Pillitteri:
Tonino? È un amico…», scrive Francesco Damato il 19
Febbraio 2017, su "Il Dubbio". Sono le ore 18 di lunedì 17 febbraio 1992,
esattamente 25 anni fa rispetto al momento in cui scrivo. Non posso nemmeno
immaginare che nulla sarà più come oggi dopo la riunione abituale che presiedo
nella stanza della segreteria di redazione del “Giorno”, a Milano, per la
selezione dei fatti e argomenti da sistemare nella prima pagina del numero di
domani. Il presidente della Repubblica Francesco Cossiga ha già fatto la sua
sparata quotidiana, proponendo l’uscita dell’Arma dei Carabinieri dall’Esercito
per consentire un migliore trattamento economico dei militari della Benemerita.
E ciò mentre i poliziotti in agitazione, sempre per motivi economici, assediano
il Viminale e minacciano di andare a dimostrare anche davanti al Quirinale.
L’apertura della prima pagina è assicurata. Difficilmente – penso- lo stesso
Cossiga, magari telefonandomi dopo qualche ora per anticiparmi un’altra
picconata, me la farà cambiare. Francesco è ormai diventato l’incubo dei
giornali per l’abitudine di terremotarli all’ultimo momento, magari quando sono
già in tipografia. Anche la spalla della prima pagina è coperta, con i giochi
olimpici di Albertville, dove le azzurre hanno conquistato il bronzo della
staffetta e domani è attesa la prestazione, addirittura, di Tomba nel gigante di
scii. Destiniamo al taglio centrale gli otto delitti di mafia compiuti in un
giorno in varie parti d’Italia, dal sud al nord. Dedichiamo una foto a colori a
Pippo Baudo che punta per la conduzione del festival di Sanremo, dal 26
febbraio, su un tris di maggiorate composto da Milly Carlucci, Brigitte Nilsen e
Alba Parietti. Sistemo invece nel taglio basso una sgradevole polemica alla
quale mi hanno costretto ‘ le bretelle rosse’ di Giuliano Ferrara. Che
sul Corriere della Sera non mi ha perdonato un’arrabbiatura con lo storico
Franco Andreucci, della casa editrice Ponte alle Grazie, evidentemente suo
amico, che mi ha combinato il guaio di trascrivermi con qualche errore,
assistito dal mio corrispondente a Mosca Francesco Bigazzi, una lettera di
Palmiro Togliatti, peraltro fotocopiata malamente nei giorni in cui a pagamento
si riusciva ad accedere a quelli che erano stati gli archivi sovietici più
inaccessibili. Ma soprattutto Giulianone non mi ha perdonato l’importanza data a
quella lettera, scritta dal leader comunista contro i militari italiani
prigionieri in Russia e trattati come bestie, lasciati morire spesso di fame.
Togliatti è morto da un bel po’, ma Giuliano, figlio della sua segretaria, ne
conserva un buon ricordo per essergli ‘ cresciuto sulle ginocchia’, come mi ha
detto per telefono Bettino Craxi come scusante di quel suo sconclusionato
attacco sul Corriere della Sera. E io di questa storia delle ginocchia mi sono
avvalso nella risposta. La riunione sta per finire quando arriva trafelato il
capocronista per darci la notizia, appena pervenutagli, dell’arresto di Mario
Chiesa in flagranza di mazzette. Presidente del Pio Albergo Trivulzio dal 1986 e
già capogruppo socialista alla provincia e poi due volte assessore al Comune di
Milano, ho conosciuto Chiesa di persona l’anno prima nella casa milanese del
geniale e simpatico fotografo Bob Krieger. L’ho reincontrato dopo qualche mese
in una cerimonia d’inaugurazione di un nuovo reparto dell’ospedale, sempre, del
Pio Albergo Trivulzio. Vi sono andato soprattutto perché informato della
presenza di Craxi e della sua intenzione di profittare dell’occasione per
esprimere un giudizio sulla situazione politica, avviata ormai verso le
elezioni. Di quella cerimonia esiste, fra le altre, una foto in cui sono ripreso
con Bettino e con Mario Chiesa. La vedrò poi pubblicata insistentemente per
ragioni non certamente occasionali, specie quando la caccia ai craxiani si farà
grossa. L’arresto del presidente del Trivulzio naturalmente mi sorprende. E ne
immagino subito le ricadute politiche, a Camere sciolte da poco per esaurimento
della legislatura e per le elezioni già fissate in aprile. Il capocronista mi
garantisce la clamorosa flagranza di reato e mi ricorda che le indagini
giudiziarie contro Chiesa sono in qualche modo collegate ad un vecchio scoop
proprio della cronaca del Giorno sui rapporti fra gli ospedali e le agenzie
delle pompe funebri. La notizia è sicuramente da prima pagina. E lì decido
personalmente di sistemarla con un grosso richiamo del servizio di cronaca a
quattro colonne, sotto il titolo centrale. Il titolo dice: Flagranza di reato
nell’ente per gli anziani - Arrestato per concussione a Milano il presidente
dell’Istituto Trivulzio. L’indomani mattina vedo che gli altri giornali di
Milano non hanno dato all’arresto di Mario Chiesa il rilievo che mi aspettavo. E
manca da alcune cronache la circostanza della flagranza, per cui mi viene il
dubbio di essere incorso in un eccesso di zelo giudiziario. Ne parlo perciò
nella prima riunione redazionale col capocronista, che mi rassicura garantendomi
di nuovo l’esattezza delle nostre notizie. Dopo molti giorni vedrò questo
particolare della riunione redazionale in qualche cronaca della ‘ concorrenza’
come una protesta, una mia ramanzina al collega, che invece stimo molto. Ma sarà
solo la prima di una serie di distorsioni tendenti a rappresentare la mia
direzione del Giorno come reticente, e a spingere il comitato di redazione ad
una vigilanza per niente sindacale, tutta politica. Ogni sera dovrò fare i conti
con chi a sua volta avrà contato il numero delle pagine e dei titoli, la
collocazione dei pezzi e quant’altro sulla escalation delle notizie provenienti
dalla Procura. Il clima diventa sempre più pesante, dentro e fuori dal giornale.
Ai funerali del padre di Craxi, che muore in tempo per risparmiarsi il dolore di
vedere dispiegarsi del tutto contro il figlio lo spettacolo di Mani pulite, mi
si avvicina Silvio Berlusconi e mi dice, preoccupato, che non può andare in giro
senza sentirsi rimproverare l’amicizia di o con Bettino. Rimango turbato, in
verità, più dalla preoccupazione di Berlusconi che dal suo racconto. Ma torniamo
al giorno dopo l’arresto di Chiesa. Ho un vecchio appuntamento a casa, per il
pranzo, con Paolo Pillitteri. Che da un mese e mezzo non è più sindaco di Milano
e si è candidato a tornare alla Camera. Gli chiedo naturalmente di Chiesa e lo
trovo sorprendentemente tranquillo, direi sarcastico con l’arrestato per le
circostanze nelle quali si è fatto sorprendere a intascare una parte della
tangente versatagli da una ditta delle pulizie del Trivulzio. Intuisco da questa
reazione di Paolo, a torto o a ragione, che Chiesa, per quanto comunemente
considerato craxiano, non faccia parte davvero del giro del segretario
socialista, di cui Paolo è cognato. Poi verrò a sapere personalmente dallo
stesso Bettino che il figlio Bobo, da lui autorizzato a candidarsi a consigliere
comunale nelle ultime votazioni milanesi e umanamente desideroso di fare una
bella figura agli occhi del padre, aveva accettato l’offerta del presidente del
Trivulzio di aiutarlo nella organizzazione della campagna elettorale, vista
l’esperienza che l’amico aveva alle spalle.
Mani pulite, tappa per tappa. Il 17
febbraio del 1992 l'arresto del presidente del Pio Albergo Trivulzio Mario
Chiesa dà il via a una serie di indagini, arresti e processi che nel giro di due
anni rivoluzionerà lo scenario politico ed economico del Paese. La scomparsa del
Pentapartito, l'esilio di Bettino Craxi, l'ascesa di Silvio Berlusconi e molto
altro, scrive il 15 febbraio 2017 “L’Espresso.
17 FEBBRAIO 1992. Arrestato il presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano
Mario Chiesa (Psi).
6 APRILE 1992. Partono le indagini sugli appalti di Malpensa 2000 e della sanità
milanese.
2 MAGGIO 1992. Avvisi di garanzia agli ex sindaci Psi di Milano Carlo Tognoli e
Paolo Pillitteri.
24 MAGGIO 1992. Il procuratore Borrelli affianca a Di Pietro e Colombo
Piercamillo Davigo.
18 GIUGNO 1992. Suicida a Lodi il segretario locale del Psi Renato Amorese.
28 GIUGNO 1992. Manifestazione a Milano a favore dei giudici impegnati in Mani
pulite.
3 LUGLIO 1992. Bettino Craxi parla alla Camera: «Bisogna dire, e tutti lo sanno,
che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale (...). Se
gran parte di questa materia dev’essere considerata puramente criminale, allora
gran parte del sistema sarebbe criminale».
3 LUGLIO 1992. Il ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli invia una
circolare contro le «manette in tv».
1 SETTEMBRE 1992. Indagato per violazione della legge sul finanziamento pubblico
dei partiti il presidente della Montedison Giuseppe Garofano.
2 SETTEMBRE 1992. Si suicida a Brescia Sergio Moroni, deputato socialista.
17 SETTEMBRE 1992. Martelli annuncia che è pronto un decreto riguardante «i rei
di corruzione, concussione e peculato».
15 DICEMBRE 1992. «Avviso di garanzia a Craxi per corruzione, ricettazione e
illecito finanziamento.
11 MAGGIO 1993. Arrestato l’ex tesoriere del Pci Renato Pollini.
10 LUGLIO 1993. Il ministro della Giustizia Giovanni Conso annuncia un disegno
di legge per correggere l’avviso di garanzia e la custodia cautelare.
20 LUGLIO 1993. Suicidio in cella nel carcere di San Vittore di Gabriele
Cagliari dopo 103 giorni di detenzione preventiva.
22 LUGLIO 1993. Inviati presso il pool di Milano gli ispettori ministeriali.
23 LUGLIO 1993. Raul Gardini si uccide con un colpo di pistola; arrestati Carlo
Sama, amministratore delegato di Montedison, e Sergio Cusani, consulente di
fiducia di Gardini.
24 AGOSTO 1993. L’inchiesta su Tangentopoli investe il tesoriere Pds Marcello
Stefanini.
4 SETTEMBRE 1993. Arrestato per corruzione il giudice Curtò per la vicenda
Enimont.
14 OTTOBRE 1993. Il tribunale della libertà scarcera Primo Greganti e critica il
pool.
28 OTTOBRE 1993. Comincia il processo a Cusani per il caso Enimont.
17 DICEMBRE 1993. Dichiarazioni di Craxi al processo Cusani-Enimont: «Tutti
sapevano nessuno parlava».
16 GENNAIO 1994. Il presidente Scalfaro scioglie le Camere.
22 GENNAIO 1994. Mino Martinazzoli chiude la Dc e dà vita al Partito popolare
italiano. Sulle ceneri del vecchio Msi nasce Alleanza nazionale.
26 GENNAIO 1994. Berlusconi annuncia la «discesa in campo».
6 FEBBRAIO 1994. Al Palafiera di Roma si tiene la prima convention di Forza
Italia dove l’ex pm Tiziana Parenti viene presentata come «il nostro futuro
ministro della Giustizia».
11 FEBBRAIO 1994. Italo Ghitti emette un’ordinanza di custodia per Paolo
Berlusconi per tangenti.
16 FEBBRAIO 1994. I tre esponenti Pds Occhetto, D’Alema e Stefanini vengono
iscritti nel registro degli indagati a seguito di una denuncia presentata da
Craxi.
9 MARZO 1994. La procura milanese chiede al gip, che non l’accoglie, la custodia
cautelare per Marcello Dell’Utri.
28 MARZO 1994. Il Polo delle libertà vince le elezioni. Forza Italia diventa il
primo partito italiano.
15 APRILE 1994. Cancellate le immunità dei vecchi deputati.
28 APRILE 1994. Sergio Cusani viene condannato a 8 anni.
5 MAGGIO 1994. Craxi si trasferisce ad Hammamet in Tunisia da dove non farà più
ritorno.
12 MAGGIO 1994. Arrestato l’ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo (Pli).
16 GIUGNO 1994. Craxi viene dichiarato “contumace”.
9 LUGLIO 1994. Arrestato il generale della Guardia di Finanza Giuseppe
Cerciello.
13 LUGLIO 1994. Il governo Berlusconi vara il decreto Biondi, che limita la
custodia cautelare in carcere e prevede un condono per le aziende.
14 LUGLIO 1994. Il pool legge in tv un comunicato contro il decreto Biondi
minacciando di abbandonare le indagini. Circa 340 detenuti lasciano il carcere
per effetto del decreto.
22 LUGLIO 1994. Dopo le proteste e le critiche della Lega, il governo ritira il
decreto e lo sostituisce con un disegno di legge.
25 LUGLIO 1994. Si costituisce Salvatore Sciascia, direttore dei servizi fiscali
della Fininvest, confessando tre tangenti alla Gdf.
26 LUGLIO 1994. Il gip Andrea Padalino firma un ordine di cattura per Paolo
Berlusconi.
29 LUGLIO 1994. Condannati per il conto Protezione Bettino Craxi, Claudio
Martelli, Licio Gelli e Silvano Larini.
22 NOVEMBRE 1994. Viene notificato a Silvio Berlusconi un invito a comparire per
concorso in corruzione di appartenenti alla Gdf durante il vertice Onu di
Napoli.
6 DICEMBRE 1994. Di Pietro, terminata la requisitoria del processo Enimont
annuncia le sue dimissioni togliendosi la toga.
7 DICEMBRE 1994. Bossi, Buttiglione e D’Alema annunciano due mozioni di sfiducia
al governo.
22 DICEMBRE 1994. Bossi toglie l’appoggio a Berlusconi che sale al Quirinale per
dare le dimissioni.
20 MAGGIO 1995. Il pool chiede il rinvio a giudizio di Silvio e Paolo Berlusconi
e del generale Cerciello per tangenti alla Gdf.
27 SETTEMBRE 1995. Tutti i 23 imputati del processo Enimont vengono condannati
in primo grado.
23 OTTOBRE 1995. Stefania Ariosto, compagna del deputato di Fi Vittorio Dotti
accusa Silvio Berlusconi e Cesare Previti di corruzione dei giudici.
7 LUGLIO 1998. Condanna in primo grado per Silvio Berlusconi nel processo per
tangenti alla Gdf (assolto in Appello e in Cassazione nel 2001).
25 anni di Mani pulite, i 10 verbali che hanno cambiato l’Italia.
Da Mario Chiesa alla maxi tangente Enimont. Dalle mazzette rosse a Berlusconi.
Tangentopoli e la fine della Prima Repubblica. Le confessioni che hanno rivelato
i segreti del potere in versione integrale, scrive Paolo Biondani il 16 febbraio
2017 su "L'Espresso". Dieci verbali che hanno cambiato la storia d’Italia. Sono
interrogatori che hanno scoperchiato il sistema della corruzione nella Prima
Repubblica. Le confessioni a valanga del primo arrestato. Le tangenti di Bettino
Craxi tra piazza Duomo e i conti svizzeri. Le corruzioni con la targa del
colosso Fiat. I fondi neri versati dall’Eni ai partiti di governo. La
maxi-tangente Enimont. Le mazzette rosse del “compagno G” e la bustarella
della Lega. Il brigadiere-eroe che denuncia la Guardia di Finanza. Lo scontro
finale tra Silvio Berlusconi e i magistrati di Mani Pulite. Sono passati 25 anni
dall’inizio dell’inchiesta giudiziaria che ha fatto crollare il muro della
cosiddetta Tangentopoli. Una corruzione enorme, sistematica, radicata a tutti i
livelli, che ha fatto esplodere il nostro debito pubblico e intossicato la
politica, l’economia, la pubblica amministrazione, le autorità di controllo. Un
sistema che inizia a crollare il 17 febbraio 1992, quando i carabinieri
ammanettano Mario Chiesa, presidente socialista di un grande ospizio milanese,
il Pio Albergo Trivulzio. L’ingegner Chiesa ha appena intascato una bustarella
di 7 milioni di lire (3.500 euro), portati nel suo ufficio da un piccolo
imprenditore di Monza, Luca Magni, che lo ha denunciato all’allora
semi-sconosciuto pm Antonio Di Pietro. In meno di tre anni, fino al dicembre
1994, i magistrati di Mani Pulite raccolgono montagne di prove che portano a
1.233 condanne definitive per corruzione, concussione, finanziamento illecito
dei partiti e fondi neri aziendali (falso in bilancio). I processi di Mani
Pulite continuano ancora oggi a dividere l’Italia in due partiti trasversali:
sostenitori e detrattori, cosiddetti giustizialisti e sedicenti garantisti. Ma
un fatto è innegabile: in nessun altro periodo si sono accumulate tante
rivelazioni sui segreti del potere. Anzi, vere e proprie confessioni.
La prima è datata 23 marzo 1992. Dopo 35 giorni di cella, Mario Chiesa rompe il
silenzio: «Intendo dire la verità». Il pm Di Pietro e il gip Italo Ghitti gli
lasciano spiegare tutta la sua carriera politica, il dramma familiare provocato
dall’arresto. Quel mattino, a San Vittore, Chiesa non si limita a confessare
l’accusa per cui è stato ammanettato, ma vuota il sacco. Ammette di aver
intascato la sua prima tangente «nel 1974 circa» e la penultima «due o tre ore
prima dell’arresto» per la bustarella di Magni. A verbale finiscono quasi
vent’anni di corruzioni. Chiesa elenca 16 aziende che gli hanno versato denaro
per gli appalti. E fa i nomi dei politici con cui ha diviso i soldi, tra cui
spiccano gli ultimi due sindaci socialisti di Milano, Carlo Tognoli e Paolo
Pillitteri. Pochi giorni dopo, le confessioni di Chiesa provocano la prima
retata di otto imprenditori, che confessano e chiamano in causa altri. È
l’inizio di un effetto-domino che fa crollare il sistema. Da un arresto
all’altro, da una confessione all’altra, l’inchiesta si allarga a tutte le
centrali degli appalti a Milano e in Lombardia: Comune, Provincia, Regione,
società controllate dai partiti come Mm (metropolitana), Atm (tram e bus), Sea
(aeroporti), Aem (centrali elettriche), e poi sanità, discariche, edilizia.
Ovunque gli amministratori di nomina politica manovrano gli appalti a favore di
aziende privilegiate, che in cambio versano mazzette ai tesorieri occulti dei
partiti, chiamati “collettori”. In breve dai cassieri lombardi si arriva ai
tesorieri nazionali. Severino Citaristi, per la Dc, confessa un decennio di
finanziamenti illeciti dopo aver ricevuto oltre 70 avvisi di garanzia. Il leader
socialista Bettino Craxi, indagato dal 15 dicembre 1992, nega tutto e attacca i
magistrati.
Il 7 febbraio 1993 un suo grande amico, Silvano Larini, si costituisce dopo una
latitanza all’estero. E confessa. Larini spiega di aver avuto da Craxi (e dal
suo padrino politico Antonio Natali) l’incarico di «incassare per il Psi il
denaro versato dalle imprese per gli appalti della metropolitana». E precisa:
«Dal 1987 fino alla primavera del 1991 ho ricevuto circa 7-8 miliardi di lire,
che ho portato negli uffici di Craxi in piazza Duomo 19». Quindi l’ex capo del
governo non solo sapeva delle tangenti al Psi, ma ha intascato per anni,
personalmente, buste piene di soldi. E a dirlo è un «intimo amico di Craxi»,
come Larini si autodefinisce. Confessa di aver prestato già allora un suo conto
svizzero, chiamato Protezione, allo stesso Craxi e al suo vice, Claudio
Martelli, che lo usarono per incassare 7 milioni di dollari: mazzette al Psi
pagate dal Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, il banchiere poi ucciso dalla
mafia a Londra (simulando un suicidio). Un segreto negato per oltre un decennio,
che era annotato in un dossier ricattatorio sequestrato a Licio Gelli quando fu
scoperta la lista degli iscritti alla loggia P2. Già dal 1992 le corruzioni
negli appalti travolgono tutti i partiti di governo (Dc, Psi, Pri, Psdi, Pli) e,
a Milano, anche la corrente migliorista del Pci-Pds, alleata dei socialisti.
Tra il 2 e il 25 febbraio 1993, un manager del gruppo Ferruzzi-Montedison,
Lorenzo Panzavolta, parla per la prima volta di tangenti (per circa 620 mila
euro) destinate anche al Pci nazionale, per gli appalti dell’Enel. Soldi
intascati su un conto svizzero dal “compagno G”, Primo Greganti, che subisce la
più lunga carcerazione preventiva di tutta Mani Pulite e viene condannato senza
mai confessare. Il suo silenzio impedisce di smascherare i beneficiari della
corruzione ai vertici del primo partito della sinistra italiana. Dai bonifici
delle tangenti, nel 1993 i magistrati risalgono ai fondi neri delle grandi
aziende e arrivano alle maxi-corruzioni. Pierfrancesco Pacini Battaglia è il
banchiere che dalla Svizzera ha gestito per anni i conti segreti dell’Eni:
almeno 500 miliardi di lire (oltre 250 milioni di euro). Il giudice Italo
Ghitti, con una battuta, lo definisce «l’uomo che sta un gradino sotto Dio».
Pacini si costituisce il 10 marzo 1993, svela le mediazioni milionarie per il
gas algerino e il petrolio libico e confessa di aver fatto arrivare in Italia
almeno 50 miliardi di lire: fondi neri dell’Eni, consegnati in contanti ai
tesorieri del Psi e in parte minore alla Dc. Quella primavera decine di
imprenditori e politici fanno la coda in procura per confessare, in un clima mai
più visto di collaborazione con la giustizia per “fine sistema”.
Eugenio Cefis, l’ex potentissimo re della chimica, viene convocato il 22 aprile
1993 come semplice testimone sul conto Protezione, di cui giura di non sapere
nulla. Riservato ed enigmatico come pochi, accetta però di verbalizzare i
segreti dei «finanziamenti dell’Eni ai partiti e a singoli politici», che
sostiene di aver «ereditato dal fondatore Enrico Mattei». «I partiti di
governo», spiega Cefis, venivano pagati «in automatico con fondi distribuiti dal
banchiere Arcaini dell’Italcasse: il grosso spettava alla Dc, poi al Psi, il
residuo a Pri, Psdi e Pli». L’Eni versava altri soldi «a singoli politici e a
giornali di partito». Anticomunista di ferro, Cefis parla pure di un versamento
estero al Pci per sbloccare un affare in Unione Sovietica. Ma pur descrivendo
vent’anni di tangenti, non fa neppure un nome dei politici corrotti, sostenendo
che non voleva conoscerli perché li «usava nell’interesse dell’Eni»,
disprezzandoli, «come Mattei».
Due giorni dopo, il 24 aprile 1993, Cesare Romiti consegna ai pm di Mani
Pulite un memoriale indirizzato al procuratore capo, Saverio Borrelli: è l’atto
di resa della Fiat. Dopo gli arresti di vari dirigenti, l’amministratore
delegato della prima industria italiana dichiara che i controlli interni hanno
confermato che almeno sei società del gruppo «non hanno potuto resistere» e
hanno dovuto accettare «un sistema altamente inquinato»: il memoriale si chiude
con i nomi dei manager Fiat pronti a confessare, con l’elenco degli appalti per
cui hanno pagato tangenti. Al memoriale è allegato un verbale dei vertici, con
Gianni e Umberto Agnelli, che il 13 aprile hanno approvato «la collaborazione
con la magistratura». Personalmente Romiti si difende, giurando di aver saputo
solo allora delle corruzioni («Sinceramente non immaginavo»), mentre era il
direttore finanziario Francesco Paolo Mattioli a gestire i fondi neri. Nel
processo, celebrato a Torino, i magistrati salgono un gradino più in alto e
condannano anche Romiti per falso in bilancio.
Il consenso di massa per la lotta alla corruzione si spezza per la prima volta a
fine luglio, con i suicidi di Gabriele Cagliari, ex presidente dell’Eni, e Raoul
Gardini, numero uno del gruppo Ferruzzi-Montedison. Il 27 luglio, nel carcere di
Opera, il manager Giuseppe Garofano spiega perché Gardini decise di «piegarsi al
ricatto del sistema politico» e confessa nei dettagli tutta la maxi-tangente
Enimont: oltre 150 miliardi di lire (75 milioni di euro) versati tra il 1990 e
le elezioni del 1992 ai cinque partiti di governo e a decine di parlamentari e
capicorrente. In cambio, la Montedison è uscita da Enimont incassando dall’Eni
1,4 miliardi di euro. Di Pietro esce dal carcere sfinito. La stessa sera, Cosa
nostra fa esplodere tre autobombe, due a Roma e una a Milano, dove la strage di
mafia uccide cinque innocenti.
In dicembre, mentre infuriano le polemiche sulle tangenti rosse e l’ex pm
Tiziana Parenti si prepara a candidarsi in Forza Italia, viene arrestato il
tesoriere della Lega, che dal giugno 1993 governa Milano. Si chiama Alessandro
Patelli, confessa di aver intascato 200 milioni di lire (100 mila euro) dalla
Montedison, ma giura di non aver detto niente a Umberto Bossi e sostiene che la
tangente sarebbe stata rubata da ignoti ladri. Anche il leader della Lega nega
di aver saputo, ma conferma di aver chiesto finanziamenti (leciti) ai manager
della Montedison e risarcisce alla procura i 200 milioni, raccolti tra gli
elettori leghisti. Come Patelli, anche Bossi viene poi condannato per
finanziamento illecito.
Dopo aver svelato nel 1992 la corruzione negli appalti e nel 1993 i fondi neri e
le maxi-tangenti, come spiega l’attuale procuratore di Milano Francesco
Greco, «il 1994 è l’anno in cui scopriamo che anche i controllori sono
corrotti». I magistrati hanno già inquisito un giudice civile pagato dall’Eni,
Diego Curtò e gli ex vertici della Consob. Il 26 aprile 1994, alle nove di sera,
un vicebrigadiere della Guardia di Finanza, Pietro Di Giovanni, si presenta in
procura, sconvolto: il suo capopattuglia, Francesco Nanocchio, gli ha dato una
busta con due milioni e mezzo di lire: il doppio dello stipendio del
vicebrigadiere. Che invece di tacere, intascare, entrare nel giro e arricchirsi
con altre mazzette, denuncia il reato. Scoperchiando un sistema di corruzione
nelle verifiche fiscali che coinvolge decine di graduati, fino al comandante di
Milano, il generale Giuseppe Cerciello. Il 7 luglio, in carcere, Nanocchio
confessa le sue mazzette e svela, tra l’altro, che la bustarella data al collega
arrivava da Telepiù, un’azienda televisiva controllata da Silvio Berlusconi,
diventato capo del governo. Nelle stesse ore altri ufficiali confessano di
essersi divisi quattro tangenti Fininvest. La sera del 13 luglio 1994 il governo
Berlusconi vara un decreto, intitolato al ministro Alfredo Biondi, che vieta gli
arresti e scarcera i corrotti. La legge, contestata dai pm, è ritirata a furor
di popolo. Quindi il manager Fininvest Salvatore Sciascia, arrestato, confessa
di aver pagato le tangenti alla Finanza, ma con fondi neri forniti da Paolo
Berlusconi all’insaputa di Silvio. I pm non ci credono e scoprono che in giugno
un ex finanziere diventato avvocato del Biscione, Massimo Maria Berruti, ha
incontrato Silvio a Palazzo Chigi. E subito dopo ha chiamato un suo ex collega
corrotto, per farlo tacere, promettendogli «la riconoscenza del gruppo
Fininvest». In ottobre parte un’ispezione ministeriale segreta su cento milioni
di lire prestati da un assicuratore a Di Pietro, che si dimette. Storditi
dall’addio, Borrelli e gli altri pm interrogano Berlusconi il 13 dicembre. Nel
passaggio cruciale Piercamillo Davigo gli contesta il depistaggio di Berruti. Il
leader di Forza Italia risponde attaccando i pm: «E per una cosa del genere
avete indagato il capo del governo? Ma vi rendete conto del danno all’Italia?».
Condannato in primo grado, Berlusconi ottiene la prescrizione in appello e una
trionfale assoluzione in Cassazione, che condanna Sciascia, Berruti e tutti gli
altri. Solo lui poteva non sapere. A Tangentopoli, alla fine, ha stravinto
Berlusconi.
Tangentopoli, i dieci verbali integrali.
Il 17 febbraio del 1992 viene arrestato Mario Chiesa. Un mese
dopo iniziano le ammissioni. Alla fine dell'inchiesta ci saranno 1.233 condanne
definitive. Ecco le carte originali delle confessioni, scrive Paolo Biondani il
15 febbraio 2017 su "L'Espresso". Dieci verbali che hanno cambiato la storia
d’Italia. Sono interrogatori che hanno scoperchiato il sistema della corruzione
nella Prima Repubblica. Dalle confessioni a valanga del primo arrestato allo
scontro finale tra Silvio Berlusconi e i magistrati di Mani Pulite. Ecco la
storia raccontata dai documenti della magistratura.
Mario Chiesa è stato il primo dei circa mille arrestati di Mani Pulite,
l’inchiesta della Procura di Milano che tra il 1992 e il 1994 ha travolto il
vecchio sistema dei partiti. Presidente socialista di un ospizio milanese,
Chiesa viene ammanettato il 17 febbraio 1992 quando ha appena incassato una
bustarella di 7 milioni di lire (3.500 euro) versata da un imprenditore delle
pulizie. Il 23 marzo 1992, davanti al pm Antonio Di Pietro, confessa vent’anni
di corruzioni sugli appalti. Le sue rivelazioni chiamano in causa decine di
indagati: imprenditori che pagavano e politici socialisti a cui consegnava
personalmente buste di denaro. Le sue accuse provocano altri arresti nuove
confessioni: l’inchiesta continua ad allargarsi e svela il sistema di
Tangentopoli.
Dagli appalti milanesi l’inchiesta risale ai tesorieri nazionali dei partiti. Il
7 febbraio 1993 si costituisce Silvano Larini, ricercato per corruzione sugli
appalti del metrò e grande amico di Bettino Craxi. Larini confessa di aver
ricevuto per anni tangenti milionarie, che consegnava personalmente al leader
socialista nel suo ufficio in piazza Duomo. Larini ammette anche di aver
prestato un suo deposito svizzero a Craxi e al suo vice, Claudio Martelli: su
quel conto, chiamato Protezione, sono arrivati 7 milioni di dollari versati nel
1980 dal Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, con la mediazione di Licio Gelli.
Pierfrancesco Pacini Battaglia è il banchiere italo-svizzero che ha gestito una
massa di fondi neri dell’Eni: oltre 500 miliardi di lire (250 milioni di euro).
Il 10 marzo 1993 si costituisce davanti al giudice Italo Ghitti e al pm Antonio
Di Pietro. Pacini Battaglia svela le mediazioni segrete sui grandi affari per il
gas e il petrolio. E confessa di aver fatto arrivare in Italia oltre 50 miliardi
di lire, consegnati in contanti ai tesorieri del Psi e della Dc, i partiti che
controllavano il colosso energetico di Stato, allora in grave crisi. Le
rivelazioni del banchiere aprono le indagini sui fondi neri delle grandi aziende
e sulle maxi-corruzioni.
Tra il 2 e il 25 febbraio 1993 si apre il fronte delle tangenti rosse. Lorenzo
Panzavolta, manager della Calcestruzzi del gruppo Ferruzzi, confessa di aver
versato mazzette (in totale circa 620 mila euro) al Pci-Pds nazionale. A
incassarle, su un conto svizzero svelato nell’interrogatorio del 25 febbraio,
era Primo Greganti, ex funzionario comunista senza incarichi ufficiali nel
partito. Prima dei verbali di Panzavolta, ie indagini per corruzione avevano
coinvolto solo la corrente migliorista, al potere a Milano con i socialisti ma
avversata dal vertice nazionale del partito. Detenuto per mesi, Greganti non
confessarà mai a chi dava i soldi.
Eugenio Cefis, il riservatissimo ed enigmatico ex re della chimica, viene
convococato come semplice testimone, il 22 aprile 1993, dai magistrati che
indagano sul crac Ambrosiano e sul conto Protezione. Spiega di non sapere nulla
di quelle vicende, ma di poter dire molto sui finanziamenti illeciti deil’Eni ai
partiti. Cefis mette a verbale i meccanismi di un sistema automatico di
creazione di fondi neri, distribuiti ai cinque partiti di governo dal banchiere
Arcaini dell’Italcasse. Un sistema che dice di aver ereditato da Enrico Mattei,
il fondatore dell’Eni. Cefis parla anche di un versamento estero al vecchio Pci
per sbloccare affari in Unione sovietica.
Il 24 aprile 1993 Cesare Romiti, amministratore delegato del gruppo FIat,
consegna ai magistrati un memoriale indirizzato al procuratore capo Francesco
Saverio Borrelli. Dopo vari arresti di manager Fiat, i vertici del gruppo
ammettono che sei società di costruzioni e forniture per i trasporti hanno
dovuto pagare tangenti per vincere appalti. Romiti sostiene di averlo saputo
solo dopo Tangentopoli, con un’inchiesta interna. Il memoriale, autorizzato da
Gianni e Umberto Agnelli, fa i nomi dei manager Fiat pronti a collaborare con la
giustizia. Una svolta per il mondo delle imprese.
Nell’autunno del 1993 i magistrati scoprono che anche la Lega Nord ha incassato
tangenti dalla Montedison. Il tesoriere del partito padano, Alessandro Patelli,
viene arrestato e il 15 dicembre 1993 confessa di aver incassato 200 milioni di
lire (100 mila euro), versatigli in contanti, in nero, dai manager del gruppo
chimico. Il leader della Lega, Umberto Bossi, nega di aver saputo della tangente
e sostiene che Patelli gliene parlò solo a cose fatte. Dopo l’interrogatorio,
Bossi restituisce alla Procura un assegno di 200 milioni raccolti con una
colletta tra i militanti leghisti e al processo Enimont viene condannato per il
reato di finanziamento illecito insieme a Patelli.
Dopo il suicidio di Raoul Gardini, il manager Giuseppe Garofano, cervello
finanziario del gruppo Ferruzzi- Montedison, detenuto nel carcere di Opera,
confessa tutti i dettagli della maxi-tangente Enimont: fondi neri per oltre 150
miliardi di lire (più di 75 milioni di euro) versati ai cinque partiti di
governo, tra il 1990 e il 1992, e a decine di parlamentari e capicorrente. Il
processo Enimont, ripreso in diretta dalle principali reti televisive, porterà
alle condanne definitive per finanziamenti illeciti di tutti i segretari e
tesorieri della Dc, Psi, Psdi, Pri e Pli, segnando la fine del vecchio sistema
dei partiti.
Il 26 aprile 1994 un vicebrigadiere della Guardia di Finanza, Pietro Di
Giovanni, denuncia una tentata corruzione: il suo capopattuglia gli ha offerto
due milioni e mezzo di lire. Il caso fa esplodere lo scandalo della corruzione
nelle verifiche fiscali, che porta alla condanna di decine di graduati, fino al
generale Giuseppe Cerciello. A partire dal 7 luglio alcuni ufficiali confessano
di aver intascato quattro tangenti dalla Fininvest. Il 13 luglio il governo
Berlusconi vara un decreto, intitolato al ministro Alfredo Biondi, che impone di
scarcerare i corrotti. Il decreto viene ritirato dopo una protesta dei pm.
Il 21 novembre 1994 Silvio Berlusconi, allora capo del governo, viene indagato
come imprenditore con l’accusa di aver autorizzato i suoi manager a pagare
tangenti alla Guardia di Finanza. Alla vigilia della data fissata per
l’Interrogatorio, Di Pietro si dimette improvvisamente. La deposizione viene
rinviata al 13 dicembre 1994. Nell’interrogatorio il pm Piercamillo Davigo
contesta a Berlusconi un depistaggio cruciale per far tacere un finanziere
corrotto. Il leader di Forza Italia nega tutto e attacca i magistrati.
Condannato in primo grado, Berlusconi ottiene l’assoluzione in Cassazione, che
condanna tutti gli altri manager Fininvest che hanno corrotto la Finanza.
Mani Pulite, Antonio Di Pietro: "Non ho rimorsi per i suicidi in
carcere", scrive il 16 febbraio 2017 “Libero
Quotidiano”. Oggi Mani Pulite "compie" 25 anni. L'inchiesta che sconvolse
l'Italia e fece crollare la prima Repubblica fa un quarto di secolo. E così,
su Il Giorno, per "celebrarla" intervistano uno dei grandi protagonisti di
quell'epoca, Antonio Di Pietro. Che azzanna, subito: "Il virus della corruzione?
Invece di cercare una cura, il sistema ha reso il ceppo resistente ai vaccini".
Insomma, per Tonino non è cambiato nulla. Ma ciò che più impressiona
dell'intervista sono altri passaggi. Per esempio, spiega di non essersi pentito
di nulla: "Errori? È inevitabile che ci siano. Se ne ho commessi, l'ho fatto
sempre in buona fede, mentre compivo il mio dovere". E ancora, aggiunge: "Se mi
posso rimproverare qualcosa, è di non essere riuscito a finire le inchieste, a
causa dei dossieraggi e delle calunnie che mi hanno spinto a smettere la toga.
Mi sono affidato all'autorità giudiziaria e sono uscito pulito". Dunque gli si
chiedono se non si abusò della carcerazione preventiva per favorire le
confessioni. Di Pietro risponde: "È una falsa giustificazione di chi non vuole
ammettere i fatti. Chi commetteva reati non era un ladro di polli, c'era
concreto pericolo di inquinamento delle prove. La carcerazione preventiva era un
atto necessario, li avevamo presi con la marmellata". Si prova dunque ad
indagare sul possibile pentimento per i suicidi ai quali spinse proprio la
carcerazione preventiva. Pentimento che non c'è. Si chiede a Di Pietro se ha dei
rimorsi, per esempio, per la morte del presidente Eni, Gabriele Cagliari, e Di
Pietro afferma: "Come faccio ad avere dei rimorsi? Intendiamoci: tutto avrei
voluto, tranne che qualcuno si togliesse la vita. Però la vita è uguale per
tutti, non capisco perché non ci sono polemiche quando a morire è un
tossicodipendente o un poveraccio. Se mi si dice: 'non bisogna più arrestare
nessuno', poi non lamentatevi se viene meno lo Stato di diritto".
25 anni dopo la stagione di Tangentopoli: quell’inutile inchiesta
di Mani pulite. L’arresto di Mario Chiesa il 17
febbraio del 1992 diede il via alla stagione che travolse la Prima Repubblica e
pensava di cambiare la storia d’Italia. Ma a distanza di un quarto di secolo
bisogna riconoscere che il problema della corruzione nel Paese è anche più
forte, scrive Antonello de Gennaro il 17 febbraio 2017 su "Il Corriere del
Giorno". Il 17 febbraio di 25 anni fa l’arresto di Mario Chiesa presidente del
Pio Albergo Trivulzio di Milano, diede inizio alla “rivoluzione
giudiziaria” che ribalta la Prima Repubblica. In appena due anni, in
cui passarono sul banco degli imputati ex premier ed ex ministri: Bettino
Craxi e Arnaldo Forlani risposero nella stessa giornata alle domande dell’(oggi
ex) pubblico ministero Antonio Di Pietro. Il terremoto si scatenò soltanto un
mese dopo quando, alle 10 del mattino del 23 marzo, Chiesa cominciò a rispondere
alle domande del pubblico ministero e del gip Italo Ghitti nel carcere di San
Vittore. Quella mattina Mario Chiesa confessò le tangenti, riempì 17 pagine di
verbale, e si vendicò di Bettino Craxi. Che soltanto venti giorni prima i aveva
commesso un errore grossolano definendo Chiesa “un mariuolo che getta un’ombra
su tutta l’immagine di un partito che a Milano, in 50 anni, non ha mai avuto un
amministratore condannato per reati gravi contro la pubblica amministrazione”.
Qualcuno, in carcere, aveva raccontato quella definizione al presidente del Pio
Albergo Trivulzio, che si sentì isolato ed abbandonato al suo destino
giudiziario dietro le sbarre. E Chiesa decise di iniziare a parlare. Fu così che
Tangentopoli ebbe inizio. Di giorno in giorno mentre si susseguivano gli
arresti i pm Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo e Piercamillo
Davigo diventavano il simbolo della speranza di cambiamento a Milano ed in
Italia. Davanti al portone del Palazzo di giustizia milanese di via Freguglia,
si trasmettevano in diretta gli effetti di quella speranza che veniva dal quarto
piano dagli uffici della procura milanese. I giornalisti bivaccavano nei
corridoi per raccontare “Tangentopoli”, anche se in quei giorni a nessuno di
noi era ben chiara dove e come sarebbe finita quella inchiesta. Si vedeva però
il terrore sui volti e negli occhi di chi attendeva di varcare la porta dei
magistrati per confessare le proprie responsabilità. Si vedevano, per la prima
volta i potenti ridotti in vittime. Ma anche persone sconosciute si presentavano
davanti alle porte dei magistrati del pool “Mani pulite”. I giornalisti
li vedevano e chiedevano loro chi fossero. Molto spesso non rispondevano,
guardavano pallidi, nervosi, sudati nel vuoto. Cosa accadeva dietro le porte dei
magistrati, noi giornalisti non potevamo vederlo. Si riusciva a
saperlo soltanto dopo, dalla voce di qualche avvocato o da qualche carta che
sfuggiva ai rigorosi controlli del pool. In un libro del 1996, Il vizio della
memoria, l’ex- pm Gherardo Colombo scriveva che “Queste nuove fonti erano di
solito persone sconosciute che si presentavano, accompagnate dal difensore, in
uno dei nostri uffici, generalmente quello di Antonio, e senza che noi sapessimo
nulla di loro raccontavano, raccontavano fatti, reati, persone coinvolte,
circostanze, date, passaggi di contanti, aperture di conti in Svizzera e così
via”. “Ogni tanto si apriva una nuova ramificazione – aggiungeva Colombo – ogni
tanto sulla superficie del cono, appariva il vertice di una nuova figura,
destinato a essere autonoma origine di un nuovo filone, che si sarebbe
sviluppato come quelli già avviati. Fin dall’inizio l’indagine aveva preso la
forma di una spirale che, seguendo i contorni di un immaginario cono rovesciato,
partendo dal vertice, si estendeva e saliva. Da un episodio quasi banale, come
ne succedono tanti – l’arresto in flagranza di un funzionario pubblico che aveva
chiesto denaro a un imprenditore recalcitrante per “consentirgli” di continuare
a lavorare presso l’istituto che presiedeva – Antonio (Di Pietro, nda),
all’inizio da solo, era riuscito ad avviare il meccanismo, fondato su una serie
di rimandi”. L’inchiesta che travolse la politica della Prima Repubblica sì
consumò ed esaurì dal febbraio 1992 al dicembre 1994 in meno di tre anni. Nei
corridoio del quarto piano le espressioni dei volti dei singoli magistrati erano
diventati il termometro degli alti e bassi dell’indagine. Ad Antonio Di Pietro,
Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo erano stati affiancati dal procuratore
capo Francesco Saverio Borrelli, da altri pm fra cui l’attuale procuratore capo
di Milano Francesco Greco, Fabio De Pasquale, Paolo Ielo, Elio Ramondini,
Raffaele Tito, Margherita Taddei e Tiziana Parenti, a causa della moltitudine
dei i filoni d’inchiesta che si erano aperti da seguire, interminabili le
confessioni da far verbalizzare, per non parlare poi delle richieste di
autorizzazione a procedere da inviare in Parlamento a carico dei politici
coinvolti. Man mano che le pressioni politiche sul pool aumentarono d’intensità,
si cominciavano a scorgere sui volti dei magistrati non più la stanchezza per
quelle interminabili confessioni raccolte, ma bensì la preoccupazione che
l’inchiesta potesse essere bloccata. Quando ormai l’indagine era decollata da un
anno e mezzo, un venerdì pomeriggio 23 luglio 1993, Antonio Di Pietro stravolto
fu visto picchiava i pugni contro il muro. Tutto il pool “Mani pulite” era sotto
choc. Quella mattina fra le 8,30 e le 8,45 poco prima di essere arrestato Raul
Gardini si era sparato un colpo di pistola alla tempia. Una a morte che seguì di
soli tre giorni il suicidio del presidente dell’Eni, Gabriele Cagliari nel nel
carcere di San Vittore. Nel settembre 1992 cera già stato un precedente momento
di crisi: il primo suicidio di Mani pulite, quello del parlamentare
socialista Sergio Moroni. Il segretario del PSI Bettino Craxi, commentò quella
morte assurda con una frase concisa che diceva tutto contro i magistrati del
pool: “Hanno creato un clima infame”. E’ stata una stagione politica che si può
capire solo con una lettura completa del corso degli eventi, in quanto le
inchieste milanesi si sono incrociate con le stragi di mafia e con una
disastrosa crisi economica profonda, che ha provocato la scomparsa di aziende
storiche e la svalutazione della lira, che spinse il Governo Amato a
prelevare dai conti correnti di tutti gli italiani il 6 per mille. Ma è stata
anche una stagione di speranza, con la speranza di un rinnovamento generazionale
ed etico della vita pubblica che si è rivelato disastroso. Sono nati nuovi
movimenti politici, da Forza Italia di Silvio Berlusconi e Giuliano Urbani,
alla Lega di Bossi e Maroni, e altri sono nati dalle polveri della tradizione
democristiana e comunista. Ma nello stesso tempo i nuovi “politicanti” si sono
ben guardati dall’instaurare di nuove leggi e strutture create per impedire
che le tangenti tornassero a circolare in tutto il Paese. E più di prima. Al
contrario sono stati introdotti dei provvedimenti che invece di rendere più
giusti i processi hanno ottenuto l’effetto contrario ostacolando la “macchina”
della Giustizia, e provocando per effetto della prescrizione la scomparsa di
migliaia di inchieste. Venticinque anni dopo, Francesco
Greco che Gherardo Colombo definiva nel suo libro “dai tempi lunghi, il più
assiduo a lavorar sulle carte, a esaminare i bilanci, a incunearsi nelle
contabilità sociali per scoprirne mancanze, falsità, duplicazioni” siede ora
nell’ufficio che fu di Francesco Saverio Borrelli. Antonio Di Pietro si è
ritirato nella sua Montenero di Bisaccia dopo aver fondato un partito l’Italia
dei Valori, ormai pressochè scomparso, ed essere stato ministro. Piercamillo
Davigo è presidente di sezione in Cassazione e presidente dell’Associazione
nazionale magistrati. Gherardo Colombo è stato componente pressochè
ininfluente del consiglio di amministrazione della RAI, è attualmente
coordinatore del Comitato per la legalità e la trasparenza del Comune di Milano
ed è presidente degli Organismi di vigilanza della Banca Popolare di Milano e
del gruppo Sole 24 Ore le cui recenti vicende societarie confermano che non sia
più molto vigile ed attento a quanto accade in giro. Dopo i venticinque anni
trascorsi, è doveroso tristemente ammettere che il Paese non è stato in grado di
fare tesoro di quel ciclone giudiziario. Risultato che oggi il problema della
corruzione è incredibilmente più forte di prima. Le ragioni e cause sono
le stessi del 1992: il finanziamento della politica non è trasparente, i partiti
continuano a “lottizzare” indisturbati società ed enti pubblici. Certo, non
esiste più quel sistema verticistico che applicava il manuale Cencelli anche
alla spartizione delle tangenti, definendo quote precise a livello cittadino,
provinciale, regionale e nazionale. Un sistema in cui – a livello locale e
nazionale – le indagini dimostrarono anche un ruolo del Partito Comunista
Italiano, da sempre molto vicino agli ambienti e correnti della magistratura.
L’inchiesta “Mani pulite” ha fatto cadere la Prima Repubblica ma non ha
sconfitto la corruzione. L’illusione dei magistrati è durata lo spazio di pochi
anni. Gli echi di quella stagione si sono spenti. Ed al quarto piano del Palazzo
di giustizia di Milano sono esplosi i veleni fra gli stessi magistrati. Le
inchieste chiaramente non si sono fermate ma non viene più assegnato loro quella
speranza che si respirava ascoltato il pensiero e le opinioni degli italiani
nella stagione di “Tangentopoli”. Adesso i magistrati hanno solo il compito che
dovrebbero sempre avere: semplicemente trovare i reati, impedirli e punirli.
Senza avere la pretesa che debbano essere i magistrati i delegati a correggere
le storture della democrazia nel nostro Paese. Nel 2017 le segreterie dei
partiti non sono più il fulcro della gestione dei finanziamenti illeciti. Adesso
il mercato della corruzione è dominato da consorterie trasversali, bande che
legano gli interessi di politici e imprenditori. E sempre più spesso le mafie si
inseriscono in queste dinamiche, offrendo bustarelle e mettendo a disposizione i
loro capitali. E’ il copione di Mafia Capitale, è il modello criminale che
minaccia il nostro futuro. E Roma sotto la guida del
procuratore capo Pignatone non è più il porto delle nebbie, mentre non sono
pochi i magistrati che in Italia vengono denunciati per gli abusi commessi
nell’esercizio del loro potere, a volte vengono arrestati, si lanciamo in
politica e spesso finiscono sotto inchiesta del Consiglio Superiore della
Magistratura come il novello autocandidato “salvatore del Paese ” Michele
Emiliano che ha dimenticato e rimosso….frettolosamente certe frequentazioni e
rapporti personali con la famiglia di imprenditori baresi De Gennaro coinvolti
nell’inchiesta su alcuni appalti realizzati a Bari negli ultimi anni. E’
l’Italia….bellezza? O ha ragione chi sostiene che il nostro Paese viveva meglio
nella Prima Repubblica, e la politica nonostante tutto era una cosa seria?
Un inedito di Bettino Craxi: «Ecco cosa fu Tangentopoli».
A partire da martedì prossimo, fino a sabato, il Dubbio pubblicherà il memoriale
di Craxi, scrive Piero Sansonetti il 12 febbraio 2017 su "Il Dubbio". Nel
febbraio di venticinque anni fa (esattamente il 17 febbraio) nasceva
Tangentopoli. Cioè iniziava quell’inchiesta giudiziaria, chiamata “Mani pulite”,
condotta da un pool di magistrati i cui nomi sono ancora oggi molto noti (Di
Pietro, Davigo, Colombo, D’Ambrosio, Ielo, coordinati dal Procuratore Borrelli)
che in pochi mesi avrebbe raso al suolo la Prima Repubblica, cancellato partiti
democratici radicatissimi, come la Dc e il Psi (oltre a vari partiti più
piccoli), eliminato leader di grande statura, riformato profondamente e
ridimensionato tutta la politica italiana. I numeri di quella inchiesta sono
impressionanti. Più di 20 mila avvisi di reato, più di quattromila arresti, una
decina di suicidi. Tutti tra esponenti alti e medio- alti del mondo politico e
imprenditoriale. Alla fine ci furono un migliaio di condanne. Che indubbiamente
sono tante, ma sono anche poche se si considera la quantità di persone travolte
dall’inchiesta e poi risultate innocenti. Più o meno 19 mila. Tra i condannati,
molti hanno continuato a reclamare la propria innocenza. E tra questi il più
famoso di tutti, e anche il più combattivo, è stato Bettino Craxi. Sapete che
Craxi nel 1994 si rifugiò in esilio in Tunisia. E lì trascorse gli ultimi sei
anni della sua vita. Pochi mesi pima di morire, nella speranza che il parlamento
si decidesse a varare una commissione di inchiesta su Tangentopoli, Craxi
scrisse un memoriale di 24 pagine che poi non fu consegnato a nessuno, perché la
commissione di inchiesta non fu mai formata, forse per pigrizia, più
probabilmente per non sfidare la magistratura, che non gradiva. Così il
memoriale di Craxi, che doveva essere una relazione da consegnare alla
commissione parlamentare, è rimasto in questi anni alla fondazione Craxi. La
quale gentilmente, in occasione di questo anniversario, ci ha concesso di
pubblicarlo. Lo faremo, sul Dubbio, a partire da martedì prossimo,
suddividendolo in cinque puntate: una puntata al giorno, fino a sabato. Si
tratta di un documento inedito, molto interessante, e di valore storico
assoluto. Perché ricostruisce la vera struttura di Tangentopoli. E cioè racconta
di come la Repubblica italiana, dall’inizio della sua vita, nel 1945, ha visto
la propria struttura politica principale – costituita dai partiti – finanziata
permanentemente in modo illegale o irregolare. E di come questa metodologia
fosse da tutti ben conosciuta e da tutti accettata. Nel mondo politico, nel
mondo dell’economia, nella magistratura. Perché allora il problema fu sempre
ignorato? Perché nessuno aveva mai voluto mettere le mani sulla questione, molto
complicata, del finanziamento dei partiti. Per superare il finanziamento
illegale c’erano solo due strade: realizzare un robusto e adeguato finanziamento
pubblico, che rendesse inutile il finanziamento illegale, oppure abolire i
partiti. Fu scelta la seconda via. Craxi descrive in modo dettagliato i costi
della politica democratica, e poi racconta la natura dei finanziamenti (che
erano e non potevano essere che ingenti) dagli anni 40 in poi: potenze
straniere, enti pubblici, impresa privata. E ragiona anche su come, almeno in
parte, questi finanziamenti condizionassero le scelte dei partiti, sia sul
terreno delle politiche economiche sia della politica estera. La lettura del
memoriale- Craxi pone, quasi 20 anni dopo la sua morte, alcune domande molto
serie e anche difficili. Provo a riassumerle in modo schematico:
1) Se è vero – e non mi pare che nessuno mai abbia nemmeno provato a smentire
questo dato – che tutta la politica, per quasi cinquant’anni, è stata finanziata
illegalmente, perché solo nel 1992 la magistratura ha deciso di intervenire?
2) Se è vero che tutta la politica era finanziata illegalmente, perché furono
colpiti solo i partiti di governo, e in particolare il Psi?
3) Se è vero, come oggi dice il dottor Davigo, che i finanziamenti illegali sono
continuati per anni, e ancora continuano, come mai nel 1994, e cioè dopo che
Bettino Craxi era stato abbattuto, “Mani pulite” si fermò? Craxi era un
obiettivo speciale per il pool milanese? La sua sconfitta fu considerata un
risultato sufficiente per il successo dell’inchiesta?
4) La scelta di affrontare il finanziamento illecito dei partiti coi
“bulldozer”, che provocò di fatto la fine del partito politico – di massa,
democratico e popolare – che avevamo conosciuto fino ad allora, fu sostenuta in
qualche modo da forze estranee alla magistratura ( forse economiche, editoria,
giornali) che erano interessate a nuove forme, leaderistiche e personalistiche,
di politica, che riducessero al minimo il tasso democratico, e semplificassero
il processo decisionale e il rapporto tra politica e altri poteri?
Per ora ci fermiamo a queste domande. Nei prossimi giorni, pubblicando il
memoriale di Bettino Craxi, cercheremo di aprire la discussione su questi
argomenti. Forse il fatto che sia passato un quarto di secolo può consentire,
oggi, una discussione vera, senza tabù, per capire davvero cos’è successo,
perché è successo, se tutto quello che è successo è stata una grande opera di
giustizia o di ingiustizia.
A 25 anni dall’inchiesta “Mani pulite” è pubblicato su "Il Dubbio" del 14
Febbraio 2017 il Memoriale scritto dall’ex premier e segretario socialista prima
di morire. Un testo in cui descrive i meccanismi del finanziamento illegale
della politica e la differenza tra finanziamento illegale e corruzione. «Vi
spiego come funzionava Tangentopoli», scriveva Bettino Craxi.
«In Italia, il finanziamento illegale della politica non è di certo un fenomeno
nato e vissuto solo negli anni ’ 80 e seguenti. Eppure c’è chi, a digiuno di
storia e navigando nella mistificazione, ne parla come se di questo si sia
trattato. Tutto al contrario questo fenomeno accompagna addirittura la storia
nazionale, almeno dall’unità d’Italia in poi. I mezzi finanziari per sostenere
le attività politiche, le loro strutture permanenti di sostegno, le campagne di
propaganda e le campagne elettorali sono sempre stati ricercati e trovati
seguendo sentieri che molto spesso sono andati ben al di là delle regole e dei
confini della normalità, della trasparenza e della legalità. Senza scavare in
mezzo agli innumerevoli episodi di tempi ormai molto lontani, attraverso il
corso della storia italiana prima dello Stato unitario, monarchico, liberale e
poi fascista ma limitandoci solo a considerare la vita della Repubblica
democratica si può senz’altro dire che sin dalle sue origini e cioè sin dal
decorrere del dopoguerra, il finanziamento della politica, tanto nei suoi
aspetti interni che in quelli internazionali, ha presentato molti lati oscuri, a
tutt’oggi peraltro non tutti chiariti o chiariti solo in parte. All’interno di
un fenomeno così diffuso non sono poi naturalmente mancati, nelle varie epoche,
episodi molteplici di corruzione, di degenerazione e di malcostume. Era una
materia per la quale il concetto di controllo era sempre molto discutibile, la
segretezza delle operazioni aveva un suo ruolo così come lo aveva la delicatezza
delle implicazioni politiche. I Partiti, le correnti organizzate dei partiti, i
clan politici, i singoli esponenti della classe politica, nello scorrere della
vita democratica, delle sue contrapposizioni, delle sue alleanze e dei suoi
contrasti, si sono comunque sempre alimentati finanziariamente nelle forme più
diverse, unendo insieme entrate dichiarate e rese pubbliche ad entrate invece
molto più spesso non dichiarate e quindi rimaste sostanzialmente nell’ombra,
ignorate persino dai membri stessi delle singole organizzazioni. La storia della
democrazia repubblicana potrebbe così essere letta anche attraverso la complessa
storia del finanziamento dei soggetti politici che hanno esercitato in essa un
ruolo preminente e significativo, partecipando e determinando lo svolgimento e
la dialettica propria della vita democratica. Intendiamo riferirci in questo
modo soprattutto a sistemi e fonti di finanziamento attorno alle quali si sono
mosse le influenze di potere, l’azione dei gruppi economici pubblici e privati e
delle organizzazioni sociali, le relazioni, le influenze, le solidarietà e i
commerci, con connessioni o meno, a seconda dei casi, con attività di carattere
spionistico, eversivo, illegale, internazionali. Anche la corruzione nella
Pubblica Amministrazione e la corruzione aziendale non sono di certo
caratteristiche specifiche e nuove nate negli anni ’ 80. Si tratta di fenomeni,
tanto il primo che il secondo, che hanno come è noto radici antiche anzi
antichissime. Esse giungono attraverso vie secolari sino alla moderna società
industriale dove hanno avuto una loro diffusione con tratti particolari ma
comunque sempre assai ben individuabili. Esse hanno trovato e trovano i loro
collegamenti con il finanziamento illegale della politica, senza tuttavia
necessariamente identificarsi con esso, trattandosi di fenomeni di portata ben
più generale, con responsabilità ed interessi propri e diretti di classi
burocratiche, manageriali, imprenditoriali, professionali oltreché naturalmente
di soggetti individuali della politica e dell’amministrazione. Di finanziamenti
non dichiarati e quindi, dopo l’entrata in vigore di apposite leggi, che
regolavano la materia, di finanziamenti illegali, hanno certamente beneficiato
sistematicamente tutti i partiti democratici nessuno escluso. Se vi sono delle
eccezioni, come da qualche parte si afferma, si tratta di formazioni minori di
cui tuttavia non risulta che nessuno mai abbia effettuato controlli sui bilanci,
le entrate, le spese. Di finanziamenti non dichiarati ha certamente beneficiato
gran parte della classe politica, ivi compresi quindi buona parte di coloro che,
in questi anni, si sono messi le maschere e i panni del moralizzatore. Ce ne è
in circolazione un numero notevole a rendere ancor più falsa e paradossale
l’attuale situazione. Vi sono alcuni tra questi che lo hanno fatto sino a quando
non sono stati smascherati. Altri lo continuano a fare, sino a quando,
nonostante tutte le protezioni, non finiranno con il subire la stessa sorte di
altri, come è possibile e naturalmente auspicabile che avvenga, anche se ormai
tanto materiale è finito in cavalleria e per riesumarlo occorrerebbero ricerche
molte impegnate. Gli uni e gli altri, Partiti e classe politica, fronteggiavano
un bagaglio di spese, che, a parte possibili ma abbastanza poche eccezioni di
soggetti ad alto reddito personale, che meriterebbero di essere elencati, non
potevano essere affrontate se non con il ricorso ad entrate di tipo
straordinario. Questa linea di condotta era propria di tutti i maggiori Partiti
del Paese, sia che si trattasse di Partiti di governo che di Partiti di
opposizione. Tutti si avvalevano, naturalmente in misura diversa, di strutture
burocratiche diversificate, di reti associative, di scopo che esercitavano
un’azione permanente di sostegno, di reti di informazione fondata su quotidiani
e periodici, di canali radiofonici e televisivi, di attività editoriali, di
centri-studi, di scuole di formazione politica. Altre iniziative di rilievo
finanziario riguardavano acquisizioni immobiliari per sedi e luoghi di incontro,
circoli e quant’altro si proponeva come utile e necessario per favorire ed
incrementare la vita associativa e per moltiplicare le iniziative di incontro, i
dibattiti, le manifestazioni. I Partiti minori, in forma minore, con esigenze
minori, partecipavano tuttavia anch’essi alla ricerca possibile dei mezzi
finanziari di cui avevano bisogno. Operavano naturalmente con strutture ridotte,
apparati più piccoli, esigenze finanziarie di spesa non paragonabili quindi a
quelle dei grandi partiti. E tuttavia, anche quasi tutti i Partiti minori, come
appare documentato, contavano su quotidiani, periodici, case editrici, sedi in
gran parte dei comuni del paese, e, nell’insieme, affrontavano le campagne
elettorali gareggiando spesso per l’ampiezza delle risorse impegnate con la
propaganda dei Partiti maggiori e campagne elettorali personali assolutamente
competitive per i mezzi di propaganda impegnati. Non sarebbe difficile per
questo fare qualche esempio perfettamente documentabile. Piccolo partito, grande
candidato, grande campagna elettorale. Per tutti, l’asprezza della lotta
politica, l’urto frontale che contrapponeva le forze tra loro, la concorrenza e
la contrapposizione sovente esasperata, la lotta tra i candidati per conquistare
la elezione, l’organizzazione della raccolta delle preferenze per i singoli, per
i clan, le correnti, e le cordate, finivano con il giustificare agli occhi dei
responsabili politici, nell’ottica dello scontro e della rivalità, e nella
prospettiva del successo o della sconfitta, la ricerca talvolta anche la più
spregiudicata dei mezzi finanziari. E, talvolta, così come era spregiudicata la
raccolta egualmente ne era spregiudicato l’utilizzo. I Partiti in ogni caso non
hanno mai vissuto dei soli mezzi derivanti dalle quote associative e dalle
sottoscrizioni così come essi venivano dichiarando ufficialmente. Il sistema era
ben più complesso, articolato e spesso incontrollato e talvolta anche assai
contorto e tutti i dirigenti ne erano perfettamente consapevoli. Alla entrate
ordinarie e dichiarate si aggiungeva così una parte cospicua costituita da forme
di finanziamento non dichiarato proveniente dalle fonti più varie e disparate,
ed anche quindi con caratteristiche di provenienza illegittima e comunque in
violazioni di leggi dello Stato ed in primo luogo della legge sul finanziamento
dei partiti. L’industria di Stato, l’industria privata, i gruppi economici e
finanziari, il movimento cooperativo, le associazioni che univano grandi
categorie della produzione, della distribuzione e dei servizi, singoli, gruppi e
società hanno tutti nell’insieme concorso al finanziamento della politica, e del
personale politico, ed a seconda dei casi, in forma stabile, in forma periodica,
in occasioni di campagne elettorali in modo diretto ed in modo indiretto. Le
loro decisioni si diversificavano per l’entità delle contribuzioni e per la loro
destinazione a seconda delle loro differenti opzioni politiche, delle loro
convenienze, delle loro preferenze personali. È così capitato che il movimento
cooperativo rosso per esempio sia diventato uno dei principali agenti
organizzatori e trasmettitori di finanziamenti in forma regolare e costante al
Pci. Ciò avveniva soprattutto in certe regioni ma anche su scala nazionale,
tanto al Nord che al Centro che al Sud. Il Psi partecipava a questa forma di
finanziamento ricevendone vantaggi ma con caratteri e con un ruolo tuttavia
assolutamente minore. Tutto questo sistema può naturalmente essere rivisitato e
ricostruito, perlomeno nelle sue grandi linee, percorrendo le epoche diverse che
sono state attraversate, e analizzando tutti gli aspetti vari, particolari e
specifici su cui esso si era venuto strutturando.
Tutta l’esperienza che si è accumulata nella vita democratica repubblicana
conduce a concludere, con assoluta evidenza, che il complesso del sistema
economico, a partire della sue entità maggiori e più significative, partecipava
con l’erogazione diretta di mezzi finanziari e attraverso altre forme indirette
di appoggio, ed anche nel campo della informazione, della pubblicità e dei
servizi, al sostegno ed anche allo sviluppo del sistema politico democratico e
delle sue attività politiche, associative, culturali, formative,
propagandistiche, elettorali. Parimenti il sistema economico esercitava sul
sistema politico e sulle sue decisioni un’azione di condizionamento che era
maggiore o minore in relazione alla capacità ed alla forza di autorità e di
autonomia delle differenti formazioni politiche e dei diversi soggetti politici.
Questo processo di condizionamento si esercitava sui Partiti, sul loro
espressioni parlamentari, governative ed amministrative ed anche naturalmente
sui singoli esponenti politici soprattutto quando questi ultimi divenivano
personalmente tributari in modo decisivo per le loro attività, per il sostegno
della propria organizzazione ed immagine, e per il successo elettorale proprio e
dei propri grandi elettori. In questo modo ricevevano contributi sia i Partiti
che le correnti dei Partiti, spesso organizzate come sotto-partiti, che i
singoli esponenti politici che necessitavano anch’essi di reti di supporto
burocratiche, associative o più semplicemente clientelari. Agendo in questo modo
i gruppi economici finanziatori erano a loro volta mossi da obiettivi
molteplici. Perseguivano obiettivi di carattere generale volti a difendere un
sistema di valori da cui si sentivano garantiti e a sostenere determinati
equilibri politici e le forze che li costituivano e li alimentavano e che quindi
ricercavano, mantenevano, o si sforzavano di mantenere, un quadro di stabilità
politica nel governo generale della Repubblica, sostenendo posizioni anche tra
loro divergenti. Erano mossi ancora da motivi di carattere generale in funzione
di politiche economiche finanziarie, industriali, scientifiche, ed anche di
politiche comunitarie ed internazionali che consideravano adeguate e necessarie
per il proprio sviluppo e corrispondenti alle esigenze produttive ed economiche
generali del Paese. Ancora erano mossi da interessi più particolari con
riferimento a specifiche decisioni legislative, normative, amministrative e di
orientamento e definizione della spesa pubblica. Ancora vi erano interessi più
delimitati che riguardavano i programmi, la loro attuazione, e le decisioni
relative delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Pubblici nazionali,
regionali e locali. In quest’ambito aveva una valenza l’influenza dei Partiti e
dei gruppi politici, ma nell’insieme le maggiori forze economiche avevano anche
e soprattutto proprie strutture e capacità di influenza diretta sulla Pubblica
Amministrazione e sugli Enti pubblici con un complesso di relazioni spesso
dirette e personali e con un grado quindi di penetrazione notevole ed efficace,
volto a predisporre ed ad indirizzare nelle direzioni volute le decisioni
pubbliche e la stessa condotta del ceto politico. Tuttavia anche in questi casi,
quando l’influenza veniva esercitata in una forma lineare, il grado di garanzia
e di tutela del pubblico e generale interesse poteva essere salvaguardato.
Quando invece questa influenza veniva esercitata in forma spregiudicata e
distorta, con l’impiego di mezzi e secondo metodi di corruzione personale, cui
spesso non erano estranei gli interessi degli stessi soggetti erogatori,
sull’interesse pubblico reale veniva sovente steso un velo interessato e
pietoso. Nel mondo politico gli interlocutori privilegiati erano le istituzioni
governative, parlamentari e le formazioni che componevano le maggioranze. Ma non
venivano affatto trascurate quelle di opposizione, naturalmente in modo diverso
a seconda dei casi, ed in rapporto alla loro influenza nel Parlamento, nelle
istituzioni, nei grandi Enti Pubblici, nelle Amministrazioni regionali e locali
e in generale nella vita del Paese e negli orientamenti della pubblica opinione.
Nelle Amministrazioni regionali e locali, del resto le maggioranze politiche e
di governo si diversificavano a secondo delle Regioni, dei Comuni e delle
Province e, in molti casi, formazioni all’opposizione sul piano nazionale,
costituivano invece il perno politico centrale o sussidiario del governo
regionale e locale. Quando si trattava di decisioni che potevano avere effetto
sull’attività produttiva o riguardavano programmi di Enti sociali, veniva
ricercata e spesso ottenuta anche l’influenza e l’accordo di interlocutori del
mondo sindacale e sociale anche con contributi finanziari volti ed effettuati in
questa direzione. In taluni casi, rappresentanze sindacali anche di livello
nazionale ricevevano perciò, in forma diretta o indiretta, contribuzioni in
forma periodica ed anche continuativa. In particolare, in relazione all’attività
di Enti amministrati da rappresentanze sindacali il dialogo e le eventuali
contribuzioni finanziarie connesse veniva stabilito direttamente con
interlocutori sindacali oppure attraverso la mediazione di fiduciari dei Partiti
cui le rappresentanze sindacali in questione erano collegate. Il finanziamento
irregolare ed illegale rivolto ai partiti ed alle attività politiche, ed anche a
gruppi e singoli esponenti del mondo politico, oltreché di carattere interno era
anche di carattere e provenienza internazionale. Si tratta in questo caso di un
capitolo molto complesso. Esso non è mai stato esplorato sino in fondo, anche
se, per molte parti, a distanza di decenni, taluni dei suoi aspetti sono venuti
alla luce in modo abbastanza evidente e documentato. Il finanziamento
internazionale a forze politiche italiane nel periodo repubblicano ha sempre
presentato una natura composita. Esso comprendeva voci e fonti molto
diversificate, era di natura finanziaria diretta e di natura indiretta, si
poteva presentare anche in forma di servizi e spesso in connessione con attività
commerciali. I Paesi che, nelle varie forme, hanno concorso a questo tipo di
finanziamento sono stati molti. Tuttavia, sostanzialmente, si trattava di
strutture dipendenti dagli Usa e dall’URSS e di attività e strutture proprie dei
Paesi appartenenti alle loro aree di influenza politico- militare. Le due
maggiori potenze, guidando le loro alleanze politico- militari, avevano
ingaggiato tra loro un braccio di ferro durato poi decenni. Si trattava di una
contrapposizione e di una contesa che si proponeva di difendere, consolidare ad
estendere le rispettive aree di influenza e quindi, in particolare, punti
geopolitici di importanza strategica. A questo scopo venivano effettuati
interventi soprattutto nei Paesi considerati anelli deboli e, a causa della loro
fragilità ed instabilità politica, esposti al rischio ed alla possibilità di una
frattura interna e di un rovesciamento delle posizioni, e in aree che, per le
loro caratteristiche, potevano essere considerate utili. In Europa, tra i grandi
Paesi, l’Italia era certamente considerato uno di questi. In questo contesto,
diversi Partiti italiani e diversi leader politici, in epoche diverse hanno
sollecitato, accettato, beneficiato di finanziamenti di questa natura, anche se
ci riferiamo soprattutto agli anni del dopoguerra. Tutti i maggiori leader del
dopoguerra italiano hanno fatto i conti con questa realtà ed hanno rafforzato la
propria azione anche ricorrendo all’aiuto di finanziamenti internazionali. Dei
finanziamenti provenienti dagli Usa hanno così beneficiato, per tutto un certo
periodo, formazioni politiche dei governi postbellici. Dei finanziamenti
provenienti dall’URSS e dal blocco sovietico ha beneficiato soprattutto il
Partito Comunista. Quest’ultimo ne ha del resto sempre beneficiato sin dalla sua
origine e via via attraverso le fasi travagliate della sua storia, sino agli
anni più recenti e cioè sino alla caduta dell’impero sovietico ed alla fine del
potere comunista nell’URSS. Dalla sua nascita, e prima ancora come corrente del
PSI, sino alla sua scomparsa, visse di finanziamenti sovietici il PSIUP e, per
aggiunta, ricevettero finanziamenti sovietici singole personalità o frazioni
politiche tanto del PSIUP che del PCI. Anche il partito Socialista aveva
ricevuto nel passato finanziamenti dall’estero, sotto varie forme, dirette ed
indirette Sino al 1956, e cioè l’anno della rivolta ungherese, della solidarietà
espressa dai socialisti italiani ai patrioti insorti a Budapest, con la
conseguente aspra polemica con l’invasore sovietico e la rottura che poi ne
seguì con i comunisti italiani, il PSI aveva ricevuto aiuti finanziari e
materiali dall’URSS e da altri Paesi del Patto di Varsavia. Nel periodo
immediatamente successivo ricevette invece un aiuto finanziario direttamente
dagli Usa. Sotto le direzioni politiche che seguirono il PSI non mi risulta
abbia mai ricevuto alcun finanziamento proveniente da Partiti o da Stati
stranieri, mentre non si deve escludere che singoli esponenti del PSI ne abbiano
potuto beneficiare sulla base di loro relazioni personali e particolari e in
quest’ambito anche gli stessi Amministratori del PSI.
In materia di finanziamento estero il Pci, divenuto poi Pds, a differenza degli
altri Partiti, aveva organizzato una vera e propria struttura permanente che nel
corso dei decenni, si è venuta costantemente ampliando e perfezionando sì da
garantire dei flussi di finanziamento costanti che rappresentavano una parte
certamente rilevante delle sue entrate. Il potere sovietico, anche nei momenti
di incomprensione e di difficoltà nei suoi rapporti con il Pci e le sue
elaborazioni politiche, sia pure diffidandone, ha sempre continuato a
considerare il Partito Comunista italiano come il suo principale alleato
occidentale. In nessun altro Paese dell’Occidente un partito comunista era mai
del resto riuscito a realizzare un così forte radicamento popolare e ad
esercitare una così grande influenza come il Pci in Italia. La sua posizione era
considerata di essenziale importanza anche perché si trattava di un Paese di
frontiera dell’Alleanza Atlantica. Tra l’Urss e il Pci si mantenne vivo un
legame storico profondo che tale rimase anche quando si erano allargate le
maglie dell’autonomia del movimento comunista italiano e si era venuto
modificando il rapporto di stretta obbedienza ideologica e politica rispetto al
potere sovietico, e la stessa Urss aveva preso a finanziare frazioni interne del
Pci. Restava comunque la sistematica continuità e l’ampiezza degli aiuti
finanziari che non sono mai venuti a mancare. Questi contributi provenivano
direttamente dal Pcus e, a partire dal ’ 74, da una apposita organizzazione
alimentata con fondi dell’Urss e dagli altri Paesi del Patto di Varsavia.
Provenivano da interventi specifici del Kgb e da Servizi Segreti collegati.
Provenivano da altre entità ed istituzioni sovietiche compresa la “Croce Rossa”.
Si trattava di aiuti finanziari e di altre forme di solidarietà attraverso la
erogazione gratuita di servizi sanitari, di ospitalità politica e turistica, di
servizi culturali, di formazione accademica e professionale ed anche di
specializzazione in vari campi, ivi compresi attività di natura spionistica e
clandestina. Ma la parte di gran lunga più rilevante proveniva dalle attività di
import- export, dirette, indirette, partecipate e dalle commissioni sui grandi
lavori effettuati da imprese italiane in Urss e nei Paesi del Comecon. Era anche
in ragione di questo sostegno straordinario che proveniva, con un flusso
costante, dal blocco politico- militare avverso al blocco politico- militare di
cui faceva parte il nostro Paese, che il maggior Partito di opposizione poteva
contare su strutture burocratiche partitiche permanenti che non avevano l’eguale
in nessun altro Paese del mondo non comunista, e poteva parimenti contare su
risorse certamente all’altezza se non superiori a quelle di qualsiasi altro
Partito Italiano di governo e non. Nello scontro politico non mancava un fattore
anomalo. Risulterà infatti anche storicamente accertato il comportamento di
totale cinismo di gruppi economici ed industriali di primo piano del nostro
Paese che, perseguendo il loro particolare interesse e, in taluni casi, anche in
violazione delle norme concordate in sede di Alleanza Atlantica, alimentarono la
possibilità di finanziamento dei comunisti italiani, contribuendo ad accrescere
in tal modo la distorsione dei rapporti nella vita democratica nazionale. Non
c’è dubbio, del resto che il finanziamento estero assicurato ai comunisti
italiani era di natura tale da provocare, in questo campo, il moltiplicarsi
delle reazioni, in un certo senso convenzionali, delle formazioni politiche di
Governo. Le leggi sul finanziamento pubblico dei partiti che si proponevano di
riportare ordine nella materia, di regolarla, di assicurare un sostegno pubblico
sostitutivo dei sistemi di finanziamento irregolare che si erano venuti sempre
più diffondendo, in realtà non riuscirono affatto a modificare di molto la
situazione. Mentre da un lato infatti i Partiti potevano contare su di un
contributo annuale certo anche se delimitato, dall’altro si trovavano sempre di
fronte ad un aumento crescente dei fabbisogni e delle spese. I contributi dello
Stato erogati sulla base della legge erano d’altra parte già in partenza del
tutto inadeguati e per di più non indicizzati. Con il passare del tempo
l’incidenza ed il valore del contributo pubblico si venne così progressivamente
ridimensionando. In rapporto ai contributi erogati dallo Stato ai Partiti
politici in altre democrazie europee, per esempio la Repubblica Federale
tedesca, il contributo italiano appariva di gran lunga inferiore e largamente
insufficiente. Dal canto loro invece le spese continuavano ad aumentare. Era il
portato stesso dello sviluppo della società burocratica, dall’estendersi delle
reti di informazione e dei servizi mentre si moltiplicavano le varie
articolazioni e strutture necessarie per l’efficacia della propaganda e mentre
contemporaneamente crescevano anche gli stimoli verso la spettacolarizzazione
della politica, e la connessa competitività per la conquista del consenso. La
ricerca di mezzi finanziari per sostenere ed alimentare le attività politiche in
tutte le loro diverse espressioni, invece di ridursi, era sollecitata ad
allargarsi, sia ripercorrendo le vie consuete che individuandone di nuove. In
questo modo finivano con l’ampliarsi anche aree contigue ed oscure entro le
quali questa ricerca di mezzi finanziari, fatta in nome e per contro dei
partiti, spesso si trovava ad agire in modo incontrollato e difficilmente
controllabile. E, all’interno di aree oscure, diventava molto difficile impedire
il diffondersi, in livelli diversi, di degenerazioni e di corruttele di
molteplice natura. Bisogna considerare inoltre che all’aumento continuo delle
spese corrispondeva da un altro lato una progressiva riduzione delle entrate
tradizionali ordinarie e cioè quelle derivanti dalle quote associative e dalle
sottoscrizioni volontarie. Talune spese erano peraltro di natura tale da non
poter essere fatte oggetto di riduzioni. Per esempio le spese per il personale.
Queste non potevano essere quasi mai ridotte. Di fronte a misure di riduzione,
intervenivano pretori sempre pronti ad imporre le riassunzioni del personale. I
sindacati per parte loro avevano ottenuto la introduzione nei partiti del
contratto del commercio, e data la sua improprietà, in aggiunta anche di un
contratto integrativo aziendale. A ciò si aggiunga che, almeno per quanto
riguarda il Psi, l’Amministrazione centrale venne chiamata a rispondere, subendo
ripetute condanne, anche del personale liberamente assunto da organizzazioni
periferiche e da loro retribuito. La riduzione delle entrate d’altro canto si
poneva in parallelo con una società del benessere che, facendosi strada con gli
stili propri di un consumismo sempre più diffuso, con le sue più ampie libertà,
e con gli spazi vitali occupati dal video e dallo spettacolo, riducevano il
valore e la portata associativa dell’entità tradizionale e tipica del Partito.
Un tempo la vita associativa del Partito, per i suoi aderenti, se non era tutto
rappresentava certo moltissimo. Il Partito non era solo uno strumento di lotta
politica e di lotta elettorale ma rispondeva a bisogni associativi, sociali,
culturali, umani. Entrando in una nuova fase l’associazionismo partitico,
seguendo la sorte che deriva da una più generale evoluzione, perde di peso, si
riduce, si isterilisce. Dalla nuova società che avanza vengono offerte altre
opportunità ed altre possibilità di incontri, di attività, di iniziativa
personale e di gruppo. La struttura Partito, soprattutto nelle grandi città,
tende generalmente a trasformarsi. Succede così che il suo ruolo cambia, mentre
la vita interna si rianima e rinasce solo e soprattutto in funzione delle fasi
elettorali e pre-elettorali. Nell’area partitica prende contemporaneamente corpo
un nuovo fenomeno negativo. Paradossalmente infatti mentre da un lato si riduce
e si isterilisce il ruolo associativo dei partiti, e quindi l’attività dei suoi
membri, dall’altro tende ad aumentare il numero degli iscritti. E’ il segno
inequivocabile di una degenerazione che penetra nella vita dei Partiti, o almeno
in una parte importante del sistema partitico e in particolare di quello di
governo.
Nella vita partitica si affaccia il mercato delle tessere i cui pacchetti,
corrispondenti ad iscritti inesistenti o forzati o semplicemente favoriti,
servono solo a mantenere ed a consolidare l’influenza interna delle nomenklature
e dei gruppi organizzati ed a regolare i rapporti tra di loro. Si tratta il più
delle volte di configurazioni oligarchiche che si sono via via formate
attraverso processi di selezione interna, ma che sovente si sono trasformate in
incrostazioni praticamente quasi inamovibili. Il loro prevalere impedisce il
ricambio naturale e dialettico o lo realizza solo per la via obbligata della
cooptazione. La democrazia in questi Partiti è già entrata in una fase di
involuzione e di decadenza. Naturalmente questa degenerazione si riflette anche
sull’insieme del sistema di finanziamento partitico e dell’attività politica.
Già le correnti politiche si erano venute sempre più radicando come correnti
anche elettorali e quindi con esigenze di spesa che le spingevano verso una
ricerca propria ed autonoma di finanziamento. Lo stadio negativo ulteriore si
veniva poi configurando nella definizione di aree di influenza tanto sulle
gestioni amministrative che nella rappresentanza di influenze lobbistiche.
Attorno ad esse si raggruppavano ramificazioni clientelari che fornivano ad un
tempo un valido supporto per la rappresentanza elettorale interna ed esterna.
Era una mobilitazione di gruppi che si avvaleva, nella sua presentazione
pubblica, di formule e proposizioni ideologiche e politiche, ma che in realtà
era sempre meno intessuta dei valori propri della ideologia e della politica.
Dal canto suo il fenomeno del tesseramento artificioso costituiva anche un
ulteriore fattore di spesa nel contesto delle spese già dilatate per il
complesso delle esigenze politiche normali e straordinarie. Vi furono diversi
responsabili di Partiti, che resisi consapevoli di questi fenomeni degenerativi,
tentarono di organizzarsi per contrastarli. La loro azione non poteva essere
disciplinare e di controllo, giacché in concreto una azione di questa natura si
presentava praticamente impossibile. Essa si proponeva e ricercava la via di
riforme statutarie con lo scopo di porre argini ad una degradazione che veniva
assumendo proporzioni ed espressioni sempre più evidenti. Videro così la luce,
in taluni Partiti, riforme statutarie che miravano a ridurre l’influenza dei
clan, a limitare l’incidenza del tesseramento irregolare ad accrescere il volume
delle entrate ordinarie, ufficiali, legittime e dichiarate attraverso un
sensibile aumento delle quote di iscrizione e l’organizzazione di specifiche
sottoscrizioni. Per anni, i Partiti hanno dato mostra di aver regolato la
materia del proprio finanziamento attraverso le leggi sul finanziamento pubblico
dei Partiti. Ma la realtà delle cose era ben diversa. Il finanziamento dei
partiti ha sempre continuato a mantenere caratteri di irregolarità e di
illegalità. Il finanziamento pubblico si riassumeva in una cifra complessiva che
non aveva nessun rapporto con le dimensioni reali del problema che si proponeva
di risolvere. Ci voleva una grande dose di disinvolta ipocrisia per credere o
far credere che i fondi stanziati dalla legge erano quanto bastava per
sorreggere la complessa macchina burocratica e la varietà di strutture e di
attività su cui poggiava la democrazia dei Partiti. La legge veniva violata
sistematicamente da tutti o da quasi tutti. Forse qualche gruppuscolo minore
aveva le carte in regola e forse, anche in qualche caso tra questi, a ben
guardare le cose, la regolarità e la legalità non veniva sempre rigorosamente
rispettata. Diversi gruppi minori venivano poi finanziariamente aiutati dai
gruppi maggiori, per ragioni di affinità, di solidarietà, o di mera tattica.
Queste violazioni di legge, su cui in buona parte si è fondato poi il processo
di criminalizzazione della democrazia repubblicana, definita come Prima
Repubblica, avvenivano sulla base di una complicità e di un consenso pressoché
unanimi. Quale fosse la realtà vera delle cose, almeno nelle sue caratteristiche
più tipiche, erano ben consapevoli tutti i dirigenti dei Partiti, i
parlamentari, gli amministratori. Ne erano consapevoli certamente le maggiori
cariche istituzionali dello Stato nelle quali si alternavano del resto
personalità che a loro volta avevano ricoperto impegnative responsabilità
politiche e partitiche. Faccio solo l’esempio dell’ultimo Presidente della
camera Napolitano, divenuto poi anche Ministro degli Interni, che, avendo
ricoperto per anni l’incarico di ministro degli Esteri del PCI non poteva di
certo non essere a conoscenza del fatto che le entrate del suo Partito si
componevano anche di flussi finanziari, provenienti dall’URSS e dai Paesi
dell’impero comunista e che questi non figuravano certo nei bilanci di Partito
presentati al Parlamento. Faccio l’esempio del Presidente del Senato, il defunto
Spadolini, che avendo per anni diretto il Partito Repubblicano, non poteva non
sapere che il suo Partito non viveva solo delle quote degli iscritti e delle
sottoscrizioni, e che ciò che si aggiungeva di straordinario non figurava
puntualmente nei bilanci presentati al Parlamento. Faccio l’esempio dell’attuale
Presidente del Senato Nicola Mancino, tempo addietro Presidente alla Camera e al
Senato dei gruppi parlamentari della DC, che in materia di conoscenza del
sistema di finanziamento alla DC, dei suoi gruppi e dei suoi parlamentari non
era certo a digiuno. Sarebbe far torto alla sua intelligenza ed alla sua onestà.
Faccio l’esempio dell’ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro,
eletto per tredici volte deputato della Democrazia Cristiana. Tredici campagne
elettorali bastano e avanzano per capire come funzionavano le cose. I precedenti
Capi dello Stato a loro volta, pur vivendo lontani dalla politica pratica e
dalla gestione diretta dei Partiti vivevano pur sempre al Quirinale che è sempre
stato un osservatorio della vita nazionale di non poco conto. Di certo nessuno
di loro se ne stava sulla luna. Nessuno, salvo forse, in qualche caso, qualche
voce isolata in Parlamento e nel dibattito politico pubblico, ha per anni, anzi
per decenni, aperto porte e finestre su di una questione tanto delicata. La
questione era d’altra parte anche scottante e nessuno si è mai voluto scottare.
Non è stata così denunciata con la forza necessaria l’anomalia, la irregolarità,
la illegalità complessiva della situazione. Per trovare in uno scritto, una
descrizione del fenomeno con relative denunce, a mia memoria, bisogna risalire a
molti decenni addietro. Nessuno, che io ricordi, nel mondo politico ha levato la
voce e spezzato una lancia per proporre opportuni rimedi al corso delle cose o
per aprire una pubblica riflessione sul sistema di finanziamento dei Partiti e
delle attività politiche in generale. C’è anche chi lo ha fatto ma mentre lo
faceva non diceva la verità perché allo stesso tempo si assicurava contributi,
sostegni, finanziamenti. C’è chi propose come rimedio un aumento del contributo
pubblico ma mal gliene incolse e dovette subito zittirsi, travolto da ondate
contrarie di demagogico rifiuto. Sta di fatto che i Partiti, pur presentando in
Parlamento, per decenni, bilanci che non corrispondevano al vero, e cioè bilanci
falsi, non sono mai stati fatti oggetto da parte di nessuno di denunce per le
loro gravi irregolarità. I Partiti di opposizione di regola non denunciavano i
Partiti di governo e i partiti di governo non denunciavano i partiti
d’opposizione. La complicità in questo senso, era totale o quasi. Nessuno
ricorda clamorose polemiche al proposito. Forse qualche questione di forma,
qualche denuncia di irregolarità, ma mai una vera e propria questione, mai una
battaglia in piena regola, un vero e proprio scandalo sollevato con clamore
attorno ad un bilancio ritenuto manifestamente falso. Certo mai una Commissione
di inchiesta. Con la sistematica approvazione dei bilanci dei Partiti in
Parlamento si veniva approvando in realtà tutta la natura distorta almeno del
sistema di finanziamento ai Partiti ed alle attività politiche, e quindi tutti
nel contempo, salvo i distratti e i pochissimi eventualmente esclusi, sapevano
benissimo di che cosa si trattava. La democrazia repubblicana approvava il
proprio modo di vivere, almeno in questo campo, si assolveva per le violazioni
della legge sul finanziamento, e pur essendo consapevole delle irregolarità del
sistema preferiva andare avanti per quella strada piuttosto che per mano ad una
legislazione più consona tanto eventualmente nel senso di contributi pubblici
più adeguati, che nel senso di una maggiore libertà nella raccolta di fondi
volontari, che in direzione di un più efficace ed effettivo sistema di
controlli.
Il sistema di finanziamento della politica si presentava nel suo insieme come un
sistema complesso per il quale bisognava tenere conto di livelli, responsabilità
e causali diverse. Vanno tenuti in conto infatti i livelli amministrativi e
gestionali delle strutture nazionali delle organizzazioni periferiche regionali,
provinciali e cittadine, delle associazioni e strutture collaterali,
associative, di carattere culturale, sociale, sindacale, giovanile ed altro. A
questo si debbono aggiungere le attività editoriali, gli organi di informazione
politica, lo spettacolo politico, gli strumenti di formazione e di orientamento,
le attività internazionali, ideali, politiche, di solidarietà concreta verso
soggetti singoli e verso organizzazioni. L’attività politica dei partiti
comprende convegni tematici, di settore, di categoria, convegni giovanili,
femminili, Congressi locali, regionali, nazionali, internazionali. Un livello
fondamentale è fissato dalle scadenze elettorali. Elezioni politiche nazionali,
regionali e locali, elezioni europee, elezioni amministrative parziali che
risultavano sovente particolarmente impegnative perché normalmente assumevano il
valore di test e di sfide di carattere nazionale. Bisognava tener conto dei
candidati e dell’alto grado di competitività che si stabiliva tra loro, dalle
spese che si gonfiavano insieme alle ambizioni ed alle illusioni, o alla ricerca
di successi personali da raggiungersi in termini particolarmente clamorosi in
modo da poterli far valere poi sul mercato politico delle cariche maggiori. Allo
stesso modo bisognava tener conto degli eletti che sono per vocazione e per
giusta natura sempre tendenzialmente rieleggibili e che quindi sono portati a
costruirsi strutture di sostegno permanenti specie quando la loro rielezione non
poteva dipendere da una vincolante designazione dipendente dagli organi e dalla
burocrazia del Partito. Anche nella struttura democratica così come essa si
è venuta definendo nella democrazia repubblicana si è venuto formando un vero e
proprio ceto politico ed amministrativo professionale, o semiprofessionale. Il
suo lavoro politico sostituisce in tutto o in parte il suo lavoro professionale,
sovente creando dei vuoti nelle disponibilità complessive di reddito. Questi
vuoti vengono coperti o da vantaggi indiretti ricavati da una influenza politica
o anche da contributi e finanziamenti di carattere politico personale, sempre
per rimanere al di qua della frontiera che separa un finanziamento di natura e
scopo politico dai veri e propri reati contro la Pubblica Amministrazione. Come
già ho sottolineato, nella realtà politica e partitica si era diffusa e radicata
la esistenza di clan e di correnti, entro le quali si erano venute stabilendo
solidarietà ed interessi che molto spesso andavano al di là dei legami con
l’entità Partito anche se si mantenevano e si muovevano all’interno ed entro le
istituzioni, i simboli e le formule proprie dell’entità Partito. I rapporti tra
tutte queste articolazioni si sono naturalmente presentate in forma diversa nei
diversi partiti. Ciò che appariva in generale sempre più evidente era la
tendenza verso un indebolimento progressivo delle capacità e delle possibilità
di un controllo centrale sugli altri livelli. Le realtà periferiche, i gruppi,
le posizioni consolidate di influenza gestionale e clientelare, potevano sempre
di più sfuggire alla direzione ed al controllo del livello centrale e ciò non
solo sotto il profilo dei mezzi e metodi di finanziamento ma spesso, in molti
casi, anche sotto il profilo della stessa direzione politica. Più di altri
sfugge invece a questa tendenza il PCI e poi il PCI- PDS, almeno negli anni
iniziali della sua prima strutturazione. Il Partito Comunista ed il Partito
ex-Comunista si sono, per ideologia e natura, formati su schemi centralizzati
che, pur modificando nel tempo la loro rigidità originaria, avevano mantenuto
una loro validità ed efficacia che naturalmente, anch’essa, si veniva
indebolendo e sgretolando. Sotto questo profilo mentre da un lato risulta più
evidente, anche in materia di finanziamenti, il controllo centrale e quindi la
consapevolezza e la responsabilità dei maggiori dirigenti politici, dall’altro
prendono avvio e maggiore consistenza fenomeni propri di una più vivace
dialettica politica interna, con un seguito di iniziative di gruppo e di
corrente. Diversamente, in altri partiti, molti candidati, in occasione delle
campagne elettorali, ricevono contributi diretti dal Partito in ragione del loro
ruolo, altri si avvalgono di solidarietà di gruppo, altri ancora organizzano in
proprio il reperimento di fondi, ed altri infine fanno tutte e due o tutte e tre
le cose contemporaneamente. La struttura centralizzata consentiva invece una
certa disciplina e comunque un maggiore controllo anche su questo tipo di spese.
Va detto, infine, che, sempre in materia di raccolta di fondi per le spese
elettorali, non di rado il nome del Partito e dei suoi vertici più conosciuti e
più autorevoli veniva utilizzato senza tanti scrupoli e complimenti anche da chi
non era minimamente autorizzato a farlo. Del millantato credito, di cui erano
spesso vittime i dirigenti più conosciuti, in moltissime occasioni era vittima
lo stesso Partito, in nome del quale venivano abusivamente avanzate richieste,
ricevute offerte, raccolti contributi di genere e provenienza varie, e di cui le
organizzazioni amministrative responsabili di Partito non avevano in realtà il
benché minimo riscontro o ne avevano un riscontro del tutto parziale, il più
delle volte indiretto o casuale. Le entrate del Partito erano costituite da
tutte le voci presenti e dichiarate nei bilanci e da contributi che non venivano
dichiarati. Per esempio la raccolta dei fondi indirizzati al Partito Socialista
a vario titolo veniva fatta direttamente dall’amministrazione,
dall’Amministratore o suoi collaboratori diretti, a questo consegnate da altri
dirigenti del Partito o da persone che venivano considerate alla stregua di
collaboratori di fiducia. La modalità di questi versamenti venivano decise
dall’Amministrazione. Ciò avveniva nella gran parte dei casi, in relazione alle
situazioni concrete che si presentavano. I contributi che venivano versati al
Partito erano di varia natura. Di natura politica e cioè a dire erogazioni di
sostegno fatte esclusivamente o prevalentemente per ragioni di adesione o di
convinzione e valutazione politica. Contributi che potevano essere invece
definiti come prova e ricerca di “buone relazioni” e cioè dati senza un concreto
e specifico riferimento ma assicurati solo allo scopo di stabilire o mantenere
con l’entità Partito un rapporto che potesse essere considerato amichevole e
quindi suscettibile di una attenzione da parte degli esponenti del Partito
presenti in varie sedi istituzionali. Contributi raccolti e versati da singoli
esponenti del Partito nell’ambito della loro responsabilità. Contributi versati
in funzione di ottenere specifiche sollecitazioni ed interventi favorevoli ai
finanziatori. A questi contributi di natura vana si aggiungevano entrate di
carattere pubblicitario ed entrate derivanti da sponsorizzazioni in cambio delle
quali veniva comunque fornito un servizio commerciale generalmente adeguato
specie in occasione di Congressi e di grandi iniziative e manifestazioni
pubbliche che costituivano un veicolo di indubbia importanza ed interesse di
carattere locale, nazionale ed internazionale. Su questo stato di cose è stato
avviato, organizzato, sviluppato ed esteso a tutto il Paese un processo di
criminalizzazione strumentale che ha manipolato e mistificato la realtà dei
fatti, le circostanze storiche in cui i fatti si sono verificati, il contesto
generale delle responsabilità democratiche che erano state assolte da forze
politiche che avevano garantito il quadro delle libertà democratiche, la
stabilità politica, lo sviluppo dell’economia, la crescita dei valori e delle
opportunità sociali, la presenza ed il dinamismo della vita e della dialettica
democratica, l’alto ruolo internazionale raggiunto dalla nazione tanto nel
contesto europeo che in quello mondiale. La classe politica dei Partiti ed in
generale tutta la classe politica era quindi, come non è difficile dimostrare,
mentre sarebbe difficilissimo dimostrare il contrario, ben consapevole della
natura del finanziamento politico, dei metodi seguiti, delle pratiche che erano
diffuse, costanti e sistematiche. C’è semmai da chiedersi se, essendo queste le
condizioni, come sia possibile credere o far credere che la magistratura ed
altri apparati dello Stato ignorassero ciò che avveniva anche sotto i loro
occhi, non nel caso di una particolare stagione, ma addirittura nel corso di
decenni. C’è semmai da chiedersi perché questo sia avvenuto. C’è da chiedersi,
se si ricorda a memoria, come sia stato possibile che nell’arco di quasi un
ventennio raramente è stato aperto un caso. In ogni caso non risulta che si
siano mai svolti processi e non si siano mai pronunciate sentenze di condanna
per lo specifico reato di finanziamento illegale. C’è da chiedersi come sia
stato possibile che mentre per bocca della stessa magistratura questa pratica
veniva definita “notoria e costante”, contemporaneamente non veniva promossa
l’azione penale per le violazioni della legge sul finanziamento dei partiti.
Nessuno lo impediva, nessuno poteva impedirlo, nessuno ha denunciato un caso nel
quale ad un magistrato è stato impedito di compiere il dovere che la legge gli
avrebbe imposto di compiere. Probabilmente anche questo è avvenuto, e magari
anche in più casi, ma nessuno protestò e picchiò i pugni sul tavolo sino a farsi
sentire. Ciò che è singolare invece è che improvvisamente, in forme violente ed
anche e soprattutto discriminatorie, si siano scoperchiate parti significative
del sistema di finanziamento illegale dei Partiti e delle attività politiche, e
si sia dato vita ad un processo di criminalizzazione con ritmi crescenti,
seguendo sovente cadenze proprie di una orologeria politica, con un particolare
accanimento diretto soprattutto e in primo luogo verso alcune direzioni, mentre
ad altre veniva riservato un trattamento ben diverso e molte cose venivano
sottaciute, ignorate, o addirittura sfacciatamente oscurate e protette. Il
trionfo della regola dell’ingiustizia consistente nell’uso di “due pesi e due
misure”. Ciò che è singolare è che nel 1989, quando cadevano i muri e non si
sapeva che cosa si sarebbe potuto ritrovare tra le macerie, in fretta e furia il
Parlamento italiano varò una amnistia, nella quale fu fatto comprendere il
finanziamento illegale alla politica. L’amnistia non incontrò di certo forti
ostacoli. Passò diritta filata, alla chetichella e sembra neppure con un voto di
Aula ma addirittura con un voto in Commissione. Una amnistia lampo. Parliamo di
qualcosa che è diventata invece, dopo d’allora, solo a nominarla, una specie di
peccato mortale, di offesa alla civiltà del diritto, di scandalosa distorsione
della giustizia. Non ci furono allora alti lai di eguale natura. La piazza non
si scompose, i Palazzi non si scomposero, i grandi moralizzatori di professione
non entrarono in campagna. Il colpo di spugna invece ci fu. Fu rapido, efficace,
risolutivo. Il grande crimine riguarda invece allora gli anni ’89 - ’92.
Incredibile ma vero. Spesso è dalla categoria degli amnistiati dell’89 che
vengono poi i censori più spietati e i demagoghi più sfacciati. La campagna
contro i finanziamenti illegali della politica, trasformata nella maggior parte
dei casi in un fenomeno di corruzione e di reati ancora più gravi, ha assunto
così toni e metodi di tale violenza demagogica e finalità strumentali ad una
lotta di potere che è dilagata nel Paese. Talvolta vi abbiamo riconosciuto
trampolini di lancio per esibizionistiche ambizioni ma, nel quadro più generale,
si è fatta avanti una corsa pseudo - rivoluzionaria in veste di nuovo potere
egemone della società e dello Stato.»
Memoriale scritto nel 1999 da Bettino Craxi su Tangentopoli.
Craxi voleva consegnare questo scritto a una commissione di inchiesta
parlamentare, che però non fu mai costituita. Il documento è rimasto inedito.
Forche, balle e toghe rosse: il catalogo anti-Mani Pulite.
Revisionismi. Lettera aperta ad Alessandro Sallusti: “Macché sciagurata
stagione. Hai scritto tante menzogne, dagli indagati a vanvera a Di Pietro”,
scrive Massimo Fini, Martedì 14 Febbraio 2017, su "Il Fatto Quotidiano". «Caro
Alessandro, quando Cairo voleva entrare in Libero–direttore Feltri - mi chiese
se volevo seguirlo. Risposi di no. Mi pregò allora di fargli il nome di qualche
giornalista valido. Indicai te e Paolo Martini. Ti conoscevo da quando dirigevi
La Provincia di Como per la quale mi chiedesti anche di collaborare. Avevo di te
un’ottima opinione sia professionale che umana. Per questo mi è particolarmente
spiacevole commentare il vergognoso pezzo che hai scritto per Il Giornale (8/2),
godendo come un riccio perché alla celebrazione dei 25 anni dalle inchieste di
Mani Pulite non c’era praticamente nessuno. Il tuo articolo dovrebbe essere
pubblicato in toto perché sia reso evidente alla cittadinanza il cumulo di
menzogne, di omissioni, di dimenticanze che metti in campo. Ma qui devo
limitarmi ad alcuni excerpta.
1. Tu definisci quella di Mani Pulite una “sciagurata stagione” e Mani Pulite
“la più violenta inchiesta giudiziaria nella storia della Repubblica”.
2. Parli dei suicidi in carcere e “del dolore di 4.250 famiglie di indagati il
più delle volte a vanvera come dimostra il bilancio a istruttorie chiuse e
processi celebrati”.
3. Affermi che in Italia fu introdotta “la carcerazione preventiva come arma di
minaccia e ricatto”.
4. Prendi particolarmente di mira Antonio Di Pietro e sostieni che entrò in
politica per “sfilarsi dal clima di sospetti sulla sua persona” e che non a caso
entrò poi nel Pci-Pds per poi creare il “partitino, Italia dei Valori”.5.
Definisci i magistrati di Mani Pulite “toghe rosse”.
Cerchiamo di mettere un po’ di ordine in questa accozzaglia di argomenti o,
meglio, di pseudoargomenti. L’azione di un magistrato non può essere violenta.
Il magistrato risponde alla legge: o la rispetta o la viola. E non risulta che
in tutta l’inchiesta di Mani Pulite ci siano state violazioni di legge. Il
magistrato non può essere né forcaiolo né garantista, categorie che vi siete
inventate voi. Comunque il forcaiolismo fu casomai della stampa. In particolare
dell’Indipendente di Vittorio Feltri che chiamava Bettino Craxi “il
cinghialone”, trasformando un’inchiesta giudiziaria del tutto legittima in una
caccia sadica e prendeva di mira anche i figli di Bettino. Lavoravo anch’io a
quell’Indipendente e toccò a me difendere i Craxi dagli eccessi del mio
direttore, in particolare con due articoli “Vi racconto il lato buono di
Bettino” scritto in piena bufera quando tutti, anche i suoi amici, fiocinavano
la balena sanguinante, L’Indipendente, 17/12/92, e “Caro direttore, ti sbagli su
Stefania Craxi”, L’Indipendente, 11/5/92. In quel periodo prevaleva al contrario
uno strusciarsi indecoroso ad Antonio Di Pietro considerato il vincitore di
giornata. Mi ricordo in particolare un vergognoso editoriale del direttore del
Corriere, Paolo Mieli, titolato “Dieci domande a Tonino”. A Tonino, come se ci
fosse andato a pranzo e cena da sempre. Con Tonino, ridiventato Antonio Di
Pietro, che dell’inchiesta di Mani Pulite fu il simbolo, tu ti accanisci.
Affermi che entrò in politica per “sfilarsi dal clima di sospetti sulla sua
persona”. Dimentichi che per quei sospetti Di Pietro è stato processato sette
volte ed è uscito regolarmente assolto e uno di quei processi era stato
innescato da due testimoni prezzolati dall’onorevole Berlusconi. Del Di Pietro
politico non dovremmo qui occuparci perché quello che interessa è la sua azione
di magistrato, ma quando tu definisci l’Italia dei Valori un partitino
dimentichi che è stato defalcato di alcuni suoi componenti, a cominciare
dall’onorevole De Gregorio cui Berlusconi diede tre milioni perché passasse al
centrodestra. In ogni caso se Di Pietro fosse entrato in politica il giorno dopo
essersi tolto la toga avrebbe avuto il 90 per cento dei consensi. Invece,
correttamente, a differenza di altri magistrati (Ingroia, De Magistris) aspettò
un anno. La carcerazione preventiva in Italia esiste da sempre. Pietro Valpreda
fece quattro anni di carcerazione preventiva senza processo e Giuliano Naria
nove per citare solo alcuni esempi famosi fra le centinaia che si potrebbero
fare. Non mi risulta che tu o la parte politica che oggi rappresenti abbiate mai
levato un dito contro queste aberrazioni che non erano dei magistrati ma della
legge (le leggi le fa il parlamento, cioè i politici). Vi accorgeste della
carcerazione preventiva solo quando toccò, non per anni ma per qualche
settimana, a lorsignori. Tu affermi però che in questo caso la carcerazione
preventiva sarebbe stata usata “come arma di minaccia e ricatto”. E a queste
sciocchezze Francesco Saverio Borrelli, procuratore capo del pool di Mani
Pulite, replicò: “Non è così. Noi li arrestiamo e loro confessano”. Che è cosa
ben diversa. Tu parli dei suicidi in carcere. Se un magistrato dovesse caricarsi
delle possibili conseguenze dei suoi legittimi provvedimenti non si potrebbe più
amministrare giustizia. I suicidi riabilitano moralmente coloro che ne sono
stati protagonisti, perché evidentemente, a differenza di altri, si vergognavano
di ciò che avevano fatto, ma non li assolvono. In quanto al dolore delle 4.250
famiglie degli indagati “il più delle volte a vanvera” fai finta di dimenticare
che moltissime di queste assoluzioni avvennero per patteggiamento o
prescrizione. Ma questi calcoli lasciamoli a Marco Travaglio. Dimentichi invece,
con molta disinvoltura, le ‘morti bianche’, cioè i suicidi di quegli
imprenditori onesti che non vollero piegarsi al ricatto delle tangenti e videro
perciò andare in fumo le loro aziende. Sorvoli su uno degli atti più contestati
quando Di Pietro, Davigo, Colombo, Greco si presentarono in televisione per
affermare che avrebbero chiesto a Borrelli di lasciare l’inchiesta. Come mai non
ne parli? Perché quella singolare apparizione dei magistrati in tv seguiva uno
dei primi provvedimenti del governo Berlusconi, un decreto chiamato ‘salvaladri’
che depenalizzava i reati di corruzione e similari e quindi salvava, oltre a
Berlusconi e ai suoi cari, la falange dei corrotti e dei corruttori coinvolti in
Tangentopoli. Definire i magistrati di Mani Pulite toghe rosse è risibile.
Casomai se si vuole a tutti i costi dar loro una connotazione politica erano dei
conservatori, il più ‘a sinistra’ era un cattolico, Gherardo Colombo, un
magistrato impeccabile rispettato anche dai suoi indagati. In due anni, con
tutti i testimoni del tempo ancora in vita, i ladri, con una campagna stampa che
ti vide protagonista, divennero le vittime e i magistrati i colpevoli. La classe
dirigente del Paese non tollerava di dover rispondere, per la prima volta o
quasi nella storia italiana, a quelle leggi che noi tutti comuni cittadini siamo
tenuti a rispettare. Ecco perchè tu, divenuto nel frattempo portavoce di una
parte di quella classe dirigente, definisci “sciagurata” la stagione di Mani
Pulite. In realtà Mani Pulite fu l’ultima occasione per la nostra classe
politica per emendarsi dai crimini che andava perpetrando da anni. Non la colse,
anzi l’avversò ferocemente e così siamo arrivati alla situazione attuale dove la
corruzione è discesa giù per li rami a tutto il Paese. Proprio per questo il
Palazzo di Giustizia di Milano era deserto nel 25° anniversario di Mani Pulite.
Tutti hanno capito che l’azione dei magistrati è stata inutile, continua a
essere inutile e probabilmente lo sarà anche in futuro, e quindi i cittadini
hanno perso anche la voglia di ribellarsi e accettano supinamente la parte di
pecore tosate senza emettere neanche un belato. In Romania, per un decreto molto
simile a quello emesso a suo tempo dal governo Berlusconi, la popolazione si è
ribellata e glielo ha ricacciato in gola. Dal punto di vista dell’etica pubblica
siamo quindi al di sotto anche dei disprezzati rumeni. Recentemente, davanti ad
altre persone, hai detto “Massimo Fini mi attacca un giorno sì e un giorno no,
ma devo ammettere che è l’ultimo giornalista libero in Italia”. Non è così,
fortunatamente ce ne sono altri. Ma non posso negare che questa tua affermazione
mi ha fatto piacere. Ma la libertà si paga. Il rendersi servi invece ripaga. Ad
abundantiam».
Lettera aperta a chi esalta quelli dalle Mani pulite,
Massimo Fini sul "Fatto" difende il pool di Milano e accusa il "Giornale" che lo
critica. Ma è la storia a dargli torto, scrive Alessandro Sallusti, Mercoledì
15/02/2017, su "Il Giornale". «Caro Massimo Fini, ieri mi hai dedicato un
lungo articolo sul Fatto Quotidiano per confutare quello breve che ho
recentemente scritto per segnalare il flop delle celebrazioni per il
venticinquesimo anniversario dell'inchiesta Tangentopoli. Difendi a spada tratta
i magistrati di quella stagione, tratti con cinismo i morti e i feriti di quella
stagione, neghi che i pm di quel pool soprattutto citi Di Pietro - avessero mire
e ambizioni politiche, mi accusi di servilismo e racconti un aneddoto vero:
«Davanti a testimoni scrivi Sallusti mi criticò, ma disse che mi riteneva
l'ultimo giornalista libero». Quest'ultima cosa la confermo, e nella libertà che
ti riconosco c'è anche quella di sbagliare. Potrei raccontarti di ragazzini di
allora che ancora oggi, a distanza di anni, sono in cura per lo shock subito
vedendo i loro padri portati via in piena notte da uomini entrati in casa con il
mitra spianato (non parliamo di trafficanti di droga o rapinatori, ma di
amministratori poi risultati innocenti). Potrei ricordati la curiosa coincidenza
che tre dei cinque pm di quel pool (Di Pietro, D' Ambrosio e Colombo) hanno poi
fatto politica nelle liste del Pd o avuto incarichi per conto del Pd. Potrei
ribattere tante altre cose sulla limpidezza e sulle vere mire di Di Pietro in
particolare. Ma non mi crederesti, mi ritieni fazioso. E allora ti propongo una
lettura interessante. È l'articolo a firma Luigi Corvi uscito sul Corriere della
Sera il 12 marzo 1997, giorno in cui vennero depositate le motivazioni con cui
Di Pietro fu assolto dal tribunale di Brescia dall'accusa di concussione (e con
lui Paolo Berlusconi, Previti e altri da quella di aver complottato contro il
Pm). Chiedo scusa al bravo collega per lo scippo non autorizzato e riproduco
alla lettera:
"Antonio Di Pietro lasciò la toga perché voleva entrare in politica. Dietro quel
gesto non ci furono complotti, anche se i fatti raccontati da Giancarlo Gorrini
erano veri: «Alcuni rivestivano caratteri di dubbia correttezza, se visti
secondo la prospettiva della condotta che si richiede a un magistrato, altri
erano decisamente idonei ad un'iniziativa sul piano disciplinare». Tuttavia
l'apertura e la rapida archiviazione dell'inchiesta ministeriale nata dalle
accuse dell'ex presidente della Maa non fu la causa delle dimissioni di Di
Pietro e i quattro imputati (Paolo Berlusconi, Cesare Previti, Ugo Dinacci e
Domenico De Biase) non misero in atto alcun complotto per il semplice motivo che
non avevano interesse a far dimettere il pm di Mani Pulite. Queste in sostanza
le motivazioni, depositate ieri, con cui il 29 gennaio la seconda sezione del
tribunale di Brescia ha assolto tutti gli imputati dall'accusa di concussione.
In quasi duecento pagine i giudici analizzano nel dettaglio i fatti (...). Sui
rapporti poco corretti intercorsi tra Di Pietro e Gorrini si era già soffermato
il gip nell'ordinanza di rinvio a giudizio. Ma il tribunale, sviluppando gli
stessi concetti, va oltre. «È indubbio - scrivono i giudici - che i fatti
raccontati da Gorrini si erano realmente verificati (la prestazione di attività
lavorativa di Cristiano Di Pietro in favore della Maa, l'assegnazione di alcune
cause a Susanna Mazzoleni da parte della Maa, l'erogazione di un prestito da
parte di Gorrini, la cessione a Di Pietro, sempre da parte di Gorrini, di
un'autovettura recuperata dalla Maa e trasformata da Di Pietro stesso in
prestito, l'intervento di Di Pietro per ottenere che D'Adamo e Gorrini
erogassero prestiti a Rea onde favorire l'estinzione di debiti consistenti)».
Secondo il tribunale, Tonino - che della deposizione di Gorrini aveva appreso in
tempo reale da un giornalista - aveva di che preoccuparsi. «Era in gioco il suo
prestigio come magistrato, come magistrato onesto, come persona dai
comportamenti cristallini, e proprio questo prestigio era minacciato a causa di
leggerezze commesse e per le quali egli era pronto a fare ammenda. Era in gioco,
in definitiva, un ruolo e un'immagine». (...) I fatti denunciati dall'ex
presidente della Maa «rappresentavano per Di Pietro una minaccia, per giunta
avente il requisito della verosimile serietà» (...). Tonino in effetti si
preoccupò molto e preparò subito una memoria difensiva «in previsione di essere
chiamato per chiarire la vicenda», telefonò all'allora ministro della Difesa
Previti (...) «chiedendo addirittura un intervento in suo favore del ministro
Biondi». (...) Le ragioni delle dimissioni esposte da Di Pietro (in primo luogo
i molteplici tentativi di delegittimazione) «sono - secondo il tribunale -
talmente troppe e troppo eterogenee da sembrare una congerie alquanto
scontata....». È vero che il pm di Mani Pulite aveva accumulato stanchezza
fisica e psicologica, ma la molla decisiva che lo spinse a lasciare la toga fu
l'intenzione - maturata già nella primavera del '94 - «di intraprendere
l'attività politica, ovvero di ottenere incarichi pubblici di maggior rilievo».
E quando a Silvio Berlusconi disse di non essere stato d'accordo sull'invio
dell'avviso di garanzia, mentì perché era «alla ricerca iniziale di probabili
alleanze» politiche. Infine Tonino - secondo i giudici - sino all'ultimo non
rivelò i suoi progetti ai colleghi perché temeva di «inquinare quella sua
indiscussa leadership all'interno e all'esterno del pool con consequenziali
ripercussioni nell'immagine esterna» e c'era il rischio che gli altri pm lo
rendessero «meno partecipe dell'attività giudiziaria»."
Caro Massimo, questo dicono le carte. Se questi sono gli eroi che ammiri, libero
di farlo. Ma riconosci a me la libertà di pensarla diversamente, senza per
questo dover essere servo di qualcuno.»
La festa oscena dei manettari. I 25 anni di Tangentopoli,
scrive Alessandro Sallusti, Mercoledì 8/02/2017, su "Il Giornale". Doveva essere
la celebrazione dell'epopea di Mani pulite, nel venticinquesimo anniversario
dell'avvio di quell'inchiesta. Ma nel salone d'onore del Palazzo di Giustizia di
Milano si sono presentati una decina tra fotografi e giornalisti e altrettanti
attivisti grillini. Non un magistrato, non un avvocato, non un cittadino comune.
Sul palco due reduci di quella sciagurata stagione, Piercamillo Davigo e Antonio
Di Pietro ad autocelebrarsi nel deserto. Il primo ora è capo dell'Associazione
nazionale magistrati, il secondo è un ricco pensionato che aveva tentato, anche
per sfilarsi dal clima di sospetti sulla sua persona, l'avventura politica
guarda caso con il Pci-Pds prima e poi con il suo partitino «Italia dei valori»,
soprannominato «Italia dei valori immobiliari» per via di strani investimenti in
case fatti coi soldi del partito che alla fine gli costarono la faccia e il
posto. Perché si debba celebrare il compleanno della più violenta inchiesta
giudiziaria nella storia della Repubblica lo sanno solo loro. Da ricordare c'è
semmai l'introduzione in Italia della carcerazione preventiva come arma di
minaccia e ricatto, i non pochi suicidi di persone dimenticate in carcere o
portate all'impazzimento, il dolore delle 4.250 famiglie di indagati il più
delle volte a vanvera come dimostra il bilancio a istruttorie chiuse e processi
celebrati. Ma soprattutto resta la resa della politica al potere giudiziario a
sua volta preso ostaggio dalle toghe comuniste di Magistratura democratica. Se
proprio devo, preferisco ricordare quella stagione con le parole che Carlo
Nordio, storico pm di Venezia che visse in prima linea quei mesi e che oggi si
ritira senza clamore a vita privata, ha consegnato al Foglio: «Quando le
indagini si concentrarono su democristiani e socialisti non ci furono polemiche
e fummo dipinti come eroi. Quando iniziai a indagare sulle cooperative rosse e
su D'Alema, sono scoppiate molte polemiche anche con i colleghi di Milano. Ma
per me fu un onore avere le riserve da parte dei colleghi di Magistratura
democratica». Due vecchi signori un po' patetici che parlano in un'aula vuota
pensando di avere davanti folle osannanti. Questo resta venticinque anni dopo.
Fantasmi, ma purtroppo ancora in grado di fare tanti danni, perché continuano a
seminare odio e rancore.
Mani Pulite, 25 anni dopo parla Di Pietro ma la sala è vuota: "E'
la desolazione". Video di Antonio Nasso su "Repubblica
tv" il 7 febbraio 2017. "Cosa è cambiato nel corso di questi anni? Lo vediamo
oggi, in questa sala vuota. C'è la desolazione da parte dell'opinione pubblica,
che non crede più che si possa cambiare il Paese". Così l'ex magistrato simbolo
di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, durante il suo intervento in aula magna a
Palazzo di Giustizia di Milano per una conferenza a 25 anni dalla scoperta di
Tangentopoli. Conferenza alla quale però hanno partecipato solo poche decine di
persone.
In un'aula deserta la patetica rimpatriata dei duri di Mani
pulite. Nell'anniversario dell'inizio dell'indagine solo 31 persone ad ascoltare
Di Pietro e Davigo. Di Pietro confessa: "Se non mi fossi dimesso dalla
magistratura mi avrebbero arrestato", scrive Luca
Fazzo, Mercoledì 8/02/2017, su "Il Giornale". Eh sì: sono passati venticinque
anni, non gliene importa (fortunatamente) più niente a nessuno, e l'aula magna
del tribunale, poche ore prima gremita per un convegno sul cyberbullismo, si
svuota dolorosamente quando si comincia a parlare di Mani Pulite. A popolare le
rade sedie occupate una platea di trentuno persone, giornalisti esclusi. Ma in
fondo va bene così, perché questo permette a Piercamillo Davigo di ripetere
l'aforisma sulle prede e i predatori («abbiamo catturato le zebre lente, abbiamo
affinato le specie») senza che nessuno si alzi a protestare per averlo sentito
già centodue volte; e, cosa forse più grave, che lo stesso Davigo possa dire
impunemente che «ho visto assoluzioni che gridano vendetta, il codice è scritto
per farla fare franca ai farabutti», e amen se il codice l'ha scritto uno che si
chiamava Gian Domenico Pisapia. Va in scena così, come una piece un po' fuori
moda, l'anniversario di Mani Pulite, in quella stessa aula magna in cui
Francesco Saverio Borrelli lanciò il suo proclama,
«resistere-resistere-resistere» tra le ovazioni dei suoi pm. Poche facce,
qualche sopravvissuto: «Siamo l'associazione combattenti e reduci», scherza Di
Pietro. Combattenti e reduci però tutti della stessa parte, magistrati e
cronisti un tempo risolutamente schierati al loro fianco; la voce degli
sconfitti, gli arrestati, i pochi avvocati con la schiena dritta, nessuno ha
pensato che valesse la pena sentirla; ma d'altronde a organizzare il tutto è una
associazione di marcate simpatie grilline, e grillino è l'unico politico seduto
sul palco: e anche questo va bene, perché così si possono inanellare
allegramente strafalcioni storici e giuridici, dicendo che il decreto Biondi del
luglio 1994 venne fatto per liberare Paolo Berlusconi, che all'epoca era già
libero da un pezzo, o persino che la legge Severino è stata fatta per salvare
Silvio Berlusconi e Filippo Penati. Della sala deserta, gli organizzatori danno
la colpa a un fantomatico complotto ordito ai loro danni. Vabbè. Di Pietro
invece si consola spiegando che l'altro giorno a Borgomanero la sala era piena,
e comunque «c'è la desolazione dell'opinione pubblica che non crede più che
possa cambiare qualcosa»; ma non spiega cosa la famosa opinione pubblica sarebbe
dovuta venire a capire, visto che non c'è l'ombra di una autocritica e nemmeno
di una analisi, «noi eravamo le guardie e loro i ladri», punto e fine. Di Pietro
ritira fuori la storia di quando il Sisde lo spiava e dossierava per fermarlo,
spiega che Mani Pulite venne bloccata quando iniziò ad occuparsi di mafia e
politica, insomma niente di nuovo sotto il sole. «La tangente Enimont - dice -
era di centocinquanta miliardi, ne abbiamo trovati settanta, gli altri che fine
hanno fatto?», e fa la faccia di chi conosce benissimo la risposta. «Abbiamo
esagerato con le scarcerazioni», dice serio Davigo. Erano anni che Di Pietro non
metteva piede a Palazzo di giustizia. A sentirlo non è venuto neanche uno dei
suoi ex colleghi. (Mezz'ora prima del convegno, al bar sotto il tribunale. Di
Pietro, che in fondo era il meno cinico del pool, mangia un boccone con un
vecchio amico. Antonio, vista come è finita, rifaresti tutto? «Il magistrato
sicuramente sì. Sul fatto che dopo mi sono messo a fare politica ci penserei due
volte la prossima volta». Beh, potevi continuare a fare il magistrato... «Se non
mi dimettevo andava a finire che mi arrestavano»).
"Democrazia a rischio". Quella lezione di Craxi ancora attuale
oggi. Mentre scoppiava Mani pulite, l'ex premier Bettino Craxi in Aula gettava
le basi per ricostruire il Paese. Pubblichiamo stralci del discorso che l’allora
segretario del Psi Bettino Craxi tenne alla Camera il 3 luglio del 1992, in
pieno scandalo Tangentopoli, durante la fiducia al nascente governo Amato.
All’ombra della politica, l’ammissione, "fioriscono e si intrecciano casi di
corruzione e di concussione", scrive "Il Giornale"
l'8/02/2017. Bettino Craxi. «Onorevole presidente, onorevole presidente del
Consiglio, onorevoli deputati, nella vita democratica di una nazione non c'è
nulla di peggio del vuoto politico. Da un mio vecchio compagno ed amico, che
aveva visto nella sua vita i drammi delle democrazie, ho imparato ad avere
orrore del vuoto politico. Nel vuoto tutto si logora, si disgrega e si
decompone. E in questo senso ho sempre pensato e penso che un minuto prima che
una situazione degeneri bisogna saper prendere una decisione, assumere una
responsabilità, correre un rischio. Il sistema dei partiti, che hanno costituito
l'impianto e l'architrave della nostra struttura democratica e che ora mostrano
tutti i loro limiti, le loro contraddizioni e degenerazioni, al punto tale che
vengono ormai sistematicamente screditati e indicati come il male di tutti i
mali, soprattutto da chi immagina o progetta di poterli sostituire con simboli e
poteri taumaturgici che di tutto sarebbero dotati, salvo che di legittimità e
natura democratica. Sono immagini e progetti che contengono il germe demagogico
e violento di inconfondibile natura antidemocratica. È vero che nel tempo si
sono accumulati molti ritardi per tanti fattori negativi; per miopia,
velleitarismo, conservatorismo. E tutto ciò è avvenuto in modo tale che il
logoramento del sistema ha finito con il progredire inesorabilmente, come non
era difficile prevedere. Ora non c'è più molto tempo a disposizione, onorevoli
colleghi. Vi sono dei processi di necrosi che sono giunti ormai ad uno stadio
avanzato. Il Parlamento deve reagire, deve guardare alto e lontano, dando
innanzitutto l'avvio ad una fase costituente per decidere rapidamente riforme
essenziali di ammodernamento, di decentramento e di razionalizzazione.
Serviranno a ridare efficienza e prestigio alle Camere, a rompere un centralismo
dello Stato, per parte sua duro a morire, rafforzando i poteri e l'autonomia
delle Regioni come suggeriamo nel nostro programma sino ai limiti del
federalismo, a garantire autorevolezza e stabilità all'esecutivo. Bisognerebbe
porre mano subito alla riforma delle leggi elettorali con uno sguardo rivolto ai
modelli e alle esperienze delle democrazie europee ed un altro rivolto alle
tradizioni della democrazia italiana. C'è un problema di moralizzazione della
vita pubblica che deve essere affrontato con serietà e rigore, senza
infingimenti, ipocrisie, ingiustizie, processi sommari e «grida» spagnolesche. È
tornato alla ribalta in modo devastante il problema del finanziamento dei
partiti, o meglio del finanziamento del sistema politico nel suo complesso,
delle sue degenerazioni, degli abusi che si compiono in suo nome, delle
illegalità che si verificano da tempo, anzi da tempo immemorabile. In quest'aula
e di fronte alla nazione penso che si debba usare un linguaggio improntato alla
massima franchezza. Bisogna innanzitutto dire la verità delle cose e non
nascondersi dietro nobili ed altisonanti parole di circostanza che molto spesso
e in certi casi hanno tutto il sapore della menzogna. Si è diffusa nel Paese,
nella vita delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, una rete di
corruttele grandi e piccole, che segnalano uno stato di crescente degrado della
vita pubblica. Uno stato di cose che suscita la più viva indignazione,
legittimando un vero e proprio allarme sociale e ponendo l'urgenza di una rete
di contrasto che riesca ad operare con rapidità e con efficacia. I casi sono
della più diversa natura, spesso confinano con il racket malavitoso e talvolta
si presentano con caratteri particolarmente odiosi di immoralità e di
asocialità. Purtroppo, anche nella vita dei partiti molto spesso è difficile
individuare, prevenire, tagliare aree infette, sia per l'impossibilità oggettiva
di un controllo adeguato sia, talvolta, per l'esistenza ed il prevalere di
logiche perverse. E così, all'ombra di un finanziamento irregolare ai partiti e
ripeto, meglio, al sistema politico fioriscono e si intrecciano casi di
corruzione e di concussione, che come tali vanno definiti, trattati, provati e
giudicati. E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire, e che tutti sanno
del resto benissimo, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o
illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o
piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con
essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono
all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di
questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran
parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Ma non credo che ci sia nessuno
in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa
alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché
presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. E del
resto, andando alla ricerca dei fatti, si è dimostrato e si dimostrerà che tante
sorprese non sono in realtà mai state tali. Per esempio, nella materia tanto
scottante dei finanziamenti dall'estero, sarebbe solo il caso di ripetere
l'arcinoto «tutti sapevano e nessuno parlava». Un finanziamento irregolare o
illegale al sistema politico, per quante reazioni e giudizi negativi possa
comportare e per quante degenerazioni possa aver generato, non è e non può
essere considerato ed utilizzato da nessuno come un esplosivo per far saltare un
sistema, per delegittimare una classe politica, per creare un clima nel quale di
certo non possono nascere né le correzioni che si impongono né un'opera di
risanamento efficace, ma solo la disgregazione e l'avventura. Del resto,
onorevoli colleghi, nel campo delle illegalità non ci sono solo quelle che
possono riguardare i finanziamenti politici. Il campo è vasto e vi si sono
avventurati in molti, come i fatti spero si incaricheranno di dimostrare,
aiutando tanto la verità che la giustizia. Ebbene, a questa situazione ora va
posto un rimedio, anzi più di un rimedio. È innanzitutto necessaria una nuova
legge che regoli il finanziamento dei partiti e che faccia tesoro
dell'esperienza estremamente negativa di quella che l'ha preceduta. Penso che se
la legislatura imbocca la sua strada maestra, allora non avrà tempo per
fermarsi. Ne trarranno giovamento i partiti che vogliono percorrere una stagione
di rinnovamento interno, di revisione degli statuti, di riforma delle regole, di
ricambio degli uomini, di promozione di nuove associazioni tra loro e di più
strette alleanze. Anche il governo sarà aiutato ad avanzare lungo i binari del
buon programma che si è dato, dovendo affrontare le emergenze che lo stringono
d'assedio, in primo luogo, quella economica e quella criminale. Se così non sarà
e certo non me lo auguro la sorte della legislatura scivolerà su un piano
inclinato e sarà allora rapidamente segnata. Non me lo auguro innanzitutto per
il paese, onorevole presidente. Per la sua economia, che ha bisogno di un clima
di operosità, di fiducia e di collaborazione sociale: una economia che deve
essere stimolata ed aiutata a ritrovare iniziativa e competitività. Per i
livelli occupazionali, a cominciare dall'occupazione nell'industria, che ha già
ricevuto duri colpi ed altri purtroppo può riceverne ancora. Per il riequilibrio
della finanza pubblica, che è urgente, necessario e non rinviabile: un record
mondiale negativo, che in questi prossimi anni dobbiamo riuscire a toglierci di
dosso nell'interesse di tutti, levando dal nostro futuro una grande incognita ed
una tagliente spada di Damocle. Ridefinire e riselezionare la spesa sociale e le
protezioni dello Stato sociale, senza smantellarlo secondo le invocazioni dei
peggiori conservatori: anche questo è necessario, urgente e non più rinviabile.
Sono questi gli anni del passaggio verso un'Europa più unita, più integrata ed
auguralmente più coesa. Tuttavia, quando si sentono magnificare i nuovi
traguardi europei come se si trattasse di una sorta di paradiso terrestre che ci
attende, c'è solo da rimanere sconcertati. È naturalmente fondamentale che
l'Italia riesca a raggiungere il passo dei suoi grandi partner europei.
Diversamente, si produrrebbe una frattura di portata storica nelle linee di
fondo del nostro progresso. Tuttavia dobbiamo insistere a chiederci quale Europa
vogliamo: non un'Europa sottratta ad ogni controllo dei poteri democratici; non
verso politiche determinate solo sulla base di criteri macroeconomici,
indifferenti di fronte alla valutazione dei costi sociali. Un'Europa, dunque
fondata su un mercato unico, aperto e libero, ma il cui sviluppo non contraddica
il principio che gli anglosassoni definiscono come «il mercato più la
democrazia». Non un'Europa in cui la modernizzazione diventi brutalmente
sinonimo di disoccupazione, ma un'Europa dove le rappresentanze sindacali
abbiano un loro spazio, una loro dignità ed una loro influenza; un'Europa che
guardi al proprio riequilibrio interno ma anche all'altra Europa, che si è
liberata dal comunismo, ma che rischia di restare ancora separata e divisa dal
muro del denaro. Un'Europa capace di una vera politica estera e di una più larga
apertura verso il mondo più povero che ha assolutamente bisogno di un
acceleratore che gli consenta di uscire dalla depressione, dalla stagnazione e
dal sottosviluppo, senza di che le ondate migratorie diventeranno sempre più
incontrollabili. Sono gli interrogativi che ci poniamo, partendo dalla nostra
fede nelle democrazie europee, dalle nostre convinzioni europeiste, dal
contributo che abbiamo direttamente dato per aprire la strada ad un nuovo
capitolo della costruzione europea. Nella vita delle nazioni e nella storia gli
eroi e i martiri sono sempre stati un grande esempio ed una formidabile leva
morale; e nel loro nome si sono potute realizzare grandi imprese.
Tangentopoli: «E invece Mario Chiesa parlò». Craxi, Di Pietro e
quei due anni che non salvarono l’Italia. Venticinque
anni fa — il 17 febbraio 1992 — l’allora presidente del Pio Albergo Trivulzio di
Milano venne arrestato. Fu l’inizio di un percorso che, in 27 mesi, portò
all’esilio di Craxi — e a uno strappo mai ricucito nel tessuto della nostra
convivenza democratica, scrive Goffredo Buccini il 4 febbraio 2017 su “Il
Corriere della Sera”. «Figuriamoci se quello parla!», dicevamo. Invece Mario
Chiesa parlò. E in fondo può stare tutto qui, in un paio di righe che il 17
febbraio del 1992 apparivano ancora un improbabile accidente della storia, il
senso di Mani pulite e dei successivi due anni e rotti: i ventisette mesi che
portarono, nel maggio ‘94, alla fuga di Bettino Craxi in Tunisia e, in
definitiva, a uno strappo nel tessuto della nostra convivenza democratica mai
ricucito davvero. Intendiamoci: è stupido oltre che assai ingiusto ridurre la
dimensione d’un uomo di Stato, il primo a intuire (con forte anticipo) la
necessità d’una grande riforma delle istituzioni repubblicane, a quella del
«latitante di Hammamet» disegnata da certa pubblicistica. I figli di Craxi hanno
sacrosante ragioni per dolersene e magari per considerare il loro padre vittima
di un infernale marchingegno mediatico e giudiziario, a diciassette anni dalla
morte. Se tuttavia quell’uomo di Stato, gravato da condanne e procedimenti
penali, decide di abbandonare l’Italia, non è necessario essere discepoli di
Socrate per vedere come, proprio in virtù del suo ruolo, stia negando alla
radice legittimità ai processi, alle sentenze e, in definitiva, allo Stato che
lui stesso ha rappresentato ai massimi livelli. Mai come nell’ultimo ventennio
della storia repubblicana s’è andata allargando la distanza tra cittadini e
istituzioni, assieme all’idea che ciò che vediamo sia mera mistificazione di ciò
che accade davvero in stanze più o meno segrete. Quest’idea storta che, per
dirla col sociologo Gérald Bronner, genera dalla crisi della reciproca fiducia,
sta ormai ponendo in questione la sopravvivenza stessa della democrazia e ha,
ovviamente, una dimensione planetaria: ma, per ciò che riguarda gli affari di
casa nostra, nasce forse proprio allora. Da una frattura dentro lo Stato.
Le origini di un duello. I due anni che
prendono le mosse dall’arresto del presidente del Pio Albergo Trivulzio,
fedelissimo craxiano (sopra, foto Ansa), colto in flagranza da Antonio Di Pietro
e dal capitano dei carabinieri Roberto Zuliani con la famosa mazzetta da sette
milioni (di lire) pagata dall’imprenditore Luca Magni, si possono riassumere in
realtà come una sfida quasi personale tra i magistrati di Milano e il segretario
nazionale del Psi. Ha scritto Sergio Romano che «la notizia dell’arresto di
Mario Chiesa non rivelò niente che gli italiani non sapessero». Vero. Le
bustarelle erano oggetto di barzellette al bar. Quanti in Italia erano al
corrente del sistema? Tra quelli che intascavano almeno una frazione di tangente
e i loro familiari «non meno di qualche milione» di persone, osserva Romano. Un
bel segreto di Pulcinella, insomma. Molto s’è congetturato, dunque, sul perché
si sia rotto il meccanismo proprio allora.
I teorici della cospirazione.
Immancabili sono le ricostruzioni complottistiche, a partire da quella secondo
cui gli americani abbiano lavorato sottotraccia coi nostri (immancabili) servizi
per far pagare a Craxi «lo schiaffo di Sigonella»: quando, da presidente del
Consiglio, rivendicò la sovranità nazionale fino a far circondare dai
carabinieri i marines che stavano catturando in territorio italiano i terroristi
responsabili del dirottamento dell’Achille Lauro. Tra Garofano e Procure le
relazioni erano in verità difficili già dagli anni Ottanta, almeno dal caso
Tortora in poi. Il nuovo codice di procedura penale firmato da Giuliano Vassalli
nell’89, introducendo il rito accusatorio (all’americana, diremmo, banalizzando)
avrebbe inoltre potuto avere prima o poi come logica conseguenza la separazione
delle carriere tra pubblica accusa e funzione giudicante (pm e gip) e può darsi
che anche questo inasprisse negli anni successivi l’animo di taluni pubblici
ministeri. Teorie, concause, suggestioni, zero prove. La spiegazione forse più
semplice (e dunque più plausibile) è che i soldi erano finiti: il ‘92,
ricordiamolo, anno in cui tutti gli equilibri italiani si infransero (persino
con la svolta stragista della mafia), fu anche l’anno della finanziaria «lacrime
e sangue» varata da Giuliano Amato e dell’uscita della lira dallo Sme; il
sistema dei partiti aveva perso presa dalla caduta del Muro di Berlino che tutto
stava rimodellando. Gli imprenditori (che avevano avuto dal sistema il loro bel
tornaconto in termini di protezione dalla libera concorrenza) si sentirono
infine strangolati e scaricarono i politici: Luca Magni, con la sua piccola
impresa di pulizie, fu insomma un apripista. Come lo fu Milano rispetto al resto
d’Italia.
Il rito ambrosiano. La notizia vera non
fu però l’arresto di Chiesa. Anche Antonio Natali, presidente della
Metropolitana milanese e imbuto di tangenti per maggioranza e opposizione, era
finito in galera sette anni prima: non aveva aperto bocca. Craxi, che lo
considerava una sorta di papà politico, s’era mosso personalmente per fargli una
visitina d’incoraggiamento a San Vittore, poi l’aveva fatto eleggere senatore:
quando Saverio Borrelli aveva chiesto l’autorizzazione a procedere, il Senato
gliel’aveva negata tra gli applausi della destra, del centro e della sinistra
dell’emiciclo. Chiesa parlò, invece: eccola, la notizia. Aveva resistito quando
Di Pietro, forte delle micidiali carte bancarie raccolte dalla moglie per la
causa di separazione, gli aveva contestato i conti svizzeri Levissima e Fiuggi,
sibilando al suo avvocato: «L’acqua minerale è finita... lo dica al suo
cliente». Aveva retto giorni in cella con tenacia. Poi però, aveva sentito alla
tv il suo leader, Bettino, che, sotto la pressione popolare, lo scaricava,
marchiandolo con una parola terribile perché beffarda: mariuolo. Parlò per sette
giorni l’ex enfant prodige del Psi milanese, detto il Kennedy di Quarto Oggiaro
per via del ciuffo giovanilistico, e fu il primo dei grandi collettori di
tangenti a vuotare il sacco. Non avesse parlato, la faccenda sarebbe finita come
le altre volte, forse. In quell’epiteto, mariuolo, c’è la hybris di Bettino e il
ghigno del fato che si diverte a cambiare l’esito delle battaglie. È questo
l’elemento più forte contro tutte le teorie del complotto prodotte ex post: che
tutto nacque da un evento francamente imprevedibile, Chiesa parlò. E
probabilmente parlò perché Craxi lo insultò in tv per difendere il Psi e se
stesso. Quando smise di parlare, ci fu un attimo di sospensione, giusto il tempo
di digerire il risultato elettorale: il 5 aprile segnò il tracollo dei partiti
della Prima Repubblica. Poi, il 22 aprile, arrestarono otto imprenditori:
avevano lavorato per il Pio Albergo Trivulzio, pagato il solito obolo a Chiesa.
Entrarono a San Vittore, confessarono, uscirono. Pochi mesi prima tutti i
partiti milanesi avevano fatto una riunione per gestire il sistema degli
appalti: ora tutto emergeva. Gli avvocati venivano fuori dai primi interrogatori
annunciando «centinaia di arresti in arrivo!».
Il sistema di Tonino e il pool. Il
grande balzo in avanti di Mani pulite avvenne in effetti perché gli otto
imprenditori denunciarono i cassieri segreti dei partiti, i cosiddetti
«elemosinieri», e mandarono in galera personaggi come Maurizio Prada della Dc o
Sergio Radaelli del Psi: l’omertà si ruppe. Un boiardo del calibro di Prada,
allora presidente dell’azienda municipale dei trasporti, dovette infatti vivere
la faccenda come un tradimento e iniziò a raccontare le tangenti che le aziende
a loro volta offrivano per primeggiare. Fu una reazione a catena, tipica del
sistema messo a punto da Di Pietro: vai dentro, denunci i complici, diventi per
loro inaffidabile, esci. Confessioni estorte? Indubbiamente sì, da un certo
punto di vista: la carcerazione ne fu elemento essenziale. E tuttavia anche
confessioni perfettamente legali. Si potrà discutere fino a perdere la voce
sull’accettabilità di una procedura del genere (si badi: sempre avallata da un
gip, ma sempre dallo stesso gip, Italo Ghitti). Ormai però tutto questo è
storia. Sei giorni dopo la confessione degli otto, ventitré giorni dopo le
elezioni politiche, Borrelli affiancò a Di Pietro due pm di cui aveva grande
fiducia, Gherardo Colombo, che aveva scoperto gli elenchi della P2 e s’era
scornato sui fondi neri dell’Iri, e Piercamillo Davigo, detto dai nemici
Vichinsky, il procuratore delle purghe staliniane. Ancora giovani ma molto
esperti, e con una forte cultura della giurisdizione, come usava dire,
sottintendendo che Tonino il tribuno ne era alquanto sprovvisto.
Libera nos a malo. Messo a punto un
sistema, molto controverso, nato il primo nucleo del pool, l’Italia cominciò a
tifare come a un campionato del mondo. «Liberaci dal male che ci perseguita»,
scrivevano a Tonino da ogni parte. Nacquero comitati, si fecero fiaccolate,
manifestazioni sotto Palazzo di Giustizia al grido di «Tonino non mollare!», si
mescolarono le facce di Sabina Guzzanti e Paolo Rossi a quelle degli ancora
missini di Gianfranco Fini. In libreria apparvero le prime agiografie in cui Di
Pietro era descritto come un mix tra Superman e Padre Pio. Il poster degli
«Intoccabili» con le facce del pool in fotomontaggio diventò un gadget
irrinunciabile in quella Milano, quando Borrelli e i suoi si concessero due
passi in Galleria e l’evento diventò un bagno di folla. E naturalmente si può
dire molto male di tanti voltagabbana che, dopo avere votato e blandito potenti
e corrotti per decenni, si misero ad applaudire coloro che ne stavano mozzandone
la testa. Tuttavia, per un breve momento, in quella babele di voci, desideri,
rivendicazioni, rivalse e aspettative ci fu anche dell’altro: una voglia di
cambiare genuina, poi andata persa, come sempre, nei momenti chiave del nostro
Paese.
Quando Bettino diventò «il Cinghialone».
Il soprannome gli fu affibbiato un po’ al bar e un po’ nella sala
stampa di Palazzo di giustizia e rivelava l’immutabile tendenza italica a
maramaldeggiare su chi sta perdendo, soprattutto se è stato un potente. Quella
fu l’estate di Craxi, ancora a giugno candidato alla presidenza del Consiglio:
una prima ondata di indiscrezioni sui verbali di Chiesa (di cui certo dovremmo
discutere provenienza e legittimità) arrivò nelle redazioni e ne stroncò le
ambizioni. Sentendo che il suo tempo stava per finire, Bettino pronunciò un
memorabile discorso alla Camera sul sistema di finanziamento della politica che
sapeva di chiamata in correità per tutti gli altri leader (tranne un giovane
Massimo D’Alema, nessuno fiatò). Poi, nel segno di quella duplicità tra uomo di
Stato e nemico dei magistrati che lo stava perdendo, lasciò circolare voci
insistenti sul suo «poker contro Di Pietro», un miscuglio di veleni e mezze
notizie che riscaldarono molto il clima di quei mesi già roventi: apripista di
un lungo elenco di rivelazioni vere o presunte, tutte volte a dimostrare che
l’eroe nazionale era un mezzo eroe o, addirittura, un poco di buono.
La processione degli avvocati accompagnatori.
Ciascuno può oggi rileggere la storia come vuole, dalla citatissima Mercedes
facile fino alla «sbiancatura» del finanziere Chicchi Pacini Battaglia: ma va
rammentato che Di Pietro conosceva, sì, qualcuno tra quelli che arrestò e
tuttavia l’arrestò ugualmente, e che è uscito pulito da una lunga serie di
processi subiti da imputato e vincitore da molti altri in qualità di querelante.
Più grave del «poker», probabilmente, perché avveniva sotto gli occhi dei
giornalisti, fu la processione degli avvocati accompagnatori, quei legali che in
barba alla loro deontologia salivano in Procura non per difendere il cliente ma
soltanto per fargli confessare in fretta ciò che i pm volevano: nessuno vi diede
gran peso, sembrando quella specie di liturgia parte integrante di un rito
catartico nazionale. Gravi, e grave segno dell’eccessiva vicinanza dei cronisti
all’inchiesta, furono le grida di esultanza che il 15 dicembre del ’92 si
levarono dalla sala stampa del Palazzo di giustizia quando arrivò la notizia che
a Craxi era stato consegnato il primo avviso di garanzia. Imperdonabile fu non
rammentare che dietro ogni provvedimento c’erano famiglie, figli, mogli,
reputazioni: vite.
Il «clima infame». Il primo a
suicidarsi fu Renato Amorese, segretario socialista di Lodi: «Mi hanno
sputtanato», disse, e uscì di scena con dignità, in punta di piedi. Sergio
Moroni, deputato socialista, s’ammazzò il 2 settembre, dopo avere mandato a
Napolitano, allora presidente della Camera, una lettera terribile in cui
s’interrogava su una politica da cambiare ma parlava anche di processo «sommario
e violento» e di «decimazioni». Sua figlia Chiara, che ne ha ereditato la
passione civile, ha raccontato a Federico Ferrero che era insopportabile per lui
«essere scaraventato nel calderone dei ladri». «Hanno creato un clima infame»,
disse Craxi, commosso, uscendo dalla visita di condoglianze a casa Moroni. Poi
si uccisero Gabriele Cagliari e Raul Gardini. Il saggio di Ferrero cita uno
studio di Nando Dalla Chiesa e colloca a 43 il numero delle vittime «per cui è
accertata una morte cagionata dall’onta del coinvolgimento nel giro della
corruzione e del finanziamento illecito». Molti anni dopo è doveroso riflettere
su questo dato. Accanto a un’Italia che festeggiava ogni arresto e ogni avviso
di garanzia come una liberazione dal nemico, c’era un’altra Italia frastornata,
confusa, abbandonata in un angolo con le proprie paure e talvolta i propri
rimorsi, incapace di resistere in un mondo che di colpo si era rovesciato.
Poster azzurri e tangenti rosse. In
vista delle elezioni di marzo ’94, mentre gli altri partiti affogavano, Achille
Occhetto pensava di avere tra le mani una «gioiosa macchina da guerra». Ma già
sui muri delle grandi città erano apparsi manifesti misteriosi con bambini su
sfondo azzurro che balbettavano teneramente uno slogan: «Fozza Itaia». Il Paese
stava cambiando in fretta, perché nulla cambiasse davvero. Nell’inchiesta erano
entrati la Fininvest di Berlusconi e il Pci-Pds, e i fascicoli avevano portato
uno strascico ideologico inquinante. Il filone delle tangenti rosse venne
affidato a Tiziana «Titti» Parenti, che subito puntò sul tesoriere Pds Marcello
Stefanini per le mazzette che sarebbero state versate dal gruppo Ferruzzi a
Primo Greganti. In galera, il «compagno G» ruppe lo schema
confessione-scarcerazione e non disse una parola sul suo partito, accreditando
ulteriormente l’idea di una certa diversità comunista. L’inesperta Titti,
spaesata nella macchina ormai rodata del pool, accusò i colleghi più anziani di
«isolarla». L’avviso di garanzia a Stefanini fu il punto di non ritorno nella
crisi dei suoi rapporti con il procuratore aggiunto Gerardo D’Ambrosio,
incaricato di sovrintendere a questo filone e da sempre sospettato di essere
troppo tenero con Botteghe Oscure. Le accuse reciproche di avere voluto
affossare o salvare gli ex comunisti accompagneranno entrambi. Titti ottenne un
seggio con Forza Italia e poi mollò la politica, D’Ambrosio divenne più tardi
senatore del Partito democratico.
Il tempo dei latitanti. È la stagione
dei fuggiaschi, e dei ritorni. Il 7 febbraio del ’93 si consegnerà a Di Pietro,
appena varcato il valico di Ventimiglia dopo mesi trascorsi in Polinesia, il più
famoso, pirotecnico ed enigmatico di loro: Silvano Larini. Architetto amico di
Craxi, Larini è l’incarnazione stessa dei luoghi comuni sulla «Milano da bere»
degli anni Ottanta, grande protagonista delle notti al Giamaica di Brera. Ma
soprattutto è il detentore di uno dei segreti più resistenti della storia
repubblicana: il mistero del conto Protezione, numero 633369 sull’Ubs di Lugano,
spuntato per la prima volta oltre dieci anni addietro dalle carte della P2 di
Licio Gelli. Il conto è sempre stato suo, spiega, ma Craxi, accompagnato da
Claudio Martelli, durante una passeggiata tra corso di Porta Romana e piazza
Missori, nell’autunno dell’80, gli chiese di prestarglielo per operazioni di
finanziamento all’estero: i primi tre milioni e mezzo di dollari arrivarono il
mese stesso, altrettanti furono accreditati a febbraio dell’anno successivo.
Eutanasia di un sistema in diretta tv.
In un gioco di specchi senza precedenti per una democrazia occidentale,
quell’autunno gli italiani guardarono in diretta tv il disfacimento dell’Italia
che sino ad allora avevano conosciuto e alla quale appartenevano. Il 28 ottobre
Di Pietro portò in aula, per la tangente Enimont, Sergio Cusani: tutte le
udienze furono trasmesse dalla Rai in una infinita soap opera dagli ascolti
clamorosi. Si trattò in termini mediatici della frattura totale tra elettori ed
eletti, rappresentanti e rappresentati: l’altra parte dello strappo nel tessuto
della democrazia italiana nata nel 1946. Bocconiano, ex leader del Movimento
studentesco, amico personale di Gardini, Cusani era accusato di avere mediato
tra il patron della Ferruzzi e i politici. Non volendo tradire il rapporto con
Gardini, morto nel frattempo suicida, rifiutò di collaborare coi pm e mantenne
un atteggiamento di grande dignità, scegliendo il difensore più lontano per
storia e attitudine dagli «avvocati accompagnatori»: Giuliano Spazzali, ex
Soccorso Rosso, vero antagonista della cultura del pentimento catartico sottesa
a Mani pulite (sopra, i due davanti a Palazzo di giustizia a Milano,
Fotogramma). Decidendo di processarlo da solo, Di Pietro volle di fatto
concludere con un espediente mediatico il processo all’intera Prima Repubblica,
trascinando alla sbarra in qualità di testimoni, e dunque con l’obbligo di
rispondere e dire il vero, i principali leader dei partiti che finora erano
sempre sfuggiti a un confronto diretto con lui grazie alle guarentigie
parlamentari. Processualmente, zero. Politicamente, un cataclisma.
La neolingua «dipietrese». Le udienze,
memorabili e piene di pathos, vennero recitate dal pm di Montenero di Bisaccia
in una neolingua fatta di dialetto, smorfie e motti popolari, il «dipietrese»,
che anticipava di due decenni la svolta pop dei grillini. I milanesi facevano la
fila per trovare posto in aula. Tutti o quasi, uscirono con le ossa rotte. Il
penoso farfugliamento di Arnaldo Forlani, incapace di controllare la propria
salivazione davanti alle telecamere, resta forse l’immagine più imbarazzante di
quel cambio di stagione. Se la cavò solo Craxi, orgoglioso fino all’arroganza: a
lui Di Pietro, con gli altri irridente, concesse una specie di onore delle armi
che molto fece almanaccare le tricoteuse incollate alla tv. In capo a qualche
mese, Bettino sarebbe partito per la Francia e poi per la Tunisia, proprio
mentre stavano per bloccargli il passaporto. La sua vicenda politica s’era del
resto già conclusa da un pezzo, la sera che una folla indignata lo aveva
aspettato sotto il suo albergo romano, il Raphael, per tirargli monetine e
coprirlo di insulti. A Palazzo Chigi nella primavera del ‘94 si stava insediando
Berlusconi: la reciproca delegittimazione tra potere politico e potere
giudiziario avrebbe segnato nei vent’anni successivi la vita dell’Italia.
Fiandaca: «Il populismo giudiziario non è diritto e i magistrati
non sono tribuni», scrive Giulia Merlo il 4 Febbraio
2017 su "Il Dubbio". “La cosiddetta rivoluzione giudiziaria realizzata dal pool
milanese non avrebbe potuto vedere la luce se i pubblici ministeri non si
fossero accollati la missione di ripulire la vita pubblica e moralizzare la
politica, credendo di assolvere così una sorta di mandato popolare neppure tanto
tacito”. «Sentenza populista» è solo l’ultima esternazione – pronunciata da un
difensore per definire l’esito di un procedimento penale – che associa il
populismo alla giustizia. Un legame complesso, che affonda le radici nella
storia del nostro Paese e nell’indissolubile connubio tra politica e diritto.
«Una tendenza – quella del populismo penale – che porta, sul versante politico,
alla strumentalizzazione del diritto penale, con l’impiego della punizione come
medicina per ogni malattia sociale; su quello giudiziario alla pretesa del
magistrato di assumere il ruolo di autentico interprete delle aspettative di
giustizia del popolo» è la tesi di Giovanni Fiandaca, professore ordinario di
diritto penale presso l’Università di Palermo e autore del saggio Populismo
politico e populismo giudiziario.
Cominciamo dalla locuzione “populismo penale”. Lei lo considera
un concetto improprio?
«Il concetto di populismo si presta,
nella sua potenziale estensione, a ricomprendere fenomeni molto diversi e può,
perciò, essere piegato anche ad usi impropri. In un mio saggio del 2013 ho
provato a mettere insieme alcuni spunti di riflessione sul populismo penale,
distinguendone due possibili forme che peraltro non sono necessariamente
destinate a manifestarsi in forma congiunta, nel senso che l’una può mantenere
una certa autonomia rispetto all’altra: alludo da un lato al populismo penale
“politico- legislativo” e, dall’altro, al populismo penale “giudiziario”. Il
primo sottintende l’idea di un diritto penale utilizzato come risorsa politico-
simbolica per lucrare facile consenso elettorale in chiave di rassicurazione
collettiva rispetto a paure e ansie prodotte dal rischio- criminalità, specie
quando la fonte di tale rischio viene identificata nel “diverso”, nello
straniero, in quell’ immigrato extracomunitario che finisce con l’assumere il
ruolo di nuovo nemico della società da controllare, punire e bandire: insomma,
inasprire la risposta punitiva nei confronti del presunto nemico significa farsi
populisticamente carico del bisogno di sicurezza del popolo sano, a difesa di
una sorta di “ideologia del guscio” e di una supposta identità culturale ( e
perfino razziale!) che rischierebbe di essere inquinata dai nuovi barbari».
In questo che lei chiama «farsi carico populisticamente del
bisogno di sicurezza» rientra anche la creazione di nuove fattispecie di reato?
«Sì, in generale può parlarsi di
populismo penale in tutti i casi, in cui i politici assecondano la tentazione di
creare nuovi reati o inasprire reati preesistenti allo scopo di dimostrare alla
gente di volere combattere sul serio e in modo drastico i diversi mali che
affiggono la società. Insomma, la risposta punitiva rappresenta uno strumento
non solo apparentemente risolutore proprio perché energico, ma anche molto
comunicativo perché semplice, facilmente comprensibile da tutti nella sua
elementare simbologia; inoltre, essa canalizza pulsioni vendicative e sentimenti
di indignazione morale diffusi a livello popolare e, ancora, esime la politica
dalla ricerca di strategie di intervento più costose e tecnicamente più
appropriate. Questa ricorrente tendenza alla strumentalizzazione politica del
diritto penale, e all’impiego della punizione come medicina quasi per ogni
malattia sociale è stata, non a caso, esplicitamente criticata anche da Papa
Francesco».
E veniamo ora alla seconda forma di populismo penale, il
populismo giudiziario…
«Il “populismo giudiziario”, quale
specifica forma di manifestazione del populismo penale sul versante della
giurisdizione, è un fenomeno che ricorre tutte le volte in cui il magistrato
pretende di assumere il ruolo di autentico rappresentante o interprete dei veri
interessi e delle aspettative di giustizia del popolo (o della cosiddetta
gente), e ciò in una logica di concorrenza- supplenza, e in alcuni casi di
aperto conflitto con il potere politico ufficiale. Questa sorta di
magistratotribuno, che pretende di entrare in rapporto diretto con i cittadini,
finisce col far derivare la principale fonte di legittimazione del proprio
operato, piuttosto che dal vincolo alle leggi scritte così come prodotte dalla
politica, dal consenso e dall’appoggio popolare».
Viene automatico chiederle: possiamo fare qualche esempio, più
o meno recente?
«Esemplificazioni concrete d’un tale
populismo giudiziario non è difficile rinvenirne, ieri come oggi. E’ fin troppo
facile individuarne un modello prototipico nell’Antonio Di Pietro protagonista
di “Mani pulite”. Anzi, direi che proprio Di Pietro ha acceso la miccia di un
populismo destinato, successivamente, a proliferare in forme anche più
direttamente politiche. Aggiungo, incidentalmente, che sarebbe anche maturato il
tempo per effettuare un autentico bilancio critico degli effetti politici ad
ampio raggio – alcuni dei quali, a mio giudizio, del tutto negativi – prodotti
dalla cosiddetta rivoluzione giudiziaria milanese. Personalmente, temo che una
giustizia penale che si autoinveste di missioni palingenetiche, alla fine, causi
più danni che vantaggi».
“Mani pulite” come modello di populismo giudiziario, dunque. Di
quale missione palingenetica si sarebbero investiti i magistrati milanesi?
«La cosiddetta rivoluzione giudiziaria
realizzata dal pool milanese non avrebbe potuto vedere la luce se i pubblici
ministeri non si fossero accollati la missione di ripulire la vita pubblica e
moralizzare la politica, credendo di assolvere così una sorta di mandato
popolare neppure tanto tacito. Altra cosa è che un obiettivo “sistemico” così
ambizioso fosse veramente alla portata dell’azione giudiziaria di contrasto
della corruzione. A riconsiderare quell’esperienza a venticinque anni di
distanza, sembra più che lecito dubitarne».
Ecco il punto: è possibile associare il termine populismo alla
giustizia, quindi?
«Si può associare se utilizziamo il
termine “giustizia” per indicare i bisogni, le aspettative di tutela e le
aspirazioni di giustizia della popolazione secondo la chiave interpretativa che
pretendono di fornirne le forze politiche o i magistrati di vocazione populista.
Se guardiamo al concetto di giustizia sotto un’angolazione diversa e più
generale, invece, tra populismo e giustizia può esservi conflitto».
Proviamo ora a ricercare le origini del fenomeno. Secondo lei
dove affondano?
«Il discorso è complesso. Direi una
miscela di fattori oggettivi o di contesto, e soggettivi come il protagonismo di
una parte della magistratura. Tra i fattori di contesto, annovererei – in
sintesi – la crisi della politica ufficiale e la sfiducia verso i politici,
l’emergere di tendenze antipolitiche (o, meglio, antipartitiche), la tentazione
politica di delegare alla magistratura il compito di affrontare e risolvere
grosse questioni sociali, criminali e non. Tra i fattori soggettivi, porrei
l’accento sulla vocazione lato sensu politica di una parte della magistratura,
sul diffondersi di una cultura giudiziaria di tipo attivistico- combattente e
sulla tendenza – appunto – di alcuni magistrati a impersonare il ruolo di
giustizieri, angeli del bene o tribuni del popolo. Questi fattori oggettivi e
soggettivi interagiscono secondo dinamiche complesse e non univoche».
Provando a spostare l’analisi sull’attuale sistema politico, si
può dire che il diritto penale è stato strumentalizzato in chiave populista?
«Questo fenomeno di strumentalizzazione
è esistita e continua ad esistere, peraltro sia a destra che a sinistra».
Concretamente, possiamo citare qualche caso?
«Faccio due esempi, entrambi
emblematici: la circostanza aggravante della clandestinità introdotta in epoca
berlusconiana, e poi bocciata dalla Corte costituzionale; il nuovo reato di
omicidio stradale fortemente voluto da Matteo Renzi, in una prospettiva
sinergica populista- vittimaria: nel senso che la motivazione politica di fondo
sottostante all’omicidio stradale ( come reato autonomo) è stata non solo quella
di dare un segnale anche simbolico di grande rigore nel contrastare la
criminalità stradale con pene draconiane, ma anche di indirizzare un messaggio
di attenzione e vicinanza nei confronti dei familiari delle vittime della strada
e delle loro associazioni. Al di là di questo discutibilissimo populismo
vittimario, quel che rimane da dimostrare con criteri empirici è – beninteso –
che l’omicidio stradale serva davvero a prevenire più efficacemente gli
incidenti mortali».
Secondo lei la politica sta tendendo ad avvicinarsi al lessico
tipicamente “accusatorio” della magistratura requirente?
«Ritengo che vi siano esempi di questo
avvicinamento anche in Italia. Alludo, com’ è intuibile, al fenomeno di
esponenti politici a vari livelli che pongono al centro della loro azione
politica o del loro programma di governo la lotta alla criminalità o la difesa
della legalità: una sorta di professionismo politico specificamente
anticriminale o antimafioso. Con una tendenziale differenza, peraltro, a seconda
che questo tipo di politico militi sul fronte conservatore o progressista: nel
primo caso, egli muoverà guerra soprattutto alla criminalità comune e alla
criminalità da strada; nel secondo caso, alle mafie e alla criminalità dei
“colletti bianchi”. In entrambi i casi, comunque, il politico di turno tenderà a
vestire i panni del pubblico ministero più che del giudice: porrà infatti
l’accento, con parecchia enfasi, sulla necessità di denunciare, indagare,
accertare, impiegare tutti i mezzi di contrasto possibili e immaginabili per
sradicare la mala pianta del crimine e fare terra bruciata intorno ad esso,
applicare pene draconiane, controllare e neutralizzare gli individui pericolosi
o sospettabili tali».
Tornando al populismo penale, il termine viene utilizzato in
accezione negativa. Eppure lei ha scritto che il diritto penale è, in qualche
modo o misura, populistico. E’ una provocazione?
«Sì è una provocazione intellettuale,
nel senso che tento di chiarire. Tradizionalmente, ogni codice penale è stato
considerato una specie di marcatore simbolico dell’identità culturale e
valoriale di un determinato popolo: in questo senso, ogni codice nazionale
rifletterebbe la storia, i valori, gli usi sociali, i sentimenti collettivi
della nazione in questione. Con formula efficace, si è anche detto che un codice
penale rispecchia il “minimo etico” della popolazione. Ciò premesso, io
avanzerei in realtà riserve rispetto alla tendenza a caricare il dritto penale
di valenze fortemente identitarie, a maggior ragione nelle società in cui
viviamo caratterizzate da un accentuato pluralismo: incombe, infatti, il rischio
di voler autoritariamente attribuire alla punizione il compito illusorio di
riaffermare o rinsaldare identità “comunitarie” ormai inesistenti o indebolite
contro criminali percepiti come nemici estranei e inquinanti. Un simile
atteggiamento sarebbe non solo incostituzionale, ma sostanzialmente fascistico-
razzistico».
Nel suo saggio sul populismo penale, lei cita il criminologo
Jonathan Simon, che attribuisce un ruolo politico decisivo alla paura per la
criminalità. Che funzione esercita, secondo lei, la paura nell’affermarsi del
populismo?
«Un ruolo certo non piccolo, non solo
in Italia. Come ha appunto messo in evidenza Simon riguardo ad esempio agli
Stati uniti, si può verosimilmente diagnosticare uno specifico paradigma di
governance politica incentrato sulle strategie di repressione e prevenzione
della criminalità quali essenziali elementi costitutivi dell’azione di governo.
Ma il fenomeno è da tempo registrabile in molti paesi».
Per concludere, le richiamo una citazione di Leonardo
Sciascia che lei usa come incipit del suo saggio: “Quando un uomo sceglie la
professione di giudicare i propri simili, deve rassegnarsi al paradosso doloroso
per quanto sia – che non si può essere giudice tenendo conto dell’opinione
pubblica, ma nemmeno non tenendone conto”. Lei condivide? Ma come può chi
giudica tenere conto dell’opinione pubblica?
«Condivido il senso profondo del
paradosso sciasciano, che lascia trasparire la difficoltà oggettiva ma, al tempo
stesso, la necessità di conciliare in qualche misura due esigenze opposte. Cioè
il giudice dovrebbe in teoria, per un verso, essere sempre capace di prendere
criticamente le distanze dal clima ambientale, dalle pressioni esterne e dalle
aspettative di punizione delle stesse vittime del reato e, aggiungerei, anche
dai propri pregiudizi e dai sentimenti personali, e di emettere decisioni basate
soprattutto sulle norme, sul ragionamento rigoroso e sul senso di equilibrio, in
modo da contemperare tutti i valori in campo: il che, passando dalla teoria alla
realtà, può peraltro avverarsi soltanto fino a un certo punto. Anche i giudici
sono esseri umani!»
E però rimane il fardello dell’opinione pubblica…
«Infatti. Per altro verso, chi giudica
neppure dovrebbe pronunciare sentenze così difformi dalle aspettative della
società esterna e delle vittime da risultare poco comprensibili e, perciò,
inaccettabili. Ma la grande difficoltà, il dramma stanno proprio in questo: non
di rado, le aspettative popolari di giustizia sono molto emotive, poco filtrate
razionalmente e perciò, come tali, irricevibili da una giustizia che aspiri a
condannare e punire sulla base di motivazioni razionali e in misura
proporzionata alla gravità dei reati e delle colpe accertate».
Viene da chiederle, se mai esiste una risposta: è possibile
trovare la “misura” nel giudicare?
«Che cosa sia davvero “proporzionato”
in campo penale, è una questione a sua volta intrinsecamente controvertibile: in
proposito, non c’è verità scientifica, né si può esigere la precisione del
farmacista. Si ripropone, dunque, il paradosso “doloroso” di Sciascia: un
paradosso che non consente facili vie di uscita, né tollera risposte capaci di
tranquillizzare – appunto – la coscienza di chi ha scelto la professione di
giudicare».
Di Pietro continua a infangare Craxi: "Non si intitolano vie a
chi ha commesso reati". L'ex pm Antonio Di Pietro
critica chi vuole riabilitare Bettino Craxi: "Ritengo che le vie vadano
intitolate a persone che sono un punto di riferimento, soprattutto per le nuove
generazioni. Non a chi è stato condannato", scrive Raffaello Binelli, Sabato
21/01/2017 su "Il Giornale". Non c'è nulla da fare. Di Pietro ce l'ha sempre
avuta e continua ad avercela con Bettino Craxi, nonostante l'ex leader
socialista sia morto ormai da diciassette anni. All'ex pm di Mani Pulite non va
giù che si cominci, molto lentamente, a rivedere sotto una luce diversa i fatti
di Tangentopoli. E così mette tutti sull'attenti (o almeno ci prova), ricordando
a tutti che Craxi, in fondo, era colpevole di tante malefatte. E che quindi oggi
non merita l'intitolazione di alcuna via. Vediamo cosa ha detto Antonio Di
Pietro, in un'intervista al quotidiano La Stampa, in merito al dibattito aperto
dal sindaco di Milano Giuseppe Sala per intitolare una strada all'ex presidente
del Consiglio. "Ritengo che le vie vadano intitolate a persone che sono un punto
di riferimento, soprattutto per le nuove generazioni. Che siano un esempio da
imitare. Una persona che è stata condannata più volte non penso che si possa
indicare come esempio. Mi sembra una furbata questo dibattito, vogliono buttarla
in politica per nascondere le responsabilità giudiziarie". E Di Pietro spiega
cosa vuol dire col termine furbata: "Si è fatto credere all' opinione pubblica
che in questo Paese c'è stata una guerra tra magistrati e politica. Ma non è
colpa dei magistrati se qualcuno ha commesso dei reati. I magistrati hanno fatto
le indagini per accertare chi aveva commesso reati giudiziari". Ora, se questo è
vero (ed è vero, i reati sono stati commessi), è altrettanto vero (perché lo
dice la storia) che i partiti politici italiani dal dopoguerra al 1992, si sono
quasi tutti finanziati in modo illecito. Ed è altresì vero che il più grande
partito dell'opposizione, il Pci, riceveva (in modo illegale) i fondi
dall'ex Unione Sovietica oltre a quelli con cui si foraggiavano anche le altre
forze politiche. Eppure la tanto sbandierata rivoluzione di Tangentopoli non ha
fatto luce fino in fondo su questi reati (coperti dall'amnistia del 1990). La
magistratura dell'epoca, dunque, ha svolto il proprio lavoro in modo strabico,
col risultato di indurre i cittadini a credere che una parte politica, quella
dei partiti che per oltre 40 anni avevano governato il Paese, fosse solo un
manipolo di "ladroni", mentre l'altra parte c'erano dei veri e propri
gentiluomini, puri e immacolati. Mai possibile credere, ancora oggi, ad una
simile barzelletta? Di Pietro riconosce che il sindaco di Milano Sala "sul piano
personale può avere o non avere un giudizio su di lui (Craxi, ndr). Ma come
sindaco non può volere questa cosa. Milano non può dimenticare di essere stata
Tangentopoli, la città degli affari illeciti che con questi ha contribuito
all'impoverimento del Paese". E rincara la dose: "Sembra che si voglia a tutti i
costi dimenticare che Bettino Craxi è stato condannato anche in vita a più di 10
anni di carcere per corruzione e finanziamento illecito ai partiti. Condanne
arrivate perché ci sono persone che ci hanno riferito di appalti con tangenti e
di conti correnti anche all' estero intestati a lui e al suo gruppo. Altro che
"è stato condannato perché non poteva non sapere". Altro che "non c' erano
finanziamenti illeciti".
Odiate, odiate, e il consenso verrà,
scrive Piero Sansonetti il 21 gennaio 2017 su "Il Dubbio". Il Fatto di
Travaglio definisce Alfano “Ministro della malavita” perché è andato sulla tomba
di Bettino Craxi. Il problema dell’odio, dell’eccesso di odio nella lotta
politica, non è solo una questione culturale. E’ un problema molto concreto,
perché l’odio sta scalzando la stessa lotta politica. Sostituendola, assumendone
la funzione. E sta prendendo il posto dei programmi, delle idee. L’odio – che
una volta era un accessorio del conflitto, una aggiunta – è diventato
l’essenziale, e soprattutto è diventato lo strumento principale della conquista
del consenso. Odia, odia, vedrai che diventi popolare. Vorrei sottoporvi questo
titolo pubblicato ieri con grande evidenza sulla prima pagina del “Fatto”. Dice
così, testualmente: «Alfano, ministro della malavita, sulla tomba del latitante
Craxi». Cos’è che colpisce? Certo, colpisce l’ingiuria, usata con incredibile
arroganza e leggerezza. Alfano viene qualificato come un gangster. Il capo dei
gangster. Il riferimento è probabilmente a una polemica del primo novecento tra
Gaetano Salvemini e Giovanni Giolitti, per via dei brogli elettorali dei
giolittiani in Puglia. Salvemini usò quell’epiteto. Ma nell’articolo del “Fatto”
non c’è nessun accenno a Salvemini, del resto il povero articolista neanche si
sogna di definire Alfano un bandito. La polemica è tutta del titoli- sta. Il
quale, probabilmente, già sa che la magistratura difficilmente condannerà il
“Fatto” che è il suo giornale di riferimento, e quindi non fa caso agli insulti
e li usa con larghezza. (Se penso che un Pm di Palermo mi ha chiesto più di
centomila euro di risarcimento per aver scritto che era stato maleducato
nell’interrogatorio di De Mita, mi chiedo quanto potrebbe chiedere Alfano
apostrofato come il capo della delinquenza: 1 milione, 10 milioni? E però son
sicuro che il Pm di Palermo con me vincerà, e Alfano non vedrà mai una lira…).
Ma quel che più colpisce nel titolo non è nemmeno l’improperio sfrontato per il
ministro. E’ l’odio, l’odio incontenibile e viscerale e imperituro, per un
signore che ha contribuito a fare la storia della repubblica, che ha avuto un
ruolo importantissimo nella storia della sinistra, e che è morto quasi vent’anni
fa. Il gusto di parlare di una persona morta apostrofandola come latitante, ha
pochi precedenti nelle tradizioni della polemica politica italiana. L’odio,
l’odio come carburante per l’intelletto. L’odio come certezza dell’esistere.
Come assicurazione sulla propria probità. Voi dite che ormai è una tendenza
inarrestabile? Speriamo di no.
Martelli: «Alla fine i moralisti finiscono alla gogna»,
scrive Giulia Merlo il 17 Dicembre 2016 su "Il Dubbio". «Chiunque faccia
dell’onestà il principale, se non l’unico motivo della propria iniziativa
politica, nasconde un’assenza di programmi più approfonditi”. «Nessun ritorno a
Mani Pulite». Claudio Martelli, ex ministro della Giustizia nel difficile
biennio tra il 1991 e il 1993, analizza le inchieste che hanno gettato nel caos
le amministrazioni di Milano e Roma, a partire dal rapporto sempre teso tra
politica e magistratura.
Onorevole, traballano sia Milano che Roma: con Beppe Sala
autosospeso e il braccio destro della sindaca Virginia Raggi arrestato. Ci sono
somiglianze con il 1992 di Mani Pulite?
«Somiglianze non direi. Non vedo
un’ondata di arresti scatenati da metodi di indagine alla Di Pietro, in cui il
motto era «o parli o butto la chiave», con una catena di delazioni a comando
provocate dalla carcerazione preventiva. Vedo però uno stillicidio continuo di
indagini e accuse e una particolare devozione della nostra magistratura alle
indagini sulla pubblica amministrazione. Per un verso bisogna rallegrarsene, per
altro verso suscita qualche interrogativo, a fronte della mole di reati, anche
più gravi, non perseguiti».
Partiamo dal caso–Roma. L’amministrazione grillina rischia di
crollare sotto il peso delle dimissioni di Paola Muraro e l’arresto di Raffaele
Marra. Che fine ha fatto lo slogan “onestà–onestà”?
«Come le volpi finiscono in
pellicceria, così i moralisti finiscono alla gogna. S’è già visto in passato:
quelli che sbandieravano il partito degli onesti poi finirono nel tritacarne
giudiziario e questo è vero anche oggi.
Chiunque faccia dell’onestà il principale se non l’unico motivo della propria
discesa politica in campo nasconde un’assenza di programmi più approfonditi.
L’onestà è una precondizione e la politica è un mestiere talmente difficile e
insidioso che pensare di cavarsela semplicemente restando onesti è una pia
illusione».
Poi anche Milano, la sua città: Expo è stato uno dei più
sbandierati successi del governo Renzi e ora rischia di essere la pietra tombale
del Comune, faticosamente mantenuto dal Pd. Quali equilibri si stanno muovendo?
«La procura aveva archiviato il caso
Sala, in cui non si era trovata traccia di tangenti. Per dirla con Ilda
Boccassini, non c’era odor di «piccioli», ma solo una gran fretta, che ha fatto
compiere anomalie. Sembra infatti che sia stato retrodatato un documento di
indizione di una gara d’appalto, per poter rientrare nei termini di legge. Nei
giorni di Expo, infatti, ricordo grande frenesia per arrivare con le opere
compiute all’inaugurazione, smentendo i gufi del «non ce la farete mai»».
Invece la procura generale ha ritenuto di riaprire l’inchiesta…
«Che la procura generale abbia ritenuto
di riaprire un caso archiviato dalla procura della Repubblica e come questo si
inserisca nella lotta devastante della magistratura milanese, purtroppo è nelle
carte. Del resto, è stato lo stesso Csm a tentare di sedare le lotte,
legittimando Edmondo Bruti Liberati e trasferendo Alfredo Robledo. Io temo che
l’iscrizione di Sala ne registro degli indagati possa essere un danno
collaterale provocato da quel conflitto. Del resto, i conflitti tra magistrati
sono i più accaniti e avvelenati, perché tutte le parti brandiscono il diritto,
indossano la toga e sono ammantati di intransigenza assoluta, impuntata su
dettagli e cavilli».
Una magistratura milanese, dunque, molto diversa da quella di
Mani Pulite?
«Decisamente. Allora c’era una
compattezza incredibile nel pool di Mani Pulite: anche quando – come poi si
scoprirà – i giudici non erano d’accordo uno con l’altro, erano però tutti saldi
nel far fronte comune contro l’opinione pubblica rispetto ai politici».
Ma anche oggi si ripete, però, un dualismo guerriero tra
magistratura e politica?
«Questa è la visione manichea di
Piercamillo Davigo, che parla di lotta del bene contro il male, in cui i
magistrati sono tutti buoni e politici tutti corrotti».
Lei, invece, come la pensa?
«Io credo ci sia la somma di due mali.
E’ vero che la corruzione in Italia alligna più che altrove che questo merita
indagini e sanzioni. Se però nelle indagini si cede a eccessi giustizialisti,
ecco che si somma male ad altro male: la corruzione diffusa e la repressione
arbitraria».
Torna, dunque, al centro il rapporto difficile tra politica a
tutti i livelli e magistratura.
«Io credo che, di questo, il caso di
Beppe Sala sia emblematico. Ancora non si sa con certezza se abbia ricevuto un
avviso di garanzia e tutto è nato da indiscrezioni sui giornali. Quando dalle
procure trapelano notizie riservate, storcendo il principio della tutela
dell’indagato e del suo diritto alla riservatezza, ecco che si è già compiuto un
abuso grave. Ma la violazione del segreto istruttorio è diventata un passatempo,
ed anzi è strano quando ciò non avviene. Se si distrugge la reputazione
dell’imputato nella fase precedente l’indagine formale, però, si altera il corso
della giustizia e questo è il punto cruciale e che più interessa i rapporti tra
politica e magistratura. La sentenza, infatti, può anche essere di assoluzione,
ma intanto la carriera politica è già bella che finita».
L’autosospensione di Sala è una scelta politica che deriva da
questa distorsione del sistema?
«Io credo che lui abbia fatto una
scelta opportuna. La sua decisione fungerà da sollecito alla procura generale,
perché si decida in fretta a formalizzare le accuse o archiviarle».
Il caso Roma, invece, ha delle implicazioni diverse. Raggi è
sotto scacco?
«L’elemento politico di questa vicenda
lo ha colto bene Giorgia Meloni, che si è chiesta se ci troviamo di fronte a
incompetenza assoluta oppure a stupida malizia della sindaca Raggi. Perché ha
insistito a scegliere personaggi che hanno fatto il loro curriculum
amministrativo nelle passate gestioni, che in pubblico lei è stata la prima a
condannare? Questo a me pare incomprensibile. Noi siamo osservatori estranei, ma
anche dal suo stesso movimento in tanti l’hanno messa in guardia. La sua è stata
ostinazione, ma del resto questo è un periodo in cui va di moda per sindaci ed
ex sindaci non ascoltare i consigli».
Un riferimento a Matteo Renzi?
«Non ho fatto che leggere elogi per la
cosiddetta «determinazione» di Matteo Renzi. Eppure io credo che ostinarsi sia
un errore, non certo una qualità. E di qualità Renzi ne avrebbe molte altre».
Così nacquero Tangentopoli e poi il giustizialismo,
scrive Fabrizio Cicchitto il 27 Dicembre 2016 su "Il Dubbio". L’intervento del
ministro Orlando alla direzione del Pd e la lunga intervista al Dubbio del
filosofo Biagio De Giovanni hanno costituito la prima radicale rimessa in
questione di quel giustizialismo che nel Pds– Ds e poi nel Pd ha costituito una
fondamentale scelta ideologica di larga parte dei post– comunisti (con
l’eccezione dei miglioristi come Chiaromonte, Napolitano, Umberto Ranieri) e una
altrettanto marcata scelta politica determinata da un misto di strategia e di
tattica di cui poi vedremo le ragioni di fondo. Orlando ha denunciato il fatto
che per anni il giustizialismo esercitato contro Berlusconi ha sostituito le
scelte culturali e politiche di stampo realmente riformista che invece non sono
state fatte. Biagio De Giovanni ha denunciato il fatto che sul giustizialismo
della sinistra si sono innestati due fenomeni devastanti: “la politica distrutta
dall’invadenza della magistratura” e un’antipolitica che si innesta su questo
ruolo prevaricante di un potere dello stato e che attraverso di esso sta
distruggendo il confronto politico e culturale. De Giovanni ha anche rilevato, a
proposito dell’attività più propriamente politica del ministro Orlando, che egli
ha realizzato positivi interventi sulle carceri ma non è riuscito neanche a
sfiorare i due temi centrali della riforma della giustizia, la separazione delle
carriere e il superamento dell’obbligatorietà dell’azione penale. Per completare
questa rassegna preliminare citiamo anche l’intervista di Giorgio Napolitano
sul Messaggero a proposito del confronto sul referendum: Napolitano ha rilevato
che la forza dell’antipolitica è diventata tale che nell’ultima fase della
campagna referendaria il Presidente Renzi ha pensato bene di riuscire a smontare
il vantaggio del No dando al Sì il valore della lotta alla casta: fatto dal
presidente del Consiglio in carica questo appello è risultato controproducente e
anche un po’ grottesco. Ciò detto, però, dobbiamo per forza fare un passo
indietro. Il finanziamento organicamente irregolare dei partiti parte dagli anni
40 e ha per nome e cognome una serie di padri della patria (da Alcide de
Gasperi, a Palmiro Togliatti a Pietro Nenni). Negli anni ’ 40–’ 50 la Dc era
finanziata dalla Confindustria, dalla Cia, da una rete di imprenditori privati.
Poi, con l’avvento di Fanfani, il finanziamento della Dc fu sostenuto anche
dalle aziende a partecipazione statale. A sua volta il Pci era finanziato dal
Pcus, dalle cooperative rosse, da una rete di imprenditori amici, specie nelle
regioni rosse. Prima di Craxi, il Psi dipendeva per il suo finanziamento dal
principale alleato: nella fase frontista esso si basò sul finanziamento
sovietico e sulle cooperative rosse, nella fase del centro– sinistra sulle
partecipazioni statali. Tutto ciò si aggregò in un sistema organico, quello di
Tangentopoli. A fondare quel sistema dal lato imprenditoriale furono altri due
padri della patria, cioè Vittorio Valletta ed Enrico Mattei. Mattei considerava
i partiti e le loro correnti dei “taxi” (tant’è che finanziava abbondantemente
anche l’Msi, un partito che poi anch’esso, come del resto il Pci– Pds, si è
rifatto la verginità), e poi fondò in modo esplicito con Albertino Marcora
quella sinistra di base (corrente democristiana) che ha esercitato una grande
influenza nella Dc e nell’intero sistema politico. Che il Pci affondasse le sue
risorse in un finanziamento irregolare dalle molteplici fonti (altro che feste
dell’Unità) è messo in evidenza dal verbale di alcune riunioni svoltesi in Via
delle Botteghe Oscure citato a pagina 495– 498 nel libro di Guido Crainz “Il
paese mancato”. Giorgio Amendola nella direzione del 1 febbraio 1973 disse:
“quando me ne sono occupato io “le entrate straordinarie” (eufemismo ndr) erano
del 30% ora siamo al 60%”. A sua volta Elio Quercioli disse: “molte entrate
straordinarie derivano da attività malsane. Nelle amministrazioni pubbliche
prendiamo soldi per far passare certe cose. In questi passaggi qualcuno resta
con le mani sporche e qualche elemento di degenerazione finisce per toccare
anche il nostro partito”. E nella riunione dell’1 e del 2 marzo 1974 il Pci
diede il sostegno alla legge sul finanziamento pubblico con l’esplicita
motivazione di ridurre il finanziamento sovietico e le “entrate straordinarie
derivanti da attività malsane”. Armando Cossutta disse: “negli ultimi anni si è
creato in molte federazioni un sistema per introitare fondi che ci deve
preoccupare. C’è un inquinamento nel rapporto con le nostre amministrazioni
pubbliche nel quale c’è di mezzo l’organizzazione del partito e poi ci stanno
dei singoli che fanno anche il loro interesse personale”. Quando, poi, decollò
la politica di unità nazionale, il Pci entrò anche nel “sistema degli appalti
pubblici” che aveva come sede di compensazione l’Italstat: in quella sede c’era
un meccanismo che assicurava la rotazione nell’assegnazione degli appalti che
riguardava tutte le grandi imprese di costruzione pubbliche e private: alle
cooperative rosse era garantita una quota che oscillava dal 20 al 30%. A sua
volta Bettino Craxi per rendere reale fino in fondo l’autonomia del Psi dalla Dc
e dal Pci, prese direttamente e tramite Vincenzo Balzamo rapporti con il mondo
imprenditoriale: una mossa i cui rischi furono evidenti poi. Avendo però alle
spalle quella realtà del suo partito, Berlinguer fece la famosa intervista sulla
questione morale nella quale presentava il Pci come il partito delle “Mani
Pulite”: la mistificazione è evidente. In sostanza Tangentopoli era un sistema
che si fondava su un organico rapporto collusivo fra tutte le grandi imprese
pubbliche e private senza eccezione alcuna (quindi compresa la Cir di De
Benedetti, come risultava dalle sue stesse ammissioni processuali) e da tutti i
partiti dell’arco costituzionale senza eccezione alcuna (quindi compreso il Pci;
l’Msi, a sua volta, o aveva diretti rapporti con le imprese, vedi l’Eni, o, a
livello locale era “tacitato” dagli altri partiti). Questo sistema era fondato
sulle grandi imprese, sui partiti, sulle correnti dei partiti. In esso, dalla
seconda metà degli anni ’ 80 in poi, emersero degenerazioni personali. Comunque,
con l’adesione dell’Italia al trattato di Maastricht che costrinse “a calci” il
capitalismo italiano a fare i conti con il mercato e la libera concorrenza (cosa
che fino ad allora non aveva fatto) il sistema di Tangentopoli diventò
chiaramente antieconomico (lo era anche prima ma esistevano meccanismi di
compensazione quali il debito pubblico e specialmente le svalutazioni
competitive, in genere decise di comune intesa fra la Fiat e Banca d’Italia) e
doveva essere superato. Ora la via maestra di quel superamento–eliminazione
avrebbe dovuto essere un’operazione consociativa, con un’intesa generale fra le
forze politiche, quelle imprenditoriali, quelle giudiziarie, e magari concluso
con un’amnistia. Le cose non andarono affatto così. L’ultima amnistia fu quella
del 1989 che servì a salvare il Pci dalle conseguenze penali del finanziamento
irregolare di derivazione sovietica. Negli anni ’ 90 i partiti, specie la Dc, il
Psi, i partiti laici, ma per altro verso anche il Pci (che con il cambio del
nome in Pds e il “superamento” del comunismo perse circa metà del suo
elettorato) avevano perso vivacità culturale e consenso. A quel punto, invece,
si affermò nella magistratura la corrente più aggressiva e più ideologica, cioè
Md, che teorizzava il ruolo sostanzialmente rivoluzionario del magistrato che,
superando un’asettica e burocratica terzietà, avrebbe dovuto rimettere in
questione gli equilibri economici e quelli politici. Questa teorizzazione trovò
nel pool di Milano di Mani Pulite chi la cavalcò sul piano dell’esercizio della
giurisdizione mettendo in essere un’operazione del tutto unilaterale, fondata su
due pesi e due misure: nel caso della Dc, Mani Pulite arrivò addirittura a
distinguere fra le correnti di centro–destra di quel partito che furono
sostanzialmente distrutte ( chi non ricorda Forlani al processo Enimont, e poi,
fuori da Milano, Andreotti alla sbarra per l’assassinio di Pecorelli e per il
concorso con la mafia e Antonio Gava e Paolo Cirino Pomicino in carcere?) e
invece la sinistra Dc, e sull’altro versante, il Pci–Pds, furono interamente
salvati. A loro volta il Psi, il Psdi, il Pli, il Pri furono rasi al suolo.
Quando l’unilateralità dell’operazione non era ancora chiara e sembrava che
avrebbe colpito tutto e tutti, Achille Occhetto si precipitò alla Bolognina a
“chiedere scusa agli italiani” perché conosceva bene il retroterra finanziario
del Pci– Pds. Quella di Mani Pulite fu comunque un’operazione rivoluzionario–
eversiva unica in Europa: fu l’unico caso nel quale ben 5 partiti di governo
furono distrutti prima dai magistrati che dagli elettori. Lo strumento
principale di questa operazione era la cosiddetta “sentenza anticipata”: se un
dirigente politico viene raggiunto da un avviso di garanzia, enfatizzato da
giornali e da televisioni, a quel punto egli perde totalmente il suo consenso
elettorale. Se la stessa sentenza colpisce altri mille dirigenti di quel
partito, è il partito nel suo complesso ad essere azzerato. Se poi, magari dopo
cinque o sette anni, interviene la vera sentenza processuale ed è di
assoluzione, i suoi effetti politici sono nulli. In seguito a Mani Pulite, dal ’
92–’ 94 in poi, i rapporti fra politica e magistratura sono stati totalmente
rovesciati. A “comandare” è chiaramente la seconda. A sancire quel cambio di
equilibrio fu anche nel 1993 l’eliminazione di quell’immunità parlamentare che
fu ideata dai costituenti proprio per bilanciare la totale autonomia di cui gode
la magistratura italiana diversamente da altri ordinamenti. In un primo tempo il
Pds fu l’utilizzatore passivo di quella unilateralità dell’azione della
magistratura. Poi ne diventò il fruitore attivo. La storia, però, è paradossale.
Il Pds di Occhetto, D’Alema, Veltroni credeva che grazie a Mani Pulite sarebbe
arrivato sicuramente al potere. Di conseguenza la discesa in campo di Berlusconi
fu un’amara sorpresa per il gruppo dirigente del Pds. Berlusconi da parte sua
fece leva anche sul “nuovismo”, sul populismo e sull’antipolitica che Mani
Pulite aveva suscitato. A quel punto, però, il giustizialismo fu esercitato dal
Pds (e da tutto il circolo mediatico costituito da Repubblica, il Tg3,
Samarcanda, poi Travaglio e Il Fatto) contro Berlusconi provocando una “guerra
civile fredda” durata 20 anni. Anche in questo secondo caso, però, c’è stata
un’altra amara sorpresa: quando Berlusconi è stato messo fuori gioco attraverso
un’interpretazione retroattiva di una legge già di per sé assolutamente iniqua,
qual è la Severino, il Pd di Bersani si è trovato di fronte ad un altro scherzo
della storia: Forza Italia era stata messa fuori gioco, il centro– destra era in
crisi ma a quel punto, a cavalcare fino in fondo la tigre e l’onda del
giustizialismo e dell’antipolitica, è nata una forza integralmente
protestataria, ultra– giustizialista e gestita con meccanismi di stampo
autoritario da un comico– demagogo e dalla società di comunicazione della
Casaleggio associati. Bisogna guardare anche all’altra faccia della medaglia:
mentre a suo tempo Tangentopoli era un sistema fondato su grandi imprese e sui
partiti in quanto tali, da dopo il ’ 92–’ 94 è avvenuta la parcellizzazione
della corruzione, che si è fondata su una miriade di mini– catene o reti
composte da singoli imprenditori, singoli alti burocrati, singoli politici, in
qualche caso anche con singoli magistrati. Questa corruzione capillare è ciò che
è avvenuto dopo il ’ 92–‘94 enfatizzando a dismisura il ruolo della magistratura
con effetti sconvolgenti. Oggi anche gli apprendisti stregoni sono vittime di sé
stessi e cioè anche i grillini sono ormai dominati dall’incubo dell’avviso di
garanzia che per loro, è ancor più distruttivo perché finora, quando esso
riguardava gli “altri” equivaleva ad una sentenza di terzo grado. Per
concludere: le riflessioni del ministro Orlando e di Biagio De Giovanni
costituiscono certamente un fatto positivo: non vorrei, però, che essi arrivino
troppo tardi, quando già Davigo, non a caso eletto “a furor di popolo”
presidente dell’Anm, si comporta come una sorta di super– commissario ad acta
nei confronti del fallimento delle istituzioni della Repubblica, del Parlamento
e dei parlamentari in primis, soggetti, questi ultimi, considerati dei
delinquenti potenziali, da trattare nei dovuti modi.
Non sono i giudici a poter rendere l’Italia un Paese migliore.
Assistiamo a un rapporto tra i poteri ormai molto diverso da quello stabilito
dalla nostra Costituzione, scrive Giovanni Belardelli il 27 dicembre 2016 su "Il
Corriere della Sera". Le notizie degli ultimi giorni e settimane (le indagini
sul ministro Lotti, quelle milanesi sul sindaco Sala, quelle romane su Marra e
Muraro e presto — potrebbe essere — sulla stessa Virginia Raggi) confermano che
ci troviamo di fronte a un’alterazione stabile, per certi aspetti definitiva,
nei rapporti tra politica e giustizia. Dunque questa alterazione non era
collegata se non in piccola parte alla discesa in campo di Berlusconi — come
invece molti avevano a lungo ritenuto — visto che, anche adesso che il leader di
Forza Italia ha un ruolo certamente secondario, continua a segnare la nostra
vita collettiva. Caratterizza con ogni evidenza la vita politica, dove
assistiamo a un rapporto tra i poteri ormai molto diverso da quello stabilito
dalla nostra carta fondamentale. Nella costituzione materiale del Paese — cioè
nell’assetto effettivo dei rapporti tra istituzioni e poteri dello Stato — è da
tempo evidente infatti che il potere legislativo e quello esecutivo sono
condizionati in modo consistente dalla magistratura nelle sue varie
giurisdizioni. Questioni che ritenevamo di stretta competenza del governo e del
Parlamento — dalla legge elettorale al sistema pensionistico, dalla chiusura di
una fabbrica alle norme della «buona scuola» — sono spesso decise da una
sentenza della Corte costituzionale o di un tribunale civile, penale,
amministrativo. Non è solo la politica ma tutta la vita sociale a risentire di
questa accresciuta presenza dell’ordine giudiziario. Negli ultimi anni gran
parte del nostro diritto di famiglia — dalle norme sulla fecondazione assistita
all’adozione del figlio del partner nelle coppie omosessuali — è stata
modificata attraverso decisioni dei tribunali. La liceità di una cura medica, la
possibilità di iscriversi all’università, i risultati di un concorso o
l’effettività di una promozione: questo e molto altro dipende ormai, come è
esperienza comune di tanti italiani, dalla sentenza di un tribunale. Non a caso
qualche tempo fa Romano Prodi ha provocatoriamente proposto l’abolizione dei Tar
e del Consiglio di Stato per favorire lo sviluppo economico, visto quanto il
continuo ricorso alla giustizia amministrativa influisce negativamente sugli
investimenti. Naturalmente occorre non dimenticare che un fenomeno del genere
caratterizza gran parte delle democrazie contemporanee. Ma forse nel nostro
Paese si presenta in modo accentuato. Anzitutto, è lo stesso apparente permanere
di una diffusa corruzione politica a sollecitare il continuo intervento delle
procure. Abbiamo poi troppe leggi, e troppo mal scritte, così da richiedere
spesso l’intervento di un magistrato per chiarire come vadano interpretate e
applicate. Ancora, abbiamo una classe politica poco capace o poco incline ad
assumersi le proprie responsabilità e ad esercitare i propri poteri: sintomatica
la vicenda delle leggi elettorali, in cui la politica chiede alla Corte
costituzionale cosa deve e può fare. Ma il progressivo assorbimento della
politica nel diritto, il condizionamento che le decisioni della magistratura
esercitano sulla vita sociale, dipendono anche da altro, in particolare da una
nuova concezione dei compiti della magistratura, soprattutto della magistratura
penale, affermatasi nel corso degli ultimi decenni. Tale concezione le assegna
come compito fondamentale non solo l’accertamento di, e la pronuncia su, singole
ipotesi di reato, bensì un generale controllo di legalità. Il magistrato,
dunque, non è tenuto a intervenire soltanto dopo aver ricevuto una notizia di
reato, ma — ha scritto Luciano Violante riassumendo (e criticando) questa
concezione — ha il compito di verificare «che la legalità non sia stata per caso
violata». In questo modo l’ordine giudiziario viene potenzialmente investito —
anche grazie al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, che nei fatti
estende la discrezionalità della magistratura inquirente — di una funzione di
supervisione sul complesso della vita politica e amministrativa. Bisogna dire
che in questo la magistratura è stata fortemente sollecitata da una domanda
proveniente dall’opinione pubblica, sempre più disgustata dalle cattive prove
offerte dalla classe politica. È nata così, da questo doppio movimento, l’idea
secondo cui la magistratura stessa sarebbe la grande tutrice della vita
collettiva del Paese, il soggetto che dovrebbe renderlo migliore sotto il
profilo dell’onestà e della moralità. Ma, a un quarto di secolo da Mani Pulite,
i continui casi di corruzione politica, le continue testimonianze di scarso
rispetto delle leggi in una parte significativa della società italiana, ci
dicono che non possono essere i giudici a rendere un Paese migliore.
De Giovanni: «La politica distrutta dall’invadenza delle
magistrature», scrive Errico Novi il 22 Dicembre 2016
su "Il Dubbio". L’analisi del filosofo sul vuoto della democrazia e il
predominio del potere giudiziario. Si può comprendere il mondo e ammettere di
non riuscirci. Può farlo solo un grande filosofo. Biagio De Giovanni ha dalla
sua non solo il pregio di entrare nella definizione, ma anche la luce di
ottantacinque anni, compiuti ieri e segnati in gran parte dalla riflessione
rigorosa e appassionata nello stesso tempo. Ne regala una sulla giustizia, e più
precisamente sulla perdita di ogni equilibrio tra i poteri, la politica da una
parte, «le Corti, le Alte Corti innanzitutto» dall’altra. Un intervento
sul Mattino di sabato scorso mette in fila in un sol colpo l’urgenza di superare
l’obbligatorietà dell’azione penale, l’ineludibilità della separazione delle
carriere, l’impossibilità di contrastare il «populismo giustizialista». Il caso
vuole che siano anche le battaglie in cui s’impegna con tutte le forze da anni
l’avvocatura. Il professore di Dottrine politiche, ex europarlamentare del Pci e
oggi appunto editorialista di Mattino e Corriere della Sera, individua nella
«invadenza della giurisdizione» un fenomeno caratteristico della crisi e una
concausa della perdita di autorevolezza delle élites. Nel giorno in cui compie
ottantacinque anni, è facile chiedere a un filosofo come De Giovanni di fingere
la resa di fronte al caos, per trovare molte risposte.
Anche la magistratura può temere una perdita di consenso? E
dietro il ritorno a una invadenza della giurisdizione nei confronti della
politica si nasconde anche un timore, tra i magistrati, di perdere popolarità?
«In prima battuta mi sentirei di
respingere l’ipotesi. C’è sfiducia, scetticismo, disincanto e rifiuto in una
forma così violenta nei confronti delle élites politiche che non si riesce a
scorgere qualcosa di analogo che riguardi la magistratura. E anzi l’impressione
è che mai come adesso l’azione dei magistrati si dispieghi a tutto campo, dalla
frittura di pesce a fatti più consistenti. È un’invadenza che non ha precedenti,
e che certo si inserisce in un processo iniziato con Mani pulite, passaggio che
ha alterato la fisionomia stessa del rapporto tra poteri».
Capita però che alcune sentenze non soddisfino appieno l’attesa
alimentata dal “populismo giustizialista”: a Roma una condanna a 20 anni anziché
all’ergastolo, per un omicidio, ha scatenato un putiferio in aula, solo qualche
giorno fa.
«I casi estremi si verificano. Resta
fermo un punto: sono le cosiddette élites politiche dominanti ad essere travolte
da quella tendenza del senso comune che faticosamente continuiamo a individuare
come populismo giustizialista. Renzi era leader da appena 3 anni eppure, come ho
detto dopo l’esito del referendum, è stato interpretato come nuova casta. La
vecchia, per converso, è diventata vergine, da De Mita a D’Alema. Ma c’è
qualcosa di vero anche nel dissolversi della fiducia nei magistrati: oggi
persino il giudizio penale si muove nell’incertezza della decisione. Prima si
condanna, poi si assolve, sembra divenuta impalpabile persino la certezza del
diritto. Anche questo canone delle vecchie società è crollato».
Non esiste insomma un potere che regga, in questa
destrutturazione.
«È possibile che la sfiducia nella
magistratura ci sia in una forma più indiretta. Il dispregio verso l’élite
politica resta però l’aspetto decisivo del nuovo ordine mondiale, chiamiamolo
così, che si va delineando. Una tenuta si registra forse in Germania dove il
sistema ha una forza formidabile, ma persino negli Stati Uniti capita che
Hillary, ritenuta espressione dell’establishment, ceda a Trump, che non è
nessuno, un uomo d’affari, eppure 60 milioni di persone nel Paese più potente al
mondo l’hanno votato».
Si delegittima la politica: ma così il potere scivola nelle mani
di altri soggetti, le élites finanziarie per esempio.
«Non c’è dubbio. Nel 2008 abbiamo
assistito a una prima grande crisi della globalizzazione, di natura finanziaria,
ora siamo nel pieno di nuova crisi, politica. E una fenomenologia di questa fase
è l’invadenza delle giurisdizioni».
Qual è il meccanismo preciso che spalanca le porte a questa
invadenza?
«Nessuno è in grado di governare la
complessità del mondo ed emergono poteri indiretti, non legittimati.
Nell’intervento apparso la settimana scorsa sul Mattino segnalo anche il
predominio delle Alte Corti sui Parlamenti. Che può sembrare un grande fatto di
civiltà, e in parte lo è: ma se una Corte costituzionale prevarica il potere
legislativo, si arriva alla distruzione dell’autonomia della politica».
Lei sostiene che si tratta di un pericolo sottovalutato.
«Siamo su un crinale che visto nel suo
insieme deve necessariamente preoccupare, e molto. Nello specifico si tratta di
un tema delicatissimo, di cui si parla con frequenza nel resto d’Europa ma non
in Italia, per timore che il solo accenno possa fraintendersi come volontà di
intaccare le prerogative della Corte costituzionale».
La causa decisiva di questo squilibrio è nella perdita di
autorevolezza della politica?
«Sicuramente, e temo si tratti di uno
squilibrio non rimediabile a breve».
Perché?
«La delegittimazione della politica
innesca un circolo vizioso che peggiora la qualità della classe dirigente e
induce ulteriore delegittimazione. È veramente difficile che ora come ora una
persona di spessore si impegni in un ruolo politico o amministrativo, sapendo
che al primo stormir di foglie l’obbligatorietà dell’azione penale entra in
campo, e arrivano i pm, e arriva la Guardia di finanza… Non è che voglio
sottovalutare il grado di degenerazione corruttiva che c’è in Italia, non è
questo il punto, ma se i pm oltrepassano ogni confine, mi domando chi ancora
possa decidere di mettersi in politica, se non un disperato in cerca di lavoro,
per non dire di peggio. Chi è che si va a impegnare in un’attività
amministrativa, in condizioni simili? È un pasticcio gigantesco, siamo di fronte
a un caos difficile da descrivere, figurarsi a volerlo dominare».
Non è che i cosiddetti privilegi della casta, dai vitalizi alle
immunità, sono in fondo garanzie a tutela di chi nel dedicarsi alla politica
mette a rischio il proprio ruolo sociale?
«Non c’è dubbio che sia così. E
aggiungo: nel Parlamento di oggi c’è ben poco che corrisponda alla condizione di
un’assemblea elettiva nazionale, i deputati sono cani sciolti, non sopravvive
più alcuna struttura mediana che garantisca l’effettiva espressione della
sovranità popolare. E a proposito di garanzie, fino ai primi anni Novanta era
necessario ricorressero condizioni davvero molto particolari perché un’assemblea
parlamentare potesse perdere un proprio componente. Il che non aveva a che
vedere con un privilegio abusivamente autoassegnato da una casta di impostori,
ma con il fatto appunto che il Parlamento è espressione del popolo sovrano, e in
quanto tale la sua collocazione è sacra, va tutelata, fino a un certo limite che
sia in armonia con lo Stato di diritto. Ma sfido a dire che le norme
sull’immunità non lo fossero».
Lei ha scritto: “La politica diventa qualcosa in cui si
preferisce non immischiarsi, sempre più abbandonata dai migliori”. Oltre
all’invadenza della giurisdizione, c’entra anche la retorica anti- casta?
«È un’ulteriore elemento che mette in
discussione la qualità della classe dirigente. Intendiamoci: il fenomeno di cui
parliamo non esiste solo in Italia, segna l’intero Occidente, come ricordato a
proposito di Trump, anche se da noi assume un carattere di gravità eccezionale.
Il tratto generale della crisi delle élites politiche, che si vede non solo in
Italia, è nell’impossibilità di cogliere un punto di mediazione tra globalismo
sovranazionale, cosmopolita, da una parte, e le appartenenze, le identità,
dall’altra».
In che modo questo spaesamento ci porta alla crisi della
rappresentanza?
«Innanzitutto è in questo vuoto che si
accresce il peso di poteri diversi, da quello finanziario al potere giudiziario.
Ma la risposta in sintesi è nel caso a noi più vicino: l’Europa si è dimostrata
incapace di governare la complessità della crisi finanziaria e politica che si è
affacciata nel 2008. Noi non possiamo limitarci a descrivere con tono disgustato
i critici delle élites, dobbiamo anche criticare le élites stesse. Non possiamo
ignorare cioè le ragioni del cosiddetto populismo, lo scollamento complessivo
tra governanti e governati. Non è che tutto sia riducibile alla cattiveria o
alla superficialità di chi alimenta la propaganda antisistema: è impossibile
negare il fatto che non ci sia una cultura politica in grado di governare la
complessità di questa crisi».
Il che non è un giudizio opinabile: è un fatto.
«Be’, abbiamo davanti un’intera
generazione distrutta. E appunto non è che si può risolvere tutto con il dito
puntato contro i populisti brutti, sporchi, cattivi e urlanti. Dentro quel buio
ci sono delle ragioni, non è che nasce dal nulla. Nasce dal fatto che nessuno,
tantomeno le élites, riesce a trovare le passerelle di passaggio dallo Stato
nazionale alla dimensione sovranazionale».
Lei sul Mattino individua l’urgenza di una riforma della
giustizia, e precisamente due passaggi: superamento dell’obbligatorietà
dell’azione penale e separazione delle carriere. La prima delle due questioni
non sarebbe perfetta, come terreno di incontro tra politica e magistratura per
una riforma, diciamo, concordata dell’ordinamento giudiziario?
«E sì che lo sarebbe, naturalmente, ma
abbia pazienza: davvero possiamo pensare che ci sia una politica così autorevole
da poter sollevare il tema dell’obbligatorietà dell’azione penale? Prendiamo ad
esempio il governo appena sconfitto dal referendum, che pure qualcosa provava a
farlo, ma che proprio sulla giustizia non è riuscito a muovere alcuna delle
questioni decisive di cui parliamo. Penso al ministro, Andrea Orlando, a questo
giovane pure così dinamico, che è riuscito a fare dei passi significativi su un
tema difficile come il carcere: ecco, come mai anche lui su punti come
obbligatorietà dell’azione penale e separazione delle carriere non ha detto
niente per tre anni?»
Ha detto, per essere precisi, che non c’erano assolutamente le
condizioni minime perché si potesse anche solo discutere di temi del genere.
«Appunto: alludeva evidentemente al
fatto che se ci avesse provato avrebbero subito detto ‘ecco gli amici dei
corrotti stanno provando a derubricare l’obbligatorietà dell’azione penale’. Non
è che si sarebbe riconosciuta la necessità di razionalizzare l’arbitrio».
Non c’è margine di discussione, nel senso comune si è diffuso un
riflesso condizionato che stronca in radice ogni tentativo su questo fronte.
«Nessuno vuol negare il rischio che
superare l’obbligatorietà schiuda il rischio di un controllo della giurisdizione
da parte dell’esecutivo, come avviene in Francia: eppure deve esserci una diga
al potere assoluto dei pubblici ministeri. Qui a Napoli è girata la notizia di
una misura chiesta dalla Procura, e negata dal gip, in cui l’accusa di
corruzione si basava sul fatto che l’indagato offrisse spesso alla controparte
caffè e cappuccini».
Considerare corruttivo il pagamento di un caffè a Napoli è
oggettivamente una bestemmia, senza dover scomodare Luciano De Crescenzo.
«Nel ridicolo farsa e tragedia si
mescolano sempre».
Figurarsi se esiste un margine per discutere di separazione delle
carriere.
«Non c’è possibilità. Dovremmo trovarci
con una classe dirigente politica talmente autorevole, dotata di una tale
legittimazione da essere in grado di sfidare anche l’ordalia che verrebbe
inevitabilmente scatenata dall’Associazione nazionale magistrati. La quale
arriverebbe a forme di contestazione estrema, allo sciopero, iniziative gravi
che un ordine giudiziario non si dovrebbe consentire. Ecco, possiamo dire che
quando ci troveremo con una classe politica in grado di inoltrarsi su un terreno
così accidentato allora potremo dire di essere usciti dalla crisi».
Sangermano: «Noi giudici non siamo maestri di morale», scrive Errico Novi il 24
Dicembre 2016 su "Il Dubbio". «No alla supplenza della magistratura:
comprometterebbe la legittimazione del sistema”. Un magistrato sa di non avere
strumenti per rimediare alla «debolezza della politica», come la definisce il
dottor Antonio Sangermano. Sa di non potersi neppure sostituire al legislatore.
Eppure il componente del direttivo Anm e sostituto procuratore a Prato – casa
sua e destinazione gradita dopo gli anni a Milano in cui tra l’altro è stato pm
al processo Ruby – prova a «proporre una riflessione anche su quello che è
inevitabilmente il tema del giorno, l’immigrazione, e su una misura dolorosa,
innanzitutto da punto di vista morale e religioso: arrivare a espulsioni
immediatamente efficaci per gli immigrati che hanno commesso reati sul
territorio nazionale. Lungi dal pretendere di indicare un dispositivo di legge:
è una riflessione, punto». Certo un’analisi, per Sangermano, è doverosa anche a
proposito della perdita di consenso sofferta dalla politica, che non si risolve
con una supplenza da parte dell’ordine giudiziario. E anzi, «se la magistratura
si sostituisse alla politica farebbe un danno innanzitutto a se stessa».
Partiamo da qui allora: mai come adesso la politica è al fondo
dell’indice di gradimento, e voi magistrati vi rendete conto ancora meglio,
forse, che non potete sostituirla: è così?
«Credo che la magistratura non debba
fare da supplente, vorrei chiarirlo subito. Il magistrato ha interesse a che la
politica sia forte e autorevole e nello stesso tempo rispetti l’autonomia e
indipendenza dei giudici. Se assumiamo un ruolo di supplenti, indeboliamo lo
stesso ordine giudiziario».
Perché, esattamente?
«Una supplenza dei magistrati certifica
il fallimento dello Stato, attribuisce loro un funzione in assenza di
legittimazione democratica. Anche se processi del genere non si attivano per
volontà espansiva, rappresentano comunque una delegittimazione del sistema: la
magistratura è un potere dello Stato, si fortifica quanto più solida è la
legittimazione del sistema nel suo complesso».
D’accordo, ma allora Mani pulite come si colloca in questa sua
condivisibilissima analisi?
«Premessa: considero Mani pulite un
momento di riscatto nazionale al pari del Risorgimento e della Resistenza, in
ufficio ho la foto del Pool. Il punto è che se un potere viene meno ai suoi
compiti, se nello specifico è un’intera classe politica a venir meno, la
magistratura deve fare il proprio dovere. In un caso come quello di Mani pulite
può verificarsi che la notevole quantità degli illeciti faccia apparire l’azione
giudiziaria come il processo a un fenomeno. Ma è solo la diffusività del
fenomeno a creare la percezione. D’altronde gli effetti che ne derivano tornano
a un certo punto nel do- minio della politica, come avvenne dopo il ’ 92-’ 93,
quando il vuoto creatosi favorì l’affermarsi di nuovi soggetti come il partito
di Berlusconi».
Senza volerla indurre a sostituirsi al legislatore, il tema
dell’immigrazione va affrontato semplicemente con una rigorosa distinzione tra
chi ha diritto all’asilo e i migranti economici?
«No, temo di no. Che l’accoglienza sia
la soluzione più consentanea ai principi di moralità ed etica non c’è dubbio.
Sono contrario ai respingimenti in mare: ma l’aspirazione etica va coniugata con
i dati di realtà, il che vuol dire riconoscere che un’accoglienza indiscriminata
crea un’effettiva insicurezza sociale».
E qual è il punto di equilibrio?
«L’integrazione deve coniugarsi a dei
doveri, il primo dei quali è il rispetto della legalità. Ora, se prendiamo i
curricula di chi in questi mesi si è reso responsabile di stragi in Paesi
europei, sarà difficile trovarne uno che non abbia precedenti per reati commessi
in quegli stessi Paesi o in altri del Vecchio Continente. Ecco perché dovremmo
riflettere sull’opportunità di rendere obbligatoria e non più facoltativa
l’espulsione di chi commette reati sul territorio nazionale».
Si dovrebbe attendere la condanna definitiva?
«No, d’altronde la norma vigente già
prevede la possibilità di espellere all’esito di un primo accertamento del
reato. Va fatta attenzione a possibili profili di incostituzionalità o di
incompatibilità con il diritto europeo. E so che l’obbligatorietà e
l’effettività manu militari delle espulsioni va ad impattare con aspetti
delicatissimi come i ricongiungimenti familiari. Ma credo si debba riservare una
particolare attenzione al profilo della sicurezza. Non v’è dubbio che il
legislatore dovrebbe trovare una forma normativa il più possibile umanizzata.
Così come si dovrebbe tener conto del fatto che non c’è solo il terrorismo, ma
anche il caso di chi reitera sul territorio nazionale reati di altra natura».
Le espulsioni pongono il problema dei Paesi d’origine, spesso
poco collaborativi, in materia.
«Però ad esempio il Paese d’origine di
Anis Amri, la Tunisia, se li riprende».
Da componente del direttivo Anm, condivide le critiche aspre
rivolte dal vostro presidente Davigo ai partiti, responsabili a suo giudizio di
non allontanare subito chi è accusato di corruzione?
«Ho un grande rispetto per il
presidente Davigo. È una persona di rara cultura e di garbo esemplare, ma non
concordo con lui su tutto. La politica ha il dovere di vigilare al proprio
interno e ha senso ricordarlo, ma senza che questo appaia come una sorta di
monito morale. A noi spetta accertare i reati. Possiamo suggerire soluzioni ma
senza che sembrino la scure di Danton».
Certo Davigo ha grande visibilità: potrebbe convenire all’Anm
prorogare la sua presidenza?
«Credo che Davigo sia un ottimo
presidente. E che la sua visibilità mediatica giovi all’intera magistratura,
perché consente di far affiorare giuste rivendicazioni. Nel corso di quest’anno
abbiamo ottenuto risultati, e mi lasci dire che questo credo dipenda anche
dall’impegno della mia componente, Unicost, servito a smussare posizioni
talvolta non condivisibili. Davigo ha avuto grande intelligenza politica
nell’incontro con Renzi di fine ottobre: credo che nella misura in cui saprà
portare a sintesi le diverse anime dell’Anm sarà un ottimo presidente, non lo
sarà se prevalesse un’inclinazione al protagonismo».
Ma potrà restare presidente anche oltre aprile?
«L’accordo fissa quella scadenza e non
penso che lui abbia intenzione di andare oltre, ha già pubblicamente dichiarato
di non vedere l’ora di concludere il mandato».
È vero che molti giudici si lamentano dei criteri seguiti dal Csm
nell’assegnare gli incarichi, e che sarebbe necessario chiarirli?
«Guardi, in questa consiliatura
l’organo di autogoverno ha predisposto un testo unico che definisce le regole
per l’attribuzione di direttivi e semidirettivi: la trovo una conquista storica.
In precedenza la progressione di carriera avveniva per mera assenza di demerito,
si è stabilito che invece deve basarsi sul merito. È il Csm che ha titolo a fare
le valutazioni: poi certo, il testo unico deve completare una fase di rodaggio,
ma al Consiglio superiore si deve dare atto della scelta innovativa. E
personalmente credo che non si dovrebbe mai delegittimare il Csm: in questi anni
ha assicurato davvero l’autonomia e l’indipendenza di noi magistrati».
Piercamillo Davigo: «A 25 anni da Mani Pulite, l’Italia è
ancora più corrotta». Il leader dell’Anm: il codice
penale è uno spaventapasseri, in cella vanno solo gli sciocchi. «Il giudice è
messo nella condizione di dover scegliere tra rispettare la legge rinunciando a
fare giustizia o tentare di fare giustizia forzando la legge», scrive Giuseppe
Guastella il 12 febbraio 2017 su “Il Corriere della Sera”. Il presidente
dell’Associazione nazionale magistrati, Piercamillo Davigo (foto sopra), ha
partecipato ad un forum al Corriere della Sera con il vice direttore Giampaolo
Tucci e con i giornalisti Marco Ascione, Giovanni Bianconi, Luigi Ferrarella,
Mario Gerevini, Giuseppe Guastella e Fiorenza Sarzanini. Argomento del
dibattito, che si è svolto nella redazione di via Solferino a Milano, il pianeta
giustizia a 25 anni dall’inizio dell’inchiesta Mani pulite e in occasione
dell’uscita del libro «Il sistema della corruzione» (Editori Laterza) scritto
dall’ex pm del pool Mani pulite, ora presidente di sezione in Cassazione.
A 25 anni da Mani pulite, in Italia è cambiato poco o nulla?
«È drammatico quanto poco sia cambiata la situazione e quanto sulla corruzione
peggiori la deriva dell’Italia nel panorama internazionale».
Un Paese corrotto?
«A livelli diversi, finalità e modalità diverse. È un Paese che sta morendo. C’è
sfiducia, la gente non va più a votare, espatria».
Ci vuole una rivoluzione culturale?
«Bisogna cominciare dalla scuola».
Migliore l’Italia degli anni di Mani pulite?
«L’effetto domino non fu innescato da un sussulto di coscienza civile, ma dal
fatto che erano finiti i soldi».
Lei sostiene che per la corruzione ci vorrebbe un doppio binario,
come per la mafia.
«Bisognerebbe introdurre alcune delle norme che valgono per i mafiosi».
Ad esempio?
«Un sistema premiale forte e serio e le operazioni sotto copertura».
La corruzione spesso è alimentata da fondi neri esteri, sempre
più difficili da aggredire.
«È un problema internazionale. L’assistenza giudiziaria internazionale è un
relitto ottocentesco che richiede tempi talmente lunghi, incompatibili con la
durata di un processo».
Corruzione «Simonia secolarizzata». Cioè?
«Nella Chiesa c’è il sacerdote che vende cose sacre, nello stato c’è il
funzionario pubblico che vende le cose che per lui dovrebbero essere sacre,
perché ha giurato fedeltà alla Repubblica».
Il pool Mani pulite ha fatto errori?
«Secondo me, no. Ha fatto quello che poteva. Se non ci avessero cambiato le
leggi a partita in corso, saremmo andati avanti. Molte leggi possono avere su il
nome dell’imputato».
Forse fino a un’epoca determinata.
«Sì, poi è cambiata la maggioranza e da allora le fanno più sofisticate. Ad
esempio, la legge Severino non contrasta la corruzione ma è stata gabellata per
una legge che la contrasta».
Monti, il premier di allora, non era sospettabile di essere
vicino ai corrotti.
«Quella legge l’ha fatta il Parlamento. Ricordo che il ministro della Giustizia
rispose alle obiezioni: “Era il massimo che si potesse fare in quel momento con
quelle Camere”».
I vostri rappresentanti dissero che era una buona legge, come nel
caso di quella sull’autoriciclaggio. C’è anche un problema vostro?
«Certo che c’è anche un problema della magistratura, ma cerchiamo di capirci,
gioca anche molto il modo di fare leggi dovuto all’incompetenza della pubblica
amministrazione che, purtroppo, non è più quella di cento fa, fatta di
funzionari competenti e con il senso dello Stato. Quando ho incontrato la prima
volta il ministro Orlando, gli ho fatto presente che la depenalizzazione che
avevano fatto non serviva a niente perché toglieva solo le briciole ma alcuni
reati depenalizzati avevano l’effetto non di ridurre il carico di lavoro, ma di
aumentarlo. Mi rispose che l’Anm aveva dato parere favorevole, io gli dissi che
non sarebbe accaduto più perché avevamo costituito delle commissioni interne».
Ha un giudizio molto negativo sui politici.
«Ce ne sono anche perbene, ma i meccanismi talvolta favoriscono il malaffare».
Cosa ne pensa di chi, come i 5 Stelle, ha introdotto codici
interni legati alle inchieste?
«La politica non deve agganciarsi ad atti formali nel giudizio, ma a una
valutazione autonoma dei fatti. Si può cacciare uno che è innocente o tenerlo se
è colpevole. Sono due valutazione diverse, una è politica, l’altra di
giustizia».
Non si introduce così un’inversione del principio di non
colpevolezza?
«Non è così. Molte volte non c’è bisogno di aspettare la sentenza per far
scattare la responsabilità politica, ma in questo Paese non avviene mai, neanche
di fronte ai casi evidenti».
Prendiamo il caso di Roma e della sindaca Raggi, è un caso
controverso.
«Premesso che non parlo dei procedimenti in corso, in qualche caso la politica
può dire “aspetto di vedere come va finire” o “mi sono fatto un’idea”, ma non
può dire sempre “aspettiamo le sentenze”. Significa caricare sulla decisione del
giudice la selezione della classe politica».
I politici dovrebbero darsi codici di comportamento?
«Secondo me sì. Basta anche il buonsenso».
Non c’è il rischio di finire nel moralismo?
«Se mi mandano in udienza con un collega che si è saputo che ruba, io non vado
perché chi ci vede pensa che siamo uguali. Io non rubo».
L’Anm accoglie pm e giudici. Non le sembra forte dire che il
codice di procedura penale è fatto per farla fare franca ai farabutti?
«Il nostro giudice è vincolato da un sistema di inutilizzabilità sconfortante
perché una prova acquisita, valida nei confronti di un imputato, diventa
inutilizzabile per un altro se è stata acquisita a termini delle indagini
preliminari scaduti. Il giudice è messo nella condizione di dover scegliere tra
rispettare la legge rinunciando a fare giustizia o tentare di fare giustizia
forzando la legge. È inaccettabile. E allora è normale che uno venga arrestato e
poi assolto. Se non volevano questo non dovevano scrive il codice così, oppure
dovevano dirci di non arrestare più».
Riporta una frase del generale Dalla Chiesa che diceva: che c’è
chi parla di manette facili e chi di ingiustizia che assolve. Ingiustizia?
«L’ingiustizia può essere nella legge oltre che negli uomini, se la legge è
contraria al senso comune di giustizia, e molte delle norme che applichiamo lo
sono. Ora la minaccia del carcere non è credibile perché il codice penale è uno
spaventapasseri, da lontano fa paura, quando ci si avvicina appare innocuo. In
galera ci va chi è così sciocco da farsi arrestare in flagranza e gli
appartenenti alla criminalità organizzata. Gli altri in media ci vanno di meno».
Lei è un giudice, un suo imputato potrebbe avere difficoltà
leggendo: «Ne prendiamo pochi e quando li prendiamo vengono condannati a pene
esigue che non vengono fatte scontare».
«Nel nostro sistema il rispetto delle regole formali, che il più delle volte non
hanno nessuna utilità, vanifica la ricostruzione storica dei fatti. A un certo
punto ho lasciato la Procura per fare il giudice in appello, volevo capire come
mai le sentenze venissero quasi sempre riformate. Ho visto che era vero quello
che mi aveva insegnato un anziano magistrato che diceva che i giudici del
tribunale sono come i padri, severi quando è necessario, quelli della Corte
d’appello come i nonni, di regola rovinano i nipoti. Dato che su cento ricorsi
in appello, 98 sono degli imputati condannati, si cominciano a vedere i problemi
solo con una certa ottica e spesso è impossibile resistere alla tentazione di
ridurre le pene. Bisognerebbe cambiare anche l’appello».
Solo carcere? E l’esecuzione esterna?
«Dipende dai reati e dal tipo degli imputati».
E stato mai tentato di forzare le regole?
«No. Le ho sempre rispettate, e anche quando ero convinto che l’imputato fosse
colpevole l’ho assolto se la prova era inutilizzabile, pensando che era un
mascalzone che l’aveva fatta franca».
Un sistema che protegge l’impunità?
«In un sistema ben ordinato, un innocente non deve essere assolto, non deve
neppure andare a giudizio perché per lui il processo è una tragedia. I filtri
dovrebbero essere all’inizio».
Qual è la priorità?
«La depenalizzazione. Il problema della giustizia è il numero dei processi. O
abbiamo il coraggio di dire che va drasticamente ridotto o non se ne uscirà mai.
Nel penale basta intervenire con una massiccia depenalizzazione e introdurre
meccanismi di deterrenza delle impugnazioni, quelli che ci sono, sono risibili».
La politica invece va su una strada diversa e introduce nuovi
reati come l’omicidio stradale.
«Cose prive di senso. Per l’omicidio stradale la pena è talmente alta che tra un
po’ a qualcuno converrà dire che voleva ammazzare per rispondere di omicidio
volontario».
Che ne dice dei suoi colleghi dell’Anm dell’Emilia Romagna dopo
il comunicato sulla decisione del Tribunale del riesame?
«Non lo conosco, non posso sapere tutto».
È stata trovata la decisione di un collegio prima dell’udienza.
L’Anm locale ha detto che poi altri giudici hanno confermato la decisione dei
primi che si erano astenuti...
«Bisogna distinguere l’ipocrisia dal malcostume. Un giudice diligente non
potendo ricordare a memoria decine di processi al giorno, si appunta lo studio
che fa. L’ho sempre fatto, ma non firmo gli appunti e non li metto nel
fascicolo».
E allora, a cosa serve la discussione?
«Si può cambiare la decisione».
Lei lo fa?
«Quando un avvocato dice cose che non avevo notato, raro, o che mi convincono,
cambio opinione perché solo gli imbecilli non lo fanno».
Trump, il giudice e Davigo a piede libero,
scrive Alessandro Sallusti, Domenica 05/02/2017, su "Il Giornale". Un giudice
americano, James Robart, ha annullato il decreto di Donald Trump che blocca
l'ingresso negli Stati Uniti di cittadini provenienti da sette Paesi sospettati
di complicità con il terrorismo islamico. È il primo braccio di ferro tra il
potere giudiziario e il neopresidente che non demorde e parla di «decisione
ridicola di un cosiddetto giudice che sarà presto ribaltata». Come andrà a
finire lo vedremo, ma è comunque bello vedere che il detentore del potere
esecutivo non si faccia intimorire e alzi la voce di fronte allo sconfinamento
del potere giudiziario, che le leggi le deve applicare e non contestare,
quest'ultimo compito - nei sistemi democratici - spetta al Parlamento e alla
Corte costituzionale. La sindrome di onnipotenza dei magistrati è purtroppo cosa
a noi nota. La differenza con quello che sta succedendo in America è che dalle
nostre parti nessuno osa contrastarla a dovere. La politica si è arresa ed è di
fatto commissariata dalle toghe. Non dico un Trump, ma mi sarei aspettato, per
esempio, un sussulto di fronte alle parole pronunciate l'altra sera a Porta a
Porta da Piercamillo Davigo, noto manettaro di Mani pulite e oggi presidente
dell'Associazione nazionale magistrati. Di fronte a un allibito Bruno Vespa, ha
sostenuto che un imputato assolto non è un innocente ma solo un colpevole che
l'ha fatta franca e che gli errori giudiziari non sono colpa dei giudici ma
degli inquirenti, cioè polizia e carabinieri, che non sanno fare il loro lavoro
e che «estorcono false confessioni con la forza e a volte la tortura». Detto
alla Marchese del Grillo: «Noi siamo noi e tutti voi non siete un cazzo». C'è
chi si chiede: chi ci difenderà da Trump? Io sono molto più preoccupato perché
non vedo nessuno che difenda noi e la democrazia da Piercamillo Davigo. Pensavo
che finita la trasmissione fosse caricato su una ambulanza e sottoposto a un
trattamento sanitario obbligatorio. Mi dicono invece che l'uomo è a piede libero
e che continua a fare il capo dei magistrati, senza che nessuno abbia da
eccepire. Forse è proprio vero che i colpevoli a volte la fanno franca, Davigo
ne è la prova. E siccome nessuno ha il coraggio di dirglielo, ci provo io: si
vergogni, signor presidente, e comunque si ricordi che «noi siamo noi» e il
«nessuno» è lei.
Gli avvocati in rivolta contro Davigo (Anm): "Democrazia in
pericolo". Appello dell'Associazione Italiana Giovani
Avvocati alle istituzioni: stop alla deriva giustizialista, scrive Orlando
Sacchelli, Giovedì 09/02/2017, su "Il Giornale". Nel corso degli anni
Piercamillo Davigo ha rilasciato alcune dichiarazioni che denotano il suo modo
di concepire la giustizia. Vediamone alcune: «Non esistono innocenti, ma solo
colpevoli non ancora scoperti»; «Se la giustizia perde di severità ed efficienza
è a causa dell'elevato numero di avvocati»; «L'errore giudiziario non esiste:
sono i testimoni che, mentendo, traggono in inganno il giudice. Il giudice non
sbaglia»; «Non esistono nemmeno le ingiuste detenzioni: la colpa è del nostro
ordinamento che non consente l'utilizzabilità nel dibattimento delle
dichiarazioni assunte nella fase delle indagini preliminari». Ovviamente
ciascuna frase va contestualizzata, perché estrapolata dal discorso in cui è
stata pronunciata può avere un significato diverso da quello voluto. Però, si
sa, le parole pesano. Specie se a pronunciarle è un magistrato. E il crescente
attivismo mediatico di Davigo, in qualità di presidente dell'Associazione
nazionale magistrati, non poteva di certo passare inosservato. E infatti provoca
le proteste dei legali, controparti naturali dei pubblici ministeri. «Il
crescendo delle esternazioni del dottor Davigo - dichiara l'avvocato Michele
Vaira, presidente dell'Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) -
inizialmente derubricate dalla maggior parte degli osservatori a mere
provocazioni retoriche di un singolo, sebbene autorevole, esponente della
magistratura, comincia a preoccupare». Cerchiamo di capirne di più. «Rese in
rappresentanza del 90% dei magistrati italiani osserva Vaira - mettono in
discussione non solo i principali punti fermi segnati in secoli di progresso
giuridico, ma le stesse fondamenta della nostra architettura costituzionale e
delle più importanti convenzioni internazionali». In altre parole sono a rischio
«la presunzione di innocenza, il diritto di (e alla) difesa e il contraddittorio
nella formazione della prova». Preoccupa inoltre un altro aspetto. «Da quando
Davigo ha assunto la presidenza dell'Anm denuncia Vaira - non una voce di
dissenso si è levata da parte di alcuna componente dell'ordinamento
giudiziario». Vuol dire che le tesi di Davigo coincidono con la visione che la
magistratura italiana ha del processo e dei diritti fondamentali della persona?
«Se così fosse - puntualizza il presidente dell'Aiga - saremmo in presenza di
una vera e propria emergenza democratica». Una cosa è certa: le affermazioni di
Davigo suscitano quasi sempre un notevole clamore mediatico, alimentato dalla
forte esposizione del presidente di Anm sugli organi di stampa. Ciò per Vaira
comporta un rischio enorme: «Che le stesse contribuiscano a formare un'opinione
pubblica insensibile al rispetto dei fondamentali diritti della persona umana».
E visto che Davigo ricopre anche la carica di presidente di sezione della Corte
di cassazione, osserva Vaira, ciò «contribuisce ad aumentare lo sconcerto e la
preoccupazione per le sue argomentazioni». Il quadro è indubbiamente allarmante.
I giovani avvocati sollecitano le massime istituzioni politiche (nella persona
del ministro della Giustizia), giudiziarie (il vice presidente del Csm) e
forensi (presidente del Consiglio nazionale forense) ad una «immediata ed
inequivoca presa di posizione, con l'obiettivo di porre un argine (prima di
tutto culturale) alla deriva giustizialista insita nella teorizzazione da parte
del presidente dell'Anm di principi in contrasto con la Convenzione europea dei
diritti dell'uomo e con la Costituzione della Repubblica italiana». Le
istituzioni chiamate in causa dai giovani avvocati interverranno, in qualche
modo, per rispondere a questa grave denuncia?
Quando Beppe Grillo creò la politica del vaffa: l'intervista del
1992 è il suo vero manifesto. I partiti? Nuovi o
vecchi, fanno schifo. La gente? Stordita dalla tv. La satira? Non serve a nulla.
In questo colloquio con l'Espresso allo scoppio di Tangentopoli, il comico
enunciava la sua teoria sull'efficacia del fanculare politici e gente comune.
Una testimonianza che letta oggi assume un sapore tutto diverso, scrive Roberto
Gatti il 16 febbraio 2017 su “L’Espresso”. Lo spettacolo è appena terminato,
e Beppe Grillo, madido di sudore, elegantissimo nel suo doppiopetto Armani
«identico a quello di Michele Santoro, ma io sono di famiglia ricca» - se ne sta
in piedi nel suo camerino piccolissimo e affollatissimo, a bere acqua minerale e
a esternare in totale libertà. È un Grillo furioso, quello che ci si para
davanti. Ha appena finito di "fanculare" mezzo mondo, da Vittorio Sgarbi al
ministro Francesco De Lorenzo, da Licio GeIIi a Maurizio Costanzo: e ora, non
contento, se la prende con un paio di malcapitati ambientalisti, che non gli
hanno perdonato le battutine ironiche lanciate all'indirizzo di Fulco Pratesi,
l'ex presidente del Wwf Italia. Reo di aver fatto da testimoniai all'American
Express, e di aver quindi contribuito a incrementare il tasso di inquinamento
atmosferico: «Perché per ogni spesa fatta con la carta di credito ti danno in
dotazione tre foglietti di carta, che poi vengono bruciati e creano pulviscolo
atmosferico, che poi ricade in mare e viene mangiato dai pesci, che vengono poi
mangiati da noi, nei ristoranti alla moda. Come siamo intelligenti: ci mangiamo
le nostre carte di credito a 50 mila lire il chilo...». Questo Grillo furioso,
lontano le mille miglia dal comico giovialone del "Te la do io l'America", ma
anche dal Grillo rabbioso che spara dalla tv contro Bettino Craxi e Pietro
Longo, ha appena finito di fare il pieno allo Smeraldo di Milano e si appresta a
rifarlo al teatro Olimpico di Roma, dal 9 al 18 marzo prossimi. Sempre da solo,
con l'unico sostegno di un telefono amplificato e di una linea verde, con i
quali entra in contatto con mezza Italia: un po' per dialogare amabilmente con
il suo interlocutore di turno, più spesso per "fancularli" di brutto. In questo
aiutato, con enorme entusiasmo, dal pubblico presente in sala: che non vede
l'ora di urlare tutta la sua rabbia in faccia al nemico di turno. Quasi si fosse
accorto che ormai dopo la protesta urlata, dopo i graffi sanguinosi della satira
politica non resti altro che l'insulto. Grazie all'efficacia di un usatissimo
trisillabo.
La pagina dell'intervista a Grillo, sull'Espresso del 1992.
Signor Grillo, partiamo dai "fanculo" che ogni sera spara a
raffica: non le sembrano un mezzo un po' volgare per scatenare l'ilarità della
gente?
«Ma quale volgare... Volgare non sono io, che dico "figa, cazzo, culo" quando il
senso della frase lo richiede. Volgare è la Sampò, che chiama "cappuccetto" il
preservativo, e pensa così di essersi salvata la faccia: e allora io la mando
affanculo. Ancora. C'è gente che mi chiama al telefono in teatro, e ha il
cervello talmente spappolato dalla televisione che mica mi chiede come sto; mi
chiede: "sono in diretta?". E io, questa gente qua, non dovrei fancularla? Ma mi
faccia il piacere...».
Non è un po' troppo facile, però, prendersela con gli Sgarbi e
con i Ferrara, e lasciare in ombra i nemici veri, i politici corrotti, i
mafiosi, i disonesti?
«Guardi, in tanti prima sparano l'apprezzamento, dicono che sei geniale e che
hai trovato il modo giusto di comunicare con la gente; poi incominciano a
correggere il tiro, dicono che questo è troppo facile e quest'altro troppo
scontato, insomma che da te s'aspettava di più. In tanti trinciano giudizi senza
neanche venirti a vedere. Ma Io vorrei ricordare a tutti questi che non è colpa
mia se Licio Gelli o Paolo Cirino Pomicino non si fanno trovare al telefono.
Così come non è colpa mia se quella merda del mago Othelma ha deciso di
presentarsI alle elezioni con un programma che prevede l'abolizione delle
cinture di sicurezza e il ripristino della pena di morte; oppure se Maurizio
Costanzo prima dIchiara che si è iscritto alla P2 per caso, e poi fa il
testimoniai per un settimanale contro gli sprechi e contro la corruzione; oppure
se la Raffai, oltre a fare la spiona di professione, ha scritto pure un libro da
29 mila lire su quelli che scappano dalla famiglia proprio perché c'hanno quella
famiglia lì. E io tutta questa gente non dovrei fancularla? Ma la fanculo a
raffica!».
Mi tolga una curiosità: il suo fanculo odierno ricorda da vicino
il "fangala" urlato da MaIik Maluk, alias Giorgio Bracardi, nell'"Alto
gradimento" di Arbore e Boncompagni. È da lì che le è nata l'idea?
«No, perché quello era un divertentissimo motto di spirito, e invece il mio è un
autentico urlo di rabbIa. In quanto tale, sono certo che il suo antecedente sia
il "coglione" con cui, anni fa, ho apostrofato il giornalista Sandro Mayer:
perché, a "Domenica in", aveva intervistato un bambino appena liberato da un
lunghissimo rapimento. Giuro che non volevo offendere Mayer: volevo soltanto
urlare la mia rabbia, il mio disgusto, per un uso così cinico dell'intervista
giornalistica. E quando, nei giorni successivi, ho ricevuto i messaggi di
tantissima gente incazzata come me, che mi diceva che avevo fatto bene a urlare
"coglione", ho capito che quella era la strada giusta. E il fanculo di oggi ne è
la logica conseguenza».
Ma non trova un po' strano che questo urlo di rabbia sia sempre
più spesso indirizzato contro la gente comune, invece che contro i potenti?
«Lei lo trova strano? lo no. Sono stanco delle battute, sono stanco della satira
politica: non serve a nulla. Tant'è vero che Cossiga ormai non è più un uomo: è
uno spot. E dell'ex sindaco ho semplicemente detto che deve avere due palle
così, per aver sposato la sorella: di quello la. E dei socialisti non voglio più
parlare, perché quando li ho accusati di rubare hanno guadagnato il cinque per
cento dei voti: e dunque è meglio che me ne stia zitto, così magari si eliminano
da soli. E di Mario Chiesa, presidente della Baggina, ho parlato solo
all'inizio, quando sembrava che avesse rubato sette o otto milioni e il suo mi
pareva proprio un caso di disperazione esistenziale. Ed è vero che ho
ripetutamente fanculato il ministro De Lorenzo: ma non perché sia incompetente,
ma per il semplice fatto che ha accettato un ministero senza speranza come
quello della Sanità. Diciamolo chiaro: io di questa gente non voglio più
saperne. E se ogni tanto mi capita di fancularli, è solo perché voglio parlare
alla suocera perché nuora intenda».
Sarebbe a dire?
«È semplice. Il fanculamento dei politici, dei potenti, è un mero pretesto per
fanculare la gente, lei, me stesso. Perche è colpa nostra se siamo ancora
comandati da individui di questo tipo. È colpa nostra se continuiamo a farci
truffare dai pubblicitari, quelli che hanno inventato la famiglia di dementi del
Mulino Bianco: quando nei paesi più civili, per esempio in Danimarca, hanno già
fatto leggi che tutelano splendidamente i consumatori. È colpa nostra se
l'ambiente è ridotto allo schifo che sappiamo, al buco nell'ozono, alle targhe
alterne che non risolvono niente. E guardi che queste cose mica gliele dice un
ambientalista. Anzi, gli ambientalisti proprio non li reggo, perché sono gli
unici che non hanno ancora capito che il vero problema dell'umanità non è la
tutela della foca monaca: ma la riduzione del tempo di lavoro. Lavorare meno per
poter lavorare tutti. E godere di più».
E quindi secondo lei, signor Grillo, anche le prossime elezioni
serviranno a poco...
«A poco? Dica pure a nulla. Perché i partiti nuovi fanno ancora più schifo di
quelli vecchi. E perché, soprattutto, in Italia la situazione è talmente
disgregata, deteriorata, compromessa, da lasciar presagire un futuro nero. Nero
come la pece».
Pubblicata sull'Espresso dell'8 marzo 1992
Tangentopoli si fermò davanti al Pci. D'Ambrosio disse: "Mani
pulite è finita". Il pm del Pool nel '93 mi confessò:
il marcio è già emerso. Ecco perché le mazzette "rosse" non travolsero il
partito, scrive Stefano Zurlo, Sabato 18/02/2017, su "Il Giornale". A volte
modesti dettagli aiutano a capire. A volta la concatenazione precisa degli
avvenimenti può sfuggire nel frastuono generale. A maggior ragione se l'epopea
di cui parliamo è quella di Mani pulite, oggi sotto i riflettori per il
venticinquesimo compleanno. L'opinione pubblica si è divisa, anzi accapigliata,
perché il Pool non riuscì a espugnare Botteghe oscure, così come aveva travolto
il ponte di comando della Dc e del Psi. E ciascuno dei protagonisti a distanza
di tanto tempo racconta i passaggi di quella storia controversa e cerca di
spiegare perché lo squadrone di Mani pulite si arenò davanti alle mura della
cittadella rossa. Dunque, un piccolo episodio può fornire gocce di informazione
a chi vuol capire, senza teoremi e tabù. Era la primavera del 1993 e lavoravo
per l'Europeo, il settimanale di casa Rizzoli. Il direttore Myriam De Cesco mi
aveva chiesto di seguire proprio l'indagine milanese che stava squassando i
palazzi del potere. Un pomeriggio arrivai dunque a Palazzo di giustizia. Era la
prima volta o una delle primissime occasioni che avevo di entrare nel tempio
della giustizia italiana. Com'è sempre stato da quelle parti, a dispetto di
mille annunci di cambiamento e razionalizzazione delle abitudini e dei
comportamenti, a quell'ora non c'era nessuno o quasi e io mi aggiravo,
perplesso, per quei lunghissimi corridoi che mi ricordavano i quadri di De
Chirico. Conoscevo a grandi linee l'intricata geografia del Palazzaccio, se non
altro perché figlio di avvocati, ma vagavo con un certo disagio in quegli
ambienti, sonnacchiosi a quell'ora, in cui si stava riscrivendo la storia
d'Italia. Mi ritrovai nell'interminabile corridoio della Procura, al quarto
piano, il punto nevralgico della rivoluzione di rito ambrosiano. Camminavo e
qualcuno mi veniva incontro: era Gerardo d'Ambrosio, il procuratore aggiunto, il
coordinatore del Pool, in quel momento con Di Pietro, Borrelli, Davigo e Colombo
uno degli uomini più famosi d'Italia. Mi squadrò, io mi presentai. Due minuti,
qualche battuta con il suo inconfondibile timbro napoletano denso di ironie e
umorismo, poi il procuratore mi rifilò la notizia che quasi non entrava nella
mia testa: «Mani pulite è finita». Lui parlava, io ascoltavo sgranando gli
occhi, incredulo per lo scoop che stavo arpionando senza nemmeno aver buttato
l'amo. La sostanza del ragionamento era che il più era stato fatto. Tangentopoli
era stata svelata e il marcio attaccato. Formulai qualche domanda, tornai in
redazione pronto a ricevere i complimenti della direzione che puntualmente
arrivarono. Capivo e non capivo il perché di quella clamorosa confessione. Come
mai un magistrato così navigato si era spinto fino a quel punto? Preparai il
pezzo che fu pubblicato nei giorni successivi con grande enfasi e fu ripreso dai
telegiornali. Lui, visto l'inevitabile clamore, accennò un mezzo dietrofront,
qualcosa smentì e qualcosa smussò ma il messaggio era chiaro. E quella «lettera»
aveva un destinatario: Tiziana Parenti, il pm del Pool che indagava sulle
presunte mazzette versate proprio al Pci-Pds e cercava di avanzare su quello che
allora i quotidiani chiamavano pomposamente il fronte orientale di tangentopoli.
In quelle settimane cruciali l'inchiesta era arrivata davvero a un passo da
Botteghe oscure. Molti osservatori ritenevano che la svolta fosse vicina. Ancora
un po' e pure il vecchio, glorioso Partito comunista sarebbe franato sotto il
piccone del Pool. C'erano grandi aspettative, ma anche enormi difficoltà. Per la
struttura del partito e dei suoi quadri, gente all'antica che non era certo
disposta a piegarsi davanti al vento di Mani pulite. I personaggi alla Greganti,
per capirci, rimanevano in cella senza fiatare, alimentando leggende e voci di
ogni tipo. Certo, non correvano come centometristi per raccontare a Di Pietro
quel che sapevano e inguaiare qualcun altro come facevano i loro colleghi del
pentapartito. C'erano poi i rapporti complicati della Parenti con il resto del
Pool: la pm, già alle prese con un contesto ostico, non godeva di grande
simpatia e stima presso gli altri magistrati. Fuori le claque si dividevano: la
Parenti veniva beatificata dai moderati, D'Ambrosio, da sempre icona della
sinistra e in una futura seconda vita, anni dopo, parlamentare dei Ds, scaldava
le platee dei compagni. E poco importava che a proposito di piazza Fontana e
della morte di Pinelli non avesse sposato la vulgata più facile che voleva
l'anarchico vittima della violenza di Stato. Quell'intervista arrivò in testa
alla pm come un missile. O almeno così la prese lei: qualche settimana dopo,
incrociandola nel solito corridoio, fu lei a dirmi poche parole colme di
sconforto: «Quell'articolo mi ha delegittimato». Chissà cosa replicherebbe
D'Ambrosio che oggi purtroppo non c'è più e non può ribattere. Probabilmente la
partita sarebbe finita allo stesso modo. Chissà. Alla fine gli assediati si
salvarono e il partito pagò un prezzo tutto sommato accettabile alla grande
tempesta: gli arresti decimarono la corrente dei miglioristi, scaricati come
succursale dei corrotti del Psi. Il fronte orientale, che era stato fatale a
Napoleone, lo fu anche a Mani pulite. E quella sconfitta, inattesa, raffreddò
gli entusiasmi di una parte del Paese. Cominciava, fra divisioni e spaccature,
un'altra storia che va avanti ancora oggi.
Gherardo Colombo: «Lasciai la toga perché mi sentivo un
idraulico». In un’intervista a Tv2000, l’ex magistrato
racconta perché disse addio alle aule di giustizia e perché da tempo ha cambiato
il suo modo di vedere la funzione del carcere, scrive Franco Stefanoni il 17
febbraio 2017 su "Il Corriere della Sera". «Mi sono dimesso dalla magistratura
perché mi sono sentito come un idraulico». Lo ha detto Gherardo Colombo, in
un’intervista al telegiornale di Tv2000, rilasciata nel 25esimo anniversario
dell’inizio di Tangentopoli. «Spiego questa mia frase - ha aggiunto Gherardo
Colombo - con una metafora: un signore va in cucina per farsi il caffè ma dal
rubinetto non esce acqua. Così decide di chiamare l’idraulico che prova a
smontare il rubinetto e i tubi ma l’acqua continua a non arrivare. Allora
l’idraulico va in cantina e lavora al rubinetto centrale, quello che porta
l’acqua al condominio. Così torna in cucina e finalmente l’acqua esce dal
rubinetto. È come se per 33 anni in magistratura mi fossi occupato solo del
rubinetto della cucina. Per quanto impegno ci si mettesse non c’era niente da
fare: la giustizia funzionava malissimo. Così ho pensato di guardare a qualcosa
che venisse prima dei tribunali, le corti d’appello, le sentenze, gli avvocati.
Alla fine ho trovato il `rubinetto centrale´ cioè la relazione che esiste tra le
persone e le regole. Se non capiamo questo la giustizia non funziona». Colombo
ha anche ribadito il suo cambio di rotta sulla funzione del carcere: «Sulla
custodia cautelare ho cambiato il mio modo di vedere. Per quanto pensassi che il
carcere dovesse essere l’extrema ratio, cioè l’ultima misura possibile e
immaginabile, tuttavia pensavo che fosse educativo. Oggi non la penso più così:
il carcere non solo non serve ma danneggia anche la cittadinanza. Il 70% delle
persone che sono state in carcere, ci ritornano perché hanno ricommesso di nuovo
il reato. Il carcere è più una scuola di criminalità che un rimedio. Per questo
penso che non si possano tenere le persone in carcere per tutta la vita».
Mani Pulite, l'eredità disastrosa di Tangentopoli.
Le scuse di Borrelli: non valeva la pena buttar via il mondo precedente, scrive
Claudio Martelli il 17 febbraio 2017 su “Il Quotidiano.net”. Per alcuni "Mani
Pulite" fu la giusta – divina forse? – punizione per l’indebita l’euforia degli
anni ottanta che indebitò lo Stato. Ma è una leggenda. Nell’83 quando Craxi
diventa presidente del Consiglio il debito pubblico ammontava già al 70 per
cento del Pil. La dilatazione della spesa era cominciata nei Settanta col
consociativismo spendaccione tra Dc e Pci e con l’inflazione a due cifre che
moltiplicava gli interessi sul debito. È vero che con il governo Craxi e i
successivi il debito continua a salire ma, almeno, nel quadriennio di Craxi
l’inflazione venne abbattuta e l’economia crebbe sino al 4,5 per cento. Un
miraggio negli anni successivi. Ora il debito pubblico – in euro – in metà del
tempo è cresciuto del doppio nonostante i bassissimi interessi e i massicci
acquisti della Bce. Quanto a industrie e infrastrutture quelle non vendute
ristagnano, la produttività e il tenore di vita sono calati rispettivamente del
20 e del 14 per cento e abbiamo meno diplomati e laureati di tre lustri fa. Solo
la corruzione è aumentata eppure i partiti sono morti. Vive la partitocrazia in
simulacri al servizio di capi e capetti che nominano senatori e deputati i loro
servitori. Nulla più della parabola di Di Pietro dà il senso del disastro. Il
grande inquisitore processato perché prendeva soldi in prestito da chi inquisiva
dovette lasciare la toga. Poi, svergognato da un’inchiesta tv per aver fatto man
bassa dei finanziamenti pubblici al suo partito, ha dovuto lasciare anche la
politica. Non diversa la storia dei segretari amministrativi della Lega e della
Margherita arrestati per analoghi motivi. O vogliamo parlare di Fini? O degli
scandali Parmalat, Cirio, Monte dei Paschi? Ciascuno eccede dieci, venti volte
il finanziamento Enimont che ruinò la Prima repubblica. Quella che Di Pietro
marchiò come «la madre di tutte le tangenti» al confronto appare quasi una
parente povera. L’epitaffio l’ha scritto Francesco Saverio Borrelli,
l’inflessibile guida del pool «Mani pulite»: «Chiedo scusa per il disastro
seguito a Mani pulite. Non valeva la pena di buttare il mondo precedente per
cadere in quello attuale». Nei codici questa condotta si chiama «delitto
colposo» e la colpa ammessa è quella, avendo «buttato» la Prima repubblica di
aver propiziato la Seconda. La Prima era quella dei partiti che l’avevano creata
trasformando il regime fascista in un regime di partiti. Partiti veri,
formazioni storiche, comunità organizzate, divise da ideologie, legami
internazionali, conflitti di classe. Migliaia di sedi, giornali, funzionari,
congressi, associazioni fiancheggiatrici, campagne elettorali non si finanziano
con parole. Il sistema di finanziamento era vasto, ramificato e spesso illegale.
Casi di corruzione individuale e scandali clamorosi furono neutralizzati o dal
regime delle immunità politiche o dall’indulgenza giudiziaria. La repubblica
doveva essere riformata in radice, soprattutto da quando, con il crollo del
comunismo e il varo del mercato unico europeo, il contesto internazionale da
protettivo si era fatto ostile. Ma i leader democratici o non capirono o non
agirono e furono travolti dalla rivolta antipartitica scatenata da un
establishment impaurito e dai media, dalle nuove e vecchie forze anti sistema.
Mentre il paese precipitava nella crisi economica, la lira veniva svalutata e il
governo nottetempo metteva le mani sui conti correnti degli italiani si aprì la
caccia al capro espiatorio. Arma letale fu l’uso violento della giustizia, gli
arresti e il carcere preventivo per estorcere confessioni, delazioni, chiamate
di correità a catena. «Mani pulite» è stata la più colossale operazione di
polizia giudiziaria della nostra storia: trentamila indagati, tremila arrestati,
tra cui cinquecento parlamentari, decine tra ministri e primi ministri, grandi e
piccoli imprenditori, dirigenti, funzionari. Decapitati in piazza e in effigie i
leader e i partiti di governo la repubblica si schiantò e cominciò una crisi che
non ci ha più lasciato.
Vittorio Feltri su “Libero Quotidiano il 18 febbraio 2017: Mani
pulite, coscienze sporche. Così i magistrati sono diventati una casta di
intoccabili. Domani ricorrono i 25 anni di Mani
Pulite. Manette d’argento potrebbe andare come titolo della celebrazione del
quarto di secolo, e invece della marcia nuziale con l’organo, per la colonna
sonora suggerirei il tintinnare degli schiavettoni a cura dei comunisti col
Rolex, J-Ax e Fedez, possibilmente ospiti di Fabio Fazio. Ma che tristezza. Di
solito si dice: sembrava ieri. A tutti noi, parlo a naso ma ci azzecco, paiono
invece cento anni. Le decrepite rievocazioni raccolgono quattro gatti
acciaccati. Le tricoteuses, che affollavano furenti e festanti corridoi e aule
di Palazzo di Giustizia di Milano, preferiscono da tempo Sanremo. Tutto il resto
è noia, per restare in tema di canzoni. Una barba. Un coro universale di
lamenti, da destra e sinistra, inquirenti e inquisiti d’accordo nel giudizio: il
rimedio non è servito o addirittura è stato peggiore del male. I componenti del
famoso pool, che hanno fatto tutti carriera, si lagnano che quella stagione
della loro gloria non è servita a niente, eccettuata la loro popolarità, e ogni
cosa è come prima, quanto a corruzione e latrocini. I parenti dei 45 suicidi,
tra i 5.000 arrestati di quella epopea carceraria, eccepiscono che non è proprio
come prima: mancano i loro cari, annientati dal terrore e dal discredito
preventivo della carcerazione un tanto al chilo, usata a mo’ di tortura.
Venticinque anni per nulla? Un bilancio è roba da storici più che da
gazzettieri. Mi affido perciò al professor Paolo Mieli. Da direttore della
Stampa e del Corriere della Sera egli fu protagonista di quella macchina da
guerra che assemblava in magica alchimia pool di toghe e di cronisti. Ci diede
dentro da par suo, occupandosi anche di consegnare lui, tramite edicola, un
mandato di comparizione per corruzione a Berlusconi durante il raduno dell’Onu
contro la criminalità che il Cavaliere presiedeva da premier a Napoli (22
novembre 1994), dopo di che precipitò. Tutto bello, tutto giusto? Mica tanto.
Mieli ammise lealmente nel 1998, a frittata fatta a proposito di Mani pulite:
«Ci ho creduto e l’ho sostenuta. Ma adesso capisco che Mani Pulite non è il
nuovo, è la vecchia storia dei buoni contro i cattivi. Perché ci sono voluti
tanti anni per comprendere che anche il Pci-Pds non era estraneo al sistema di
Tangentopoli? Con Berlusconi abbiamo esagerato, mentre con l’Ulivo siamo stati
troppo cortigiani». Parole sante, ma tardive come è giusto sia per gli storici.
Da modesto scriba di note quotidiane me ne accorsi un bel po’ di anni prima. Non
c’era bisogno di aquile per denunciare la parzialità dell’ambaradan messo su
alla procura di Milano e che il procuratore generale del tempo, Giulio Catelani,
buon’anima, definì «Rivoluzione italiana», che è cosa un po’ fuori dai binari
dell’amministrazione della giustizia e diventa politica della peggior specie,
quella che non si nutre di voti ma di fax. Con il risultato di travolgere il
sistema democratico e di nuocere alla reputazione dei Tribunali. In effetti Mani
Pulite divenne ben presto un modo per stringersi intorno al collo di qualcuno
lasciando intatti altri. La macchina da guerra delle toghe infatti preparò la
strada - una volta demoliti leader e quadri dirigenti del pentapartito (per i
giovani: democristiani e socialisti non filocomunisti, socialdemocratici,
repubblicani e liberali) - all’altra macchina da guerra, quella gioiosa, quella
di Occhetto. Che fu preservata per un incantesimo da decimazioni e inchieste,
salvo a livello basso, dove i tangentari furono trattati persino da eroi che non
parlano. Con L’Indipendente sostenni dagli inizi e fino al 1993, il lavoro di
lavanderia specialmente di Antonio Di Pietro: avevo creduto alla promessa che la
sua scopa avrebbe spazzato il letame anche dagli angoli di sinistra della piazza
politica. Non accadde, e ne tirai presto le conseguenze proponendo l’alleanza
trinitaria tra Berlusconi, Bossi e Fini, con ciò mandando all’aria il disegno
neanche tanto sotterraneo sopra rivelato da Mieli, il quale, non
dimentichiamolo, aveva per editore la Fiat. Sono certo che uno come Piercamillo
Davigo se avesse avuto modo di rovesciare i calzini dei compagni avrebbe
sistemato da par suo anche capi e capetti comunisti ed ex comunisti. Questo
magistrato, oggi capo del sindacato delle toghe, non ha mai avuto venerazione
per le Botteghe Oscure, semmai per le gattabuie. Il suo ideale politico sono
sempre state le galere, purché piene. Ma i risultati sono quelli che sono. Noia
e persino nostalgia (ingiusta) degli Anni 80, quando la magistratura aveva
buttato le ancore nel porto delle nebbie. Il risultato di quell’attivismo
unilaterale è una stanchezza generale. E l’impressione non immune da verità è
che la magistratura abbia abusato di quella popolarità guadagnata a suon di
arresti e processi di alti papaveri per erigersi a casta di intoccabili. Infatti
la politica, che per tanti aspetti fa schifo, così come ripugnano i mestieranti
della medesima, subisce di tanto in tanto la scrematura delle elezioni popolari
e le scrollate spesso politicamente orientate dei colleghi di Davigo. Mentre le
toghe si sono elevate da se stesse sopra i cieli dove pretendono di essere come
la Madonna. Che non a caso è l’appellativo con cui colleghi, cronisti e
simpatizzanti avevano battezzato Di Pietro. Il quale sarà pure una brava persona
ma è la cosa più lontana dall’Immacolata Concezione che io riesca ad immaginare.
Di Vittorio Feltri
Venticinque anni fa i Pm demolirono la prima Repubblica,
scrive Piero Sansonetti il 17 Febbraio 2017 su "Il Dubbio". “Mani pulite” fu una
grandiosa operazione politica, l’obiettivo era “purificare”: 25mila indagati,
4mila arresti, meno di 2mila condanne e il sistema dei partiti venne raso al
suolo. Vinse l’alleanza tra magistratura e media. L’operazione “mani pulite”
iniziò esattamente 25 anni fa, il 17 febbraio del 1992, con l’arresto di Mario
Chiesa, funzionario socialista milanese piuttosto ignoto, beccato con sette
milioni di tangente in tasca. Anche se dall’arresto di Chiesa all’esplodere
dello scandalo politico che travolse la prima repubblica passarono poi diversi
mesi. In mezzo ci fu una campagna elettorale, la vittoria della Lega Nord,
l’uccisione del big democristiano (andreottiano) siciliano Salvo Lima, il
terrificante attentato mortale a Giovanni Falcone, e infine l’elezione del nuovo
presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Poi arrivò l’estate e in una
caldissima giornata di fine giugno ci si preparava a dare notizia della nomina
di Bettino Craxi a presidente del consiglio incaricato, e invece successe il
finimondo. Nelle redazioni dei giornali arrivarono delle carte nelle quali si
parlava del coinvolgimento diretto di Bettino Craxi in una storia di tangenti
milanesi. Le carte – presumibilmente: molto presumibilmente – erano state
inviate dalla stessa procura di Milano, dove – agli ordini del Procuratore
Saverio Borrelli – si era costituito un pool di magistrati, incaricato
esplicitamente di muovere l’assalto al quartier generale della politica, e in
particolare all’asse Dc-Psi, e ancor più in particolare alla persona di Bettino
Craxi. I nomi dei magistrati del pool sono i nomi più noti tra tutti i nomi dei
magistrati del mondo: Di Pietro, D’Ambrosio, Colombo, Davigo. La prima mossa fu
quel dossier fatto giungere anonimamente alla redazioni. La notizia rimbalzò a
Montecitorio e al Quirinale, e Scalfaro da un mese presidente della repubblica,
decise di soprassedere alla nomina di Craxi. Fece qualcosa di più: avvertì Craxi
che il suo nome era fuorigioco e che toccava a lui scegliere tra i suoi due
delfini: Claudio Martelli o Giuliano Amato. Craxi scelse Amato, facendo
infuriare Martelli (che mai gliela perdonò) e il 28 giugno Amato fu incaricato.
È da quel momento che “mani pulite”, eliminato il nemico numero 1, inizia in
grande stile. Il Psi viene travolto in pochi mesi. La destra Dc altrettanto. La
sinistra Dc e il Pci vengono colpiti di striscio, ma escono quasi incolumi dal
bombardamento. I numeri dell’inchiesta “mani pulite” sono incerti.
Ieri Repubblica par- lava di 4520 indagati e di 661 tra condannati e persone che
accettarono di patteggiare (i condannati veri e propri furono 316, cioè circa il
7 per cento degli indagati). In realtà questi numeri si riferiscono solo alla
Procura di Milano, che fu il motore di “mani pulite”, ma le inchieste, e gli
avvisi di garanzia, e gli arresti, si estesero a tutt’Italia. I numeri finali
sono incerti: più o meno gli indagati furono 25 mila, gli arrestati circa 4000,
il numero delle condanne non si conosce ma comunque la media nazionale è simile
a quella milanese: circa il 7 per cento. Capite bene che 25 mila indagati è un
numero enorme. Un pezzo gigantesco del ceto politico fu messo alla sbarra. E nel
clima che si era creato, soprattutto per la partecipazione attiva della stampa e
della televisione alle indagini, si era realizzata una situazione nella quale
chiunque ricevesse un avviso di garanzia era costretto a dimettersi e a lasciare
la politica. Di quelle circa 20 mila persone che furono costrette a lasciare la
politica e poi risultarono innocenti (o comunque non furono condannate) si e no
una decina riuscì a rientrare nel giro. Gli altri furono messi fuori dal campo e
basta. Gli avvisi di garanzia arrivavano quasi sempre al momento giusto. A Craxi
arrivò l’avviso nel dicembre del ‘ 92, dieci giorni prima di Natale, e fu un
siluro che lo costrinse a lasciare la segretaria del partito. Claudio Martelli
si mise in corsa per prendere il posto di Craxi, disse che voleva “salvare
l’onore politico del Psi”, ma il 19 febbraio del 1993, mentre era in corso una
riunione dell’assemblea nazionale del Psi all’hotel Ergife di Roma, e mentre
Martelli si stava per candidare alla segretaria, arrivò l’avviso anche a lui.
Lui era il ministro della Giustizia, era il leader politico che aveva promosso e
protetto Falcone: non piaceva alla Procura di Milano, che se ne disfò in quattro
e quattr’otto. Martelli, che era uno dei dieci uomini più potenti d’Italia,
scomparve dalla scena in quell’esatto momento. Naturalmente questo meccanismo da
Santa Inquisizione non poteva funzionare se la magistratura fosse stata sola a
guidare l’operazione. Ma la magistratura non era sola: con lei si era schierata
praticamente tutta la stampa italiana. Quella di destra, quella di sinistra,
quella di centro, quella politica e quella scandalistica. Guidata dai giornali
della Fiat, dal Corriere della Sera, ma anche dai giornali più vicini al Pci
come la Repubblica e naturalmente anche l’Unità. La magistratura in un primo
tempo aveva spaventato anche gli editori dei giornali, perché aveva colpito duro
i vertici della Fiat e aveva persino, per qualche ora, messo in arresto De
Benedetti. Ma l’imprenditoria si arrese quasi subito e accettò di collaborare
con la magistratura e di mettere a disposizione i propri giornali, in cambio
dell’impunità. Così fu. E’ ancora così. Dicevamo dei 25.000 procedimenti avviati
e conclusi con un po’ più di mille condanne. Possiamo dire che dal punto di
vista giudiziario “mani pulite” fu un fallimento. Fu però un successo senza
precedenti dal punto di vista politico. Il pool di Milano riuscì a portare a
termine la più clamorosa riforma istituzionale mai realizzata nell’Italia
repubblicana. Il sistema democratico fondato sui partiti – sulle loro strutture,
sulle loro idee, sui loro meccanismi popolari – fu raso al suolo in poco più di
un anno. I leader di quel sistema politico scacciati e messi in fuga o alla
berlina. I rapporti tra politica e magistratura rovesciati. Diciamo che la prima
repubblica fu cancellata. Quando si dice prima repubblica spesso si intende un
sistema politico partitocratico e corrotto, che stava rovinando il paese. Non è
esatto. La prima repubblica era quella costruita sui valori della lotta
partigiana e sulle idee di grandi tradizioni politiche come quelle del
cristianesimo sociale, del comunismo, del socialismo e del liberalismo.
Immaginata e costruita da personaggi come De Gasperi, Einaudi, Croce, Togliatti,
Nenni, Calamandrei, La Malfa. Sarebbe quella compagine che ricostruì l’Italia
distrutta dal fascismo, la portò pienamente dentro un regime democratico, ne
promosse lo sviluppo economico e sociale, la modernizzò attraverso grandiose
riforme di tipo socialista o di tipo liberale. Non proprio una schifezza. Se uno
prova a fare un bilancio storico politico e sociale della prima repubblica e lo
mette a confronto con un bilancio della seconda repubblica (quella nata sulla
spinta dell’inchiesta “mani pulite”) si mette a ridere. La fine della prima
repubblica pone fine al primato della politica. E dunque ridimensiona fortemente
la portata della democrazia. Il potere si trasferisce. In particolare nelle mani
dei potentati economici, che dettano le scelte di fondo. In parte nelle mani
della magistratura, che da quel momento diventa largamente in grado di
controllare il ceto politico e di determinarne la selezione e anche le scelte.
“Mani pulite fu un complotto”? No, io non lo credo. Però “mani pulite” riuscì
perché perseguì un disegno politico. Che era duplice: “purificare” la società
italiana e abolire i partiti. Il pool di Milano credeva sinceramente e con
passione che le due cose coincidessero. La seconda parte di questo disegno è
perfettamente riuscita. La prima no. E da quel momento la magistratura si
convinse che il proprio compito non fosse quello di giudicare i colpevoli e gli
innocenti, come dice la Costituzione, ma quello di assumere un ruolo di Guida
Etica della società e dello Stato. E di garante della moralità.
Martelli: «Alla fine i moralisti finiscono alla gogna»,
scrive Giulia Merlo il 17 Dicembre 2016 su "Il Dubbio". «Chiunque faccia
dell’onestà il principale, se non l’unico motivo della propria iniziativa
politica, nasconde un’assenza di programmi più approfonditi”. «Nessun ritorno a
Mani Pulite». Claudio Martelli, ex ministro della Giustizia nel difficile
biennio tra il 1991 e il 1993, analizza le inchieste che hanno gettato nel caos
le amministrazioni di Milano e Roma, a partire dal rapporto sempre teso tra
politica e magistratura.
Onorevole, traballano sia Milano che Roma: con Beppe Sala
autosospeso e il braccio destro della sindaca Virginia Raggi arrestato. Ci sono
somiglianze con il 1992 di Mani Pulite?
«Somiglianze non direi. Non vedo
un’ondata di arresti scatenati da metodi di indagine alla Di Pietro, in cui il
motto era «o parli o butto la chiave», con una catena di delazioni a comando
provocate dalla carcerazione preventiva. Vedo però uno stillicidio continuo di
indagini e accuse e una particolare devozione della nostra magistratura alle
indagini sulla pubblica amministrazione. Per un verso bisogna rallegrarsene, per
altro verso suscita qualche interrogativo, a fronte della mole di reati, anche
più gravi, non perseguiti».
Partiamo dal caso–Roma. L’amministrazione grillina rischia di
crollare sotto il peso delle dimissioni di Paola Muraro e l’arresto di Raffaele
Marra. Che fine ha fatto lo slogan “onestà–onestà”?
«Come le volpi finiscono in
pellicceria, così i moralisti finiscono alla gogna. S’è già visto in passato:
quelli che sbandieravano il partito degli onesti poi finirono nel tritacarne
giudiziario e questo è vero anche oggi.
Chiunque faccia dell’onestà il principale se non l’unico motivo della propria
discesa politica in campo nasconde un’assenza di programmi più approfonditi.
L’onestà è una precondizione e la politica è un mestiere talmente difficile e
insidioso che pensare di cavarsela semplicemente restando onesti è una pia
illusione».
Poi anche Milano, la sua città: Expo è stato uno dei più
sbandierati successi del governo Renzi e ora rischia di essere la pietra tombale
del Comune, faticosamente mantenuto dal Pd. Quali equilibri si stanno muovendo?
«La procura aveva archiviato il caso
Sala, in cui non si era trovata traccia di tangenti. Per dirla con Ilda
Boccassini, non c’era odor di «piccioli», ma solo una gran fretta, che ha fatto
compiere anomalie. Sembra infatti che sia stato retrodatato un documento di
indizione di una gara d’appalto, per poter rientrare nei termini di legge. Nei
giorni di Expo, infatti, ricordo grande frenesia per arrivare con le opere
compiute all’inaugurazione, smentendo i gufi del «non ce la farete mai»».
Invece la procura generale ha ritenuto di riaprire l’inchiesta…
«Che la procura generale abbia ritenuto
di riaprire un caso archiviato dalla procura della Repubblica e come questo si
inserisca nella lotta devastante della magistratura milanese, purtroppo è nelle
carte. Del resto, è stato lo stesso Csm a tentare di sedare le lotte,
legittimando Edmondo Bruti Liberati e trasferendo Alfredo Robledo. Io temo che
l’iscrizione di Sala ne registro degli indagati possa essere un danno
collaterale provocato da quel conflitto. Del resto, i conflitti tra magistrati
sono i più accaniti e avvelenati, perché tutte le parti brandiscono il diritto,
indossano la toga e sono ammantati di intransigenza assoluta, impuntata su
dettagli e cavilli».
Una magistratura milanese, dunque, molto diversa da quella di
Mani Pulite?
«Decisamente. Allora c’era una
compattezza incredibile nel pool di Mani Pulite: anche quando – come poi si
scoprirà – i giudici non erano d’accordo uno con l’altro, erano però tutti saldi
nel far fronte comune contro l’opinione pubblica rispetto ai politici».
Ma anche oggi si ripete, però, un dualismo guerriero tra
magistratura e politica?
«Questa è la visione manichea di
Piercamillo Davigo, che parla di lotta del bene contro il male, in cui i
magistrati sono tutti buoni e politici tutti corrotti».
Lei, invece, come la pensa?
«Io credo ci sia la somma di due mali.
E’ vero che la corruzione in Italia alligna più che altrove che questo merita
indagini e sanzioni. Se però nelle indagini si cede a eccessi giustizialisti,
ecco che si somma male ad altro male: la corruzione diffusa e la repressione
arbitraria».
Torna, dunque, al centro il rapporto difficile tra politica a
tutti i livelli e magistratura.
«Io credo che, di questo, il caso di
Beppe Sala sia emblematico. Ancora non si sa con certezza se abbia ricevuto un
avviso di garanzia e tutto è nato da indiscrezioni sui giornali. Quando dalle
procure trapelano notizie riservate, storcendo il principio della tutela
dell’indagato e del suo diritto alla riservatezza, ecco che si è già compiuto un
abuso grave. Ma la violazione del segreto istruttorio è diventata un passatempo,
ed anzi è strano quando ciò non avviene. Se si distrugge la reputazione
dell’imputato nella fase precedente l’indagine formale, però, si altera il corso
della giustizia e questo è il punto cruciale e che più interessa i rapporti tra
politica e magistratura. La sentenza, infatti, può anche essere di assoluzione,
ma intanto la carriera politica è già bella che finita».
L’autosospensione di Sala è una scelta politica che deriva da
questa distorsione del sistema?
«Io credo che lui abbia fatto una
scelta opportuna. La sua decisione fungerà da sollecito alla procura generale,
perché si decida in fretta a formalizzare le accuse o archiviarle».
Il caso Roma, invece, ha delle implicazioni diverse. Raggi è
sotto scacco?
«L’elemento politico di questa vicenda
lo ha colto bene Giorgia Meloni, che si è chiesta se ci troviamo di fronte a
incompetenza assoluta oppure a stupida malizia della sindaca Raggi. Perché ha
insistito a scegliere personaggi che hanno fatto il loro curriculum
amministrativo nelle passate gestioni, che in pubblico lei è stata la prima a
condannare? Questo a me pare incomprensibile. Noi siamo osservatori estranei, ma
anche dal suo stesso movimento in tanti l’hanno messa in guardia. La sua è stata
ostinazione, ma del resto questo è un periodo in cui va di moda per sindaci ed
ex sindaci non ascoltare i consigli».
Un riferimento a Matteo Renzi?
«Non ho fatto che leggere elogi per la
cosiddetta «determinazione» di Matteo Renzi. Eppure io credo che ostinarsi sia
un errore, non certo una qualità. E di qualità Renzi ne avrebbe molte altre».
Così nacquero Tangentopoli e poi il giustizialismo,
scrive Fabrizio Cicchitto il 27 Dicembre 2016 su "Il Dubbio". L’intervento del
ministro Orlando alla direzione del Pd e la lunga intervista al Dubbio del
filosofo Biagio De Giovanni hanno costituito la prima radicale rimessa in
questione di quel giustizialismo che nel Pds– Ds e poi nel Pd ha costituito una
fondamentale scelta ideologica di larga parte dei post– comunisti (con
l’eccezione dei miglioristi come Chiaromonte, Napolitano, Umberto Ranieri) e una
altrettanto marcata scelta politica determinata da un misto di strategia e di
tattica di cui poi vedremo le ragioni di fondo. Orlando ha denunciato il fatto
che per anni il giustizialismo esercitato contro Berlusconi ha sostituito le
scelte culturali e politiche di stampo realmente riformista che invece non sono
state fatte. Biagio De Giovanni ha denunciato il fatto che sul giustizialismo
della sinistra si sono innestati due fenomeni devastanti: “la politica distrutta
dall’invadenza della magistratura” e un’antipolitica che si innesta su questo
ruolo prevaricante di un potere dello stato e che attraverso di esso sta
distruggendo il confronto politico e culturale. De Giovanni ha anche rilevato, a
proposito dell’attività più propriamente politica del ministro Orlando, che egli
ha realizzato positivi interventi sulle carceri ma non è riuscito neanche a
sfiorare i due temi centrali della riforma della giustizia, la separazione delle
carriere e il superamento dell’obbligatorietà dell’azione penale. Per completare
questa rassegna preliminare citiamo anche l’intervista di Giorgio Napolitano
sul Messaggero a proposito del confronto sul referendum: Napolitano ha rilevato
che la forza dell’antipolitica è diventata tale che nell’ultima fase della
campagna referendaria il Presidente Renzi ha pensato bene di riuscire a smontare
il vantaggio del No dando al Sì il valore della lotta alla casta: fatto dal
presidente del Consiglio in carica questo appello è risultato controproducente e
anche un po’ grottesco. Ciò detto, però, dobbiamo per forza fare un passo
indietro. Il finanziamento organicamente irregolare dei partiti parte dagli anni
40 e ha per nome e cognome una serie di padri della patria (da Alcide de
Gasperi, a Palmiro Togliatti a Pietro Nenni). Negli anni ’ 40–’ 50 la Dc era
finanziata dalla Confindustria, dalla Cia, da una rete di imprenditori privati.
Poi, con l’avvento di Fanfani, il finanziamento della Dc fu sostenuto anche
dalle aziende a partecipazione statale. A sua volta il Pci era finanziato dal
Pcus, dalle cooperative rosse, da una rete di imprenditori amici, specie nelle
regioni rosse. Prima di Craxi, il Psi dipendeva per il suo finanziamento dal
principale alleato: nella fase frontista esso si basò sul finanziamento
sovietico e sulle cooperative rosse, nella fase del centro– sinistra sulle
partecipazioni statali. Tutto ciò si aggregò in un sistema organico, quello di
Tangentopoli. A fondare quel sistema dal lato imprenditoriale furono altri due
padri della patria, cioè Vittorio Valletta ed Enrico Mattei. Mattei considerava
i partiti e le loro correnti dei “taxi” (tant’è che finanziava abbondantemente
anche l’Msi, un partito che poi anch’esso, come del resto il Pci– Pds, si è
rifatto la verginità), e poi fondò in modo esplicito con Albertino Marcora
quella sinistra di base (corrente democristiana) che ha esercitato una grande
influenza nella Dc e nell’intero sistema politico. Che il Pci affondasse le sue
risorse in un finanziamento irregolare dalle molteplici fonti (altro che feste
dell’Unità) è messo in evidenza dal verbale di alcune riunioni svoltesi in Via
delle Botteghe Oscure citato a pagina 495– 498 nel libro di Guido Crainz “Il
paese mancato”. Giorgio Amendola nella direzione del 1 febbraio 1973 disse:
“quando me ne sono occupato io “le entrate straordinarie” (eufemismo ndr) erano
del 30% ora siamo al 60%”. A sua volta Elio Quercioli disse: “molte entrate
straordinarie derivano da attività malsane. Nelle amministrazioni pubbliche
prendiamo soldi per far passare certe cose. In questi passaggi qualcuno resta
con le mani sporche e qualche elemento di degenerazione finisce per toccare
anche il nostro partito”. E nella riunione dell’1 e del 2 marzo 1974 il Pci
diede il sostegno alla legge sul finanziamento pubblico con l’esplicita
motivazione di ridurre il finanziamento sovietico e le “entrate straordinarie
derivanti da attività malsane”. Armando Cossutta disse: “negli ultimi anni si è
creato in molte federazioni un sistema per introitare fondi che ci deve
preoccupare. C’è un inquinamento nel rapporto con le nostre amministrazioni
pubbliche nel quale c’è di mezzo l’organizzazione del partito e poi ci stanno
dei singoli che fanno anche il loro interesse personale”. Quando, poi, decollò
la politica di unità nazionale, il Pci entrò anche nel “sistema degli appalti
pubblici” che aveva come sede di compensazione l’Italstat: in quella sede c’era
un meccanismo che assicurava la rotazione nell’assegnazione degli appalti che
riguardava tutte le grandi imprese di costruzione pubbliche e private: alle
cooperative rosse era garantita una quota che oscillava dal 20 al 30%. A sua
volta Bettino Craxi per rendere reale fino in fondo l’autonomia del Psi dalla Dc
e dal Pci, prese direttamente e tramite Vincenzo Balzamo rapporti con il mondo
imprenditoriale: una mossa i cui rischi furono evidenti poi. Avendo però alle
spalle quella realtà del suo partito, Berlinguer fece la famosa intervista sulla
questione morale nella quale presentava il Pci come il partito delle “Mani
Pulite”: la mistificazione è evidente. In sostanza Tangentopoli era un sistema
che si fondava su un organico rapporto collusivo fra tutte le grandi imprese
pubbliche e private senza eccezione alcuna (quindi compresa la Cir di De
Benedetti, come risultava dalle sue stesse ammissioni processuali) e da tutti i
partiti dell’arco costituzionale senza eccezione alcuna (quindi compreso il Pci;
l’Msi, a sua volta, o aveva diretti rapporti con le imprese, vedi l’Eni, o, a
livello locale era “tacitato” dagli altri partiti). Questo sistema era fondato
sulle grandi imprese, sui partiti, sulle correnti dei partiti. In esso, dalla
seconda metà degli anni ’ 80 in poi, emersero degenerazioni personali. Comunque,
con l’adesione dell’Italia al trattato di Maastricht che costrinse “a calci” il
capitalismo italiano a fare i conti con il mercato e la libera concorrenza (cosa
che fino ad allora non aveva fatto) il sistema di Tangentopoli diventò
chiaramente antieconomico (lo era anche prima ma esistevano meccanismi di
compensazione quali il debito pubblico e specialmente le svalutazioni
competitive, in genere decise di comune intesa fra la Fiat e Banca d’Italia) e
doveva essere superato. Ora la via maestra di quel superamento–eliminazione
avrebbe dovuto essere un’operazione consociativa, con un’intesa generale fra le
forze politiche, quelle imprenditoriali, quelle giudiziarie, e magari concluso
con un’amnistia. Le cose non andarono affatto così. L’ultima amnistia fu quella
del 1989 che servì a salvare il Pci dalle conseguenze penali del finanziamento
irregolare di derivazione sovietica. Negli anni ’ 90 i partiti, specie la Dc, il
Psi, i partiti laici, ma per altro verso anche il Pci (che con il cambio del
nome in Pds e il “superamento” del comunismo perse circa metà del suo
elettorato) avevano perso vivacità culturale e consenso. A quel punto, invece,
si affermò nella magistratura la corrente più aggressiva e più ideologica, cioè
Md, che teorizzava il ruolo sostanzialmente rivoluzionario del magistrato che,
superando un’asettica e burocratica terzietà, avrebbe dovuto rimettere in
questione gli equilibri economici e quelli politici. Questa teorizzazione trovò
nel pool di Milano di Mani Pulite chi la cavalcò sul piano dell’esercizio della
giurisdizione mettendo in essere un’operazione del tutto unilaterale, fondata su
due pesi e due misure: nel caso della Dc, Mani Pulite arrivò addirittura a
distinguere fra le correnti di centro–destra di quel partito che furono
sostanzialmente distrutte ( chi non ricorda Forlani al processo Enimont, e poi,
fuori da Milano, Andreotti alla sbarra per l’assassinio di Pecorelli e per il
concorso con la mafia e Antonio Gava e Paolo Cirino Pomicino in carcere?) e
invece la sinistra Dc, e sull’altro versante, il Pci–Pds, furono interamente
salvati. A loro volta il Psi, il Psdi, il Pli, il Pri furono rasi al suolo.
Quando l’unilateralità dell’operazione non era ancora chiara e sembrava che
avrebbe colpito tutto e tutti, Achille Occhetto si precipitò alla Bolognina a
“chiedere scusa agli italiani” perché conosceva bene il retroterra finanziario
del Pci– Pds. Quella di Mani Pulite fu comunque un’operazione rivoluzionario–
eversiva unica in Europa: fu l’unico caso nel quale ben 5 partiti di governo
furono distrutti prima dai magistrati che dagli elettori. Lo strumento
principale di questa operazione era la cosiddetta “sentenza anticipata”: se un
dirigente politico viene raggiunto da un avviso di garanzia, enfatizzato da
giornali e da televisioni, a quel punto egli perde totalmente il suo consenso
elettorale. Se la stessa sentenza colpisce altri mille dirigenti di quel
partito, è il partito nel suo complesso ad essere azzerato. Se poi, magari dopo
cinque o sette anni, interviene la vera sentenza processuale ed è di
assoluzione, i suoi effetti politici sono nulli. In seguito a Mani Pulite, dal ’
92–’ 94 in poi, i rapporti fra politica e magistratura sono stati totalmente
rovesciati. A “comandare” è chiaramente la seconda. A sancire quel cambio di
equilibrio fu anche nel 1993 l’eliminazione di quell’immunità parlamentare che
fu ideata dai costituenti proprio per bilanciare la totale autonomia di cui gode
la magistratura italiana diversamente da altri ordinamenti. In un primo tempo il
Pds fu l’utilizzatore passivo di quella unilateralità dell’azione della
magistratura. Poi ne diventò il fruitore attivo. La storia, però, è paradossale.
Il Pds di Occhetto, D’Alema, Veltroni credeva che grazie a Mani Pulite sarebbe
arrivato sicuramente al potere. Di conseguenza la discesa in campo di Berlusconi
fu un’amara sorpresa per il gruppo dirigente del Pds. Berlusconi da parte sua
fece leva anche sul “nuovismo”, sul populismo e sull’antipolitica che Mani
Pulite aveva suscitato. A quel punto, però, il giustizialismo fu esercitato dal
Pds (e da tutto il circolo mediatico costituito da Repubblica, il Tg3,
Samarcanda, poi Travaglio e Il Fatto) contro Berlusconi provocando una “guerra
civile fredda” durata 20 anni. Anche in questo secondo caso, però, c’è stata
un’altra amara sorpresa: quando Berlusconi è stato messo fuori gioco attraverso
un’interpretazione retroattiva di una legge già di per sé assolutamente iniqua,
qual è la Severino, il Pd di Bersani si è trovato di fronte ad un altro scherzo
della storia: Forza Italia era stata messa fuori gioco, il centro– destra era in
crisi ma a quel punto, a cavalcare fino in fondo la tigre e l’onda del
giustizialismo e dell’antipolitica, è nata una forza integralmente
protestataria, ultra– giustizialista e gestita con meccanismi di stampo
autoritario da un comico– demagogo e dalla società di comunicazione della
Casaleggio associati. Bisogna guardare anche all’altra faccia della medaglia:
mentre a suo tempo Tangentopoli era un sistema fondato su grandi imprese e sui
partiti in quanto tali, da dopo il ’ 92–’ 94 è avvenuta la parcellizzazione
della corruzione, che si è fondata su una miriade di mini– catene o reti
composte da singoli imprenditori, singoli alti burocrati, singoli politici, in
qualche caso anche con singoli magistrati. Questa corruzione capillare è ciò che
è avvenuto dopo il ’ 92–‘94 enfatizzando a dismisura il ruolo della magistratura
con effetti sconvolgenti. Oggi anche gli apprendisti stregoni sono vittime di sé
stessi e cioè anche i grillini sono ormai dominati dall’incubo dell’avviso di
garanzia che per loro, è ancor più distruttivo perché finora, quando esso
riguardava gli “altri” equivaleva ad una sentenza di terzo grado. Per
concludere: le riflessioni del ministro Orlando e di Biagio De Giovanni
costituiscono certamente un fatto positivo: non vorrei, però, che essi arrivino
troppo tardi, quando già Davigo, non a caso eletto “a furor di popolo”
presidente dell’Anm, si comporta come una sorta di super– commissario ad acta
nei confronti del fallimento delle istituzioni della Repubblica, del Parlamento
e dei parlamentari in primis, soggetti, questi ultimi, considerati dei
delinquenti potenziali, da trattare nei dovuti modi.
Non sono i giudici a poter rendere l’Italia un Paese migliore.
Assistiamo a un rapporto tra i poteri ormai molto diverso da quello stabilito
dalla nostra Costituzione, scrive Giovanni Belardelli il 27 dicembre 2016 su "Il
Corriere della Sera". Le notizie degli ultimi giorni e settimane (le indagini
sul ministro Lotti, quelle milanesi sul sindaco Sala, quelle romane su Marra e
Muraro e presto — potrebbe essere — sulla stessa Virginia Raggi) confermano che
ci troviamo di fronte a un’alterazione stabile, per certi aspetti definitiva,
nei rapporti tra politica e giustizia. Dunque questa alterazione non era
collegata se non in piccola parte alla discesa in campo di Berlusconi — come
invece molti avevano a lungo ritenuto — visto che, anche adesso che il leader di
Forza Italia ha un ruolo certamente secondario, continua a segnare la nostra
vita collettiva. Caratterizza con ogni evidenza la vita politica, dove
assistiamo a un rapporto tra i poteri ormai molto diverso da quello stabilito
dalla nostra carta fondamentale. Nella costituzione materiale del Paese — cioè
nell’assetto effettivo dei rapporti tra istituzioni e poteri dello Stato — è da
tempo evidente infatti che il potere legislativo e quello esecutivo sono
condizionati in modo consistente dalla magistratura nelle sue varie
giurisdizioni. Questioni che ritenevamo di stretta competenza del governo e del
Parlamento — dalla legge elettorale al sistema pensionistico, dalla chiusura di
una fabbrica alle norme della «buona scuola» — sono spesso decise da una
sentenza della Corte costituzionale o di un tribunale civile, penale,
amministrativo. Non è solo la politica ma tutta la vita sociale a risentire di
questa accresciuta presenza dell’ordine giudiziario. Negli ultimi anni gran
parte del nostro diritto di famiglia — dalle norme sulla fecondazione assistita
all’adozione del figlio del partner nelle coppie omosessuali — è stata
modificata attraverso decisioni dei tribunali. La liceità di una cura medica, la
possibilità di iscriversi all’università, i risultati di un concorso o
l’effettività di una promozione: questo e molto altro dipende ormai, come è
esperienza comune di tanti italiani, dalla sentenza di un tribunale. Non a caso
qualche tempo fa Romano Prodi ha provocatoriamente proposto l’abolizione dei Tar
e del Consiglio di Stato per favorire lo sviluppo economico, visto quanto il
continuo ricorso alla giustizia amministrativa influisce negativamente sugli
investimenti. Naturalmente occorre non dimenticare che un fenomeno del genere
caratterizza gran parte delle democrazie contemporanee. Ma forse nel nostro
Paese si presenta in modo accentuato. Anzitutto, è lo stesso apparente permanere
di una diffusa corruzione politica a sollecitare il continuo intervento delle
procure. Abbiamo poi troppe leggi, e troppo mal scritte, così da richiedere
spesso l’intervento di un magistrato per chiarire come vadano interpretate e
applicate. Ancora, abbiamo una classe politica poco capace o poco incline ad
assumersi le proprie responsabilità e ad esercitare i propri poteri: sintomatica
la vicenda delle leggi elettorali, in cui la politica chiede alla Corte
costituzionale cosa deve e può fare. Ma il progressivo assorbimento della
politica nel diritto, il condizionamento che le decisioni della magistratura
esercitano sulla vita sociale, dipendono anche da altro, in particolare da una
nuova concezione dei compiti della magistratura, soprattutto della magistratura
penale, affermatasi nel corso degli ultimi decenni. Tale concezione le assegna
come compito fondamentale non solo l’accertamento di, e la pronuncia su, singole
ipotesi di reato, bensì un generale controllo di legalità. Il magistrato,
dunque, non è tenuto a intervenire soltanto dopo aver ricevuto una notizia di
reato, ma — ha scritto Luciano Violante riassumendo (e criticando) questa
concezione — ha il compito di verificare «che la legalità non sia stata per caso
violata». In questo modo l’ordine giudiziario viene potenzialmente investito —
anche grazie al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, che nei fatti
estende la discrezionalità della magistratura inquirente — di una funzione di
supervisione sul complesso della vita politica e amministrativa. Bisogna dire
che in questo la magistratura è stata fortemente sollecitata da una domanda
proveniente dall’opinione pubblica, sempre più disgustata dalle cattive prove
offerte dalla classe politica. È nata così, da questo doppio movimento, l’idea
secondo cui la magistratura stessa sarebbe la grande tutrice della vita
collettiva del Paese, il soggetto che dovrebbe renderlo migliore sotto il
profilo dell’onestà e della moralità. Ma, a un quarto di secolo da Mani Pulite,
i continui casi di corruzione politica, le continue testimonianze di scarso
rispetto delle leggi in una parte significativa della società italiana, ci
dicono che non possono essere i giudici a rendere un Paese migliore.
De Giovanni: «La politica distrutta dall’invadenza delle
magistrature», scrive Errico Novi il 22 Dicembre 2016
su "Il Dubbio". L’analisi del filosofo sul vuoto della democrazia e il
predominio del potere giudiziario. Si può comprendere il mondo e ammettere di
non riuscirci. Può farlo solo un grande filosofo. Biagio De Giovanni ha dalla
sua non solo il pregio di entrare nella definizione, ma anche la luce di
ottantacinque anni, compiuti ieri e segnati in gran parte dalla riflessione
rigorosa e appassionata nello stesso tempo. Ne regala una sulla giustizia, e più
precisamente sulla perdita di ogni equilibrio tra i poteri, la politica da una
parte, «le Corti, le Alte Corti innanzitutto» dall’altra. Un intervento
sul Mattino di sabato scorso mette in fila in un sol colpo l’urgenza di superare
l’obbligatorietà dell’azione penale, l’ineludibilità della separazione delle
carriere, l’impossibilità di contrastare il «populismo giustizialista». Il caso
vuole che siano anche le battaglie in cui s’impegna con tutte le forze da anni
l’avvocatura. Il professore di Dottrine politiche, ex europarlamentare del Pci e
oggi appunto editorialista di Mattino e Corriere della Sera, individua nella
«invadenza della giurisdizione» un fenomeno caratteristico della crisi e una
concausa della perdita di autorevolezza delle élites. Nel giorno in cui compie
ottantacinque anni, è facile chiedere a un filosofo come De Giovanni di fingere
la resa di fronte al caos, per trovare molte risposte.
Anche la magistratura può temere una perdita di consenso? E
dietro il ritorno a una invadenza della giurisdizione nei confronti della
politica si nasconde anche un timore, tra i magistrati, di perdere popolarità?
«In prima battuta mi sentirei di
respingere l’ipotesi. C’è sfiducia, scetticismo, disincanto e rifiuto in una
forma così violenta nei confronti delle élites politiche che non si riesce a
scorgere qualcosa di analogo che riguardi la magistratura. E anzi l’impressione
è che mai come adesso l’azione dei magistrati si dispieghi a tutto campo, dalla
frittura di pesce a fatti più consistenti. È un’invadenza che non ha precedenti,
e che certo si inserisce in un processo iniziato con Mani pulite, passaggio che
ha alterato la fisionomia stessa del rapporto tra poteri».
Capita però che alcune sentenze non soddisfino appieno l’attesa
alimentata dal “populismo giustizialista”: a Roma una condanna a 20 anni anziché
all’ergastolo, per un omicidio, ha scatenato un putiferio in aula, solo qualche
giorno fa.
«I casi estremi si verificano. Resta
fermo un punto: sono le cosiddette élites politiche dominanti ad essere travolte
da quella tendenza del senso comune che faticosamente continuiamo a individuare
come populismo giustizialista. Renzi era leader da appena 3 anni eppure, come ho
detto dopo l’esito del referendum, è stato interpretato come nuova casta. La
vecchia, per converso, è diventata vergine, da De Mita a D’Alema. Ma c’è
qualcosa di vero anche nel dissolversi della fiducia nei magistrati: oggi
persino il giudizio penale si muove nell’incertezza della decisione. Prima si
condanna, poi si assolve, sembra divenuta impalpabile persino la certezza del
diritto. Anche questo canone delle vecchie società è crollato».
Non esiste insomma un potere che regga, in questa
destrutturazione.
«È possibile che la sfiducia nella
magistratura ci sia in una forma più indiretta. Il dispregio verso l’élite
politica resta però l’aspetto decisivo del nuovo ordine mondiale, chiamiamolo
così, che si va delineando. Una tenuta si registra forse in Germania dove il
sistema ha una forza formidabile, ma persino negli Stati Uniti capita che
Hillary, ritenuta espressione dell’establishment, ceda a Trump, che non è
nessuno, un uomo d’affari, eppure 60 milioni di persone nel Paese più potente al
mondo l’hanno votato».
Si delegittima la politica: ma così il potere scivola nelle mani
di altri soggetti, le élites finanziarie per esempio.
«Non c’è dubbio. Nel 2008 abbiamo
assistito a una prima grande crisi della globalizzazione, di natura finanziaria,
ora siamo nel pieno di nuova crisi, politica. E una fenomenologia di questa fase
è l’invadenza delle giurisdizioni».
Qual è il meccanismo preciso che spalanca le porte a questa
invadenza?
«Nessuno è in grado di governare la
complessità del mondo ed emergono poteri indiretti, non legittimati.
Nell’intervento apparso la settimana scorsa sul Mattino segnalo anche il
predominio delle Alte Corti sui Parlamenti. Che può sembrare un grande fatto di
civiltà, e in parte lo è: ma se una Corte costituzionale prevarica il potere
legislativo, si arriva alla distruzione dell’autonomia della politica».
Lei sostiene che si tratta di un pericolo sottovalutato.
«Siamo su un crinale che visto nel suo
insieme deve necessariamente preoccupare, e molto. Nello specifico si tratta di
un tema delicatissimo, di cui si parla con frequenza nel resto d’Europa ma non
in Italia, per timore che il solo accenno possa fraintendersi come volontà di
intaccare le prerogative della Corte costituzionale».
La causa decisiva di questo squilibrio è nella perdita di
autorevolezza della politica?
«Sicuramente, e temo si tratti di uno
squilibrio non rimediabile a breve».
Perché?
«La delegittimazione della politica
innesca un circolo vizioso che peggiora la qualità della classe dirigente e
induce ulteriore delegittimazione. È veramente difficile che ora come ora una
persona di spessore si impegni in un ruolo politico o amministrativo, sapendo
che al primo stormir di foglie l’obbligatorietà dell’azione penale entra in
campo, e arrivano i pm, e arriva la Guardia di finanza… Non è che voglio
sottovalutare il grado di degenerazione corruttiva che c’è in Italia, non è
questo il punto, ma se i pm oltrepassano ogni confine, mi domando chi ancora
possa decidere di mettersi in politica, se non un disperato in cerca di lavoro,
per non dire di peggio. Chi è che si va a impegnare in un’attività
amministrativa, in condizioni simili? È un pasticcio gigantesco, siamo di fronte
a un caos difficile da descrivere, figurarsi a volerlo dominare».
Non è che i cosiddetti privilegi della casta, dai vitalizi alle
immunità, sono in fondo garanzie a tutela di chi nel dedicarsi alla politica
mette a rischio il proprio ruolo sociale?
«Non c’è dubbio che sia così. E
aggiungo: nel Parlamento di oggi c’è ben poco che corrisponda alla condizione di
un’assemblea elettiva nazionale, i deputati sono cani sciolti, non sopravvive
più alcuna struttura mediana che garantisca l’effettiva espressione della
sovranità popolare. E a proposito di garanzie, fino ai primi anni Novanta era
necessario ricorressero condizioni davvero molto particolari perché un’assemblea
parlamentare potesse perdere un proprio componente. Il che non aveva a che
vedere con un privilegio abusivamente autoassegnato da una casta di impostori,
ma con il fatto appunto che il Parlamento è espressione del popolo sovrano, e in
quanto tale la sua collocazione è sacra, va tutelata, fino a un certo limite che
sia in armonia con lo Stato di diritto. Ma sfido a dire che le norme
sull’immunità non lo fossero».
Lei ha scritto: “La politica diventa qualcosa in cui si
preferisce non immischiarsi, sempre più abbandonata dai migliori”. Oltre
all’invadenza della giurisdizione, c’entra anche la retorica anti- casta?
«È un’ulteriore elemento che mette in
discussione la qualità della classe dirigente. Intendiamoci: il fenomeno di cui
parliamo non esiste solo in Italia, segna l’intero Occidente, come ricordato a
proposito di Trump, anche se da noi assume un carattere di gravità eccezionale.
Il tratto generale della crisi delle élites politiche, che si vede non solo in
Italia, è nell’impossibilità di cogliere un punto di mediazione tra globalismo
sovranazionale, cosmopolita, da una parte, e le appartenenze, le identità,
dall’altra».
In che modo questo spaesamento ci porta alla crisi della
rappresentanza?
«Innanzitutto è in questo vuoto che si
accresce il peso di poteri diversi, da quello finanziario al potere giudiziario.
Ma la risposta in sintesi è nel caso a noi più vicino: l’Europa si è dimostrata
incapace di governare la complessità della crisi finanziaria e politica che si è
affacciata nel 2008. Noi non possiamo limitarci a descrivere con tono disgustato
i critici delle élites, dobbiamo anche criticare le élites stesse. Non possiamo
ignorare cioè le ragioni del cosiddetto populismo, lo scollamento complessivo
tra governanti e governati. Non è che tutto sia riducibile alla cattiveria o
alla superficialità di chi alimenta la propaganda antisistema: è impossibile
negare il fatto che non ci sia una cultura politica in grado di governare la
complessità di questa crisi».
Il che non è un giudizio opinabile: è un fatto.
«Be’, abbiamo davanti un’intera
generazione distrutta. E appunto non è che si può risolvere tutto con il dito
puntato contro i populisti brutti, sporchi, cattivi e urlanti. Dentro quel buio
ci sono delle ragioni, non è che nasce dal nulla. Nasce dal fatto che nessuno,
tantomeno le élites, riesce a trovare le passerelle di passaggio dallo Stato
nazionale alla dimensione sovranazionale».
Lei sul Mattino individua l’urgenza di una riforma della
giustizia, e precisamente due passaggi: superamento dell’obbligatorietà
dell’azione penale e separazione delle carriere. La prima delle due questioni
non sarebbe perfetta, come terreno di incontro tra politica e magistratura per
una riforma, diciamo, concordata dell’ordinamento giudiziario?
«E sì che lo sarebbe, naturalmente, ma
abbia pazienza: davvero possiamo pensare che ci sia una politica così autorevole
da poter sollevare il tema dell’obbligatorietà dell’azione penale? Prendiamo ad
esempio il governo appena sconfitto dal referendum, che pure qualcosa provava a
farlo, ma che proprio sulla giustizia non è riuscito a muovere alcuna delle
questioni decisive di cui parliamo. Penso al ministro, Andrea Orlando, a questo
giovane pure così dinamico, che è riuscito a fare dei passi significativi su un
tema difficile come il carcere: ecco, come mai anche lui su punti come
obbligatorietà dell’azione penale e separazione delle carriere non ha detto
niente per tre anni?»
Ha detto, per essere precisi, che non c’erano assolutamente le
condizioni minime perché si potesse anche solo discutere di temi del genere.
«Appunto: alludeva evidentemente al
fatto che se ci avesse provato avrebbero subito detto ‘ecco gli amici dei
corrotti stanno provando a derubricare l’obbligatorietà dell’azione penale’. Non
è che si sarebbe riconosciuta la necessità di razionalizzare l’arbitrio».
Non c’è margine di discussione, nel senso comune si è diffuso un
riflesso condizionato che stronca in radice ogni tentativo su questo fronte.
«Nessuno vuol negare il rischio che
superare l’obbligatorietà schiuda il rischio di un controllo della giurisdizione
da parte dell’esecutivo, come avviene in Francia: eppure deve esserci una diga
al potere assoluto dei pubblici ministeri. Qui a Napoli è girata la notizia di
una misura chiesta dalla Procura, e negata dal gip, in cui l’accusa di
corruzione si basava sul fatto che l’indagato offrisse spesso alla controparte
caffè e cappuccini».
Considerare corruttivo il pagamento di un caffè a Napoli è
oggettivamente una bestemmia, senza dover scomodare Luciano De Crescenzo.
«Nel ridicolo farsa e tragedia si
mescolano sempre».
Figurarsi se esiste un margine per discutere di separazione delle
carriere.
«Non c’è possibilità. Dovremmo trovarci
con una classe dirigente politica talmente autorevole, dotata di una tale
legittimazione da essere in grado di sfidare anche l’ordalia che verrebbe
inevitabilmente scatenata dall’Associazione nazionale magistrati. La quale
arriverebbe a forme di contestazione estrema, allo sciopero, iniziative gravi
che un ordine giudiziario non si dovrebbe consentire. Ecco, possiamo dire che
quando ci troveremo con una classe politica in grado di inoltrarsi su un terreno
così accidentato allora potremo dire di essere usciti dalla crisi».
Sangermano: «Noi giudici non siamo maestri di morale», scrive Errico Novi il 24
Dicembre 2016 su "Il Dubbio". «No alla supplenza della magistratura:
comprometterebbe la legittimazione del sistema”. Un magistrato sa di non avere
strumenti per rimediare alla «debolezza della politica», come la definisce il
dottor Antonio Sangermano. Sa di non potersi neppure sostituire al legislatore.
Eppure il componente del direttivo Anm e sostituto procuratore a Prato – casa
sua e destinazione gradita dopo gli anni a Milano in cui tra l’altro è stato pm
al processo Ruby – prova a «proporre una riflessione anche su quello che è
inevitabilmente il tema del giorno, l’immigrazione, e su una misura dolorosa,
innanzitutto da punto di vista morale e religioso: arrivare a espulsioni
immediatamente efficaci per gli immigrati che hanno commesso reati sul
territorio nazionale. Lungi dal pretendere di indicare un dispositivo di legge:
è una riflessione, punto». Certo un’analisi, per Sangermano, è doverosa anche a
proposito della perdita di consenso sofferta dalla politica, che non si risolve
con una supplenza da parte dell’ordine giudiziario. E anzi, «se la magistratura
si sostituisse alla politica farebbe un danno innanzitutto a se stessa».
Partiamo da qui allora: mai come adesso la politica è al fondo
dell’indice di gradimento, e voi magistrati vi rendete conto ancora meglio,
forse, che non potete sostituirla: è così?
«Credo che la magistratura non debba
fare da supplente, vorrei chiarirlo subito. Il magistrato ha interesse a che la
politica sia forte e autorevole e nello stesso tempo rispetti l’autonomia e
indipendenza dei giudici. Se assumiamo un ruolo di supplenti, indeboliamo lo
stesso ordine giudiziario».
Perché, esattamente?
«Una supplenza dei magistrati certifica
il fallimento dello Stato, attribuisce loro un funzione in assenza di
legittimazione democratica. Anche se processi del genere non si attivano per
volontà espansiva, rappresentano comunque una delegittimazione del sistema: la
magistratura è un potere dello Stato, si fortifica quanto più solida è la
legittimazione del sistema nel suo complesso».
D’accordo, ma allora Mani pulite come si colloca in questa sua
condivisibilissima analisi?
«Premessa: considero Mani pulite un
momento di riscatto nazionale al pari del Risorgimento e della Resistenza, in
ufficio ho la foto del Pool. Il punto è che se un potere viene meno ai suoi
compiti, se nello specifico è un’intera classe politica a venir meno, la
magistratura deve fare il proprio dovere. In un caso come quello di Mani pulite
può verificarsi che la notevole quantità degli illeciti faccia apparire l’azione
giudiziaria come il processo a un fenomeno. Ma è solo la diffusività del
fenomeno a creare la percezione. D’altronde gli effetti che ne derivano tornano
a un certo punto nel do- minio della politica, come avvenne dopo il ’ 92-’ 93,
quando il vuoto creatosi favorì l’affermarsi di nuovi soggetti come il partito
di Berlusconi».
Senza volerla indurre a sostituirsi al legislatore, il tema
dell’immigrazione va affrontato semplicemente con una rigorosa distinzione tra
chi ha diritto all’asilo e i migranti economici?
«No, temo di no. Che l’accoglienza sia
la soluzione più consentanea ai principi di moralità ed etica non c’è dubbio.
Sono contrario ai respingimenti in mare: ma l’aspirazione etica va coniugata con
i dati di realtà, il che vuol dire riconoscere che un’accoglienza indiscriminata
crea un’effettiva insicurezza sociale».
E qual è il punto di equilibrio?
«L’integrazione deve coniugarsi a dei
doveri, il primo dei quali è il rispetto della legalità. Ora, se prendiamo i
curricula di chi in questi mesi si è reso responsabile di stragi in Paesi
europei, sarà difficile trovarne uno che non abbia precedenti per reati commessi
in quegli stessi Paesi o in altri del Vecchio Continente. Ecco perché dovremmo
riflettere sull’opportunità di rendere obbligatoria e non più facoltativa
l’espulsione di chi commette reati sul territorio nazionale».
Si dovrebbe attendere la condanna definitiva?
«No, d’altronde la norma vigente già
prevede la possibilità di espellere all’esito di un primo accertamento del
reato. Va fatta attenzione a possibili profili di incostituzionalità o di
incompatibilità con il diritto europeo. E so che l’obbligatorietà e
l’effettività manu militari delle espulsioni va ad impattare con aspetti
delicatissimi come i ricongiungimenti familiari. Ma credo si debba riservare una
particolare attenzione al profilo della sicurezza. Non v’è dubbio che il
legislatore dovrebbe trovare una forma normativa il più possibile umanizzata.
Così come si dovrebbe tener conto del fatto che non c’è solo il terrorismo, ma
anche il caso di chi reitera sul territorio nazionale reati di altra natura».
Le espulsioni pongono il problema dei Paesi d’origine, spesso
poco collaborativi, in materia.
«Però ad esempio il Paese d’origine di
Anis Amri, la Tunisia, se li riprende».
Da componente del direttivo Anm, condivide le critiche aspre
rivolte dal vostro presidente Davigo ai partiti, responsabili a suo giudizio di
non allontanare subito chi è accusato di corruzione?
«Ho un grande rispetto per il
presidente Davigo. È una persona di rara cultura e di garbo esemplare, ma non
concordo con lui su tutto. La politica ha il dovere di vigilare al proprio
interno e ha senso ricordarlo, ma senza che questo appaia come una sorta di
monito morale. A noi spetta accertare i reati. Possiamo suggerire soluzioni ma
senza che sembrino la scure di Danton».
Certo Davigo ha grande visibilità: potrebbe convenire all’Anm
prorogare la sua presidenza?
«Credo che Davigo sia un ottimo
presidente. E che la sua visibilità mediatica giovi all’intera magistratura,
perché consente di far affiorare giuste rivendicazioni. Nel corso di quest’anno
abbiamo ottenuto risultati, e mi lasci dire che questo credo dipenda anche
dall’impegno della mia componente, Unicost, servito a smussare posizioni
talvolta non condivisibili. Davigo ha avuto grande intelligenza politica
nell’incontro con Renzi di fine ottobre: credo che nella misura in cui saprà
portare a sintesi le diverse anime dell’Anm sarà un ottimo presidente, non lo
sarà se prevalesse un’inclinazione al protagonismo».
Ma potrà restare presidente anche oltre aprile?
«L’accordo fissa quella scadenza e non
penso che lui abbia intenzione di andare oltre, ha già pubblicamente dichiarato
di non vedere l’ora di concludere il mandato».
È vero che molti giudici si lamentano dei criteri seguiti dal Csm
nell’assegnare gli incarichi, e che sarebbe necessario chiarirli?
«Guardi, in questa consiliatura
l’organo di autogoverno ha predisposto un testo unico che definisce le regole
per l’attribuzione di direttivi e semidirettivi: la trovo una conquista storica.
In precedenza la progressione di carriera avveniva per mera assenza di demerito,
si è stabilito che invece deve basarsi sul merito. È il Csm che ha titolo a fare
le valutazioni: poi certo, il testo unico deve completare una fase di rodaggio,
ma al Consiglio superiore si deve dare atto della scelta innovativa. E
personalmente credo che non si dovrebbe mai delegittimare il Csm: in questi anni
ha assicurato davvero l’autonomia e l’indipendenza di noi magistrati».
I GIORNALISTI. I KILLER DELLA PRIMA REPUBBLICA.
Così i giornalisti fecero i killer della prima Repubblica,
scrive Piero Sansonetti il 29 Dicembre 2016, su "Il Dubbio". La grande alleanza
tra media e pm affondò un intero sistema politico. La Prima Repubblica era una
cosa buona? Chi l’ha uccisa? Pierluigi Battista ha scritto un articolo sulla
“Lettura” (il supplemento domenicale del “Corriere della Sera”) nel quale
rimpiange quel periodo della storia recente del nostro paese, che fu il periodo
del grande sviluppo economico e della affermazione della democrazia. E ne esalta
molti aspetti positivi. Ieri Emanuele Macaluso, in uno scritto che abbiamo
pubblicato sul Dubbio, ha fatto osservare che negli anni nei quali la prima
Repubblica fu liquidata dall’inchiesta “Mani Pulite” i giornali certamente non
la difesero. Vorrei andare un pochino oltre la giusta affermazione di Macaluso
(che è stato tra i dirigenti più importanti di quella fase della vita
repubblicana). Credo che i giornali e i giornalisti svolsero il ruolo di killer
del sistema dei partiti e quindi della prima Repubblica. Assumendosi l’incarico
di demolire una parte della Costituzione repubblicana, e cioè quella che
delineava un sistema democratico forte e fondato sulla struttura dei partiti e
dei sindacati. (Curioso notare che oggi quelli che ritengono intoccabile la
Costituzione repubblicana sono o gli stessi o gli eredi di coloro che la
demolirono 25 anni fa). I giornali e i giornalisti presero su di se,
consapevolmente e baldanzosamente, una responsabilità diretta e macroscopica.
Guidando la cacciata dei partiti dal potere politico, spianando la strada alla
magistratura, e costruendo le basi materiali e teoriche per il giustizialismo, e
cioè per quella ideologia robusta che – dall’inizio degli anni novanta – diventò
(ed è ancora) l’ideologia nazionale, sostituendo l’ideologia dell’antifascismo,
che nel primo mezzo secolo del dopoguerra aveva costituito l’elemento unificante
dello spirito pubblico nazionale. Cosa fecero i giornali e i giornalisti?
Usarono le inchieste della magistratura come artiglieria per sparare sul
quartier generale. Decisero, con uso largo di grandi mezzi, di descrivere il
Palazzo della politica come un luogo ignobile di ruberie e sotterfugi, abitato
esclusivamente da malfattori e lestofanti. E subito dopo assunsero il ruolo di
guida del paese, che era stato abbandonato dalla politica in fuga e che non
poteva essere raccolto direttamente dai magistrati, modificando completamente la
propria funzione intellettuale e civile, e preparandosi a partecipare al nuovo
potere politico. Il disegno non riuscì del tutto perché quando la prima
Repubblica sprofondò definitivamente, prima con un plebiscito che abolì la legge
elettorale e quindici giorni dopo con il linciaggio in piazza di Bettino Craxi (
18 e 30 aprile 1993), cioè con due strumenti tipici dell’insurrezione, ci fu la
reazione ( imprevista) di un pezzo minoritario ma assai rampante della
borghesia, guidato da Silvio Berlusconi, che deviò la rotta che giornali,
magistrati e poteri economici ( soprattutto quelli che si radunavano attorno
alla famiglia Agnelli) avevano previsto. E’ nata così, un po’ sbilenca, la
seconda repubblica. In quella alleanza coi magistrati e la grande finanza, il
compito dei giornalisti fu decisivo, e il modo nel quale si organizzarono molto
ben studiato e definito. E’ vero che alla fine gli altri due membri
dell’alleanza portarono a casa gran parte del bottino, e i giornalisti restarono
a mani vuote, ma questo non ridimensiona il ruolo che ebbero di “punta di
lancia” dell’operazione. Altre volte ho parlato come testimone diretto di quella
vicenda. Ora, visto che il tema è tornato alla ribalta – e credo che sia un nodo
decisivo della storia, non spettacolare, della crisi del giornalismo italiano e
dello stato di subalternità e di inferiorità nel quale vive – voglio essere
ancora più preciso. I principali giornali italiani avevano costituito un “pool”,
rinunciando a quell’elemento decisivo, storicamente, nella vita dei giornali e
del giornalismo, che è la competizione e la concorrenza. Quattro giornali
firmarono un patto di ferro: “Il Corriere della Sera”, “La Stampa”, “L’Unità” e
“La “Repubblica”. Tranne Eugenio Scalfari, tutti gli altri direttori furono
direttamente coinvolti in questo patto. Erano personaggi di primissimo piano, e
contavano moltissimo nell’establishment, e furono tra i pochissimi che non
furono travolti dall’” insurrezione”, anzi la guidarono. Paolo Mieli, Ezio
Mauro, Walter Veltroni, che erano i direttori dei primi tre giornali, e un certo
numero di capiredattori di Repubblica, il nome più noto è quello di Antonio
Polito. Non ho mai potuto accertare se Scalfari sapesse e se approvasse. Ho solo
un sospetto. Io all’epoca ero condirettore dell’Unità, e dunque – lo confesso –
partecipai direttamente a molti colloqui e assistetti a tutto ciò che avvenne.
Ogni sera, verso le sette, i direttori o i vicedirettori o i capiredattori, si
sentivano per telefono e decidevano come fare le prime pagine, come dare le
notizie, con quale forza, con quale gerarchia. Tutte le notizie, ovviamente, ma
soprattutto le notizie che riguardavano il palazzo e l’inchiesta sulle Tangenti,
che ogni giorno mieteva nuove vittime. Le “macchine”, come si dice in gergo, dei
giornali furono rivoluzionate. I giornalisti non erano più titolari delle
notizie, rispondevano a questa specie di “spectre” che era il supervertice dei
quattro giornali. Il pool di direttori si interfacciava con in pool di
giornalisti giudiziari, che aveva coinvolto anche giornalisti delle Tv, ed era
alle dirette dipendenze delle Procure, e in particolare della Procura di Milano.
Nessun giornalista giudiziario che non facesse parte del pool poteva più
accedere a nessun tipo di notizia di giudiziaria, e rapidamente, per questa
ragione, veniva eliminato dalla piazza. Il pool dei direttori – nel quale
spiccava una specie di diarchia: Mieli che era il giornalista più autorevole, e
Veltroni, che guidava un giornale ma era l’unico esponente della politica
ammesso a questo consesso – aveva assunto anche vere e proprie funzioni
legislative. L’esempio più clamoroso è quello del decreto– Conso. E’ un decreto
legge varato dal Consiglio dei ministri il 5 marzo del 1993 ( come vedete, se
fate attenzione alle date, di poche settimane precedente al referendum–
plebiscito e al linciaggio di Craxi, cioè agli atti finali dell’insurrezione)
nel quale il ministro della giustizia, Giovanni Conso ( giurista celebre e
stimatissimo, ex presidente della Corte Costituzionale) disponeva la
depenalizzazione del finanziamento illecito dei partiti ( non degli
arricchimenti personali) per porre un argine all’ondata giustizialista. Il
decreto non fu bocciato dal Parlamento ma dal pool dei giornali. Ricordo che
quel giorno all’ Unità era arrivato un articolo di un dirigente del partito,
favorevole al decreto. Poi alle sette del pomeriggio ci fu l’abituale giro di
telefonate con gli latri direttori e si decise di affossare il decreto.
L’editoriale fu corretto. Il giorno dopo i quattro giornali spararono a palle
incatenate, e tutti gli altri giornali li seguirono (la potenza di fuoco di quei
quattro giornali era grandissima e costringeva le altre testate ad adeguarsi).
Il Presidente della Repubblica si rifiutò di firmare il decreto, che decadde. E
quello fu lo squillo di tromba che diede il via all’ultima e definitiva
offensiva che travolse gli argini e annientò la prima Repubblica e un’intera, e
valorosissima, classe dirigente che aveva portato l’Italia ai grandi successi
economici e alla conquista della democrazia piena e dello Stato di diritto. Le
cose andarono così, e tanti miei colleghi possono confermare. Quali furono le
conseguenze per la solidità della nostra democrazia è ancora oggetto di
discussione. Personalmente credo che la democrazia fu fortemente indebolita. Da
due elementi. Il primo è il dilagare dell’ideologia giustizialista, che ha
travolto lo Stato di diritto. Il giustizialismo è una ideologia che non credo
sia compatibile con la democrazia liberale. Il secondo elemento è lo strapotere
che è stato assunto dalla magistratura e dall’economia, che ha messo in
discussione lo Stato liberale. Non si è mai invece nemmeno discusso di quali
furono le conseguenze per il giornalismo italiano. Io credo che in quei giorni
il giornalismo italiano morì. Sepolto dal suo tradimento. Il giornalismo nel suo
Dna ha l’obbligo di informare, ha la ricerca dell’oggettività, la terzietà
rispetto agli scontri di potere. Il giornalismo ha l’obbligo di criticare il
potere, di contrapporvisi. In quelle giornate tra il 1992 e il 1993 abiurò.
Decise di farsi travolgere nelle lotte del potere e di diventarne parte attiva e
anzi parte dirigente. Di accettare la subalternità ai magistrati e ai potenti
dell’economia, nella convinzione di poter poi svolgere una funzione di guida
nella nuova alleanza. Non gli fu affidata la guida, invece, ma solo una funzione
servile. Non si è mai ripreso – credo – da quel crollo. Forse per questo oggi il
giornalismo italiano è lontano mille miglia dal grande giornalismo europeo e
americano. Loro hanno “Le Monde”, il “New York Times”, fanno informazione e
cultura. Noi abbiamo “Il Fatto” (e molti altri simili), facciamo propaganda e
ufficio stampa alle Procure.
Quella giornata particolare del 1992 in cui incontrai Di Pietro…scrive
Francesco Damato il 30 Dicembre 2016 su "Il Dubbio". Il pm mi rassicurò che in
nessuna delle carte spedite dalla procura alla Camera si può trovare uno spunto
a carico dell’ex presidente del Consiglio Bettino Craxi. All’onesto e
autocritico racconto di Piero Sansonetti, ieri sul Dubbio, vorrei aggiungere una
testimonianza sul ruolo a dir poco improprio svolto dai giornali negli anni
terribili delle indagini giudiziarie sul finanziamento troppo a lungo illegale
della politica. Terribili, come li ha giustamente definiti in un libro di
meritato successo Mattia Feltri, rimbrottato dal padre, Vittorio, che diede in
quei tempi il suo contributo all’imbarbarimento dell’informazione, scambiando
spesso lucciole per lanterne, comunque trasformandosi in un megafono delle
Procure, a cominciare naturalmente da quella di Milano. È proprio a Milano che
scorre, nella primavera del 1992, quella giornata particolare, diciamo così,
della mia esperienza più diretta di Mani pulite, che è rimasto il nome della
vicenda giudiziaria costata la vita a un po’ di imputati, suicidi o no, e
soprattutto alla cosiddetta prima Repubblica. Che pure non aveva certamente
demeritato nella costruzione della democrazia in Italia dopo le tragedie del
fascismo e della guerra. Quella giornata particolare del 1992 quando incontrai a
Milano Tonino Di Pietro…Le agenzie trasmettono dalla prima mattina indiscrezioni
provenienti dalla Camera, dove la giunta delle autorizzazioni a procedere è alle
prese con le carte giunte dalla Procura ambrosiana sugli ex sindaci socialisti
di Milano Paolo Pillitteri e Carlo Tognoli, sospettati di ricettazione delle
tangenti gestite dal collega di partito Mario Chiesa, arrestato il 17 febbraio
in flagranza di reato con un’operazione diretta da Antonio Di Pietro. Le
indiscrezioni romane, in gran parte diffuse o attribuite poi, a torto o a
ragione, al deputato ambientalista Mauro Paissan, ex direttore
del Manifesto, considerano il leader del Psi Bettino Craxi, peraltro cognato di
Pillitteri, già coinvolto nelle indagini. E quindi fortemente a rischio nella
crisi che sta gestendo il nuovo presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro
per la formazione del primo governo della legislatura uscita dalle urne del 18
aprile. Si sa che esiste un accordo addirittura pre-elettorale fra democristiani
e socialisti per un ritorno di Craxi a Palazzo Chigi, da dove egli era stato
sfrattato in malo modo nel 1987, dopo quasi quattro anni di governo, dall’allora
segretario della Dc Ciriaco De Mita, sostituito poi da Arnaldo Forlani, vice
dello stesso Craxi in quell’esperienza di capo del governo. Nel pomeriggio di
quella giornata di primavera, tornando a piedi nella redazione del Giorno, che
dirigo da tre anni, incontro per caso in Piazza della Scala Antonio Di Pietro.
Che allontana col cenno di una mano gli agenti della scorta per venirmi incontro
e parlarmi. Ci conosciamo solo superficialmente, avendolo incontrato una sola
volta a pranzo, all’inizio del mio incarico al Giorno, col comune amico Claudio
Dini, presidente della Metropolitana Milanese. Debbo inoltre a Di Pietro una
certa gratitudine professionale perché, pur conoscendo il modo non acritico in
cui seguivo le sue inchieste, ha avuto l’onestà in una intervista di difendermi
dalle accuse, provenienti anche dall’interno del mio giornale, di non divulgare
col dovuto rilievo, diciamo così, le notizie della Procura. D’altronde era stato
proprio Il Giorno a destare l’anno prima la curiosità della Procura con servizi
di cronaca su ciò che accadeva negli ospedali per la macabra corsa delle agenzie
funebri all’accaparramento dei clienti. E all’arresto di Chiesa, presidente
della cosiddetta Baggina, ospedale e insieme casa di riposo, Il Giorno era stato
il solo a sparare la notizia in prima pagina, per mia personale decisione: tanto
che all’indomani, visti gli altri giornali, nella prima riunione redazionale
chiesi, un po’ preoccupato, al responsabile della Cronaca se fosse sicuro della
notizia nei termini da noi riferiti. Cosa, questa, che dopo qualche tempo –
giusto per darvi l’idea del clima che stava montando – avrei trovato raccontato
su un quotidiano come prova di un mio intervento censorio sulla redazione. Ma
torniamo all’incontro con Di Pietro in quel pomeriggio. Tonino, come lo chiamano
gli amici, allarga le braccia e mi esprime tutto il suo stupore per le notizie,
anzi per le indiscrezioni diffuse dalle agenzie sul coinvolgimento del
presidente. Ch’egli nomina così facendo cenno verso la Galleria, cioè verso gli
uffici milanesi di Craxi. Di Pietro mi assicura che in nessuna delle carte
spedite dalla Procura alla Camera si può trovare uno spunto a carico dell’ex
presidente del Consiglio. E mi anticipa che fra poco la stessa Procura emetterà
una nota. In effetti dopo un paio d’ore viene diffusa una smentita dagli uffici
giudiziari con la classica formula dell’estraneità di Craxi ‘ allo stato’ delle
indagini. Formula che poi sarà usata dal capo della Procura, Francesco Saverio
Borrelli, nella inusuale partecipazione alle consultazioni riservate del
presidente della Repubblica per la formazione del nuovo governo. Che si
risolveranno col conferimento dell’incarico a Giuliano Amato, anziché a Craxi.
Nella riunione serale di redazione per la confezione della prima pagina
decidiamo di titolare sul comunicato della Procura, destinando le indiscrezioni
a carico del segretario socialista non ricordo più se al sommario o al
catenaccio, come si chiama in gergo tecnico un rigo vistoso di sottotitolo:
tutto a metà pagina, per dare più spazio agli arresti ormai di giornata. A tarda
sera, mentre sto per scendere in tipografia a chiudere il giornale – altro gergo
tecnico – mi chiama da Roma l’amico Ugo Intini, portavoce e consigliere di
Craxi, per chiedermi la cortesia di dirgli come saremmo usciti. Alla lettura del
titolo mi chiede un’altra cortesia: Posso farti chiamare da Roberto? Che è
Villetti, direttore dello storico Avanti!, il quotidiano ufficiale del Psi.
Villetti mi chiama dopo un quarto d’ora e non mi lascia neppure il tempo di
salutarlo perché mi assale, letteralmente, con questa domanda: ‘ Ma è vero che
esci titolando sulla smentita della Procura? Certo. È l’unica notizia vera. Il
resto è un assemblaggio di condizionali, di sembra che, di pare. Vuoi che
privilegi questa roba, utile solo a boicottare l’incarico di governo a Craxi?,
gli rispondo. Roberto si traveste da fratello, non bastandogli più l’amicizia, e
mi dice, accorato: ‘ Francesco, ma che fai? Non essere più realista del re.
Questo ti nuoce professionalmente. Non reggo più a sentirlo. Lo saluto e fuggo
via dal telefono. Sono sinceramente esterrefatto. Mi metto le mani fra i capelli
pensando a qualche mese prima, a quella trattoria di Bari dove avevo trattenuto
Bettino dall’intenzione che mi aveva espresso di cambiare il direttore
dell’Avanti!. Non avevo neppure fatto tanta fatica. Mi era bastato chiedere a
Craxi perché mai volesse fare di Roberto un martire. Il primo avviso di garanzia
al leader socialista sarebbe arrivato verso la fine del 1992: il primo di una
lunga serie. E dopo qualche settimana si sarebbe dimesso da segretario del
partito scrivendomi, con quella sua grafia grande e frettolosa: ‘ Faccio come il
generale Kutuzov. Indietreggio per poter poi attaccare’. Povero Bettino. Si
illudeva di poter ancora fronteggiare la belva scatenata da quella che dopo,
molto dopo, il buon Luciano Violante avrebbe sarcasticamente chiamato la
carriera unica di pubblici ministeri e giornalisti. E che Piero Sansonetti ha
efficacemente descritto raccontando delle telefonate che scorrevano ogni sera
fra le redazioni dei maggiori giornali, compreso il suo, l’Unità, per
consultarsi e uscire poi il più omogeneamente possibile. *** Fa bene Piero a
dubitare della consapevolezza di Eugenio Scalfari in questa partita. Di lui
ricordo nitidamente, senza bisogno di ricorrere all’archivio, l’editoriale sui
decreti che, su iniziativa dell’allora guardasigilli Giovanni Conso, il primo
governo di Giuliano Amato varò nel marzo del 2013 per la cosiddetta ‘ uscita
politica’ da Tangentopoli. Che non sarebbe forse servita a salvare lo stesso la
prima Repubblica – quella vera, non la Repubblica di carta di Scalfari – ma
avrebbe probabilmente ridotto le perdite. Usciti peraltro da una lunghissima
riunione del Consiglio dei ministri, sospesa una ventina di volte per consentire
consultazioni telefoniche fra gli uffici di Palazzo Chigi e del Quirinale, i
decreti Conso furono giudicati positivamente da Scalfari. Che non aveva previsto
le proteste della Procura di Milano, il cui capo lesse personalmente davanti
alle telecamere una dichiarazione di forte dissenso, negando che quella roba lì
rispondesse in qualche modo, come si era scritto da qualche parte, alle attese
degli ormai stanchi inquirenti; spiegando che le nuove norme avrebbero invece
danneggiato le indagini; minacciando infine ricorsi alla Corte Costituzionale.
Tanto bastò al capo dello Stato per scomodare di domenica i suoi uffici al
Quirinale e fare annunciare un suo motivato rifiuto di firmare i decreti legge e
renderli esecutivi. Giocò, in particolare, contro uno dei decreti il fatto che,
riformando la legge sul finanziamento dei partiti avrebbe fatto saltare un
imminente referendum abrogativo della stessa legge promosso dai radicali. Se il
decreto non fosse stato approvato dalle Camere entro i 60 giorni prescritti
dalla Costituzione, il danno apportato al referendum – osservò Scalfaro –
sarebbe risultato irrimediabile. Comunque motivato, l’imprevisto rifiutò della
firma di Scalfaro segnò, dopo la resa della libera informazione e quella della
politica, la resa anche delle istituzioni. Per la Repubblica, senza
discontinuità purtroppo fra la prima che moriva e la seconda che si affacciava
in quei giorni alle finestre del referendum elettorale contro il sistema
proporzionale, fu un’altra storia. Per uscire dalla quale, con un riequilibrio
fra politica e giustizia, entrambe al minuscolo per favore, chissà quanto altro
tempo dovrà ancora trascorrere.
Com'è stato "ucciso" Craxi, scrive
"Abcnews.free.fr" (Da "Sicilia Sera"). La morte di Bettino Craxi ha messo in
luce alcune gravi aberrazioni del sistema giuridico italiano (condannate
costantemente già da tempi dalla Corte europea per i diritti dell'uomo di
Strasburgo) che hanno permesso e permettono abusi in serie. Calpestati
sistematicamente principi fondamentali del diritto. Una dichiarazione
illuminante del Procuratore della Repubblica di Milano, Gerardo D'Ambrosio. A
seguito della morte di Bettino Craxi, il "pool" milanese detto di "mani pulite"
è stato letteralmente sommerso da accuse per non aver permesso a Craxi di
rientrare in Italia da libero per consentirgli di curarsi adeguatamente in una
clinica milanese che dava ogni garanzia operatoria e post-operatoria, invece che
in una struttura tunisina assai meno adeguata. Ciò avrebbe permesso a Craxi di
essere curato seriamente, ed oggi sarebbe probabilmente ancora in vita. Per
difendersi da queste critiche, il Procuratore di Milano Gerardo D'Ambrosio ha
dichiarato a "Repubblica" che non era possibile far rientrare Craxi in Italia da
libero, poiché c'erano ormai a suo carico condanne definitive. Ebbene, con
questa dichiarazione, il D'Ambrosio non ha fatto che dare - certo
involontariamente - la misura di quanto aberrante sia l'attuale sistema
giuridico italiano. In qualunque altro paese civile infatti una condanna non può
mai diventare definitiva se emessa in un processo in cui l'accusato, per una
ragione o l'altra, non è stato presente. Anche nel caso che, come Craxi, vi si
sta sottratto volontariamente "con la fuga", come suol dirsi. Nessuno in effetti
è tenuto ad andare volontariamente contro se stesso presentandosi al carnefice,
o comunque ad un tribunale che potrebbe attribuirgli una pesante condanna. Per
esempio in Francia (la cui magistratura è notoriamente fra le più rispettate del
mondo) se un tribunale condanna qualcuno non presente al processo (cioè, come
suol dirsi, "contumace" o "latitante") la condanna non può diventare definitiva.
Se in seguito il condannato si presenta volontariamente, oppure è catturato, il
processo viene rifatto in sua presenza. Un processo è infatti costituito da tre
elementi indispensabili: l'accusatore, l'accusato e il giudice. Se ne manca uno
- per esempio l'accusato - non può considerarsi un vero processo. Si tratta di
un principio fondamentale, inderogabile del diritto, mirante ad evitare che si
possa condannare qualcuno senza che si difenda. Anche in Italia "culla del
diritto"(ma divenutane la tomba) vigeva naturalmente questo principio
fondamentale. Finchè prima della seconda guerra mondiale, negli anni 30, il
regime di allora, per mettere facilmente i suoi oppositori nell'impossibilità di
nuocere, trovò comodo sostituirlo con il criterio antigiuridico che una condanna
"contumaciale" poteva diventare definitiva ed esecutiva. Questo "criterio"
mostrò largamente la sua efficacia con accusati che si chiamavano, per esempio,
Pietro Nenni, Giuseppe Saragat, Sandro Pertini, Luigi Sturzo, Giorgio Amendola.
Grazie ad esso, alcuni di costoro si trovarono in galera senza essersi potuti
difendere, in seguito a condanne che si facevano risultare "definitive ed
esecutive" senza che al processo si fossero mai visti gli accusati; ed altri,
per non subire la stessa sorte, dovettero riparare all'estero, Francia e Stati
Uniti soprattutto. Finita la guerra e caduto il regime di allora, molte cose
cambiarono in Italia, ed anche si ribaltarono. Saragat e Pertini, i condannato
rifugiatisi in Francia, divennero perfino Presidenti della repubblica italiana.
Ma, stranamente, quel criterio antigiuridico che era stato loro applicato non fu
eliminato dal nuovo regime repubblicano...Ed è così che lo si è potuto applicare
ora anche a Bettino Craxi ... fino alla sua morte. Il più strano è che nessun
media ha rilevato quanto elemento di importanza capitale. Eppure, a causa di
questo criterio antigiuridico, l'Italia ha già subito innumerevoli condanne
dalla Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo che le ha ingiunto,
come in suo potere, di rientrare nella legalità rispettando quel principio
fondamentale. Ma l'Italia non ha ancora ottemperato, restando così in piena
illegalità. Identico sistema era stato a suo tempo usato contro un giornalista e
scrittore le cui famose inchieste e campagne di stampa negli anni 60 e 70
rendevano particolarmente "scomodo" per certi ambienti e personaggi politici ed
economici italiani molto "in alto, dalle attività non precisamente confessabili.
Stiamo parlando di Stefano Surace. Non riuscendo a farlo condannare normalmente,
poiché le sue inchieste erano ben documentate, gli si lanciarono contro degli
ordini di cattura per pretesti reati a mezzo stampa, sicché fu costretto a
riparare all'estero (come farà appunto Craxi). Dopodiché gli si lanciò, in sua
assenza, una vera raffica di condanne per pretesi reati a mezzo stampa, per un
assurdo totale di ... diciotto anni di galera (neanche per un assassinio
efferato); che, come per Craxi, furono fatte diventare subito definitive ed
esecutive grazie a quel criterio antigiuridico. Ma per Surace le cose andarono
un po' diversamente che per Craxi. La magistratura francese (ripetiamo, fra le
più stimate del mondo) ha considerato "inesistenti giuridicamente" tutte
(diciamo tutte) quelle condanne attribuitegli in Italia, constatando che erano
state emesse in violazione di principi fondamentali del diritto; fra cui quello,
appunto, che una condanna contumaciale non può essere dichiarata definitiva. Per
di più il Presidente della repubblica francese, Jacques Chirac, decorò Surace
della medaglia d'oro, sulla quale è inciso "Parigi a Stefano Surace"...Lezione
esemplare per quei magistrati italiani che pretendevano di fargli fare diciotto
anni di galera! Surace è stato letteralmente coperto di onori anche in Spagna,
in Gran Bretagna e perfino in Giappone. Lo stesso governo italiano, rendendosi
conto di quanto l'"affaire Surace" danneggiasse anche all'estero l'immagine
della Penisola - e non sapendo cos'altro fare poiché il giornalista-scrittore
rifiutava ogni ipotesi di grazia che non comportasse una esplicita sconfessione
ufficiale di quelle condanne - rinunciò a qualsiasi tentativo di estradizione
(d'altronde senza speranza) vietando agli organi competenti qualsiasi procedura
in tal senso nei suoi riguardi. Da aggiungere che, allorché Surace dovette
espatriare in Francia, certi personaggi dell'Ordine dei giornalisti, invece di
mobilitarsi in sua difesa come loro dovere, tentarono di pugnalarlo alle spalle,
radiandolo. Ma in seguito la Corte di Appello di Napoli e la Corte di Cassazione
hanno dichiarato illegittima questa radiazione e l'Ordine ha dovuto
reiscriverlo. Ed ora i legali del Surace hanno citato l'Ordine per 19 miliardi
di lire, a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali cagionati da
quella radiazione indebita. Ma questo contro Surace non era stato che l'ultimo
episodio di una lunga serie di autentici "safari" contro personaggi scomodi. Per
esempio quello contro un altro grande giornalista, Gaetano Baldacci. Fondatore
de "Il Giorno" (quotidiano che in qualche mese di vita, con lui direttore, aveva
quasi superato il "Corriere della Sera") in seguito aveva lasciato "Il Giorno"
fondando il celebre settimanale "ABC" (di cui era direttore ed editore)
concentrandovi quasi tutti i giornalisti italiani "troppo vivaci". Ma non si
tardò a lanciargli un ordine di cattura con un'accusa fasulla, tanto che dovette
rifugiarsi in Libano e poi in Canada. Parecchi anni dopo si riconobbe che
l'accusa era fasulla, ma intanto era stato distrutto: tornato in Italia, dopo
pochi mesi morì di crepacuore. Mino Pecorelli, giornalista molto deprecato in
certi ambienti anche per la straordinaria esattezza delle sue notizie, commentò
ad un certo punto sul suo settimanale "OP" ("Osservatorio Politico"): "Una
giustizia che realizzi simili exploits perde ogni residua credibilità non solo
all'interno del Paese, ma anche a livello internazionale. Non si tratta difatti
di semplici errori come possono sempre capitarne, ma di una serie lunghissima di
fatti aberranti". Ebbene, pochi giorni dopo aver scritto queste righe, Pecorelli
fu ucciso da un killer. Si cercò di addossare la colpa del delitto ad Andreotti,
chiudendo sistematicamente gli occhi su altre piste, indicate proprio da Stefano
Surace in alcuni suoi libri e interviste alla stampa e alla televisione. Piste
che conducevano diritto ad ambienti vicini a certi magistrati di Monza, che
Pecorelli aveva additato alla pubblica attenzione per certo loro operato a
favore di petrolieri evasori e di loro complici "ad alto livello", nel quadro
del famoso scandalo dei petroli. Dopo anni, le accuse contro Andreotti sono
cadute clamorosamente, ma - poiché le altre piste erano state ignorate con cura
- i responsabili di quel delitto restano tuttora "ignoti"...Intanto un gruppo di
intellettuali (l'italiano Federico Navarro, il francese Daniel Mercier e
l'italo-francese Angelo Zambon) hanno promosso una petizione indirizzata alle
autorità politiche, in cui si sottolineano fra l'altro "i casi gravissimi che
sono stati resi possibili dal fatto che in Italia è ancora in vigore un tipo di
processo penale contumaciale che viola gravemente il diritto, consentendo fra
l'altro di dichiarare definitive ed esecutive condanne emesse in assenza
dell'accusato; come costantemente ribadito anche dalla Corte europea pei diritti
dell'uomo, che per questa ragione ha condannato ormai innumerevoli volte
l'Italia". Affare da seguire...
TANGENTOPOLI. UN TEMA STORICO.
Vi racconto la vera storia del linciaggio a Bettino Craxi,
scrive Francesco Damato l'1 dicembre 2016, su "Il Dubbio". Il paragone tra lui e
Renzi? Non è esatto. Così fu lasciato solo il leader socialista. La timida
difesa di D'Alema da "l'assalto dei cani". A Bettino Craxi non è capitata la
disavventura del suo antagonista Enrico Berlinguer, arruolato d'ufficio ai
primordi della campagna referendaria nel fronte del Sì alla riforma
costituzionale fra le proteste della figlia Bianca. Che forse ha perduto anche
per questo, la direzione del Tg3, già pericolante di suo e logorata da una
durata non comune nella storia della Rai. Bianca, d'altronde, è lì,
professionalmente in sella come merita. Ma allo scomparso leader socialista è
forse accaduto anche di peggio. Non so, se dove si trova, e presumo possa
guardare molto dall'alto ciò che miseramente accade quaggiù, può aver gradito
quella "certa arroganza" rimproveratagli dall'amico Silvio Berlusconi, in una
intervista alla nostra Paola Sacchi, per paragonarlo all'attuale presidente del
Consiglio. Dal quale comunque, e per fortuna, l'ex Cavaliere ha avuto almeno il
buon gusto di distinguerlo per l'ampiezza di visione politica che mancherebbe al
toscano. Meno male, visto anche come Renzi parla di Craxi, lamentandone quanto
meno l'"opportunismo", contrapposto alla "generosità", o qualcosa di simile, di
Berlinguer. Non so neppure quanto abbia potuto Craxi apprezzare da lassù il
merito appena rivendicato quaggiù da Massimo D'Alema di averlo difeso dai "cani"
che l'azzannarono dopo la caduta, come forse lo stesso D'Alema teme o spera di
dover fare col rottamatore Renzi dopo la prevedibile, e comunque da lui
prevista, sconfitta rovinosa nel referendum di domenica prossima. L'ultima
immagine di D'Alema conservata da Craxi, riferitagli da me dopo un incontro col
nostro comune amico Gerardo Bianco, è quella di un uomo gelidamente silenzioso,
e consenziente, in una riunione che precedette alla Camera le votazioni a
scrutinio segreto sul grappolo delle autorizzazioni a procedere contro l'ormai
ex segretario giornalista avanzate dalla Procura di Milano e altre. Si era a
fine aprile del 1993. Il governo di Carlo Azeglio Ciampi, comprensivo di
ministri e sottosegretari del Pds-ex Pci, era fresco di nomina e attendeva la
fiducia dei deputati. Achille Occhetto, accompagnato appunto da D'Alema, chiese
un incontro col segretario della Dc Mino Martinazzoli, che Bianco ospitò nel
proprio ufficio di Montecitorio. Il segretario dell'ex Pci chiese come "prova
della svolta" politica costituita dal governo Ciampi, subentrato al primo
governo di Giuliano Amato, che i deputati democristiani, per i quali avrebbe
parlato in aula proprio Bianco, votassero a favore dei processi a Craxi.
Martinazzoli cadde dalle nuvole e, anche come avvocato, spiegò come e perché i
parlamentari democristiani non fossero soliti ricevere ordini in quelle
circostanze, dovendo votare solo "secondo coscienza". Cosa che in effetti fu poi
ripetuto in assemblea da Bianco con un discorso interrotto dalla sinistra, dalla
destra e dai leghisti perché troppo riguardoso verso l'ex presidente del
Consiglio. Di cui furono permessi solo alcuni dei processi, non tutti. Scoppiò
allora il finimondo, in aula e fuori. Occhetto, sempre nel silenzio del suo
capogruppo, ordinò per ritorsione il ritiro della "delegazione" post-comunista
dal governo. E la folla inferocita, raccolta per un comizio in Piazza Navona, si
riversò davanti alla vicina residenza alberghiera di Craxi per rovesciargli
addosso ingiurie, sputi, monetine, accendini, ombrelli: uno spettacolo
semplicemente ignobile, sul piano umano ma anche politico. L'allora capogruppo
dell'ex Pci alla Camera non si vide e neppure si sentì allora per soccorrere
Craxi dall'assalto dei "cani". Egli cercò invece di soccorrerlo dopo sei anni da
presidente del Consiglio, come si è appena vantato in quel di Campobasso, per
avviare o sostenere una "trattativa umanitaria", apertamente auspicata
dall'Unità diretta da Peppino Caldarola, dopo che Piero Sansonetti aveva già
proposto la grazia, perché a Craxi, ormai prossimo alla morte, fosse concesso di
tornare libero in Italia dal suo rifugio tunisino: libero, cioè senza che fosse
piantonato come un detenuto in ospedale. Fedeli alla "durezza senza uguali" che
sarebbe stata lamentata dopo dieci anni da Giorgio Napolitano, nel frattempo
diventato presidente della Repubblica, i magistrati di Milano resistettero.
"Resistere, resistere, resistere" era del resto diventato un po' il motto di
Francesco Saverio Borrelli, il mitico capo della Procura di Milano negli anni di
Mani pulite e poi Procuratore generale della Corte d'Appello, quando, chiuso il
caso Craxi, cominciò all'ombra della Madonnina la lunga avventura giudiziaria e
politica di Berlusconi. Non ho motivo per non credere a ciò che D'Alema ha
raccontato a Campobasso: che Craxi avesse conosciuto e apprezzato il suo
soccorso parlandone con l'amico Arafat, a sua volta affrettatosi alla prima
occasione a riferirne, come a ringraziarlo, all'allora presidente del Consiglio.
Temo, purtroppo, a dramma consumatosi, dopo la morte e la sepoltura di Bettino
in quel piccolo cimitero di Hammamet affacciato sul mare che separa la Tunisia
dall'Italia. Ma non ho motivo neppure per nascondere o dimenticare una scena
raccontatami dal carissimo e compianto Nicola Mansi, amico oltre che fedelissimo
autista di Craxi. Molti furono i messaggi arrivati a Bettino prima e dopo il
difficile, direi disperato intervento chirurgico eseguito su di lui dai suoi
medici di Milano nell'ospedale militare di Tunisi, il più attrezzato del paese,
dove però i chirurghi avevano dovuto portare i ferri dall'Italia e la lampada
per illuminare quell'angolo della sala operatoria fu sollevata è tenuta ferma
con le mani da un infermiere. Fra i messaggi augurali ce ne fu uno portato
personalmente, credo, dall'ambasciatore italiano a Tunisi. Ma era un dispaccio
desolante per la sua forma burocratica. Non era neppure firmato Massimo D'Alema,
potendo, anzi dovendo bastare la qualifica del presidente del Consiglio. Craxi
sarà pure rimasto contento e commosso del pur inutile tentativo di D'Alema di
farlo tornare vivo e libero in Italia, senza peraltro che il presidente del
Consiglio avesse pubblicamente polemizzato con i magistrati insensibili anche a
questo passaggio estremo, ma di quel messaggio fece un mezzo gomitolo di carta e
lo buttò a terra. Lì, arrotolata, fini in qualche modo anche la già malmessa
sinistra italiana. Com'era finita nel 1968, fra gli inutili e disperati appelli
di Aldo Moro all'umanità e alla sua personale salvezza nella guerra dichiarata e
condotta da un manipolo di brigatisti rossi, la Democrazia Cristiana. Che alla
fine di Moro sopravvisse come un vegetale per 15 anni, per buona parte proprio
grazie a Craxi. Sarò forse esagerato, mi faranno velo la stima e l'amicizia
avute con entrambi, al netto di tutti gli errori che l'uno e l'altro, così
diversi fra loro, potettero commettere come uomini e come politici, ma questa è
la convinzione che ho maturato vedendo ciò che è seguito alla loro scomparsa,
compreso questo pasticciatissimo referendum alle porte. Del quale ormai prima ci
libereremo e meglio sarà per i troppi significati di cui è stato caricato, nel
bene e nel male. Un referendum che credo lascerà la bocca amara a tutti,
vincitori o sconfitti che saranno, o si proclameranno.
Tangentopoli è materia per gli storici,
scrive il 27 settembre Federico Di Luigi su Rete 8. La parola ai vinti.
Tangentopoli allo scanner, tra problematiche interne e scenari internazionali è
stato questo il titolo del convegno organizzato dal Master “Enrico Mattei”
dell’Università degli studi di Teramo. Al convegno sono intervenuti, tra gli
altri, Bobo Craxi, sottosegretario per i rapporti con l’ONU sotto il governo
Prodi il quale ha parlato della Fine della guerra fredda, falsa “Rivoluzione”
italiana e Paolo Cirino Pomicino, ministro dei governi democristiani, con un
intervento dal titolo “Un paese politicamente disarmato”. All’incontro anno
partecipato anche Danilo Sentella, opinionista politico ed economico e direttore
del Centro Studi Malfatti il quale è intervenuto sulle Conseguenze di
Tangentopoli sulla politica italiana, Nico Perrone, storico presso le Università
di Bari e di Roskilde (DN) il quale ha parlato del patrimonio pubblico italiano
mentre Claudio Moffa, coordinatore del master Enrico Mattei, ha illustrato le
Proiezioni internazionali dell’operazione Mani Pulite. «I vinti – ha spiegato
Moffa – sono i cittadini italiani, colpiti dalle conseguenze economiche di
Tangentopoli. Ne parlano alcune persone fuori dal coro, a ricordare che nei
rivolgimenti drammatici di quegli anni, segnati da abusi, morti oscure e
attentati, non c’era solo l’innegabile corruzione esistente tra i politici di
allora, ma anche altri temi meno citati e discussi, cruciali per la storia della
Repubblica: le privatizzazioni dell’Industria di Stato e della Banca d’Italia
del 1992, gli scenari internazionali caratterizzati dall’attivismo di eminenti
personalità americane contro il governo Craxi-Andreotti, il duo protagonista
della storica pagina di Sigonella (7 ottobre 1985)».
1992-93. Tangentopoli investe l’Italia. Gli Stati Uniti temono un
golpe. Report e cablo inviati dall’ambasciata al
Dipartimento di Stato raccontano i timori di Washington e le fonti utilizzate
per aggiornarsi. Nei dispacci anche le simpatie per i pm, scrive Francesco
Battistini il 22 ottobre 2016 su "Il Corriere della Sera". L’Italia rischia un
golpe? È la sera del 12 marzo 1993, ore 18.49. L’aria di Roma è ancora fresca,
la bufera giudiziaria infuria. Dall’ambasciata americana, l’incaricato d’affari
Daniel Serwer invia al Dipartimento di Stato l’ennesimo rapporto sulla
«rivoluzione» (la chiama così) di Tangentopoli. Tempi duri: da Washington
premono per capire che cosa diavolo stia succedendo in Italia. Nelle ultime
settimane si sono dimessi i segretari Bettino Craxi e Giorgio La Malfa, il
presidente Scalfaro s’è rifiutato di firmare l’ennesimo decreto salvaladri, i
manager Fiat sono finiti in manette, il finanziere Pacini Battaglia s’è
costituito per svelare i fondi neri Eni… Un intero mondo sta crollando, scrive
Serwer, e non manca «any worry about a possible coup»: qualche preoccupazione
per un possibile colpo di Stato. Ma di chi? Il diplomatico fa un giro d’opinioni
e riferisce le parole di vari leader italiani. C’è il segretario pds Achille
Occhetto che esclude un simile rischio: «L’Italia non ha una tradizione di
golpe». E Piero Fassino che rassicura di persona l’ufficio politico
dell’ambasciata Usa: «Le forze armate italiane sono di leva e riluttanti a farsi
coinvolgere nella politica interna». Gli americani però non si fidano, perché
«il leader leghista Umberto Bossi in private conversazioni ha espresso
ripetutamente preoccupazione per tentativi di golpe o per l’uso di forze
paramilitari che ostacolino il cambiamento». Anche in ambienti del Pds, osserva
il rapporto, si dubita che «i servizi d’intelligence o i carabinieri rimangano
spettatori neutrali», tanto che Massimo D’Alema è stato esplicito nell’insinuare
«che i servizi segreti siano coinvolti nelle rivelazioni sui collegamenti fra il
Pds e un conto svizzero utilizzato per le tangenti». Insomma, c’è da temere? La
rivoluzione italiana è in corso e «i venti sono potenti», dice l’ambasciatore,
ma oltreoceano stiano tranquilli: «Roma oggi non è la Parigi del 1789, la
Pietroburgo del 1917 e nemmeno la Boston del 1775, il cambiamento non si
raggiungerà con armi e ghigliottina». E questo — il diplomatico spiega con un
filo d’ironia le immagini tv dei giuramenti di Pontida — «nonostante alcune
persone si siano travestite da guerrieri medievali e abbiano contestato le tasse
inique». Sono 42 pagine «confidential». Sette cablo, inviati fra il 15 settembre
1992 e il 27 luglio 1993. Report inediti e declassificati di cui il «Corriere
della Sera» è entrato in possesso. Raccontano come l’ambasciatore americano
Peter Secchia e il reggente Serwer valutassero Mani pulite e la fine della Prima
Repubblica. Con chi parlavano, di chi si fidavano, che cosa prevedevano. Con
qualche sorprendente giudizio: sull’operato del Quirinale, per esempio, definito
«insolito» quando Scalfaro suggerisce al premier Giuliano Amato di stare alla
larga dalle direzioni d’un Psi ormai morente (un’evidente reazione alle parole
di Craxi, scrivono da via Veneto, dopo che il segretario socialista ha chiesto
una commissione parlamentare d’inchiesta sul finanziamento di tutti i
partiti...). Gli americani hanno le idee chiare: la strategia di Bettino è
«disperata», anche se «le possibilità che finisca in prigione sono remote». I
report dell’ambasciata non nascondono per il leader socialista un’antipatia che
dura fin dai tempi del blitz di Sigonella ed è evidente che Washington, adesso,
preferisca puntare sul Pds di Occhetto, considerato nei cablo «personalmente
ostile» a Craxi e un interlocutore privilegiato degli americani: a Bettino, pur
riconoscendo d’aver tenuto il Pci fuori dal governo fin dagli anni Settanta, si
rimprovera proprio d’avere poi evitato di proposito l’unità delle sinistre, pur
di non perdere il suo ruolo d’«indispensabile alleato della Dc». «Queste carte
invertono la vulgata di un’America che temeva gli eredi del Pci — commenta
Andrea Spiri, storico e ricercatore che ha spulciato gli archivi di Washington
—. Tangentopoli aveva cambiato tutto rispetto al 1989, solo quattro anni prima,
quando la storica visita del comunista Occhetto negli Usa era stata accolta
ancora con grande diffidenza». A un quarto di secolo da Mani pulite, ci si
chiede sempre quale fu il ruolo degli americani. Il socialista Formica lo dà per
certo. L’ambasciatore Reginald Bartholomew, succeduto a Secchia in via Veneto,
disse una volta che il suo predecessore era molto vicino al Pool. E anche il
console a Milano, Peter Semler, ammise una stretta confidenza con Di Pietro. Dai
nuovi report declassificati, affiora di sicuro una chiara simpatia: «Le
intenzioni dei magistrati sono nobili — si legge —, seguono solo la via
giudiziaria, i martelletti delle loro decisioni sono risultati efficaci come
pistole (…). Hanno intrapreso un processo di cambiamento che non possono
controllare o guidare completamente (…), ma come giudici la loro responsabilità
è d’assicurarsi che giustizia sia fatta, non d’indicare linee politiche per
stabilire quando se ne ha abbastanza. Quello è un lavoro che spetta ad altri». A
chi? L’Amico Americano qui ha meno certezze. Ed entrando nelle questioni interne
del Psi, il più in crisi del Pentapartito, descrivendo nei dettagli gli ultimi
congressi «senza garofani e in sale modeste», punta senza troppa convinzione su
Claudio Martelli bell’e «pronto a mollare Craxi», sponsorizzando un suo viaggio
negli Usa. L’ambasciata è un’antenna e capta dove può: fonti dirette e
privilegiate, convocate spesso a collaborare nella raccolta d’informazioni e
citate nei report, sono i socialisti Gino Giugni («ci dice che Craxi è pronto a
tutto per salvarsi»), Valdo Spini e Luca Josi, assieme a un non meglio
specificato «portavoce del Pds». Interessa la politica italiana, certo, ma
soprattutto sapere se la portaerei Italia rischi la deriva. Il timore di via
Veneto è che «i continui scossoni possano avere un impatto negativo» sulle
relazioni bilaterali con gli Usa: «Abbiamo avuto la dimostrazione nella saga di
Ustica che politici fra loro rivali, come i ministri Martelli e Andò, possono
lustrarsi a nostre spese», mentre «in questa fase di cambiamento dovremo stare
molto attenti a evitare d’essere trascinati nei maneggi politici italiani».
Intromettersi è sempre rischioso, come hanno insegnato gli endorsement di Obama
e del suo ambasciatore sul referendum: già 25 anni fa, s’apprende, a Washington
erano convinti che «senza una riforma elettorale che dia all’Italia governi più
forti (…), si fa difficile la leggendaria arte italiana d’arrangiarsi». Gli
americani spulciavano le proposte in cantiere, nei cablo s’accenna anche a
Mattarella, ma alla fine si trovavano a citare il Gattopardo: per tutto il
dopoguerra, scrivevano, «l’Italia ha dato un nuovo senso all’adagio “tutto
cambia perché tutto resti uguale”…». E se questo «cambiamento politico senza
precedenti» sarà pacifico e l’Italia resterà comunque ancorata all’Occidente,
sempre meglio stare attenti: nessuna rivoluzione ha un esito prevedibile. La
chiusa è truce: «Il vecchio sistema politico muore, il sangue versato continuerà
a scorrere ancora per un po’ e altre teste rotoleranno. Ci vorrà una buona dose
di competenza e di fortuna, per venirne fuori».
"Tangentopoli nera", dalle carte segrete di Mussolini arriva la
verità sulla corruzione del Ventennio fascista. Le
mazzette giravano sotto il Regime, mentre la propaganda inneggiava
all'austerità, scrive il 16/10/2016 "Adn Kronos". Quando c’era Lui, il Duce, non
solo i treni arrivavano in orario, ma si poteva lasciare aperta la porta di
casa, perché l’ordine e la legalità erano così importanti da valere persino il
sacrificio della libertà. L’immagine di un potere efficiente e incorruttibile,
costruita da una poderosa macchina propagandistica, ha alimentato fino a oggi il
mito di un fascismo onesto e austero, votato alla pulizia morale contro il
marciume delle decrepite istituzioni liberali. Ma le migliaia di carte custodite
nei National Archives di Kew Gardens, a pochi chilometri da Londra, raccontano
tutta un’altra storia: quella di un regime minato in profondità dalla corruzione
e di gerarchi spregiudicati dediti a traffici di ogni genere. Dalle carte
segrete di Mussolini arriva la verità sulla corruzione, la faida interna al
partito fascista, le ruberie, i ricatti e gli scandali nell'Italia del
Ventennio. A raccontarla due studiosi Mario José Cereghino e Giovanni Fasanella
nel saggio "Tangentopoli nera", ora in uscita per Sperling e Kupfer (pagg. 252,
euro18). Il primo, saggista, è esperto di archivi anglosassoni; il secondo è un
giornalista investigativo, specializzato nella storia segreta italiana. Così, si
scopre che, a Milano, il segretario federale del Fascio, Mario Giampaoli, e il
podestà Ernesto Belloni si arricchiscono con le mazzette degli industriali e con
i lavori pubblici per il restauro della celebre Galleria, coperti dall’amicizia
col fratello di Mussolini. Il ras di Cremona, Roberto Farinacci, conquista
posizioni sempre più importanti tramite una rete occulta di banchieri, criminali
e spie. Diventa così il principale antagonista del Duce, che a sua volta fa
spiare i suoi maneggi. Lo squadrista fiorentino Amerigo Dumini tiene in scacco
il governo con le carte - sottratte a Giacomo Matteotti dopo averlo assassinato
- che provano le tangenti pagate alle camicie nere dall’impresa petrolifera
Sinclair Oil. Utilizzando i documenti della Segreteria particolare di Mussolini
e quelli britannici desecretati di recente, gli autori ricostruiscono, con lo
scrupolo degli storici e il fiuto degli investigatori, l’intreccio perverso tra
politica, finanza e criminalità nell’Italia del Ventennio. E attraverso alcune
storie emblematiche che si dipanano col ritmo di una 'spy story', vengono
mostrati i meccanismi profondi e mai completamente svelati delle ruberie, delle
estorsioni e degli scandali sui quali crebbe, in pochi anni, una vera e propria
"Tangentopoli nera". Ma i misteri continuano ad essere tanti. Ad esempio quelli
dei documenti scomparsi a Roma il 10 giugno 1924: si tratta delle carte della
borsa di Matteotti, sottratte da Amerigo Dumini, militare a capo della
squadraccia che sequestrò e uccise il politico antifascista. Saranno usati come
arma di ricatto contro Mussolini e poi seguiranno Dumini nelle sue
peregrinazioni nel mondo. "A oltre 90 anni dal delitto -spiegano all'Adnkronos i
due autori- quelle carte continuano ad essere irreperibili, malgrado decenni di
ricerche in Europa e in America, da parte di storici e studiosi. Ma è innegabile
che, al giorno d'oggi, siano custodite negli archivi segreti del Naval
Intelligence Department, a Londra, e in quelli del Federal Bureau of
Investigation e del Dipartimento di Stato statunitense, a Washington". Inglesi e
americani, dunque, gli alleati.
Le mazzette dei gerarchi nella “Tangentopoli nera”.
Cereghino e Fasanella raccontano in un libro la corruzione ai tempi di
Mussolini, scrive Pietro Spirito il 10 ottobre 2016 su “Il Piccolo". Tra i più
attivi c’erano, a Milano, Mario Giampaoli, segretario federale del Fascio, e il
podestà Ernesto Belloni. In combutta tra loro si arricchirono con le mazzette
degli industriali e i lavori pubblici per il restauro della Galleria, facendo
sentire tutto i loro peso politico, forti dell’amicizia di Arnaldo Mussolini, il
fratello del Duce. E poi c’era il ras di Cremona, Roberto Farinacci, che da un
lato denunciava il malaffare e il marcio all’interno del partito, dall’altro
conquistava posizioni sempre più importanti grazie a una rete occulta di
banchieri, criminali e spie. E che dire dello squadrista fiorentino Amerigo
Dumini, che tiene in scacco lo stesso governo fascista con le carte sottratte a
Giacomo Matteotti dopo averlo assassinato, carte che provano le tangenti pagate
alle camicie nere dall’impresa petrolifera Sinclair Oil. Del resto, in un
colloquio personale poi riferito al Duce dalle spie, il grande filosofo liberale
Benedetto Croce l’aveva detto già nel 1930: non c’è da credere «alla veridicità
dei bilanci dello Stato», perché «il Fascismo è una grande organizzazione di
affaristi. Tutti pensano a rimpinguare le tasche e, quando si farà la storia di
questi tempi, quello che uscirà fuori farà rabbrividire». E a fare la storia del
malaffare al tempo del fascismo ci hanno pensato adesso. Mario José
Cereghino e Giovanni Fasanella nel libro “Tangentopoli nera” (Sperling&Kupfer.
pagg. 252, euro 15,30), da domani in tutte le librerie. Segugi d’archivio di
lungo corso, investigatori del passato con uno sguardo sempre rivolto al
presente, Cereghino e Fasanella sono una coppia rodata della storiografia
investigativa e hanno come terreno d’azione i National Archives di Kew Gardens,
a pochi chilometri da Londra, la memoria dello spionaggio britannico, uno dei
più antichi e organizzati del mondo. Ed è qui, nei National Archives, che i due
studiosi hanno scovato «migliaia di carte private di Mussolini». «Sono -
spiegano gli autori - per lo più resoconti scritti da agenti segreti, lettere di
camerati, soffiate anonime e precise denunce con tanto di firma». Materiali che
Mussolini aveva conservato gelosamente fino al 25 luglio 1943 quando, sfiduciato
dal Gran Consiglio, finì agli arresti. Solo una parte di quell’archivio seguì il
Duce a Salò dopo la liberazione da parte dei parà tedeschi, mentre il resto
«subì una vera e propria diaspora». Dopo la guerra in parte i documenti vennero
copiati dagli alleati in un’impegnativa ricostruzione dell’archivio di
Mussolini, e le copie inviate sia negli Stati Uniti che a Londra, mentre le
carte originali, depositate all’Archivio Centrale dello Stato, subirono nel
tempo non pochi «saccheggi»: «Molte scomparvero - scrivono Cereghino e Fasanella
-, probabilmente quelle sui personaggi del vecchio regime riciclati
nell’establishment (...) molte altre finirono invece sul mercato nero e, da qui,
su rotocalchi e giornali scandalistici». Così, dopo il libro “Le carte segrete
del Duce”, dove si parla dei rapporti tra il fascismo e la massoneria e degli
scandali sessuali del regime, Cereghino e Fasanella mettono insieme i tasselli
recuperati negli archivi londinesi per tracciare una mappa dettagliata dei
livelli di corruzione e malaffare al tempo del fascismo. Ne esce un quadro che
se nelle sue grandi linee era noto, nella messa a fuoco dei dettagli fa emergere
in modo netto quanto per il fascismo la politica fosse in buona misura
«strumento di elevazione sociale e di arricchimento illecito attraverso
tangenti, colossali ruberie pubbliche e traffici di ogni genere, anche con la
malavita organizzata». Senza per altro «dimenticare l’uso spregiudicato del
potere bancario per conquistare e mantenere il consenso, e di quello mediatico
per regolare i conti fra cricche rivali». La “fabbrica del fango” non è certo
un’invenzione dei nostri giorni. Nella loro inchiesta a ritroso Cereghino e
Fasanella puntano l’obiettivo su alcuni episodi e personaggi chiave della
diffusa tangentopoli, come i citati Giampaoli e Belloni, Farinacci, lo stesso
Arnaldo Mussolini, e altri nomi che usciranno da archivi segreti privati. Come
quello del massone Leandro Arpinati, un ricattatore (e non era l’unico) con il
pallino di archiviare qualsiasi documento e prova sulle questioni interne del
regime per trarne profitto. Da questo archivio saltano fuori i nomi per esempio
di Marcello Diaz, figlio del “Duca della Vittoria” Armando Diaz, a capo di una
vera e propria «cricca affaristica», o quello di Italo Balbo che, diventato
potente al punto di insidiare la leadership del Duce, finirà come noto abbattuto
con il suo aeroplano “per sbaglio” dal fuoco amico dalla contraerea italiana sui
cieli di Tobruk, in Cirenaica. Non prima, però, che uno dei suoi più stretti
collaboratori, il giornalista Gino D’Angelo, finisse travolto da uno scandalo
con l’accusa di essersi «appropriato di gran parte del fondo istituito dal
sindacato dei giornalisti, circa 60.000 lire, per i sussidi di disoccupazione».
Altro che ordine e disciplina, il regime fascista era marcio alle radici, più di
quelle decrepite istituzioni liberali che aveva combattuto. Ma la domanda delle
domande che punteggia le pagine della “Tangentopoli nera” è: Mussolini sapeva?
Naturalmente sì, visto che la stragrande maggioranza delle fonti utilizzate
dagli autori provengono dal suo archivio. Sapeva eccome, e utilizzava il suo
sapere a seconda del bisogno: qua e là teste cadevano - come quelle di Giampaoli
e Belloni -, polizia e magistratura facevano il loro dovere. Qualche volta con
punizioni esemplari, altre volte con misure blande o di facciata. Altre volte
ancora Mussolini lasciava correre, o indirizzava le reti occulte a suo
vantaggio, per sciogliere questo o quel nodo politico, questa o quella faida
intera al partito. Insomma il Duce sapeva e faceva con il malaffare quello che
ha sempre fatto e sempre farà ogni dittatore e ogni detentore di un potere fuori
controllo.
IN QUESTO
MONDO DI LADRI.
In Questo
Mondo Di Ladri di Antonello Venditti.
Eh, in questo
mondo di ladri
C' ancora un
gruppo di amici
Che non si
arrendono mai.
Eh, in questo
mondo di santi
Il nostro
cuore rapito
Da mille
profeti e da quattro cantanti.
Noi, noi
stiamo bene tra noi
E ci fidiamo
di noi.
In questo
mondo di ladri,
In questo
mondo di eroi,
Non siamo
molto importanti
Ma puoi venire
con noi.
Eh, in questo
mondo di debiti
Viviamo solo
di scandali
E ci sposiamo
le vergini.
Eh, e
disprezziamo i politici,
E ci
arrabbiamo, preghiamo, gridiamo,
Piangiamo e
poi leggiamo gli oroscopi.
Voi, vi
divertite con noi
E vi rubate
tra voi.
In questo
mondo di ladri,
In questo
mondo di eroi,
Voi siete
molto importanti
Ma questa
festa per noi.
Eh, ma questo
mondo di santi
Se il nostro
cuore rapito
Da mille
profeti e da quattro cantanti.
Noi, noi
stiamo bene tra noi
E ci fidiamo
di noi.
In questo
mondo... in questo mondo di ladri...
In questo
mondo... in questo mondo di ladri...
In questo
mondo... in questo mondo di ladri...
Le persone
perbene non riescono a fare carriera all’interno della pubblica amministrazione.
Un giudizio lapidario che viene dal presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione Raffaele Cantone, scrive “Blitz Quotidiano” il 28 ottobre 2015.
Un giudizio appena mitigato dai due minuti di spiegazione dell’affermazione:
Cantone spiega che, a volte, questo avviene anche per colpe dei diretti
interessati. “Spesso le persone perbene all’interno della pubblica
amministrazione sono quelle che hanno meno possibilità di fare – dice Cantone –
Spesso fanno meno carriera. Spesso sono meno responsabilizzati perché
considerati per bene”. Secondo Cantone è ora di recuperare parole che non si
usano nel nostro mondo del lavoro. Una è la parola “controllo”. E il presidente
dell’anticorruzione si riferisce a chi osserva i colleghi timbrare il cartellino
e poi lasciare il posto di lavoro senza denunciare nulla. Quello che serve,
secondo Cantone, è una “riscossa interna” e un recupero non imposto dall’alto di
moralità e cultura dello Stato, il terzo settore e di conseguenza il nostro
Paese si salveranno dalla mala gestione della cosa pubblica.
Commenti
disabilitati su Cantone: “Non sono tutti fannulloni ma nella Pubblica
amministrazione, le persone perbene hanno meno possibilità”,
scrive Antonio Menna il 28 ottobre 2015 su “Italia Ora”. “Non sono tutti
fannulloni nella Pubblica amministrazione. Meno che mai sono tutti corrotti. Ma
è vero che le persone perbene sono quelli che vengono meno coinvolti nelle
scelte, meno responsabilizzati. Sono quelli che hanno meno possibilità di fare
carriera”. Lo dice chiaro e tondo, Raffaele Cantone, magistrato anticamorra, e
presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione. Lo dice nel corso di una
intervista pubblica al Sermig di Torino e il segmento sulla corruzione nella
pubblica amministrazione (rilanciato da un video del Corriere della Sera) è
quello che impressiona di più. Quante volte lo abbiamo pensato che essere onesti
è una penalizzazione? Chi è onesto non va lontano. “A volte, però”, chiarisce
Cantone, “anche per sue responsabilità. Dobbiamo trovare il coraggio di
ripristinare alcune parole che nel nostro lessico si sono dimenticate: la parola
controllo, per esempio. Se il mio amico, vicino di stanza, usa il badge per
coprire i colleghi che magari sono in vacanza, devo stare zitto? Perché devo
stare zitto? Queste apparenti distrazioni sono complicità. La società dei
piccoli favori, magari banali, magari che non portano necessariamente alla
corruzione, ci abitua all’idea che ci sia uno spazio dove tutto si può
comprare.” “Il problema – conclude Cantone – non è solo la disonestà ma, a
volte, anche non capire con chi parlare. Ci sono cento centri di costo solo
nella città di Roma, cento uffici che fanno appalti e spesa. Come li controlli?
La deresponsabilizzazione la fa da padrona, ed è essa stessa una delle ragioni
che giustifica la corruzione.”
In Italia si fa carriera solo se si è ricattabili,
scrive il 5 giugno 2015 Claudio Rossi su "L'Uomo qualunque".
“Il nostro Paese sta sprofondando nel conformismo (…) siamo usciti da una
consultazione elettorale che ha dato il risultato a tutti noto, ma la cosa che
colpisce è questo saltare sul carro del vincitore. Tacito diceva che una delle
abitudini degli italiani è di ruere in servitium: pensate che immagine potente,
correre ad asservirsi al carro del vincitore. Noi tutti conosciamo persone
appartenenti al partito che ha vinto le elezioni che hanno opinioni diverse
rispetto ai vertici di questo partito. Ora non si tratta affatto di prendere
posizioni che distruggono l’unità del partito, ma di manifestare liberamente le
proprie opinioni senza incorrere nell’anatema dei vertici di questo partito (…)
Queste persone, dopo il risultato elettorale, hanno tirato i remi in barca e le
idee che avevano prima, oggi non le professano più. Danno prova di conformismo.
(…) La nostra rappresentanza politica è quella che è (…) La diffusione della
corruzione è diventata il vero humus della nostra vita politica, è diventata una
sorta di costituzione materiale. Qualcuno, il cui nome faccio solo in privato,
ha detto che nel nostro Paese si fa carriera in politica, nel mondo della
finanza e dell’impresa, solo se si è ricattabili (…) Questo meccanismo della
costituzione materiale, basato sulla corruzione, si fonda su uno scambio, un
sistema in cui i deboli, cioè quelli che hanno bisogno di lavoro e
protezione, gli umili della società, promettono fedeltà ai potenti in cambio di
protezione. È un meccanismo omnipervasivo che raggiunge il culmine nei casi
della criminalità organizzata mafiosa, ma che possiamo constatare nella nostra
vita quotidiana (…) Questo meccanismo funziona nelle società diseguali, in cui
c’è qualcuno che conta e che può, e qualcuno che non può e per avere qualcosa
deve vendere la sua fedeltà, l’unica cosa che può dare in cambio (…) Quando
Marco Travaglio racconta dei casi di pregiudicati o galeotti che ottengono 40
mila preferenze non è perché gli elettori sono stupidi: sanno perfettamente
quello che fanno, ma devono restituire fedeltà. Facciamoci un esame di coscienza
e chiediamoci se anche noi non ne siamo invischiati in qualche misura. (…)
Questo meccanismo fedeltà-protezione si basa sulla violazione della legge. Se
vivessimo in un Paese in cui i diritti venissero garantiti come diritti e non
come favori, saremmo un paese di uomini e donne liberi. Ecco libertà e onestà.
Ecco perché dobbiamo chiedere che i diritti siano garantiti dal diritto, e non
serva prostituirsi per ottenere un diritto, ottenendolo come favore. Veniamo
all’autocoscienza: siamo sicuri di essere immuni dalla tentazione di entrare in
questo circolo? (…) Qualche tempo fa mi ha telefonato un collega di Sassari che
mi ha detto: “C’è una commissione a Cagliari che deve attribuire un posto di
ricercatore e i candidati sono tutti raccomandati tranne mia figlia. Sono venuto
a sapere che in commissione c’è un professore di Libertà e Giustizia…”. Io ero
molto in difficoltà, ma capite la capacità diffusiva di questo sistema di
corruzione, perché lì si trattava di ristabilire la par condicio tra candidati.
Questo per dire quanto sia difficile sgretolare questo meccanismo, che si basa
sulla violazione della legge. Siamo sicuri di esserne immuni? Ad esempio,
immaginate di avere un figlio con una grave malattia e che debba sottoporsi a un
esame clinico, ma per ottenere una Tac deve aspettare sei mesi. Se conosceste il
primario del reparto, vi asterreste dal chiedergli il favore di far passare
vostro figlio davanti a un altro? Io per mia fortuna non mi sono mai trovato in
questa condizione, ma se mi ci trovassi? È piccola, ma è corruzione, perché se
la cartella clinica di vostro figlio viene messa in cima alla pila, qualcuno che
avrebbe avuto diritto viene posposto. Questo discorso si ricollega al problema
del buon funzionamento della Pubblica amministrazione: se i servizi
funzionassero bene non servirebbe adottare meccanismi di questo genere. Viviamo
in un Paese che non affronta il problema della disonestà e onestà in termini
morali. (…) Se non ci risolleviamo da questo, avremo un Paese sempre più
clientelarizzato, dove i talenti non emergeranno perché emergeranno i
raccomandati, e questo disgusterà sempre di più i nostri figli e nipoti che
vogliono fare ma trovano le porte sbarrate da chi ha gli appoggi migliori. È una
questione di sopravvivenza e di rinascita civile del nostro Paese. Ora,
continuiamo a farci questo esame di coscienza: non siamo forse noi, in qualche
misura, conniventi con questo sistema? Quante volte abbiamo visto vicino a noi
accadere cose che rientrano in questo meccanismo e abbiamo taciuto? Qualche
tempo fa, si sono aperti un trentina di procedimenti penali a carico di colleghi
universitari per manipolazione dei concorsi universitari (…) Noi non sapevamo,
noi non conoscevamo i singoli episodi (…) e per di più non siamo stati parte
attiva del meccanismo, ma dobbiamo riconoscere che abbiamo taciuto, dobbiamo
riconoscere la nostra correità. Proposta: Libertà
e Giustizia è una associazione policentrica che si basa su circoli, che
sono associazioni nella associazione, radicati sul territorio e collegati alla
vita politica. Non sarebbe il caso che i circoli si attrezzassero per monitorare
questi episodi, avendo come alleati la stampa libera e la magistratura autonoma?
Potrebbe essere questa una nuova sfida per Libertà e Giustizia, controllare la
diffusione di questa piovra che ci invischia tutti, cominciando dal basso,
perché dall’alto non ci verrà nulla di buono, perché in alto si procede con quel
meccanismo che dobbiamo combattere.”
Gustavo Zagrebelsky.
“I cittadini silenziosi possono essere dei perfetti sudditi per
un governo autoritario, ma sono un disastro per una democrazia”.
Robert Alan Dahl
Il volume più letto dai politici? Un manuale per ottenere
l'immunità. Alle
Biblioteca delle Nazioni Unite non hanno più nemmeno una copia. Spiega i vari
tipi di immunità e chi può usufruire, scrive Gabriele Bertocchi Venerdì,
08/01/2016, su “Il Giornale”. Non è un semplice libro, è il libro che ogni
politico dovrebbe leggere. E infatti è cosi, tutto lo vogliono. È diventato il
libro più richiesto alla biblioteca delle Nazioni Unite. Vi starete chiedendo
che volume è: magari se è un'opera di letteratura classica, oppure un trattato
sulla politica internazionale. Nessuno di questi, si chiama "Immunità di capi e
funzionari di Stato per crimini internazionali", è uno scritto da Ramona
Pedretti, ex studentessa dell’Università di Lucerna. È una tesi di dottorato,
un vademecum che spiega e illustra che tipo di immunità esistono per tali
soggetti. "Più che un libro è una star" commenta Maria Montagna sulle
pagine de La Stampa, una delle addette alla gestione banca dati di Dag
Hammarskjold Library, libreria dedicata al'ex segretario generale, alle Nazioni
Unite. "È senza dubbio il libro più richiesto del 2015, anche più di classici
della letteratura Onu o grandi dossier" continua l'addetta. Il successo lo
si deve anche a Twitter, infatti la Dag Hammarskjold Library ha pubblicato il
"primato" del libro, creando così un vero e prioprio cult da leggere. Ma
all'interno cosa si può imparare, come scrive la Pedretti, autrice del volume,
si può scoprire che esistono due dtipi di immunità: quella ratione personae che
mette i capi di stato al riparo dalla giurisdizione penale straniera, e quella ratione
materiae che protegge atti ufficiali e funzionari che agiscono per conto
dello Stato dal giudizio di tribunali di altri Paesi. La Montagna spiega che "ora
però la platea di lettori si è allargata vista la pubblicità dei social", ma
prima era perlopiù composta da funzionari degli uffici legali e storici Onu,
interessati in particolare alle conclusioni tratte da Pedretti. La tesi è che
capi o alti esponenti di Stato in carica non possono essere perseguiti da corti
straniere, al contrario degli ex. E intanto, come si legge su La Stampa, arriva
la conferma da parte della libreria: "Mi spiace, al momento non abbiamo
neanche una copia disponibile".
Va a ruba all’Onu il libro che insegna ai leader come avere
l’immunità. Esaurito in
biblioteca. Tesi di
laurea. Il pamphlet è stato scritto da Ramona Pedretti ex studentessa
dell’Università di Lucerna, scrive Francesco Semprini su “La Stampa” l’8 gennaio
2016. Basta entrare nella biblioteca delle Nazioni Unite e menzionare il nome
del libro per capire che non stiamo parlando di un volume qualunque. Maria
Montagna, una delle addette alla gestione della banca data di Dag Hammarskjold
Library - la libreria dedicata all’ex segretario generale - guarda la collega
Ariel Lebowitz e sorride. «Più che un libro è una star - dice - aspetti qui,
controlliamo subito». L’opera in questione è «Immunità di capi e funzionari di
Stato per crimini internazionali», un pamphlet scritto da Ramona Pedretti, ex
studentessa oriunda dell’Università di Lucerna. È una tesi di dottorato, un
vademecum per capire che tipo di immunità esistono per tali soggetti. Ne
esistono due, come spiega Pedretti nel suo scritto, quella ratione personae che
mette i capi di stato al riparo dalla giurisdizione penale straniera, e quella
ratione materiae che protegge atti ufficiali e funzionari che agiscono per conto
dello Stato dal giudizio di tribunali di altri Paesi. «È senza dubbio il libro
più richiesto del 2015, anche più di classici della letteratura Onu o grandi
dossier», dice Maria. Twitter ha fatto il resto, visto che Dag Hammarskjold
Library ha rilanciato sul social network il «primato» del libro moltiplicandone
notorietà e richieste. Ma chi lo chiede in prestito? All’inizio erano
soprattutto funzionari degli uffici legali e storici Onu, interessati in
particolare alle conclusioni tratte da Pedretti. La tesi dell’autrice è che capi
o alti esponenti di Stato in carica non possono essere perseguiti da corti
straniere, al contrario degli ex. È questo il principio ad esempio che ha
portato all’arresto di Adolph Eichmann da parte di Israele e Augusto Pinochet
dalla Spagna. «Ora però la platea di lettori si è allargata vista la pubblicità
dei social», chiosa Maria. E arriva la conferma: «Mi spiace, al momento non
abbiamo neanche una copia disponibile».
Fondazioni, i soldi nascosti dei politici.
Finanziamenti milionari anonimi. Intrecci con banchieri,
costruttori e petrolieri. Società fantasma. Da Renzi a Gasparri, da Alfano ad
Alemanno, ecco cosa c'è nei conti delle fondazioni, scrivono Paolo Biondani,
Lorenzo Bagnoli e Gianluca De Feo il 7 gennaio 2016 su “L’Espresso”.
Finanziamenti milionari ma anonimi. Un intreccio tra ministri, petrolieri,
banchieri e imprenditori. Con una lunga inchiesta nel numero in edicola
“L'Espresso” ha esaminato i documenti ufficiali delle fondazioni che fanno capo
ai leader politici, da Renzi a Gasparri, da Alfano a Quagliarello, tutte
dominate dall'assenza di trasparenza. Nel consiglio direttivo di Open, il
pensatoio-cassaforte del premier, siedono l’amico che ne è presidente Alberto
Bianchi, ora consigliere dell’Enel, il sottosegretario Luca Lotti, il braccio
destro Marco Carrai e il ministro Maria Elena Boschi. Il sito pubblica centinaia
di nomi di finanziatori, ma omette «i dati delle persone fisiche che non lo
hanno autorizzato esplicitamente». Il patrimonio iniziale di 20 mila euro,
stanziato dai fondatori, si è moltiplicato di 140 volte con i contributi
successivi: in totale, 2 milioni e 803 mila euro. Sul sito compaiono solo tre
sostenitori sopra quota centomila: il finanziere Davide Serra (175), il defunto
imprenditore Guido Ghisolfi (125) e la British American Tobacco (100 mila).
Molto inferiori le somme versate da politici come Lotti (9.600), Boschi (8.800)
o il nuovo manager della Rai, Antonio Campo Dell’Orto (solo 250 euro). Ma un
terzo dei finanziatori sono anonimi per un importo di 934 mila euro. Ad Angelino
Alfano invece fa oggi capo la storica fondazione intitolata ad Alcide De
Gasperi, che ha «espresso il suo dissenso» alla richiesta ufficiale della
prefettura di far esaminare i bilanci: per una fondazione presieduta dal
ministro dell’Interno, la trasparenza non esiste. Nell’attuale direttivo
compaiono anche Fouad Makhzoumi, l’uomo più ricco del Libano, titolare del
colosso del gas Future Pipes Industries. Tra gli italiani, Vito Bonsignore, l’ex
politico che dopo una condanna per tangenti è diventato un ricco uomo d’affari;
il banchiere Giovanni Bazoli, il marchese Alvise Di Canossa, il manager Carlo
Secchi, l’ex dc Giuseppe Zamberletti, l’ex presidente della Compagnia delle
Opere Raffaello Vignali, l’avvocato Sergio Gemma e il professor Mauro Ronco. Ma
tutti i contributi alla causa di Alfano sono top secret. Invece la fondazione
Magna Carta è stata costituita dal suo presidente, Gaetano Quagliariello, da un
altro politico, Giuseppe Calderisi, e da un banchiere di Arezzo, Giuseppe
Morbidelli, ora numero uno della Cassa di risparmio di Firenze. Gli altri
fondatori sono tre società: l’assicurazione Sai-Fondiaria, impersonata da Fausto
Rapisarda che rappresenta Jonella Ligresti; la Erg Petroli dei fratelli Garrone;
e la cooperativa Nuova Editoriale di Enrico Luca Biagiotti, uomo d’affari legato
a Denis Verdini. Il capitale iniziale di 300 mila euro è stato interamente
«versato dalle tre società in quote uguali». I politici non ci hanno messo un
soldo, ma la dirigono insieme ai finanziatori. Nel 2013 i Ligresti escono dal
consiglio, dove intanto è entrata Gina Nieri, manager di Mediaset. L’ultimo
verbale (giugno 2015) riconferma l’attrazione verso le assicurazioni, con il
manager Fabio Cerchiai, e il petrolio, con Garrone e il nuovo consigliere
Gianmarco Moratti. La fondazione pubblica i bilanci, ma non rivela chi l’ha
sostenuta: in soli due anni, un milione di finanziamenti anonimi. La Nuova
Italia di Gianni Alemanno invece non esiste più. “L’Espresso” ha scoperto che il
23 novembre scorso la prefettura di Roma ne ha decretato lo scioglimento: «la
fondazione nell’ultimo anno non ha svolto alcuna attività», tanto che «le
raccomandate inviate dalla prefettura alla sede legale e all’indirizzo del
presidente sono tornate al mittente con la dicitura sconosciuto». Ai tempi d’oro
della destra romana sembrava un ascensore per il potere: dei 13 soci promotori,
tutti legati all’ex Msi o An, almeno nove hanno ottenuto incarichi dal ministero
dell’agricoltura o dal comune capitolino. All’inizio Gianni Alemanno e sua
moglie Isabella Rauti figurano solo nel listone dei 449 «aderenti» chiamati a
versare «contributi in denaro». I primi soci sborsano il capitale iniziale di
250 mila euro. Tra gli iscritti compaiono tutti i fedelissimi poi indagati o
arrestati, come Franco Panzironi, segretario e gestore, Riccardo Mancini,
Fabrizio Testa, Franco Fiorito e altri. La “Fondazione della libertà per il bene
comune” è stata creata dal senatore ed ex ministro Altero Matteoli assieme ad
altre dieci persone, tra cui politici di destra come Guglielmo Rositani (ex
parlamentare e consigliere Rai), Eugenio Minasso, Marco Martinelli e Marcello De
Angelis. A procurare i primi 120 mila euro, però, sono anche soci in teoria
estranei alla politica, come l’ex consigliere dell’Anas Giovan Battista Papello
(15 mila), il professor Roberto Serrentino (10 mila) e l'imprenditore, Erasmo
Cinque, che versa 20 mila euro come Matteoli. La fondazione, gestita dal
tesoriere Papello, pubblica i bilanci: tra il 2010 e il 2011, in particolare,
dichiara di aver incassato 374 mila euro dai «soci fondatori», altri 124 mila di
«contributi liberali» e solo duemila dalle proprie attività (convegni e
pubblicazioni). Gli atti della prefettura però non spiegano quali benefattori li
abbiano versati. Espressione di Massimo D'Alema, ItalianiEuropei nel 1999 è
stata una delle prime fondazioni. I fondatori sono l'ex premier Giuliano Amato,
il costruttore romano Alfio Marchini, il presidente della Lega Cooperative,
Ivano Barberini, e il finanziere esperto in derivati Leonello Clementi. Il
capitale iniziale è di un miliardo di lire (517 mila euro), quasi totalmente
versati da aziende o uomini d’affari: 600 milioni di lire da varie associazioni
di cooperative rosse, 50 ciascuno da multinazionali come Abb ed Ericsson, la
Pirelli di Tronchetti Provera, l’industriale farmaceutico Claudio Cavazza, oltre
che da Marchini (50) e Clementi (55). ItalianiEuropei deposita regolari bilanci
e ha autorizzato la prefettura di Roma a mostrarli. L’ultimo è del 2013. Gli
atti identificano solo i finanziatori iniziali del 1998. A quei 517 mila euro,
però, se ne sono aggiunti altri 649 mila sborsati da «nuovi soci», non
precisati. Nei bilanci inoltre compare una diversa categoria di «contributi alle
attività» o «per l’esercizio»: in totale in sei anni i finanziamenti ammontano a
un milione e 912 mila euro. Italia Protagonista nasce nel 2010 per volontà di
due leader della destra: Maurizio Gasparri, presidente, e Ignazio La Russa,
vicepresidente. Tra i fondatori, che versano 7 mila euro ciascuno, c’è un
ristretto gruppo di politici e collaboratori, ma anche un manager, Antonio
Giordano. Dopo la fine di An, però, La Russa e i suoi uomini escono e la
fondazione resta un feudo dell’ex ministro Gasparri. Come direttore compare un
missionario della confraternita che s’ispira al beato La Salle, Amilcare
Boccuccia, e come vice un suo confratello spagnolo. Tra i soci viene ammesso
anche Alvaro Rodriguez Echeverria, esperto e uditore del sinodo 2012 in
Vaticano, nonché fratello dell’ex presidente del Costarica. L’ultimo bilancio
riguarda il 2013, quando il capitale, dai 100 mila euro iniziali, è ormai salito
a 231 mila. Le donazioni di quell’anno, 56 mila euro, non sono bastate a coprire
le spese, con perdite finali per 63 mila, però in banca ci sono 156 mila euro di
liquidità. Ma sui nomi dei benefattori, zero informazioni. «Quello che è
assolutamente inaccettabile è l’assenza di una regolamentazione che quanto meno
adegui le fondazioni alle regole dei partiti politici», dichiara
Raffaele Cantone a “l'Espresso” :
«Fermo restando che la riforma Letta sulla pubblicità ai partiti si è rivelata
inadeguata, perché il sistema delle verifiche è assolutamente ridicolo, ma
almeno ha introdotto un meccanismo di controllo. Sulle fondazioni invece c’è
totale anarchia: non si possono conoscere entrate e uscite, non c’é trasparenza
sui finanziatori».
«Non si possono conoscere entrate e uscite, non c’é trasparenza sui
finanziatori. I conti delle fondazioni possono essere fatti in modo
semplicistico e semplificato, senza rendere noto come arrivano i soldi e come
vengono spesi», scrive Gianluca De Feo il 7 gennaio 2016 su "L'Espresso". «È una
situazione che ha raggiunto i limiti dell’indecenza». Un anno fa Raffaele
Cantone fu il primo a lanciare l’allarme sui fondi opachi trasferiti alla
politica attraverso le fondazioni. Con un’intervista a “l’Espresso” il
presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione sottolineò il problema della
carenza di controlli. Negli ultimi mesi le indagini hanno poi evidenziato altri
sospetti sui soldi passati attraverso questi canali per finanziare l’attività
dei partiti.
Raffaele Cantone, ma da allora è cambiato qualcosa?
«Non è cambiato nulla. Ma questo più che un finanziamento ai partiti è un modo
di sovvenzionare gruppi interni ai partiti, quelle che un tempo si chiamavano
correnti. Nel tempo le correnti si sono organizzate in realtà di tipo
associativo: questa scelta potrebbe essere positiva, perché in qualche modo dà
una struttura evidente alle correnti. Quello che è assolutamente inaccettabile è
l’assenza di una regolamentazione che quanto meno adegui le fondazioni alle
regole dei partiti politici. Fermo restando che la riforma Letta sulla
pubblicità ai partiti si è rivelata inadeguata, perché il sistema delle
verifiche è assolutamente ridicolo, ma almeno ha introdotto un meccanismo di
controllo. Sulle fondazioni invece c’è totale anarchia. Viene previsto solo il
controllo formale e generico delle prefetture, che non hanno capacità di
incidere sui bilanci: non si possono conoscere entrate e uscite, non c’é
trasparenza sui finanziatori. I conti delle fondazioni possono essere fatti in
modo semplicistico e semplificato, senza rendere noto come arrivano i soldi e
come vengono spesi».
Molte
di queste fondazioni politiche sono semplici associazioni, che non depositano
neppure una minima documentazione.
«Bisogna tenere presente che nel nostro Paese per ragioni culturali queste
realtà sono state un momento significativo della libertà di associazione. Nel
diritto civile sono previste le associazioni non riconosciute, tutelate perché
si tutela la libertà di associazione, che devono avere una loro possibilità di
operare. Il problema è che in questi casi viene a mancare persino quel minimo di
controllo esercitato dalle prefetture: sono in tutto uguali a una bocciofila.
Non ci sono né regole, né rischi legali quando vengono usate per incassare
finanziamenti sospetti: possono solo incorrere in verifiche fiscali della
Guardia di Finanza se emergono pagamenti in nero. È una carenza normativa che si
fa sentire e più volte il Parlamento ha espresso esigenza di intervenire. Sono
stati presentati diversi disegni di legge, alcuni dei quali validi, ma non sono
mai andati in discussione».
Negli
organi che gestiscono le fondazioni politiche c’è poi una diffusa commistione
tra centinaia di imprenditori e di politici. È una confusione che può alimentare
i conflitti di interesse?
«In sé non è un aspetto deleterio. Che ci sia un legame nelle attività delle
fondazioni tra chi svolge politica attiva e chi si occupa di attività
economiche, imprenditoriali e professionali, non è un dato atipico delle moderne
democrazie. Anzi, avviene in tutte le democrazie occidentali. Il problema è che
i potenziali conflitti di interesse possono essere contrastati o attenuati solo
attraverso meccanismi di trasparenza. Se l’imprenditore Tizio finanzia la
fondazione del politico Caio e questo dato è noto, come avviene ad esempio negli
Usa, questo sterilizza il conflitto d’interessi perché quando si discuterà di
provvedimenti che riguardano l’imprenditore Tizio, direttamente o
indirettamente, tutti potranno rendersi conto dei legami. Quello che è grave è
l’assenza di pubblicità nel modo in cui le due situazioni si interfacciano
all’interno delle fondazioni».
Alfano nasconde i soldi perfino ai suoi prefetti.
La Fondazione presieduta dal ministro non pubblica
l'elenco dei finanziatori. E il dg Rai è sponsor di Renzi, scrive
Paolo Bracalini Sabato,
09/01/2016, su “Il Giornale”. Un investimento da appena 250 euro che ne
rende ogni anno 650mila (di stipendio), un posto di assoluto comando nella tv
pubblica e prima ancora il Cda di Poste italiane. In epoca di rendimenti bassi o
negativi, l'investimento di Antonio Campo Dall'Orto è da manuale di finanza. Il
nuovo direttore generale della Rai ha donato 250 euro alla Fondazione Open, la
cassaforte renziana, entrando così nel cerchio ristretto degli amici dell'ex
sindaco di Firenze, che poi da premier ha ricambiato quelli che aveva creduto in
lui nominandoli nelle partecipate pubbliche. Dall'Orto è uno dei molti
finanziatori «in chiaro» della fondazione guidata da Maria Elena Boschi, Luca
Lotti e Marco Carrai. I donatori, cioè, che hanno dato il consenso alla
pubblicazione dei propri nomi nell'elenco dei finanziatori del think tank legato
a Renzi.Ma c'è una zona grigia. Sui 2.803.953,49 euro raccolti dalla Open,
infatti, quasi un terzo (913mila euro) arriva da ignoti sostenitori del renzismo
che preferiscono restare anonimi. E nemmeno tirando in ballo le prefetture, che
per legge vigilano (poco) su enti di diritto privato come le fondazioni, si
riesce a sapere di più. Il test lo ha fatto l'Espresso, contattando via mail
sette prefetti di altrettanti città italiane (da Roma a Napoli) dove hanno sede
le associazioni politiche espressione di qualche leader o presunto tale. Ma
anche l'intervento dello Stato, nella figura del prefetto, non sembra illuminare
granché di quella zona d'ombra che nasconde le modalità di finanziamento delle
fondazioni. Il paradosso è che persino quella che fa capo ad Angelino Alfano,
ministro dell'Interno e dunque riferimento istituzionale dei prefetti, «esprime
dissenso» alla richiesta di fornire bilanci e informazioni sulla Fondazione De
Gasperi, presieduta appunto dal leader di Ncd e capo del Viminale. L'unico
patrimonio tracciabile risale all'eredità della vecchia Dc, 400 milioni di lire,
passati alla fondazione intitolata al grande statista democristiano. Il resto
dei finanziatori si può solo immaginare guardando i membri del consiglio di
amministrazione (Bazoli di Intesa San Paolo, il miliardario libanese Makhzoumi
Fouad...), visto che la fondazione del ministro non si rende trasparente ai
prefetti. E donatori ne servono, visto che anche il 5 per mille per
l'associazione di Alfano è andato molto male: l'ultima volta solo 59
contribuenti hanno espresso la preferenza nella dichiarazioni dei redditi, per
complessivi 6.700 euro. Spiccioli. Di fondazioni politiche ce n'è un centinaio,
ma le più importanti (e ricche) sono una ventina. Ricevono fondi ministeriali,
accedono al 5 per mille, hanno sgravi fiscali, a differenza dei partiti possono
ricevere donazioni da aziende pubbliche - munifici colossi come Eni,
Finmeccanica, Poste - e non devono rendere pubblici i bilanci. Tanti vantaggi
che ne spiegano la proliferazione. Una di quelle storiche è ItalianiEuropei di
Massimo D'Alema. Quando nasce, nel 1999, viene innaffiata di soldi da
cooperative rosse, grosse multinazionali, colossi della farmaceutica. La
fondazione dell'ex premier Ds ha autorizzato la prefettura a rendere pubblici i
suoi bilanci. Dai quali, però, non si ricavano le informazioni complete sui
finanziatori. In totale dai rendiconti fino al 2013 risultano quasi 2 milioni di
euro di donazioni, registrate genericamente come «contributi all'attività» da
«nuovi soci». Ma quali siano i loro nomi non è dato saperlo.
Figuraccia italiana nella
visita a Riad: rissa per il Rolex regalato a Renzi & C. I 50 membri della
delegazione si sono azzuffati per i regali offerti dalla famiglia reale. Il
premier li fa sequestrare ma a Palazzo Chigi non sono ancora arrivati,
scrive TGCOM il 9
gennaio 2016. Monta la polemica per il viaggio
diplomatico e commerciale compiuto da Matteo Renzi e una delegazione
politico-economica in Arabia Saudita l'8 novembre 2015. E non c'entrano gli appalti
miliardari o la crisi internazionale
con l'Iran a causa delle esecuzioni capitali compiute da Riad. Il problema sono
i Rolex, i regali che i ricchi sauditi avevano preparato per alcuni membri della
delegazione italiana ma che alla fine tutti avrebbero preteso. Stando alle
indiscrezioni di stampa questi Rolex non è chiaro che fine abbiano fatto. E' il
Fatto Quotidiano a ricostruire la vicenda: i 50 ospiti arrivati da Roma (tra cui
vertici di aziende statali e non come Finmeccanica, Impregilo e Salini) sono a
cena con la famiglia reale. Arrivano gli omaggi preparati dagli sceicchi,
pacchettini con nomi e cognomi, in italiano e arabo. C'è il pacchettino di serie
A, con il Rolex svizzero, e quello, diciamo, di serie B con un cronografo
prodotto a Dubai che vale "solo" 4mila euro. Il
fattaccio avviene quando un furbetto della delegazione italiana scambia il suo
cronografo arabo col pacchetto luccicante svizzero. Il "proprietario" del Rolex
se ne accorge e scoppia una quasi rissa. Tutti vogliono il Rolex, i reali
sauditi sarebbero anche pronti a cambiare tutti i regali pur di non vedersi di
fronte questa scena da mercato del pesce. Ma interviene la security di Renzi che
sequestra tutti i pacchetti. Ora,
denuncia il Fatto Quotidiano, di questi orologi si è persa traccia. Va ricordato
che il governo di Mario Monti varò una norma che impedisce ai dipendenti
pubblici di accettare omaggi del valore superiore a 150 euro. I Rolex e gli
altri cadeau avrebbero dovuto essere depositati nella stanza dei regali al terzo
piano di Palazzo Chigi. Ma qui non si trovano. Interpellata
sul caso, Ilva Saponara, padrona del cerimoniale di Palazzo Chigi, non risponde,
dice di avere la febbre e di non ricordare nemmeno il contenuto dei doni offerti
dai sauditi. Anche l’ambasciatore Armando Varricchio, consigliere per l'estero
di Renzi, non parla ma annuisce di fronte alla ricostruzione del caso. Non dice
che fine hanno fatto i Rolex ma rassicura: "I doni di rappresentanza ricevuti
dalla delegazione istituzionale italiana, in occasione della recente visita
italiana in Arabia Saudita, sono nella disponibilità della Presidenza del
Consiglio, secondo quello che prevedono le norme. Come sempre avviene in questi
casi, dello scambio dei doni se ne occupa il personale della presidenza del
Consiglio e non le cariche istituzionali". Se ne deduce che qualcuno ancora non
ha restituito il Rolex in questione. E chissà se mai lo farà.
Governo in visita in Arabia Saudita. La missione finisce in rissa
per i Rolex in regalo. Durante la trasferta a Ryad
dello scorso novembre, i delegati italiani si sono accapigliati per dei
cronografi da migliaia di euro, un omaggio dei sovrani sauditi. Per questo la
delegazione del premier li ha sequestrati. Nota di Palazzo Chigi: "Sono nella
nostra disponibilità", scrive Carlo Tecce l'8 gennaio 2016 su "Il Fatto
Quotidiano". Parapiglia tra dirigenti del governo in viaggio con Matteo Renziper
i Rolex elargiti dagli amici di Ryad. Questo racconto, descritto da testimoni
oculari, proviene dall’Arabia Saudita. È una grossa figuraccia internazionale
per l’Italia. È ormai la notte tra domenica 8 e lunedì 9 novembre. Il palazzo
reale di Ryad è una fonte di luce che illumina la Capitale saudita ficcata nel
deserto. La delegazione italiana, che accompagna Matteo Renzi in visita ai
signori del petrolio, è sfiancata dal fuso orario e dal tasso d’umidità. La
comitiva di governo è nei corridoi immensi con piante e tende vistose, atmosfera
ovattata, marmi e dipinti. Gli italiani vanno a dormire. Così il cerimoniale
di Palazzo Chigi, depositario degli elenchi e dei protocolli di una trasferta di
Stato, prima del riposo tenta di alleviare le fatiche con l’inusuale
distribuzione dei regali. Quelli che gli oltre 50 ospiti di Roma – ci sono anche
i vertici di alcune aziende statali (Finmeccanica) e private (Salini Impregilo)
– hanno adocchiato sui banchetti del salone per la cena con la famiglia al
trono: deliziose confezioni col fiocco, cognome scritto in italiano e pure in
arabo. Gli illustri dipendenti profanano la direttiva di Mario Monti: gli
impiegati pubblici di qualsiasi grado devono rifiutare gli omaggi che superano
il valore di 150 euro oppure consegnarli subito agli uffici di competenza. Qui
non si tratta di centinaia, ma di migliaia di euro. Perché i sovrani sauditi
preparano per gli italiani dei pacchetti con orologi preziosi: avveniristici
cronografi prodotti aDubai, con il prezzo che oscilla dai 3.000 ai 4.000 euro e
Rolex robusti, per polsi atletici, che sforano decine di migliaia di euro,
almeno un paio. A Renzi sarà recapitato anche un cassettone imballato,
trascinato con il carrello dagli inservienti. Il cerimoniale sta per conferire i
regali. Il momento è di gioia. Ma un furbastro lo rovina. Desidera il Rolex.
Scambia la sua scatoletta con il pacchiano cronografo con quella dell’ambito
orologio svizzero e provoca un diverbio che rimbomba nella residenza di re
Salman. Tutti reclamano il Rolex. Per sedare la rissa interviene la scorta di
Renzi: sequestra gli orologi e li custodisce fino al ritorno a Roma. La
compagine diplomatica, guidata dall’ambasciatore Armando Varricchio, inorridisce
di fronte a una scena da mercato di provincia per il chiasso che interrompe il
sonno dei sauditi. Anche perché i generosi arabi sono disposti a reperire presto
altri Rolex pur di calmare gli italiani. Non sarà un pezzo d’oro a sfaldare i
rapporti tra Ryad e Roma: ballano miliardi di euro di appalti, mica affinità
morali. Nonostante le decapitazioni di Capodanno, tra cui quella dell’imam
sciita che scatena la furia dell’Iran, per gli italiani Ryad resta una meta
esotica per laute commesse. E che sarà mai una vagonata di Rolex? Il guaio è che
degli orologi, almeno durante le vacanze natalizie, non c’era più traccia a
Palazzo Chigi. Non c’erano nella stanza dei regali al terzo piano. Chi avrà
infranto la regola Monti e chi l’avrà rispettata? E Renzi ce l’ha o non ce l’ha,
il Rolex? La dottoressa Ilva Sapora, la padrona del cerimoniale di Palazzo
Chigi, non rammenta il contenuto dei doni. Ha la febbre e poca forza per
rovistare nella memoria. Varricchio ascolta le domande e la ricostruzione dei
fatti di Ryad: annuisce, non replica. Varricchio è il consigliere per l’estero
di Renzi, nonché il prossimo ambasciatore italiano a Washington. Allora merita
un secondo contatto al telefono. Non svela il destino del Rolex che ha ricevuto,
ma si dimostra comprensivo: “I cittadini devono sapere. Queste vicende meritano
la massima attenzione. Le arriverà una nota di Palazzo Chigi. Che la voce sia
univoca”. Ecco la voce del governo, che non smentisce niente, che non assolve la
Sapora, ma precisa i ruoli: “I doni di rappresentanza ricevuti dalla delegazione
istituzionale italiana, in occasione della recente visita italiana in Arabia
Saudita, sono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio, secondo quello
che prevedono le norme. Come sempre avviene in questi casi, dello scambio dei
doni se ne occupa il personale della presidenza del Consiglio e non le cariche
istituzionali”. Il racconto non finisce. Cos’è accaduto dopo la notte di Ryad?
Chi non voleva restituire o non ha ancora restituito i Rolex? Da
il Fatto Quotidiano di venerdì 8 gennaio 2016.
Renzi, Caporale vs Fiano (Pd): “Ci fu rissa tra dirigenti per
Rolex regalati dai sauditi”. “Scena ignominiosa, ma per me non c’è notizia”,
continua "Il Fatto Quotidiano tv". Polemica vivace tra Antonello
Caporale, inviato de Il
Fatto Quotidiano, e il deputato Pd
Emanuele Fiano, durante Omnibus,
su La7. Lo scontro è innescato dall’articolo
di Carlo Tecce,
pubblicato sul numero odierno del Fatto, circa il parapiglia esploso nello
scorso novembre tra i dirigenti del governo in viaggio con Matteo
Renzi in Arabia Saudita: la
rissa tra i dirigenti governativi della folta delegazione italiana è
stata scatenata dalla generosa elargizione di circa 50 Rolex di varia
fattura ad opera del re saudita. Come spiega Caporale nella
trasmissione, nella hall dell’hotel di Ryad alcuni dirigenti italiani si sono
ribellati perché avevano ricevuto l’orologio meno lussuoso, peraltro in barba
alla legge Monti che impone di rifiutare doni oltre i 150 euro. Successivamente
la scorta di Renzi ha dovuto sequestrare gli orologi, tutti prodotti a Dubai e
dal valore oscillante tra3mila e 4mila euro. Caporale commenta:
“Temo che la mediocrità del gruppo dirigente e di coloro che dovrebbero
guidare l’Occidente a risolvere questa crisi internazionale sia tale che anche i
dettagli illustrino il pessimismo generale. E questo episodio è un dettaglio
significativo”. Il giornalista definisce il caso dei Rolex d’oro donati
dagli ‘amici di Ryad’ un dettaglio di costume non certo folkloristico: “E’
indicatore della nostra ambiguità che ovviamente non è solo italiana, e
simboleggia la debolezza dell’Occidente. Che non riesce non solo a porre un’idea
generale cu come far fronte a una guerra così asimmetrica, pericolosa, atipica,
difficile da condurre, ma nemmeno a misurare le forze per far fronte a cose più
banali”. Insorge Fiano, che ribadisce di aver letto l’articolo de Il Fatto
Quotidiano ‘parola per parola': “Qui c’è un grande titolo, ma di notizie
certe non c’è nulla”. “E’ notizia certa che i Rolex siano stati
dati”, replica Caporale. “L’unica fonte che viene citata” – obietta il
parlamentare Pd – “è un consigliere diplomatico di Palazzo Chigi”. “C’è
la nota di Palazzo Chigi alla fine dell’articolo” – ribatte la firma de
Il Fatto – “lo legga tutto”. Ma il deputato Pd, pur definendo “ignominiosa” la
rissa descritta nell’articolo di Tecce, ripete che non c’è notizia, né la nota
di Palazzo. In realtà, la versione del governo c’è e non smentisce nulla, ma
precisa i ruoli: “I doni di rappresentanza ricevuti dalla delegazione
istituzionale italiana, in occasione della recente visita italiana in Arabia
Saudita, sono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio, secondo
quello che prevedono le norme. Come sempre avviene in questi casi, dello
scambio dei doni se ne occupa il personale della presidenza del Consiglio e non
le cariche istituzionali”.
CHI FA LE LEGGI?
Chi fa le leggi? Tante proposte ma
poche tagliano il traguardo. E otto su dieci sono del governo.
Dati Openpolis: nelle ultime due legislature la
percentuale di successo delle iniziative di Palazzo Chigi è stata 36 volte più
alta di quelle parlamentari. L'apice con Letta. I tempi: neanche due settimane
per il trattato su risanamento banche e bail in, quasi 800 giorni per Italicum,
divorzio breve e anti-corruzione, scrive Michela Scacchioli il 5 gennaio 2016 su
“La Repubblica”.
Neanche due settimane per ratificare il trattato sul fondo di risoluzione unica,
quello - tanto discusso in questi giorni di proteste
dei risparmiatori - su risanamento
bancario e salvataggio
interno (bail
in).
Ben 871 giorni, invece, per licenziare il ddl sull'agricoltura sociale che ha
impiegato quasi due anni e mezzo per diventare legge. Nel mezzo ci sono da un
lato lo svuota-carceri, i decreti lavoro, fallimenti, missione
militare Eunavfor Med, competitività e riforma della
pubblica amministrazione che hanno tagliato il traguardo con - al massimo - 44
giorni di tempo. Dall'altro si piazzano Italicum,
divorzio breve, ecoreati, anti-corruzione e affido familiare che oscillano tra i
664 e i 796 giorni necessari al via libera finale. Leggi lepre. E leggi lumaca.
Per rimanere in tema: durante la consueta conferenza stampa di fine anno, il
premier Matteo Renzi ha
detto a proposito delle unioni civili che
sì, il tema divide, ma che "nel 2016 queste vanno" necessariamente "portate a
casa" perché "a differenza di quello che avrei voluto, non siamo riusciti ad
approvare nel 2015" il ddl Cirinnà presentato
in commissione a Palazzo Madama già a marzo del 2013 e successivamente
modificato. "Purtroppo - ha poi aggiunto Renzi - non siamo riusciti a tenere il
tempo. Da segretario del Pd farò di tutto perché il dibattito che si apre al
Senato" a fine gennaio "sia il più serio e franco possibile. Un provvedimento di
questo genere non è un provvedimento su cui il governo immagina di inserire
l'elemento della fiducia, bisognerà lasciare a tutti la possibilità di
esprimersi". In fatto di leggi, tuttavia, i numeri appaiono chiari. Sono 565 le
norme approvate nelle ultime due legislature su un totale di oltre 14mila
proposte. In percentuale, però, tra quelle che sono riuscite a completare
l'iter, otto su dieci sono state presentate dal governo e non dal parlamento
italiano nonostante - costituzionalmente - siano Camera e Senato a essere
titolari del potere legislativo. Vero è che nel corso degli anni, i governi,
detentori di quello esecutivo, hanno ampliato il proprio raggio d'azione. Tanto
che la percentuale di successo delle proposte avanzate da Palazzo Chigi è 36
volte più alta di quelle parlamentari. Le cifre sono
quelle analizzate (al 4 dicembre 2015) da Openpolis per
Repubblica.it.
Secondo l'osservatorio civico, infatti, "ormai è diventata una prassi che la
stragrande maggioranza delle leggi approvate dal nostro parlamento sia di
iniziativa del governo". Nell'attuale legislatura, come nella scorsa, circa
l'80% delle norme approvate è stato proposto dai vari esecutivi che si sono
succeduti. Ma cosa trattavano le oltre 500 leggi votate nelle ultime due
legislature? E poi: nei pochi casi in cui l'iniziativa del parlamento è andata a
buon fine, quali gruppi si sono resi protagonisti? Con che provvedimenti? Quanto
ci vuole in media a dire sì a una legge?
Chi
arriva in fondo. Un’analisi
sulla produzione legislativa del nostro parlamento non può che partire dai
numeri. Dei circa 183 disegni di legge che vengono presentati ogni mese, solo
sei raggiungono la fine del percorso. Di questi sei, nell'80% dei casi si tratta
di proposte avanzate dal governo. E mentre le iniziative di deputati e senatori
diventano legge nello 0,87% delle volte, la percentuale sale al 32,02% quando si
tratta del governo. Delle oltre 565 leggi approvate nelle ultime due
legislature, ben 440 sono state presentate dai vari esecutivi che si sono
succeduti. Fra i governi presi in considerazione, l’apice è stato raggiunto con
il governo di Enrico Letta:
in quel periodo il parlamento ha presentato soltanto l’11% delle leggi poi
approvate.
I tempi. In
media, dal momento della presentazione a quello dell’approvazione finale
trascorrono 151 giorni se si tratta di una proposta del governo. Ne passano 375
se si tratta di un’iniziativa parlamentare. Non stupisce quindi che la top 10
delle 'leggi lumaca' sia composta per il 90% da ddl presentati da deputati e
senatori, e che nella top 10 delle 'leggi lepre' vi siano soltanto quelle
proposte del governo. Se in media l’esecutivo impiega 133 giorni a trasformare
una proposta in legge (poco più di 4 mesi), i membri del parlamento ne impiegano
408 (oltre 1 anno). Nell’attuale legislatura si evidenziano trend opposti:
mentre le proposte del governo sono più lente rispetto allo scorso quinquennato,
quelle del parlamento risultano più veloci.
Tante ratifiche di trattati. Un
altro elemento analizzato è il contenuto di questi testi. Delle 565 leggi
approvate nelle ultime due legislature, il 36,28% erano ratifiche di trattati
internazionali, il 26,55% conversione di decreti leggi. Questo vuol dire che 6
volte su 10 una legge approvata da Camera e Senato non nasce in seno al
parlamento ma viene sottoposta all’aula per eventuali modifiche o bocciature.
Cambi di gruppo e instabilità. Se
da un lato la XVII legislatura
ha confermato lo squilibrio fra governo e parlamento nella produzione
legislativa, dall'altro ha introdotto una forte instabilità nei rapporti fra
maggioranza e opposizione. Il continuo
valzer parlamentare dei cambi di gruppo, con la nascita di tanti nuovi
schieramenti (molti dei quali di 'trincea' fra maggioranza e opposizione) ha
fatto sì che l'opposizione reale, dati alla mano, fosse composta solamente da
tre gruppi: Fratelli d'Italia, Lega Nord e Movimento 5 Stelle. Soltanto questi
tre infatti, alla fine hanno votato nella maggior parte dei casi in contrasto
con il Partito democratico.
Pd in
testa. Dalle politiche
del 2013, sono 30 le proposte di deputati e senatori che hanno completato l’iter
parlamentare (su più di 5mila ddl di iniziativa parlamentare). Protagonista
assoluto è il Partito democratico, che ha presentato il 73,33% dei testi in
questione. A seguire Forza Italia (10%), e poi 5 gruppi a pari merito: Movimento
5 Stelle, Scelta Civica, Per le Autonomie-Psie-Maie, Misto e Lega Nord.
I decreti. A
seguire nell'analisi, con un’altra fetta importante della torta, le conversioni
in legge dei decreti emanati dai vari governi che si sono susseguiti. La
conversione in legge dei decreti è una delle attività principali del nostro
parlamento. Succede molto raramente che un testo deliberato dal Consiglio dei
ministri non venga poi approvato da Camera e Senato. Negli ultimi 4 governi, il
più 'efficiente' è stato è stato quello a guida Letta, con soltanto il 12% dei
decreti decaduti. I decreti deliberati dal Consiglio dei ministri devono essere
convertiti entro 60 giorni. Non sorprende quindi che il 90% delle leggi che
rientra nella top 10 delle più veloci sia conversione di decreti. Fra le 10 più
lente invece, tutte tranne una sono state proposte da membri del parlamento. La
legge di iniziativa governativa più lenta è stata l’Italicum, che ha impiegato
779 giorni dal momento della presentazione per completare il suo iter.
Le Regioni. Nelle
ultime due legislature le Regioni italiane hanno presentato 119 disegni di
legge. Di questi, solamente 5 hanno completato l’iter, e tutti nello scorso
quinquennato. Tre dei cinque erano modifiche agli statuti regionali (di Sicilia,
Friuli-Venezia Giulia e Sardegna), uno è stato approvato come testo unificato
(in materia di sicurezza stradale), mentre l’ultimo è stato assorbito nella
riforma del federalismo fiscale sotto il governo Berlusconi.
Come si vota. Un
altro elemento fondamentale nell'approvazione delle leggi è il voto.
Soffermandosi in particolare sull'attuale legislatura, l'analisi si è
concentrata su chi ha contribuito, e in che modo, all'approvazione finale di
questi provvedimenti. Dalla percentuale di posizioni favorevoli sui voti finali
dei singoli gruppi presenti in aula, alla consistenza della maggioranza nel
corso della legislatura, passando per il rapporto fra voti finali e questioni di
fiducia. Se si prende il Pd come punto di riferimento in qualità di principale
forza politica all'interno della coalizione di governo, si è ricostruita la
distanza (o vicinanza) dall’esecutivo degli altri gruppi parlamentari. Il primo
dato che emerge è che su 435 votazioni finali, in 104 occasioni (23,01%), tutti
i gruppi alla Camera e al Senato hanno votato con il Pd.
Le opposizioni. Il
comportamento delle opposizioni nei voti finali regala molti spunti
interessanti. Perché se su carta alcuni schieramenti nel corso dei mesi si sono
dichiarati in contrasto con gli esecutivi di Letta prima e Renzi poi, i dati
raccontano altro. Nei voti finali alla Camera, ad esempio, Sel, gruppo di
opposizione, ha votato il 52% delle volte in linea col Pd. Al Senato, ramo in
cui i numeri a favore dell’esecutivo sono più risicati, solamente due gruppi
(Lega Nord e Movimento 5 Stelle) hanno votato nelle maggior parte dei voti
finali (più del 50%) diversamente dal Pd.
Voto di
fiducia: chi l'ha usato di più. Per
completare il quadro sulle votazioni, non si poteva non affrontare il tema delle questioni
di fiducia sui progetti di legge. Due
gli aspetti analizzati: da un lato il rapporto tra blindatura e leggi approvate,
dall’altro le occasioni durante le quali lo strumento è stato utilizzato più di
due volte sullo stesso provvedimento. Non solo la maggior parte delle leggi
viene proposta dal governo, ma emerge pure che l'approvazione richiede un
utilizzo elevato delle questioni di fiducia. In media, nelle ultime due
legislatura, il 27% delle leggi approvate ha necessitato di un voto di fiducia,
con picchi massimi raggiunti dal governo Monti: il 45,13 per cento. Ma quali
sono stati i provvedimenti che hanno richiesto più voti di fiducia? Al primo
posto c'è la riforma del lavoro, governo Monti, che ha richiesto 8 voti di
fiducia. Cinque voti di fiducia per il ddl anti-corruzione (sempre governo
Monti) e ancora cinque per la Stabilità 2013. Quattro voti di fiducia per il
decreto sviluppo e la riforma fiscale (governo Monti), tre per la legge sviluppo
2008 (governo Berlusconi). Tre voti di fiducia per la Stabilità 2014 (governo
Letta), tre anche per Stabilità 2015, Italicum, Jobs Act e riforma Pa (governo
Renzi).
Voti finali alla Camera. Uno
dei modi per capire il reale posizionamento in aula dei gruppi parlamentari è
vedere se il loro comportamento durante i voti finali è in linea o meno con
quello del governo. Questo esercizio permette anche di osservare come è variato
il sostegno all’esecutivo con la staffetta Letta-Renzi. Se da un lato Forza
Italia durante il governo Letta votava l’86% delle volte con il Pd (al tempo in
maggioranza), con il governo Renzi - e il riposizionamento dei berlusconiani -
la percentuale è scesa al 64,57 per cento.
Voti finali al Senato. I
numeri del governo a Palazzo Madama sono molto più risicati rispetto a quelli di
Montecitorio. Non sorprende quindi che la maggior parte dei gruppi, per un
motivo o per l’altro, spesso e volentieri abbia votato con il Pd nei voti finali
dei provvedimenti discussi in aula. Da sottolineare come i fuoriusciti da Forza
Italia, sia
Conservatori e Riformisti (di Raffaele
Fitto) che Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (di Denis
Verdini), da quando sono nati hanno votato rispettivamente il 78,69% e
il 78,13% delle volte in linea con il governo nei voti finali.
Voti finali panpartisan. Nel
dibattito parlamentare può succedere che su determinati argomenti si arrivi ad
una votazione panpartisan. Sono i casi i cui tutti i gruppi che siedono in aula
votano a favore, con nessuno ad astenersi o votare contro. Su 435 voti finali
che si sono tenuti da inizio legislatura, è successo ben 104 volte (23,91%). Più
ricorrente al Senato (28,10%) che alla Camera (20%). Trattasi principalmente,
nel 74% dei casi, di ratifica di trattati internazionali.
"PADRI
DELLA PATRIA" VITTIME E COMPLICI DELLA
NOSTRA ROVINA.
Lettera da
Crispi a Garibaldi - Caprera. Torino, 3 febbraio 1863.
Mio Generale!
Giunto da Palermo, dove stetti poco men che un
mese, credo mio dovere dirvi qualche cosa della povera isola che voi chiamaste a
libertà e che i vostri successori ricacciarono in una servitù peggiore di prima.
Dal nuovo regime quella popolazione nulla ha
ottenuto di che potesse esser lieta. Nissuna giustizia, nissuna sicurezza
personale, l'ipocrisia della libertà sotto un governo, il quale non ha
d'italiano che appena il nome. Ho visitate le carceri e le ho trovate piene
zeppe d'individui i quali ignorano il motivo per il quale sono prigionieri. Che
dirvi del loro trattamento? Dormono sul pavimento, senza lume la notte, sudici,
nutriti pessimamente, privi d'ogni conforto morale, senza una voce che li
consigli e li educhi onde fosser rilevati dalla colpa.
La popolazione in massa detesta il governo
d'Italia, che al paragone trova più tristo del Borbonico. Grande fortuna che non
siamo travolti in quell'odio noi, che fummo causa prima del mutato regime! Essa
ritien voi martire, noi tutti vittime della tirannide la quale viene da Torino e
quindi ci fa grazia della involontaria colpa. Se i consiglieri della Corona non
mutano regime, la Sicilia andrà incontro ad una catastrofe.
E' difficile misurarne le conseguenze, ma esse
potrebbero essere fatali alla patria nostra. L'opera nostra dovrebbe mirare ad
evitare cotesta catastrofe, affinchè non si sfasci il nucleo delle provincie
unite che al presente formano il regno di Italia. Con le forze di questo regno e
coi mezzi ch'esso ci offre, noi potremmo compiere la redenzione della penisola e
occupar Roma. Sciolto cotesto nucleo, è rimandata ad un lontano avvenire la
costituzione d'Italia. Della vostra salute,
alla quale tutti c'interessiamo, ho buone notizie, che spero sempre migliori. Di
Palermo tutti vi salutano come vi amano.
Abbiatevi i complimenti di mia moglie e voi continuatemi il vostro affetto e
credetemi. Vostro ora
e sempre. F. Crispi.
La verità è rivoluzionaria. Gli oltraggi subiti dalle popolazioni meridionali
sono incommensurabili. Non credo di aver fatto del male. Nonostante ciò, non
rifarei oggi la via dell'Italia meridionale, temendo di essere preso a sassate,
essendosi colà cagionato solo squallore e suscitato solo odio. Giuseppe
Garibaldi (da una lettera scritta ad Adelaide Cairoli, 1868)
Cronologia moderna delle azioni massoniche e mafiose.
27 marzo 1848 - Nasce la Repubblica Siciliana. La Sicilia ritorna ad essere
indipendente, Ruggero Settimo è capo del governo, ritorna a sventolare l'antica
bandiera siciliana. Gli inglesi hanno numerosi interessi nell'Isola e
consigliano al Piemonte di annettersi la Sicilia. I Savoia preparano una
spedizione da affidare a Garibaldi. Cavour si oppone perchè considera
quest'ultimo un avventuriero senza scrupoli (ricordano impietositi i biografi
che Garibaldi ladro di cavalli, nell' America del sud, venne arrestato e gli
venne tagliato l'orecchio destro. Sarà, suo malgrado, capellone a vita per
nascondere la mutilazione) [Secondo altre fonti l’orecchio gli sarebbe stato
staccato con un morso da una ragazza che aveva cercato di violentare all’epoca
della sua carriera di pirata, stupratore, assassino in America Latina, NdT]. Il
nome di Garibaldi, viene abbinato altresì al traffico di schiavi dall'Africa
all'America. Rifornito di denaro inglese da i Savoia, Garibaldi parte per la
Sicilia.
11 maggio 1860 - Con la protezione delle navi inglesi Intrepid e H.M.S. Argus,
Garibaldi sbarca a Marsala. Scrive il memorialista garibaldino Giuseppe Bandi: I
mille vengono accolti dai marsalesi come cani in chiesa! La prima azione mafiosa
è contro la cassa comunale di Marsala. Il tesoriere dei mille, Ippolito Nievo
lamenta che si trovarono pochi spiccioli di rame. I siciliani allora erano meno
fessi! E' interessante la nota di Garibaldi sull'arruolamento: "Francesco Crispi
arruola chiunque: ladri, assassini, e criminali di ogni sorta".
15 maggio 1860 - Battaglia di Calatafimi. Passata alla storia come una grande
battaglia, fu invece una modesta scaramuccia, si contarono 127 morti e 111
furono messi fuori combattimento. I Borbone con minor perdite disertano il
campo. Con un esercito di 25.000 uomini e notevole artiglieria, i Borbone
inviano contro Garibaldi soltanto 2.500 uomini. E' degno di nota che il generale
borbonico Landi, fu comprato dagli inglesi con titoli di credito falsi e che
l'esercito borbonico ebbe l'ordine di non combattere. Le vittorie di Garibaldi
sono tutte una montatura.
27 maggio 1860 - Garibaldi entra a Palermo da vincitore!....Ateo, massone,
mangiapreti, celebra con fasto la festa di santa Rosalia.
30 maggio 1860 - Garibaldi dà carta bianca alle bande garibaldine; i villaggi
sono saccheggiati ed incendiati; i garibaldini uccidevano anche per un grappolo
d'uva. Nino Bixio uccide un contadino reo di aver preso le scarpe ad un
cadavere. Per incutere timore, le bande garibaldine, torturano e fucilano gli
eroici siciliani.
31 maggio 1860 - Il popolo catanese scaccia per sempre i Borbone. In
quell'occasione brillò, per un atto di impavido coraggio, la siciliana
Giuseppina Bolognani di Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Issò sopra un carro un
cannone strappato ai borbonici e attese la carica avversaria; al momento
opportuno, l'avversario a due passi, diede fuoco alle polveri; il nemico,
decimato, si diede alla fuga disordinata. Si guadagnò il soprannome Peppa 'a
cannunera (Peppa la cannoniera) e la medaglia di bronzo al valor militare.
2 giugno 1860 - Con un decreto, Garibaldi assegna le terre demaniali ai
contadini; molti abboccano alla promessa. Intanto nell'Isola divampava impetuosa
la rivoluzione che vedeva ancora una volta il Popolo Siciliano vittorioso. Fu lo
stesso popolo che unito e compatto costrinse i borbonici alla ritirata verso
Milazzo.
17 luglio 1860 - Battaglia di Milazzo. Il governo piemontese invia il Generale
Medici con 21.000 uomini bene armati a bordo di 34 navi. La montatura
garibaldina ha fine. I contadini siciliani si ribellano, vogliono la terra
promessagli. Garibaldi, rivelandosi servo degli inglesi e degli agrari, invia
loro Nino Bixio.
10 agosto 1860 - Da un bordello di Corleone, Nino Bixio ordina il massacro di
stampo mafioso di Bronte. Vengono fucilati l'avvocato Nicolò Lombardo e tre
contadini, tra i quali un minorato! L'Italia mostra il suo vero volto.
21 ottobre 1860 - Plebiscito di annessione della Sicilia al Piemonte. I voti si
depositano in due urne: una per il "Sì" e l'altra per il "No". Intimorendo, come
abitudine mafiosa, ruffiani, sbirri e garibaldini controllano come si vota. Su
una popolazione di 2.400.000 abitanti, votarono solo 432.720 cittadini (il 18%).
Si ebbero 432.053 "Sì" e 667 "No". Giuseppe Mazzini e Massimo D'Azeglio furono
disgustati dalla modalità del plebiscito. Lo stesso ministro Eliot, ambasciatore
inglese a Napoli, dovette scrivere testualmente nel rapporto al suo Governo che:
"Moltissimi vogliono l'autonomia, nessuno l'annessione; ma i pochi che votano
sono costretti a votare per questa". E un altro ministro inglese, Lord John
Russel, mandò un dispaccio a Londra, cosí concepito: "I voti del suffragio in
questi regni non hanno il minimo valore".
1861 - L'Italia impone enormi tasse e l'obbligo del servizio militare, ma per
chi ha soldi e paga, niente soldato. Intanto i militari italiani, da mafiosi,
compiono atrocità e massacri in tutta l'Isola. Il sarto Antonio Cappello,
sordomuto, viene torturato a morte perchè ritenuto un simulatore, il suo
aguzzino, il colonnello medico Restelli, riceverà la croce dei "S.S. Maurizio e
Lazzaro". Napoleone III scrive a Vittorio Emanuele: "I Borbone non commisero in
cento anni, gli orrori e gli errori che hanno commesso gli agenti di Sua Maestà
in un anno”.
1863 - Primi moti rivoluzionari antitaliani di pura marca indipendentista. Il
governo piemontese instaura il primo stato d'assedio. Viene inviato Bolis per
massacrare i patrioti siciliani. Si prepara un'altra azione mafiosa contro i
Siciliani.
8 maggio 1863 - Lord Henry Lennox denuncia alla camera dei Lords le infamie
italiane e ricorda che non Garibaldi ma l'Inghilterra ha fatto l'unità
d'Italia.
15 agosto 1863 - Secondo stato d'assedio. Si instaura il terrore. I Siciliani si
rifiutano di indossare la divisa italiana; fu una vera caccia all'uomo, le
famiglie dei renitenti furono torturate, fucilate e molti furono bruciati vivi.
Guidava l'operazione criminale e mafiosa il piemontese Generale Giuseppe Govone.
(Nella pacifica cittadina di Alba, in piazza Savona, nell'aprile 2004 è stato
inaugurato un monumento equestre a questo assassino. Ignoriamo per quali
meriti.)
1866 - In Sicilia muoiono 52.990 persone a causa del colera. Ancora oggi, per
tradizione orale, c'è la certezza che a spargervi il colera nell'Isola siano
state persone legate al Governo italiano. Intanto tra tumulti, persecuzioni,
stati d'assedio, terrore, colera ecc. la Sicilia veniva continuamente depredata
e avvilita; il Governo italiano vendette perfino i beni demaniali ed
ecclesiastici siciliani per un valore di 250 milioni di lire. Furono, nel
frattempo, svuotate le casse della regione. Il settentrione diventava sempre più
ricco, la Sicilia sempre più povera.
1868 - Giuseppe Garibaldi scrive ad Adelaide Cairoli:"Non rifarei la via del
Sud, temendo di essere preso a sassate!". Nessuna delle promesse che aveva fatto
al Sud (come quella del suo decreto emesso in Sicilia il 2 giugno 1860, che
assegnava le terre comunali ai contadini combattenti), era stata mantenuta.
1871 - Il Governo, con un patto scellerato, fortifica la mafia con l'effettiva
connivenza della polizia. Il coraggioso magistrato Diego Tajani dimostrò e
smascherò questa alleanza tra mafia e polizia di stato e spiccò un mandato di
cattura contro il questore di Palermo Giuseppe Albanese e mise sotto inchiesta
il prefetto, l'ex garibaldino Gen. Medici. Ma il Governo italiano, con fare
mafioso si schiera contro il magistrato costringendolo a dimettersi.
1892 - Si formano i "Fasci dei Lavoratori Siciliani". L'organizzazione era
pacifica ed aveva gli ideali del popolo, risolvere i problemi siciliani.
Chiedeva, l'organizzazione dei Fasci la partizione delle terre demaniali o
incolte, la diminuzione dei tassi di consumo regionale ecc.
4 gennaio 1894 - La risposta mafiosa dello stato italiano non si fa attendere:
STATO D'ASSEDIO. Francesco Crispi, (definito da me traditore dei siciliani a
perenne vergogna dei riberesi) presidente del Consiglio, manda in Sicilia 40.000
soldati al comando del criminale Generale Morra di Lavriano, per distruggere
l'avanzata impetuosa dei Fasci contadini. All'eroe della resistenza catanese
Giuseppe De Felice vengono inflitti 18 anni di carcere; fu poi amnistiato nel
1896, ricevendo accoglienze trionfali nell'Isola.
Note di "Sciacca Borbonica": Sono molti i paesi del mondo che dedicano vie,
piazze e strade a lestofanti e assassini. Ma pochi di questi paesi hanno fatto
di un pirata macellaio addirittura il proprio eroe nazionale. Il 27 luglio 1995
il giornale spagnolo "El Pais", giustamente indignato per l’apologia di
Garibaldi fatta dall’allora presidente Scalfaro (quello che si prendeva 100
milioni al mese in nero dal SISDE, senza che nessuno muovesse un dito) nel corso
di una visita in Spagna, così gli rispose a pag. 6: “Il presidente d'Italia è
stato nostro illustre visitante...... Disgraziatamente, in un momento della sua
visita, il presidente italiano si è riferito alla presenza di Garibaldi nel Rio
della Plata, in un momento molto speciale della storia delle nazioni di questa
parte del mondo. E, senza animo di riaprire vecchie polemiche e aspre
discussioni, diciamo al dott. Scalfaro che il suo compatriota [Garibaldi] non ha
lottato per la libertà di queste nazioni come egli afferma. Piuttosto il
contrario". Il 13 settembre 1860, mentre l'unificazione italiana era in pieno
svolgimento, il giornale torinese Piemonte riportava il seguente articolo.
(1): «Le imprese di Garibaldi nelle Due Sicilie parvero sin da allora così
strane che i suoi ammiratori ebbero a chiamarle prodigiose. Un pugno di giovani
guidati da un audacissimo generale sconfigge eserciti, piglia d'assalto le città
in poche settimane, si fa padrone di un reame di nove milioni di abitanti. E ciò
senza navigli e senz'armi... Altro che Veni, Vedi, Vici! Non c'è Cesare che
tenga al cospetto di Garibaldi. I miracoli però non li ha fatti lui ma li fecero
nell'ordine: 1°)-L'oro con il quale gli inglesi comprarono quasi tutti i
generali borbonici e col quale assoldarono 20.000 mercenari ungheresi e slavi e
pagarono il soldo ad altri 20.000 tra carabinieri e bersaglieri, opportunamente
congedati dall'esercito sardo-piemontese e mandati come "turisti" nel Sud, altro
che i 1000 scalcinati eroi...... 2°)-il generale Nunziante ed altri tra
ufficiali dell'esercito e della marina che, con infinito disonore, disertarono
la loro bandiera per correre sotto quella del nemico eccovi servito un piccolo
elenco di traditori al soldo degli anglo-piemontesi, oltre al
Nunziante: Generale Landi, Generale Cataldo, Generale Lanza, Generale Ghio,
Comandante Acton, Comandante Cossovich,ed altri ancora; 3°)-i miracoli li ha
fatti il Conte di Siracusa con la sua onorevolissima lettera al nipote Francesco
II° (lettera pubblicata in un post a parte); 4°)-li ha fatti la Guardia
Nazionale che, secondo il solito, voltò le armi contro il re che gliele avea
date poche ore prima; 5°)-)li ha fatti il Gabinetto di Liborio Romano il quale,
dopo aver genuflesso fino al giorno di ieri appié del trono di Francesco II, si
prostra ai piedi di Garibaldi; 6°)- La quasi totalità della nobiltà siciliana.
Beh, Con questi miracoli ancor io sarei capace di far la conquista, non dico
della Sicilia e del Reame di Napoli, ma dell'universo mondo. Dunque non state a
contare le prodezze di Sua Maestà Garibaldi I. Egli non è che il comodino della
rivoluzione. Le società segrete (la massoneria) che hanno le loro reti in tutto
il paese delle Due Sicilie, hanno di lunga mano preparato ogni cosa per la
rivoluzione. E quando fu tutto apparecchiato si chiamò Garibaldi ad eseguire i
piani [...]. Se non era Garibaldi sarebbe stato Mazzini, Kossuth, Orsini o Lucio
della Venaria: faceva lo stesso. Appiccare il fuoco ad una mina anche un bimbo
può farlo. Di fatto vedete che dappertutto dove giunge Garibaldi la rivoluzione
è organizzata issofatto, i proclami sono belli e fatti, anzi stampati. In questo
modo credo che Garibaldi può tranquillamente fare il giro del mondo a piantare
le bandiere tricolori del Piemonte. Dopo Napoli Roma, dopo Roma Venezia, dopo
Venezia la Dalmazia, dopo la Dalmazia l'Austria, caduta l'Austria il mondo è di
Garibaldi, cioé del Piemonte! Oh che cuccagna! Torino capitale dell'Europa, anzi
dell'orbe terracqueo. Ed i torinesi padroni del mondo!». Dai Savoia agli
Agnelli, da una famiglia di vampiri ad un altra.....per il Sud sempre lo stesso
destino.......dar loro anche l'ultima goccia di sangue. Comunque la Giustizia
Divina arriva sempre........i savoia son finiti nella merda e nel ludibrio, gli
Agnelli nella tomba e nella droga che certamente sarà il mezzo con quale ci
libereremo di questa gente maledetta.
Gli eurobond che fecero l'Unità d'Italia quando il Regno di
Napoli era come la Germania, scrive
Giuseppe
Chiellino il 30 giugno 2012 su “Il Sole 24 Ore”. Il vertice europeo di
fine giugno ha cancellato gli eurobond dall'agenda. Almeno per ora. Angela
Merkel è stata drastica: «Mai finchè sarò viva» aveva detto in pubblico qualche
giorno prima. Chissà se la cancelliera tedesca aveva avuto il tempo di leggere
lo studio di Stéphanie Collet, storica della finanza della Université Libre de
Bruxelles che è andata a spulciare negli archivi delle Borse di Parigi e Anversa
per studiare l'unico precedente assimilabile agli Eurobond: l'unificazione del
debito sovrano dei sette stati che 150 anni orsono, su iniziativa del Piemonte e
sotto tutela di Francia e Inghilterra, costituirono il Regno d'Italia. Nella
storia dello stato moderno è l'esperienza storicamente più vicina al
faticosissimo tentativo di dare maggiore consistenza politica all'Unione
europea, anche attraverso l'integrazione delle politiche economiche e fiscali,
compresi debiti sovrani dei 17 paesi dell'euro. Un precedente prezioso, secondo
la Collet, per cercare di capire – mutatis mutandis - come potrebbero
comportarsi i mercati finanziari di fronte all'unificazione del debito pubblico
dei paesi della zona euro. «Come l'Italia di allora, l'Europa oggi è fatta da
stati eterogenei, con economie di dimensioni e condizioni diverse, che parlano
lingue diverse e hanno sistemi di imposizione fiscale separati» ricorda la
studiosa. Grazie al fatto che anche dopo l'unificazione i titoli del Regno
d'Italia conservarono fino al 1876 l'indicazione della loro origine (per
esempio, ad Anversa le emissioni del Regno delle Due Sicilie erano indicate come
"Italy-Neapolitean") la Collet è riuscita a ricostruire le serie storiche dei
prezzi settimanali tra il 1847 e il 1873. Un lavoro certosino di raccolta
manuale dei dati dagli archivi e dai database originali per capire come si sono
mosse le quotazioni, prima e dopo l'unità, politica ed economica. 25 emissioni
suddivise in quattro gruppi: Regno di Piemonte e Sardegna, Lombardo-Veneto, Due
Sicilie e Stato Pontificio. La prima cosa che balza agli occhi è lo spread
(anche allora!) tra i rendimenti dei diversi gruppi di bond prima e dopo
l'Unità. Quelli del Regno delle Due Sicilie (che erano un quarto del totale)
prima del 1861 pagavano i tassi più bassi: 4,3%, 140 punti base in meno delle
emissioni papali e di quelle piemontesi (che rappresentavano rispettivamente il
29% e il 44% del debito unitario dopo la conversione) e 160 in meno rispetto a
quelle Lombardo-Venete (che però erano solo il 2%). Insomma, a voler utilizzare
le categorie di oggi, il Regno di Napoli economicamente era per l'Italia quello
che oggi la Germania è per l'Eurozona. «Come il Regno di Napoli prima
dell'integrazione del debito sovrano, la Germania di oggi è l'economia più forte
dell'eurozona e beneficia del costo del debito più basso in assoluto» scrive
Collet. Considerazioni, queste, che faranno storcere il naso a molti, ma
sicuramente non di parte. Del resto, come ricorda Collet, Napoli era di gran
lunga la città più importante del neonato Regno d'Italia. E le regioni del Sud
avevano una discreta struttura industriale, un'agricoltura fiorente sia pure
basata sul latifondismo, e importanti porti commerciali. Subito dopo il 1861,
però, lo scettiscismo dei mercati nel processo unitario italiano impose un "risk
premium" comune a tutti i bond degli stati preunitari, anche a quelli che fino a
quel momento avevano goduto di maggiore fiducia e dunque di rendimenti più
bassi. Proprio quello che oggi la Germania teme possa avvenire con gli eurobond:
l'anno successivo, infatti, i rendimenti dei titoli convertiti in "Regno
d'Italia" si allinearono ben al di sopra dei tassi precedenti, al 6,9%. Per gli
"Italy – Neapolitean" 260 punti base in più che diventarono 460 nel 1870, per
poi cominciare a ripiegare dopo il 1871, quando cioè l'annessione di Venezia e
di Roma e il trasferimento della capitale nella città del papato convinsero gli
investitori, e non solo, che l'Unità era ormai irreversibile. L"Italia" non era
più una mera "espressione geografica", come l'aveva definita Metternich nel
1847, ma dopo tre guerre d'indipendenza e più di vent'anni di manovre
diplomatiche era diventata uno stato unitario. «L'integrazione dei debiti
sovrani era stato uno strumento per portare avanti l'integrazione politica, come
sarebbe oggi per l'Europa» afferma Collet, ma nota anche che «un aumento del
premio di rischio aggraverebbe la crisi del debito che sta vivendo l'Europa
piuttosto che risolverla. Significherebbe che, se fossero introdotti gli
eurobond, la Germania perderebbe il suo rating elevato». Questo portava Collet a
definire, già nei mesi scorsi, «remote» le speranze di vedere nel breve termine
un mercato integrato dei titoli di debito dell'eurozona. Nel lungo termine,
invece, i risultati della ricerca sul caso italiano dimostrano che «nel tempo i
rendimenti dei titoli diminuirono». Alla luce di questo, oggi la domanda è:
quanto tempo ci vorrà perché anche l'Europa sia considerata come un blocco unico
e in grado di dotarsi di un vero e proprio piano di salvataggio per l'euro? Per
l'Italia ci volle all'incirca un decennio. Considerato che quella italiana fu
un'annessione anche militare e quella europea è un'integrazione consensuale, e
che i mercati dei capitali si muovono a ritmi diversi rispetto alla seconda metà
dell'800, anche Collet concorda che un aumento del costo del debito nel breve
termine sarebbe un prezzo che potremmo permetterci di pagare se avessimo la
certezza di avere, tra qualche anno, un'Europa più unita. Ma questa certezza
nessuna ricerca, per quanto accurata, potrà mai darla. Serve, forse, la capacità
di andare oltre il breve periodo, di guardare un po' più lontano rispetto alla
prossima scadenza elettorale, superando la "veduta corta" che per Tommaso Padoa
Schioppa è stata «la radice» della crisi.
Moratoria
dei pm su Expo? Il pm snobba la questione.
Nel
suo ultimo discorso pubblico da Procuratore, Edmondo Bruti Liberati liquida con
poche ma esplicite righe il tema della presunta "moratoria" concessa durante
Expo per non infierire con arresti e avvisi di garanzia sull'andamento
dell'esposizione universale, scrive Luca Fazzo Mercoledì 11/11/2015 su “Il
Giornale”. "La Procura di Milano ha svolto il ruolo che le compete di
accertamento rigoroso dei fatti di reato. "La magistratura penale non deve farsi
carico di "compatibilitá"". Nel suo ultimo discorso pubblico da Procuratore,
Edmondo Bruti Liberati liquida con poche ma esplicite righe il tema che da
settimane, ma soprattutto nelle ultime ore, incombe sulla sua gestione della
Procura di Milano: la presunta "moratoria" concessa durante Expo per non
infierire con arresti e avvisi di garanzia sull'andamento dell'esposizione
universale. Una sorta d conferma dell'esistenza della moratoria é venuta ieri
dal presidente del Consiglio Matteo Renzi, che nel suo discorso milanese ha
ringraziato la magistratura per la "responsabilità " dimostrata in questi mesi.
"Non ci siamo fermati checché se ne dica oggi in alcuni commenti", ha detto
Bruti replicando agli articoli odierni innescati dal "ringraziamento" di Renzi.
Bruti, che aveva assunto su di sé il coordinamento delle indagini sull'evento
milanese, nega che una moratoria vi sia stata. Rivendica le inchieste compiute
prima dell'avvio dell'esposizione, "la massima celerità" impressa alle indagini,
che "ha consentito alla struttura Expo 2015 di adottare te elettivamente i
provvedimenti per la sostituzione dei manager colpiti da custodia cautelare
evitando ogni stasi nel periodo delicatissimo di predisposizione delle strutture
di base dell'evento". "Spettava ad altre articolazioni istituzionali operare
affinché seguissero iniziative gestionali ed amministrative atte a assicurare la
prosecuzione delle opere in condizioni di ripristinata legalità ". Il
riferimento é alle indagini che portarono all'arresto di alcuni tra i
collaboratori più stretti del commissario di Expo Giuseppe Sala e di alcuni
sopravvissuti di Tangentopoli. Se altre indagini si sono accumulate nel
frattempo nei cassetti, e se daranno i loro frutti dopo la chiusura di Expo, lo
si scoprirà solo nelle prossime settimane. Oggi Bruti Liberati dá l'addio alla
carica, presentando il Bilancio sociale della procura che ha guidato per cinque
anni. Alla presenza del ministro Andrea Orlando, Bruti rivendica numeri alla
mano una serie di numeri che dimostrano come il lavoro quotidiano dei suoi
ottanta sostituti abbia risposto sempre meglio alle esigenze di una città alle
prese con i multiformi aspetti della criminalità. Vero. Ma lo stesso Procuratore
sa bene che il tema cruciale é quello del rapporto con il potere politico. E su
questo punto le polemiche non sono destinate a chiudersi con la sua uscita di
scena.
Trattativa
Pd-magistrati.
Renzi svela l'accordo con la procura di Milano: grazie per la
vostra sensibilità, scrive Alessandro Sallusti Mercoledì 11/11/2015 su “Il
Giornale”. In visita ieri a Milano per il dopo Expo, Matteo Renzi ha detto:
«Ringraziamo i magistrati che hanno avuto sensibilità nel rispetto rigoroso
delle leggi», svelando così un segreto di Pulcinella. Perché quello che tutti
sapevano, e che nessuno osava dire, è che c'è stata una trattativa sull'asse
Quirinale-Palazzo Chigi-Procura di Milano per sospendere le inchieste
giudiziarie sui vertici dell'Expo per tutto il periodo della rassegna
universale. Non si doveva rovinare la festa al governo di sinistra, non scalfire
l'immagine di Giuseppe Sala, capo di Expo e futuro candidato sindaco del Pd a
Milano. Altro che trattativa Stato-mafia. Qui siamo alla trattativa
Stato-magistrati, che evidentemente - ce lo dice Renzi in persona - è andata a
buon fine. Sarebbe interessante sapere chi ha trattato con chi, chi ha ordinato
ai magistrati di fermarsi e chi a Palazzo di giustizia si è fatto garante
dell'accordo. Verrebbe da dire: finalmente qualcuno fa valere l'interesse di
Stato sulla furia devastatrice di pm incoscienti. Ma ci chiediamo anche perché
questo sano principio non sia stato applicato durante la ventennale caccia a
Silvio Berlusconi presidente del Consiglio, che enormi danni ha provocato
all'interessato ma soprattutto al Paese. Ricordate l'avviso di garanzia - il
primo a un premier in carica nella storia repubblicana - spedito da questi
stessi magistrati a Berlusconi a Napoli, nel pieno della conferenza
internazionale sulla criminalità organizzata? Non ci fu alcuna «sensibilità», né
«rispetto delle leggi», tanto che l'allora premier fu poi totalmente assolto.
Così come gli interessi del Paese sono stati negli anni calpestati con inchieste
farlocche sui vertici delle nostre grandi aziende, da Eni a Finmeccanica, da
Fastweb a Unicredit. Solo con un governo di sinistra i magistrati abbassano la
testa e ripongono nei cassetti i faldoni delle intercettazioni. Questa è la
prova che l'uso politico della giustizia non è una fantasia di qualche
squilibrato. È un fatto. Le procure si muovono contro una parte, che è sempre la
stessa, ma anche a difesa di una parte che, guarda caso, è pure quella sempre la
stessa. Tutto ciò spiega anche perché Giuseppe Sala stia prendendo tempo prima
di accettare la candidatura del Pd a guidare Milano: vuole sapere se il suo
lasciapassare è scaduto con la chiusura dei cancelli di Expo o se sarà rinnovato
fino alle elezioni, meglio all'infinito. Ma così la partita è truccata. E addio
democrazia.
Trattativa
Pd-pm milanesi: presto cadranno tutti i segreti.
Dopo il plauso di Renzi ai giudici che hanno salvato Expo e Sala,
il procuratore smentisce: "Nessuna moratoria". Bruti va in pensione, se
ripartono le inchieste sarà la controprova, scrive Luca Fazzo Giovedì 12/11/2015
su “Il Giornale”. Procuratore, cosa c'è nei vostri cassetti? La domanda rimane
senza risposta. Edmondo Bruti Liberati scivola via, inghiottito nel nugolo di
agenti che scortano, pochi metri più in là, il ministro della Giustizia Andrea
Orlando. Per Bruti è il giorno dell'addio. Nell'aula magna del tribunale il
Procuratore ha tenuto il suo ultimo discorso. Tra tre giorni andrà in pensione.
È un addio amaro. Non solo perché Bruti se ne va anzitempo, sull'onda delle
polemiche furibonde che hanno lacerato la Procura milanese, e che lo esponevano
al rischio di essere esautorato dal Csm. Ma anche perché, manco a farlo apposta,
alla vigilia del suo addio gli è piombato addosso un ringraziamento che somiglia
a un killeraggio: quello del presidente del Consiglio.«Voglio ringraziare i
magistrati di Milano per il rispetto rigoroso della legge ma anche del sistema
istituzionale», aveva detto Matteo Renzi. Parole che a chiunque (compresi
numerosi magistrati) sono suonate come la conferma ufficiale di quanto da mesi
si dice nel Palazzo di giustizia milanese, e che solo un vecchio reporter
iconoclasta come Frank Cimini aveva osato scrivere: l'esistenza di una moratoria
tacita, un accordo tra potere politico e procura milanese per consentire a Expo
di svolgersi al riparo da retate e avvisi di garanzia. «Nessuna moratoria - dice
ieri Bruti - io sto ai fatti: le indagini su Expo sono state fatte». Se un
riguardo c'è stato, dice il procuratore, è consistito nella «celerità
dell'indagine» perché non si bloccassero i lavori dell'esposizione».
Nient'altro. E il ministro Orlando prova anche lui a smosciare, spiegando che il
«rispetto istituzionale» dimostrato dalla Procura milanese ha significato
soltanto «fare ciò che impone la legge»: frase evidentemente priva di
significato. E dunque? Di cosa parla davvero Renzi, quali accordi taciti o
espliciti sono intercorsi in questi mesi perché non si disturbasse l'Expo di
Giuseppe Sala? Per capire la portata di questi interrogativi bisogna andare
indietro, alla nomina di Bruti alla guida della Procura cinque anni fa,
conquistata grazie ad un accordo bipartisan in Csm fortemente voluto da Giorgio
Napolitano: e a come il Quirinale abbia sempre vegliato su Bruti, considerandolo
un magistrato non ottusamente chiuso nei codici ma aperto anche alle esigenze
della società e della politica, e poi difendendolo apertamente anche nel momento
più difficile, lo scontro con il suo vice Alfredo Robledo.Di questa
interpretazione «politica» del suo ruolo, Bruti ha beneficiato a volte anche il
centrodestra: come quando evitò il carcere a Alessandro Sallusti, o aprì la
strada all'affidamento ai servizi sociali di Silvio Berlusconi. Ma è oggettivo
che il caso più eclatante, l'inchiesta Sea dimenticata in cassaforte, ha tolto
una rogna dal cammino della giunta rosso-arancione di Milano. Ed è altrettanto
evidente che le inchieste su Expo che ieri Bruti rivendica si sono fermate tutte
alla vigilia dell'esposizione. Dopo le retate del 2014, le indagini si sono
fermate.Solo nelle prossime settimane, chiusa Expo e pensionato Bruti, si capirà
se davvero, come si dice da tempo in tribunale, le notizie di reato relative
all'esposizione siano continuate ad arrivare, e siano tenute sotto nomi di
copertura in attesa della fine della moratoria.
Cassazione, Stefania Craxi deve pagare debito per condanne
Bettino: all’Erario andranno 676 mila euro. Una tegola
fiscale piombata addosso alla figlia dell’ex leader Psi per una sentenza dei di
«Mani pulite», quella sulle tangenti della metropolitana di Milano, scrive
“Il Corriere della
Sera” del’11 novembre 2015. Una tegola fiscale, chiamiamola così, che le
piomba addosso dai tempi di «Mani pulite». Stefania Craxi deve pagare al fisco
676 mila per il recupero dell’imposta di registro - tassa che colpisce i
trasferimenti di proprietà - iscritta a debito anni e fa e riferita alla
sentenza penale di condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione riportata da
suo padre Bettino. Era relativa al processo per le tangenti della «Metropolitana
milanese» (forse il più importante del filone meneghino di Tangentopoli) per
corruzione e illecito finanziamento ai partiti, davanti alla Corte di Appello di
Milano il 24 luglio 1998. Lo ha stabilito la Cassazione. I supremi giudici,
infatti, hanno respinto il ricorso con il quale la figlia di Craxi - difesa da
Giancarlo Zoppini e Giuseppe Russo Corvace, dello studio Virtax - ha provato ad
evitare la condanna al pagamento di questa somma. Ingente assai dato che la
quantificazione è rapportata al valore della causa nella quale l’ex segretario
del Psi era stato condannato a risarcire la metropolitana con dieci miliardi di
vecchie lire per i danni provocati dalle sue malversazioni. Senza successo,
Stefania Craxi ha sostenuto nel ricorso alla Suprema Corte di aver accettato
l’eredità paterna con beneficio d’inventario, atto che consente di «fare
confusione» tra patrimoni ricevuti in eredità in caso di debiti .E dunque di
potersi esimere - nel caso di Stefania e Bettino - dall’assumere l’onere di
adempiere a questo debito erariale maturato dal padre per via della sua pendenza
giudiziaria penale. Tale circostanza è però rimasta sguarnita di prova, secondo
i giudici della Commissione tributaria di Milano. Gli «ermellini» le hanno
spiegato che ormai è troppo tardi per far valere l’eventuale beneficio di
inventario, dal momento che la circostanza dell’accettazione condizionata
dell’eredità doveva essere fatta presente impugnando a suo tempo l’avviso di
liquidazione dell’imposta di registro. «Nel caso di specie - rilevano i supremi
giudici - non è stato impugnato il titolo (l’avviso di pagamento) a mezzo del
quale era stata fatta valere illimitatamente dall’erario, nei riguardi
dell’erede, la pretesa obbligatoria concernente il debito tributario del defunto
Bettino Craxi». «Dunque - conclude il verdetto della sentenza 23061 della
Sezione tributaria della Cassazione - l’erede non poteva più eccepire, in sede
di riscossione, né potrà farlo nell’eventuale sede di esecuzione, la ridotta
responsabilità derivante dall’accettazione con beneficio di inventario».
Lo Stato perseguita Craxi: la figlia paghi 700mila euro.
La Cassazione boccia il ricorso contro una cartella
esattoriale legata all'imposta di registro per una condanna risalente al 1998.
L'ira di Stefania: "È una vergogna", scrive Anna Maria Greco Giovedì 12/11/2015
su “Il Giornale”. Le colpe dei padri ricadono sui figli. Almeno se ti chiami
Craxi. Ora Stefania deve pagare al fisco ben 676 mila euro di imposta di
registro, dovuti per la condanna del 1998 a 4 anni e 6 mesi di reclusione di suo
padre Bettino, nel processo per le tangenti della Metropolitana milanese, per
corruzione e illecito finanziamento ai partiti.La Cassazione, infatti, non fa
sconti. La sezione Tributaria di piazza Cavour ha infatti bocciato il ricorso
della figlia del leader socialista che rivendicava la «prescrizione del diritto
azionato» e, soprattutto, affermava di aver accettato l'eredità paterna con
«beneficio d'inventario».Ma le sue ragioni, sostenute dai legali Giancarlo
Zoppini e Giuseppe Russo Corvace, sono state respinte dai Supremi giudici.
Stefania dovrà dunque pagare questa grossa somma, la cui quantificazione è
rapportata al valore della causa nella quale l'ex segretario del Psi era stato
condannato a risarcire la metropolitana con dieci miliardi di vecchie lire, per
i danni provocati dalle sue malversazioni.L'interessata è semplicemente furiosa:
«Questo Stato - dice Stefania Craxi al Giornale - si deve vergognare. Mio padre
è stato condannato in processi senza prove, lui che ha reso l'Italia grande nel
mondo e ha migliorato la vita di tutti i cittadini. Ora è incredibile che si
chieda a me, che mi sono sempre guadagnata ogni cosa nella mia vita, di pagare
una somma del genere. È l'ennesima vergogna di questo Stato e della sua
magistratura»Per la Cassazione, ormai è troppo tardi perché la figlia di Bettino
faccia valere la sua «ridotta responsabilità», per esimersi dal far fronte al
debito erariale maturato dal padre in seguito alla sua pendenza giudiziaria
penale.L'eventuale beneficio d' inventario (di cui, per i giudici, non ci
sarebbe prova), cioè l'accettazione condizionata dell'eredità, doveva essere
fatta presente impugnando a suo tempo l'avviso di liquidazione dell'imposta di
registro. Dopo, non è più possibile esimersi dal pagamento. La Craxi contesta
decisamente questo aspetto. «Non è vero, io ho accettato l'eredità con beneficio
d'inventario. Ho parlato con il mio avvocato e anche lui è caduto dal pero per
questa sentenza. Non capisce, come non capisco io. Domani leggeremo la sentenza,
che ancora non abbiamo».Per la Cassazione, invece, tutta la procedura è stata
regolare, perché per la somma «infruttuosamente richiesta», l'invito di
pagamento «era stato notificato in base alla sentenza il 5 marzo 2005 sicché la
cartella pacificamente notificata il 15 aprile 2006 era tempestiva».La figlia
del leader socialista aveva impugnato davanti alla Commissione provinciale di
Milano la cartella di pagamento per l'iscrizione a ruolo di 676.717 euro per il
recupero dell'imposta di registro, prenotata a debito, dovuta in riferimento
alla sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Milano il
24 luglio 1998 nei confronti di Bettino Craxi.La Suprema Corte, bocciando il
ricorso, ha ricordato che nel caso in questione «non è stato impugnato il titolo
a mezzo del quale era stata fatta valere illimitatamente dall'erario, nei
riguardi dell'erede, la pretesa obbligatoria» relativa al debito tributario di
Bettino Craxi.E i Supremi giudici hanno contestato l'aspetto della prescrizione,
perché per il calcolo dei tempi, in caso di procedimento di riscossione del
tributo di registro relativo alle imposte prenotate a debito su atti giudiziari,
è applicabile il termine decennale di prescrizione e non quello cui faceva
riferimento la difesa della figlia di Bettino.Quindi, come erede di suo padre,
Stefania dovrà far fronte al suo debito tributario. Il verdetto della sentenza
23061 della Sezione tributaria della Cassazione non lascia spazio a dubbi.
Tutti i segreti di Tonino Di Pietro: "Vi dico il mio rimpianto
più grande", scrive Luca Telese su “Libero Quotidiano”
l’11 novembre 2015.
Pronto Tonino?
«Ciao Luca! Scusami: è un brutto momento con il trattorino, puoi richiamare? Tra
poco, dammi un secondo». (Click)
Pronto Tonino?
«Oh, buongiorno! Gesù, che ora è? Ti sembrerà assurdo, ma adesso c' è un
problema serio con la scuotitrice». (Click)
Pronto, Tonino? Ti ricordi quell' intervista, per Libero?
«Oh si! Ma dobbiamo fare sabato! Adesso sto al frantoio».
Ma torni a Roma?
«Stai scherzando? E lascio tutto qui, a marcire sulle piante? Mi sa che ti tocca
proprio venire a Montenero, ah ah ah ah! Ci sentiamo sabato, ore 14.30 Sii
puntuale!».
Pronto, Tonino: indovina?
Sono le 14.30 e… «Oh scusami, stavolta: l'ora è giusta ma sono sbagliato io».
In che senso?
«È che stavo tendendo la rete, quando dal tronco di un albero è scappato fuori
uno sciame di calabroni. Mi hanno punto proprio sotto l' occhio. Sto qui al
pronto soccorso».
Le interviste a volte sono così. Cerchi qualcuno e finisci per infilarti in un
frammento della sua vita. Cercavo Antonio Di Pietro perché ci eravamo fatti l'
idea che la cosa più interessante, in questo momento di scandali e di inchieste
era tornare al Di Pietro magistrato, al giustizialista degli esordi. Chiedergli
quello che ha da dire oggi su Mafia capitale, Expo, sul suo ex segretario
regionale dell' Italia dei Valori, Vincenzo Maruccio, indagato per rapporti con
la 'ndrangheta nell' inchiesta Hydra. Sull' ipotesi ricicciata più volte di una
sua candidatura a Milano. Lo cerchi e scopri che Tonino sta proprio da un' altra
parte. Ha indossato un' altra vita, ti dice con tono tra l' ironico e il
disincantato che potrebbe fare simpatia persino al suo grande nemico, Filippo
Facci: «Senti, io adesso per la politica sono un ex. La seguo come un guardone
che punta le coppiette».Di Pietro in questo momento sta qui. Dice tutto quello
che passa per la testa, abbiamo deciso di pubblicare l' intervista comunque.
Uno pensa Di Pietro e pensa il magistrato…
«Errore: sono un dimissionario e pensionato».
Uno pensa Di Pietro e immagina il leader di partito…«Quale
partito?» Come quale? L' Italia dei valori, il tuo. L'hai fondata tu.
«Non ho più nulla a che vedere».
Addirittura.
«Si, ma con il massimo del rispetto, senza un filo di pensieri o rancore. Io sto
a Montenero di Bisaccia a raccogliere le olive, loro a Roma. So che vogliono
entrare nella maggioranza di Renzi».
E non ti convince?
«Mhhhfffg….». Cosa? «Diciamo così. Rispetto ai miei valori è follia. Rispetto
alla logica di chi fa politica per la politica può avere senso».
Sei acidino, adesso.
«No, giuro, non mi importa proprio nulla, sto lontano mille miglia. Facciano
quello che vogliono, io non c' entro più».
E il tuo erede, Messina?
«Tanto buono e caro, poverino. Ma sono altrove».
Perché?
«Hanno ucciso il padre, hanno de-dipietrizzato. Io gli ho lasciato un gruzzolo
da 11 milioni. Loro se lo amministrano belli belli, è giusto così. Hanno, come
si dice? Ucciso il padre, ecco».
Dici Di Pietro e pensi il dipietrese.
«Vedi? Quasi non lo parlo più».
Dici Di Pietro e pensi all'avvocato.
«Ecco: quello ancora lo faccio, teoricamente».
Come teoricamente?
«Ho lo studio, sono un penalista. Ma per ora ho pochi clienti, e quasi tutti
squattrinati».
Non ci credo. Chi non si farebbe difendere dal campione dei
tribunali?
«Effettivamente in Aula ho fatto tutto, dal piemme all'imputato. E poi giudice
civile, testimone, l'indagato, il querelante… Non mi manca nulla».
E quindi?
«Vedi, è proprio quello. Il problema? In linea di massimo ho due tipo di
aspiranti clienti che vengono a bussare alla mia porta».
Quali?
«O il grande personaggio, quello con tanti soldi e grandi problemi che la sera
lo vedi inguaiato nei titoli dei tiggì ... Oppure il caso disperato, quello con
il processo già compromesso in Cassazione».
E perché?
«Gli hanno detto: a te ti salva solo Tonino o Lourdes. E lui ha scelto la prima
che hai detto. Hai capito la morale?».
Non ancora.
«O zozzoni o poveri cristi».
Beh, sono clienti: cosa volevi, tutti santi?
«Insomma. È che non me la sento di tradire la mia storia, di andare a fare la
balia di un Quattrocentosedici-bis…». Proviamoci. Tu entri con il signor
quattrocentosedici-bis, la toga in spalla… «Vedi? Non riesco a immaginarmi con
un boss di mafia a fare l' arringa: è innocente, vostro onore, innocente! Ve lo
dice Di Pietro».
Dovresti difendere tutti per deontologia, lo sai.
«Sto dicendo che conosco le regole, ma il problema è mio. Eppure come vorrei
buttarmi in un processo, trovare uno disperato che vale la pena di salvare. Per
questo ascolto tutti, valuto».
E in attesa del principe azzurro?
«Patrocini gratuiti, la mia passione».
Adesso, per esempio?
«Mi sto divertendo con due poveracci che c'hanno sul collo due cartelle
esattoriali ammazzacristi».
Il grande Di Pietro e la cartella esattoriale.
«Non sfottere. Perché il bello deve ancora venire: c' ho una cartellina con un
paio di tartassati di multe, e infrazioni varie».
Ma allora, se penso Di Pietro, che devo raccontare ai nostri
lettori?
«Coltivatore diretto».
Maddaì!
«È quello che faccio ogni giorno. Quando maturano a novembre, devi macinare il
più presto possibile, sennò arriva la mosca».
Hai tante piante?
«Ce n'ho qualche migliaio».
Mica male…Rendono? «Un quintale, tredici litri» E prima delle
olive?
«Raccolta dell' uva».
Sei biologico?
«Ehhhh… certo. Potato, arato, concime organico».
E l' uva?
«Pure. Ecche mi metto a infilare le medicine per due quintali in più di
raccolto?».
Ci guadagni?
«Ecco il problema. Mentre stiamo parlando il frantoio l' olio me lo paga sei
euro, ma solo se gli spari in fronte».
Ci rientri?
«Scherzi? A me costa 30 euro il litro. C' ho tre pakistani e tre italiani:
contratto di bracciante agricolo. Possono fare i vaucher solo pensionati e
studenti».
Quanto ti costa?
«Sono 48,6 euro al giorno. E 70 euro di costo aziendale».
Però incassi.
«Per i due quintali che ho qui sono 1200 euro. Mi spieghi come cazzo si fa?».
Sei tu il coldiretto.
«È che questo contadino non esiste più. C'ho amici che l'olio se lo vendono all'
estero, ed è una strada. Oppure vai a finire in una grande macchina, pendono la
tua roba, lo tagliano con la polvere di topo, ed ecco l' olio che ti bevi tu».
Ma tu che ci fai con 35 quintali di olio?
«Venti li vendo, cinque li regalo. Se questa intervista mia piace, e lo escludo,
ti becchi due litri pure tu.... Ma lo faccio soprattutto come realizzazione di
me stesso».
Vediamo la tabella mi marcia.
«Mi sveglio alle 5.30 della mattina. Carico i braccianti con il pulmino».
Ma ci vai tu?
«Come diceva mio nonno: il contadino sa sempre stare un metro avanti».
Riecco il dipietrese.
«Ti sei giocato i due litri».
Lavorate fino al buio?
«Alle 16.30 metto a posto gli attrezzi, alle 17.30 vado col carico al frantoio».
E i contatti con D' Alema, Renzi, Vendola…?
«Quelli li sente Belpietro al telefono più di me».
Fatica?
«Sì, ma guardala così. Prima prendevo i farmaci per lo stress, non dormivo,
crisi epilettiche tachicardia. E ora? Dormo come un angioletto».
Ma perdi tutti questi soldi per ammazzarti di lavoro?
«Domanda a Renzi. Se ti mando l' olio a Natale. Mi dovrei fare autofattura?».
Programmi per stasera?
«Maria, la mia vicina mi ha portato le bietole. Domani si spenna il pollo. Mo'
lascio te e vado a prendere l' olio fatto al frantoio».
Ma la politica per cui ti stavi prendendo il coccolone?
«La mattina non posso leggere i giornali. Vado al computer dopo cena, guardo le
mail, scrivo. Alle 23 sono già a letto».
Ah, ti piace….
«Lo dico sinceramente? La politica si è fatta oscena».
Eri disposto a candidarti a Milano, però.
«Sì, ma tra il dire e il fare c' è di mezzo il mare. Come li metti in pista 400
candidati?».
Però ti sarebbe piaciuto.
«Tanto. Il giorno stesso il Pd ha detto con lui mai, i Grillini hanno già fatto
un loro statuto e li rispetto, ed ecco perché sto qui a Montenero».
Non ti è rimasto nulla?
«Lo dici tu. C' è stata una bellissima stagione, quella dei referendum. E poi
un' altra molto bella, quella della foto di Vasto. La rivendico
orgogliosamente».
Hai perso.
«Perché c' è stato l' atto anticostituzionale di fare il governo Monti,
altrimenti noi staremmo al posto di Grillo. Sono bivi».
O ti ha ammazzato la Gabanelli?
«Ho una causa in corso, posso dirti questo: con quale intenzione l'abbia fatto
non lo so. Ma so che la gente ha percepito una realtà distorta».
Quindi non hai fatto errori?
«Eccome: mi sono messo con Ingroia, Occhetto... Ferrero. Pensavo: l'unione non
fa la forza. È stato devastante».
Sempre la querela facile?
«La Santanché è stata condannata a 20 mila euro. Però da quando sono in campagna
ho sospeso le cause…». E la scorta? «Prima che la togliessero ho rinunciato. Per
me, che l'ho avuta tanti anni è stata una liberazione. E poi che ci facevo, li
mettevo a fare vendemmia?».
Adesso mi dirai che non hai letto di Maruccio.
«Invece seguo tutto: voglio sapere esattamente che cosa è successo».
Lo difendi?
«Era un bravo ragazzo: se ce n' era un altro lo vedrò. Apprezzo che si affidi
alla giustizia e non la contesta».
E Mannino?
«Lo hanno assolto per non aver commesso il fatto. Ci credo punto».
Però sotto sotto….
«No. Si è fatto venti anni di processo: massimo rispetto. A lui e al giudice.
Non condivido che lui attacchi i magistrati, e, peggio ancora, che qualcuno si
infili in questa cosa per fare campagne».
Ti piacerebbe tornare in aula con questi processi?
«Rimpiango di essermene andato, sì: mi piacerebbe essere in campo».
Adesso sei proprio crepuscolare.
«Non illudetevi che io scompaia, è una stagione interlocutoria. Ci si vede dopo
la semina».
Di nuovo dipietrese.
«Lù, a Milano aspettano il tuo pezzo: Corri a scrivere e lasciami in pace!».
Luca Telese
Una cosa è
certa, però. Per i poveri cristi vale “Colpevole fino a prova contraria”. Per
gli intoccabili vale "Innocente fino a prova contraria o fino all’archiviazione
o alla prescrizione".
Nel
"palazzo dello scandalo". Un giorno con i giudici indagati,
scrive Riccardo Lo Verso Mercoledì 23 Settembre 2015 su “Live Sicilia”. Da
Silvana Saguto a Tommaso Virga, passando per Lorenzo Chiaromonte e Dario
Scaletta. Alcuni hanno cambiato incarico, altri hanno rinunciato a parte dei
loro compiti, ma è negli uffici giudiziari palermitani che attenderanno il
giudizio del Csm sulla loro eventuale incompatibilità ambientale. Tommaso Virga
è nella sua stanza al primo piano del nuovo Palazzo di giustizia di Palermo. Due
rampe di scale lo separano dalla sezione Misure di prevenzione finita sotto
inchiesta. Siede alla scrivania dopo avere appeso la toga e tolto la pettorina,
il bavaglino bianco che un regio decreto del 1865 impone di indossare ai giudici
in udienza. Questioni di forma e decoro. Virga parla con i cancellieri e prepara
il calendario delle udienze della quarta sezione penale. Fa tutto ciò che deve
fare un presidente che si è appena insediato. Archiviata l'esperienza di
consigliere togato al Consiglio superiore della magistratura aspettava che si
liberasse una sezione a Palermo. Un incrocio, quanto meno insolito, ha fatto sì
che andasse a prendere il posto di Mario Fontana, chiamato a sostituire Silvana
Saguto, l'ex presidente delle Misure di prevenzione travolta dall'indagine in
cui è coinvolto lo stesso Virga. Che si mostra disponibile con il cronista che
bussa alla sua porta. “Nel rispetto del ruolo che ricopro non ho mai fatto
dichiarazioni”, dice il presidente chiarendo subito la sua intenzione di non
cambiare idea proprio adesso. Inutile chiedergli dell'indagine che lo coinvolge,
della credibilità della magistratura che vacilla, della perplessità legittima di
chi si chiede se questa storia possa intaccare la serenità necessaria per chi
deve amministrare la giustizia al di là di ogni ragionevole dubbio,
dell'opportunità di continuare a fare il giudice a Palermo. Perché tutti i
magistrati coinvolti nell'indagine sono e resteranno a Palermo. Alcuni hanno
cambiato incarico, altri hanno rinunciato a parte dei loro compiti, ma è negli
uffici giudiziari palermitani, nei luoghi dello scandalo, che attenderanno il
giudizio del Csm sulla loro eventuale incompatibilità ambientale. Virga è tanto
garbato quanto ermetico. Si limita a fare registrare un dato incontrovertibile:
“Sono al mio posto, a lavorare”. I suoi gesti e il tono della voce sembrano
rispondere alla domanda sulla serenità. Qualcuno degli addetti alla cancelleria
si spinge oltre le impressioni con una frase asciutta: “L'autorevolezza del
presidente Virga è fuori discussione”. Già, l'autorevolezza, al centro delle
discussioni che impegnano gli addetti ai lavori nell'apparente normalità di una
mattinata al Palazzo di giustizia. Apparente perché è profondo il solco
tracciato dalla domanda che anima ogni capannello che si forma nei corridoi o
davanti alle aule: può essere credibile una magistratura segnata da un'indagine,
fastidiosa oltre che grave visti i reati ipotizzati? Nello scandalo dei beni
confiscati sono coinvolti quattro magistrati. Uno è Tommaso Virga, gli altri
sono Silvana Saguto e Lorenzo Chiaramonte (vecchi componenti della sezione
Misure di prevenzione, azzerata con l'arrivo di Fontana) e il pubblico ministero
Dario Scaletta. Hanno ruoli diversi nella vicenda. Per tutti vale il principio
della presunzione di non colpevolezza su cui si basa il nostro stato di diritto.
La Saguto sarebbe il vertice del presunto sistema affaristico - i pubblici
ministeri di Caltanissetta ipotizzano i reati di corruzione, induzione alla
concussione e abuso d'ufficio - creato attorno alla gestione dei beni
sequestrati e confiscati alla mafia. Un sistema che avrebbe finito per favorire
alcuni amministratori giudiziari piuttosto di altri. Fra i “favoriti” ci
sarebbero Gaetano Cappellano Seminara, il principe degli amministratori, e il
giovane Walter Virga, figlio del Tommaso di cui sopra. A detta dei pm nisseni,
il primo sarebbe stato nominato in cambio di consulenze assegnate al marito
della Saguto e il secondo per "ringraziare" Virga padre che, quando era
consigliere del Csm, avrebbe calmato le acque che si agitavano sull'operato
della Saguto. Un aiuto smentito nei giorni scorsi da Virga, tramite il suo
legale, l'avvocato Enrico Sorgi: “Durante il proprio mandato al Csm non
risultano essere stati avviati procedimenti disciplinari a carico della Saguto.
I fatti che formano oggetto della notizia diffusa sono del tutto privi di
potenziale fondamento”. Chiaramonte, invece, è indagato per abuso d'ufficio
perché non si sarebbe astenuto quando ha firmato l'incarico di amministratrice
giudiziaria a una persona di sua conoscenza. Infine c'è Dario Scaletta, pm della
Direzione distrettuale antimafia e rappresentante dell'accusa nei processi in
fase di misure di prevenzione. Scaletta avrebbe fatto sapere alla Saguto che era
stata trasferita da Palermo a Caltanissetta l'inchiesta su Walter Virga e cioè
il fascicolo da cui è partito il terremoto giudiziario. Il pubblico ministero ha
chiesto di non occuparsi più di indagini su Cosa nostra e di misure di
prevenzione. Tutti i magistrati, coinvolti nell'indagine a vario titolo e con
profili diversi, restano a Palermo. Silvana Saguto, appena avrà recuperato da un
infortunio fisico, andrà a presiedere la terza sezione della Corte d'assise.
Chiaramonte, ultimate le ferie, prenderà servizio all'ufficio del Giudice per le
indagini preliminari. Sarà il Csm a decidere se e quando trasferirli. Sul caso è
stato aperto un fascicolo, di cui si occuperà la Prima Commissione, competente
sui trasferimenti per incompatibilità ambientale e funzionale dei giudici. Il
Consiglio superiore della magistratura per tradizione non spicca in velocità. In
una giustizia spesso lumaca non fa eccezione il procedimento davanti
all'organismo di autogoverno della magistratura che somiglia molto, nel suo
svolgimento, ad un processo ordinario. A meno che non venga preso un
provvedimento cautelare urgente ci vorrà tempo prima di conoscere il destino dei
magistrati, forse più di quanto ne servirà ai pubblici ministeri di
Caltanissetta per chiudere le indagini o agli stessi indagati per chiarire la
loro posizione. Il “forse” è dovuto al fatto che le indagini affidate ai
finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Palermo sembrano essere appena
all'inizio e i pm non hanno alcuna intenzione, al momento, di sentire i
magistrati che avevano chiesto di essere interrogati. Oggi, però, son arrivate
le parole del vicepresidente del Csm Giovanni Legnini durante il plenum. "Oggi
parlerò con il presidente della Repubblica", ha detto ribadendo la volontà di
"procedere con la massima tempestività e rigore".
ONESTA’ E
DISONESTA’
1. Era una
donna virtuosa, ma il caso volle che sposasse un cornuto. (Sacha Guitry)
2. L'amore ha
diritto di essere disonesto e bugiardo. Se è' sincero. (Marcello Marchesi)
3. Proposta:
"Facciamo il governo degli onesti!". "Già, e il pluralismo?". (Manetta)
4. Il
socialista più elegante? Martelli. Il più grasso? Craxi. Il più onesto? Manca!
5. Due manager
discutono di come scegliere la segretaria e uno dei due dice di avere un metodo
speciale tutto suo: "Io la ricevo in ufficio e le faccio trovare per terra un
biglietto da 100.000 lire; poi con una scusa mi allontano e osservo quello che
succede. La loro reazione è molto istruttiva". Dopo qualche tempo
si reincontrano e il primo chiede: "Allora, amico mio, come è andata la scelta
della segretaria?". "Ho fatto come mi hai detto: la prima ha raccolto il
biglietto e l'ha messo velocemente nella sua borsetta. La seconda l'ha raccolto
e me lo ha consegnato. La terza ha fatto come se niente fosse". "E quale hai
scelto?". "Quella con le tette più grosse!".
6.
La disumanità del computer sta nel fatto che, una volta programmato e messo in
funzione, si comporta in maniera perfettamente onesta (Isaac Asimov).
7. Convinto
dalla tangente, il cerchio accettò di trasformarsi in quadrato. L'angolo invece
rifiutò: era sempre stato retto e tale voleva restare.
8. Come ci
sono oratori balbuzienti, umoristi tristi, parrucchieri calvi, potrebbero
esistere benissimo anche politici onesti. (Dario Fo)
9. A volte è
difficile fare la scelta giusta perché o sei roso dai morsi della coscienza o da
quelli della fame. (Totò in "La banda degli onesti")
10. C'è un
modo per scoprire se un uomo è onesto: chiedeteglielo. Se risponde di sì, è
marcio. (Groucho Marx)
11. Se la
canaglia impera, la patria degli onesti è la galera (proverbio italiano)
12.
L'onestà paga. La disonestà è pagata. (Silvia Ziche)
13.
Definizione di corrotto: vezzeggiativo politico. (S. M. Tafani)
14. Il segreto
della vita è l'onestà e il comportarsi giustamente. Se potete simulare ciò lo
avete raggiunto. (Groucho Marx)
15. Niente
assomiglia tanto a una donna onesta quanto una donna disonesta di cui ignori le
colpe.
16. Se
l'esperienza insegna qualcosa, ci insegna questo: che un buon politico, in
democrazia, è tanto impensabile quanto un ladro onesto. (H.L Mencken)
17. Nel dolore
un orbo è avvantaggiato, piange con un occhio solo. (Antonio (Totò) in "La banda
degli onesti")
18. L'onestà
è la chiave di una relazione sentimentale. Se riuscite a far credere di essere
onesti, siete a cavallo. (Richard Jeni)
19. L'onestà
è lodata da tutti, ma muore di freddo. (Giovenale)
20. "Jim, dove
posso trovare dieci uomini onesti?". "Cosa? Diogene si sarebbe contentato di
trovarne uno". (Robert A. Heinlein, Cittadino della galassia)
21. A molti
non mancano che i denari per essere onesti. (Carlo Dossi)
22. Le donne
oneste non riescono a consolarsi degli errori che non hanno
commesso. (SachaGuitry)
23. Un
politico onesto è quello che una volta "comprato" resta comprato. (Legge di
Simon Cameron)
24. Le persone
oneste e intelligenti difficilmente fanno una rivoluzione, perché sono sempre in
minoranza. (Aristotele)
25. "Signora -
dice la nuova cameriera - in camera sua, sotto il letto, ho trovato questo
anello!". "Grazie Rosi. L'avevo messo apposta per controllare la sua onestà".
"E' proprio quello che ho pensato anch'io, signora!".
26. Ero
veramente un uomo troppo onesto per vivere ed essere un politico. (Socrate)
27. Un governo
d'onesti è come un bordello di vergini. (Roberto Gervaso)
28. Si dice:
"La disonestà dei politici non paga mai!". E' vero. Generalmente riscuote.
29. Sei onesta
come le mosche d'estate, al mattatoio, che rinascono dalla loro stessa merda.
(dall'Otello) (William Shakespeare)
30. A volte mi
viene il sospetto che avere la fama di essere scrupolosamente onesto equivalga a
un marchio di idiozia. (Isaac Asimov)
31. In tutta
onestà, non credo nell'onestà.
32. Un uomo
onesto può essere innamorato come un pazzo, ma non come uno sciocco.
(François de La Rochefoucauld) 33. Ammetto di essere onesto. Ma se si sparge la
voce, sono rovinato: nessuno si fiderà più di me. (Pino Caruso)
34. Donne
oneste ce ne sono più di quelle che non si crede, ma meno di quelle che si dice.
(Alessandro Dumas figlio) (in "L'amico delle donne")
35. La
principale difficoltà con le donne oneste non è sedurle, è portarle in un luogo
chiuso. La loro virtù è fatta di porte semiaperte. (Jean Giraudoux)
36. Una volta
l'onestà, in un individuo, era il minimo che gli si richiedesse. Oggi è un
optional. (Maurizio Costanzo)
37. Le anime
belle, le figurine del presepe, le persone oneste... Ne ho conosciute tante,
erano tutte come te. Facevano le tue domande, e con voi il mondo diventa più
fantasioso, più colorato... Ma non cambia mai !! (Il ministro Nanni Moretti a
Silvio Orlando in "Il portaborse")
38. Non è grave il clamore chiassoso dei violenti, bensì il silenzio spaventoso
delle persone oneste. (Martin Luther King)
39. Era così onesto che quando trovò un lavoro, lo restituì.
40. Mi piace
un soprabito scoperto dagli americani, il koccomero, quello che si aggancia con
i calamari. (Totò in "La banda degli onesti")
41. Il
tipografo Lo Turco ammira tutto l'armamentario per fabbricare banconote false:
"Ma questa è filagrana!". Toto': "Sfido io! Viene dal policlinico dello
Stato!". (In "La banda degli onesti")
42. L'onestà
nella compilazione della dichiarazione dei redditi viene considerata in Italia
una forma blanda di demenza. (Dino Barluzzi)
43. Non
abbiamo bisogno di chissà quali grandi cose o chissà quali grandi uomini.
Abbiamo solo bisogno di più gente onesta. (Benedetto Croce)
44. Ci sono
fortune che gridano "imbecille" all'uomo onesto. (Edmond e
Jules de Goncourt)
45. L'onestà
dovrebbe essere la via migliore, ma è importante ricordare che, a rigor di
logica, per eliminazione la disonestà è la seconda scelta. (George Carlin)
46. In Italia
si ruba con onestà, rispettando le percentuali. (Antonio Amurri)
47. I nordici
prendono il caffè lungo, noi sudici lo prendiamo corto. (Totò in "La banda degli
onesti")
48. Ben poche
sono le donne oneste che non siano stanche di questo ruolo. (FriedrichNietzsche)
49. L'onestà è
un lusso che i ricchi non possono permettersi. (Pierre de Coubertin)
50. Neanche la
disonestà può offuscare la brillantezza dell’oro.
51. Ti ho
insegnato ad essere onesto, perché intelligente non sei. (Bertold Brecht)
52. L'onestà paga, ma pare non abbastanza per certe persone. (F. M. Hubbard)
53. Nessuna
persona onesta si è mai arricchita in breve tempo. (Menandro)
54. Nessuno può guadagnare un milione di dollari onestamente. (No one can earn a million
dollars honestly).
(William
Jennings Bryan)
55. Sicuramente ci sono persone disoneste nei governi locali. Ma è anche vero
che ci sono persone disoneste anche nel governo nazionale. (Richard Nixon)
56. Le persone
oneste si riconoscono dal fatto che compiono le cattive azioni con più
goffaggine. (Charles Péguy)
57. L'onestà,
come tante altre virtù, dipende dalle circostanze. (Roberto Gervaso)
58. Nessun
uomo può guadagnare un milione di dollari onestamente, così come è disonesto ed
invidioso chi dichiara il contrario. (Antonio Giangrande)
59. Colmo per
un uomo retto: innamorarsi di una donna tutta curve.
60. Una
politica onesta proietta una nazione sana nel futuro. Per questo si chiama
Fantascienza. (Mauroemme)
61. Per il
mercante anche l'onestà è una speculazione. (Charles Baudelaire)
62. In
politica l'onestà è forse la cosa più importante. Chi ce l'ha deve partire con
un grosso handicap! (Bilbo Baggins)
63. Dimettersi
per una multa è soprattutto un ennesimo esempio della severità del rapporto tra
etica e politica in Gran Bretagna. Tranquilli, ci pensiamo noi qua a ristabilire
l'equilibrio europeo. (Annalisa Vecchiarelli)
64. La massima
ambizione dell'uomo? Diventare ricco. Come? In modo disonesto, se è possibile;
se non è possibile, in modo onesto. (Mark Twain)
65. Era un
uomo così onesto e probo, da non essere neanche capace d'ingannare il tempo...
(Fabio Carapezza)
66. Se
l'esperienza ci insegna qualcosa, ci insegna questo: che un buon politico, in
democrazia, è tanto impensabile quanto un ladro onesto.
67. La
disperazione più grave che possa colpire una società e' il dubbio che vivere
onestamente sia inutile. (Corrado Alvaro)
68. In
un'epistola Orazio fustiga un doppiogiochista della morale che, ammirato da
tutto il popolo, offre un bue e un porco agli dei, pregando Giove e Apollo ad
alta voce. Ma subito dopo si rivolge a LAVERNA, dea protettrice dei ladri e a
fior di labbra, in modo che nessun lo intenda, prega: "Laverna bella, fammi la
grazia ch'io possa imbrogliar il prossimo, concedi ch'io passi per un
galantuomo, un santo, e sopra i miei peccati distendi la notte, sopra gli
imbrogli una nube". (Orazio)
69. Ingiuriare
i mascalzoni con la Satira è cosa nobile, a ben vedere significa onorare gli
onesti. (Aristofane)
70. L'onestà andrà di moda. (Beppe Grillo)
71. L'onestà
è sempre la migliore scelta... ma spesso bisogna seguire la seconda scelta.
72. Odiare i
mascalzoni è cosa nobile. (Quintiliano)
73. Uomini
onesti si lasciano corrompere in un solo caso: ogniqualvolta si presenti
l'occasione. (Gian Carlo Moglia)
74. Maresciallo: "...hanno arrestato anche il tipografo". Totò: "Lo Turco!!".
Maresciallo: "No, lo svizzero". Totò: "Allora mi ha dato un nome falso!!"
(Totò in "La banda degli onesti")
75. Portieri
si nasce, non si diventa. (Totò in "La banda degli onesti")
76. Perchè
anch'io, modestamente, nella media borghesia italiana occupo una società...
condomini che vanno e che vengono, che quando è natale, pasqua mi danno la
mancia, per il mio nome mi regalano lumini..." (Totò ne "La banda degli onesti")
77. Ho mandato
mia moglie e i miei figli a un funerale, così si divagano un po'. (Totò' ne "La
banda degli onesti")
78. Tanto
Gentile il segretario pare se si dimette
e la poltrona
sua saluta
e ogni lingua
de li colleghi trema muta
che
altrimenti vorrebber commentare.
Egli si va,
sentendosi laudare,
per la
rinuncia d’umiltà vestuta,
e par quasi
fosse cosa non dovuta
ma invece
scelta per obbligo morale.
Che
il popolino l’onestà l’ammira,
e dà agli
illusi una dolcezza al core,
chi se ne va
senza aspettar altre prove.
Ma i peggiori
non v’è modo li si muova,
né per decenza
oppur spinti dall’onore,
che sol per la
poltrona l’anima lor sospira. (Bilbo Baggins)
79. L'onestà non paga. Se vuoi fare l'onesto lo devi fare gratis. (Pino Caruso)
80. Ricòrdati che l'onestà paga sempre! Specialmente le tasse! (Renato R.)
81. La madre
dei cretini è sempre incinta. Quella degli onesti ormai è in menopausa.
82. L'onestà è un lusso che i ricchi non possono permettersi. (Pierre
de Coubertin)
83. Sto
cercando di fare di mio figlio un italiano onesto, leale, corretto, solidale,
amante della giustizia... "Un disadattato, insomma". (Stefano Mazzurana)
84. Io sono
onesto. Contro chi devo scagliare la prima pietra? (Renato R.)
85. Nigeriano
disoccupato trova 4.350 euro e li restituisce. Bisogna dire basta a questi gesti
inappropriati, se vengono nel nostro paese devono rispettare le nostre regole.
Che sono venuti qua ad insegnarci l'onestà? (Barbara Zappacosta)
86. Viviamo
tempi in cui se dici "onesto!" a qualcuno, rischi d'offenderlo... (Alessandro
Maso)
87. Sono una
persona molto onesta e corretta. Mi sento un verme anche quando, ad un incontro,
inganno l'attesa. (DrZap)
88. Secondo un
emendamento del decreto milleproroghe, il M5S verrà multato per aver rifiutato i
rimborsi elettorali. Sancendo la nascita di un nuovo reato: ONESTARE.
(Kotiomkin) (Giovy Novaro)
Di Pietro, Grillo, il Movimento 5 Stelle e gli “utili idioti
giustizialisti”.
L’Opinione del dr. Antonio Giangrande. Scrittore, sociologo storico, blogger,
youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie.
Le incalzanti notizie di cronaca giudiziaria provocano reazioni variegate tra i
cittadini della nostra penisola. Sgomento, sorpresa, sdegno, compassione o
incredulità si alternano nei discorsi tra i cittadini. Ma emerge, troppo spesso,
una ipocrisia di fondo che è la stessa che attraversa, troppo spesso, la nostra
società. Ma… chi è onesto al cento per cento? Credo nessuno, nemmeno il Papa.
Chi non ha fatto fare qualche lavoretto in nero? Chi ha fatturato ogni lavoro
eseguito? Chi ha sempre pagato l’iva? Chi ha dichiarato l’esatta metratura dei
propri locali, per evitare di pagare più tasse sulla spazzatura? Chi lavora per
raccomandazione o ha vinto un concorso truccato? Chi è un falso invalido o un
baby pensionato? Chi per una volta non ha marinato l’impiego pubblico? Ecc.. Chi
è senza peccato scagli la prima pietra! Naturalmente, quando non paghiamo
qualche tassa, ci giustifichiamo in nome della nostra “onestà” presunta, oppure
del fatto che fan tutti così: “Io non sono un coglione”! E così via…
Ecco allora che mi sgranano gli occhi all'ultimo saluto a Casaleggio il 14
aprile 2016. La folla grida “Onestà, onestà, onestà”, frase di sinistroide e
giustizialistoide natali. "Onestà, onestà". Questo lo slogano urlato a più
riprese dai militanti del M5S alla fine dei funerali del cofondatore Roberto
Casaleggio a Milano. Applausi scroscianti non solo al feretro, ma anche ai
parlamentari presenti a Santa Maria delle Grazie, tra cui Alessandro Di Battista
e Luigi Di Maio. Abbracci, lacrime e commozione fra i parlamentari all'uscita.
“La follia di fare dell'onestà un manifesto politico”, scrive Alessandro
Sallusti, Venerdì 15/04/2016, su "Il Giornale". «Gli unici onesti del Paese
sarebbero loro, come vent'anni fa si spacciavano per tali i magistrati del pool
di Mani pulite, come tre anni fa sosteneva di esserlo il candidato del Pd Marino
contrapposto a Roma ai presunti ladri di destra. Come tanti altri. Io non faccio
esami di onestà a nessuno, me ne guardo bene, ma per lavoro seguo la cronaca e
ho preso atto di un principio ineluttabile: chi di onestà colpisce, prima o poi
i conti deve farli con la sua, di onestà. Lo sa bene Di Pietro, naufragato sui
pasticci immobiliari del suo partito; ne ha pagato le conseguenze Marino con i
suoi scontrini taroccati; lo stesso Grillo, a distanza di anni, non ha ancora
smentito le notizie sui tanti soldi in nero che incassava quando faceva il
comico di professione».
In pochi, pochissimi lo sanno. Ma prima di diventare il guru del Movimento 5
Stelle di Beppe Grillo, Gianroberto Casaleggio aveva avuto rapporti con la
politica attraverso le sue società di comunicazione. In particolare con un
politico anni fa molto in voga e oggi completamente in disgrazia: Antonio Di
Pietro.
«E' così,
quando vedono una figura che potrebbe offuscare o affiancare la popolarità di
Grillo, i vertici del Movimento si affrettano a epurarla». La sua storia,
dall'appoggio incondizionato ricevuto all'allontanamento improvviso, è il
simbolo del rapporto tra l'Italia dei Valori e Beppe Grillo, scrive Francesco
Oggiano il 22 giugno 2012 su “Vanity Faire”. Il partito dell'ex pm è da sempre
quello più vicino per contenuti al Movimento. Il sodalizio è iniziato con la
nascita del blog ed è continuato almeno fino agli scorsi mesi. Grillo ha sempre
sostenuto l'ex pm, definito una «persona perbene» e soprannominato «Kryptonite»,
per essere rimasto «l'unico a fare veramente opposizione al Governo
Berlusconi». I «vertici» sarebbero quelli della Casaleggio Associati, società
fondata dal guru Gianroberto che cura la comunicazione del Movimento 5 Stelle.
La «figura» in ascesa era lei, Sonia Alfano. 40 anni, l'esplosiva eurodeputata
eletta con l'Idv, poi diventata Presidente della Commissione Antimafia europea,
arrivando al culmine di una carriera accidentata (prima la rottura con Grillo,
poi con l'Idv) iniziata nel 2008. Figlia del giornalista Beppe assassinato dalla
mafia, l'eurodeputata è stata la prima ad aver creato una lista civica regionale
certificata da Grillo, nel 2008. Già attiva da tempo nel Meetup di Palermo, si
presentò in Sicilia ignorata dai media tradizionali e aiutata dal comico prese
il 3% e 70 mila preferenze. «Alla vigilia delle elezioni europee del 2009,
Grillo e Di Pietro vennero da me e mi chiesero di candidarmi a Strasburgo. Io
non sapevo neanche di che si occupava l'Europarlamento», racconta oggi. Perché
Casaleggio avrebbe dovuto allontanare due europarlamentari popolari come Sonia
Alfano e Luigi De Magistris? Chiede Francesco Oggiano a Sonia Alfano: «La mia
sensazione è che quando i vertici del Movimento annusano una figura
"carismatica" che può offuscare, o quantomeno affiancare, la leadership
mediatica di Grillo, diano inizio all'epurazione».
Già dal gennaio 2003 il Presidente dell'Associazione Contro Tutte le Mafie, dr
Antonio Giangrande, in una semideserta ed indifferente assemblea dell'IDV a
Bari, in presenza di Antonio Di Pietro e di Carlo Madaro (il giudice del caso Di
Bella) criticò il modo di fare nell'IDV. L'allora vice presidente provinciale di
Taranto contestò alcuni punti, che furono causa del suo abbandono: Diritto di
parola in pubblico e strategie politiche esclusiva di Di Pietro; dirigenti
"Yes-man" scelti dal padre-padrone senza cultura politica, o transfughi da altri
partiti, o addirittura con troppa scaltrezza politica, spesso allocati in
territori non di competenza (in Puglia nominato commissario il lucano Felice
Bellisario); IDV presentato come partito della legalità-moralità in realtà era
ed è il partito dei magistrati, anche di quelli che delinquono impunemente;
finanziamenti pubblici mai arrivati alla base, così come ne hanno tanto parlato
gli scandali mediatici e giudiziari.
Ma non è questo che fa pensare cento volte prima di entrare in un movimento
insipido come il M5S. Specialmente a chi, come me, per le sue campagne di
legalità contro i poteri forti è oggetto perpetuo degli strali dei magistrati.
Incensurato, ma per quanto?
FU IL TENENTE GIUSEPPE DI BELLO IL PRIMO A SCOPRIRE L’INQUINAMENTO IN
BASILICATA, PER PUNIZIONE LO DENUNCIARONO PER “PROCURATO ALLARME!” Tenente della
polizia provinciale di Potenza denuncia l’inquinamento e perde la divisa. A
Potenza viene sospeso e condannato. Il caso affrontato con un servizio di Dino
Giarrusso su "Le Iene" del 17 aprile 2016. “Io rovinato per aver fatto il mio
dovere. E per aver raccontato i veleni del petrolio in Basilicata prima di
tutti”. In un colloquio lo sfogo di Giuseppe Di Bello, tenente di polizia
provinciale ora spedito a fare il custode al museo di Potenza per le sue denunce
sull'inquinamento all'invaso del Pertusillo, scrive Antonello Caporale il 4
aprile 2016 su "Il Fatto Quotidiano". «La risposta delle istituzioni è la
sentenza con la quale vengo condannato a due mesi e venti giorni di reclusione,
che in appello sono aumentati a tre mesi tondi. Decido di candidarmi
alle regionali, scelgo il Movimento Cinquestelle. Sono il più votato nella
consultazione della base, ma Grillo mi depenna perché sono stato condannato, ho
infangato la divisa, sporcato l’immagine della Basilicata. La Cassazione annulla
la sentenza (anche se con rinvio, quindi mi attende un nuovo processo).
Il procuratore generale mi stringe la mano davanti a tutti. La magistratura
lucana ora si accorge del disastro ambientale, adesso sigilla il Costa Molina.
Nessuno che chieda a chi doveva vedere e non ha visto, chi doveva sapere e ha
taciuto: e in quest’anni dove eravate? Cosa facevate?».
A questo punto ritengo che i movimenti a monoconduttura o padronali, che basano
il loro credo sulla propria presunta onestà per non inimicarsi i magistrati,
ovvero per non essere offuscati dall’ombra degli eroi che combattono i poteri
forti e ne subiscono le ritorsioni giudiziarie, vogliano nelle loro fila solo
“utili idioti”. Cioè persone che non hanno una storia da raccontare, o
un’esperienza vissuta; non hanno un bacino elettorale che ne conosca le
capacità. Insomma i padroni del movimento vogliono dei “Yes-Man” proni al volere
dei loro signori. “Utili idioti” scelti in “camera caritatis” o a forza di poche
decine di click su un blog imprenditoriale. “Utili idioti” sui quali fare i
conti in tasca: sia mai che guadagnino più del loro guru. A pensarci bene, però,
gli altri partiti non è che siano molto diversi dal Movimento 5 Stelle o l’IDV.
La differenza è che gli altri non gridano all’onestà, ben sapendo di essere
italiani.
TRIBUNALE DI POTENZA. SI DECIDE SUL DIRITTO DI CRITICA, MA ANCHE
SUL DIRITTO DI INFORMARE.
Le maldicenze dicono che i giornalisti sono le veline dei
magistrati. Allora, per una volta, facciamo parlare gli imputati.
Tribunale di Potenza. All’udienza tenuta dal giudice Lucio Setola finalmente si
arriva a sentenza. Si decide la sorte del dr. Antonio Giangrande. Scrittore,
sociologo storico, blogger, youtuber, presidente dell’Associazione Contro Tutte
le Mafie, conosciutissimo sul web. Ma noto, anche, agli ambienti giudiziari
tarantini per le critiche mosse al Foro per i molti casi di ingiustizia trattati
nei suoi saggi, anche con interrogazioni Parlamentari, tra cui il caso di Sarah
Scazzi e del caso Sebai, e per le sue denunce contro l’abilitazione nazionale
truccata all’avvocatura ed alla magistratura. Il tutto condito da notizie non
iscritte nel registro dei reati o da grappoli di archiviazioni (anche da
Potenza), spesso non notificate per impedirne l’opposizione. Fin anche
un’autoarchiviazione, ossia l’archiviazione della denuncia presentata contro un
magistrato. Lo stesso che, anziché inviarla a Potenza, l’ha archiviata. Biasimi
espressi con perizia ed esperienza per aver esercitato la professione forense,
fin che lo hanno permesso. Proprio per questo non visto di buon occhio dalle
toghe tarantine pubbliche e private. Sempre a Potenza, in altro procedimento per
tali critiche, un Pubblico Ministero già di Taranto, poi trasferito a Lecce,
dopo 9 anni, ha rimesso la querela in modo incondizionato.
Processato a Potenza per diffamazione e calunnia per aver esercitato il suo
diritto di difesa per impedire tre condanne ritenute scontate su reati riferiti
ad opinioni attinenti le commistioni magistrati-avvocati in riferimento
all’abilitazione truccata, ai sinistri truffa ed alle perizie giudiziarie false.
Alcuni giudizi contestati, oltretutto, non espressi dall’imputato, ma a lui
falsamente addebitati. Fatto che ha indotto il Giangrande per dipiù a presentare
una istanza di rimessione del processo ad altro Foro per legittimo sospetto (di
persecuzione) ed a rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Rigettata dalla Corte di Cassazione e dalla Cedu, così come fan per tutti.
Per dire: una norma scomoda inapplicata.
Processato a Potenza, secondo l’atto d’accusa, per aver presentato una richiesta
di ricusazione nei confronti del giudice di Taranto Rita Romano in tre distinti
processi. Motivandola, allegando la denuncia penale già presentata contro lo
stesso giudice anzi tempo. Denuncia sostenuta dalle prove della grave
inimicizia, contenute nelle motivazioni delle sentenze emesse in diversi
processi precedenti, in cui si riteneva Antonio Giangrande una persona
inattendibile. Atto di Ricusazione che ha portato nel proseguo dei tre processi
ricusati all’assoluzione con giudici diversi: il fatto non sussiste. Questione
rinvenibile necessariamente durante le indagini preliminari, ma debitamente
ignorata.
Ma tanto è bastato all’imputato, nell’esercitare il diritto di difesa ed a non
rassegnarsi all’atroce destino del “subisci e taci”, per essere processato a
Potenza. Un andirivieni continuo da Avetrana di ben oltre 400 chilometri. Ed è
già una pena anticipata.
L’avvocato
della difesa ha rilevato nell’atto di ricusazione la mancanza di lesione
dell’onore e della reputazione del giudice Rita Romano ed ha sollevato la
scriminante del diritto di critica e la convinzione della colpevolezza del
giudice da parte dell’imputato di calunnia. La difesa, preliminarmente, ha
evidenziato motivi di improcedibilità per decadenza e prescrizione. Questioni
Pregiudiziali non accolte. L’accusa ha ravvisato la continuazione del reato, pur
essendo sempre un unico ed identico atto: sia di ricusazione, sia di denuncia di
vecchia data ad esso allegata.
Il giudice
Rita Romano, costituita parte civile, chiede all’imputato decine di migliaia di
euro di danno. Imputato già di per sé relegato all’indigenza per impedimento
allo svolgimento della professione.
Staremo a
vedere se vale la forza della legge o la legge del più forte, al quale non si
possono muovere critiche. Che Potenza arrivi a quella condanna, dove Taranto
dopo tanti tentativi non è riuscita?
Dicono su
Avetrana accusata di omertà: “Chi sa parli!” Se poi da avetranese parli o
scrivi, ti processano.
La
“presunta” onestà degli italiani,
scrive il 2 agosto 2015 don Giorgio De Capitani. In questi ultimi tempi, anche a
causa delle polemiche inerenti ai profughi che, dietro ordini delle
Prefetture, vengono smistati e messi in alcuni locali dismessi dei Comuni, è
uscita di colpo la “presunta” onestà dei cittadini italiani. Anche sul mio sito,
ho letto frasi simili: da 50 anni pago le tasse, ho lavorato e sudato
onestamente, ed ecco che arriva questa gente, per non dire “gentaglia”, che mi
fa sentire cittadino di serie B o Z, quasi umiliato nei miei diritti, eccetera,
eccetera. C’è un giornale online locale, Merateonline, dove, ogni giorno, magari
con la soddisfazione del suo Direttore, appaiono lettere e lettere di cittadini
frustrati dalla presenza di questi “loschi” individui, che non pagano le tasse,
non lavorano, anzi li disturbano, non li fanno più vivere in santa pace. Se
volete toccare di persona il polso della solidarietà o umanità della gente
brianzola, ecco, ne potete avere una certa idea. Sì, una certa idea, perché in
realtà i brianzoli sono ancor più egoisti, al di là della loro “innocenza”
battesimale o del loro utile pragmatismo pastorale, con la benedizione dei
parroci consenzienti. Ma… chi è onesto al cento per cento? Credo nessuno,
nemmeno il papa. Chi non ha fatto fare qualche lavoretto in nero? Chi ha
fatturato ogni lavoro eseguito? Chi ha sempre pagato l’iva? Chi ha dichiarato
l’esatta metratura dei propri locali, per evitare di pagare più tasse sulla
spazzatura? Chi lavora per raccomandazione o ha vinto un concorso truccato, chi
è un falso invalido o un baby pensionato, ecc. Chi è senza peccato scagli la
prima pietra! Naturalmente, quando non paghiamo qualche tassa, ci giustifichiamo
in nome della nostra “onestà” presunta, oppure del fatto che gli altri non
pagano: “Io non sono un coglione”! E così via…E poi, soprattutto nel campo
ecclesiastico, c’è sempre una ragione “valida” per non pagare tutte le tasse:
faccio il bene, mi do da fare per gli altri, sono qui tutto il giorno al
servizio della comunità anche civile, e poi dovrei pagare anche le tasse? Il
bene mi fa sentire in diritto di esserne esente! Ma questo è un altro discorso,
anche complesso. Ma ciò che non sopporto è la “presunta” onestà degli italiani,
a giustificazione del proprio egoismo di cittadini che, per il fatto di vantare
la propria onestà in base a criteri del tutto personali (ognuno si è fatto il
proprio Codice e la propria Costituzione), rifiutano coloro che essi ritengono
“diversi”, “estranei”, “illegali”, addirittura “pericolosi”, che mettono a
rischio la “presunta” onestà di cittadini italiani.
Chi scaglia
la prima pietra?
L’editoriale di Sebastiano Cultrera del 06.02.2016. Le incalzanti notizie di
cronaca giudiziaria provocano reazioni variegate tra i cittadini della nostra
isola. Sgomento, sorpresa, sdegno, compassione o incredulità si alternano nei
discorsi tra i cittadini. Ma emerge, troppo spesso, una ipocrisia di fondo che è
la stessa che attraversa, troppo spesso, la nostra società procidana. “La devono
pagare cara!” ho sentito dire da qualche anima bella “Anche per rispetto ai
procidani onesti”. E questa storia dell’ONESTA’ è una specie di ritornello al
quale, anche in politica, qualcuno si appella, e di solito lo fa chi è a corto
di argomenti: naturalmente declinando il concetto di “onestà” a propria
convenienza e piacimento. Io sono convinto, e ho cercato di sostenerlo anche
recentemente, che il popolo procidano è un popolo profondamente onesto. Forse il
nostro peggior difetto è il menefreghismo, unito ad un individualismo esasperato
(i procidani sono “sciuontere”, usa dirsi). Ma rispetto ad altre realtà, anche
contigue alla nostra, non possiamo certo lamentarci: non prosperano qui bande
criminali, né (per fortuna) si registrano un numero di crimini particolarmente
allarmante. Sostanzialmente il popolo procidano (che ha una grande storia
imprenditoriale, densa di integrazione culturale e di commerci internazionali) è
un popolo sano, produttivo e lavoratore, con un bagaglio etico del lavoro e
della famiglia di tipo tradizionale. Tuttavia l’Onestà Aà Aà (quella degli
slogan) è un’altra cosa, e proprio quegli esacerbati che la proclamano ai
quattro venti (o semplicemente nelle chiacchiere da bar o da aliscafo)
dovrebbero, prima, almeno, farsi delle domande. Il quadro che, in effetti,
emerge dalle notizie che i media ci restituiscono, rispetto alle inchieste in
corso, è un quadro complesso, che lascia intendere una vastissima rete di
complicità, con l’abitudine a piccoli e grandi privilegi individuali o di
“categoria” che erano diventati, nel tempo, dei veri e propri abusi; magari
questi episodi non rivestono sempre rilevanza penale, ma, ciò non di meno, sono
egualmente molti distanti da qualunque ideale corretto di ONESTA’. E’, poi,
meritevole di approfondimento (e a breve mi piacerebbe farlo) la differenza tra
i concetti di ONESTA’, di ETICA e di MORALE, recentemente abusati e usati
talvolta a sproposito. Faccio solo notare che essi necessitano, per concretarsi,
di un quadro di VALORI condiviso, che invece non esiste più o non è
sufficientemente condiviso. Giacché ciascuno si fa una morale a proprio uso e
consumo e si finisce per riferirsi, volentieri, alla sola dis-ONESTA’ degli
ALTRI, in un eterno gioco di specchi asimmetrico: che, come Lui ha insegnato, ci
fa concentrare, colpevolmente, esclusivamente sulle pagliuzze altrui. I sepolcri
imbiancati di oggi è facile riconoscerli: sono quelli che, in certi frangenti,
si sbattono più di tutti, quelli che vagano stracciandosi le vesti predicando
ONESTA’ a sproposito, come se fosse una confezione di dentifricio atta a pulire
bocca e denti. E nulla dicono su di loro stessi e sui loro amici, sui costumi
diffusi di una comunità che non si riscatta additando le colpe di altri, neanche
di uno o più capri espiatori. Invece il largo stuolo di professionisti,
impiegati, commercianti e cittadini che beneficiavano (o beneficiano?) di quel
“sistema” o comunque si integravano in quel quadro è imponente (e non risparmia
neanche molti soggetti dispensatori di slogan o in vario modo in contiguità col
moralismo di maniera); essi non sono esattamente dei criminali, almeno fino a
prova contraria (e nessuno lo è, quindi, fino a sentenza definitiva). Ma certo
dobbiamo dire con ONESTA’ INTELLETTUALE (ahia, l’ho detto anche io!) che tra
multe cancellate, impunità varie, spiate e dossier, professionalità tecniche
asservite a “papocchi” amministrativi, emerge un quadro sconfortante. Se poi
apriamo il focus e vediamo anche il popolo delle casse marittime facili, dei
piccoli e grandi abusi e delle piccole e grandi evasioni, possiamo allora essere
certi di avere toccato quasi ogni famiglia isolana. Poiché l’averla “fatta
franca” non significa essere moralmente meno colpevoli, ciò NON AUTORIZZA a
scagliare la PRIMA PIETRA per ferire (a colpi di ONESTA’) chi sciaguratamente è
stato scoperto. Spesso, infatti, è proprio la cattiva coscienza che porta a
voler concentrarsi su uno o più responsabili (presunti) del decadimento morale,
anche al fine di mondare catarticamente le proprie responsabilità e quindi la
coscienza stessa. Invece la strada per la “salvezza” (cioè verso una nuova
consapevolezza) passa attraverso una presa di coscienza collettiva delle VIRTU’,
ma anche dei VIZI di una comunità: al fine di migliorarla.
La follia
di fare dell'onestà un manifesto politico.
Io non so se Casaleggio, parlandone da vivo, fosse o no il re degli onesti. So
che il suo partito, dove governa, non riesce a risolvere neppure mezzo problema
in più di qualsiasi altro, scrive Alessandro Sallusti, Venerdì 15/04/2016, su
"Il Giornale". «Onestà, onestà», hanno intonato dirigenti e simpatizzanti
grillini sul sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie all'uscita della
bara di Gianroberto Casaleggio. Come ultimo saluto, una preghiera laica in linea
con il dogma pentastellato che al di fuori del loro club tutto è marcio e
indegno. Gli unici onesti del Paese sarebbero loro, come vent'anni fa si
spacciavano per tali i magistrati del pool di Mani pulite, come tre anni fa
sosteneva di esserlo il candidato del Pd Marino contrapposto a Roma ai presunti
ladri di destra. Come tanti altri. Io non faccio esami di onestà a nessuno, me
ne guardo bene, ma per lavoro seguo la cronaca e ho preso atto di un principio
ineluttabile: chi di onestà colpisce, prima o poi i conti deve farli con la sua,
di onestà. Lo sa bene Di Pietro, naufragato sui pasticci immobiliari del suo
partito; ne ha pagato le conseguenze Marino con i suoi scontrini taroccati; lo
stesso Grillo, a distanza di anni, non ha ancora smentito le notizie sui tanti
soldi in nero che incassava quando faceva il comico di professione. Cari Di Maio
e compagnia, smettetela con questa scemenza del partito degli onesti che fa la
morale a tutti, cosa che fra l'altro porta pure male. L'onestà non è un
programma politico, è una precondizione personale per affrontare la vita in un
certo modo. Io voglio comportarmi onestamente, e mi piacerebbe facessero
altrettanto il mio fruttivendolo, chi mi vende l'automobile, chi si occupa della
mia salute, il politico che voto. Ma da loro pretendo solo una cosa: che la
frutta sia buona e sana, che l'auto funzioni come mi aspettavo, che se
necessario il mio medico mi salvi la vita, che la politica sia efficiente nel
risolvere i miei problemi. L'onestà che viene a mancare è un problema della loro
coscienza, e giudiziario se comporta la violazione delle leggi e se danneggia la
comunità. Io non so se Casaleggio, parlandone da vivo, fosse o no il re degli
onesti. So che il suo partito, dove governa, non riesce a risolvere neppure
mezzo problema in più di qualsiasi altro. Anzi, a volte, vedi casi Livorno e
Quarto, fanno disastri ben peggiori. Cosi come in Parlamento la strategia
grillina ha prodotto tanto fumo e zero arrosto. Sarò all'antica, ma in chiesa,
ai cori sull'esclusiva dell'onestà («chi è senza peccato scagli la prima
pietra», diceva il Padrone di casa) preferisco ancora una preghiera.
IL
GIUSTIZIALISMO GIACOBINO E LA PRESCRIZIONE.
Appello contro
i Giustizialisti Giacobini (e invito alla sollevazione contro il Klan delle tre
G). Come si sa, i Giustizialisti Giacobini dormono, la notte, adagiati fra le
teste mozzate dei nemici uccisi. Di essi hanno bevuto il sangue. Delle loro
carni si sono saziati. Non c’è nulla di più detestabile di un Giustizialista
Giacobino. In lui infatti convergono, tautologicamente, due orribili vizi:
l’essere giustizialista, e l’essere giacobino. E’, come si sa, una combinazione
devastante ed esiziale. Da essa proviene ogni male della terra. Si pensa che
anche Eva, quella di Adamo, fosse malata di questa malattia. Non parliamo di
Giuda. Si nutrono cauti sospetti anche su Robespierre. Data la gravità dei loro
crimini, siamo tutti in grado di riconoscere i Giustizialisti Giacobini, tutti
conosciamo le loro malefatte. Appare dunque superfluo definirli. Si sa quello
che sono. Nomina sunt consequentia rerum. Dunque parliamo di fatti e bando alle
ciance:
1)
Il Giustizialista Giacobino è colui che non evoca la giustizia come risoluzione
di alcuni problemi giudiziari, ma vorrebbe perversamente che essa li
risolvesse tutti. Tutti ovviamente vogliamo la giustizia e tutti,
socraticamente, sappiamo che la “giustizia è giusta”. Quello che è ingiusto
ovviamente è l’uso giacobino e giustizialista della giustizia. Tale uso si
caratterizza per la pretesa, assolutamente ignobile, di processare coloro che
sono indiziati, e di condannare coloro che sono risultati colpevoli dagli atti
processuali, quando quei reati ci riguardano e riguardano i nostri interessi.
I Giudici Giustizialisti e Giacobini (l’orribile Klan delle Tre G) se ne fregano
della micro o macro criminalità quotidiana e di strada. Come se un criminale
abituale e seriale, ad esempio il ladruncolo di strada extra comunitario, fosse
ladro tanto quanto (forse meno!) di finanzieri e politici corrotti e corruttori,
di falsificatori di bilanci e dispensatori di mazzette, di evasori fiscali. Come
se il gioielliere che spara al ladro che l’ha privato di tutti i suoi averi,
fosse colpevole come il ladro stesso!
2) Si dirà che
tale idea della differenziazione della giustizia ha un che di antiquato, di
classista, distingue ricchi da poveri, privilegiati e non, potenti e miserabili.
Ma questa, ovviamente, è la tipica obiezione del Giustizialista Giacobino.
Questa ignobile creatura sa infatti molto bene, ma finge di non sapere, che se
la giustizia è sempre giusta non sempre lo sono i giudici. Essi si dividono
in Giudici Giustizialisti Giacobini e Giudici Non Giustizialisti e Non
Giacobini. I primi condannano per scopi politici, per rancori personali, per
invidia sociale. I secondi sono animati da giustizia, saggezza e santità. Per
riconoscere una sentenza come Giustizialista basta individuare chi è stato
colpito da essa. Se è qualcuno che ha sparato a zero sul Giustizialismo
Giacobino, potete stare certi che la sentenza sarà il prodotto del medesimo. E’
un circolo da cui non si sfugge. Ne consegue che, chi denuncia
il Giustizialismo Giacobino, verrà preferibilmente condannato dai Giudici
Giustizialisti. La denuncia del Giustizialismo causa la vendetta
dei Giustizialisti. Qualcuno forse obietterà che spesso i giudici vengono
definiti Giustizialisti Giacobini a sentenza di condanna avvenuta. Ma a questo è
facile rispondere che, fino ad allora, l’imputato ingiustamente condannato non
si era reso conto di quando il suo giudice fosse Giustizialista e Giacobino.
Certo i cittadini sono troppo onesti e hanno un troppo elevato senso della
giustizia per concepire che un giudice possa essere così perverso. E quando lo
scoprono sulla loro pelle, perché vengono condannati, sentono il dovere morale
di denunciarlo.
3) Altra cosa
del Giustizialismo Giacobino è invocare una giustizia rapida, inflessibile, con
inasprimento delle pene e accelerazione dell’iter processuale, incarcerazione
preventiva prolungata e cancellazione delle attenuanti e dell’habeas corpus per
i reati commessi dai nemici giurati della comunità civica e dunque della
giustizia giusta. Neri, maghrebini, rumeni ed albanesi, frange estremiste e
disperate, vagabondi che insozzano le nostre strade, devastatori e disturbatori
dell’ordine pubblico di qualsiasi etnia, debbono patire la giustizia giusta,
severa e spietata, e questo ovviamente non è Giustizialismo.
Il Giustizialismo Giacobino è infatti l’uso politico, ingiusto ed abusivo della
giustizia. In questo caso si tratta invece di eque pene (anche troppo morbide,
diciamola tutta) che dimostrano che lo Stato ha forte e coerente il senso della
giustizia giusta.
Riassumiamo
dunque. La giustizia è sempre giusta, ma i giudici possono essere giusti ed
ingiusti. I giudici ingiusti sono i Giustizialisti Giacobini, che condannano
animati da sete di vendetta politica. Il cittadino che denuncia un giudice
come Giustizialista Giacobino lo fa perché capisce, presto o tardi e sulla sua
pelle, che tale giudice lo odia e vuole condannarlo. Su di lui piove crudele la
vendetta dei Giustizialisti. Pertanto, alla fine della sua giornata, il Giudice
Giustizialista può aver condannato anche moltissimi innocenti. E’ dunque
opportuno costituire un Partito degli Innocenti (P.d.I.) che ribatta colpo su
colpo all’offensiva dei Giudici Giustizialisti e Giacobini. Il Klan delle tre
Gdeve essere colpito e affondato. Trattiamo finalmente da esuli i latitanti e da
innocenti i colpevoli. Distinguiamo fra colpevoli-colpevoli,
innocenti-innocenti, innocenti-colpevoli e colpevoli-innocenti. Rendiamo un
utile servizio all’umanità e al nostro paese. Diciamo basta al Giustizialismo
Giacobino e ai giudici che perversamente lo praticano! Viva la libertà! Viva la
giustizia giusta! Abbasso la giustizia ingiusta! Prescrizione per tutti!
Glossario (nel
caso ci fosse ancora qualcuno che non sappia del Klan delle Tre G)
Giudici:
Strane creature, in genere provenienti dai reparti neuropsichiatrici, la cui
sindrome si manifesta attraverso la pretesa di giudicare altri esseri umani, in
genere mentalmente molto più stabili di loro, mediante uno strano sistema di
norme, astratte e sconclusionate, chiamate leggi. Si tratta di un comportamento
evidentemente insolito, assurdo, e chiaramente inficiato da delirio paranoico e
di onnipotenza. Si guardassero a casa loro e nel loro orto, invece di cercare la
trave del vicino nel primo cammello che capita a tiro (forse non è così, non mi
ricordo bene...). Questo non vuol dire che alcuni di questi strani individui non
si comportino egregiamente e tendano ad assolvere le persone che noi vogliamo
che assolvano (compresi noi stessi). Ma gli altri sono inguaribili strafottenti,
che esercitano la giustizia come se brandissero una clava.
Giustizialismo: Il temine in sé è neutrale e vorrebbe indicare, immaginiamo,
l’esercizio della giustizia tramite la condanna dei colpevoli. In realtà il
termine tende ad evidenziare il comportamento della maggior parte dei giudici,
che condannano tutti quelli che ritengono colpevoli e non solo quelli che noi
onesti cittadini vorremmo che fossero giudicati tali. Il Giustizialismo è quindi
definibile come l’attitudine ad esercitare la giustizia in modo abusivo. Questo
ovviamente comporta il problema di chi possa giudicare i giudici riguardo a tali
abusi. La risposta è quanto mai ovvia e scontata: coloro che si oppongono
al giustizialismo!
Giacobini:
Esseri dalle apparenti sembianze umane (o che assumono ingannevoli sembianze
umane), ma probabilmente provenienti da altri pianeti e comunque non dalle
comunità occidentali progredite del nostro pianeta. Coloro i quali affermano che
i giacobini nascano in Occidente, e affondino le loro radici culturali nella
tradizione occidentale, sono probabilmente giacobini essi stessi. I giacobini
sono esseri talmente crudeli che spesso si divorano tra di loro. Sono dotati di
una doppia fila di zanne e secernono liquidi urticanti dai pori delle loro pelle
squamosa. Quando sorridono, si vede che non lo sanno fare. Né si divertono mai,
perché passano il loro tempo a tramare contro l’umanità. Si riuniscono in luoghi
oscuri e fangosi dove praticano l’accoppiamento fra coppie non sposate (e spesso
dello stesso sesso) e il sacrificio umano (bambini soprattutto). Quando si
travestono da uomini e popolano le nostre città, vivono spesso anche
nei quartieri alti. In tal caso si riuniscono in salotti bene e firmano
petizioni allo scopo di epurare l’umanità dai suoi elementi migliori. Tendono
naturalmente a diventare giudici (per natura e per attitudine, data la loro
devastata biologia e la loro perversione innata) o a influenzare i giudici,
probabilmente per mezzo di facoltà telepatiche e di controllo della mente.
“I grillini
confermano la loro imbarazzante inclinazione al becero giustizialismo e nel
presentare il loro programma di governo si affrettano a sottolineare che tra i
primi punti ci sarebbe l’abolizione della prescrizione. Prescrizione che, tra
l’altro, è stata allungata nei tempi dal Governo Renzi. Anziché voler lavorare
per una giustizia vera e per garantire tempi certi nei processi ai cittadini,
così come sancito dalla nostra Costituzione, i grillini optano per procedimenti
giudiziari infiniti che paralizzerebbero la vita delle persone, anche di quelle
innocenti. Se malauguratamente diventassero forza di governo ci sarebbe davvero
di che preoccuparsi”. Così Gabriella Giammanco, parlamentare di Forza Italia. 18
ottobre 2015.
Quali saranno
i primi punti di un governo a 5 Stelle? “La prima cosa da fare è eliminare la
corruzione con l’onesta, mettere mano alla giustizia, eliminare la prescrizione,
mettere persone oneste nelle amministrazioni”. Lo sostiene Gianroberto
Casaleggio, che ha risposto così ai giornalisti che, a Italia 5 Stelle, gli
chiedevano i primi punti del programma. Il primo criterio sarà “la fedina
penale”, i sospettabili non sarà possibile sceglierli. La piattaforma è in grado
di accogliere i contenuti, che possono essere tanti e diversi, il problema sarà
fare una sintesi. “Fra i primi punti del programma dell’ipotetico governo del
Movimento 5 stelle c’è l’abolizione della prescrizione, il che vuol dire la
possibilità di tenere sotto processo un innocente per tutta la vita. I grillini
si dimostrano sempre più funzionali alla retorica giustizialista che tanti danni
ha provocato in questi anni, non avendo mai nascosto del resto la loro
avversione verso il Parlamento e le Istituzioni rappresentative”. Lo afferma
Deborah Bergamini, responsabile Comunicazione di Forza Italia. 18 ottobre 2015
LA
PRESCRIZIONE.
Dissertazione
di Giovanni Ciri, sabato 18 maggio 2013. "Detesto il fanatismo, la faziosità e
le mode pseudo culturali. Amo la ragionevolezza, il buon senso e la vera
profondità di pensiero". La Prescizione. E' l'istituto più odiato dai
giustizialisti, sto parlando della prescrizione del reato. Vorrebbero tempi di
prescrizione lunghissimi, praticamente infiniti. Non conta quando hai commesso
un reato, dicono, conta se lo hai commesso, e se lo hai commesso devi essere
punito, punto e basta. E non va loro giù che la prescrizione intervenga dopo che
il processo ha avuto inizio. Citano addirittura gli Stati Uniti d'America, dove
i termini di prescrizione si interrompono appena è stata emessa la sentenza di
rinvio a giudizio. Si, è proprio così, negli Usa la prescrizione si interrompe
dal momento in cui il sospettato è rinviato a giudizio, ma, quali sono i termini
di prescrizione negli Stati uniti d'America? Un delitto che comporta la pena
dell'ergastolo è sempre perseguibile. Ogni altro delitto grave (rapine, furti,
stupri, sequestri di persona) è perseguibile entro CINQUE ANNI. I delitti meno
gravi sono perseguibili entro DUE ANNI, quelli minimi entro UN ANNO. Esclusi i
delitti gravissimi, sempre perseguibili, negli Usa ogni crimine deve essere
perseguito entro termini temporali abbastanza ristretti. Nel momento in cui
inizia il processo però i termini di prescrizione si interrompono, e si evitano
in questo modo eventuali manovre dilatorie. Questo non fa sì che l'imputato
debba passare lunghi periodi nella “zona di nessuno” in cui necessariamente vive
chi è sottoposto a procedimento penale. Negli Usa infatti i processi sono
piuttosto rapidi. Le udienze sono quotidiane, i giurati vivono praticamente da
reclusi, impossibilitati addirittura a leggere i giornali o a guardare la TV,
questo perché chi è chiamato a giudicare della vita di un essere umano deve
formarsi la propria convinzione in base a ciò che emerge dal dibattimento, non
dai talk show televisivi o dai predicozzi di giornalisti alla Travaglio. La
differenza con quanto avviene in Italia è lampante. Un giudice popolare italiano
ascolta oggi un teste, fra due mesi un altro, fra sei mesi la requisitoria del
PM e fra otto l'arringa del difensore. Se tutto va bene fra un anno entrerà in
camera di consiglio (fanno eccezione i processi a carico di Berlusconi che sono
di solito rapidissimi). E' difficile pensare che in questo modo il giudice
popolare italiano possa maturare una convinzione ponderata sulla base di quanto
emerge dal dibattimento. Si aggiunga che negli Usa il pubblico accusatore non è,
come in Italia, un collega del giudice, che la difesa contribuisce alla
selezione della corte giudicante, che i giurati devono decidere alla unanimità e
ci si renderà conto che in quel paese il processo penale, anche se esclude i tre
gradi di giudizio automatici, è molto più garantista che nel nostro. E'
interessante mettere in evidenza una cosa: se nel nostro paese fosse in vigore
la normativa americana molti procedimenti a carico di Berlusconi non avrebbero
neppure potuto iniziare. Come hanno agito infatti i magistrati col cavaliere?
Non appena è entrato in politica hanno iniziato inchieste riguardanti vecchie
storie sulle quali sino a quel momento nessuno aveva indagato o, se indagini
c'erano state le loro risultanze giacevano da tempo sotto montagne di pratiche
inevase. Nel processo All Iberian il cavaliere è stato rinviato a giudizio nel
1996 per finanziamento illecito ai partiti, reato che è avvenuto (se è avvenuto)
fra il 1991 ed il 1992, e di certo non è un reato grave (negli Usa non è neppure
previsto come reato). La prima inchiesta a carico di Berlusconi, quella per le
famose tangenti alla guardia di finanza, riguarda diverse tangenti, corrisposte
a diversi soggetti, la prima della quali risalente al 1989, l'ultima al 1994. Il
rinvio a giudizio è del 1995, quanto meno le prime tangenti non avrebbero quindi
dovuto rientrare nel procedimento che, come si sa, si concluse con la piena
assoluzione dell'imputato. Una indagine a carico di Berlusconi per traffico di
droga si è conclusa nel 1991 con una archiviazione, i fatti risalgono al 1983.
Non voglio continuare perché non sono e non mi interessa essere uno specialista
in Belusconismo giudiziario (ho preso i dati dalla rete). Mi va solo di
sottolineare che i termini americani di perseguibilità avrebbero reso assai più
difficile il lavoro di magistrati assolutamente imparziali e privi di pregiudizi
come Antonio Di Pietro o Ilda Boccassini. Ma, a parte ogni tecnicismo, quale è
la filosofia che sta dietro l'istituto della prescrizione, che i forcaioli di
ogni tipo odiano? La risposta è semplicissima, la si può riassumere in una sola
parola: garantismo. Garantismo che vale a tre livelli. In primo luogo, una
persona non può essere indagata a vita. Se sei indagato vivi in una situazione
di estrema provvisorietà. Se cerchi lavoro tutto diventa più difficile se è in
corso un procedimento giudiziario a tuo carico, se il lavoro lo hai già le
prospettive di carriera si complicano terribilmente. Chi è indagato ha diritto
che in tempi ragionevolmente brevi il suo caso si chiuda. Ha diritto a questo
anche chi è stato offeso dall'eventuale azione criminosa dell'indagato. Insomma,
una giustizia rapida è nell'interesse di tutti, meno che dei criminali e dei
calunniatori di professione. In secondo luogo, a meno che non si tratti di reati
gravissimi, nessuno può essere chiamato a rispondere di cose avvenute molto
tempo prima, con tutte le difficoltà di ricordare eventi, nomi, situazioni.
Infine, ed è la cosa più importante di tutte, i termini di perseguibilità
tendono ad impedire che qualche solerte magistrato possa perseguitare un
cittadino andando a spulciare nella sua vita passata in cerca di qualche
reato. Questa in particolare è la filosofia che sta dietro alla normativa
americana. Tizio può essere indagato solo se esiste una specifica ipotesi di
reato a suo carico e se c'è il ragionevole sospetto che possa essere implicato
in quel reato. I magistrati insomma devono indagare su reati accertati, non
andare alla ricerca di reati, meno che mai lo devono fare concentrandosi su una
persona, ancora meno andando a spulciare tutta la sua esistenza per appurare se
per caso ci sia in essa qualcosa di poco regolare. L'istituto della prescrizione
è inoltre collegato teoricamente con il principio della presunzione di
innocenza. Non è vero che la assoluzione per prescrizione equivale ad una
condanna. I termini di prescrizione fissano dei limiti alla azione del
magistrato: questi deve riuscire a far condannare il sospettato da lui ritenuto
colpevole entro quei limiti, se non ci riesce il sospettato è innocente perché
nei paesi civili la innocenza è presunta. Da quanto si è detto emerge che non è
affatto un caso che i giustizialisti forcaioli di tutte le risme abbiano
profondamente in odio la prescrizione. Il loro ideale è una società in cui tutti
si sia indagati, tutti si viva sempre sotto sorveglianza. Un “magistrato” come
Ingroia è arrivato addirittura a proporre, in campagna elettorale, la inversione
dell'onere della prova nei processi per reati finanziari: se Tizio è sospettato
di evasione gli si confischino i beni, ha detto, poi lui avrà sei mesi di tempo
per dimostrare la sua innocenza... magnifico! A Tizio sono concessi sei mesi per
provare la sua innocenza, ma dieci anni per prescrivere un reato sono pochi, per
il dottor Ingroia! E ora questo signore è di nuovo magistrato, non invidio
valdostani. La cosa grave è che simili idee forcaiole sono molto diffuse nel
paese. Molta, troppa gente è convinta che il garantismo sia quasi un lusso, che
tutto sia lecito pur di mettere dentro un presunto corrotto. Non si capisce che
ogni arbitrio è possibile se vengono meno le fondamentali garanzie a tutela
della libertà dei singoli, ogni arbitrio ed anche ogni corruzione.
Se La
Repubblica vuole ancora più processi,
scrive Giovanni Torelli su “L’Intraprendente” il 15 febbraio 2016. No, alla
sinistra non basta la quantità abnorme di processi penali che si celebrano ogni
anno in Italia e di quelli ancora pendenti (sono circa 3 milioni e mezzo). Ne
vuole ancora di più, perché desidera un sacco alimentare sia la macchina
della Burocrazia che quella del Giustizialismo. E così, in un dossier pubblicato
lo scorso sabato, la Repubblica lamenta il fatto che, per colpa della
prescrizione troppo breve voluta dalla legge ex Cirielli del 2005, nel nostro
Paese vengano cancellati ogni anno circa 130mila reati. E che quindi altrettanti
presunti colpevoli restino inevitabilmente impuniti…Insomma, alla macchina già
ingolfata della giustizia italiana (la cui inefficacia non è certo colpa della
prescrizione troppo breve, semmai della lentezza di certi magistrati) la
Repubblica vorrebbe aggiungere un ulteriore carico, appoggiando l’ipotesi di
riforma voluta dal ministro della Giustizia Orlando, che intende allungare di
tre anni per tutti i processi penali i tempi della prescrizione. Il sovraccarico
potrebbe essere facilmente calcolabile: “riabilitando” 130mila processi annui è
verosimile che in un decennio i processi ancora pendenti in Italia
diventino circa 5 milioni. Che dire, un’ideona…E vabbè, uno dirà, non è giusto
che 80mila fascicoli non arrivino neppure in sede di dibattimento ma vengano
bloccati dalla scure della prescrizione già in fase di indagini preliminari; ed
è ingiusto che la giustizia non faccia il suo pieno corso, “costringendo” oltre
23mila processi a fermarsi in primo grado per raggiunti limiti di tempo e altri
24mila a bloccarsi in Appello per la stessa ragione. La giustizia piena vuole
che siano affrontati tutti i tre gradi di giudizio, dicono loro. È una forma di
garanzia verso l’imputato ma anche di sicurezza che il colpevole ottenga la
giusta pena, dicono loro. Il punto vero però è che molte di quelle indagini
preliminari muoiono ancor prima di addivenire a giudizio perché vengono aperte
in ritardo rispetto al reato, sono fondate su prove inconsistenti, non hanno
riscontri concreti e tergiversano fino a concludersi in un nulla di fatto:
altroché prescrizione, molte di quelle indagini non dovevano neppure essere
aperte. Se poi in fase di dibattimento quei processi si arenano fino a
interrompersi, la colpa spesso è oltre che dell’oggettiva lentezza della
giustizia italiana (che ha scambiato il garantismo con una dilazione immotivata
di tutti i passaggi processuali) anche di una mancata operosità di chi dovrebbe
invece favorire l’accelerazione di quei processi. Il fardello pendente dei
processi mai portati a compimento, per capirci, grava non solo sulle spalle
dell’imputato, ma soprattutto sulle coscienze di dipendenti (non sempre
efficienti) dello Stato che si chiamano magistrati. E non vorremmo che la
riforma della prescrizione voluta da Orlando e difesa da la Repubblica diventi
una scusa per prolungare ulteriormente i tempi di lavoro dei giudici. Avranno
pure le ferie più corte, adesso, ma hanno anche tre anni in più per trastullarsi
con le carte di un processo…
"Troppo
potere mediatico ai pm. La giustizia italiana è una follia".
Piero
Sansonetti, direttore del nuovo quotidiano "il Dubbio", in edicola da martedì:
"Le toghe fanno politica, riforma necessaria", scrive Anna Maria Greco, Giovedì
07/04/2016, su "Il Giornale". Si chiama il Dubbio, esce in edicola martedì e per
5 giorni la settimana, ha 16 pagine, full color, una redazione di 13
professionisti: è il nuovo quotidiano diretto da Piero Sansonetti. Che ha come
editore la Fondazione del Consiglio nazionale forense.
Insomma,
sarà il giornale degli avvocati. Con quale obiettivo?
«La linea
politico-editoriale sarà quella dell'avvocatura, che si riassume così: i diritti
avanti a tutto. Si propone di spezzare il predominio di un pezzo della
magistratura sul mondo dell'informazione italiana e così anche la supremazia del
potere giudiziario su quello politico».
E questo
nome, Il dubbio?
«Fa
riferimento al ragionevole dubbio verso ogni accusato. Ai diritti della difesa,
che sono il fondamento dello stato di diritto. Da noi gran parte della stampa è
giustizialista, amplifica le accuse, gli avvisi di garanzia, gli arresti e
quando poi gran parte dei processi finisce con l'assoluzione, si scrive che è
stata negata la giustizia e non c'è un colpevole. Se si sostengono le ragioni
della difesa si passa per complici, così spesso vengono considerati gli avvocati
di un accusato. Questa etica della colpevolezza va contrastata».
Sarà un
nuovo Garantista?
«Sarà un
quotidiano apertissimo, in cui parleranno tutti. Non sarà né con il governo né
con l'opposizione, né di destra né di sinistra, né con Renzi né con Berlusconi.
Aperto al dialogo, su tutto e con tutti».
Però,
diciamolo, sarà un giornale contro le toghe.
«No, perché ce
ne sono di ottime e noi vogliamo fare un giornalismo senza risse e insulti,
beneducato. Contro il giustizialismo, sì. Contro quella parte forcaiola dei
magistrati e della stampa, sì. Contro quel potere politico in ginocchio davanti
alla magistratura, sì».
Che ne dici
dell'uscita critica di Renzi sulle lentezze dei magistrati, dopo il caso Guidi,
cui ha replicato l'Anm Basilicata?
«Un'uscita
coraggiosa, perché è raro che un politico osi sfidare le toghe. È vero che si
comincia con le accuse e non si arriva mai ai processi. Non hanno interesse a
celebrarli i magistrati stessi. Altro che accuse agli avvocati sulla
prescrizione: nel 70 per cento dei casi interviene in fase di indagini
preliminari, quando la difesa non ha certo potuto ritardare l'iter. I guai
dipendono dai tempi lunghi della giustizia. Ma quando Renzi l'ha detto,
immediatamente l'Anm ha reagito. Perché è una forza politica, polemizza col
governo, interviene sulle leggi da fare e come, mette in discussione
continuamente l'equilibrio tra i poteri. È impressionante. In questo scambio di
battute c'è il riassunto della follia che è oggi la giustizia».
Serve la
famosa riforma.
«Non la fa
nessuno. Non l'ha fatta Berlusconi, non la fa Renzi. E l'opinione pubblica viene
spinta dal sistema dell'informazione sempre dalla parte della pena e della
forca. Così, anche i diritti alla privacy scompaiono».
In prima
pagina ci sono Panama papers e intercettazioni dello scandalo petrolio.
«E qualcuno si
chiede se la fuga di notizie sui conti off-shore sia legale? Nessuno. O se lo
siano le intercettazioni della Guidi (che ha fatto benissimo a dimettersi,
beninteso) e degli altri? Nessuno. Chi si pone la questione che in Italia ci
siano mille volte più intercettazioni che in Gran Bretagna? Il rispetto delle
regole, il diritto alla difesa, non interessa nessuno».
Piero
Sansonetti lancia "Il Dubbio": "Non è un giornale contro i magistrati ma contro
il giustizialismo e per i diritti", scrive Laura Eduati su L'Huffington Post il
07/04/2016. Un giornale garantista e battagliero in difesa dei diritti, senza
padroni politici. Piero Sansonetti lancia "Il Dubbio", il quotidiano che ha come
editrice unica la Fondazione dell'Avvocatura Italiana del Consiglio Nazionale
Forense e che sarà in edicola e online dal 12 aprile. "Saremo la testata di
riferimento per coloro che vorranno comprendere le ragioni della difesa e non
soltanto quelle dell'accusa, ma non per questo saremo ossessionati dalla
perfidia dei magistrati. Tanto è vero che ho invitato all'inaugurazione anche il
procuratore Pignatone", spiega un po' scherzosamente l'ex cronista politico
dell'Unità, già direttore di Liberazione, di Calabria Ora e del Garantista con
la parentesi del settimanale Gli Altri. La squadra dei giornalisti è pronta. Le
firme del politico e della cronaca giudiziaria comprendono l'ex notista storico
del Messaggero Carlo Fusi, Davide Varì (ex vicedirettore di Calabria Ora) ed
Enrico Novi (Indipendente, Liberal). Per il momento non esiste un vicedirettore,
il ruolo di caporedattore centrale è affidato ad Angela Azzaro che dai tempi
di Liberazione fa parte dei cronisti di fiducia di Sansonetti. Sono già 45mila
gli abbonamenti attivati dagli avvocati in tutta Italia. Dodici le città dove
sarà possibile trovare la versione cartacea: Roma, Milano, Torino, Genova,
Padova, Venezia, Bologna, Bari, Napoli, Firenze, Pescara, Ancona. Un progetto
ambizioso: 16 pagine a colori e un contenuto generalista che troverà nella
politica e nella giustizia l'osso da mordere. L'obiettivo, spiega Sansonetti,
non è tanto criticare l'operato della magistratura quanto "mettere in
discussione la mentalità di un'Italia giustizialista che ritiene l'indagato
immediatamente colpevole, trova giusta la pubblicazione delle intercettazioni
private di Federica Guidi e scende in piazza per manifestare contro i giudici
che hanno assolto i geologi processati per il terremoto dell'Aquila". "Perché
agli italiani piacciono i processi di piazza", argomenta, "ma dimenticano che
dei 4500 politici indagati per Tangentopoli ne sono stati condannati 800:
moltissimi, anzi, troppi. Dobbiamo ricordare però che gli altri 3700 sono
innocenti". C'è un altro esempio che Sansonetti ama citare per spiegare il clima
contro il quale vorrebbe scrivere e fare cultura: il processo Cucchi. Gli agenti
della polizia penitenziaria assolti in Cassazione eppure per anni additati come
colpevoli: "Ora sono sotto inchiesta dei carabinieri per pestaggio. E' evidente
che qualcuno dovrebbe chiedere scusa ai poliziotti". "La colpa di questa
mentalità è più dei giornali che dei pubblici ministeri", osserva
Sansonetti. "Il numero delle assoluzioni in realtà è altissimo e sono sicuro che
molti magistrati la pensano come noi". A proposito della percezione che in
realtà la macchina della giustizia sia lenta e non vi sia la certezza della
pena, il direttore del "Dubbio" si trova quasi d'accordo ma con una precisazione
statistica che rovescia in parte la credenza popolare: "Spesso si dice che per
colpa della prescrizione i colpevoli non sono condannati. La verità è che il 70%
delle prescrizioni avviene durante le indagini preliminari perciò non possiamo
addossare la colpa della mancanza di giustizia agli avvocati, come se facessero
di tutto per allungare i tempi". Da anni la battaglia di Sansonetti si concentra
sulle storture dei processi. Non a caso il suo nuovo quotidiano prende il nome
dall'articolo del codice penale secondo il quale il giudice deve condannare se
ritiene l'imputato colpevole "oltre ogni ragionevole dubbio". Purtroppo,
osserva, le condanne arrivano anche quando questo dubbio esiste ed è fondato:
"Prendiamo Alberto Stasi. Il fatto che fosse stato assolto due volte doveva
scalfire la certezza della sua colpevolezza. E invece si trova in prigione dopo
l'ultimo passo alla Cassazione". Perché il pallino è la riforma della giustizia:
"Sarei per eliminare l'appello se in primo grado ti assolvono. E naturalmente
per la riforma delle carriere e in generale uno sveltimento dei procedimenti
giudiziari per evitare di celebrare un processo anche otto anni dopo il fatto".
Ma il governo è "timoroso": "Purtroppo nessuno è riuscito a far passare questa
riforma e penso che nemmeno Andrea Orlando ce la farà, il potere della
magistratura è ancora troppo forte. Matteo Renzi è un garantista timoroso.
Ricordiamoci che è probabilmente il primo premier a non godere dell'immunità
parlamentare, ciò significa che potrebbero arrestarlo senza passare dal
Parlamento". Dopo la politica e la giustizia, "Il Dubbio" avrà una seconda
missione: i diritti. "La nostra idea è che i diritti sociali e civili non
possono essere influenzati dal mercato". A chi pensa che Sansonetti stia
tornando al suo alveo politico originario (il Pci), arriva immediata la
precisazione: "Il Dubbio non sarà un quotidiano anti-mercato, così come nemmeno
io lo sono. Ma il mercato non può governare la società, a meno che non si
vogliano schiacciare i diritti fondamentali e quelli acquisiti negli ultimi
decenni in Occidente".
Davigo:
corrompiamo la corruzione.
Piercamillo
Davigo eletto presidente dell'Associazione nazionale magistrati. Riproponiamo
l'intervista su “Dirigente" il 9 aprile 2016 fatta con lui, pubblicata sul
numero di settembre della rivista Dirigente, sui temi della corruzione, della
giustizia e del ruolo della politica e dei cittadini per far cambiare le cose.
Piercamillo Davigo, ex pm di Mani Pulite, è stato eletto oggi alla presidenza
dell'Associazione nazionale magistrati (ANM). Davigo guiderà una giunta alla
quale partecipano tutte le correnti della magistratura e resterà in carica per
un anno.
L’Italia ha
tanti mali, ma quello forse più diffuso ed endemico è la corruzione. Esiste una
spiegazione?
«Secondo gli
indici di percezione della corruzione, l’Italia è collocata nelle peggiori
posizioni in Europa. Le ragioni sono da ricercare nel fatto che, dopo quanto era
emerso negli anni dal 1992 al 1995 il mondo politico, anziché cercare di
contenere la corruzione, ha cercato di contenere le indagini e i processi».
La
corruzione tra l’altro è il principale freno a una crescita strutturale e
duratura a livello economico e sociale, perché annichilisce il merito, falsa la
concorrenza sana e premia i peggiori. Come possiamo combatterla e vincerla?
«Ci sono molti
esempi storici, ma anche contemporanei, di paesi che hanno combattuto la
corruzione con efficacia: fra gli altri la Gran Bretagna di fine Settecento e in
epoca attuale Singapore. I rimedi sono relativamente semplici dal punto di vista
tecnico, in Italia probabilmente inattuabili per la resistenza della politica e,
temo, delle imprese. È necessaria un’effettiva trasparenza contabile nelle
imprese, il che implica un efficace contrasto anche all’evasione fiscale, e la
previsione di operazioni sotto copertura in materia di corruzione e turbativa
d’asta. Le operazioni sotto copertura sono previste in Italia per settori quali
terrorismo, crimine organizzato, traffico di stupefacenti e di armi,
pedopornografia e consistono nel fatto che ufficiali di polizia giudiziaria –
Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza eccetera – agiscono sotto mentite
spoglie. Negli Usa chiamano operazioni come queste test di integrità. Mi è stato
detto che è troppo difficile fare indagini sulla corruzione e che loro, dopo le
elezioni, mandano agenti sotto copertura a offrire denaro agli eletti: coloro
che lo accettano vengono arrestati. A ogni elezione ripuliscono la classe
politica».
Qual è il
ruolo della politica, potere esecutivo e legislativo?
«La politica
dovrebbe preoccuparsi di ricondurre il fenomeno a livelli fisiologici e
soprattutto far scattare meccanismi rigorosi di selezione del personale politico
e amministrativo, allontanando coloro che non tengono comportamenti
trasparenti».
E quale
quello del potere giudiziario?
«Il sistema
giudiziario è stato l’unica forza che ha tentato di contenere la corruzione, con
scarsi esiti, stante la crisi in cui si dibatte per una domanda di giustizia
patologica che non ha equivalenti in altri paesi».
E i
cittadini e la società quale ruolo hanno e cosa dovrebbero fare?
«Informarsi e
indignarsi. Quando la reazione dell’opinione pubblica è forte, la politica
adotta comunque provvedimenti. Il cosiddetto Parlamento degli inquisiti, quello
in carica fra il 1992 e il 1994, ha abolito l’autorizzazione a procedere a
fronte dell’indignazione dell’opinione pubblica».
Noi da anni
riceviamo richieste a gran voce dai nostri manager di fare qualcosa per
combattere la corruzione. Qual è il ruolo di imprenditori e manager che hanno
maggiori responsabilità degli altri lavoratori?
«Rifiutarsi di
sottostare a richieste corruttive. Purtroppo per anni molte imprese che hanno
rapporti prevalenti con le pubbliche amministrazioni si sono difese dicendo di
essere concusse, anziché denunziare le richieste, anche quando le loro
dimensioni e la loro influenza le ponevano al riparo da rappresaglie».
Lei pensa
che ci siano speranze che si risalga dagli infimi livelli nei quali siamo
relegati nella classifica sulla corruzione a livello mondiale?
«Basta volerlo
fare».
Cosa c’è
nei paesi più virtuosi che permette di relegare la corruzione a livello
fisiologico?
«Nel suo bel
volume Atlante della corruzione, Alberto Vannucci, docente di Scienza della
politica all’Università di Pisa, cita un’interessante ricerca: fino ad alcuni
anni fa i diplomatici degli stati accreditati all’Onu godevano di una totale
immunità, che si estendeva anche alle violazioni del divieto di sosta.
Verificando i verbali restituiti alla Città di New York, si sono classificati i
comportamenti dei diplomatici dei vari Stati. La sorpresa è stata che la
classifica corrisponde agli indici di percezione della corruzione. I diplomatici
dei paesi scandinavi non avevano neppure una violazione a testa. Anche senza
sanzioni rispettano la legge. Evidentemente il miglior antidoto è il senso
civico».
Tra
l’altro, la corruzione è figlia dell’evasione, che serve per fare i soldi in
nero per corrompere. Insomma, un cane che si morde la coda?
«La cosa che
trovo davvero curiosa è che in Italia a ogni annuncio di lotta all’evasione
fiscale segue un condono fiscale o una riduzione delle sanzioni penali. Capisco
che non è pensabile processare milioni di evasori, ma il condono è un potente
incentivo all’evasione».
Cosa fare
per non continuare ad evadere il problema dell’evasione?
«Basterebbe
usare gli stessi strumenti affinati nelle misure di prevenzione, soprattutto
antimafia, la confisca dei beni di cui un soggetto abbia la disponibilità anche
per interposta persona, non compatibili con i redditi dichiarati».
I giudici,
nelle loro varie funzioni, sono anche un po’ manager?
«C’è una
deriva aziendalista in magistratura che non condivido. Si cerca di fronteggiare
la domanda patologica con incrementi di produzione. Peraltro ogni incremento di
efficienza determina nuova domanda di giustizia che la riassorbe, però si
rischia di abbassare la qualità delle decisioni».
Cosa pensa
dei manager, di quelli privati che in un’Italia fatta di tantissime imprese a
gestione familiare, scarseggiano?
«Il
capitalismo a gestione familiare talvolta privilegia la fedeltà ai soci di
maggioranza piuttosto che la fedeltà alla società. Tuttavia ci sono ottimi
manager».
E della
dirigenza pubblica, della quale fate parte anche voi giudici? La “burocrazia”,
nel senso nobile, dovrebbe essere l’ossatura dell’apparato statale, ma noi forse
soffriamo di “osteoporosi” a questo livello?
«Lo Stato
italiano non ha una élite amministrativa paragonabile all’amministrazione
francese o al Civil Service Britannico. Una delle ragioni è che spesso i
dirigenti devono il loro posto non solo alla loro capacità, ma anche alla
protezione di qualche politico. In magistratura questo fenomeno è meno presente.
Naturalmente ci sono anche ottimi manager pubblici».
Non le pare
che oggi in Italia troppi non svolgano appieno il loro ruolo tra i canonici
poteri, nelle organizzazioni politiche e nei corpi intermedi?
«Certamente la
passività rispetto a determinati comportamenti è inquietante. Rivendico alla mia
categoria di aver trattato con fermezza i comportamenti devianti. I magistrati
corrotti, quando scoperti, vengono arrestati e comunque si crea il vuoto intorno
a loro. Altrove questo non sempre accade».
Anche noi
cittadini italiani siamo un po’ troppo passivi?
«Certamente.
Serve, come dicevo, informazione e indignazione. Invece di solito si scade nel
qualunquismo. Quando qualcuno mi dice che rubano tutti, gli chiedo se ruba anche
lui. Siccome mi dice di no, gli rispondo “Neanche io. Come vede, non è vero che
rubano tutti”. Occorre saper distinguere e prendere le distanze da chi ruba,
anche se è della nostra parte politica, soprattutto se è della nostra parte
politica».
Come valuta
oggi la giustizia in Italia, cosa va migliorato e, se ci sono colpe, quali sono?
«Un carico di
lavoro eccessivo che non ha equivalenti in altri paesi. Occorre introdurre serie
deterrenze che scoraggino dall’agire o resistere indebitamente in giudizio. Le
colpe altrui non le valuto, quella dei magistrati è stata di non contrastare
l’idea che si potesse risolvere il problema solo dal lato dell’offerta di
giustizia e non anche da quello della domanda. L’eccesso della domanda di
giustizia dipende anche dal fatto che in Italia è molto più tutelato chi viola
la legge, rispetto a chi subisce le violazioni altrui».
Giustizia e
politica: quale deve essere il rapporto? E cosa pensa degli uomini di Giustizia
che scendono in politica?
«Dovrebbe
esserci rispetto reciproco. A mio giudizio i magistrati non devono dedicarsi
alla politica solo quando vanno a votare».
Guardando
l’Italia tra dieci anni, come la vede?
«Di tutte le
attività umane quella del profeta è la più difficile e costantemente a rischio
di smentite».
Cosa farà
da grande?
«Il
pensionato».
Tra Vangelo
e toghe con l’elmetto, il ritorno della “dottrina Davigo”,
scrive Mario Ajello su “Il Messaggero” l’11 aprile 2016. Anche Torquemada diceva
di ispirarsi al Vangelo. Ora comunque c’è Piercamillo Davigo («Il sì sia sì, il
no sia no», c’è scritto sul biglietto da visita del nuovo presidente dell’Anm) e
più che alla grande storia il tutto sembra appartenere al vintage. Dopo un
quarto di secolo da Mani pulite di cui egli fu proverbialmente il Dottor Sottile
nel pool milanese, anche se non sempre sembra amare le sottigliezze, riguardo a
Davigo viene da pensare a Lucio Battisti: «Ancora tu, non dovevamo vederci
più?». Tra revival e remake, il «non esistono innocenti ma soltanto colpevoli
ancora da scovare» - mantra del giudice di Cassazione diventato capo
sindacalista - rappresenta il riassunto di un assolutismo etico e di un’eterna
religione morale di cui il personaggio è sempre voluto essere il simbolo senza
mediazioni o sfumature. «Dopo Tangentopoli», ecco la dottrina Davigo, «i
politici non hanno smesso di rubare, hanno soltanto smesso di vergognarsi».
Insomma, l’Onestà non può che peggiorare nel Paese dei Disonesti, agli occhi di
questa toga super-combat per il quale la guerra non finisce mai e guai a
togliersi la mimetica: «È giusto che ci sia tensione tra potere politico e
giudiziario». Se gli si dice che è un pessimista, Davigo - che vede la
“devianza” in ogni anfratto e in ogni posto di potere - condivide la
definizione: «Il pessimista - così ha spiegato - è quello che pensa che peggio
non possa andare, mentre l’ottimista è convinto che possa andare peggio». A un
tipo così, guai a parlargli di riformismo: «L’unica riforma non inutile della
giustizia è che lo Stato smetta di favorire i colpevoli». Le manette dovrebbero
tintinnare di più: «Ma purtroppo la politica da più di 20 anni è più impegnata a
contenere l’attività degli organi preposti alla repressione piuttosto che a
colpire le devianze delle classi dirigenti». Quanto alla presunzione
d’innocenza, la pensa così: «I politici che delinquono vanno mandati a casa
senza il bisogno di attendere il giudizio definitivo di un giudice». Un
Incorruttibile come Robespierre, il Maximilien Piercamillo? Il suo mito è
l’America: «Lì sì che sono organizzati. Il processo è basato non sulle esigenze
dell’imputato e del difensore, come in Italia, ma su quelle del poliziotto». E
lui poliziotto si sente, o meglio un «militare»: «Come i militari, noi giudici
usiamo la forza. Ci sentiamo dei guerrieri, non dei sacerdoti». Le due funzioni
in lui - «Un giustizialista io? Il giustizialismo non esiste» - in realtà
convivono. E questo mix produce letizia francescana nei suoi ricchi ammiratori,
come Gad Lerner: «Sono stato a casa sua e mi ha colpito la sua (dignitosissima)
modestia: buon segno, in bocca al lupo!». I grillini lo adorano e lui ricambia
partecipando alla Notte dell’Onestà (gennaio 2015) e un suo intervento sul blog
di Grillo entusiasmò quella platea. Egli non fa differenza tra destra e
sinistra: «Le cose peggiori, quelle devastanti, le fanno insieme».
PM a caccia
di reati,
scrive Massimo Bordin il 12 Aprile 2016 su “Il Foglio”. Se Antonio Di Pietro era
il bulldozer, Piercamillo Davigo nel pool Mani pulite era il rifinitore, il
giurista, “il dottor sottile”, insieme a Gherardo Colombo. L’irruenza
dell’inquisitore molisano esigeva infatti il raddoppio della marcatura. Dunque
nelle interviste diciamo così di presentazione del nuovo presidente dell’Anm
bisogna calcolare e pesare i termini usati. Sul Corriere della Sera di sabato
una frase colpisce. Sulle intercettazioni: “Se i reati spuntassero nei prati
come le margherite, il nostro lavoro sarebbe molto più semplice”. La parola
chiave è “reati”. Avesse detto “prove” non ci sarebbe nulla da obiettare. Anzi,
bella l’immagine del pm che si inoltra nel prato per cogliere facilmente le
prove-margherite. Sarebbe bello e i tempi della giustizia ne avrebbero
giovamento. Non è comunque così, d’accordo, fermo restando che l’accusatore deve
comunque partire da un’ipotesi di reato e poi cercare le prove. L’ipotesi di
reato è il prato, le prove sono le margherite. Altrimenti il prato diventa
un’altra cosa, un ambiente, una comunità, un’istituzione nella quale il pm
scruta alla ricerca di un’ipotesi di reato da formulare. Si chiama in gergo
“controllo di legalità”. Si può obiettare che non è un compito da magistrati, se
mai da poliziotti, da intelligence, e con le dovute cautele e garanzie se no si
rischierebbe uno “stato di polizia” come quello di certi regimi militari. Ma è
una obiezione che è meglio non fare al dottore Davigo. Potrebbe dire, come ha
fatto due anni fa, che secondo lui chi aveva fatto l’obiettore alla leva non
avrebbe dovuto poter accedere alla magistratura.
La toga che
vuole l'Italia pura non usa l'incenso ma le manette.
Da Mani pulite in poi il presidente dell'Anm ha un unico credo: non esistono
innocenti, solo colpevoli da incastrare a tutti i costi, scrive Stefano Zurlo,
Lunedì 18/04/2016, su "Il Giornale". Le sue massime, poco importa se vere o
verosimili, costituiscono ormai un genere letterario. E sono un metronomo
dell'Italia da Mani pulite in poi. Piercamillo Davigo sta tutto in quelle
parole, sempre in bilico fra suggestione e provocazione: «In Italia non ci sono
troppi detenuti, ma troppe poche carceri». Una grammatica chiara: molti arresti,
pene alte, zero pietà. Più detenuti e meno gente in giro. Il magistrato lombardo
è in prima linea da una vita e non ha mai cambiato il suo metro di giudizio.
Così tutti gli appiopparono una frase che in realtà fu pronunciata per la prima
volta da Giuliano Ferrara: «Rivolteremo l'Italia come un calzino». Battuta
disconosciuta e però perfettamente calzante sul Davigo-pensiero. Sempre un metro
avanti, sempre paradossale, sempre urticante e spiazzante. Era così ai tempi del
Pool, quando gli fu attribuito un altro adagio - in compartecipazione con Marco
Travaglio, come ha annotato sulla Stampa Mattia Feltri - «non ci sono innocenti,
ma colpevoli ancora da scoprire». Oggi, vent'anni e passa dopo, non è più pm ma
giudice, non è più a Milano ma a Roma, non sta più in tribunale ma in
Cassazione. E però tutti questi sono dettagli, la sostanza è immutata. Quando
c'è da polemizzare lui non si tira indietro, sempre sicuro di sé, con la sua
visione dell'universo in bianco e nero. Senza tante sfumature. Così se Renzi
accusa i pm di Potenza perché non arrivano a sentenza, toccando uno dei tanti
nervi scoperti dell'azione giudiziaria, lui replica tranchant: «È colpa della
prescrizione». Una spiegazione che fa felici girotondini, grillini e
giustizialisti doc, ma che convince solo a metà. «La verità - spiega al Giornale
un collega di Davigo - è che le cause di questa lentezza sono molteplici, ma un
aspetto non può essere trascurato, anche se non se ne parla mai: ci sono pm che
vogliono fare le inchieste, ma non i processi. In aula, a dibattimento, mandano
magari un collega che non sa nulla di quello che è successo in precedenza e che
deve ricominciare da capo». Davigo non coltiva questo dubbio o non lo manifesta.
È troppo innamorato di se stesso e impegnato a difendere il ruolo, anzi la
missione che la legge gli ha affidato. A maggior ragione adesso che è diventato
il potente presidente dell'Associazione nazionale magistrati, il temuto
sindacato delle toghe tricolori. Dal palco della sua notorietà, il magistrato
cita come esempio di inchiesta addirittura eroica quella su Abu Omar e i servizi
segreti che a suo tempo aveva provocato scintille fra poteri e fra l'Italia e
gli Usa. No, lui va dritto per la sua strada e tributa la standing ovation ad
Armando Spataro, altro peso massimo della magistratura italiana, oggi
procuratore a Torino. Allo stesso modo taglia con un colpo solo nodi
aggrovigliati da un quarto di secolo. Interviene a gamba tesa sulle
intercettazioni, oggetto di una querelle interminabile, più lunga di Beautiful.
«È sufficiente - è la presa di posizione, disarmante, del neopresidente dell'Anm
- la legge sulla diffamazione. Il resto è superfluo». Dove, oltre allo snobismo
di chi neanche prende in considerazione le questioni sollevate da più parti,
quel che conta è il non detto, per lui sottinteso: quando si captano con cimici
e microspie le conversazioni altrui non serve fare gli schizzinosi.
L'intercettazione è come il maiale: non si butta via niente. Quando l'ormai ex
ministra Federica Guidi dice al fidanzato: «Mi hai trattato come una sguattera
del Guatemala», e quelle parole così private e intime finiscono in pasto sulla
tavola di milioni di italiani, quella per lui non è una violazione possibile
della privacy, ma la spia di una relazione che interessa molto al magistrato,
perché potrebbe illuminare il reato su cui s'indaga, in quel caso il traffico di
influenze, lo sciagurato illecito introdotto qualche anno fa nel nostro codice.
Conclusione: quelle parole possono essere divulgate senza problemi perché
aiutano a dipanare la rete criminale. Certo, i politici s'inalberano e parlano
un giorno sì e l'altro pure di invasione di campo. Lui li lascia strepitare e di
fatto replica riproponendo sempre lo stesso concetto: i giudici applicano le
norme che i partiti hanno scritto. Se quelle leggi non vanno bene, basta
riscriverle. Dove il non detto questa volta è lo scalino, alto, che separa i
giudici dal Palazzo. I magistrati, nella concezione aristocratica del Pool,
hanno il compito di purificare la società. Manca l'incenso, ma ci sono le
manette. E c'è la corazza foderata con l'acciaio dell'autostima di chi si
ritiene parte di un'élite che non deve chiedere permessi o lasciapassare a
nessuno. Da questo punto di vista se Di Pietro era un super poliziotto, Davigo è
il magistrato più magistrato che sia mai passato nella cittadella di Porta
Vittoria. Attenzione: tirare in ballo le toghe rosse o quelle azzurre sarebbe
fuorviante. La sacralità della toga non ha nulla a che fare con le categorie
della destra o della sinistra; no, la toga, secondo questo schema, sta da
un'altra parte, più in alto. E non deve contaminarsi con queste dinamiche. Per
la cronaca Davigo non è mai stato di sinistra; di sinistra nel Pool era Gherardo
Colombo che poi ha lasciato la magistratura, è entrato nel cda della Rai ed è
arrivato fino quasi a candidarsi a Milano come sindaco per la sinistra radicale.
Davigo semmai era ed è di destra, ma la sua destra non si trova nella geografia
del Palazzo. I suoi riferimenti sono lontani nel tempo: Cavour, il barone
Ricasoli, la scrivania di Quintino Sella. È la destra storica, zero chiacchiere
e tanto rigore. Mito più che realtà. E però per lui che è nato a Candia
Lomellina, Lombardia piatta come un'ostia che un tempo era agganciata al
Piemonte sabaudo, lo Stato dev'essere puro e smacchiato come un vestito,
inflessibile con chi lo svilisce. L'unica ambizione di chi ne fa parte, dal
magistrato al burocrate fino al funzionario, è quella di indossare la giubba del
re, insomma dimostrare zelo e fedeltà. Fino a farne un programma di vita e il
titolo di un saggio sulla corruzione. Se Di Pietro attaccava i Craxi e i Forlani
con la bava alla bocca, il pane di Davigo, nella stagione gloriosa del Pool,
erano i finanzieri che si erano venduti. È lui a contestare per la prima volta
l'associazione a delinquere ai militari colti con le mani nel sacco e a
perquisire il Comando generale in viale XXI Aprile a Roma. Una profanazione.
Secondo lui un atto necessario per un Corpo che dovrebbe essere immacolato.
Torniamo sempre lì: estirpare il male, al fonte battesimale delle procure. E
colpire le amnesie e le titubanze dei governi, Berlusconi o Renzi non fa
differenza. Così Davigo bolla il nuovo presidente del Consiglio: definisce
l'esecutivo «poco dialogante», liquida con una punta di fastidio l'uscita sulle
troppe ferie dei magistrati. E, conversando con Repubblica, invoca gli agenti
sotto copertura ammirati negli Usa dove ha scoperto i test di integrità:
poliziotti coperti che offrono denaro ai politici: «Chi lo accettava veniva
arrestato». Un modello che lui porterebbe subito in Italia.
Adesso che
Davigo è capo dell’Anm posso smettere di comprare Topolino.
Tangentopoli come Paperopoli e Topolinia: un classico Disney, scrive Guido
Vitiello il 16 Aprile 2016 su “Il Foglio”. Rassegniamoci stoicamente a chiamarla
Tangentopoli perché, come si dice, il destino guida chi lo asseconda ma trascina
a forza i riluttanti. Per anni ho aggirato quella detestabile formula
giornalistica, ricorrendo a tutte le perifrasi e le circonlocuzioni del caso, ma
è arrivato il momento di capitolare. Quanto più il 1992 si allontana nel tempo,
tanto più cresce il vizio di leggere i problemi della giustizia e della
corruzione alla luce non già dei grandi classici del pensiero politico ma dei
Grandi Classici Disney. Tangentopoli si è aggiunta ormai alle due capitali di
quel regno di fantasia, Paperopoli e Topolinia, dove s’incontrano personaggi
come il commissario Basettoni, l’ispettore Manetta, la Banda Bassotti e
l’avvocato Cavillo Busillis. Niente di nuovo, si potrà obiettare, ci sono
disneyani di lungo corso – Travaglio con i suoi monologhi teatrali tanto amati
dalle scolaresche, l’ex magistrato Bruno Tinti che invocava tempo fa un “partito
delle guardie” nel paese dei ladri – ma lo spirito dei fumetti vive in questi
giorni la sua grande rivincita. E’ stata una settimana campale per il
fanciullino che alberga in me. Mercoledì ho preso in edicola il nuovo numero di
Topolino. Venerdì, su Repubblica, ho letto un editoriale di Stefano Rodotà che
si apriva recuperando l’“Apologo sull’onestà nel paese dei corrotti” – una
fantasia un po’ bolsa da maestro elementare dove Italo Calvino, nel 1980,
descriveva una società retta dal malaffare al cui margine resiste una
“controsocietà degli onesti” – e si chiudeva biasimando chi se la prende con la
magistratura e i moralisti, “quasi che insistere sull’etica pubblica fosse un
attacco alla politica e non la via per la sua rigenerazione”. L’ipotesi che
qualcuno possa aver da ridire sull’azione dei magistrati in nome di quella
stessa etica pubblica non arrivava a turbare la semplicità gioconda dello schema
di Rodotà – e dire che perfino nell’apologo di Calvino, a leggerlo bene, c’erano
spunti per un ragionamento meno paperopolitano. Passa appena un giorno, e il 9
aprile Piercamillo Davigo diventa presidente dell’Anm. Ora, devo confessare che
Davigo ha da sempre, ai miei occhi, il fascino degli eroi dell’infanzia. Sarà
per quel suo bel faccione da bebé, tra Elmer Fudd e Ciccio di Nonna Papera; sarà
perché l’anno scorso ha aderito alla Disneyland politica della “Notte
dell’Onestà” grillina; sarà perché il suo epiteto di Dottor Sottile, fatte salve
le competenze giuridiche, riesco a spiegarmelo solo in una logica da fumetto, la
stessa per cui, poniamo, un camionista di tre quintali è soprannominato lo
Smilzo. La visione del mondo di Davigo, ribadita in mille apparizioni
televisive, non mi pare proprio un esempio di sottigliezza: è quella del
magistrato come buon padre di famiglia che dà uno scappellotto al figlio che ha
rubato la marmellata. Più o meno la stessa filosofia di una canzone che
ascoltavo da bambino, Johnny Bassotto (“Che poliziotto Johnny Bassotto, con le
manette arresta la tua fantasia; ti fa svegliare e confessare tutto quel che hai
combinato, tu da solo o in compagnia”; e ha anche “un pappagallo che gli fa da
radiospia”). Davigo d’altronde è uomo di spirito, e un paio d’anni fa, nella
prefazione a un libro di Enzo Beretta, “Favole alla sbarra. Processo ai buoni e
ai cattivi dei cartoni animati”, si chiedeva: “Che ne sarà di soggetti come il
Gatto e la Volpe? E la condotta del Grillo parlante è lineare? In Biancaneve i
sette nani sono simpatici, ma bisognerà pure porsi delle domande sulla liceità
della costruzione della loro casetta nel bosco”. Ora che Davigo è presidente
dell’Anm, il dibattito sulla giustizia riguadagnerà la magia dei fumetti. Già
gli ho sentito dire che lo scontro tra magistratura e politica finirà quando i
politici smetteranno di rubare, che in fondo un’intercettazione è come una
chiacchierata in un bar, che solo chi ha la coscienza sporca scappa alla vista
della polizia, che chi non ha nulla da nascondere non teme di essere
intercettato, che “male non fare paura non avere”. E siamo solo al 13 aprile.
Potrò smettere di comprare Topolino.
Di nuovo il
dott. Stranamore (ovvero Pier Camillo Davigo).
Ciao Direttore, qui nell’aldilà dove possiamo passare il tempo a contemplare,
abbiamo un punto di vista su quello che accade nel mondo terreno un po’ diverso
dal vostro ed io che ancora vi voglio bene, amo darvi qualche spunto perché
sempre di più temo che la vostra libertà di pensiero e non solo, venga offuscata
dalle necessità. Orbene, non ditemi che vi è sfuggita la nomina di Pier Camillo
Davigo alla Presidenza della Associazione Nazionale Magistrati, ANM. Se non è
così, sbagliate a non replicare con forza pensando che il problema riguardi solo
Renzi. Renzi non sta simpatico nemmeno a me, non foss’altro che ha candidato
Sindaco quel pesce freddo lesso di Beppe Sala per il vostro Comune, ma non è
questo il punto. Davigo è stato messo su quella poltrona in ragione di tre fatti
che hanno rilievo per la prosecuzione della vostra democrazia.
E’ stato
eletto, direttamente o indirettamente poco importa, dagli stessi che hanno
voluto il colpo di stato noto alle cronache giornalistiche come “mani pulite”.
E’ stato
eletto per dare successo definitivo a quel processo eversivo che ha come
obiettivo l’elezione della magistratura a potere statuale principale e
sovraordinato agli altri, perché sovrasti e controlli con strumenti dittatoriali
il paese, per favorire interessi stranieri.
E’ stato
eletto perché possiate continuare a non capire di cosa parlavano Falcone e
Borsellino quando si riferivano al terzo livello.
Non lo penso
solo io che sono qui da secoli, ma come me ne parlano Sandro, Enrico, Giovanni,
Ugo, Bettino, Giulio, Renato, Francesco, Carol e tanti altri (mi correggo, sono
tanti ma non sono altri) che lì da voi hanno avuto un ruolo e che conoscono i
fatti che riguardano l’Italia moderna e contemporanea. Il vostro Davigo, novello
Stranamore, vorrebbe annullare la prescrizione dei reati dopo l’inizio dei
dibattimenti nei procedimenti penali. Significa che, mi conferma qui un noto
penalista papà di un pessimo Sindaco, che chiunque potrebbe rimanere anche 20 o
30 anni sotto processo ed in galera senza avere una sentenza ed a prescindere da
qualunque valutazione di merito sull’operato degli inquirenti e dei giudicanti.
Nemmeno ai tempi del Nazareno, quello nato a Betlemme, o a quelli di Socrate,
entrambi giudicati colpevoli dalla magistratura del tempo, vigevano simili
regole processuali.
Sempre
Stranamore ritiene che:
se i processi
durano troppo è colpa degli avvocati;
se le
intercettazioni prive di rilevanza penale vengono pubblicate è colpa dei
giornalisti;
se ci sono
troppe inchieste che finiscono nel nulla è perché si commettono troppi reati;
Ieri sera, a
questo proposito, ha litigato per davvero, ma educatamente, con paolino mieli
che a lungo negli anni ’90 sostenne lui e chi gli stava dietro. Forse
invecchiando anche paolino ha capito la cazzata che ha fatto. Lui è più
intelligente e capisce prima. Ma voi, quando vi svegliate? Concludo perche è
arrivato Ernest e vado a fami un drink: vi sono rimaste solo alcune aziende
competitive e poco altro sul piano economico. Ma avete ancora un popolo che
merita di conoscere la verità sulla propria storia prima di decidere del proprio
destino. Stranamore è tornato per impedirlo. Provvedete da soli o deve
ridiscendere il diluvio? Con affetto, Tommaso Campanella (Milano Post 13 aprile
2016)
Piercamillo
Davigo: “Renzi attacca i pm? Ma è la politica che non fa pulizia”.
Toghe e potere, il neopresidente dell'Anm replica al presidente del consiglio
che ha parlato di "barbarie giustizialista". "Giustizialismo? Una vecchia
storia, noi facciamo indagini e processi". L'inchiesta di Potenza e l'accusa di
"non arrivare mai a sentenza". "Che discorso è? Se intende lamentare un eccesso
di prescrizione, può modificare le norme", scrive Marco Travaglio il 20 aprile
2016 su "Il Fatto Quotidiano". Piercamillo Davigo, dopo l’inchiesta di Potenza
Renzi parla di “25 anni di barbarie giustizialista”, mentre Napolitano denuncia
un “riacutizzarsi” del conflitto politica-giustizia e invoca la riforma delle
intercettazioni.
«Non
commento le dichiarazioni del presidente del Consiglio. Ma è una vecchia storia,
questa del "giustizialismo" e del "conflitto". Non c’è nessuna guerra. Noi
facciamo indagini e processi. Se poi le persone coinvolte in base a prove e
indizi che dovrebbero indurre la politica e le istituzioni a rimuoverle in base
a un giudizio non penale, ma morale o di opportunità, vengono lasciate o
ricandidate o rinominate, è inevitabile che i processi abbiano effetti politici.
Se la politica usasse per le sue autonome valutazioni gli elementi che noi
usiamo per i giudizi penali e ne traesse le dovute conseguenze, processeremmo
degli ex. Senza conseguenze politiche».
Il
conflitto fra politica e magistratura è fisiologico?
«Le
frizioni fra poteri dello Stato sono la naturale conseguenza della loro
separatezza e indipendenza. Chi vuole che tutti i poteri vadano d’amore e
d’accordo dovrebbe proporre il ritorno alla monarchia assoluta, dove il sovrano
deteneva tutti i poteri senz’alcun conflitto: il re era sempre d’accordo con se
stesso. È questo che vogliono? Io, se non ci fosse tensione fra politica e
giustizia, mi preoccuperei».
Napolitano
e Renzi reclamano una legge che vi imponga di espungere dagli atti le
intercettazioni penalmente irrilevanti o riguardanti i non indagati, così i
giornali non potranno più pubblicarle.
«Non
ne vedo la necessità. Bastano e avanzano le norme sulla diffamazione e sulla
privacy, che puniscono chi mette in piazza fatti davvero privati e privi di
interesse pubblico: si possono sempre aumentare le pene, specie per la
violazione della privacy, ma poi si va a sbattere contro la giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, che sconsiglia lo strumento
penale contro la libertà di stampa. E, soprattutto, ha già affermato che, quando
un giornalista pubblica notizie anche penalmente irrilevanti, ma moralmente
importanti, su personaggi pubblici, non può essere punito».
Ma la legge
dice che dovete essere voi magistrati a cancellare dagli atti le conversazioni
extra-penali.
«A
parte il fatto che una conversazione può essere irrilevante ai fini del reato
per cui si procede e non di un altro per cui è comunque lecito procedere. Ma
poi, chi decide cosa mettere o togliere? Il pm? Il gip? E i diritti della difesa
chi li tutela? Mi meraviglia che questi discorsi vengano da chi sbandiera
garantismo un giorno sì e l’altro pure: ma lo sanno o no che ciò che è
irrilevante per il pm o per il giudice può essere rilevantissimo per il
difensore? Esempio: Tizio intercettato racconta una sua serata con un trans.
Tutti diranno: orrore, privacy, bruciare tutto! Già, e se poi quella serata col
trans serve a uno dei due interlocutori come alibi per provare che la sera di un
delitto erano altrove? Siccome l’alibi è stato distrutto, l’innocente rischia la
condanna. Bel garantismo».
A Potenza
si procede anche per traffico d’influenze illecite, reato istituito nel 2012 con
la Severino per punire chi usa amicizie o vicinanze con un pubblico ufficiale
per farsi dare soldi o altre utilità da chi vuole favori leciti o illeciti da
quest’ultimo.
«E
mica l’hanno scritta i giudici, quella legge. Era per ottemperare alla
Convenzione Ue anticorruzione, ratificata dall’Italia nel 1999 e mai attuata,
anche se forse bastava ritoccare le norme sul millantato credito. Non entro nei
processi in corso. Ma è ovvio che, per processare Tizio per la sua influenza su
Caio, e Caio, si debba verificare quali rapporti aveva con Caio».
Dicono: le
raccomandazioni son vecchie come il mondo.
«E
io rispondo: le raccomandazioni sono reato in tutta Europa, tant’è che la
Convenzione Ue ratificata da tutti gli Stati, buon’ultima l’Italia, prevede il
traffico d’influenze».
Violante
dice che le cronache politiche sembrano ormai mattinali di questura.
«Perché
processiamo gente abbarbicata alla poltrona, che nessuno si sogna di mandare a
casa malgrado condotte gravissime. Aspettano la Cassazione: Renzi ricorda la
presunzione d’innocenza, per lui conta solo la sentenza definitiva. Ma la
presunzione d’innocenza è un fatto interno al processo, non c’entra nulla coi
rapporti sociali e politici. Ha presente il professore universitario che faceva
sesso con le allieve, e sempre prima degli esami (e mai dopo, il che esclude che
fossero innamorate di lui)? L’hanno assolto e il preside s’è detto ansioso di
riaverlo in cattedra. Come se un fatto penalmente irrilevante non fosse
deontologicamente disdicevole. Ecco, i politici ragionano così».
Che
dovrebbero fare?
«Smetterla
di delegare ai magistrati la selezione delle classi dirigenti, e poi di
lamentarsi pure. Dicono: aspettiamo le sentenze. Poi, se arriva la condanna,
strillano. Se il mio vicino di casa è rinviato a giudizio per pedofilia, io mia
figlia di sei anni non gliel’affido quando vado a far la spesa. Poi, se verrà
scagionato, si vedrà. La giustizia è una virtù cardinale: ma anche la prudenza!
Tutti, al posto mio, si comporterebbero così. Perché ciò che vale nella vita
quotidiana non vale nel mondo politico-imprenditoriale?»
Appena è
esplosa l’inchiesta di Potenza, Renzi ha accusato la Procura di non arrivare mai
a sentenza.
«Ma
che discorso è? Tutte le inchieste arrivano a sentenza. Che può essere di
condanna, di assoluzione o di non doversi procedere per prescrizione. Se intende
lamentare un eccesso di prescrizione, può modificarne le norme».
Il governo
dice di averlo fatto almeno per la corruzione.
«In
realtà ha aumentato un po’ le pene, dunque ha un pochino allungato la
prescrizione. Ma il problema è rimasto pressoché inalterato: abbiamo una
prescrizione relativamente lunga prima che il reato venga scoperto, e
scandalosamente breve dal momento in cui iniziano le indagini. Per i reati
puniti fino a 6 anni, compresi molti contro la PA, è di 6 anni, prorogabile al
massimo fino a 7 anni e mezzo (dal giorno in cui il reato è stato commesso,
s’intende): se il delitto viene scoperto dopo 6 anni, restano 18 mesi per
indagini, udienza preliminare e tre gradi di giudizio. Le pare serio? Il nostro
sistema, dopo il dimezzamento dei termini causato dalla ex-Cirielli, è stato
dichiarato illegittimo dalla Corte di giustizia europea per le frodi
comunitarie, con l’invito ai giudici italiani a disapplicarlo. Così abbiamo un
doppio binario: i reati contro l’Ue non si prescrivono mai, tutti gli altri
quasi sempre. Basta una norma di una riga che sospenda la prescrizione col
rinvio a giudizio, o almeno con la prima sentenza: perché non la fanno?»
Renzi dice
che dovete lavorare di più.
«Mettere
in relazione la durata dei processi con l’accusa ai giudici di essere dei
fannulloni è un’offesa e una bugia. Segnalo i dati della Commissione del
Consiglio d’Europa sull’efficienza della giustizia: i giudici italiani, su 47
Stati membri, sono quelli che lavorano di più. Il doppio dei francesi e il
quadruplo dei tedeschi. Se i processi durano troppo è perché se ne fanno troppi
e con troppi gradi e fasi di giudizio. Invece di lanciare accuse infondate, i
politici facciano qualcosa per scoraggiare il contenzioso e i ricorsi, così
calerebbe il numero dei processi. E siano più severi con chi viola la legge e
più attenti ai diritti delle vittime, così calerebbero i reati».
Napolitano
vi chiede di “collaborare” con la politica.
«Se
collaborare vuol dire fornire un apporto tecnico, come fa per statuto il Csm,
alle leggi in discussione sulla giustizia, l’abbiamo sempre fatto. Poi però noi
magistrati facciamo un mestiere diverso: se prendiamo un politico che ruba,
dobbiamo processarlo. Non collaborare».
Come valuta
la deregulation renziana sui reati fiscali? Dal tetto alzato a 3 mila euro per i
pagamenti in contanti alle soglie più alte di non punibilità per l’evasione?
«Parlamento
e governo sono liberi di fare le leggi che vogliono. Anche di depenalizzare i
reati tributari, se l’Europa glielo permette. Ma non possono dire che così
combattono l’evasione fiscale».
L’inchiesta
di Potenza fa molto discutere anche perché, secondo alcuni, si rischia di
processare la tal legge, il tal emendamento, violando l’insindacabilità dei
parlamentari.
«Del
caso concreto non parlo. Ma, in linea di principio, la Costituzione tutela il
parlamentare nell’esercizio delle funzioni quando vota, non quando prende
mazzette o riceve favori per votare. In uno Stato di diritto, nessuno è al di
sopra della legge».
Renzi s’è
scandalizzato perché è stato intercettato il capo di Stato maggiore della
Marina, “mettendo a rischio la sicurezza nazionale”.
«Quand’ero
militare, mi insegnarono che è vietato trattare argomenti classificati al
telefono. Ergo, chi intercetta un militare non può mai violare alcun segreto:
semmai, accertare una violazione del segreto da parte di chi dovrebbe custodirlo».
Nota
differenze fra questo governo e quelli precedenti nel rapporto con la
magistratura e la legalità?
«Qualche
differenza di linguaggio, ma niente di più: nella sostanza, una certa allergia
al controllo di legalità accomuna un po’ tutti. Paolo Mieli mi ha detto che ho
sempre litigato con tutti i governi. Gli ho risposto che è un segno di
imparzialità. Sa, io ho subìto molti processi penali e non mi sono mai messo a
strillare: mi sono difeso nel processo. E sono sempre stato archiviato. Non
perché fossi un magistrato: perché ero innocente. Capisco che chi finisce
imputato non gradisca, ma chi ricopre cariche pubbliche non deve mai usarle per
tutelare i suoi interessi personali o per invocare trattamenti privilegiati».
Giuliano
Ferrara spera che lei sia un presidente Anm così forte e rappresentativo da
firmare la pace con la politica. Come l’israeliano Begin con l’egiziano Sadat.
«Se
vuol dire che tengo unita la magistratura, lo prendo come un complimento. Se
qualcuno pensa che io sia qui per svendere la magistratura e la legalità, si
sbaglia di grosso. L’Anm deve tutelare l’indipendenza dei magistrati, non
asservirli alla politica».
Davigo: "I
politici rubano di più. E non si vergognano".
Il presidente dell'Anm, Piercamillo Davigo, tuona contro la corruzione, scrive
Luca Romano, Venerdì 22/04/2016, su "Il Giornale". I politici "non hanno smesso
di rubare; hanno smesso di vergognarsi. Rivendicano con sfrontatezza quel che
prima facevano di nascosto. Dicono cose tipo: "Con i nostri soldi facciamo
quello che ci pare". Ma non sono soldi loro; sono dei contribuenti". Lo afferma
al Corriere della Sera, Piercamillo Davigo, presidente dell'Anm, spiegando che
"prendere i corrotti è difficilissimo. Nessuno li denuncia, perché tutti hanno
interesse al silenzio: per questo sarei favorevole alla non punibilità del primo
che parla. Il punto non è aumentare le pene; è scoprire i reati. Anche con
operazioni sotto copertura". Alla domanda se quindi si ruba più di prima, Davigo
spiega: "Si ruba in modo meno organizzato. Tutto è lasciato all'iniziativa
individuale o a gruppi temporanei. La corruzione è un reato seriale e diffusivo:
chi lo commette, tende a ripeterlo, e a coinvolgere altri. Questo dà vita a un
mercato illegale, che tende ad autoregolamentarsi: se il corruttore non paga,
nessuno si fiderà più di lui. Ma se l'autoregolamentazione non funziona più,
allora interviene un soggetto esterno a regolare il mercato: la criminalità
organizzata". Dopo Mani Pulite, prosegue Davigo, "hanno vinto i corrotti,
abbiamo migliorato la specie predata: abbiamo preso le zebre lente, le altre
sono diventate più veloci". A fermare quel pool "cominciò Berlusconi, con il
decreto Biondi; ma nell'alternanza tra i due schieramenti, l'unica differenza fu
che la destra le fece così grosse e così male che non hanno funzionato; la
sinistra le fece in modo mirato. Non dico che ci abbiano messi in ginocchio; ma
un pò genuflessi sì". Il governo Renzi? "Fa le stesse cose - dice Davigo -.
Aumenta le soglie di rilevanza penale. Aumenta la circolazione dei contanti, con
la scusa risibile che i pensionati non hanno dimestichezza con le carte di
credito". Sulla responsabilità civile dei magistrati, il presidente dell'Anm
parla di norme ridicole: "L'unica conseguenza è che ora pago 30 euro l'anno in
più per la mia polizza: questo la dice lunga sulla ridicolaggine delle norme.
Tutti abbiamo un'assicurazione. Non siamo preoccupati per la responsabilità
civile, ma per la mancanza di un filtro. Se contro un magistrato viene intentata
una causa, anche manifestamente infondata, gli verrà la tentazione di
difendersi; ma così non farà più il processo, e potrà essere ricusato. È il modo
sbagliato per affrontare un problema serio: perché anche i magistrati
sbagliano". Sul rapporto tra toghe e Palazzo, Davigo osserva: "I magistrati
avendo guarentigie non sono abituati al criterio di rappresentanza: per questo
sovente sono pessimi politici". Poi nel pomeriggio, intervenendo a Pisa, Davigo
ha rincarato la dose: "Dire che i magistrati devono parlare solo con le loro
sentenze equivale a dire che devono stare zitti. Le avete mai lette le sentenze?
- ha ironizzato Davigo parlando del presunto protagonismo dei magistrati - è
come quando sui giornali di provincia qualche volta c’è il pescatore che ha
pescato un luccio enorme. Io dico: è il pescatore affetto da protagonismo o è il
luccio che è enorme?". E ancora: "La classe dirigente di questo Paese quando
delinque fa un numero di vittime incomparabilmente più elevato di qualunque
delinquente da strada e fa danni più gravi". E alle parole di Davigo ha risposto
il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini: "Le dichiarazioni del presidente
Davigo rischiano di alimentare un conflitto di cui la magistratura e il Paese
non hanno alcun bisogno tanto più nella difficile fase che viviamo nella quale
si sta tentando di ottenere, con il dialogo ed il confronto a volte anche
critico riforme, personale e mezzi per vincere la battaglia di una giustizia
efficiente e rigorosa, a partire dalla lotta alla corruzione e al malaffare". E
sullo scontro tra Davigo e il governo sono arrivate diverse reazioni dalla
politica. "Conosco e stimo il presidente Anm. Lo incontrerei volentieri e lo
incontrerò. Mi piacerebbe che da parte sua ci fossero considerazioni più
circonstanziate. Io sono un politico, mi sono candidato la prima volta nel '93 e
in 23 anni non ho mai rubato una lira né sono mai stato processato o indagato
per aver rubato una lira". Così il leader della Lega Matteo Salvini, inaugurando
la sede romana del partito, risponde a chi gli chiede un commento all'accusa di
Pier Camillo Davigo . "Colui che rappresenta i magistrati non può permettersi di
dire 'i politici, i tassisti rubano e le maestre picchiano i bambini. Ci sono
politici che rubano e maestre che picchiano i bambini, ma altri no. Ci sono
tantissimi giudici che fanno il loro lavoro e altri che non fanno una mazza
dalla mattina alla sera. Lo incontrerò, potremo fare delle battaglie comuni".
Poi nel pomeriggio Davigo ha rincarato la dose intervenendo a Pisa: "Dire che i
magistrati devono parlare solo con le loro sentenze equivale a dire che devono
stare zitti. Le avete mai lette le sentenze? - ha ironizzato Davigo parlando del
presunto protagonismo dei magistrati - è come quando sui giornali di provincia
qualche volta c’è il pescatore che ha pescato un luccio enorme. Io dico: è il
pescatore affetto da protagonismo o è il luccio che è enorme?". E ancora: "La
classe dirigente di questo Paese quando delinque fa un numero di vittime
incomparabilmente più elevato di qualunque delinquente da strada e fa danni più
gravi". Le sue parole hanno scatenato le reazioni della politica.
"Quello di
Davigo è un maldestro tentativo di alimentare un inedito e violento scontro tra
istituzioni. Non mi sembra ci siano altre parole per commentare le prime sortite
del fresco leader dell'Anm, prima sul Fatto e oggi sul Corriere della sera. Le
sue dichiarazioni sono eufemisticamente poco responsabili e gli effetti
potrebbero essere devastanti qualora ci si lasciasse trascinare in quella
direzione". Lo ha detto Antonio Leone, componente laico delCsm in quota Ncd.
"Additare indiscriminatamente tutti i politici come ladri - ha precisato Leone -
può sicuramente innescare reazioni a catena. Ad esempio i politici potrebbero
dire 'come mai l'auspicio di Davigo sul fatto che sia la stessa classe politica
a cacciare i corrotti prima ancora che venga celebrato un processo, non lo si
usa anche per i magistratì? I politici potrebbero ancora chiedersi perché "ci
sono magistrati che, pur condannati e che scontano la pena in galera, continuano
a percepire lo stipendio a spese degli italianì? Giacobinismo per giacobinismo
vale per tutti. Ma tant'è. La struttura democratica di questo Paese - ha
concluso Leone - mi sembra più matura di molti rappresentanti, magistrati e
non, e ci auguriamo che le parole di Davigo restino il solito e banale metodo
per raggiungere il massimo della visibilità. Questo non significa derubricare la
gravità di certe affermazioni".
«Non c' è
nessuna guerra» tra politica e magistratura, dice Davigo, e l'unico problema è
che la politica e le istituzioni non rimuovono il personale da rimuovere. Cioè
chi, i condannati? No, s' intendono quelli da rimuovere «in base a un giudizio
morale o di opportunità»,
scrive Filippo
Facci per “Libero Quotidiano”. Tutto va bene, madama la travaglia: la politica è
sporca e non si ripulisce, la giustizia invece è perfetta e non c'è niente da
cambiare. Sul Fatto Quotidiano, ieri, il neo presidente dell'Associazione
magistrati Piercamillo Davigo si è profuso in un lungo monologo di due pagine
che, tramite la trasformazione in neretto di alcune parti del testo, è stato poi
ribattezzato «intervista»; lo stenografo si chiama Marco Travaglio, e, data la
collaudata ripetitività delle asserzioni di Davigo negli anni, la cosiddetta
intervista avrebbe potuto anche scriverla direttamente lui, Travaglio,
utilizzando il noto metodo giornalistico marzulliano «fatti una domanda, datti
una risposta e riciclala per vent' anni». In effetti Davigo dice più o meno le
stesse cose dai tempi di Mani pulite: storielle, aneddoti, paradossi, freddure,
roba da far sorridere una platea alla presentazione di un libro. Ma ora che ha
un ruolo politico - capo del sindacato dei magistrati, maggior potere non
elettivo del Paese - ogni sua uscita potrebbe diventare una posizione strategica
o appunto politica, soprattutto se il presidente del Consiglio ha appena parlato
degli stessi temi. È successo ieri. Renzi, in Senato, aveva da poco pronunciato
delle doverose ovvietà: che negli ultimi vent'anni questo Paese ha conosciuto
«autentiche barbarie giustizialiste», che spesso un avviso di garanzia è bastato
per rovinare mediaticamente persone perbene, che per esempio la recente indagine
di Potenza ha diffamato un governo prima di qualsiasi sentenza (anche se nessun
governativo è indagato) e che le intercettazioni spesso sono diffuse solo per
sputtanare: insomma delle banalità, tanto da porre il dubbio sul perché, semmai,
certi discorsi non siano stati fatti altre volte. Ecco: la risposta di Davigo,
indiretta, converge come può farlo la pallina di una partita di tennis:
l'importante è risbatterla nel campo dell'avversario. Il tappeto rosso steso dal
Fatto Quotidiano già non faceva grinze: Renzi, nel titolo, era paragonato a
Berlusconi, mentre l'editoriale di Travaglio (titolato «negazionismo peloso») lo
paragonava a Craxi. Fine della dialettica. Le negazione totale di qualsiasi
problema o difetto in seno alla magistratura italiana, da parte di Davigo,
lasciava peraltro intendere quanto il personaggio appaia indisponibile a
muoversi da una posizione di arcigna schermaglia sindacale, e quanto poco
insomma appaia disposto a un cosiddetto confronto fondato perlomeno su una
minima presa d' atto della realtà in cui si vive. Macché: «Non c' è nessuna
guerra» tra politica e magistratura, dice Davigo, e l'unico problema è che la
politica e le istituzioni non rimuovono il personale da rimuovere. Cioè chi, i
condannati? No, s' intendono quelli da rimuovere «in base a un giudizio morale o
di opportunità». Che spetta a chi? Forse a Davigo e al Fatto Quotidiano? La
leggerezza con cui Davigo nega o liquida qualsiasi cosa fa capire che la «sua»
magistratura non vuole fare prigionieri, o meglio, vuole fare tutti prigionieri.
Il conflitto tra politica e magistratura? «Naturale conseguenza della loro
separatezza e indipendenza». Le intercettazioni penalmente irrilevanti? «Bastano
e avanzano le norme sulla diffamazione e sulla privacy», come è noto. Ma perché
le intercettazioni irrilevanti non le eliminano direttamente i magistrati?
Facile: perché possono essere irrilevanti per tizio ma rilevanti per caio. Le
raccomandazioni? «Sono reato». La presunzione d' innocenza? Quella è un fatto
tecnico, «un fatto interno al processo, non c' entra nulla coi rapporti sociali
e politici», cioè: «un fatto penalmente irrilevante può essere deontologicamente
disdicevole». E via così, i problemi non esistono: i tempi della giustizia?
«Tutte le inchieste arrivano a sentenza», «i giudici italiani sono quelli che
lavorano di più», «Parlamento e governo non possono dire che combattono
l'evasione fiscale», l'insindacabilità dei parlamentari non viene mai violata,
anche questo governo denota «una certa allergia al controllo di legalità». Tutto
così: questo il biglietto da visita di un uomo che dovrebbe essere di
«trattativa» ma che pare incazzato anche quando dorme.
Qualcuno dirà:
“vabbè, Filippo Facci è di destra!”
Ecco come
funziona la “barbarie giustizialista”,
scrive Fabrizio Rondolino su “L’Unità” il 20 aprile 2016. Un’intervista della
premiata ditta Davigo-Travaglio, condita con intercettazioni prive di qualsiasi
rilevanza penale: il Fatto dimostra che Renzi ha ragione. Per comprendere bene
che cosa sia la “barbarie giustizialista” denunciata con coraggio e lucidità da
Matteo Renzi è sufficiente sfogliare il numero odierno del Fatto. Si comincia
con un’autointervista di Piercamillo Davigo, neopresidente dell’Anm, firmata dal
suo segretario e portavoce Marco Travaglio. La tesi del Piccolo Inquisitore è
semplice: tutti i governi, e naturalmente anche quello in carica, hanno “una
certa allergia al controllo di legalità”. Il che, in italiano corrente,
significa che tutti i governi sono associazioni criminali. Chiarissimo.
“Processiamo gente abbarbicata alla poltrona che nessuno si sogna di mandare a
casa”, prosegue il Piccolo Inquisitore. Le intercettazioni vanno pubblicate
perché rivelano “notizie anche penalmente irrilevanti, ma moralmente
importanti”. E infine: “La presunzione d’innocenza è un fatto interno al
processo, non c’entra nulla coi rapporti sociali e politici”. Preferiamo non
commentare il delirio carcerario del Piccolo Inquisitore perché ne avremmo,
inesorabilmente, una denuncia: i magistrati militanti querelano sempre chi li
critica e, guarda caso, ottengono sempre la condanna dell’importuno dissidente.
La giustizia, si sa, è uguale per tutti: un po’ come il server della Casaleggio
Associati srl. Continuiamo invece a sfogliare il Fatto, e a pagina 7 troviamo un
esempio perfetto di uso selvaggio delle intercettazioni. L’obiettivo questa
volta è il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro, di cui si riportano alcune
affermazioni sulla propria passione per il gentil sesso, sull’omosessualità di
Nichi Vendola e sulla prestanza virile di non si sa bene chi. Le telefonate
intercettate, precisa l’addetta alle fognature del Fatto, “non sono penalmente
rilevanti” ma meritano la pubblicazione perché “rivelano una certa distanza fra
le dichiarazioni pubbliche di Del Basso De Caro e le sue convinzioni reali”.
Ancora più incredibile è la modalità con cui queste frasi sono state carpite: il
sottosegretario, scrive l’addetta alle fognature, “non è mai stato indagato, ma
i Pm lo hanno fatto intercettare per un mese e mezzo per cercare reati di terzi.
[…] L’inchiesta si è sgonfiata. […] A ottobre 2015 il Pm ha inviato l’avviso di
conclusione delle indagini a cinque persone per un reato minore sui servizi
sociali del Comune di Benevento”. E Del Basso De Caro che c’entra? Niente,
assolutamente niente: “non è mai stato indagato”. Eccola, la barbarie
giustizialista: fino a quando consentiremo al Piccolo Inquisitore, al suo
segretario e all’addetta alle fognature di minare sistematicamente la civiltà
giuridica dell’Occidente liberale, nessuno in Italia potrà più sentirsi sicuro.
L’INTERVISTA RAFFAELE CANTONE. «Non si risolve tutto con le manette. La
magistratura ha le sue colpe».
Il capo dell’Anac: «Dire che tutto è corruzione significa che niente è
corruzione». E sottolinea: «Il mio mandato scade nel 2020. E la mia idea è
tornare a fare il magistrato», scrive Aldo Cazzullo il 22 aprile 2016 su "Il
Corriere della Sera".
Dottor
Cantone, lei è presidente dell’Autorità anticorruzione. Piercamillo Davigo
sostiene che in Italia hanno vinto i corrotti. E lei?
«Non è
assolutamente vero. Dire che tutto è corruzione significa che niente è
corruzione, e il sistema non può essere emendato. Io non accetto questo
pessimismo cosmico. Mi ribello a questa visione che esclude qualsiasi ricetta.
Il pessimismo fine a se stesso diventa una resa. E questa resa nell’Italia di
oggi non c’è».
Quindi non
è vero che oggi è peggio di Tangentopoli?
«No, non è
vero. È vero che Tangentopoli non sradicò la corruzione, che è continuata come
un fiume carsico. Ma ora vedo molte persone che vogliono provare a uscirne. E
pensano che la soluzione non sia solo la repressione, che la ricetta non sia
solo la stessa del 1993, che all’evidenza ha fallito. Uno non può ripetere le
stesse cose a distanza di anni, e dire che è sempre colpa degli altri se le
vecchie ricette non hanno funzionato».
Che cosa
intende?
«L’idea che
tutto si risolva con le manette è stata smentita dai fatti. La repressione da
sola non funziona. Colpisce ex post; spesso in modo casuale; sempre quando i
danni sono già fatti. La prevenzione ha tempi più lenti. Ma nei Paesi del Nord
Europa, dove la corruzione è bassissima, ha funzionato».
Anche
Davigo parla di prevenzione, di agenti infiltrati che incastrino i politici. E
dice che pure lei, fino a qualche tempo fa, ne parlava.
«E continuo a
farlo. Ho parlato di agenti infiltrati un mese fa, a un convegno di magistrati.
Capisco che Davigo possa non seguire quello che dico, ma in questo caso non è
molto informato. Lo stimo, sono stato tra i primi a fargli gli auguri.
Condividiamo l’amore smisurato per la magistratura; ma l’amore porta lui a
vedere solo gli aspetti positivi; e porta me a vedere gli aspetti critici».
Quali
aspetti critici?
«Molto spesso
la magistratura non riesce a dare risposte ai cittadini, perché è sovraccaricata
di compiti non suoi. Si pensa che debba occuparsi soprattutto dei grandi temi, e
un po’ meno del senso di giustizia individuale. Sul piano dei tempi e della
prescrizione la risposta è insufficiente. Non a caso Ilvo Diamanti sostiene che
la magistratura negli ultimi anni ha perso oltre il 20% della sua credibilità,
passando dal 70% a sotto il 50. Si può sempre dire che la colpa è degli altri?
Io mi ribello a questa logica del fortino assediato. La magistratura ha meriti
eccezionali; ma sarebbe scorretto non evidenziare che certi meccanismi
organizzativi non funzionano».
A cosa si
riferisce?
«A tante
persone che vengono in contatto con il sistema giustizia – non gli imputati; i
testimoni, le parti lese – e non ne darebbero questi giudizi entusiasti. Non è
giusto dire: va tutto bene madama la marchesa, e se va male la colpa è altrui.
Ci sono testimoni che sono andati dieci volte ai processi e dieci volte sono
stati rimandati indietro. Ci sono uffici giudiziari che danno risposte, e altri
che non lo fanno. Ripeto: io amo la magistratura. Ma ho un’idea diversa del suo
ruolo».
La sua idea
qual è?
«In certe
battaglie la magistratura è uno dei soggetti. Davigo pensa che sia l’unico a
poter risolvere i problemi. Non condivido una visione autoreferenziale e
salvifica. La magistratura non deve salvare il mondo; deve accertare i reati
penali e decidere i processi civili. In nessun Paese del pianeta ha il monopolio
nelle questioni di legalità; altrimenti finisce per esercitare una funzione di
supplenza nei confronti della politica».
Se i
politici smettessero di rubare darebbero una bella mano, non crede?
«Certo. La
politica deve fare molto di più. Ma è ingiusto non riconoscere quanto è stato
fatto negli ultimi anni. Dire che non cambia mai nulla è funzionale all’idea di
non far cambiare mai nulla. Noi come magistratura abbiamo chiesto nuove norme
sul falso in bilancio, sul voto di scambio politico mafioso,
sull’autoriciclaggio: e queste riforme sono state fatte. Alcune potevano essere
scritte meglio, ma qualche perplessità è stata superata dalle interpretazioni
della giurisprudenza. Non riconoscere che qualcosa si può fare è come dire che
non c’è più niente da fare, che l’unica strada sono le manette. Ma non è così».
Il sentire
diffuso è che il governo stia facendo poco contro la corruzione, e usi lei come
foglia di fico.
«Io sto ai
fatti, non alle allusioni. Tutte le volte che c’era da criticare il governo non
mi sono mai tirato indietro. Il primo a denunciare il rischio dell’innalzamento
dei contanti a 3 mila euro sono stato io. Ma per la prima volta c’è in Italia
un’Autorità indipendente contro la corruzione cui sono stati dati poteri,
secondo una visione nuova che non è affatto alternativa alla magistratura, al
contrario di quel che qualcuno tende a pensare. L’Ocse, che bacchetta sempre
l’Italia, ha elogiato il nostro lavoro sull’Expo. Il nuovo codice degli appalti
ci attribuisce poteri autentici».
Non direi:
potete intervenire solo sugli appalti sopra i 5 milioni di euro, escludendo il
95% dei contratti.
«Non è così.
Quella soglia riguarda solo le commissioni di gara; i nostri poteri riguardano
tutti gli appalti».
Sicuro?
«Ci sono
criticità, ma c’è uno sforzo autentico, e se ne vedranno i risultati».
Però
continuano gli scandali. E gli arresti.
«Sono fatti
molto gravi. Ma se emergono è la prova che il sistema reagisce. Fino a poco fa
qualche leader politico sosteneva che la corruzione non esisteva; oggi nessuno
la nega. Non dico che la strada sia conclusa, sarei un folle. Ma è sbagliato non
prendere atto di quel che è avvenuto, grazie al Parlamento che ha votato andando
oltre la maggioranza di governo».
È d’accordo
con Renzi che parla di «barbarie giustizialista»?
«Barbarie
giustizialista è un’espressione esagerata. C’è stato un periodo in cui non tanto
la magistratura, quanto l’interpretazione dei provvedimenti della magistratura
ha creato eccessi: bastava essere indagato per venire messo alla gogna».
I paragoni
sono sempre impossibili, ma viene in mente che, in un contesto diverso, Falcone
quando andò a lavorare per il ministero di Grazia e Giustizia si ritrovò
isolato.
«Una parte
della magistratura è convinta che collaborare col potere politico ti inquina. Io
dico che in questo periodo, e sono disponibile a essere sfidato sul piano della
verità, nessun politico di nessuna parte mi ha mai chiesto di fare qualcosa che
non potevo fare. Quando facevo il magistrato, qualcuno ci ha provato».
Chi le ha
fatto pressioni?
«Nessuna
pressione. Semmai, il sentore che qualcuno ci stesse provando: poteva capitare
il collega che diceva “ti stai occupando del processo X…”. Nessuno è mai andato
oltre. Ma lo posso testimoniare in qualsiasi tribunale, soprattutto nel
tribunale della mia coscienza: l’idea che ci sia un mondo tutto pulito, la
magistratura, e un mondo tutto sporco, la politica e la burocrazia, è comoda da
vendere come fiaba; ma è falsa. La magistratura è fatta al 99 per cento di
persone perbene, ma le mele marce ci sono; come ci sono persone perbene in
politica. Il retropensiero che ci si debba sporcare con i rapporti
istituzionali, malgrado quello che è successo a Falcone, continua a essere
usato: con allusioni e attacchi ingiustificati, basati sul nulla. In che cosa
noi dell’Autorità abbiamo fatto da ruota di scorta? Se Renzi la evoca di
continuo è perché finalmente l’Autorità sta provando a lottare contro la
corruzione, non perché ci sia un rapporto incestuoso. Se qualcuno ha le prove di
rapporti incestuosi, le tiri fuori; non usi illazioni. Altrimenti finisce come
quando Falcone veniva chiamato eroe dagli stessi che lo appellavano come
traditore».
A chi si
riferisce?
«Ero uditore
giudiziario quando partecipai ad assemblee di magistrati che, quando fu fatta la
Direzione nazionale antimafia, usavano per Falcone parole tra cui la più buona
era traditore. Quegli stessi, 15 giorni dopo, usavano la parola eroe».
Quegli
stessi chi?
«Riportare i
nomi di chi interveniva in assemblee private non mi pare corretto. E comunque
non è una cosa che sto improvvisando: l’ho scritta in un libro del 2007».
In Italia
servono più carceri?
«Sì, ma la
questione riguarda soprattutto l’ordine pubblico: per i reati di criminalità di
strada abbiamo una legislazione e un’applicazione della legislazione
eccessivamente elastiche».
Ci sono
troppi magistrati in politica?
«Ci sono stati
troppi magistrati in politica; e molto spesso non hanno fatto grandi figure. Il
nostro lavoro non ti abitua certo alla ricerca del consenso. È sbagliata l’idea
che un magistrato non possa fare politica; è sbagliato semmai che dopo aver
fatto politica torni a fare il magistrato».
Lei la
politica non la farà mai?
«Non ci penso
assolutamente. Il mio mandato scade nel 2020. E la mia idea è tornare a fare il
magistrato».
"In Italia
il partito dei giudici fa e disfa le leggi da decenni".
L'ex senatore:
«Le continue invasioni di campo non nascono per caso I magistrati si sentono
depositari della volontà popolare, un'anomalia», scrive Stefano Zurlo, Sabato
23/04/2016, su "Il Giornale". Prende una sentenza del 2009. E legge il passo
decisivo in cui la Cassazione rivendica, testualmente, «la funzione
interpretativa del giudice in ordine alla formazione della cosiddetta
giurisprudenza-normativa, quale autonoma fonte di diritto». «Ecco - riprende
Giuseppe Valditara, ex senatore di Fli e professore ordinario di Diritto romano
all'università di Torino - la Suprema corte ci dice che il giudice è una fonte
autonoma di diritto. È sconvolgente, capisce? Perché solo in Italia la
magistratura arriva a concepirsi come soggetto normativo che affianca e
sostituisce il legislatore. Le leggi, per capirci, le fa il Parlamento, ma la
Cassazione si mette sullo stesso piano. Succede solo nel nostro Paese, ma la
nostra storia è un susseguirsi di anomalie, una più inaccettabile dell'altra.
Tutto si tiene». Tutto si spiega. Anche le feroci polemiche di queste ore.
Piercamillo Davigo, neopresidente dell'Associazione nazionale magistrati, parla
al Corriere della Sera e liquida la nostra classe dirigente: «I politici rubano
più di prima, ma adesso non si vergognano». Scintille e ancora scintille sullo
sfondo di un conflitto fra poteri che va avanti da troppi anni. Valditara ha
appena scritto il libro Giudici e legge che vorrebbe essere una meditazione
scientifica e tecnica sulla magistratura tricolore, ma basta sfogliare quelle
trecento pagine dense di citazioni per incrociare l'attualità bruciante, le
polemiche chi si ripetono sempre uguali, le esternazioni del partito dei giudici
e di tutto l'armamentario del giustizialismo italiano.
Professor
Valditara, perché parla di anomalie italiane?
«Perché le
continue invasioni di campo delle toghe non nascono per caso».
Più d'uno a
sinistra ci aveva spiegato che i giudici alzavano la voce per rispondere alle
provocazioni e agli sconfinamenti di Berlusconi.
«Ma no. Quella
è una battaglia dentro una guerra molto più lunga e complessa. Bisogna tornare
indietro agli anni '50».
No, un
attimo, partiamo dalla diagnosi: qual è la malattia?
«Gliel'ho
detto: i giudici italiani si considerano in qualche modo i depositari della
volontà popolare e di fatto scrivono e riscrivono le leggi, le interpretano, le
disapplicano, fanno un po' quello che gli pare».
Non le pare
di esagerare?
«Ma no. Sono
loro a parlare di tutte queste cose. Prendiamo il testo della norma sulla
legittima difesa, modificato nel 2006».
D'accordo,
ma che c'entra?
«C'entra
perché la modifica è stata di fatto annullata dai giudici che, interpretando le
parole, spesso finiscono per rimettere il padrone di casa che si ribella ai
ladri sul banco degli imputati. L'esatto opposto di quel che voleva il
legislatore».
Ma come è
possibile?
«Non solo è
possibile, questo è solo un episodio dentro una strategia molto più aggressiva».
Addirittura?
«La sentenza
che riguarda il rapporto fra la Renault e le concessionarie arriva ad un punto
estremo: il giudice è autorizzato a modificare il contratto fra le parti. Non so
se ci rendiamo conto della portata di questa considerazione: c'è un contratto e
la toga lo modifica in base a sue valutazioni. Altro che equilibrio fra i
poteri. Qua il partito dei giudici fa e disfa a suo piacimento. E d'altra parte,
la sentenza numero uno della Corte costituzionale, nel 1956...»
Si fermi,
non possiamo tornare all'ormai lontano 1956.
«E invece
dobbiamo. Perché già quel lontanissimo verdetto dice che le norme della
Costituzione non hanno un valore solo programmatico. E dunque in questo modo si
scardina un'altra porta e si apre un varco enorme: gli articoli della Carta, che
hanno un indirizzo politico, vengono applicati al caso concreto dal giudice che
quindi esce dal recinto tecnico e fa politica, saltando la legge ordinaria.
Siamo all'interpretazione costituzionalmente orientata».
In
concreto?
«Per fare un
esempio paradossale il giudice potrebbe arrivare ad annullare un contratto di
affitto».
E perché?
«Perché
potrebbe giudicare troppo alto il canone in relazione all'articolo 2 della
Costituzione e dunque al dovere di solidarietà politica, economica, sociale».
Dunque, con
la sentenza del 1956 i giudici cominciano a fare politica?
«Certo. Si
avvia quel percorso perverso che arriva fino al verdetto che ricordavo del 2009.
Con tutte le conseguenze che conosciamo».
Sia più
esplicito.
«Solo in
Italia la magistratura è organizzata per correnti che sembrano clonare i
meccanismi e le divisioni del Parlamento».
Siamo a
Magistratura democratica, alle toghe rosse...
«In proposito
c'è un testo esemplare del 1970 di Franco Marrone. Marx ha affermato - nota
Marrone - che il diritto non dà niente, ma sanziona solo ciò che esiste. Che
cosa esiste attualmente nella nostra società? Esiste il dominio di una classe,
quella borghese, sulle altre. Chiaro? Il resto è solo uno sviluppo coerente di
quel programma: un'oligarchia al posto della democrazia».
POOL MANI PULITE, MAGISTRATURA DEMOCRATICA E COMUNISMO:
ATTRAZIONE FATALE PER FAR FUORI AVVERSARI POLITICI E MAGISTRATI SCOMODI!
L'attrazione fatale del Pool per la sinistra,
scrive Stefano Zurlo, Giovedì 10/03/2016, su "Il Giornale". La gente, che
correva ad adorarli sotto le finestre del Palazzo di giustizia piacentiniano,
gridava «Di Pietro- Davigo-Colombo andate fino in fondo». Missione compiuta: in
fondo a sinistra. Fatta a pezzi la Prima repubblica, gli alfieri del Pool hanno
preso il posto di quelli che prima ammanettavano. Un'attrazione fatale o, più
banalmente, una seconda vita dopo aver esaurito l'adrenalina disponibile per
l'esistenza in toga. Chissà. Autorevoli commentatori hanno scritto che questo
salto dall'altra parte della barricata autorizza inquietanti letture
retrospettive di quell'epopea che, in tre anni, dal 92 al 94, cambiò la storia
d'Italia. E lanciò in orbita i post comunisti. Percorsi differenziati, una
prospettiva comune, quasi una tendenza irresistibile: l'ultimo ad essere tentato
è Gherardo Colombo che peraltro ha già lasciato la magistratura da un pezzo, ha
visitato, con le sue lezioni sulla legalità, più scuole di Matteo Renzi, è stato
presidente della Garzanti e consigliere d'amministrazione della Rai. Ora
potrebbe scendere in campo come bandiera della sinistra-sinistra per il Comune
di Milano. Si vedrà. E però il destino sembra compiersi. Cominciò il più
scalpitante del gruppo, Antonio Di Pietro: neanche il tempo di togliersi la
toga, ammaccata dalle inchieste di Brescia, e via di corsa verso il Parlamento.
Fu la destra a corteggiarlo, ma fu poi la sinistra, più strutturata e seducente,
a reclutarlo paracadutandolo nel collegio sicuro del Mugello, rosso che più
rosso non si può. Il Tonino nazionale, che era arrivato con le sue inchieste fin
sulla porta di Botteghe oscure, si ritrovò senatore nel partito di D'Alema e
Occhetto che aveva provato, invano, a scandagliare. Cortocircuiti di
quell'intreccio perverso fra politica e giustizia. Ministro del governo Prodi,
senatore, deputato, ancora ministro, fondatore dell'Italia dei valori. Il
curriculum del Di Pietro numero due è chilometrico e pare una smentita su tutta
la linea alla predicazione purissima di Piercamillo Davigo, il più intransigente
fra gli Intoccabili di Mani pulite, che ripeteva davanti alle continue offerte
di poltrone e laticlavi: «Un arbitro non può entrare in campo e giocare la
partita». Invece, dopo Di Pietro anche Gerardo D'Ambrosio, il coordinatore del
Pool, non seppe resistere alle sirene del Palazzo. E fu eletto senatore, sempre
nel Pd. Certo, D'Ambrosio era già in pensione e la brillante carriera da Pm si
era conclusa per via anagrafica. Ma anche in questo caso non si può non
avvertire un retrogusto di disagio. Lo stesso che scatterebbe se Colombo dovesse
buttarsi nella mischia. Una scelta scansata solo da Davigo, ancora oggi in prima
linea ma dentro la magistratura, e da Francesco Saverio Borrelli, troppo
innamorato della propria posizione per cedere alle lenticchie di una poltrona in
Parlamento.
Da «pool» a pollaio, il triste tramonto della Procura.
I pm di Mani pulite per la gente erano eroi. Oggi, con la guerra tra il capo e
il suo vice, il timore è che le toghe si arrestino tra loro, scrive Vittorio
Feltri, Domenica 12/10/2014, su "Il Giornale". I ricordi quando invecchiano si
affastellano e confondono. Ma non tutti. Molti di essi rimangono impressi nella
memoria, magari non con ogni dettaglio, ma nella sostanza sì. Ci fu un lungo
momento, 20 e rotti anni orsono, in cui la Procura di Milano era considerata
come una cattedrale, piena di santi e di madonne. La madonna era Antonio Di
Pietro. I santi erano Borrelli (il capo carismatico), Davigo, Colombo eccetera.
I magistrati, in particolare i rappresentanti della pubblica accusa, furono
protagonisti di una svolta assai apprezzata dal popolo, stanco della Balena
bianca, dei socialisti (ladri per definizione, allora) e di qualsiasi partito
che non fosse tinto di rosso vermiglio. Le toghe avevano buona fama. Chi le
indossava con orgoglio e supponenza era guardato con ammirazione, facendo parte
attivissima di una sorta di esercito di liberazione. I giudici (pensavano in
molti, tra cui io stesso) ci libereranno dai tangentari, dai gaglioffi, dai
mariuoli che hanno trasformato la democrazia italiana in una palestra di
disonesti, pronti ad arricchirsi alle nostre spalle senza badare all'interesse
dei cittadini, sfruttando e mortificando la povera gente oppressa dalle tasse.
Un Di Pietro che, infischiandosene della consueta prudenza attribuita agli
amministratori della giustizia, procedeva lancia in resta contro i magliari
della politica, veniva portato in trionfo. Il suo nome si leggeva sui cavalcavia
delle autostrade: «Tonino salvaci tu». Il contadino togato piaceva da matti. In
lui identificavamo il vendicatore, colui che avrebbe ripulito anche gli angoli
della stalla politica, ormai mefitica, infetta. Le sue prime mosse non erano
gradite ai colleghi della Procura, i quali si dichiaravano stupiti e infastiditi
dal fatto che costui, da anonimo magistrato, fosse diventato in poche settimane
molto popolare, un divo acclamato. Borrelli mi scrisse una lettera all'
Indipendente, che allora dirigevo con spirito garibaldino, un po' folle, nella
quale raccomandava di non esagerare col giustizialismo. Poi successe una cosa
strana ma non troppo. I Pm si resero conto che il dipietrismo era più forte
della tradizionale ponderazione cui erano avvezzi i magistrati e mutarono
registro. Cavalcarono quasi subito il dipietrismo che in precedenza avevano
criticato, consapevoli che esso era foriero di grandi successi e incontrava il
consenso delle masse. Se dapprincipio era il solo Di Pietro ad essere
applaudito, nel giro di poco tempo il cosiddetto pool di Mani pulite salì in
blocco sul palcoscenico, salutato con entusiasmo, e incoraggiato a castigare i
mariuoli. I giornali, inizialmente titubanti e restii ad appoggiare la Procura,
abbandonarono in fretta ogni timidezza e si prestarono a fare da cassa di
risonanza alle inchieste che avevano scoperchiato il malaffare e la corruzione
diffusa. Il pentapartito - maggioranza di governo - fu presto sgominato, ogni
sua componente ridotta al lumicino. In pratica restarono in piedi soltanto l'ex
Pci (cioè il Pds), il Movimento sociale di Gianfranco Fini e la Lega di Umberto
Bossi. Ma queste sono cose note, anche se gli italiani più giovani, o meno
anziani, le ignorano. Quello che è accaduto nel nostro Paese negli ultimi 20
anni ha dell'incredibile. Poiché la famosa discesa in campo di Silvio
Berlusconi, sorprendendo gli addetti ai lavori politici, coincise con la
vittoria di Forza Italia, frenando la corsa al potere della sinistra (sconfitta
alle elezioni del marzo 1994), l'attenzione del pool milanese si concentrò sul
ricco Cavaliere, sospettato di aver brigato - e commesso dei reati - allo scopo
di agguantare il potere. Per un paio di decenni la Procura si è così distinta
nella caccia grossa con questo obbiettivo: se incastriamo l'erede del
Cinghialone torniamo alla regolarità democratica. Come è andata a finire lo
sappiamo e non è il caso di ricostruire le fasi che hanno portato alla condanna
di Berlusconi, base di lancio di Matteo Renzi, succeduto alle meteore Mario
Monti e Enrico Letta. Ciò indispensabilmente premesso, dobbiamo ora registrare
che la parziale caduta del fondatore di Forza Italia ha provocato un altro
crollo: quello della Procura di Milano, che sta vivendo un periodo orrendo,
contrastante con gli anni d'oro inaugurati da Di Pietro e che permisero a
Borrelli di candidarsi - regnante Oscar Luigi Scalfaro - alla guida
dell'esecutivo (senza fortuna). Oggi il pool sembra un pollaio. Nel senso che le
liti interne alla casta dei signori magistrati prevalgono sull'attività dei
medesimi. I media non si occupano più delle mirabili (si fa per dire) indagini
condotte dai Vip togati, saliti alla ribalta negli anni Novanta e successivi,
bensì dei contrasti violenti tra Bruti Liberati - procuratore capo - e Robledo,
suo vice. I due da mesi sono in combattimento e non si è ancora capito perché
cerchino vicendevolmente di farsi fuori. Lo spettacolo che essi mostrano ai
cittadini è desolante. Non sappiamo chi abbia ragione e chi torto, probabilmente
sbagliano entrambi a scannarsi senza requie, suscitando nei cittadini un
sentimento negativo ai confini dello scandalo. Addirittura qualcuno, con perfida
ironia, ha commentato in questo modo la disputa fra gli alti magistrati: avanti
di questo passo, in Procura si arresteranno fra loro, in una gara a chi ne fa
secchi di più. È solo una battuta, ma esprime una preoccupazione non campata in
aria. Il settore giustizia è sotto attacco da alcuni lustri. Per un po' si è
pensato che le polemiche con al centro i giudici fossero strumentali, tese a
delegittimarli per motivi di bassa bottega politica. Poi però si è constatato
che anche negli ambienti tribunalizi (che dovrebbero essere austeri e riservati)
ci si mena come disperati per una poltrona, e allora la reputazione di
lorsignori ne ha sofferto. I sondaggi sulla credibilità dei magistrati sono
crollati rispetto ad altre epoche e dimostrano che la stima di cui essi godevano
quando imperversava Mani pulite si è assottigliata paurosamente ed è prossima ad
esaurirsi. Qui più che una riforma del sistema giudiziario nel suo complesso,
che il legislatore non è stato capace neanche di cominciare ad abbozzare, urge
un drastico richiamo alle toghe di non rendersi ridicole. Già. La giustizia può
far piangere, ma non deve farsi compatire se desidera conservare un minimo di
dignità.
Ecco perché stronco il libro di mio figlio.
L'allora direttore de "L'Indipendente" sul saggio scritto dal
figlio: "L'inchiesta è finita male ma fu necessaria", scrive Vittorio Feltri,
Martedì 19/01/2016, su "Il Giornale". Non avrei mai scritto un rigo sull'ultimo
libro di mio figlio Mattia, Novantatré (L'anno del Terrore di Mani pulite), se
egli non mi avesse, pur con qualche ragione, scaraventato nella discarica dei
reietti che seguirono con passione la cosiddetta Tangentopoli, ricavandone la
sensazione che fosse un'operazione di giustizia non sommaria, ma diretta a
punire i reati commessi dai politici col pretesto di fare politica. Non voglio
impegnarmi in una difesa dalle accuse del mio diletto consanguineo rivolte ai
magistrati e ai loro complici, cioè i giornalisti (categoria alla quale non mi
onoro di appartenere): sarebbe un esercizio velleitario. Le opinioni si
discutono, ma raramente si cambiano. Tu, caro Mattia, narri con efficacia ciò
che accadeva nei giorni del 1993 (e anche del 1992): arresti in massa, il
tintinnio minaccioso delle manette che era diventato la colonna sonora di quei
tempi funesti, le detenzioni tese a strappare confessioni, le delazioni
finalizzate a ottenere la libertà (almeno) provvisoria. Racconti con dovizia di
particolari le vanterie della Procura di Milano, la paura che serpeggiava nelle
segreterie dei partiti (del Caf), le angosce degli indagati, le varie porcherie
commesse nelle stanze del Palazzaccio, la disinvoltura acritica dei cronisti
giudiziari che si abbeveravano negli uffici dei Pm e compilavano articoli
interamente ispirati dalle toghe. Hai ricostruito fedelmente, con autentico
pathos, il clima che si respirava in quegli anni tribolati a Milano: Antonio Di
Pietro, oscuro manovale del diritto, all'improvviso salito sul piedistallo
riservato agli eroi, venerato come la Madonna, invocato quale purificatore,
amato dalle folle perché per primo castigava i reprobi. Hai dipinto un quadro in
parte abbacinante e in parte fosco. La realtà, d'altronde, non è mai a tinta
unita. Hai reso alla perfezione l'atmosfera diurna dell'epoca. Ma hai
completamente trascurato cosa accadeva nelle notti della Prima Repubblica. Di
notte entrava in azione la Banda Bassotti. Forse te ne sei dimenticato. Forse ti
sei lasciato trascinare dalla vena letteraria e ti sei fissato sulle nequizie
della famosa e turpe inchiesta. La smemoratezza è una malattia di molte
famiglie, figurati se la nostra ne è immune. Di giorno i magistrati facevano
strage di mariuoli, di ladri e anche di innocenti: ma al calar delle Tenebre,
caro Mattia, si perpetravano furti su furti per decenni impuniti, considerati
perdonabile routine. Era diffusa la sensazione che la tangente fosse lecita, una
pratica di ordinaria furfanteria. I politici che rubavano per il partito non si
sentivano colpevoli, erano persuasi di agire per il bene della Patria e non
esitavano a riempirsi le tasche di denaro sporco, confondendolo con il proprio e
usandolo in proprio per pagarsi le ville sull'Appia Antica, la cui pigione
veniva saldata prelevando l'occorrente dal bottino. Su questo è opportuno
sorvolare? Essi spendevano e spandevano senza requie. Vivevano ben oltre le loro
disponibilità. Con quali mezzi? Da notare che se fregare per il partito non
sembra una grave scorrettezza, in verità è gravissima, perché non c'è neppure
l'attenuante dello stato di necessità. Rubavano, i politici, allegramente a
livello istituzionale. Autorizzati dal superiore principio secondo il quale la
democrazia costa. I partiti organizzavano congressi e riunioni faraoniche, cui
seguivano serate in discoteca dove scorrevano fiumi di champagne. Chi saldava il
conto? Le aziende che versavano le stecche in cambio di lavoro. Ciò faceva
comodo anche agli imprenditori, i quali però, se non si fossero piegati alle
richieste delle segreterie, sarebbero stati tagliati fuori dagli appalti.
Un'opera pubblica da un milione, finiva così per costare due milioni o tre. La
spartizione era assai onerosa. Risultato. Il debito pubblico impazziva. E ne
soffriamo ancora gli effetti devastanti. Che dovevano fare Di Pietro e i suoi
soci, voltare la testa dall'altra parte, fingere di non vedere? I magistrati
hanno sbarellato, ansiosi com'erano di salire alla ribalta. Ed io, come altri
cronisti, ho assecondato ciecamente un sistema investigativo pressappochistico e
dozzinale che, però, se non giustificabile, era comprensibile dato il momento.
Un momento di forti tensioni sociali, influenzato ed alimentato dal desiderio di
cancellare una classe dirigente incapace (come quella attuale) di amministrare
la cosa pubblica, sacrificandola alla saccoccia. Mattia, ti chiedo per quale
motivo il pentapartito, che era al governo, non ha mai pensato a legittimare il
finanziamento privato della politica. Era nelle sue facoltà approvare una legge
in proposito. Non ha mai provveduto a farlo perché, se tutto fosse stato chiaro
e controllato, nessuno avrebbe più distratto una lira in quanto ogni partito
sarebbe stato costretto a presentare bilanci verificati. Zero margini per
appropriazioni indebite. E con quali soldi sarebbero stati liquidati gli affitti
delle ville sull'Appia Antica? E chi avrebbe contribuito ad incrementare i
consumi della cosiddetta Milano da bere? Non siamo nati ieri, né tu né io;
abbiamo uso di mondo e siamo consapevoli di come girasse il fumo negli ambienti
politici. Sono stati trovati conti ricchi all'estero attribuibili a personaggi
dei partiti. Ovvio che la magistratura abbia colpito duro, acquisendo poi un
potere eccessivo di cui sopportiamo ancora i riflessi. Ti do atto che nel casino
generato da Mani pulite, accresciuto dallo sbandamento provocato dalla avanzata
della Lega, dal crollo del muro di Berlino, dalla perdita di credibilità dei
partiti, si sono compiute nelle indagini delle immonde esagerazioni. Cosicché ha
preso piede un giustizialismo che si spiega soltanto con la fregola di spingere
la sinistra alla conquista del primato nazionale a spese degli altri partiti. E
cara grazia che Berlusconi ha spaccato il giochino degli ex comunisti. Questo è
noto a tutti. Ma prima di dire che il dipietrismo è stato solo schifezze occorre
riflettere. Tonino non ha violentato un esercito di vergini, ma ha sbaragliato
una cosca di ladri che non ebbe il coraggio di varare una legge idonea a porre
ordine nella materia. Una classe politica di straccioni. Alcuni dei quali sono
stati castigati ingiustamente, ma altri l'hanno fatta franca, per esempio i
compagni. E ciò è indigeribile e autorizza a sospettare che le toghe non abbiano
agito con troppo zelo. Tuttavia, non sottovalutiamo un fatto: se la Giustizia ha
sbagliato al 30 per cento, i ladri della Prima Repubblica hanno sbagliato al 70
per cento. Amen. Peccato che un libro sui grassatori non sia mai uscito,
completo. Per concludere. Craxi quando disse che il ladrocinio era un male
comune colse nel segno. Sul piano storico e politico pronunciò un discorso
condivisibile in pieno. Su quello giudiziario egli aveva torto: non esistono
malversazioni a fin di bene. Se il prezzo della democrazia è la disonestà
endemica, conviene intervenire col pugno di ferro. Quanto agli errori dei
magistrati, non è il caso di enfatizzare quelli a danno dei politici. I
cittadini ogni giorno sono vittime di soprusi e angherie in tribunale, e nessun
parlamentare di oggi e di ieri ha osato fiatare.
Vent'anni di persecuzione continua.
Cambiano accuse e processi, ma l'obiettivo della Procura di Milano è sempre lo
stesso: il berlusconismo e l'impero del Cav, scrive Luca Fazzo, Venerdì
02/08/2013, su "Il Giornale". E pensare che sarebbe bastato poco. Forse un po'
di pazienza in più da parte di Silvio Berlusconi. Forse qualche oscillazione nei
misteriosi, delicati equilibri di potere che governano la Procura milanese.
Quattordici anni fa, la pace che avrebbe cambiato la storia del paese era a
portata di mano: e non si sarebbe arrivati alla sentenza di oggi. Una domenica
di maggio del 1999 Berlusconi salì nell'ufficio del pubblico ministero Francesco
Greco e ci rimase tre ore. Con Greco e il suo collega Paolo Ielo si parlò
ufficialmente di una accusa di falso in bilancio. Ma era chiaro a tutti - e il
procuratore capo Gerardo D'Ambrosio lo rese esplicito - che quell'incontro era
il segno di un tentativo di dialogo. Berlusconi faceva alcune ammissioni,
concedeva - e lo mise per iscritto in una memoria - che l'«espansione impetuosa»
del suo gruppo poteva avere creato «percorsi finanziari intricati». La Procura
si impegnava ad evitare accanimenti, e a trattare Berlusconi alla stregua di
qualunque altro imprenditore: con la possibilità di fuoriuscite soft come quelle
concesse al gruppo Fiat. Sarebbe interessante capire ora, a distanza di tanti
anni, dove si andò a intoppare il dialogo. Sta di fatto che rapida come era
emersa, la strada si arenò. Il partito della trattativa si arrese. E riprese,
violento come prima e più di prima, lo scontro senza quartiere. Da una parte un
gruppo inquirente che ha dimostrato di considerare Berlusconi, nelle multiformi
incarnazioni dei suoi reati, all'interno di quello che può in fondo essere letto
come un unico grande processo, come la sintesi dei vizi peggiori dell'italiano
irrispettoso delle leggi: il berlusconismo, insomma, come autobiografia
giudiziaria della nazione. Dall'altra, il Cavaliere sempre più convinto di avere
di fronte un potere fuori dalle regole, dalla cui riduzione ai binari della
normalità dipende la sua stessa sopravvivenza. Da vent'anni Berlusconi e la
Procura di Milano pensano che l'Italia sia troppo piccola per tutti e due. Ma da
dove nasce, come nasce, questa contrapposizione insanabile? L'apertura formale
delle ostilità ha, come è noto, una data precisa: 22 novembre 1994, data del
primo avviso di garanzia a Berlusconi. Ma la marcia di avvicinamento inizia
prima. Inizia fin dalla prima fase di Mani Pulite, quando il bersaglio grosso
della Procura milanese è Bettino Craxi. E, passo dopo passo, i pm si convincono
che Berlusconi - che pure con le sue televisioni tira la volata all'inchiesta -
è la vera sponda del «Cinghialone», il suo finanziatore e beneficiario. Chi c'è
dietro All Iberian, la misteriosa società che nell'ottobre 1991 versa quindici
miliardi di lire a Craxi, e riesce anche a farsene restituire cinque? Dietro
questa domanda, che diventa strada facendo una domanda retorica, i pm lavorano a
dimostrare la saldatura tra Craxi e Berlusconi. Quando nell'aprile 1994
Berlusconi diventa presidente del Consiglio, per il pool la vicinanza
Craxi-Berlusconi diventa anche continuità politica, perché da subito la
battaglia craxiana contro il potere (o strapotere) giudiziario diventa uno dei
cavalli di battaglia del nuovo premier. Dal Quirinale viene messo il veto alla
nomina di Cesare Previti a ministro della Giustizia. Ma al ministero va Alfredo
Biondi, che di lì a poco vara il decreto subito etichettato come «salva ladri»,
ritirato a furor di popolo dopo il pronunciamento del pool in diretta tv. È da
quel momento che lo scontro compie il salto di qualità. Per la Procura milanese
non c'è differenza sostanziale tra il Berlusconi imputato e il Berlusconi
politico, perché il secondo è funzionale al primo: come dimostreranno poi le
leggi ad personam, e, più di recente, la telefonata salva-Ruby alla questura di
Milano. Le inchieste che si susseguono in questi vent'anni stanno tutte in
questo solco, dentro la teoria della «capacità a delinquere» che diverrà uno dei
passaggi chiave della sentenza per i diritti tv. Sotto l'avanzare degli avvisi
di garanzia, Berlusconi si irrigidisce sempre di più, come ben racconta
l'evoluzione delle strategie difensive: da un professore pacato come Ennio
Amodio si passa all'ex sessantottardo Gaetano Pecorella, poi si approda alla
coppia da ring, Niccolò Ghedini e Piero Longo. Le dichiarazioni di sfiducia di
Berlusconi verso la serenità della giustizia milanese si fanno sempre più
esplicite. Per due volte, nel 2003 e nel 2013, il Cavaliere chiede che i suoi
processi siano spostati a Brescia, sotto un clima meno ostile. Per due volte la
Cassazione gli dà torto. Eppure, fino alla condanna definitiva di oggi, nessuno
dei processi era arrivato ad affossare Berlusconi. Assoluzioni con formula
piena, prescrizioni, proscioglimenti. Il catalogo dei modi in cui l'asse
Ghedini-Longo riesce a tenere l'eterno imputato al riparo da condanne definitive
è ricco. Una parte nasce da leggi varate per l'occasione, ma altre assoluzioni
danno atto dell'inconsistenza di accuse che la Procura riteneva granitiche. La
si potrebbe leggere come una prova della tenuta di fondo del sistema
giudiziario, dei contrappesi tra pubblici ministeri e giudici? Berlusconi non la
pensa così. E la severità delle ultime sentenze, i giudizi sferzanti dei
tribunali del caso Unipol, la batosta del risarcimento a De Benedetti, la
decisione dei giudici del processo Ruby 2 di candidarlo a una nuova
incriminazione per corruzione in atti giudiziari lo avevano già convinto
definitivamente che la contiguità tra pm e giudici era arrivata livelli
intollerabili. Guardia di finanza, All Iberian, Mills, Sme, Lodo Mondadori,
diritti tv, Mediatrade, Ruby, il rosario delle pene giudiziarie del Cavaliere a
Milano sembra interminabile. Cambiano i procuratori, cambiano alcuni dei
pubblici ministeri, ma la linea non cambia. Eppure questa è la Procura dove due
magistrati di spicco del pool, Antonio Di Pietro e Gerardo D'Ambrosio, hanno
detto a posteriori di non avere condiviso la decisione dell'avviso di garanzia
del 1994 (il procuratore Borrelli replicò a Di Pietro pacatamente, «Ha detto
così? Beh, se si presenta in Procura lo butto giù dalle scale»). È la Procura
dove, con Romano Prodi al governo, Francesco Greco andò a un convegno di
Micromega ad accusare il centrosinistra, «questi fanno quello che neanche Forza
Italia ha osato fare». È insomma la Procura dove la parte più pensante si rende
conto che l'insofferenza di Berlusconi verso la magistratura è in fondo
l'insofferenza di tutta la politica verso il potere giudiziario, e che non è
affatto sicuro che il dopo Berlusconi porti alle toghe spazio e prebende. Ma per
adesso lo scontro è con lui, con il Cavaliere. E i pochi giudici che in questi
anni hanno disertato, in corridoio venivano guardati storto.
Così Berlusconi smaschererà i giudici.
L'ex premier spiegherà agli italiani tutte le falle del processo Mediaset e
l'assurdità della condanna: ecco cosa dirà, scrive Paolo Guzzanti, Giovedì
22/08/2013, su "Il Giornale". Che dirà agli italiani Silvio Berlusconi
all'inizio di settembre? Tutti si arrovellano, molti si chiedono, altri
ipotizzano e quanto a me, ho formato il numero di telefono di Arcore e ho avuto
fortuna: mi ha risposto dopo un paio di minuti. Quella che segue non è
un'intervista, ma quel che resta di una conversazione durata otto minuti e 43
secondi, tanti quanti ne ha contati il mio cellulare. Che cosa farà dunque l'ex
presidente del Consiglio? Se ho capito bene, sta preparando una vera lezione di
storia. Certo, sarà la sua storia, ma nessuno può negare che la sua storia
coincida con una parte della storia collettiva del nostro Paese. Berlusconi
traccerà dunque la storia del suo processo e spiegherà ciò che a suo parere
documenta la sua innocenza e l'ingiustizia subíta. Spiegherà che cosa avrebbero
potuto dire i testimoni che la sua difesa aveva chiesto di udire, ma che sono
stati rifiutati dalla Corte. Sosterrà l'assurdità di una condanna penale per un
reato fiscale su una vicenda ancora aperta in sede di ricorso per dire ai suoi
ascoltatori ed elettori (prima o poi, si dovrà pur andare a votare) di essere
stato vittima di un'antica e ben oliata trappola giudiziaria per farlo fuori. Mi
ha però particolarmente colpito quel che Berlusconi ha detto a proposito della
magistratura. La sua tesi è che il problema non è tanto quello di un'entità
astratta (potere? ordine?) come la magistratura, ma di quella specifica parte
dei magistrati che fa capo alla corrente politica chiamata Magistratura
democratica. Così, mentre ascoltavo mi è venuto un flash: rivedevo me stesso
negli anni Sessanta e Settanta, quando ero psiuppino (da Psiup, Partito
socialista di unità proletaria) cioè parecchio più a sinistra del Pci, e
cominciai a seguire le vicende e le parole dei primi magistrati di sinistra -
chi ricorda più i «pretori d'assalto»? - i loro congressi, le pubblicazioni, i
dibattiti. Non ne mancavo uno e li trovavo straordinari: vi si diceva, su una
vasta scala di tonalità, che in Italia c'è un deficit di democrazia che sarebbe
stato colmato soltanto quando la sinistra, allora comunista, sarebbe andata al
potere. I magistrati di quella corrente che diventò «Emmedì» (Magistratura
democratica, appunto) non facevano mistero della loro missione politica mentre
indossavano la toga e dicevano tutti più o meno così: «Noi, in quanto operatori
della giustizia, dobbiamo fare tutto quanto in nostro potere per bloccare
qualsiasi persona o partito che possa ostacolare l'avanzata della sinistra». A
me, allora che avevo quarant'anni meno di oggi, sembravano propositi
meravigliosi, rivoluzionari e «in linea» con la nostra linea di allora. Non ce
ne fregava assolutamente niente - politicamente parlando - di che cosa fosse
vero e che cosa fosse falso, di chi fosse buono e di chi fosse cattivo, purché
la linea andasse avanti. Eravamo tutti, allora, «sdraiati sulla linea». Non
avevamo, noi giovani rivoluzionari e i giovani magistrati di allora, nulla di
liberale: la parola «libertà» la trovavamo utile per le lapidi e le canzoni
partigiane che cantavamo a squarciagola, perché venivamo da una scuola di
pensiero - comune a tutti i comunisti, ma anche a tutti i fascisti e
nazionalsocialisti del secolo scorso - secondo cui l'unica cosa che importa è la
presa del potere, possibilmente per vie legali e democratiche (ma senza
rinunciare ad altre opzioni che la Storia nella sua generosità può metterti a
disposizione) sapendo che questa presa del potere, come ogni parto difficile, ha
bisogno di bravi ginecologi, talvolta del forcipe e anche della lama del
bisturi. «La rivoluzione non è un pranzo di gala» disse Lenin a Bertrand Russell
orripilato per le esecuzioni di massa a Mosca, e neanche la giustizia deve
essere tanto ossessionata dalle buone maniere, o semplicemente dall'idea
«borghese» del giudice terzo, indipendente, sereno, che appende con il cappotto
anche le sue idee sull'attaccapanni. Qualcosa di analogo avveniva in
psichiatria. Ero molto amico di Franco Basaglia, padre della psichiatria
democratica, che quando era a Roma veniva spesso a prendere un caffè da me.
Basaglia mi spiegava con entusiasmo rivoluzionario che non esiste la malattia
mentale, ma soltanto la malattia generata dalla classe borghese che con le sue
contraddizioni e violenze crea la malattia, schizofrenia e paranoia. Dunque, mi
diceva, il disturbo andava trattato come una questione politica: «Non si tratta
soltanto di chiudere i manicomi - chiariva - ma di far esplodere il nucleo
sorgente della borghesia stessa, ovvero la famiglia borghese». Ne seguì una
legge di riforma psichiatrica che ha seguito quelle direttive: i manicomi sono
stati chiusi, ma la sofferenza psichiatrica è stata spostata sulla famiglia
incriminata con il bel risultato di far accatastare negli anni più di diecimila
morti per violenze psichiatriche, come documentò l'indimenticato psicanalista
liberale e libertario Luigi De Marchi in un convegno che promovemmo insieme in
Senato anni orsono. È sintomatico come due cardini regolatori della stabilità
sociale come la psichiatria e la giustizia siano stati mossi dallo stesso
impulso ideologico e negli stessi anni. E che da allora seguitino a diffondere
le conseguenze di quella distorsione ideologica. Ma torniamo alla chiacchierata
con Berlusconi. Quando mi ha riportato alla memoria storica di Emmedì per averne
letto - mi ha detto - centinaia di documenti antichi e recentissimi - mi sono
suonati parecchi campanelli. Ho ricordato che quando io stesso mi sentivo dalla
loro parte mi rendevo conto che non avessero come primo scopo l'esercizio di una
giustizia indipendente, tale da garantire ogni cittadino a prescindere dalle sue
idee. Volevano, al contrario, garantire la vittoria di chi stava sul carro della
presa del potere e procurare la sconfitta di chiunque fossa dalla parte opposta
e ostacolasse la sinistra. La fedina penale di Berlusconi diventò subito
nerissima appena sfidò «la gioiosa macchina da guerra» di Achille Occhetto e la
ridusse in frantumi. Partirono subito raffiche di avvisi di garanzia che mi
ricordavano i killer di Al Capone che, quando andavano a far fuori qualcuno,
prima di tirare il grilletto ci tenevano a precisare: «Nothing personal: it's
just business». Nulla di personale, è solo una questione di affari, e facevano
fuoco. Anche con Berlusconi, e non soltanto con lui molti magistrati sembrano
comportarsi come se fossero animati da quell'antico modo di intendere la
giustizia. E così quando il Cavaliere mi ha detto che si era messo a studiare i
dossier di tutte le dichiarazioni politiche dei magistrati di Emmedì raccolte
negli ultimi anni, ho capito perfettamente a che cosa si riferiva. Spesso si
leggono delle espressioni sarcastiche sulla questione delle «toghe rosse», come
se si trattasse di una tipica panzana berlusconiana, del tutto inventata. Penso
che siano sarcasmi difensivi. Penso anche - calendario e fatti alla mano - che
la magistratura avesse fin dal 1980, almeno, tutti gli elementi per scatenare
una campagna moralizzatrice sulle ruberie della politica, sulla commistione tra
affari e politica, come io documentai con la storica e fortunata intervista a
Franco Evangelisti passata alla storia delle cronache come «A' Fra' che te
serve». La risposta della magistratura fu il silenzio di tomba. Il sistema di
approvvigionamento dei partiti, Pci in testa, andava allora benissimo anche a
quella parte della magistratura democratica che soltanto quando partì la parola
d'ordine di decapitare la prima Repubblica, scattò gridando allo scandalo, alla
necessità di fare pulizia, di castigare e demolire. Prima, neanche un fiato.
L'operazione Mani pulite annunciò con le trombe e i tamburi la scoperta
dell'acqua calda, annunciando che i partiti prendevano il pizzo dagli
imprenditori e il Pci, in barba al codice penale e alla Costituzione, lo
prendeva dall'Urss. Anzi, il reato commesso dal Pci, che importava capitali in
nero su cui non pagava una lira di tasse - a proposito di evasione fiscale! -
veniva usato come alibi: poiché i comunisti prendono soldi dai russi, noi per
pareggiare il conto li andiamo a prelevare dalle tasche degli imprenditori. La
magistratura inquirente usò senza risparmio la detenzione preventiva come forma
di tortura che condusse molti al suicidio (penso a Gabriele Cagliari che si
ficca in testa un sacchetto di plastica e muore in cella e a Raul Gardini che si
ficca una pallottola nella tempia dopo essersi fatto una lunga doccia
purificatrice) e tutte le suggestioni mediatiche che indussero gli italiani a
credere davvero che la corruzione a favore dei partiti fosse nata con il Psi di
Craxi e con la Dc di Andreotti e Forlani. Mentre la memoria mi riportava a quei
vecchi fatti - ma come mai il libro The Italian Guillotine di Peter Burnett e
Luca Mantovano non è stato mai tradotto in italiano? - Berlusconi sosteneva che
è veramente un caso straordinario in Italia che un uomo sia condannato a una
pena detentiva per una supposta evasione fiscale per una cifra ancora sottoposta
a vari ricorsi. E riflettevo: è vero. Ditemi voi, dica qualcuno più informato di
me, quanti imprenditori, evasori, uomini politici e no, sono finiti in galera
per evasione. La memoria non mi soccorre. La Guardia di finanza ha appena
accertato che 5mila evasori totali, ora identificati, hanno sottratto al fisco
ben 17 miliardi di euro «a spese dei contribuenti onesti». Non ricordo di aver
letto che una processione di cellulari li abbia trasferiti in galera. Eppure, 17
miliardi sottratti sono più del doppio dei miliardi di ricchezza che le aziende
di Berlusconi hanno versato nelle casse dello Stato. Ma Berlusconi è stato
condannato alla galera per una supposta evasione dell'1,2 per cento delle sue
imposte. Bah, sarà tutto vero, ma non c'è qualcosa che non quadra? Per la
cronaca, Berlusconi mi ha confermato che non chiederà la grazia, non chiederà i
servizi sociali, non chiederà i domiciliari, non chiederà nulla: c'è in ballo un
enorme problema politico e a quello deve pensare chi ha gli strumenti per farlo,
dice. Penso alluda al presidente della Repubblica, ma non l'ha detto. Ci siamo
salutati e mi sembrava tutt'altro che depresso e rassegnato.
Gli Usa: l'ex Pci voleva rovinare Berlusconi e tutte le sue
aziende. Nel maggio '94 l'ambasciatore avvisò la
presidenza Clinton: "Il Pds è deciso a distruggere il nuovo premier". Pochi mesi
dopo l'agguato dei pm di Milano, scrive Stefano Zurlo, Lunedì 29/02/2016, su "Il
Giornale". La sinistra vuole distruggere Silvio Berlusconi. I postcomunisti non
accettano la discesa in campo del Cavaliere e hanno deciso di toglierlo di
mezzo. Come un abusivo. Le carte della diplomazia Usa, pubblicate oggi per la
prima volta dal Giornale, sono un documento straordinario, un'anticipazione di
quel che sarebbe puntualmente successo di lì a pochi mesi: l'uscita di scena del
premier, azzoppato dall'avviso di garanzia del Pool Mani pulite. L'ambasciatore
Usa Reginald «Reg» Bartholomew aveva capito tutto e aveva avvisato Washington e
l'amministrazione Clinton. I documenti trovati a Washington al Dipartimento di
Stato da Andrea Spiri, professore della Luiss, confermano la previsione
dell'accerchiamento e poi dell'attacco letale. È il 4 maggio 1994 quando
Bartholomew invia a Washington un documento profetico, chiamato «Profilo del
primo ministro incaricato Silvio Berlusconi». Il 4 maggio il governo deve ancora
insediarsi, il Cavaliere entrerà a Palazzo Chigi solo il 10 maggio, ma il film è
già scritto: il countdown è partito, il Pds non tollera l'idea che la gioiosa
macchina da guerra di Achille Occhetto sia stata battuta quando pensava di avere
campo libero sulle macerie della Prima Repubblica. A dicembre, ben prima delle
elezioni, Bartholomew aveva già incontrato Berlusconi e il Cavaliere gli aveva
spiegato che «il suo primo obiettivo, quando ha deciso di entrare in politica,
era sconfiggere la sinistra». Il problema è che la sinistra, che verrà presa in
contropiede dal clamoroso successo di Forza Italia, ha deciso di far fuori la
nascente anomalia in grado di scompaginare i piani di D'Alema e Occhetto.
Berlusconi l'ha raccontato subito all'ambasciatore che però ha messo insieme
altri indizi e non si fa nessuna illusione su quello che avverrà: «Berlusconi ha
riferito, e i contatti giornalistici giurano sia vero, che gli uomini del Pds (e
D'Alema in particolare) hanno apertamente fatto sapere che se venissero eletti
distruggerebbero economicamente Berlusconi. È stato riferito che D'Alema avrebbe
detto (e non l'ha mai smentito) che il suo grande desiderio era quello di vedere
Berlusconi elemosinare nel parco. È stato anche riferito che altri esponenti Pds
avrebbero detto che lo stesso Berlusconi farebbe bene a lasciare l'Italia in
caso di loro vittoria perché l'avrebbero distrutto». Storie note, fra voci e
suggestioni, rimbalzate per molti anni nell'arena del bipolarismo italiano. Ma
certo, in quel fatale maggio di 22 anni fa, Bartholomew, scomparso nel 2012 a 76
anni, mette in fila gli elementi e prefigura il copione che puntualmente si
svolgerà nelle settimane successive: il 10 maggio, solo sei giorni dopo, il
Cavaliere giura ma la macchina bellica, per niente gioiosa, è già in moto. I
postcomunisti troveranno una sponda decisiva nell'azione della magistratura che
il 21 novembre uccide di fatto il governo inviando al premier un invito a
comparire per corruzione, recapitato direttamente in edicola dal Corriere della
sera. Per di più nelle stesse ore in cui Berlusconi è impegnato in una
conferenza internazionale contro la criminalità a Napoli. L'effetto è devastante
e si somma alle manovre di Palazzo del presidente Oscar Luigi Scalfaro, lo
stesso di cui altri report americani, pubblicati ieri in esclusiva dal Giornale,
documentano l'ostilità totale verso il Cavaliere. Un intruso da sloggiare prima
possibile, come ha svelato agli americani una fonte autorevolissima: l'ex
presidente della Repubblica Francesco Cossiga. «Cossiga - scriverà Bartholomew
il 20 dicembre, quando ormai Berlusconi è sull'orlo delle dimissioni - ha detto
di ritenere che Scalfaro farebbe qualunque cosa pur di evitare un ritorno di
Berlusconi al governo». Ma il 4 maggio 1994 la breve avventura del Cavaliere
deve ancora cominciare. Eppure, con alcuni distinguo e con la necessaria
prudenza, l'amministrazione democratica sembra accogliere senza diffidenza
l'uomo cresciuto lontano dal Palazzo: «Berlusconi è un uomo che si assume dei
rischi... che si è mosso in maniera rapida per colmare il vuoto politico
provocato da Tangentopoli». Del resto con straordinaria preveggenza in un altro
report, datato addirittura 15 ottobre '92, l'ambasciatore Peter Secchia, a Roma
prima di Bartholomew, già aveva battezzato il Cavaliere «come nuovo leader
politico», con la benedizione del declinante Craxi. E aveva evidenziato la sua
partecipazione a una cena organizzata dal segretario del Pli Renato Altissimo
per creare un soggetto politico in grado di raccogliere l'eredità del
pentapartito. «Il governo Berlusconi sembra cadere - scrive a dicembre
Bartholomew - E poi? Se cade - nota con un affilato giudizio controcorrente -
questo potrebbe rafforzare l'impressione che l'Italia stia scivolando indietro».
Da Scalfaro a Napolitano: le trame anti Cav del Colle nei
rapporti segreti Usa. Ecco le carte choc della
diplomazia americana che dimostrano il pressing del Quirinale dietro le cadute
dei governi Berlusconi nel 1994 e nel 2011, scrive Stefano Zurlo, Domenica
28/02/2016, su "Il Giornale". Strategie e complotti. Washington e Silvio
Berlusconi. Amministrazioni diverse, repubblicana e poi soprattutto democratica,
ma grande attenzione ai volteggi del Cavaliere, alle convulsioni della politica
italiana dominata da Berlusconi alle cospirazioni di Palazzo. Un monitoraggio
fittissimo e a tratti invasivo lungo un ventennio. Alcune carte inedite, oggi
pubblicate per la prima volta dal Giornale, documentano rapporti consolidati e
preferenziali con alcune personalità, dubbi e oscillazioni dei presidenti a
stelle e strisce e dei loro staff. Una mole di carte che Andrea Spiri,
professore a contratto alla Luiss, ha scovato al Dipartimento di Stato di
Washington, dopo la progressiva desecretazione dei file fra l'ottobre 2012 e il
dicembre 2015. Gli americani mostrano di avere antenne molto sensibili nel
nostro Paese e individuano subito, addirittura nell'ottobre '92, in piena
tempesta Mani pulite, Silvio Berlusconi come possibile leader di un nuovo
partito. Siamo molto prima della discesa in campo, a Washington sono gli ultimi
mesi della presidenza di Bush padre, ma i riflettori si accendono subito su un
futuro che ancora nessuno conosce. L'ambasciatore Peter Secchia invia un
documento classificato come confidential: Le incertezze italiane. La soluzione è
un nuovo partito politico? L'ambasciatore ha fatto indagini che riassume con
concisione e pragmatismo: «Il segretario del Pli Altissimo ha organizzato una
cena di lavoro segreta il 12 ottobre per proporre la formazione di un nuovo
partito... La cena si è tenuta il 13 ottobre presso il Grand Hotel. Da quanto
viene riferito il gruppo, di cui faceva parte il magnate dei media Berlusconi,
così come Francesco Cossiga, ha deciso di chiedere allo stesso Cossiga di
formare un nuovo partito... La partecipazione di Berlusconi è di speciale
significato, per via della vicinanza di Craxi. La sua apparizione come un nuovo
leader politico potrebbe avere la benedizione dello stesso Craxi. Comunque è
anche la riprova che la potenza di Craxi, duramente colpito dagli scandali,
continua a declinare». In ogni caso, «gli italiani - spiega - sono confusi e
cercano il cambiamento». Una discontinuità che porterà a Palazzo Chigi nel '94
proprio Berlusconi. Due anni più tardi, a fine '94, il nuovo ambasciatore
Reginald Bartholomew scrive a Washington e descrive con una certa preoccupazione
l'agonia del primo esecutivo Berlusconi, minato dall'avviso di garanzia e dalla
manovre del presidente Oscar Luigi Scalfaro. «Il governo Berlusconi - nota
l'ambasciatore - sembra cadere. E poi? Se cade, questo potrebbe rafforzare
l'impressione che l'Italia stia scivolando indietro verso la politica screditata
che ha visto succedersi dalla fine della Seconda guerra mondiale 52 governi.
Potrebbe inoltre consolidare la percezione che la politica operi essenzialmente
in maniera indipendente e lontana dalla gente». Bartholomew, insomma, ha più di
un dubbio sull'operazione in corso a Roma per sloggiare il Cavaliere. Ma non c'è
niente da fare. Il 20 dicembre, due giorni prima delle dimissioni, Bartholomew
invia una nota a Washington in cui spiega senza tanti giri di parole che il
presidente Scalfaro l'ha giurata a Berlusconi e vuole cacciarlo da Palazzo
Chigi. A svelargli gli intrighi è stato un testimone eccellente come Francesco
Cossiga. «Cossiga - scrive l'ambasciatore rivolgendosi alo staff di Bill Clinton
- ha sottolineato che uno dei fattori che stanno incidendo sulla crisi è la
rottura irrecuperabile fra Scalfaro e Berlusconi. Cossiga ha riferito che
Scalfaro si sentiva profondamente offeso dalle recenti batoste pubbliche
ricevute dai berlusconiani, in particolare dal portavoce del governo Ferrara.
Cossiga ha detto di ritenere che Scalfaro farebbe qualunque cosa pur di evitare
un ritorno di Berlusconi al governo». Il destino è segnato. Di crisi in crisi si
arriva fino all'attualità. E all'ultimo giro di valzer del Cavaliere a Palazzo
Chigi. A novembre 2011, con lo spread impazzito e la coppia Merkel-Sarkozy che
lo guarda con sorrisetti di scherno, Berlusconi getta la spugna. Il 12 novembre
il sottosegretario alla crescita economica Robert Hormats invia una mail a Jacob
Sullivan, capo dello staff del segretario di Stato Hillary Clinton. Hormats
riprende il report spedito il 9 novembre dall'ambasciatore David Thorne:
«Continuano i battibecchi politici, ma la direzione generale è fissata». Segue
un misterioso omissis. Quindi Thorne riprende: «Sono anche intervenuti la Merkel
e Sarkozy. Lo spread è sotto il picco, ma ancora molto alto. L'Italia sa quello
che deve fare. David». «Spero - riprende un per niente galvanizzato Hormats -
che Thorne abbia ragione, che l'Italia sappia quello che deve fare. Dovremmo
vedere se Monti può farcela con gli insofferenti e se può portare dalla sua
parte l'opinione pubblica. Egli è molto brillante, ma le sue capacità politiche
e motivazionali andranno verificate». E infatti Monti si rivelerà un disastro.
Intanto, Giorgio Napolitano, presunto regista del complotto anti Cav del 2011,
annuncia che non risponderà alle domande su quel che successe in quelle
settimane. Quel che è accaduto nel 2011 - confida all'Huffington Post - possono
ricavarsi da molteplici miei interventi pubblici. Non ritengo ritornarci
attraverso mie memorie che al pari dei miei predecessori non scriverò».
Così si decapita la democrazia. Un uomo
politico è stato fatto fuori con una sentenza anziché con il voto: i pm hanno un
potere illimitato, scrive Vittorio Feltri, Venerdì 02/08/2013, su "Il Giornale".
Fino all'ultimo non ci avevamo creduto. Pensavamo fosse impossibile che si
potesse far secco un uomo politico con una sentenza anziché col voto popolare. E
invece è successo proprio questo: Silvio Berlusconi è stato fatto fuori; non
potrà più mettere piede in Parlamento. Non solo perché la pena accessoria
(interdizione dai pubblici uffici) glielo vieta per un periodo ancora da
stabilirsi, ma anche perché esiste una legge, paradossalmente voluta dal
centrodestra, secondo la quale chi ha subìto una condanna superiore a due anni
di carcere non ha facoltà di presentarsi candidato alla Camera o al Senato.
Peggior disastro era inimmaginabile. Anzi, si supponeva che il terzo grado di
giudizio agisse con mano più leggera rispetto all'appello e trovasse il modo per
salvare capra e cavoli. Dove per capra si intende la dignità della giustizia,
che aveva infierito sull'imputato eccellente, e per cavoli si intende
l'equilibrio politico che la maggioranza cosiddetta delle larghe intese
garantiva all'Italia, sostenendo il governo guidato da Enrico Letta e tenuto a
battesimo dal presidente Giorgio Napolitano. Non è stato così. I giudici della
Corte di Cassazione, nonostante la difesa brillante dell'avvocato Franco Coppi,
affiancato dal collega Niccolò Ghedini, hanno preferito confermare il verdetto
infausto che costringe il fondatore di Forza Italia e del Popolo della libertà
ad arrendersi. Non è questa la sede più adatta per entrare nel merito delle
accuse rivolte al proprietario di Mediaset nonché capo carismatico del Pdl. Ci
limitiamo a valutare le conseguenze della sentenza. Che sono terribili per il
nostro Paese. L'eliminazione diremmo fisica di un soggetto politico importante,
quale è (era) il Cavaliere, per via giudiziaria, costituisce un precedente che
fa venire i brividi: la democrazia è stata per la prima volta decapitata in un
tribunale. Un fatto inedito e gravissimo che segna l'inizio, probabilmente, di
un'era in cui l'esito della lotta politica non sarà più determinato dal consenso
popolare, bensì dalle toghe cui gli stessi politici hanno consegnato poteri
illimitati, illudendosi di trarne chissà quali vantaggi. Ci riferiamo alla
rinuncia avvenuta vent'anni orsono, da parte dei deputati e dei senatori,
dell'immunità parlamentare che i padri costituenti avevano introdotto nella
Carta allo scopo di tutelare gli eletti nella loro libertà e indipendenza, anche
dalla magistratura. Abolita l'immunità, i parlamentari si sono esposti
all'azione penale obbligatoria col risultato che qualunque sostituto procuratore
può aprire un'inchiesta e portarla a compimento contro chi sia stato prescelto
dai cittadini e ne abbia ricevuto il mandato di rappresentarli alla Camera o in
Senato. Se poi aggiungiamo che, nel periodo di Tangentopoli e Mani pulite, si è
creata una strana alleanza tra sinistra e alcune toghe, si comprende il motivo
per il quale vari magistrati hanno dato l'impressione, col loro lavoro, di
favorire un partito danneggiandone altri. Naturalmente, queste sono chiacchiere,
il cui senso molti non condividono. Rimane il fatto storico che Berlusconi, da
quando ha smesso di fare l'imprenditore e si è gettato nell'agone politico, non
ha più avuto pace. I suoi guai giudiziari cominciarono infatti nel 1994, subito
dopo aver vinto le elezioni nazionali. Decine di processi, accuse d'ogni tipo,
perquisizioni, controlli. Mediaset non ha mai più avuto requie. E il suo
principale azionista, il Cavaliere, ha trascorso più tempo a difendersi che non
a curare gli interessi degli italiani che governava o che rappresentava
all'opposizione. Un fenomeno mai visto, al quale tuttavia ci eravamo abituati. A
un certo punto, Berlusconi indagato o processato non faceva più notizia. Era una
consuetudine. Tant'è che nessuno immaginava che egli potesse essere condannato.
Anche ieri, in attesa del verdetto della Cassazione, eravamo tutti tranquilli:
non lo condanneranno mai. La nostra fantasia, pur fervida, non contemplava l'ex
premier privato della libertà personale. Viceversa, è successo anche questo: in
galera. O ai domiciliari. O ai servizi sociali. Non sono i dettagli che contano
ma la liquidazione di un personaggio con le maniere forti. Quelle della legge.
Che non si discute. Chissà perché, poi, una sentenza emessa in nome del popolo
italiano non può essere discussa, ma solamente rispettata. C'è qualcosa di
abnorme, di assurdo. Quale futuro ci attende? Non lo sappiamo. Sappiamo però che
stiamo sprofondando. E la chiamano giustizia.
Silvio no, Matteo neppure Non è che il problema sono proprio i
magistrati? I magistrati si sentono dei padreterni e
rifiutano critiche desiderando continuare a spadroneggiare, scrive Vittorio
Feltri, Domenica 25/10/2015, su "Il Giornale". Ieri i giornaloni italiani,
Corriere e Repubblica, avevano in prima pagina un titolo dedicato allo scontro
tra toghe e governo. Le prime si lagnano con il secondo perché si sentono
delegittimate. Cosa vuol dire? Senza perderci in voli pindarici, semplifichiamo:
i magistrati, dei quali non voglio parlare male perché li temo (peggio, ne ho
una paura fottuta) ce l'hanno a morte con l'esecutivo, lo accusano di essere più
attento alle intercettazioni (odiate dai politici) che alla mafia. Il premier
Matteo Renzi risponde irritato: i giudici non fanno mai autocritica. Per pura
piaggeria sarei tentato di dare ragione ai signori della cosiddetta giustizia
allo scopo di tenermeli buoni, però non posso nascondere il sospetto che essi si
sentano dei padreterni e rifiutino critiche desiderando continuare a
spadroneggiare. Perché dico questo? Quando a menare il torrone era Silvio
Berlusconi, notoriamente intenzionato a riformare l'ordine giudiziario, i
magistrati hanno fatto il diavolo a quattro per incastrarlo e ci sono riusciti
alla grande, vincendo la partita. Tant'è che lo hanno messo fuori gioco
conservando i privilegi di cui godono da sempre. Poi è arrivato Renzi a Palazzo
Chigi ed è noto com'è andata. Il premier ha cercato di ridurre le loro ferie, ha
introdotto un ampliamento della possibilità di ricorso contro di loro in caso di
negligenza, senza contare altri ritocchi limitativi. Non entriamo nei dettagli
della mini riforma onde non annoiare il lettore che, comunque, avrà capito
quanto sia difficile disciplinare il lavoro nei tribunali. Ciò che ci sorprende
è il fatto che, a prescindere dal colore della maggioranza da cui dipende la
guida del Paese, i magistrati - non tutti, ma quasi - mal sopportino le
ingerenze nella loro attività, dando l'impressione di considerarsi intoccabili,
al di sopra di ogni autorità, come se costituissero una casta divina, non
soggetta ad alcun controllo. Perfino noantri, gente volgare, siamo consapevoli
che una Repubblica democratica si regga sull'equilibrio dei poteri: legislativo,
esecutivo e giudiziario. Ma non ignoriamo neppure che esista la legittima
possibilità che ciascuno di essi sia soggetto a modifiche tese a migliorare il
funzionamento dello Stato. Un esempio. Per quale motivo qualunque lavoratore che
commette un errore è chiamato a risponderne in sede penale o civile, tranne
colui che indossi una toga? I medici, ai quali la nostra vita è legata, se
sbagliano una diagnosi o una terapia, sono processati ed eventualmente obbligati
a risarcire, mentre i magistrati sono sollevati da responsabilità? Inoltre,
perché i dipendenti pubblici sono costretti a timbrare il cartellino, eccetto
lorsignori addetti all'amministrazione della giustizia? Ci sono giudici che si
portano a casa fascicoli giudiziari, nei quali chiunque, dai figli alle mogli e
alle collaboratrici domestiche, ha facoltà di ficcarvi il naso, quando invece
dovrebbero restare segreti? Non sarebbe il caso di rivedere certe norme? Vietato
anche solo parlarne senza suscitare reazioni scomposte da parte degli
interessati. Noi non siamo tifosi di Renzi, e il lettore se ne sarà accorto, ma
nella presente circostanza siamo con lui, che non ha in programma di distruggere
l'ordine giudiziario, bensì di renderlo compatibile con gli schemi vigenti in
altri settori, non solo pubblici. Suvvia magistrati, siamo nelle vostre mani; vi
preghiamo di averle pulite. Vi consigliamo altresì la lettura del libro di un
vostro collega aderente a Magistratura democratica, Piero Tony, ex procuratore
capo di Prato, ovviamente di sinistra, che ha denunciato le porcherie della
propria categoria. Un testo istruttivo, mai smentito, dove si scoprono molti
altarini e si dimostra quanto una riforma della corporazione non sia necessaria,
bensì indispensabile. Se destra e sinistra sono critiche nei confronti della
casta togata forse la casta stessa dovrebbe tacere e cogliere l'occasione per
farsi un esame di coscienza. Se ce l'ha. Dimenticavo il titolo del volume: Io
non posso tacere.
ECCO COME MD HA IMPEDITO OGNI RIFORMA.
Le mosse di Magistratura Democratica per bloccare le riforme della giustizia,
scrive Stefano Zurlo, Giovedì 15/08/2013, su "Il Giornale". Coincidenze. Un
ministro della Giustizia, Clemente Mastella, nella tenaglia della magistratura:
estate 2007, l’Anm,a trazione Magistratura democratica, minaccia scioperi se la
riforma della giustizia, ormai in dirittura d’arrivo, non seguirà le
indicazioni del partito dei giudici; dall’altra parte lo stesso Mastella,
continuamente al telefono con pm e giudici dell’Anm, è indagato a Catanzaro
nell’inchiesta Why Not. Domanda: si può scrivere un testo così importante sotto
la doppia pressione del partito dei giudici e di un’inchiesta? Ma questo è lo
stato dell’arte su un crinale decisivo nei rapporti fra politica e magistratura
e più in generale per la definizione del ruolo della magistratura in Italia. La
sfida è decisiva: in quei giorni convulsi di luglio Mastella viene bombardato
dall’Anm, il cui segretario è Nello Rossi di Md, perché siano recepite le
direttive delle toghe. Ma contemporaneamente si svolge una gara contro il tempo
perché il fallimento di Mastella farebbe scattare inesorabilmente la precedente
riforma Castelli, che per l’Anm è fumo negli occhi. Roberto Castelli,
Guardasigilli del governo Berlusconi, ha partorito un’ambiziosissima legge che
prevede, addirittura, la mitica separazione delle carriere. O meglio, prevedeva
perché i dubbi e qualcosa in più dei dubbi dei centristi hanno finito con
l’annacquare lo spirito della norma. La separazione delle carriere, di cui si
parla a vuoto da una ventina d’anni,è rimasta in un cassetto, perché per
portarla in porto sarebbe stato necessario passare per la cruna dell’ago di una
nuova legge costituzionale, figurarsi, ma Castelli ha tenuto duro. E ha
licenziato un testo che, in sintesi, colloca i pm da una parte e i giudici
dall’altra. È la separazione non delle carriere ma delle funzioni, il massimo
che si può fare in Italia, fra debolezze della politica e proteste dei giudici.
Il conto alla rovescia va avanti in quelle settimane: Mastella è bersagliato dai
vertici dell’Anm e, con il premier Romano Prodi, è sotto inchiesta a Catanzaro
dove Luigi De Magistris si avvale dell’opera di un consulente discusso,
Gioacchino Genchi. Mastella a fine mese porta a casa le norme che
disinnescheranno quelle targate Castelli. La controriforma Castelli, come
l’hanno bollata i signori dell’Anm. L’Italia, che oggi avrebbe bisogno di
cambiare marcia proprio sulla giustizia, sconta ritardi che sono anche il
frutto di quelle giornate. Mastella, pur di non perdere il treno, è andato
anche a genuflettersi al convegno di Md, ma è stato trattato con una certe
rudezza. Edmondo Bruti Liberati, oggi procuratore a Milano, gli ha risposto per
le rime: «Attendiamo i fatti» senza rilasciare «cambiali in bianco».E Nello
Rossi, segretario dell’Anm, è stato altrettanto chiaro: «Vogliamo vedere i
fatti e prima non faremo sconti a nessuno». Poi Mastella trova la quadra,
ovvero vara una riforma che piace ai magistrati e manda su tutte le furie gli
avvocati che da sempre denunciano lo strapotere dell’accusa nelle aule di
giustizia. Non importa, va bene così. Il comitato direttivo centrale dell’Anm -
la terminologia è ancora sovietica approva con i voti decisivi di Md e delle
altre correnti di sinistra il documento che fa retromarcia sugli scioperi.
Tutti al lavoro. «Con la revoca della mia riforma- commenta amaro Castelli -
emerge la verità vera che avevo previsto. L’agitazione è finita». Coincidenze.
De Magistris e l’indagine vengono spazzati via dal Csm. Per la cronaca Roma
indaga e Rossi sequestra l’archivio Genchi in cui c’è anche una telefonata fra
lo stesso Rossi e Mastella, indagato da De Magistris e Genchi ma autore di una
riforma non sgradita a Rossi. Sembra una filastrocca. La giustizia è passata e
passa ancora oggi lungo questi tornanti.
Un campionato truccato. La magistratura di sinistra è realtà: il
pm indaga e propone, il suo compagno di corrente giudice dispone.
Una anomalia che ormai si è radicata in tutti i livelli di
giudizio, scrive Alessandro Sallusti, Lunedì 12/08/2013, su "Il Giornale". La
magistratura di sinistra, ideologica e settaria, non è un'invenzione, o
addirittura una paranoia, del berlusconismo. Nel corso degli anni le toghe rosse
hanno seminato tracce documentali che le configurano come una setta a tratti
segreta. Lo ammise anche Massimo Caprara, segretario particolare di Palmiro
Togliatti e membro del comitato centrale del Pci. Nel 2005, testimoniando a
Trento in un processo per diffamazione, Caprara svelò l'esistenza di un registro
segreto di magistrati iscritti al Pci che era custodito a Mosca. Craxi, in tempi
non sospetti, confidò di essere venuto a conoscenza di scuole del Pci per
formare magistrati organici al partito e Cossiga, nel 1997, ascoltato dalla
commissione stragi, sostenne che la magistratura occupava uno dei livelli della
Gladio rossa, la struttura paramilitare e clandestina che doveva essere pronta a
ribaltare lo Stato democratico. A metà degli anni Sessanta accadde un fatto
nuovo, destinato a cambiare per sempre la giustizia italiana. Alcuni magistrati
uscirono allo scoperto fondando, cosa senza precedenti in Paesi occidentali, una
corrente ideologica di sinistra chiamata Magistratura democratica, alla quale
aderì (e aderirà più tardi) la maggior parte dei pm e dei giudici italiani, poi
protagonisti delle inchieste che azzerarono tutti i partiti meno il Pci
(Tangentopoli) e più di recente della maggior parte dei 42 processi contro
Berlusconi. Il Pm indaga e propone, il suo compagno di corrente giudice dispone.
Chi è iscritto a Magistratura democratica fa politica, dichiara la sua fede e
combatte apertamente le altre, partecipa a convegni e dibattiti per orientare
scelte legislative, alcuni si fanno eleggere in Parlamento, ne abbiamo pure
visto uno, Ingroia, fondare un partito e candidarsi premier contro i suoi
inquisiti di centrodestra. Una anomalia che ormai si è radicata in tutti i
livelli di giudizio. Nella corte che ha confermato il carcere per Berlusconi ben
due giudici, De Marzo e Aprile, erano di area Md. Può un magistrato che dichiara
la sua idea politica, e sostiene di volerla imporre, giudicare serenamente
politici di segno opposto? È come se un giocatore arbitrasse la partita della
vita della sua squadra. La partita sarebbe truccata a prescindere, come quella
che ha visto in campo Berlusconi. E questo lo sa bene anche Napolitano, che da
quel mondo viene.
Ecco la vera storia di «Md»: i giudici rossi che fanno politica.
Così Magistratura democratica ha acquisito potere e
condizionato le scelte dei partiti La regola sin dall'inizio: le toghe devono
schierarsi e cercare il consenso della piazza, scrive Stefano Zurlo, Lunedì
12/08/2013, su "Il Giornale". Sono di sinistra e hanno accompagnato la storia
della sinistra italiana. I giudici di Magistratura democratica sono diventati
anche uno dei più famosi brand d'Italia da quando il Cavaliere ha dichiarato
loro guerra. Forse, ingenuamente, qualche anima bella penserà che chiamarle
toghe rosse sia una forzatura del nostro bipolarismo muscolare, ma non è così. O
meglio, la storia di questa costola del potere giudiziario è un riassunto delle
ideologie, degli ideali, delle ubriacature, dei condizionamenti e delle
illusioni che hanno animato il versante della magistratura che da sempre ha
coltivato ambizioni progressiste. Risultato: in un sistema malato, in cui le
toghe sono divise in correnti e le correnti compongono una sorta di parlamento
parallelo, Md è uno degli attori del sistema politico italiano. Inutile
scandalizzarsi: in Italia, come ha spiegato a suo tempo Antonio Ingroia al
Giornale, «la magistratura si concepisce per metà come corporazione per metà
come contropotere». Ecco, Md è o dovrebbe essere, perché poi spesso è diventata
il suo esatto contrario, il contropotere che si oppone alla presunta casta,
coglie le sensibilità più profonde del Paese, cattura le esigenze e le istanze
sociali più avanzate, capovolgendo gli equilibri reali dentro le istituzioni. Si
può essere d'accordo o no, ma questo è un po' il senso dei tanti manifesti e
proclami e documenti elaborati in questi lunghi anni dalle teste d'uovo della
corrente. Citiamo, per esempio, Livio Pepino con il suo articolo Appunti per la
storia di Magistratura democratica. Scrive il magistrato: «Che Magistratura
democratica sia stata (sia) la sinistra della magistratura è noto e da sempre
rivendicato». Questo l'incipit che toglie ogni ambiguità e fraintendimento.
Certo, questo non vuol dire che i magistrati siano pedine del sistema dei
partiti, dal Pci e dai suoi eredi a Rifondazione, ma indica comunque una precisa
collocazione. Ma Pepino va ben oltre, verso la militanza attiva: «La rottura con
il passato è radicale e gravida di conseguenze: ad una magistratura longa manus
del governo, si addice, infatti, un modello di giudice burocrate e neutrale,
mentre ad una magistratura radicata nella società più che nell'istituzione deve
corrispondere un giudice consapevole della propria autonomia, attento alle
dinamiche sociali e di esse partecipe». Eccolo qui il magistrato che si afferma
come contropotere: questo giudice fugge dal Palazzo, inteso come luogo di
conservazione e di stagnazione, e si mette in testa al popolo, ne guida le
battaglie, lo conduce verso la liberazione, come nel celebre dipinto di Pellizza
da Volpedo Il Quarto Stato. Si dirà che si tratta di suggestioni ma non è non è
così. E Pepino, in quel testo, lo spiega fin troppo bene: «Il dogma
dell'apoliticità si rovescia nel suo contrario». La magistratura fa politica.
Appunto. Md fa politica, da sinistra. Anche se fuori dal parlamento e senza
tessere. È tutto scritto e declamato nei sacri testi. Nei comizi. Nei convegni.
Nelle controinaugurazioni dell'anno giudiziario. Nei pugni alzati, come al
funerale di Ottorino Pesce, anima della sezione romana di Md, morto nel gennaio
'70. È quasi cinquant'anni ormai che Md cerca la sua bussola nel grande
arcipelago della sinistra. Talvolta soffrendo di collateralismo, talvolta
cercando di dettare la linea al Pci-Pds e alle altre sigle della sinistra,
oppure ancora spaccandosi al suo interno fra ortodossi e movimentisti e fra
garantisti e giustizialisti. Se un giudice, per stare ancora a Pepino, fa a
pezzi il modello basato sulla neutralità, sceglie «l'opzione di sinistra»,
testuale, «fa la sua scelta di campo», afferma il suo «sentirsi dalla parte dei
soggetti sottoprotetti», fin dove si può spingere? Siamo su un piano inclinato
su cui, sin dall'atto di fondazione del 27 luglio 1964, e poi attraverso la
virata del 30 novembre 1969, si sono esercitate almeno due generazioni di toghe,
con risultati che è difficile riassumere. Ma certo si tratta di alcuni dei nomi
più noti della magistratura italiana: da Gian Carlo Caselli a Gerardo D'Ambrosio
e a Gherardo Colombo, per rimanere fra Palermo e Milano, fra i processi alla
cupola, ad Andreotti e a Dell'Utri e l'epopea di Mani pulite. E poi Livio
Pepino, Vittorio Borraccetti, Elena Paciotti, Giuseppe Palombarini, autore del
fondamentale Giudici a sinistra. Ma l'elenco è chilometrico. E molti i tornanti,
le curve, le risse, le divisioni e le ricomposizioni, le diverse sottolineature.
Qualcuno, brutalmente, ritiene che la parabola di Md sia quella di un movimento
che porta aria fresca nelle ovattate stanze degli ermellini, rompe tabù,
distrugge un vecchio e logoro apparato di relazioni elitarie, poi piano piano,
di emergenza in emergenza, fra il terrorismo e tangentopoli, si appiattisce
sulle posizioni giustizialiste. Quelli di Md, con dietro tutti gli altri, un
tempo ribattezzati per la loro furia culturale gli iconoclasti, diventano i
picconatori della Prima repubblica e poi del berlusconismo consegnando i
santuari del potere ai postcomunisti. E così la sinistra vince in Italia
passando per la scorciatoia della via giudiziaria, ma dopo essere stata
sconfitta proprio sul piano delle idee, delle ideologie e degli ideali
naufragati fra le macerie del Muro di Berlino. È la storia drammatica che
Francesco Misiani racconta nel suo bellissimo La toga rossa. Una lunga cavalcata
nelle contraddizioni dei magistrati rossi: dall'epoca dei processi popolari, cui
il giovane e compiaciuto Misiani assiste in Cina, all'ubriacatura da manette ai
tempi di Tangentopoli quando le tentazione di abbattere un sistema marcio entra
a piedi uniti anche nelle aule di giustizia. Il matrimonio è arrivato nel grande
braciere di Mani pulite, scrive "Il Giornale" il 27/11/2013. Un partito ormai
svuotato, senza ideologia, ha sposato un'ideologia senza partito, ovvero
Magistratura democratica, la corrente di sinistra delle toghe italiane. La
corporazione ha orientato l'ago della sua bussola sull'antiberlusconismo, la
sinistra si è accodata. Non è una fiction, ma il pensiero di un ex di Md, Sergio
d'Angelo, oggi in pensione, ma per lunghi anni giudice a Milano. D'Angelo, dopo
le tante giravolte e contorsioni dei colleghi, se n'è andato. E oggi consegna
al Giornale un memoriale sul rapporto malato fra politica e giustizia.
Primavera '93. Nei lunghi corridoi dechirichiani della Procura di Milano
incrocio il capo del Pool Gerardo D'Ambrosio, scrive Stefano Zurlo, Venerdì
29/11/2013, su "Il Giornale". Lui mi concede al volo un'intervista clamorosa:
«Mani pulite è finita». Peccato che in quelle settimane Tiziana Parenti stia
indagando sul cosiddetto fronte orientale di Tangentopoli. Impresa
difficilissima, fra reticenze, silenzi, difese d'ufficio. Botteghe oscure
resiste all'assalto dei pm milanesi. Qualche giorno dopo la Parenti, sempre più
emarginata e destinata ad uscire da quel gruppo, me lo dirà apertamente: «La sua
intervista mi ha delegittimato. Ho capito che non sarei andata da nessuna
parte». Sono passati vent'anni, il Pci-Pds è passato indenne, o quasi,
attraverso le forche caudine della magistratura di rito ambrosiano e ha
assaporato il potere, salvo poi farselo portare via da un certo Silvio
Berlusconi e avviarsi a recuperarlo, giusto l'altro ieri e cambiato ancora il
nome, con l'estromissione del Cavaliere dal Senato. La battaglia
politico-giudiziaria va avanti intrecciata e confusa. E proprio di quella
stagione gloriosa e terribile, ancora oggi controversa, parla Sergio d'Angelo
nella terza puntata del memoriale scritto in esclusiva per il Giornale.
D'Angelo, che per molti anni è stato fra i membri di Magistratura democratica e
Milano e ora è in pensione, lo sguardo critico e anche di più sullo specchietto
retrovisore del suo passato, si sofferma proprio su quel periodo e fa scorrere
le facce dei magistrati che, fra avvisi di garanzia e tintinnar di manette,
hanno scritto un pezzo della nostra storia. Per D'Angelo è proprio in quei mesi
che si realizza il matrimonio fra Md, insomma la costola sempre inquieta della
sinistra in toga, e gli eredi del Partito comunista. Un partito senza ideologia,
smarritosi sotto le macerie del Muro di Berlino, sposa un'ideologia senza
partito, quella dei giudici che dagli anni Sessanta hanno elaborato una loro
strategia per cambiare i rapporti di forza dentro il potere giudiziario e poi
per entrare nei Palazzi della nomenklatura. La lunga marcia di Md, fra bandiere
rosse pugni chiusi, si compie secondo d'Angelo, con «l'occupazione» del partito.
Contemporaneamente, e se ne parlerà nella parte conclusiva del saggio,
l'ideologia forte delle toghe forti -gli iconoclasti per usare un termine allora
in voga - inizia a contaminare tutta la magistratura. Compatta conservatori e
progressisti. E troverà la sua declinazione, quasi la sua colonna sonora,
nell'antiberlusconismo. Fino all'epilogo drammatico di queste ore.
Da vent'anni è in corso una guerra tra magistratura e mondo politico, scrive "Il
Giornale" il 01/12/2013. Il cuore del problema è la messe di privilegi cui la
casta in toga non vuole rinunciare, grazie soprattutto agli eredi dell'ex Pci
cresciuti all'ombra del giustizialismo propagandato dall'ala più massimalista di
Magistratura democratica. L'ideologia senza partito di Md, che sogna di essere
una delle colonne della lotta di classe, ha sposato un partito senza ideologia
come il Pci-Pds-Ds-Pd per combattere chi aveva deciso di ostacolare il loro
piano di potere: Bettino Craxi prima, Silvio Berlusconi poi. In mezzo c'è un
Paese dilaniato tra le macerie.
Falce, Falcone e martello. Falcone è
stato ucciso da Cosa Nostra, o forse no. Mai la giurisprudenza ha seguito la
"pista russa". Oggi esce in italia un libro che cerca di fare luce sulla
vicenda: "Il viaggio di Falcone a Mosca", scrive Paolo Guzzanti, Sabato
31/10/2015, su "Il Giornale". Nessuno ha mai saputo dire per quale motivo
preciso Giovanni Falcone fu assassinato. Leggeremo il libro di Valentin
Stepankov, ex procuratore russo e amico di Falcone, e del giornalista Francesco
Bigazzi «Il viaggio di Falcone a Mosca» (Mondadori) con nuovi documenti sullo
scenario che in sede giudiziaria italiana è stato evitato come la peste.
Sostenere che Cosa Nostra abbia ucciso Falcone perché era «il più grande nemico
della mafia» è puerile, ma anche fraudolento: Cosa Nostra non dà premi Oscar
alla carriera. La mafia è una macchina per fare soldi, non per vendette
teatrali. Quando Cosa Nostra uccide, c'è sempre un motivo gravissimo e
immediato. Dunque: per schivare quale pericolo imminente fu assassinato Falcone?
Quando arrivò a Mosca la notizia della sua morte, il procuratore Valentin
Stepankov ebbe un collasso, disse di aver capito l'antifona e lasciò il suo
posto, ufficialmente per dissensi politici. Tutti coloro che in Italia
dovrebbero sapere, sanno della pista seguita da Falcone «following the money»,
ovvero seguendo il cammino in Italia del tesoro del Kgb e del Pcus.
L'ambasciatore russo Anatolij Adamiscin supplicò Cossiga di intervenire. Cossiga
si rivolse ad Andreotti che suggerì Falcone come investigatore non ufficiale.
Non aveva poteri di magistrato inquirente, ma li aveva il suo amico e confidente
Paolo Borsellino. Falcone non fece in tempo ad andare a Mosca e il 23 maggio
1992 fu Capaci. Seguì, dopo meno di tre mesi, via D'Amelio.
Rubli, falce e tritolo. Le lunghe ombre russe sulla morte di
Falcone. Nuove carte svelano gli intrecci tra mafia
dell'Urss, Cremlino e Pci. Il magistrato doveva recarsi a Mosca per indagare sui
finanziamenti ai partiti "fratelli". Ma non fece in tempo..,scrive Dario
Fertilio, Mercoledì 28/10/2015, su "Il Giornale". Un secolo e mezzo fa, per
Marx, l'ideologia era «la falsa coscienza della classe al potere». Mai l'autore
de Il Capitale ne avrebbe immaginato una versione aggiornata così: «l'ideologia
comunista è la falsa coscienza della mafia al potere». Eppure, anche in termini
rigorosamente marxiani, questa conclusione pare ineccepibile dopo aver letto Il
viaggio di Falcone a Mosca, saggio firmato da Francesco Bigazzi e Valentin
Stepankov in uscita per Mondadori (pagg. 156, euro 20). Perché l'immagine degli
ultimi giorni dell'Urss e di quelli immediatamente successivi, impressi nei
nuovi documenti raccolti dal giornalista italiano, già autore con Valerio Riva
del fondamentale Oro da Mosca, e dal primo procuratore della Federazione Russa
dopo il crollo del gigante totalitario, mostrano un panorama di macerie
impressionante: senza nulla di grandioso, e invece percorso da torme di
criminali e lezzo di corruzione che soltanto i compartimenti stagni del regime
avevano saputo fino all'ultimo dissimulare. Non bisogna pensare che il termine
mafia sia metaforico: qui batte il cuore di tenebra dell'Urss, centro propulsore
di una criminalità organizzata prima sotto le insegne della falce e martello e
poi, strappate le insegne di partito, alleata dei malavitosi di tutto il mondo,
da Cosa Nostra alla Yakuza giapponese, dalla Triade cinese alle famiglie di New
York. I documenti mettono in luce la stretta continuità fra la gestione segreta
del denaro statale al tempo del potere sovietico, il suo utilizzo all'estero
sotto forma di finanziamento ai partiti fratelli - primo fra tutti il Pci - e il
programma di sopravvivenza al crollo del sistema: una trama di conti segreti,
tra cui l'ingegnoso quanto spregiudicato utilizzo di aziende partecipate dai
partiti comunisti stranieri - di cui il sistema delle cooperative del Pci
rappresentava un modello - e il possibile riciclaggio di quegli ingenti
«contributi» da parte di organizzazioni criminali. E qui entra in campo il nome
di Giovanni Falcone richiamato nel titolo: non solo nel suo ruolo simbolico di
nemico numero uno della mafia italiana, assassinato a Capaci, ma anche in
qualità di investigatore a tutto campo, teso a scoprire i segreti dei legami tra
il Pci e il Pcus, in particolare quelli riguardanti i finanziamenti a Botteghe
Oscure e le cosiddette «attività speciali» di Mosca all'estero. È Falcone che,
durante una visita a Roma del collega russo nel maggio del fatale 1992, scopre
un'affinità elettiva con Valentin Stepankov, al punto da programmare con lui un
successivo viaggio a Mosca. Le loro strade erano fatte per incrociarsi: Falcone,
rivela Stepankov, aveva tra l'altro il compito di accertare se, nell'ambito dei
finanziamenti inviati dal Pcus al Pci, fosse stato istituito un canale per
finanziare anche le Brigate rosse e la cosiddetta «Gladio rossa»,
un'organizzazione clandestina tesa al sovvertimento violento della democrazia in
Italia. A sua volta, Stepankov si aspettava dal collega italiano un aiuto di
fondamentale importanza per rintracciare il percorso dell'«oro da Mosca»,
volatilizzatosi proprio nei giorni immediatamente successivi al fallito golpe
comunista contro la nascente democrazia. Stepankov era convinto che per portare
a termine questo compito fosse intervenuta una cooperazione tra mafia italiana e
«alcuni personaggi del Pci». Non il partito in quanto tale, piuttosto suoi
singoli esponenti collusi con la criminalità organizzata. Per non perdere tempo,
l'intrepido Stepankov inviò anche alla Procura di Roma tutta la documentazione,
e una parte dell'istruttoria raccolta per il processo che doveva essere
intentato agli autori del fallito golpe. Una simile coppia di ferro costituiva
un pericolo mortale per la nomenklatura sovietica alleata di Cosa Nostra. Venne
spezzata dai cinque quintali di tritolo fatti esplodere a Capaci il 23 maggio
del 1992.Tutto, o quasi, oggi si conosce sull'identità degli esecutori. Ma
l'attentato venne attuato con una tecnica militare così raffinata da far
apparire subito la sua matrice quantomeno sospetta. E Stepankov, che se ne
intende, non manca di farne notare l'effetto principale: le inchieste avviate
con Falcone finirono su un binario morto. Aggiunge la sensazione che il collega
italiano possa «essere stato danneggiato dalle attività» che stava conducendo al
suo fianco. E conclude: gli attentatori hanno raggiunto «l'obiettivo di impedire
il suo viaggio a Mosca».La collaborazione italo-russa, in realtà, continuò, ma
il vento della politica stava cambiando. Lo stesso Stepankov, dopo aver sfidato
il presidente Boris Eltsin condannando il bombardamento della sede dove si erano
asserragliati i parlamentari ribelli della Duma, fu costretto a dimettersi. Fine
della storia? Non del tutto, anche se l'«oro del Pcus» svanisce nel nulla, in un
vorticoso valzer d'investimenti immobiliari, nascite e morti di società
fittizie. Proprio come - rivelano i documenti - sognava a suo tempo il tesoriere
del Pcus, Nikolaj Krucina. E l'insegnamento che se ne trae? Se dietro a ogni
sistema totalitario si nasconde una piovra mafiosa, non basta tagliarne alcuni
tentacoli per farla morire. Il diritto sovietico, fino alla caduta, si basava
sul teorema Pashukanis: un reato si giudica principalmente secondo il grado di
pericolosità per il regime. Il «ladro in legge» (in russo, vor v zakone) aveva
poteri più grandi del padrino in Sicilia: come se avesse ricevuto una delega
dallo Stato, controllava tutte le attività criminali e doveva rispondere solo ai
capi dei servizi di sicurezza. Il bilancio del Pcus era per così dire in nero,
sottratto senza controllo a quello ufficiale. E il suo «tesoro», nonché i beni
dell'Urss rimasti all'estero - il ricchissimo patrimonio immobiliare sparso in
tutto il mondo e i fondi clandestini che per decenni erano stati messi a
disposizione non solo del Kgb, ma anche di altri servizi segreti militari e
politici - diventarono la grande torta da spartire e proteggere a colpi di mitra
e pistola Makarov. E, forse, anche di tritolo.
I soldi del Pcus e gli omicidi Falcone e Borsellino.
Un libro torna sull'indagine che il magistrato ucciso a Capaci
stava svolgendo sul denaro che da Mosca arrivava al Pci. Dell'inchiesta non si
parlo più, scrive Paolo Guzzanti, Giovedì 12/11/2015, su "Il Giornale". «Chi ha
ammazzato il povero Ivan?», titolava un giornale russo dando la notizia della
strage di Capaci e della morte di Giovanni (Ivan in russo) Falcone avvenuta il
23 maggio del 1992. «Chi ha ammazzato il povero Ivan» è il verso di una
filastrocca popolare russa simile a «Maramao perché sei morto?». Il significato
era ironico: tutti avevano capito chi ha ammazzato il povero Ivan. E perché.
Giovanni Falcone era molto popolare presso l'opinione pubblica russa ancora
stordita dalla fine della dittatura comunista e dell'Unione Sovietica. Lo era
diventato ancora di più quando aveva stretto un rapporto di ferro con il
procuratore generale russo Valentin Stepankov. «Ivan» era così diventato per i
russi non soltanto l'alleato, ma anche il maestro di Stepankov, autore del libro
Il viaggio di Falcone a Mosca con Francesco Bigazzi (Mondadori, pagg. 156, euro
20) e già recensito su queste colonne da Dario Fertilio il 28 ottobre scorso. Il
viaggio di Falcone a Mosca non ebbe mai luogo: la strage avvenne poche settimane
prima della data concordata. Si realizzava così la cinica massima di Stalin:
«Dove c'è uomo, c'è problema. Niente più uomo, niente più problema». Quando fu
ucciso, Falcone non aveva più poteri da procuratore, confinato dietro la
scrivania di Direttore degli affari penali in via Arenula a Roma. Francesco
Cossiga mi raccontò che l'ambasciatore russo Anatolij Adamiscin era venuto a
trovarlo agitatissimo. «Si può sapere a che gioco giocano gli italiani? Perché
nessuno interviene?». Il presidente della Repubblica apprese così da Adamiscin
che fra il 1991 e l'inizio del 1992, la Repubblica Russa ex Sovietica era stata
dissanguata dall'esportazione del tesoro del Pcus, dei fondi segreti del Kgb e
di molti patrimoni occulti della nomenklatura sovietica. «Adamiscin disse
Cossiga parlò della più devastante operazione criminale-finanziaria di tutti i
tempi». Secondo l'ambasciatore, il tesoro di Mosca era stato fatto affluire in
Italia attraverso canali finanziari già usati per il trasferimento di «aiuti ai
partiti fratelli» e alle loro aziende. Cossiga parlò con il presidente del
Consiglio Giulio Andreotti, che era allora in corsa per il Quirinale, benché
l'assassinio del suo proconsole siciliano Salvo Lima, il 12 marzo di quell'anno,
l'avesse ormai azzoppato. Andreotti rispose: «Sì, bisogna fare qualcosa. Ma non
sono io la persona adatta: se tiro in ballo il Pcus e il Kgb potrei solo
irritare i comunisti, mentre i loro voti mi sono indispensabili. Ho un'idea:
chiama Giovanni Falcone e chiedigli di dare una mano con discrezione. Gli
fornirò la copertura diplomatica». Cossiga convocò così il giudice e gli fece la
proposta che, se non era indecente, era almeno stravagante, visto che Falcone
non aveva più il potere giudiziario di indagare: «Dobbiamo far capire ai russi
che prendiamo sul serio il problema. Sono sicuri che dietro il trasferimento di
fondi ci siano entità potenti che vanno oltre la vecchia filiera dei
finanziamenti del Pcus al Pci». Falcone accettò e si gettò a capofitto
nell'inchiesta che aveva a un capolinea Mosca e all'altro Palermo e Roma. Cercò
Stepankov, che lo raggiunse a Roma. I due si piacquero molto. Claudio Martelli,
che era stato ministro di Grazia e giustizia all'epoca della strage di Capaci,
alla presentazione del libro Oro da Mosca di Valerio Riva e Francesco Bigazzi
(Mondadori, 1999) - cui parteciparono lo stesso Valentin Stepankov e Giulio
Andreotti - rievocò lo stato d'animo di Falcone: «Un giorno venne in ufficio da
me. Era molto eccitato perché aveva avuto un'eccellente impressione di Stepankov
(un uomo di prim'ordine) e poi per la materia evidentemente incandescente di cui
si stava occupando». «Incandescente» è un aggettivo appropriato. Tre giorni dopo
Capaci, il quotidiano russo Izvestia (Notizie, già organo dei soviet dal 1917)
pubblicò un articolo subito ripreso dal Corriere della Sera in cui si leggeva
che «l'omicidio del magistrato è probabilmente connesso con quel che avviene in
Russia, visto che era stato incaricato di coordinare le indagini sul riciclaggio
dei fondi del Pcus in Italia, su invito dell'ex presidente Cossiga». Falcone,
scriveva Izvestia, «lavorava in coordinazione con la brigata speciale che si
occupa della medesima indagine a Mosca sui fondi trafugati dal Pcus e portati
all'estero prima del crollo del regime comunista». L'Italia, secondo Izvestia,
«faceva parte del ristretto numero di Paesi in cui i soldi del partito e dello
Stato sovietico scorrevano a fiumi: solo negli anni Settanta, sei milioni di
dollari erano stati trasferiti annualmente dal Politburo come aiuto fraterno. La
cosa più probabile è che i soldi del partito e dello Stato fossero pompati nelle
strutture occulte italiane. L'Italia non è stata scelta a caso, visti gli
investimenti del Partito comunista, le strutture della mafia molto sviluppate,
la posizione di forza dei comunisti locali, i solidi contatti stabiliti da
tempo: tutto ciò prometteva grandi profitti agli investitori. Già alla fine del
1991 il procuratore generale della Russia, Valentin Stepankov, aveva incontrato
Falcone a Roma. E da allora i due si scrivevano costantemente, concordavano
incontri di persona e pianificavano azioni comuni dei giudici italiani e
russi...». Nello stesso articolo si sostiene che i miliardi trafugati e portati
in Italia potessero essere riciclati soprattutto attraverso canali mafiosi. Dirà
nel 1999 Stepankov alla presentazione del libro Oro da Mosca: «Ho avuto due
incontri con Falcone. Gli ho raccontato dei metodi utilizzati per il
trasferimento dei soldi in Italia e lui mi rispose che il presidente della
Repubblica gli aveva chiesto di scoprire che fine facevano questi soldi. Quando
sono tornato in Russia, lo invitai ufficialmente, ma dopo il telegramma di
conferma, abbiamo saputo della sua tragica morte». La divisione dei compiti fra
Stepankov e Falcone era chiara: il primo si occupava di indagare su quel che
succedeva alla valuta in uscita e Falcone cercava i punti d'arrivo. Lo shock che
investì il Parlamento italiano per la strage di Capaci produsse l'elezione
accelerata di un presidente istituzionale, Oscar Luigi Scalfaro. Andreotti si
era dimesso e gli era succeduto al governo Giuliano Amato, il quale,
partecipando il 28 luglio alla trasmissione di Alberto La Volpe Lezioni di
mafia, disse: «Una cosa è certa: Cosa Nostra non è soltanto italiana». E poi:
«Non c'è più bisogno di infiltrare il Kgb, che forse infiltrava noi. Dobbiamo
usare l'intelligence per avere più occhi ed orecchie dentro la mafia».
Paolo Cirino Pomicino pubblicò nel 2000 il libro Strettamente Riservato
(Mondadori) in cui scrisse: «Giovanni Falcone avrebbe dovuto incontrare a Mosca
il procuratore Valentin Stepankov, che indagava sull'uscita dalla Russia di
somme ingenti di denaro nelle disponibilità del Pcus. Stepankov ha detto che
dopo la morte di Falcone, nessuno gli ha mai più chiesto nulla. Come mai Falcone
svolgeva indagini non più di sua competenza? Tutte le conoscenze che Falcone
aveva sui flussi di denaro sporco passarono allora a Paolo Borsellino che, a sua
volta, secondo l'annuncio dato da Scotti e Martelli in tv, avrebbe dovuto
assumere la guida della Procura nazionale antimafia. Fu la sua condanna a morte.
Due mesi dopo Borsellino saltò in aria alla stessa maniera di Falcone». Vincenzo
Scotti era allora ministro dell'Interno. Il 18 giugno del 1992 (lo riferì la
Repubblica) disse ai corrispondenti della stampa estera: «La decisione di
uccidere Giovanni Falcone e l'organizzazione dell'attentato non sono stati
soltanto opera della mafia siciliana». Il direttore dell'agenzia spagnola Efe,
Nemesio Rodriguez, scrisse una lunga nota in cui riferiva che il ministro degli
Interni italiano «si è detto convinto che l'assassinio di Falcone va molto al di
là dei confini nazionali...». E poi: «La mafia non può essere considerata
soltanto un problema italiano. È invece un problema internazionale perché
internazionali sono i rapporti di Cosa Nostra, internazionali i suoi interessi e
complicità, su scala internazionale le sue operazioni di riciclaggio». Lo
storico Giancarlo Lehner, che è stato per anni mio compagno di banco alla
Camera, mi raccontò un retroscena che definire inquietante è poco. Mi disse di
aver progettato un libro sulla morte di Falcone e che la notizia era stata
pubblicata da un settimanale. Giulio Andreotti gli telefonò: «Mi venga a
trovare. Forse posso fornirle dei documenti». Lehner andò nello studio di piazza
San Lorenzo in Lucina ed Andreotti gli disse di aver personalmente fornito a
Falcone la copertura diplomatica per lavorare con Stepankov e la sua squadra di
investigatori sul riciclaggio del tesoro sovietico in Italia: «Al ministero
degli Esteri ci sono tutti i dispacci che davano la necessaria copertura
diplomatica a Falcone. Posso farglieli avere come prova documentale di quel che
cerca». Lehner ringraziò e attese. Ma Andreotti lo chiamò di nuovo nel suo
studio: «Se posso darle un consiglio, lasci perdere il suo libro sulla morte di
Falcone». Lehner era sbalordito. Andreotti spiegò: «Alla Farnesina, dove non si
è mai perso neanche un francobollo, mi hanno detto che i documenti della
missione di Falcone non si trovano più. È impossibile. Devo concludere che sono
stati eliminati da una entità più forte di noi». Di questa vicenda parlammo
insieme un giorno alla Camera Lehner, Andreotti ed io. Andreotti confermò con il
suo sorriso enigmatico di chi preferirebbe cambiare discorso. Il procuratore
nazionale antimafia Piero Grasso disse il 27 ottobre 2009, davanti alla
Commissione Antimafia: «Resta il sospetto che l'attentato non sia stato opera
solo di Cosa nostra». Morto Falcone e ucciso Paolo Borsellino, che aveva
ereditato l'inchiesta del suo amico, tutto si fermò. La memoria di quel che era
successo fu rapidamente resettata e oggi pochi ricordano questi fatti. Nessuno
ha scoperto, o voluto scoprire, a quanto ammontasse il tesoro sovietico arrivato
in Italia e che molto probabilmente modificò la storia del nostro Paese.
Stepankov ha confermato che l'inchiesta avviata con grande slancio fu
abbandonata. Diventò obbligatorio da allora negare che la morte di Falcone e
Borsellino fosse probabilmente collegata alla storia del tesoro russo
inghiottito in Italia. Fu così scelta, per dare un senso alle stragi di Capaci e
via D'Amelio, eseguite con una regia e con strumenti che non appartengono
all'identità della mafia siciliana, la sacra versione semi-teologica di una
mafia che si comporta come un anti-Stato e che quindi colpisce i «simboli» dello
Stato, cosa che la mafia non si è mai sognata di fare. Resta dunque aperta la
questione: chi ha deciso la morte del povero Ivan e poi di Paolo Borsellino, la
cui agenda rossa sparì dalla scena del delitto?
CRAXI E LE INTERPRETAZIONI DELLA STORIA TRA MANETTARI E
GARANTISTI.
"L'era di Craxi: in 16 anni dagli altari alla polvere. La battaglia per
l'egemonia a sinistra: le vittorie, le sconfitte e la rovina di un politico", è
l'interpretazione che dello statista ne dà "La Repubblica" il 19 gennaio 2000.
E' durata più di 16 anni l'era Craxi: dal luglio del 1976, quando al comitato
centrale riunito all'Hotel Midas spodestò Antonio De Martino dalla segreteria
del Psi, al febbraio 1993, quando dovette cedere la mano sotto l'impeto delle
inchieste su Tangentopoli. Anni cruciali nella vita del Paese, che iniziarono
con il Pci al suo massimo storico, mentre il Psi era sull'orlo dell'estinzione;
che rappresentarono il culmine dell'attacco terroristico al cuore dello Stato;
che affidarono all'Italia un ruolo essenziale nell'ultima spallata all'Unione
Sovietica, con il dispiegamento dei missili Cruise a Comiso. Ma sono stati anche
gli anni che diedero per la prima volta un socialista alla guida del governo,
che videro il premier italiano reagire contro un alleato storico come gli Usa.
Gli anni della P2, ma anche dell'offensiva dello Stato contro i poteri
criminali, a cominciare da Cosa Nostra, dopo decenni di colpevole tolleranza.
Craxi di quella lunga stagione è stato l'emblema, pagando il prezzo più alto
quando è rovinosamente terminata. Uomo "totus politicus", Craxi fece da ragazzo,
negli anni '50, quella che Amendola chiamava una scelta di vita". Anni durissimi
per chi stava a sinistra, ma forse ancor di più per chi, come lui, a sinistra
era considerato un destro. Nenniano, entrò nel comitato centrale del partito al
Congresso di Venezia, nel '57, che vide il leader storico del socialismo
italiano sonoramente battuto dai morandiani coalizzati con i bassiani e la
sinistra di Sandro Pertini. Aveva 23 anni (essendo nato a Milano il 24 febbraio
del '34). Nel '68, Craxi venne eletto per la prima volta deputato, ed entrò
nella segreteria nazionale del Psi, come uno dei vice segretari prima di Giacomo
Mancini e poi di Francesco De Martino. In quegli anni, per conto del partito,
iniziò un'intensa attività di politica estera, soprattutto nei confronti dei
partiti fratelli aderenti all'Internazionale socialista. Nacque così una
passione che non si appannò più. Nel 1976, eletto segretario del partito in
seguito ad una sorta di congiura di palazzo ai danni di De Martino, la sua
sembrò la classica soluzione di transizione. Non era forte nel partito, e i
leader socialisti più importanti pensarono a torto di poterlo levare di mezzo
alla prima occasione. Il Pci sembrava in un'ascesa inarrestabile. Molti
pensavano che il Psi non avesse più ragione d'esistere. "Primum vivere" fu il
suo orgoglioso slogan. E cominciò la battaglia per svecchiare il partito e per
l'egemonia a sinistra. Il comunista Enrico Berlinguer aveva lanciato il
"compromesso storico"? E lui al congresso di Torino, alleato con il lombardiano
Claudio Signorile, replicò con la strategia dell'alternativa. Durante i tremendi
55 giorni di Moro, la Dc e il Pci si attestavano sulla linea della "fermezza"?
Il Psi divenne l'alfiere della linea trattativista. E fu sempre nel '78 che il
Psi riuscì a mandare per la prima volta un suo uomo al Quirinale: Sandro
Pertini. E anche il partito fu rivoltato come un calzino, seguendo una stella
polare: svecchiare il socialismo italiano, e riscattare il Psi da una sudditanza
culturale e ideologica nei confronti del "grande partito comunista italiano",
come si diceva in quegli anni. E fu infatti nel '78 che Craxi avviò una feroce
polemica ideologica con il Pci. Berlinguer operava il suo "strappo" dall'Urss e
dalla tradizione comunista ortodossa proponendo una terza via, e Craxi gli
rispose duro buttando a mare non solo Lenin, ma anche Marx, ed esaltando il
pensiero di Pierre Joseph Proudon. Riuscì a far cambiare anche il vecchio
simbolo del suo partito (falce e martello su libro e sole nascente) con un
garofano rosso. Al congresso di Verona (1984), che si ricorda anche per la salve
di fischi che accolse Berlinguer un paio di settimane prima della sua morte
(anni dopo, Craxi, non facile alle autocritiche, disse di essersi pentito per
quell'episodio), era già presidente del Consiglio da un anno. Ciò era stato
possibile per la sconfitta subita dalla Dc nelle elezioni dell'83. La Borsa
perse l'8,6 per cento per un risultato dello Scudo Crociato che sembrò tragico:
il 32,9% dei voti, 225 deputati e 120 senatori. Il 4 agosto Craxi formò il suo
primo governo, e a fargli da braccio destro prese con sè il futuro premier
Giuliano Amato. I problemi non si fecero attendere. La grana maggiore fu da
subito la decisione di accogliere in Italia i Cruise statunitensi. Ma la prova
di forza decisiva per gli equilibri interni fu senza dubbio il referendum
dell'85 sui punti di scala mobile promosso dal Pci. Craxi, infatti, non cercò di
evitare lo scontro, e vinse quella partita che all'inizio era sembrata senza
speranza. A Settembre dovette affrontare la più grave crisi diplomatica della
sua carriera, quando ordinò di impedire ai marines americani di ripartire da
Sigonella, in Sicilia, con i terroristi palestinesi, tra i quali Abu Abbas,
responsabili del sequestro dell'Achille Lauro. Craxi rimase a Palazzo Chigi fino
al 17 aprile '87, conquistando un record: la permanenza alla guida del governo
più lunga della storia dell'Italia repubblicana. Tornato al partito, Craxi
riprese di lena la sua politica: contendere alla Dc il suo primato, e rilanciare
l'offensiva contro il Pci per creare un solo grande partito
socialdemocratico. Nel biennio '89-'90 gli sembrò essere venuto il momento della
definitiva rivincita socialista in Italia. Craxi andò a vedere con i suoi occhi
a Berlino sgretolarsi quel muro che aveva diviso in due l'Europa, e si tolse la
soddisfazione di dargli anche lui due bei colpi con martello e scalpello. E
volle poi seguire di persona il XX congresso del Pci di Rimini, e si vedeva con
quanto interesse assistesse alla nascita del nuovo partito voluto da Occhetto,
il Pds. E' in questa cornice che Craxi lanciò la parola d'ordine dell'"Unità
socialista". Nel febbraio '89 aveva già assorbito nel Psi una componente dello
Psdi, e mai come nei tumultuosi mesi che seguirono a Craxi dovette sembrare più
vicino l'obiettivo di una grande sinistra europea. Per questo, se si deve ora
indicare una data del primo scricchiolio, forse è bene partire da prima
dell'inizio di Tangentopoli. Fu alla conferenza stampa del 7 novembre 1990,
convocata da Craxi per ribadire che lui dell'esistenza di Gladio non aveva in
effetti mai saputo nulla, che i giornalisti ebbero l'impressione di non trovarsi
più di fronte il solito "Bokassa" (questo il nomignolo con cui lo chiamavano
dentro e fuori il partito). Apparve già come un leader sulla difensiva. Tutto
ciò avveniva ben prima di quel 17 febbraio 1992, quando venne arrestato Mario
Chiesa, il socialista presidente del Pio Albergo Trivulzio, che diede il via a
Mani Pulite. Tra le due date, ci fu quello che lui stesso poi riconobbe come un
errore politico: l'aver invitato gli italiani ad andare al mare e a non votare
per il referendum di Mario Segni sulla preferenza unica. Arrestato Chiesa, Craxi
pensò di poter archiviare tutto con un epiteto: "Mariuolo". Ma l'indagine di
Tangentopoli non si sarebbe arrestata al primo nome. Iniziò il declino, sotto i
colpi degli avvisi di garanzia, ma ci volle un anno prima che il vecchio leone
decidesse di gettare la spugna e lasciare la guida del partito. Un processo che
si accompagnò al disgregarsi del gruppo dirigente, con Claudio Martelli sicuro
di poter salvare il partito contrapponendosi a Craxi, e con quest'ultimo
determinato a non far finire il bastone di comando nelle mani dell'ex delfino,
che infatti fu poi preso da Giorgio Benvenuto. Subito dopo Craxi si preoccupò di
sottrarsi alla magistratura, ai suoi occhi impegnata in un'offensiva politica,
in una "falsa rivoluzione". A convincerlo dovette certo contribuire la
manifestazione davanti all'Hotel Raphael, che lo costrinse ad allontanarsi in
gran fretta sotto un fitto lancio di monetine. Si era tolto la soddisfazione di
ottenere un No del Parlamento, dopo un appassionato discorso alla Camera, ad una
richiesta di autorizzazione dei pm di Milano. Ma la via dell' "esilio" gli
dovette apparire come l'unica soluzione. E si rifugiò ad Hammamet, sempre più
malato di quel diabete che già nel '90 aveva fatto temere per la sua vita. E da
lì ha proseguito la sua battaglia fino all'ultimo a colpi di fax, chiedendo
continuamente che si cercasse la verità sul finanziamento illecito dei partiti,
rifiutandosi di passare alla storia, lui che aveva dedicato la vita alla causa
del socialismo, come il capo di una banda di criminali.
La grande bugia di Sigonella, affranca
da par suo Gianni Barbacetto su "Il Fatto Quotidiano" del 10 gennaio 2010.
Sigonella: è la parola magica che il fan di Bettino
Craxi introduce nella
discussione, quando sta per soccombere a causa dell’elenco delle tangenti, delle
condanne, dei conti all’estero; e poi degli incontri con Licio
Gelli, delle spartizioni di potere con Giulio
Andreotti, del vertiginoso incremento del debito pubblico…Sigonella:
dimostrazione che il segretario del Psi era uno statista, capace di scelte
coraggiose e autonome anche nei confronti dell’alleato Usa. Ma a Sigonella andò
davvero come ci hanno detto? Un documento americano su cui recentemente è stato
tolto il segreto ci permette oggi di raccontare una storia molto diversa. Tutto
comincia il 7 ottobre 1985, quando quattro terroristi del Fronte per la
Liberazione della Palestina s’impossessano, al largo delle coste egiziane, della
nave italiana Achille Lauro che
sta compiendo una crociera nel Mediterraneo. Il commando chiede la liberazione
di una cinquantina di palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. In caso
contrario, minaccia di uccidere i passeggeri e di far esplodere la nave.
Iniziano frenetiche consultazioni militari e diplomatiche. Le trattative
sembrano arrivare a una conclusione positiva quando Abu
Abbas, il mediatore indicato dal leader dell’Olp Yasser
Arafat, convince i dirottatori ad abbandonare la nave, in cambio
dell’immunità e di un salvacondotto per la Tunisia.Ma si viene a sapere che nel
frattempo i terroristi a bordo avevano ucciso e gettato in mare una persona: Leon
Klinghoffer, un cittadino americano di religione ebraica, disabile
bloccato in carrozzella. A questo punto gli Stati Uniti intervengono. L’11
ottobre i caccia americani intercettano l’aereo egiziano che sta portando in
Tunisia i dirottatori e lo costringono ad atterrare nella base militare di
Sigonella, in Sicilia. Venti carabinieri e trenta avieri dell’Aeronautica
militare circondano l’aereo. Sono a loro volta subito circondati da una
cinquantina di militari americani della Delta Force. Poi affluiscono
alla base i rinforzi dei carabinieri, che circondano gli americani. Il
presidente Usa Ronald Reagan telefona
a Craxi nella notte, chiedendogli la consegna immediata dei palestinesi. Craxi
mantiene fermo il suo rifiuto, finché gli americani ritirano i loro uomini.
Cinque mesi dopo. Certo a Sigonella il comportamento del governo
italiano nei confronti degli americani appare diverso da quello tenuto dopo il
rapimento, nel 2003 a Milano, dell’imam Abu
Omar da parte di uomini
della Cia. Messi sotto
processo per sequestro di persona insieme ai vertici del Sismi,
nel 2009 sono salvati dal segreto di Stato apposto da Silvio
Berlusconi. Ma ora sappiamo che, nel 1985, anche Craxi tratta subito
con gli americani e fa un immediato atto di riparazione, concedendo segretamente
a Reagan la base di Sigonella per attaccare la Libia di Gheddafi. Solo cinque
mesi dopo la tanto osannata dimostrazione di orgoglio nazionale, infatti, nel
marzo 1986 gli F111 Usa,
provenienti dalla Gran Bretagna e ufficialmente diretti alle basi inglesi di
Cipro, decollano dalla base siciliana per attaccare e bombardare il golfo della
Sirte. La concessione avviene in segreto: Craxi permette l’uso della base, ma
chiede discrezione e in pubblico critica aspramente l’azione militare. Lo ha
scoperto una giornalista italiana, Sofia
Basso, analizzando materiale Usa recentemente declassificato. Si è
imbattuta in una nota confidenziale scritta a Reagan nella primavera 1986
dall’allora segretario di Stato americano, George
Shultz, uscita dagli archivi
segreti del Dipartimento di Stato. L’appunto di Shultz spiega che «i rapporti
con Craxi erano eccellenti», l’episodio dell’Achille Lauro era
ormai «cosa del passato» e che «su base confidenziale, l’Italia aveva permesso
l’uso di Sigonella per operazioni di supporto in relazione all’esercitazione nel
golfo della Sirte». A una sola condizione: la riservatezza. È il marzo 1986. La
Libia è accusata di essere dietro gli attentati compiuti in varie parti del
mondo da terroristi arabi. Reagan, senza consultare né il Congresso, né i partner europei,
il 22 marzo manda navi e aerei nel golfo della Sirte, che Gheddafi considera
acque territoriali libiche. Si scatena una battaglia. Gli Usa colpiscono due
navi libiche e una base missilistica. Le cancellerie occidentali si dividono:
Gran Bretagna e Germania applaudono la dimostrazione di forza, il resto
dell’Europa esprime forti dubbi. Il più duro nelle critiche agli Usa è proprio
Craxi il quale, in una seduta straordinaria del Parlamento, proclama che non è
con ripetute "esercitazioni militari" in un’area già scossa da forti tensioni
che si può difendere il diritto internazionale. L’uso della forza, anzi, non
potrà che minare la stabilità della regione e rafforzare il ruolo di Gheddafi
nel mondo arabo. Deve essere chiaro che l’Italia non vuole «guerre alle soglie
di casa». Fin qui la versione ufficiale. Il memorandum di Shultz rivela invece
la verità segreta. Spiega che Craxi vuole farsi perdonare l’episodio
dell’Achille Lauro, punta a essere considerato partner privilegiato degli Usa
nelle relazioni tra Est e Ovest e a essere ammesso nel gruppo dei cinque Paesi
industrializzati. Per questo, in pubblico strilla contro gli americani ma,
sottobanco, dà loro il via libera. Purché non lo si dica in giro. Da Il
Fatto Quotidiano del 10 gennaio.
Da par suo non poteva mancare
l’intervento di Marco Travaglio: Craxi al netto delle tangenti
(Passaparola, 18 gennaio 2010). Buongiorno a tutti, siamo nel pieno delle
celebrazioni di Bettino Craxi, mi sono un po’ stufato di ricordare le tangenti
che prendeva, anche perché l’abbiamo già fatto in queste ultime settimane e poi
ci viene autorevolmente raccomandato e stiamo aspettando tutti con ansia il
messaggio del Capo dello Stato, per celebrare degnamente il decennale del
latitante, che bisogna andare oltre le vicende giudiziarie e che bisogna dare un
giudizio politico, perché naturalmente un uomo politico non può essere ridotto
soltanto alle condanne e ai processi. E’ vero, Craxi non ha avuto soltanto
condanne e processi, Craxi è stato anche altro: ha fatto politica, da questo
punto di vista vale sempre la vecchia battuta di Grillo, che nella Prima
Repubblica di solito prendevi un politico e, dopo un po’, diventava un ladro,
mentre nella seconda di solito prendi un ladro e dopo un po’ diventa un
politico. Certamente Craxi quando ha iniziato a fare politica non l’ha fatta per
rubare, ha cominciato a rubare mentre faceva politica e su Il Fatto Quotidiano
ho pubblicato un’intervista del 93 di Fabrizio Cicchitto, che non era craxiano,
era socialista lombardiano, ma fu messo da parte nel Partito Socialista dopo
l’81, quando si scoprì che era iscritto alla Loggia P2. Cicchitto è un raro caso
di socialista espulso da Craxi, messo ai margini da Craxi per indegnità morale e
per la sua iscrizione alla P2 e infatti, rancoroso nei confronti di Craxi per
essere stato sbattuto fuori per dieci anni e recuperato soltanto nel 92,
Cicchitto nel 93 diede un’intervista - pensate un po’ - a Augusto Minzolini,
l’attuale direttore del TG1, che all’epoca era cronista de La Stampa e, in
quell’intervista, Craxi veniva dipinto da Cicchitto come poco meno o poco più di
un malfattore. Se la trovo, ho qui Il Fatto di questi ultimi giorni, un piccolo
brano ve lo devo regalare, perché? Perché Cicchitto ricorda come Craxi scalò il
Partito Socialista quando, alla fine degli anni 70, sembrava che non ce la
dovesse fare a prendere il potere e poi invece ce la fece per pochissimi voti e,
disse Cicchitto, quei pochissimi voti se li era comprati, aveva praticamente
lanciato un’Opa sul Partito Socialista con quali soldi? Eh, con i soldi del
conto protezione, ossia con i soldi che gli aveva pagato il Banco Ambrosiano,
grazie ai buoni uffici di Licio Gelli e di Roberto Calvi. Conseguentemente, se
andate sul sito antefatto, o ilfattoquotidiano.it la trovate integrale
quell’intervista. Cicchitto disse, “quando scoprimmo che Craxi aveva questo ben
di Dio messo a disposizione sul conto svizzero, il famoso conto protezione, da
Licio Gelli e Roberto Calvi beh, capimmo che non ce l’avremmo fatta”. Dice anche
che Pietro Nenni gli mandò una lettera nella quale gli intimava di dimettersi, a
Craxi, ma che quella lettera fu fatta sparire: lo dico, perché chi sta a Roma
vede in questi giorni la città tappezzata di manifesti in cui si vede Craxi
giovane e Nenni vecchio con il bastone. Il rapporto tra i due era appunto che il
vecchio patriarca, sdegnato nei confronti di Craxi, aveva mandato una lettera
per intimargli di dimettersi, lettera che poi è stata fatta sparire, ma in quel
partito l’abitudine a fare sparire molte cose era diffusa. Però ci dicono che
non ci sono soltanto le tangenti, c’è anche la politica, c’è anche altro e
conseguentemente, per dare un giudizio complessivo su Craxi, bisogna valutare il
suo ruolo politico: lo scrive ancora questa mattina L’Ambasciatore Romano in uno
dei suoi pezzi solitamente ambigui, dove dà un colpo al cerchio e uno alla botte
e penso che possiamo benissimo parlare solo esclusivamente, oggi, della politica
di Craxi, per vedere se ha portato bene o ha portato male all’Italia: in fondo
stiamo parlando di un signore che ha imperversato nella politica italiana per
quasi venti anni come leader del partito, come ago della bilancia dall’alto del
suo 12 o 14% della politica italiana, come Presidente del Consiglio tra l’83 e
l’87 e come parlamentare fino al 1994, quando non si ricandidò perché sepolto
sotto le vicende giudiziarie e invece scappò all’estero. Vediamoli, dunque,
questi grandi meriti politici che ha avuto Craxi al netto delle tangenti, perché
è un po’ ricattatorio questo modo di giudicare e di dire che non bisogna pensare
soltanto alle tangenti, ma anche alla politica: intanto, se uno prende tangenti
è un tangentaro e poi è chiaro che anche il mostro di Firenze credo abbia
offerto qualche brioches a qualche bambino povero, o abbia aiutato qualche
vecchina a attraversare la strada, eppure rimane sempre il mostro di Firenze! In
ogni caso cediamo pure a questo ricatto e parliamo dei grandi meriti politici
che, secondo alcuni, ne farebbero un grande statista, paragonato addirittura a
De Michelis o a De Gasperi, o paragonato ieri sera da Claudio Martelli a
qualcosa di meglio rispetto a Berlinguer e dal Ministro Sacconi a un genio
praticamente, a un numero uno della politica italiana. Credo che, stringi
stringi, le uniche due cose positive che personalmente riesco a intravedere in
quei quasi venti anni di leadership nazionale Craxi le abbia fatte quando si è
opposto al nucleare e ha patrocinato il referendum contro il nucleare e, in
parte, quando ha dato un colpo all’inflazione stroncando, smantellando la scala
mobile. Sul secondo punto il fine giustificava i mezzi forse, visto che avevamo
un’inflazione più vicina al 20% che al 10%, ma non dimentichiamo che stroncare
la scala mobile voleva dire sganciare lo stipendio, il salario dei lavoratori
dipendenti dal costo del lavoro e quindi, naturalmente, hanno perso di potere
d’acquisto gli stipendi dei lavoratori, tanto per cambiare si è deciso di far
pagare ai più poveri i disastri della finanza pubblica, che non erano colpa
loro, per dare uno scrollone ai sindacati, che sicuramente avevano delle grosse
responsabilità. Quanto al nucleare, non so se avete notato, ma tutti i fans di
Craxi di oggi se la dimenticano quella faccenda del nucleare, del no dei
socialisti al nucleare, che poi portò al referendum che fu vinto dai nemici del
nucleare e infatti oggi tutti i fans di Craxi sono per il nucleare e sorvolano
sul fatto che Craxi era contro. Al di là di questo, francamente non vedo nessun
motivo per parlare di meriti politici, al netto delle tangenti: cominciamo dal
debito pubblico. Per fortuna, sia pure nascosto in fondo a una pagina, a pagina
17 de Il Corriere della Sera di giovedì, Salvatore Bragantini, economista molto
in gamba, molto esperto, ci ricorda che cosa ha fatto Craxi per il debito
pubblico e dice “il caso Grecia ora tiene banco, ma è solo l’inizio, tutti i
Paesi dell’Eurozone a alto debito - si fa più presto a dire chi non c’è - sono
condizionati dai vincoli di Maastricht, svuotare i quali vorrebbe dire silurare
l’Euro. Non è loro preclusa solo la leva della politica monetaria, anche lo
spazio per quella fiscale si fa impervio, non c’è una lira, i soldi (pochi)
vengono spessi per pagare gli interessi sul debito e quindi non c’è trippa per
tagliare le tasse. Si può giostrare solo a parità di gettito e la manovra è
limitata dalle norme dell’Unione Europea, per esempio per l’Iva. In questo
frangente, cosa fare in concreto per restare un grande Paese, senza farsi pian
piano relegare nella serie inferiore? Un’opinione pubblica disinformata potrebbe
reagire prendendosela con l’Europa, mentre in realtà ce la dobbiamo prendere con
noi stessi e, soprattutto, con chi oggi celebra Craxi.” E ricorda, Bragantini,
che “il risanamento morale, utile in sé, darebbe anche un robusto contributo a
quello economico”, perché l’immoralità pubblica, la corruzione pubblica che
porta aumenti di spesa pubblica sono, in realtà, all’origine del boom del nostro
debito punto di riferimento, che non è sempre stato alle stelle: ha cominciato a
andare alle stelle a partire dal 1980, cioè da quando imperò sull’Italia per
dodici anni il famoso Caf (Craxi, Andreotti, Forlani). Se ci fosse ancora una
classe dirigente degna del nome, anziché assistere in un silenzio forse non
imbarazzato, ma certo imbarazzante alla rivalutazione di Bettino Craxi, questa
classe dirigente ricorderebbe al Sindaco di Milano, che vuole dedicargli una via
o un parco, alcuni fatti stranoti nelle metropoli straniere che ama frequentare
la signora Moratti. Lasciamo pure stare i gravi reati per cui Craxi è stato
condannato e che paiono divenuti trascurabili, c’è molto di più: sotto la guida
politica sua e di De Mita, che oggi non a caso ne canta le gesta, il nostro
debito pubblico è volato dal 60 al 120% del Pil, in dodici anni è raddoppiato il
rapporto tra debito e prodotto interno lordo; di qui il macigno che tutt’ora
grava sulle spalle del Paese e ne frena lo sviluppo, sapete che quel debito lo
paghiamo con 80 miliardi di Euro all’anno di soli interessi. Nell’éscalation del
debito ebbe il suo bel peso l’aumento dei costi delle opere pubbliche dovuto
alle tangenti, scoperte grazie a Mani Pulite: quei costi, in seguito alle
indagini, crollarono di botto e chi allora accusò il colpo ce lo restituisce con
gli interessi. Nel 1992, quando crollò la Prima Repubblica sotto i colpi delle
tangenti e poi si travestì da Seconda Repubblica grazie a quel grande gattopardo
che è Berlusconi, un chilometro di metropolitana a Milano costava 192 miliardi,
nello stesso periodo a Amburgo un chilometro di metropolitana costava 45
miliardi, meno di un quarto. In quel periodo il passante ferroviario di Milano
costava 100 miliardi a chilometro e è stato realizzato in dodici anni; nello
stesso periodo il passante ferroviario di Zurigo è costato la metà, 50 miliardi
a chilometro, e ha richiesto la metà del tempo per i cantieri (sette anni,
anziché dodici). E’ così che nasce il boom del debito pubblico che, nell’80, era
il 60% del Pil, nell’83 era già il 70% del Pil, nell’83 Craxi diventa Presidente
del Consiglio, ci rimane quattro anni, è il governo più lungo della Prima
Repubblica, in quei quattro anni il rapporto tra debito e Pil passa dal 70 al
92% e, in termini liquidi, il debito pubblico passa da 400 e qualcosa mila
miliardi a un milione di miliardi in quattro anni, gli anni del governo Craxi.
Dopodiché, negli anni dei governi Goria e De Mita, il rapporto debito /Pil balza
ulteriormente dal 92 al 118%, che è il valore che ha praticamente oggi, perché
abbiamo avuto qualche anno di risanamento grazie alle politiche del
centrosinistra, soprattutto dei Ministri Ciampi e Padoa Schioppa e poi abbiamo
avuto invece lo sfondamento del centrodestra che, guarda caso, ha affidato
l’economia nelle mani degli stessi che collaboravano con Craxi ai tempi in cui
veniva scavato il grande buco del debito pubblico: oggi la nostra economia è nei
mani dei Tremonti, dei Brunetta e dei Sacconi, cioè degli stessi consulenti
economici di Craxi e De Michelis, che all’epoca stavano scavando quel gigantesco
buco che ancora non siamo riusciti a riempire. “Craxi politicamente ebbe ragione
su diversi punti: per esempio, sulla scala mobile e, chi era privo di paraocchi
ideologici lo vide subito”, scrive ancora Bragantini, “ma non uscì di scena solo
per i reati: soprattutto perché ci stava trascinando nell’abisso. Non era il
solo, ma la sua riabilitazione, oltre a reiterare il teorema per cui la
magistratura rossa dà la caccia ai politici, sancisce anche ufficialmente
l’inanità del tentativo di sfuggire a ruberie e malgestione, è questa la cosa
più grave e dà il senso di un Paese che ha smarrito con la memoria la bussola
dell’interesse generale. Tutti quelli che nelle aziende esportatrici si dannano
a recuperare la competitività perduta dovrebbero pensarci bene, prima di
avallare con il silenzio la restaurazione. Se poi Milano dovrà davvero scegliere
una via da dedicare a Craxi, cambiamo nome a quella oggi intitolata Giorgio
Ambrosoli: daremmo icasticamente l’idea di come ci siamo ridotti e del futuro
che ci stiamo preparando”, scrive il grande Bragantini, seminascosto in fondo a
pagina 17 de Il Corriere della Sera. Vediamo
altri meriti dello statista Craxi: ricorderete, per esempio, le partecipazioni
statali, erano le imprese dello Stato, ce ne era una in particolare che si
chiamava Sme e perdeva migliaia di miliardi ogni anno per produrre panettoni e
pomodori pelati di Stato. Era la grande Finanziaria alimentare dell’IRI, che
conteneva nella sua pancia i marchi di Motta, Alemagna, Cirio e era gestita dai
partiti, quindi era gestita con i piedi e noi, ogni anno, ripianavamo i buchi
della Sme: ecco perché Prodi saggiamente, nel 1984, decide di privatizzarla, la
mette sul mercato, chiede se c’è qualche privato disposto a prendersi quel
carrozzone puzzolente e maleodorante. Ebbene, si fa avanti la Buitoni, unica
offerente, la Buitoni di De Benedetti: Craxi per ragioni politiche, ossia perché
odiava De Benedetti, decide di bloccare la privatizzazione della Sme,
incaricando Berlusconi, Barilla e Ferrero di, obtorto collo, presentare una
controfferta rispetto a quella della Buitoni, per altro fuori tempo massimo, in
modo da mandare a monte il preaccordo che la Buitoni ha stipulato con l’IRI.
Risultato: va tutto a catafascio, la Sme rimane nelle partecipazioni statali e
gli italiani per anni hanno continuato a ripianare migliaia di miliardi di
debiti a quell’azienda pluridecotta, che Prodi saggiamente aveva trovato a chi
affidare per liberare lo Stato da quel bubbone purulento. Questo sarebbe il
modernizzatore, uno che non ha mai privatizzato neanche un canile: io non sono
un fanatico delle privatizzazioni, ci sono cose che debbono rimanere pubbliche,
ma i panettoni di Stato e i pomodori pelati forse potevano essere privatizzati e
gestiti meglio! Craxi si opposte e perché si oppose? Perché le partecipazioni
statali erano delle aziende che venivano gestite dagli uomini dei partiti, la DC
e il PSI e i partiti usavano le aziende pubbliche come vacche da mungere, le
depredavano per rubare, venivano finanziati da aziende pubbliche anche se era
vietato dalla legge che essi stessi avevano approvato nel 74: quella del
finanziamento pubblico dei partiti, che consentiva ai partiti di ricevere
contributi da aziende private, ma non da aziende pubbliche. E invece Craxi usava
le partecipazioni statali come se fossero il cortile di casa sua: ci metteva i
suoi uomini, il famoso Di Donna, i famosi Cagliari, Bitetto, Necci e poi
ciucciava i soldi, questa è la ragione per cui alimentò l’impresa pubblica anche
laddove non se ne sentiva il bisogno, perché rubavano i soldi pubblici dalle
aziende pubbliche. Pensate alla RAI, pensate a che cosa era la RAI nel periodo
della lottizzazione più feroce dei partiti: si dirà “ c’è anche adesso”, sì, ma
non è una buona ragione per dire che era buono quello che facevano allora o per
dire che, dato che si fa male adesso, allora va bene tutto, la RAI ha cominciato
a diventare - e ne sa qualcosa Beppe Grillo, tra l’altro - una protesi dei
partiti proprio in quegli anni, quando tra l’altro non c’erano più neanche
grandi partiti che segnalavano grandi personalità, come era accaduto nel passato
in televisione, ma c’erano partiti che segnalavano mezze calzette, le loro
amanti, i loro amici, i loro portaborse etc., per ottenere in cambio quello che
avete visto ancora l’altra sera da Giovanni Minoli. La stessa cosa accadde nel
settore televisivo privato: se oggi non abbiamo un libero mercato nella
televisione privata, se oggi non abbiamo un antitrust nella televisione privata,
se oggi abbiamo una mostruosa concentrazione nelle mani del signor Berlusconi,
lo dobbiamo a Bettino Craxi, che cominciò a salvarlo con i due famosi decreti
dell’84, quando i pretori tentarono di fare rispettare la legge a Berlusconi e
Craxi neutralizzò le ordinanze dei pretori con due decreti chiamati Berlusconi e
poi, nel 1990, quando perdemmo la grande opportunità di avere una legge
antitrust sulla televisione, perché la Legge Mammì alla fine diventò una
fotografia del trust esistente, tre reti aveva Berlusconi e tre reti potè
tenersi vita natural durante. A chi lo dobbiamo tutto questo? A Craxi, il grande
modernizzatore che ha creato il più mostruoso monopolio, soltanto perché il
monopolista era il suo amichetto che gli pagava 21 miliardi, o forse di più, 21
sono stati trovati, estero su estero. Ecco perché la corruzione non può essere
disgiunta dall’azione politica, perché queste scelte politiche venivano fatte da
uno che poi si faceva pagare: ecco perché il corrotto non è staccabile
dall’attività politica, perché la corruzione richiede qualcosa in cambio e quel
qualcosa in cambio erano le politiche che hanno ridotto l’Italia a un Paese
pseudo sovietico, per quanto riguarda la televisione, visto che abbiamo il
potere politico che controlla la televisione e questo è cominciato grazie a
Craxi, il berlusconismo lo dobbiamo a Bettino Craxi. La stessa cosa è accaduta
nell’editoria quando, raccomandato da Craxi, Berlusconi si impossessò della
Mondadori e si impossessò della Mondadori grazie a magistrati romani che
facevano parte dell’harem di Cesare Previti e da dove viene Cesare Previti? Dal
Partito Socialista, era Consigliere di amministrazione di Lalenia, ai tempi in
cui Lalenia era un feudo socialista, tutto si tiene il giudice Squillante, il
giudice che aveva 9 miliardi sui conti svizzeri, il giudice corrotto da Previti,
anche se poi l’ha fatta franca grazie alla prescrizione, ebbene il giudice
Squillante era il consigliere giuridico di Craxi a Palazzo Chigi, un giudice con
i conti all’estero comunicanti con i conti di Previti e della Fininvest. Ecco
perché a Roma i processi non si facevano mai e Craxi fu beccato dalla Procura di
Milano: perché a Roma i giudici erano capitanati - capo dei G.I.P. - da Renato
Squillante, consulente giuridico di Craxi, pappa e ciccia con Craxi, ecco perché
la corruzione non può essere disgiunta dalla politica! Pensate soltanto alle
politiche sulla droga che ha fatto Craxi: la prima legge proibizionista in
materia di droghe è proprio la legge che fu fatta, la famosa Iervolino
/Vassalli, che fu imposta da Craxi, che poi era legato ai peggiori personaggi
delle comunità, da Don Gelmini a Muccioli, vengono tutti di lì, dal craxismo. La
penalizzazione delle droghe anche leggere, il proibizionismo più retrivo,
pensate all’imbarcata di extraparlamentari di sinistra che fece il Partito
Socialista, che si importò i Boato, i Liguori, i Sofri, tutti socialisti erano
diventati quando lotta continua chiuse i battenti! Pensate alla politica
istituzionale di Craxi, che lanciò per primo il presidenzialismo, l’elezione
diretta del Presidente della Repubblica, perché naturalmente la voleva disegnare
sulle proprie caratteristiche, voleva diventare Presidente della Repubblica con
il plebiscito, è lui che ha cominciato a picconare la Costituzione, è lui che
per primo, nel 1980, insieme a Giulano Amato, suo degno consulente su queste
questioni, ha lanciato la proposta della grande riforma: che cosa era la grande
riforma? Era la trasformazione dell’Italia in una Repubblica presidenziale
craxiana, è lui che ha cominciato a diffondere il virus dell’ostilità ai valori
costituzionali e è lui il primo politico importante del governo a attaccare in
Parlamento la magistratura. Oggi ci sembra normale che i politici attacchino la
magistratura, non fanno niente altro: all’epoca non si usava, i democristiani se
ne guardavano bene, chi aveva fatto parte della Costituente e aveva mantenuto
quella tradizione si guardava bene dal delegittimare gli altri poteri, mica per
ragioni di onestà di impeccabilità, per ragioni di autoconservazione. Se un
potere comincia a distruggere gli altri, gli altri distruggeranno quel potere
lì, il potere non può delegittimarsi, le istituzioni tra loro non si possono
delegittimare, Craxi fu il primo a rompere il galateo istituzionale e
costituzionale e quando cominciò a attaccare i magistrati? Quando fu arrestato
per reati valutari nei primi anni 80 Roberto Calvi, il responsabile del più
grave crack della storia d’Europa prima del crack Parmalat, ovviamente, il crack
dell’Ambrosiano, che mandò sul lastrico migliaia, migliaia e migliaia di
famiglie e Craxi, invece di ringraziare i magistrati, che avevano beccato il
bancarottiere Calvi, il quale aveva depredato le casse dell’Ambrosiano per
compiacere la mafia, la P2 e tutto quel giro losco che c’era intorno, Craxi
attaccò i giudici in Parlamento, dicendo che rovinavano l’economia! Cioè
l’economia, che era stata appena rovinata dal più grave crack mai visto nella
storia d’Italia, veniva rovinata dai giudici che avevano scoperto il crack e il
colpevole del crack: questo fu un attacco violentissimo, che segnò una rottura,
molti che prima votavano socialista non votarono più socialista, quando
sentirono che Craxi difendeva Calvi e poi si scoprì perché Craxi difendeva
Calvi, perché in Svizzera, sul conto protezione, Calvi gli aveva appoggiato,
grazie ai buoni ufficio di Licio Gelli, una mazzettona di una decina di miliardi
dei primi anni 80, una cifra spropositata! Ecco perché ancora una volta la
corruzione non può essere disgiunta dall’attività politica: perché Craxi difende
un figuro come Calvi? Perché prendeva i soldi da Calvi! La gestione interna del
partito, l’insofferenza del dissenso, il partito cesarista, il partito
mussoliniano nella Repubblica italiana l’ha inventato Craxi, il quale espelleva
gli oppositori e reprimeva il dissenso interno: nel 1981 ha cacciato gente
onesta e perbene, oltre che grossi intellettuali come Codignola, Bassanini,
Enriquez Agnoletti, Leon, Veltri e altri dirigenti chiamandoli “ piccoli
trafficanti della politica”: pensate, Craxi che dà del piccolo trafficante della
politica a gente onesta, accusandola di intelligenza con il nemico! Non si sa
chi fosse il nemico, perché li ha cacciati? Perché avevano sollevato la
questione morale, la stessa questione morale che aveva sollevato Berlinguer dopo
che, nelle liste della P2, erano stati trovati molti socialisti craxiani e
lombardiani, nel caso di Cicchitto. Pensate ai faccendieri che si aggiravano
nell’éntourage di Craxi, ora la figlia pietosamente dice “mio padre si fidò
delle persone sbagliate, che tradirono la sua fiducia”: certo, era uno
sprovveduto, un ingenuo! E’ stato subornato, era circondato da un’associazione
per delinquere e non se ne era accorto, l’ingenuo Craxi! Faccio dei nomi, eh:
Gelli, Calvi, Tradati, Troielli, Gianlombardo, De Toma, Bitetto, Mac Di
Palmestein, Cusani, Larini, Fiorini, Parretti, Cagliari, Zampini, Biffi Gentili,
Mario Chiesa, Maurizio Raggio, Francesco Cardella. Fate qualche ricerchina su
Internet con questi nomi e vedrete che pedigree viene fuori di ciascuno di essi!
Erano tutti nell’éntourage di Craxi, ne fosse mancato uno! Uno dice “va beh,
Gesù Cristo è stato tradito da Giuda”, sì, ma uno su dodici era, qui trovarne
uno su venti che non fosse un mascalzone! Senza ricordare, naturalmente, che
cosa era diventata l’assemblea socialista, quest’organismo pletorico che si
riuniva nei palasport e dove svettavano riccastri, pervénus da mazze, mignotte:
sono i famosi ladri e ballerine di cui parlava Formica, che adesso evidentemente
se ne è dimenticato, tant’è che ieri pare che abbia baciato addirittura la
scrivania dove Craxi compilava le sue veline ricattatorie e mandava in fax in
Italia per rovinare la reputazione di quelli che diceva che l’avevano tradito.
Pensate che Craxi riuscì persino a candidare al Parlamento Gerri Scotti e
Massimo Boldi: voi direte “Massimo Boldi quello lì?”, esattamente quello lì!
Questa era la nuova classe dirigente dello statista modernizzatore, Massimo
Boldi, detto anche Max Cipollino, questa è la classe dirigente del grande
statista anticipatore di Tony Blair, come ieri sera ci ha detto Sacconi! Per non
parlare naturalmente di Giuliano Ferrara, Budget Bozzo etc., insomma non si è
fatto mancare niente, tutte persone altamente equilibrate! Prendiamo
la politica estera: per quanto riguarda la politica estera Craxi, che viene
dipinto come un fedele atlantista, uno anticomunista, uno ancorato all’occidente
e quindi quello che aveva fatto la scelta giusta tra l’est e l’ovest, mentre
l’Unione Sovietica voleva colpire etc., gli euromissili e tutta la retorica che
si fa sugli euromissili, Craxi è quello che fa entrare nel Parlamento italiano
Yasser Arafat con la pistola nel cinturone, non lo disarmano neanche, non lo
perquisiscono neanche prima di farlo entrare in Parlamento e, quando qualcuno
protesta, lui dice che Arafat è come Mazzini e Garibaldi, Arafat come Mazzini e
Garibaldi! Il capo di un’organizzazione che, in quel periodo, era ancora
un’organizzazione terroristica, che faceva gli attentati negli aeroporti e
sequestrava le navi, come poi successe qualche anno dopo con l’Achille Lauro,
che non aveva ancora neanche riconosciuto il diritto all’esistenza dello Stato
di Israele, questo sarebbe quello che le aveva azzeccate tutte! Quando
l’Inghilterra andrò a riprendersi le isole Faulklands, che i generali argentini,
i dittatori fascisti militari argentini erano andati a occupare per distrarre
l’opinione pubblica dalla crisi economica dell’Argentina e la Thatcher andò a
riprendersi le Faulklands, indovinate un po’ con chi si schierò l’Italia, grazie
al governo Craxi: con la democrazia inglese, o con i dittatori argentini?
L’Italia fu l’unico Paese in Europa alleato ai generali argentini, quelli che
sterminavano gli oppositori lanciandoli dagli aerei in quota, quelli che fecero
i desapareçidos, noi eravamo alleati con quella gentaglia lì, grazie a Craxi che
aveva visto giusto! Noi ci siamo alleati con un tiranno lurido, sanguinario come
Si Agbar, il tiranno della Somalia, missioni continue dei vari Pilliteri,
Boniver, Francesco Forte, che andavano a portare denaro pubblico a questo
delinquente: con la scusa della cooperazione con il terzo mondo abbiamo
foraggiato per anni questo tiranno sanguinario. Quando poi è stata rapita la
nave Achille Lauro, adesso voi sentite raccontare che ci fu l’episodio di
Sigonella, dove Craxi gliela fece vedere agli americani: per l’amor del cielo,
fargliela vedere agli americani quando sbagliano è sacrosanto, ma non è quello
che è successo a Sigonella; tutti dimenticano che cosa è successo a Sigonella,
raccontano solo la prima parte della storia, un commando di terroristi dell’Olp,
capitanato da Yasser Arafat - la frangia era uno delle organizzazioni che
componevano l’Olp e era il Fronte Popolare di Abu Abbas - sequestrò questa nave
nel Mediterraneo, dopodiché ci fu una trattativa con la mediazione di Mubarak,
Presidente egiziano e, alla fine, i terroristi decisero di riconsegnare la nave
e gli ostaggi in cambio della impunità per il loro capo, questo fu l’accordo
segreto, il capo era Abu Abbas, che si era spacciato per un mediatore e poi si
scoprì che era il capo della banda e che, per di più, questa banda, che aveva
garantito di non aver ucciso nessuno, aveva ucciso un ebreo paralitico, Lion
Klingoffer, che se ne stava in carrozzella e che fu preso, assassinato e buttato
giù dalla nave, tant’è che sulla chiglia dell’Achille Lauro c’era una bava di
sangue, era il sangue di questo anziano ebreo che era stato ucciso in quanto
ebreo e in quanto americano. Una cosa oscena che, quando la si scoprì, doveva
evidentemente imporre al governo italiano di prendere l’intero commando, da Abu
Abbas a tutti gli esecutori materiali, e assicurarlo alla giustizia italiana,
perché quel delitto era avvenuto su una nave italiana e quindi le navi italiane
sono territorio italiano anche quando navigano in acque internazionali. Reagan,
con una cow boyata, come la chiamò Montanelli, tentò di prelevare il commando
nella base americana di Sigonella, in territorio italiano e di portare i
terroristi per processarli in America, perché avevano ammazzato un americano.
Giustamente Craxi disse “ no, li processiamo noi”: fin lì va bene, il problema è
quello che succede dopo, ossia il gioco delle trae carte, per cui una volta
assicurato agli americani che i terroristi li processavamo noi, Abu Abbas è
stato preso, caricato su un aereo dei servizi segreti italiani, mandato a
Belgrado dal maresciallo Tito e da Belgrado è stato regalato in omaggio al
regime di Saddam Hussein, che ha ospitato Abu Abbas a Baghdad fino al giorno in
cui c’è stata la guerra nel 2003, quando Abu Abbas è stato trovato morto, non si
è ben capito in quali circostanze. Questo abbiamo fatto: abbiamo fatto scappare
il capo dei terroristi che avevano assassinato un ebreo paralitico inerme, altro
che il gesto coraggioso di Sigonella! Abbiamo fatto scappare un terrorista e
l’abbiamo restituito al suo legittimo proprietario, che era Saddam Hussein e
tutti quelli che oggi celebrano Craxi sono quelli che hanno voluto che l’Italia
partecipasse alla guerra in Iraq e sono tutti quelli che dicono di essere
contrari al terrorismo, però difendono un signore che appoggiava e salvava i
terroristi assassini! Pensate alla gestione del caso Moro: nel caso Moro fu
presa una linea sacrosanta da parte delle autorità italiane, ossia non trattare
con le brigate rosse, perché se tratti una volta i brigatisti sapranno che, ogni
volta che faranno un ostaggio, lo Stato si calerà le brache e quindi non c’è più
Stato, se lo Stato tratta con i brigatisti e infatti la Democrazia Cristiana e
il Partito Comunista decisero che non bisognava trattare, grazie al governo
Andreotti e all’oppositore. anzi, scusate, in quel momento era il governo
sostenuto dalle astensioni del Partito Comunista e quindi, grazie all’astenuto
PC di Berlinguer, la linea di Zaccagnini, segretario della DC, e di Berlinguer,
segretario del PC , nonché di Ugo Lamalfa. Sapete chi è l’unico segretario dei
partiti di maggioranza che invece voleva trattare con le brigate rosse? Era
Craxi e oggi, tutti quelli che dicono “non si tratta con i terroristi” etc.
etc., celebrano un signore che rivendicava la trattativa con le brigate rosse,
cioè liberare dei terroristi in cambio della vita di Moro! Una cosa che avrebbe
messo definitivamente in ginocchio lo Stato italiano e avrebbe segnato la
vittoria politica delle brigate rosse. Concludo con quello che faceva Craxi nei
confronti della stampa libera e degli intellettuali: diciamo che è stato il
politico - prima che arrivassero Berlusconi e anche D’Alema, in un certo qual
modo - più feroce nei confronti della stampa libera e più insofferente nei
confronti delle critiche: “intellettuale dei miei stivali” disse, quando Galli
Della Loggia si permise una critica e, quando Alberto Cavallari, direttore de Il
Corriere della Sera, scrisse che lui tra i ladri e le guardie stava dalla parte
delle guardie - Cavallari era il direttore de Il Corriere della Sera che aveva
bonificato il corriere dopo la P2 - Craxi lo denunciò, una cosa che fece epoca,
perché all’epoca non si usava intimidire i giornalisti con continue denunce come
si fa adesso, lo denunciò e lo fece condannare a un risarcimento di 500 milioni.
Dopodiché purtroppo Cavallari non ebbe la possibilità di essere riabilitato,
cioè di vedere le prove di ciò che lui aveva scritto su Il Corriere della Sera a
metà degli anni 80, perché un giorno arrivò il momento in cui si scoprì che
veramente Craxi era un ladro, soltanto che lui nel frattempo aveva dovuto pagare
il risarcimento, era stato condannato e era morto. Ecco perché oggi forse
bisognerebbe dedicare una via di Milano a Cavallari e non a Craxi, perché è
stato un grande giornalista che aveva visto giusto, come tanti altri avevano
visto giusto su Craxi, prima che arrivassero le prove nelle mani della
magistratura. Passate parola e continuate a seguire Il Fatto Quotidiano, che
questa settimana lancerà probabilmente una specie di referendum tra i lettori
per scegliere, invece, gli esempi positivi: li prenderemo sicuramente tra quelli
che avete visto nel calendario dei santi laici, che è stato distribuito anche
quest’anno insieme con il blog di Beppe Grillo. Passate parola, buona settimana.
Bettino per sempre.
Anna Craxi parla di
Bettino: "la parabola discendente cominciò con Sigonella. Gli americani non gli
perdonarono lo sgarbo. Subito dopo cominciò la persecuzione." Scrive sabato 20
dicembre 2014 Franco Bucarelli su “Visto”. «Sono trascorsi quindici anni dalla
sua morte, ma a me sembra di vederlo ancora qui,
seduto in questa poltrona, quasi sommerso da pile di giornali, scritti, fax e
documenti di ogni genere, ammonticchiati su questo tavolo, il suo preferito».
Anna Maria Moncini Craxi, 80 anni portati con classe anche dopo una fastidiosa
flebite, parla con voce pacata, ricordando suo marito Bettino Craxi, morto a 66
anni, il 19 gennaio 2000, qui in Tunisia, dove si era rifugiato per sfuggire
all’arresto, poco prima di subire una condanna a diversi anni di carcere nel
periodo di Tangentopoli. Il caldo sole della Tunisia illumina il meraviglioso
giardino di villa Craxi, che non ha alcun nome all’esterno. Ma basta chiedere a
qualunque tassista di Hammamet dove si trova, e vi portano direttamente. La
signora Anna non ama concedere interviste, perché preferisce un dignitoso
silenzio. Ma io sono stato un vecchio amico del marito, sin da quando, giovane
funzionario del suo partito, venne a lavorare a Roma, dove c’incontravamo
all’Osteria dell’Orso. Per questo sua moglie ha concesso a Visto questo
eccezionale colloquio. «Mio marito non ha mai rubato nulla a nessuno», continua
Anna Craxi, «e quei soldi li ha impiegati per la vita del partito. La prova
evidente è che qui viveva soltanto con la sua pensione di parlamentare. Senza
nessun deposito milionario in banche straniere, come altri personaggi della
politica italiana. Spesso passava il suo tempo dipingendo vasi tricolori. Oppure
chiacchierando con la gente umile, come i pescatori di Hammamet».
Signora Anna, suo marito però,
direttamente o indirettamente, è stato pienamente coinvolto nell’inchiesta nota
come Tangentopoli.
«Certo, ma era il
capo di un partito che, come tutti gli altri partiti facevano all’epoca, si
manteneva con finanziamenti leciti e anche irregolari, a cui hanno concorso
i maggiori gruppi economici ed industriali d’Italia, pubblici e privati. Il Pci,
Partito comunista italiano, accettava persino di essere finanziato dal governo
dell’Urss, e nessun giudice ha mai osato mettere bocca. Lei ha un’idea di cosa
costasse la vita di un partito? C’era da organizzare convegni, periodici, pagare
la struttura organizzativa, i manifesti, i viaggi dei funzionari e cento altre
spese ingenti, che servivano a un’attiva presenza democratica, nella vita del
Paese».
Quando è cominciata la parabola
discendente di Bettino Craxi, presidente del consiglio italiano?
«Credo l’11 ottobre 1985, quando aerei
da guerra americani dirottarono un velivolo egiziano, con a bordo alcuni
palestinesi, sulla base di Sigonella in Sicilia, per catturare due ricercati
arabi. Mio marito si oppose con molta durezza e non consegnò i due latitanti. Fu
un grande e inaspettato gesto di dignità nazionale, e un grosso schiaffo per il
presidente Ronald Reagan. Poco dopo iniziò la persecuzione politica anche ad
opera della nostra magistratura, che voleva scardinare il sistema politico
italiano».
Signora Craxi, sono stato a visitare
la tomba di suo marito. Alì, il guardiano del cimitero, mi ha detto che in
questi quindici anni sono venuti migliaia di italiani, sia per ammirazione verso
l’uomo di Stato, sia per semplice curiosità. Sono stati riempiti ventisei libri
pieni di commenti lusinghieri, ma anche di qualche invettiva, scritti su quelle
pagine sistemate accanto al bianco loculo. Perché le sue spoglie non riposano in
Italia?
«Perché Bettino volle espressamente
rimanere qui, in questa terra ospitale, dove ancora oggi la famiglia Craxi è
circondata dall’affetto di questa gente semplice, alla quale mio marito ha fatto
anche molto bene. In occasione dell’anniversario dei quindici anni dalla morte,
i miei figli, Stefania e Bobo, porteranno qui, ad Hammamet, uno splendido busto
del padre in bronzo, che le autorità tunisine vogliono sistemare sulla strada
che gli hanno intitolato. Al ristorante Achour, dove spesso mangiavamo, c’è
ancora una sua foto, segno evidente della sua popolarità in terra tunisina.
Bettino mi disse: “Non consentirò ai miei nemici di riscrivere la storia”. E io
sono certo che il tempo galantuomo restituirà alla figura di quest’uomo politico
la sua giusta statura. Il suo funerale avvenne di notte, la salma trasportata su
un furgone Transit e sepolta nella sabbia, sotto le mura dell’antica Hammamet, a
fronte mare. Io non tornerò più in Italia, e gli ho promesso di riposare per
sempre accanto a lui, un italiano che non piegò mai il capo dinanzi alle
ingiustizie ed alla prepotenza straniera».
Signora Craxi, le confesso che mi ha
colpito molto un passo del libro scritto da suo marito dove, venti anni prima,
profetizzava quello che è l’Europa oggi. Infatti scriveva: “Sarà in preda alla
disoccupazione e alla conflittualità sociale, mentre il governo italiano sarà
costretto a rinegoziare i trattati, perché diventati obsoleti e pericolosi”.
Parole che, indubbiamente, denotano una notevole visione politica.
«È vero. Mio marito pensava sempre al
futuro, perché si aggrappava alla speranza
di poter tornare nella sua patria da uomo libero. Aveva dedicato al nostro Paese
tutta la sua vita, sin dalla più giovane età, e non ha mai accettato di essere
trattato come un delinquente comune, considerando quanto gli era accaduto come
una vera infamia. Mi diceva di non conoscere la felicità, perché la sua vita era
stata una corsa ad ostacoli e non si era mai fermato, per dire a se stesso:
adesso sono un uomo felice».
Mani Pulite, sfasciare l’Italia per venderla ai suoi carnefici,
scrive “Libre idee”. Mani Pulite? Un “golpe” giudiziario per radere al ruolo la
Prima Repubblica, corrotta fin che si vuole ma non disposta a demolire la
sovranità nazionale. «La vecchia dirigenza Dc-Psi, che per anni, nel bene e nel
male, aveva governato l’Italia – scrive Gianni Petrosillo – non avrebbe mai
ceduto alle pressioni esterne tese ad ottenere la liquidazione degli asset
strategici e patrimoniali del Belpaese, per una sua completa subordinazione a
(pre)potenze straniere, in atto di ricollocarsi sullo scacchiere geopolitico
dopo l’implosione dell’Unione Sovietica». Tutto ciò «verrà fatto dopo, dai
residuati della Prima Repubblica, sospettamente scampati alla mannaia
giudiziaria, pur avendo ricoperto ruoli e funzioni di primo piano per una lunga
fase, e da nuovi partiti frettolosamente nati sulle macerie di quelli vecchi o
appena riverniciati di falso moralismo necessario a mimetizzarsi tra scandali e
persecuzioni». Un magistrato come Tiziana Maiolo denunciò le “stranezze” del
pool di Milano, «il quale, incredibilmente, insabbiò le indagini sui comunisti e
mise i bastoni tra le ruote a quei magistrati che avrebbero voluto fare maggiore
chiarezza anche da quella parte». La stessa Maiolo, scrive Petrosillo su
“Conflitti e Strategie”, «riprende la tesi del complotto della Cia nell’affaire
Tangentopoli», anche se «non arriva a comprendere come gli americani potessero
fidarsi dei comunisti, cresciuti sotto l’ala di Mosca, per raggiungere i loro
scopi». Forse alla Maiolo erano sfuggiti «importanti spostamenti di campo che il
Pci iniziò ad operare sin dalla fine degli anni ’60 e che diventarono sempre più
evidenti con il compromesso storico, le dichiarazioni berlingueriane favorevoli
alla Nato e i viaggi d’oltreoceano di Giorgio Napolitano». L’onda lunga del
“tradimento” si completerà in seguito alla caduta dell’Urss con la svolta
occhettiana della Bolognina, che porterà la “ditta” a cambiare apertamente nome
e ragione sociale. «E’ vero che la gioiosa macchina da guerra del Pds
s’ingripperà sul più bello, mentre dava l’assalto al
potere», ma in effetti anche il complotto meglio pianificato può
incontrare un inghippo: in quel caso l’inghippo fu
Berlusconi, «catalizzatore del bacino elettorale dei partiti
distrutti dai giudici». Quando il pool di Milano «procedeva come un carro armato
e tutti aspettavano che finalmente andasse a colpire anche il Pci-Pds, che
andasse a fondo, che facesse una pulizia totale», grande stupore destarono
quindi le parole del procuratore aggiunto Gerardo D’Ambrosio, che in
un’intervista rilasciata al quotidiano “L’Unità” il 26 maggio 1993 annunciò che
a grandi linee l’inchiesta su Tangentopoli era finita, dopo aver colpito Dc e
Psi e risparmiato il Pci-Pds. Fu lo stesso D’Ambrosio, aggiunge Petrosillo, a
battersi per dimostrare che Primo Greganti, il faccendiere del Pci-Pds che aveva
prelevato denaro in Svizzera dal “Conto Gabbietta”, «rubava per sé e non per il
partito». Un paio di anni dopo, quando il quadro politico era radicalmente
cambiato e non esistevano più la Dc né il Psi (ma esisteva ancora l’ex partito
di Occhetto), il ministro di giustizia del governo Dini, Filippo Mancuso,
avvierà un’ispezione nei confronti del pool di Milano, e la questione Greganti
salterà di nuovo fuori. Dov’erano finiti quei soldi? «Nelle casse del Pci-Pds».
Ma il pool di Milano cessò di indagare. E a Tiziana Parenti, la giovane
magistrata che aveva osato sfidare i vertici della Quercia, l’inchiesta fu
tolta. «Ci sarà un altro magistrato la cui inchiesta sul Pci-Pds si infrangerà
su un muro di omertà complici e di “aiutini”», continua Petrosillo. Si tratta
del procuratore di Venezia, Carlo Nordio, cui a un certo punto furono trasferiti
anche atti provenienti da Milano. «L’interrogatorio di Luigi Carnevale, che
chiamava in causa esplicitamente Stefanini, Occhetto e D’Alema, non arrivò mai.
Si disse che era stata una “dimenticanza”. E così l’inchiesta di Venezia, come
tante altre che si snodarono in tutta Italia, si risolse con le condanne dei
pesci piccoli». E che dire di quel miliardo di lire che Raul Gardini, patron di
Enimont, avrebbe consegnato a Botteghe Oscure, su cui esistono diverse
testimonianze e per il quale Sergio Cusani fu condannato a sei anni di carcere?
«Sparito nelle stanze buie della grande federazione del Pci-Pds. Nessun
magistrato, né Di Pietro né in seguito i diversi tribunali individuarono in
quali mani il denaro fosse finito. Per D’Alema e Occhetto non è mai valso il
principio del “non poteva non sapere” o della “responsabilità oggettiva” con cui
fu colpito Bettino Craxi. Eppure c’era stato il racconto (indiretto) di Sergio
Cusani che aveva riferito di aver consegnato un miliardo nelle mani di Achille
Occhetto». Il tribunale che condannò Cusani scrisse: «Gardini si è recato di
persona nella sede del Pci portando con sé 1 miliardo di lire. Il destinatario
non era quindi semplicemente una persona, ma quella forza di opposizione che
aveva la possibilità di risolvere il grosso problema che assillava Enimont e il
fatto così accertato è stato dunque esattamente qualificato come illecito
finanziamento di un partito politico». Non si ricordano urla e strepiti del
pubblico ministero Antonio Di Pietro (anche se chiederà timidamente di
interrogare D’Alema), che dopo quel processo gettò la toga, scrive Petrosillo.
Occhetto e D’Alema non furono neppure sentiti e il miliardo passò alla
storia come finanziamento illegale “a un partito”. Francesco Misiani, pm
romano di sinistra aderente alla corrente più radicale di “Magistratura
democratica”, ha spiegato in un libro quale fosse il suo stato d’animo quando
scoprì che il Pci-Pds, «lungi dal rappresentare quella “diversità” su cui tanto
si era appassionato Enrico Berlinguer, era invece assolutamente omologo (un
terzo, un terzo, un terzo) ai partiti di governo e, proprio come aveva
denunciato l’inascoltato Craxi, si era sempre finanziato in modo illecito o
illegale». Anzi, avendo anche ricevuto finanziamenti dall’Unione Sovietica, come
racconterà con franchezza in un altro libro Gianni Cervetti, aveva persino
maggiore disponibilità finanziaria. Un politico di Forza Italia come Giuliano
Urbani racconta: «Nel 1994, quando ero ministro del primo governo Berlusconi,
fui avvicinato da alcuni professori miei amici, che erano legati alla Cia, i
quali mi misero in guardia da Di Pietro, mi suggerirono di diffidare della
persona. Mi dissero con certezza che Di Pietro nella costruzione di tangentopoli
era stato aiutato dai servizi segreti americani». Secondo i “contatti” di
Urbani, il desiderio di vendetta degli Stati Uniti nei confronti di Craxi,
Spadolini e Andreotti per i fatti di Sigonella ebbe diversi strumenti operativi,
tra cui appunto l’uso di Tonino Di Pietro. «Il quale in effetti arrivò,
distrusse e se ne andò. Su mandato dei servizi segreti americani». Il racconto
di Urbani, proprio perché proviene da un liberale che arrivò nei palazzi del
potere “dopo”, e quindi non aveva nessun motivo di revanchismo nei confronti del
Pm di Mani Pulite, sembra convincente: «Quegli amici mi hanno avvicinato per
avvertirmi della doppiezza dell’uomo, che era stato protagonista di una pagina
oscura. E mi hanno proprio cercato loro, appositamente». Vengono con facilità
alla memoria quelle trattative, poi saltate, per far entrare Di Pietro nel
governo Berlusconi. E i dubbi aumentano. «Sappiamo come è cominciata, ma non
sappiamo perché», osserva Petrosillo. «Perché una colossale retata giudiziaria a
strascico abbia rivoluzionato la fisionomia politica del paese». C’è chi ha
sposato la teoria del complotto internazionale, scrive Petrosillo. Sostenuta da
molti esponenti governativi prestigiosi della Prima Repubblica (Craxi in
primis), questa ipotesi parte dal presupposto che la magistratura fino al 1992
ignorò il finanziamento illecito dei partiti. Poi, con l’arresto di Mario
Chiesa, il caso esplose e si trasformò in un “processo al sistema”. «Qualcuno,
si dice, aveva interesse ad annientare l’intera classe politica al governo e
sostituirla con un’altra. Chi? Perché?». Francesco Cossiga ha fatto parte di
coloro che hanno creduto al complotto internazionale. In una delle sue ultime
interviste, attribuì alla Cia un ruolo importante sull’inizio di Tangentopoli,
così come sulle “disgrazie” di Craxi e Andreotti. In quel periodo alla Casa
Bianca c’erano amministrazioni del Partito democratico, «le più interventiste e
implacabili». Un altro boss della Prima Repubblica, l’ex ministro democristiano
Paolo Cirino Pomicino, sostiene che il “complotto” iniziò proprio nel 1992, la
data fatidica di Mani Pulite. In quei giorni il capo della Cia, James Woolsey,
spiegò che l’amministrazione Clinton aveva disposto un vero spionaggio
industriale, e a Milano sbarcò l’agenzia privata di investigazioni Kroll. Gli
Usa raccolsero corposi dossier sul finanziamento illecito. E il capo della Cia
fece sapere al suo governo che c’era la possibilità di far scoppiare scandali,
se fosse servito. Nell’analisi di Cirino Pomicino, aggiunge Petrosillo, c’è
anche la Gran Bretagna, dove «la Thatcher aveva perso la battaglia sulla moneta
unica e gli americani iniziarono una politica aggressiva per difendere il
dollaro», oltre che una certa attenzione ai problemi avuti da Chirac in Francia
e Kohl in Germania. In quel momento «sarebbe stata scelta l’Italia, come luogo
dove far scoppiare lo scandalo». Il punto debole, conclude Petrosillo, è la
strategia che gli americani avrebbero avuto sul “dopo”. «Chi assaltò il Palazzo
d’inverno, chi prese la Bastiglia aveva un progetto per il giorno dopo la
rivoluzione. I servizi segreti americani avevano dunque un accordo con Occhetto?
Oppure con quei “poteri forti” che cercavano la discontinuità e che non ameranno
mai Berlusconi, trattato sempre come un Maradona, geniaccio arrivato
d’improvviso dalle favelas?». La risposta è nei fatti, dal Britannia in poi, col
clamoroso precedente del divorzio tra il Tesoro e Bankitalia, quando la banca
centrale era retta da Ciampi. Lo ha spiegato molto bene Nino Galloni, consulente
di Andreotti alla vigilia del Trattato di Maastricht: l’Italia fu
deliberatamente azzoppata, con la complicità delle sue élite tecnocratiche in
quota al futuro centrosinistra, per sabotare il sistema produttivo nazionale,
come chiedeva la Germania per aderire all’euro e
gestire il disegno strategico di indebolimento generale dell’Europa.
Il resto è cronaca, e si chiama crisi.
Mani Pulite? Un “golpe” giudiziario per radere al ruolo la Prima Repubblica,
corrotta fin che si vuole ma non disposta a demolire la sovranità nazionale. «La
vecchia dirigenza Dc-Psi, che per anni, nel bene e nel male, aveva governato
l’Italia – scrive Gianni Petrosillo – non avrebbe mai ceduto alle pressioni
esterne tese ad ottenere la liquidazione degli asset strategici e patrimoniali
del Belpaese, per una sua completa subordinazione a (pre)potenze straniere, in
atto di ricollocarsi sullo scacchiere geopolitico dopo l’implosione dell’Unione
Sovietica». Tutto ciò «verrà fatto dopo, dai residuati della Prima Repubblica,
sospettamente scampati alla mannaia giudiziaria, pur avendo ricoperto ruoli e
funzioni di primo piano per una lunga fase, e da nuovi partiti frettolosamente
nati sulle macerie di quelli vecchi o appena riverniciati di falso moralismo
necessario a mimetizzarsi tra scandali e persecuzioni». Un magistrato come
Tiziana Maiolo denunciò le “stranezze” del pool di Milano, «il quale,
incredibilmente, insabbiò le indagini sui comunisti e mise i bastoni tra le
ruote a quei magistrati che avrebbero voluto fare maggiore chiarezza anche da
quella parte». La stessa Maiolo, scrive Petrosillo su “Conflitti e Strategie”,
«riprende la tesi del complotto della Cia nell’affaire Tangentopoli», anche se
«non arriva a comprendere come gli americani potessero fidarsi dei comunisti,
cresciuti sotto l’ala di Mosca, per raggiungere
i loro scopi». Forse alla Maiolo erano sfuggiti «importanti spostamenti di campo
che il Pci iniziò ad operare sin dalla fine degli anni ’60 e che diventarono
sempre più evidenti con il compromesso storico, le dichiarazioni berlingueriane
favorevoli alla Nato e i viaggi d’oltreoceano di Giorgio Napolitano». L’onda
lunga del “tradimento” si completerà in seguito alla caduta dell’Urss con la
svolta occhettiana della Bolognina, che porterà la “ditta” a cambiare
apertamente nome e ragione sociale. «E’ vero che la gioiosa macchina da guerra
del Pds s’ingripperà sul più bello, mentre dava l’assalto al potere», ma in
effetti anche il complotto meglio pianificato può incontrare un inghippo: in
quel caso l’inghippo fu Berlusconi,
«catalizzatore del bacino elettorale dei partiti distrutti dai giudici». Quando
il pool di Milano «procedeva come un carro armato e tutti aspettavano che
finalmente andasse a colpire anche il Pci-Pds, che andasse a fondo, che facesse
una pulizia totale», grande stupore destarono quindi le parole del procuratore
aggiunto Gerardo D’Ambrosio, che in un’intervista rilasciata al quotidiano
“L’Unità” il 26 maggio 1993 annunciò che a grandi linee l’inchiesta su
Tangentopoli era finita, dopo aver colpito Dc e Psi e risparmiato il Pci-Pds. Fu
lo stesso D’Ambrosio, aggiunge Petrosillo, a battersi per dimostrare che Primo
Greganti, il faccendiere del Pci-Pds che aveva prelevato denaro in Svizzera dal
“Conto Gabbietta”, «rubava per sé e non per il partito». Un paio di anni dopo,
quando il quadro politico era radicalmente cambiato e non esistevano più la Dc
né il Psi (ma esisteva ancora l’ex partito di Occhetto), il ministro di
giustizia del governo Dini, Filippo Mancuso, avvierà un’ispezione nei confronti
del pool di Milano, e la questione Greganti salterà di nuovo fuori. Dov’erano
finiti quei soldi? «Nelle casse del Pci-Pds». Ma il pool di Milano cessò di
indagare. E a Tiziana Parenti, la giovane magistrata che aveva osato sfidare i
vertici della Quercia, l’inchiesta fu tolta. «Ci sarà un altro magistrato la cui
inchiesta sul Pci-Pds si infrangerà su un muro di omertà complici e di
“aiutini”», continua Petrosillo. Si tratta del procuratore di Venezia, Carlo
Nordio, cui a un certo punto furono trasferiti anche atti provenienti da Milano.
«L’interrogatorio di Luigi Carnevale, che chiamava in causa esplicitamente
Stefanini, Occhetto e D’Alema, non arrivò mai. Si disse che era stata una
“dimenticanza”. E così l’inchiesta di Venezia, come tante altre che si snodarono
in tutta Italia, si risolse con le condanne dei pesci piccoli». E che dire di
quel miliardo di lire che Raul Gardini, patron di Enimont, avrebbe consegnato a
Botteghe Oscure, su cui esistono diverse testimonianze e per il quale Sergio
Cusani fu condannato a sei anni di carcere? «Sparito nelle stanze buie della
grande federazione del Pci-Pds. Nessun magistrato, né Di Pietro né in seguito i
diversi tribunali individuarono in quali mani il denaro fosse finito. Per
D’Alema e Occhetto non è mai valso il principio del “non poteva non sapere” o
della “responsabilità oggettiva” con cui fu colpito Bettino Craxi. Eppure c’era
stato il racconto (indiretto) di Sergio Cusani che aveva riferito di aver
consegnato un miliardo nelle mani di Achille Occhetto». Il tribunale che
condannò Cusani scrisse: «Gardini si è recato di persona nella sede del Pci
portando con sé 1 miliardo di lire. Il destinatario non era quindi semplicemente
una persona, ma quella forza di opposizione che aveva la possibilità di
risolvere il grosso problema che assillava Enimont e il fatto così accertato è
stato dunque esattamente qualificato come illecito finanziamento di un partito
politico». Non si ricordano urla e strepiti del pubblico ministero Antonio Di
Pietro (anche se chiederà timidamente di interrogare D’Alema), che dopo quel
processo gettò la toga, scrive Petrosillo. Occhetto e D’Alema non furono neppure
sentiti e il miliardo passò alla storia come
finanziamento illegale “a un partito”. Francesco Misiani, pm romano di sinistra
aderente alla corrente più radicale di “Magistratura democratica”, ha spiegato
in un libro quale fosse il suo stato d’animo quando scoprì che il Pci-Pds,
«lungi dal rappresentare quella “diversità” su cui tanto si era appassionato
Enrico Berlinguer, era invece assolutamente omologo (un terzo, un terzo, un
terzo) ai partiti di governo e, proprio come aveva denunciato l’inascoltato
Craxi, si era sempre finanziato in modo illecito o illegale». Anzi, avendo anche
ricevuto finanziamenti dall’Unione
Sovietica, come racconterà con franchezza in un altro libro Gianni Cervetti,
aveva persino maggiore disponibilità finanziaria. Un politico di Forza Italia
come Giuliano Urbani racconta: «Nel 1994, quando ero ministro del primo governo Berlusconi,
fui avvicinato da alcuni professori miei amici, che erano legati alla Cia, i
quali mi misero in guardia da Di Pietro, mi suggerirono di diffidare della
persona. Mi dissero con certezza che Di Pietro nella costruzione di tangentopoli
era stato aiutato dai servizi segreti americani». Secondo i “contatti” di
Urbani, il desiderio di vendetta degli Stati Uniti nei confronti di Craxi,
Spadolini e Andreotti per i fatti di Sigonella ebbe diversi strumenti operativi,
tra cui appunto l’uso di Tonino Di Pietro. «Il quale in effetti arrivò,
distrusse e se ne andò. Su mandato dei servizi segreti americani». Il racconto
di Urbani, proprio perché proviene da un liberale che arrivò nei palazzi del potere “dopo”,
e quindi non aveva nessun motivo di revanchismo nei confronti del Pm di Mani
Pulite, sembra convincente: «Quegli amici mi hanno avvicinato per avvertirmi
della doppiezza dell’uomo, che era stato protagonista di una pagina oscura. E mi
hanno proprio cercato loro, appositamente». Vengono con facilità alla memoria
quelle trattative, poi saltate, per far entrare Di Pietro nel governo Berlusconi.
E i dubbi aumentano. «Sappiamo come è cominciata, ma non sappiamo perché»,
osserva Petrosillo. «Perché una colossale retata giudiziaria a strascico abbia
rivoluzionato la fisionomia politica del
paese». C’è chi ha sposato la teoria del complotto internazionale, scrive
Petrosillo. Sostenuta da molti esponenti governativi prestigiosi della Prima
Repubblica (Craxi in primis), questa ipotesi parte dal presupposto che la
magistratura fino al 1992 ignorò il finanziamento illecito dei partiti. Poi, con
l’arresto di Mario Chiesa, il caso esplose e si trasformò in un “processo al
sistema”. «Qualcuno, si dice, aveva interesse ad annientare l’intera classe politica al
governo e sostituirla con un’altra. Chi? Perché?». Francesco Cossiga ha fatto
parte di coloro che hanno creduto al complotto internazionale. In una delle sue
ultime interviste, attribuì alla Cia un ruolo importante sull’inizio di
Tangentopoli, così come sulle “disgrazie” di Craxi e Andreotti. In quel periodo
alla Casa Bianca c’erano amministrazioni del Partito democratico, «le più
interventiste e implacabili». Un altro boss della Prima Repubblica, l’ex
ministro democristiano Paolo Cirino Pomicino, sostiene che il “complotto” iniziò
proprio nel 1992, la data fatidica di Mani Pulite. In quei giorni il capo della
Cia, James Woolsey, spiegò che l’amministrazione Clinton aveva disposto un vero
spionaggio industriale, e a Milano sbarcò l’agenzia privata di investigazioni
Kroll. Gli Usa raccolsero
corposi dossier sul finanziamento
illecito. E il capo della Cia fece sapere al suo governo che c’era la
possibilità di far scoppiare scandali, se fosse servito. Nell’analisi di Cirino
Pomicino, aggiunge Petrosillo, c’è anche la Gran Bretagna, dove «la Thatcher
aveva perso la battaglia sulla moneta unica e gli americani iniziarono una politica aggressiva
per difendere il dollaro», oltre che una certa attenzione ai problemi avuti da
Chirac in Francia e Kohl in Germania.
In quel momento «sarebbe stata scelta l’Italia, come luogo dove far scoppiare lo
scandalo». Il punto debole, conclude Petrosillo, è la strategia che gli
americani avrebbero avuto sul “dopo”. «Chi assaltò il Palazzo d’inverno, chi
prese la Bastiglia aveva un progetto per il giorno dopo la rivoluzione. I
servizi segreti americani avevano dunque un accordo con Occhetto? Oppure con
quei “poteri forti” che cercavano la discontinuità e che non ameranno mai Berlusconi,
trattato sempre come un Maradona, geniaccio arrivato d’improvviso dalle
favelas?». La risposta è nei fatti, dal Britannia in poi, col clamoroso
precedente del divorzio tra il Tesoro e Bankitalia, quando la banca centrale era
retta da Ciampi. Lo ha spiegato molto bene Nino Galloni, consulente di Andreotti
alla vigilia del Trattato di Maastricht: l’Italia fu deliberatamente azzoppata,
con la complicità delle sue élite tecnocratiche in quota al futuro
centrosinistra, per sabotare il sistema produttivo nazionale, come chiedeva la Germania
per aderire all’euro e
gestire il disegno strategico di indebolimento generale dell’Europa. Il resto è
cronaca, e si chiama crisi.
Quando Bettino Craxi osò sfidare il gigante Usa.
In La notte di Sigonella documenti d'epoca,
rapporti segreti e testi del premier socialista svelano tutti i retroscena del
braccio di ferro tra Roma e Washington, scrive Stefano Zurlo lunedì 5 ottobre
2015. L'orgoglio italiano. La rabbia americana. E una scena da film di
fantascienza: cinquanta carabinieri che circondano un aereo egiziano e sono
circondati a loro volta da cinquanta militari della Delta Force. Tutto sulla
pista di una base Nato siciliana. Tutto in poche ore. Tutto dentro un grande
scombussolamento dei rapporti fra Roma e Washington. Ora quella storia
drammatica e intricata, ultimo atto del sequestro dell'Achille Lauro, diventa un
libro, La notte di Sigonella, Mondadori, da domani in libreria, a firma del
protagonista numero uno di quelle giornate dell'autunno 1985: Bettino Craxi. Un
volume particolarmente interessante, soprattutto perché dai documenti, alcuni
inediti, e dalla corrispondenza, finalmente declassificata, a stelle e strisce,
si capisce che, nel turbinio di quelle ore fra notizie contraddittorie e
confuse, Craxi prese infine la strada giusta. Il governo italiano assicurò alla
giustizia i quattro dirottatori dell'Achille Lauro, responsabili dell'atroce
morte dell'ebreo americano Leon Klinghoffer, ucciso a sangue freddo e gettato in
mare; l'Italia però non si piegò agli Usa che avevano organizzato un blitz a
Sigonella per catturare e portare via Abu Abbas, il mediatore della vicenda,
ritenuto dagli americani un complice dei terroristi. Craxi disse no e ora, dalle
carte finalmente disponibili, s'intuisce che gli americani dovettero infine
riconoscere, al di là del malumore, le ragioni italiane. In una missiva del 24
ottobre 1985, pochi giorni dopo la conclusione della vicenda, l'ambasciatore a
Roma Maxwell Rabb scrive alla Segreteria di Stato: «L'esperienza dimostra che
dobbiamo migliorare il nostro coordinamento, agire insieme piuttosto che
unilateralmente». Sì, autocritica più che critica davanti alla scoperta,
probabilmente inattesa, che l'Italia di quell'ottobre 1985 non è più l'Italietta
dell'8 settembre. Debole, incerta, senza voce nel concerto delle grandi potenze.
Craxi si fa sentire, eccome. E nella nota spedita a tutte le rappresentanze
diplomatiche del Medio Oriente e del Sudest asiatico, la Segreteria di Stato
ammette candidamente: «Secondo il nostro trattato di estradizione, se l'Italia
processa per gli stessi fatti per i quali vorremmo processare, l'Italia ha il
diritto di rigettare la nostra richiesta di estradizione. Non abbiamo alcuna
giurisdizione sull'omicidio di Leon Klinghoffer». Sembra di leggere il pensiero
tricolore, per una volta alto e forte, e invece è quello che si sostiene a
Washington. Insomma, il coraggio tricolore, quel no e ancora no detto e
ripetuto, lacera la tela dei rapporti ma non la strappa. E semmai costringe gli
Usa a riflettere. Del resto gli americani in quelle ore trattano Roma come una
colonia. La storia comincia alle 13.10 del 7 ottobre quando al largo di Port
Said, in Egitto, viene dirottata la nave da crociera; i terroristi sono
palestinesi. Arafat invia Abu Abbas e il 9 ottobre sembra delinearsi il lieto
fine: la nave viene liberata. All'apparenza senza spargimento di sangue e invece
non è così, in un susseguirsi di colpi di scena. Il primo: si scopre che un
passeggero paralitico è stato scaraventato in mare. Il secondo arriva alle 23.50
del 10 ottobre; la Casa Bianca chiama il premier Bettino Craxi e annuncia: il
Boeing dell'EgyptAir, con a bordo i dirottatori e Abu Abbas, è stato
intercettato da quattro caccia F-14 e obbligato a dirigersi verso l'Italia. Di
lì a pochi minuti tutti i velivoli saranno a Sigonella. L'America vuole tutto e
subito: la consegna degli assassini e dei mediatori palestinesi che verranno
immediatamente trasferiti negli Usa. Craxi però non si arrende e anzi delinea
una sua linea ben precisa: i sequestratori hanno colpito una nave italiana in
acque internazionali, dunque saranno processati a Roma e non negli Usa. Inoltre
Abu Abbas è un mediatore e non un complice, anche se il commando è una scheggia
impazzita della sua fazione. In quell'interminabile notte si rischia un
conflitto a fuoco senza precedenti: i carabinieri sono intorno al Boeing
egiziano, ma sono a loro volta nel mirino dei militari americani del generale
Carl Steiner. Lunghi minuti di tensione. Poi, alle quattro del mattino, l'alto
ufficiale si ritira e lascia il campo ai padroni di casa. E' finito il primo
round, la contesa va avanti. In una difficilissima operazione di equilibrio,
Craxi sposta il Boeing da Sigonella a Ciampino. E questo per due ragioni: per
garantire ai membri dell'Olp a bordo la possibilità di consultarsi con
l'ambasciata egiziana a Roma e poi per dare tempo agli americani che stanno
cercando nuove prove contro Abu Abbas. Alle sei del mattino del 13 ottobre gli
Stati Uniti recapitano la richiesta di arresto provvisorio. L'Italia però
scandisce un altro no: le prove non ci sono. Abu Abbas è libero e abbandona
l'Italia via Belgrado. In una lettera al Giornale, pubblicata l'11 marzo 1997,
Craxi afferma: «Mi si chiedeva una cosa francamente impossibile e perciò non la
feci, anche se mi costò una crisi di governo, subito poi rientrata. Il
presidente americano mi scrisse una lettera che iniziava “caro Bettino” e mi
invitava a New York». Ronald Reagan alla fine si adeguò.
OPERATORI
DI (IN)GIUSTIZIA…..
Giustizia:
per l'Unione europea la presunzione d'innocenza è un diritto fondamentale,
scrive Damiano Aliprandi su "Il Garantista" del 15 aprile 2015.
Iniziato iter per la Direttiva. Il giustizialismo è diventato un problema
europeo e la commissiono europarlamentare vuole correre ai ripari. "La
presunzione d'innocenza è un diritto fondamentale e anzitutto un principio
essenziale che intende garantire da abusi giudiziari e giudizi arbitrari nei
procedimenti penali!", ha dichiarato la francese Nathalie Griesheck, relatore
del provvedimento in Commissione Libertà civili che prevede una normativa in
grado di dissuadere le autorità giudiziarie nazionali dal fare dichiarazioni
sulla colpevolezza di un condannato prima del giudizio definitivo, o che violino
i principi dell'onere della prova (che spetta alla pubblica accusa), quello di
rimanere in silenzio durante gli interrogatori e quello di essere presenti
fisicamente al proprio processo. Questa "proposta di direttiva nasce dal fatto
che notiamo un'erosione del principio di presunzione di innocenza in diversi
Paesi membri", ha aggiunto sempre la Griesheck, Il provvedimento della
Commissione pone anche il problema dei mezzi di informazione molto spesso legati
con le autorità giudiziarie che fanno da megafono. Infatti l'emendamento
richiede ai Paesi membri di vietare alle autorità giudiziarie locali di dare
informazioni - incluse interviste e comunicazioni in collaborazione con i media
- che potrebbero creare pregiudizio o biasimo nei confronti di indagati o
accusati prima della sentenza finale in tribunale. L'europarlamento in pratica
chiede di promuovere un vero e proprio codice etico e di rispettarlo. Un altro
aspetto dell'emendamento è quello di non far travisare - attraverso i mezzi di
informazione - la legittima facoltà di non rispondere dell'imputato come "prova"
di colpevolezza. "L'esercizio di questo diritto - spiega sempre la relatrice
Nathalie Griesbeck - non deve mai essere considerato come una conferma dì una
tesi sui fatti occorsi". Con l'approvazione della Commissione ora inizia il
negoziato con il Consiglio Uè per poi arrivare alla formale proposta di
direttiva. Sempre attraverso la suddetta Commissione, in questi giorni, ci si
sta occupando della situazione carceraria e il commissario Nìls Muiznieks ha
espresso gratitudine per i miglioramenti apportati per rimediare al nostro
sovraffollamento penitenziario, ma ha precisato che ancora non abbiamo risolto
definitivamente il problema. Nel corso di un'audizione della Commissione Libertà
civili, è stato ascoltato il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola
Gratteri e consulente del Governo Renzi sui problemi della giustizia e la lotta
alle mafie, ha dichiarato di non rallegrarsi per quello che è stato detto dal
Consiglio d'Europa sullo svuotamento delle carceri in Italia. Ma sempre per
Gratteri la soluzione è la costruzione di nuove carceri e non subire ciò che
dice l'Europa. Gratteri, ricordiamo, solo per un soffio al momento della
formazione del Governo Renzi non diventò ministro della Giustizia così come era
stato annunciato.
Gherardo
Colombo: "Io, magistrato pentito, non credo più nella punizione".
Il modello possibile della giustizia riparativa. Rispetto a un sistema che non
riconosce le vittime e che crea solo inutile sofferenza. Rendendo più insicura
la società. Ma i politici hanno un solo cruccio: aumentare le pene. Come nel
caso - "fuori luogo" - dell'omicidio stradale. Parla il grande giudice e pm,
scrive Francesca Sironi su “L’Espresso”. Gherardo Colombo: «Questa donna ha
ragione. E va ascoltata. Perché se oggi il carcere svolge una funzione, è la
vendetta». Prima giudice, poi pubblico ministero in inchieste che hanno fatto la
storia d’Italia come la Loggia P2 o Mani Pulite, Gherardo Colombo ha messo
profondamente in discussione le sue idee: «Ero uno che le mandava le persone in
prigione, convinto fosse utile. Ma da almeno quindici anni ho iniziato un
percorso che mi porta a ritenere errata quella convinzione».
Da uomo di
legge, la sua è una posizione tanto netta quanto sorprendente.
«È concreta. I
penitenziari sono inefficaci, se non dannosi per la società. Anziché aumentare
la sicurezza, la diminuiscono, restituendo uomini più fragili o più pericolosi,
privando le persone della libertà senza dare loro quella possibilità di recupero
sancita dalla Costituzione. Esistono esempi positivi, come il reparto “La Nave”
per i tossicodipendenti a San Vittore, o il carcere di Bollate, ma sono minimi».
Molti dati
mostrano la debolezza della rieducazione nei nostri penitenziari. Ma perché
parlare addirittura di vendetta?
«Credo sia
così. Pensiamo alle vittime: cosa riconosce la giustizia italiana alla vittima
di un reato? Nulla. Niente; se vuole un risarcimento deve pagarsi l’avvocato.
Così non gli resta che una sola compensazione: la vendetta, sapere che chi ha
offeso sta soffrendo. La nostra è infatti una giustizia retributiva: che
retribuisce cioè chi ha subito il danno con la sofferenza di chi gli ha fatto
male».
Esistono
esperienze alternative?
«Sì. In molti
Paesi europei sono sperimentate da tempo le strade della “giustizia riparativa”,
che cerca di compensare la vittima e far assumere al condannato la piena
responsabilità del proprio gesto. Sono percorsi difficili, spesso più duri dei
pomeriggi in cella. Ma dai risultati molto positivi».
Se questa
possibilità è tracciata in Europa, perché un governo come quello attuale, così
impegnato nelle riforme, non guarda anche alle carceri?
«Nei discorsi
ufficiali sono tutti impegnati piuttosto ad aumentare le pene, a sostenere
“condanne esemplari”, come sta succedendo per la legge sull’omicidio stradale -
una prospettiva che trovo quasi fuori luogo: quale effetto deterrente avrebbe su
un delitto colposo? Ma al di là del caso particolare, il problema è che i
politici rispondono alla cultura dei loro elettori. Il pensiero comune è che al
reato debba corrispondere una punizione, che è giusto consista nella sofferenza.
Me ne accorgo quando parlo nelle scuole del mio libro, “Il perdono
responsabile”: l’idea per cui chi ha sbagliato deve pagare è un assioma
granitico, che solo attraverso un dialogo approfondito i ragazzi, al contrario
di tanti adulti, riescono a superare. D’altronde il carcere è una risposta alla
paura, e la paura è irrazionale, per cui è difficile discuterne».
È una paura
comprensibile, però. Parliamo di persone che hanno rubato, spacciato, ucciso,
corrotto.
«Ovviamente
chi è pericoloso deve stare da un’altra parte, nel rispetto delle condizioni di
dignità spesso disattese nei nostri penitenziari. Ma solo chi è pericoloso. Ed è
invece necessario pensare fin da subito, per tutti, alla riabilitazione. Anche
perché queste persone, scontata la condanna, torneranno all’interno di quella
società che li respinge».
Luigi
Manconi: "Aboliamo il carcere".
Inefficace, costoso e violento. Per questo il sistema penitenziario va cambiato.
Le proposte in un libro appena uscito, continua Francesca Sironi. Primo: il
carcere È inutile, perché sette detenuti su dieci tornano a compiere reati.
Secondo: le galere non esistono da sempre. Terzo: le celle sono violente.
Cambiare l’esecuzione della pena in Italia è l’obiettivo di un libro implacabile
scritto da Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone e Federica
Resta, appena pubblicato da Chiarelettere con il titolo: «Abolire il carcere,
una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini». Il volume raccoglie
dati, storie e notizie su torture, recidiva, costi assurdi, sbagli e omissioni
di un sistema che restituisce alla collettività criminali peggiori di quelli che
aveva rinchiuso. Da questa analisi, scrive Luigi Manconi, presidente della
Commissione diritti umani del Senato, emerge come «la pena si mostri in carcere
nella sua essenzialità quale vera e propria vendetta. E in quanto tale priva di
qualunque effetto razionale e totalmente estranea a quel fine che la
Costituzione indica nella rieducazione del condannato». Per questo gli autori
propongono dieci riforme possibili. A partire dall’idea che «il carcere da
regola dovrebbe diventare eccezione, extrema ratio», come sostiene il
costituzionalista Gustavo Zagrebelsky nella postfazione.
Soro, Garante
della privacy: «Stop ai processi mediatici, ne va della vita delle persone»,
scrive Errico Novi su “Il Garantista”. C’è una parola che Antonello Soro non si
stanca di ripetere: «Dignità». A un certo punto tocca chiedergli: presidente, ma
com’è possibile che non riusciamo a tenercela stretta, la dignità? Che abbiamo
ridotto il processo penale a un rodeo in cui la persona è continuamente sbalzata
per aria? E lui, che presiede l’Autorità garante della Privacy, può rispondere
solo in un modo: siete pregati di scendere dalla giostra. La giostra del
processo mediatico, s’intende. «È una degenerazione del sistema che può essere
fermata in un modo: se ciascuna delle parti, stampa, magistrati, avvocati, evita
di dare un’interpretazione un po’ radicale delle proprie funzioni. C’è un nuovo
integralismo, attorno al processo, da cui bisogna affrancarsi. Anche perché la
giustizia propriamente intesa si fonda sulla presunzione d’innocenza. Quella
mediatica ha come stella polare la presunzione di colpevolezza».
Senta
presidente Soro, ma non è che il processo mediatico è una droga di cui non
possiamo più fare a meno, magari anche per alleviare i disagi di una condizione
generale del Paese ancora non del tutto risollevata?
«Non
credo che per spiegare le esasperazioni dell’incrocio tra media e giustizia sia
necessario arrivare a una lettura del genere. Siamo in una fase, che ormai dura
da molto, in cui prevale un nuovo integralismo, anche rispetto alla preminenza
che ciascuno attribuisce al proprio ruolo. Succede in tutti gli ambiti, compreso
quello giudiziario. Ciascuna delle parti si mostra poco disponibile ad
affrontare le criticità del fenomeno che chiamiamo processo mediatico.
Be’, lei
descrive una tendenza che brutalmente potremmo definire isteria forcaiola.
«È
il risultato di atteggiamenti – che pure non rappresentano la norma –
sviluppatisi tra i giornalisti e anche tra i magistrati, persino tra gli
avvocati. Ciascuna di queste componenti finisce in alcuni casi per deformare la
propria missione. Il tema è sicuramente complesso, io mi permetto sempre di
suggerire che si lascino da parte i toni ultimativi, quando si affronta la
questione. Lo sforzo che va fatto è proprio quello di trattenersi dall’esaltare
la propria indispensabile funzione. Esaltare la propria si traduce fatalmente
nel trascurare la funzione degli altri.
È una
situazione di squilibrio in cui parecchi sembrano trovarsi a loro agio, tanto da
difenderla. È il caso delle intercettazioni.
«Nessuna
persona ragionevole può mettere in discussione l’utilità delle intercettazioni e
il diritto dei cittadini all’informazione. Due elementi di rango differente ma
ugualmente imprescindibili. Nessuno pensa di rinunciare né alle intercettazioni
né all’informazione. Si tratta di valutare con il giusto spirito critico la
funzione di entrambe.
E non
dovrebbe volerci uno sforzo così grande, no?
«No.
Però cosa abbiamo davanti? Paginate intere di intercettazioni, avvisi di
garanzia anticipati ai giornali, interrogatori di indagati in stato detentivo di
cui apprendiamo integralmente il contenuto, immagini di imputati in manette,
processi che sembrano celebrarsi sui giornali più che nelle aule giudiziarie. E
in più c’è una variabile moltiplicatrice.
Quale?
«La
rete. E’ un tema tutt’altro che secondario. La diffusione in rete delle
informazioni e della produzione giornalistica non è neppure specificamente
disciplinata dal codice deontologico dei giornalisti, che risale al 1998, quando
il peso oggi acquisito dal web non era ancora stimabile.
Qual è
l’aspetto più pericoloso, da questo punto di vista?
«Basta
riflettere su una differenza, quella tra archivi cartacei e risorse della rete.
Su quest’ultima la notizia diviene eterna, non ha limiti temporali, ha la forza
di produrre condizionamenti irreparabili nella vita delle persone.
La gogna
della rete costituisce insomma un fine pena mai a prescindere da come finisce un
processo.
È uno degli
aspetti che contribuiscono a rendere molto complesso il fenomeno dei processi
mediatici. Tutto può essere riequilibrato, ma ora vedo scarsa attenzione per
tutto quanto riguardi il bilanciamento tra i diritti fondamentali in gioco. Un
bilanciamento che invece ritengo indispensabile quando riguarda la dignità delle
persone.
È un
principio di civiltà così elementare, presidente, che il fatto stesso di doverlo
invocare fa venire i brividi. Di paura.
«Nel
nostro sistema giuridico anche chi è condannato deve veder riconosciuta la
propria dignità. Basterebbe recuperare questo principio. Che nella nostra
Costituzione è centrale. Una comunità che rinuncia a questo presidio di civiltà
ha qualche problema».
Com’è
possibile che abbiamo rinunciato?
«Ripeto:
stiamo dicendo per caso che dobbiamo eliminare l’uso delle tecnologie più
sofisticate nelle indagini? No. Si pretende di negare il diritto
all’informazione? Neppure. Si dovrebbe solo coniugare questi aspetti con la
dignità delle persone, anche con riguardo alla loro vita privata. La privacy non
è un lusso. Il fondamento della privacy è sempre la dignità della persona».
Se si prova
a toccare le intercettazioni parte subito la retorica del bavaglio.
«Al
giudice, in una prima fase, spetta la decisione sull’acquisizione delle
intercettazioni rilevanti ai fini del procedimento, mentre al giornalista
spetta, in seconda battuta, la scelta di quelle da pubblicare perché di
interesse pubblico. Non è detto che il giornalista debba pubblicare tutti gli
atti che ha raccolto compresi quelli irrilevanti ai fini del processo».
Spesso
quelli irrilevanti sul piano penale sono i più succosi da servire al lettore.
«Guardi,
è plausibile che alcune intercettazioni contengano elementi utili per la
ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti anche se non riguardano la persona
indagata. Può avere senso che elementi del genere vengano resi pubblici. Ma
altri che non hanno utilità ai fini del processo andrebbero vagliati con
particolare rigore in funzione di un vero interesse pubblico. Prescinderei dai
singoli episodi. Ma ricorderei due princìpi abbastanza trascurati. Da una parte,
la conoscenza anche di un dettaglio della vita privata di un personaggio che
riveste funzioni pubbliche può essere opportuna, se quel fatto rischia di
condizionarne l’esercizio della funzione. È giusto che il cittadino conosca cose
del genere».
Ad esempio,
il fatto che Berlusconi ospitasse a casa sua molte giovani donne, alcune delle
quali erano prostitute e lui neppure lo sapeva.
«Sì,
però poi i dettagli sulle attività erotiche di un leader politico, tanto per
dire, possono alimentare curiosità, ma è difficile riconoscerne il senso, in
termini di diritto all’informazione. In altre parole: può essere utile sapere
che quel leader, in momenti in cui esercita la propria funzione pubblica, compie
atti che, ad esempio, lo espongono al ricatto; ma riportare atti giudiziari che
entrano morbosamente nel dettaglio, diciamo così, va al di là di
quell’informazione utile di cui sopra. A meno che non riferiscano comportamenti
che costituiscono reato».
Negli
ultimi anni l’inopportunità di certe divulgazioni spesso è emersa quand’era
troppo tardi.
«E
in proposito mi preoccupa ancor di più il dramma vissuto da privati cittadini
casualmente intercettati ed esposti a una gogna molto pesante. E la gogna
mediatica è una pena inappellabile, a prescindere da come finisce in tribunale.
Ho segnalato più volte la situazione del cittadino Massimo Bossetti. Nel suo
caso sono stati divulgati i dati genetici di tutta famiglia, i comportamenti del
figlio minore e di tutti familiari, fino al filmato dell’arresto, all’ audio
dell’interrogatorio e al colloquio con la moglie in carcere: tutto questo
contrasta la legge sul diritto alla riservatezza. Che rappresenta una garanzia
per i cittadini e che però viene travolta da una furia iconoclasta, funzionale
al processo mediatico. Nel processo propriamente inteso vige la presunzione di
innocenza, in quello mediatico si impone la presunzione di colpevolezza».
Come se ne
esce?
«Tutti,
magistrati, giornalisti, avvocati, cittadini, debbono cercare il punto di
equilibrio più alto. E smetterla di pensare che qualche diritto debba essere
cancellato. Anche perché oltre alla dignità delle persone è in gioco anche la
terzietà del giudice».
Cosa
intende?
«Chi
siede in una Corte viene ‘inondato’ da una valanga di informazioni dei media che
finiscono per costruire un senso comune. In un ordinamento in cui esistono anche
i giudici popolari c’è il rischio che questi non formino la loro convinzione in
base alla lettura degli atti ma in base al processo mediatico, che ha deciso la
condanna molto tempo prima, e non nella sede dovuta. Intercettazioni, atti e
immagini divulgati dai media, non solo costituiscono uno stigma perenne per la
persona, ma rischiano di condizionare anche l’esercizio della giurisdizione in
condizioni di terzietà».
Ma non è
che i magistrati alla fine spingono il processo mediatico perché pensano di
acquisire in quel modo maggiore consenso?
«Guardi,
quando un singolo magistrato ricerca il consenso può casomai far calare un po’
il consenso dell’intera magistratura. E questo lo hanno affermato negli ultimi
tempi autorevoli magistrati, che hanno usato parole molto eloquenti nel
criticare gli abusi di singoli colleghi. Mi riferisco in particolare al
procuratore capo di Torino Armando Spataro quando dice che durante Mani pulite,
per esempio, alcuni magistrati sembravano più preoccupati della formazione della
notizia da prima pagina che della conclusione del processo. Ecco, la
legittimazione che ha il magistrato viene messa in discussione proprio da quei
comportamenti impropri. La ricerca del consenso non è propria della funzione del
magistrato. Chi ha da decidere della giustizia ha un compito che da solo
gratifica e impegna la vita. Io ho una grandissima considerazione di questo
compito e credo vada preservato».
Nordio agita i
colleghi in toga: "Niente multe, via i pm scarsi". Il procuratore di Venezia
critica la scelta del governo sulla responsabilità civile: "Inutile, paga
l'assicurazione", scrive Anna Maria Greco su “Il Giornale”. I magistrati hanno
una gran fretta: per denunciare davanti alla Consulta l'incostituzionalità della
legge sulla responsabilità civile, varata solo a febbraio, non hanno aspettato
che un cittadino chiedesse i danni a uno di loro. Hanno giocato d'anticipo. Per
il giudice civile Massimo Vaccari del tribunale di Verona basta il timore di un
giudizio di responsabilità per condizionare l'autonomia e l'indipendenza della
toga, ledere i suoi diritti e privarla della necessaria serenità nel suo lavoro.
Così, il 12 maggio ha inviato alla Corte costituzionale 17 pagine di ricorso,
che sostengono contrasti con diversi articoli della Carta. La notizia arriva
proprio mentre il Matteo Renzi ricorda su Twitter l'anniversario della morte di
Enzo Tortora, sottolineando che da allora, e grazie a lui, le cose sono
cambiate. «Ventisette anni dopo la morte di Tortora - scrive il premier-,
abbiamo la legge sulla responsabilità civile dei giudici e una normativa diversa
sulla custodia cautelare #lavoltabuona». Nella stessa giornata e proprio
partendo dal tempestivo ricorso del giudice veronese, su Il Messaggero il
procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio firma un editoriale che certo non
farà piacere ai suoi colleghi. Basta il titolo: «Il magistrato che sbaglia va
rimosso più che multato». Mentre le toghe, con l'Anm in testa, protestano
aspramente per la legge, minacciano lo sciopero e si organizzano perché la
Consulta la faccia a pezzi, Nordio sostiene dunque che le nuove norme sono
troppo deboli e non risolvono i problemi, cioè le cause degli errori giudiziari:
dall'«irresponsabile potere dei pm» a quello dei giudici di «riprocessare e
condannare un cittadino assolto», con una «catena di sentenze». Il magistrato
accusa governo e Parlamento di aver «risposto in modo emotivo» alle richieste
dell'opinione pubblica, puntando sull'«effetto intimidatorio delle sanzioni,
privilegiando peraltro quelle pecuniarie». Così, per Nordio, hanno fatto «una
scelta inutile, perché ci penserà l'assicurazione; e irragionevole, perché la
toga inetta o ignorante non va multata, va destituita». Denunciando davanti
all'Alta corte, sostiene il pm, «la parte più ambigua della legge, quella che
consente, o pare consentire, di far causa allo Stato prima che la causa sia
definitivamente conclusa», paralizzando i processi, se ne otterrà forse una
parziale abrogazione. E «i magistrati impreparati o inetti tireranno un sospiro
di sollievo». Vedremo se andrà proprio così. Intanto, il ricorso a bocce ferme
del giudice veronese deve superare il giudizio di ammissibilità. Vaccari cita un
precedente simile contro la legge del 1989, ma non è affatto detto che riesca
nel suo intento. I magistrati, però, si sono organizzati da un pezzo per ricorsi
singoli o collettivi e, se questo verrà bloccato, di certo alla Consulta ne
arriveranno molti altri. L'ultima parola sarà anche stavolta dei giudici
costituzionali.
Il super-Pm
sbotta: «Giudici, ora basta»,
scrive l'11 maggio 2015 Piero Sansonetti su “Il Garantista”. Lo sapete tutti che
nei manuali di giornalismo c’è scritto che una notizia è notizia quando l’uomo
morde il cane, e non viceversa. Beh, stavolta è ancora più notizia: è il
magistrato che morde il magistrato. Cosa mai vista, finora. E il magistrato in
questione non è un tizio qualunque, ma è il Procuratore di Torino Armando
Spataro, anni 67, carriera lunghissima, sempre impegnato in indagini molto
delicate, prima la lotta al terrorismo di sinistra, nei primi anni ottanta, poi
l’antimafia. Spataro è un’icona di coloro che amano i Pm. Duro, rigoroso,
burbero, cattivo, non sorride mai. Uno sceriffo. E uno che parla chiaro, non si
nasconde, te le grida in faccia. A occhio non è proprio il tipo del magistrato
garantista. Ed è difficile trovare qualche sua frase di simpatia per i
garantisti. Beh, ieri Spataro è andato a parlare nella tana del nemico, e cioè a
un convegno organizzato dalla camere penali del Piemonte, e ha pronunciato una
requisitoria delle sue, ma stavolta contro i suoi colleghi. Spataro ha tuonato
contro i magistrati protagonisti, i magistrati presunti ”eroi”, i magistrati
moralisti, i magistrati maestri di storia, i magistrati faziosi, i magistrati
narcisi eccetera eccetera. Ha messo nel mirino (senza mai nominarli) Ilda
Boccassini, Vittorio Teresi, Antonio Ingroia, Antonio Di Pietro (ma anche
Borelli, D’Ambrosio e Colombo) forse anche Pignatone, sicuramente, e con
durezza, il ministro Alfano. E poi ha disintegrato l’immagine dei giornalisti
giudiziari, accusandoli di pigrizia e scarsa professionalità (ma anche un po’ di
servilismo…). Ha pronunciato un discorso simile agli articoli che su questo
giornale scrive Tiziana Maiolo…I casi sono due. O prendiamo questo sfogo di
Armando Spataro come una boutade (o come semplice espressione della lotta
interna tra le correnti della magistratura); oppure lo prendiamo sul serio ed
esaminiamo una a una le cose che lui ha detto e immaginiamo che forse si è
arrivati – nella vicenda del potere sempre più grande in mano alla magistratura
– a quel punto di rottura che provoca reazioni, discussioni, dubbi, e che forse
può portare a una inversione di tendenza. Speriamo. Naturalmente è chiaro che
alcuni degli attacchi di Spataro possono essere effettivamente letti all’interno
della lotta tra correnti della magistratura. Spataro ce l’ha sempre avuta con
”Magistratura Democratica” e oggi gli tira un po’ di frecce avvelenate. Così
come è noto che Spataro non ha mai amato la Boccassini, che addirittura una
volta fece pedinare degli indagati sui quali stava indagando, appunto, Spataro,
che la prese molto male. Ed è anche noto che Spataro non ama il ministro Alfano
e perciò – come vedrete – lo espone a impietosi paragoni con ministri
dell’Interno del passato (Virginio Rognoni, in particolare) e lo maltratta in
tutti i modi. Detto ciò, vediamo quali sono i sassolini che Spataro si toglie
dalla scarpa. Trascrivendo pari pari le frasi che ha pronunciato a Torini, senza
cambiare una virgola. «E’ una fortuna che sia finita l’era di mani pulite e
l’era di Di Pietro. Rammento i giornalisti a frotte dietro i pubblici ministeri
nei corridoi, e devo dire che alla fine qualche collega era più convinto
dell’importanza della notizia in prima pagina che non dell’esito del
processo…«Badate che non sto contestando il diritto e il dovere del magistrato
di intervenire nel dibattito civile. E’ giusto che intervenga. Senza però dare
alcun segnale di dipendenza o vicinanza politica…«Vi faccio qualche esempio di
protagonismo non virtuoso: c’è un magistrato che a Palermo, dopo aver letto una
sentenza che disattendeva le sue conclusioni, disse che se lui fosse stato un
professore avrebbe dato quattro meno al giudice che aveva fatto quella sentenza
(e qui si riferisce al dottor Vittorio Teresi, coordinatore del pool
antimafia della Procura di Palermo, il quale pronunciò quella frase infelice
commentando la sentenza del processo Mori, ndr); poi c’è chi ha detto che il
Csm avrebbe dovuto valutare, al fine di designare il nuovo procuratore capo di
Palermo, il grado di condivisione dei candidati con l’impostazione del processo
sulla trattativa Stato mafia (e qui si riferisce ancora a Teresi, ma anche a
Ingroia e più in generale a tutti i Pm che fanno capo all’ex Procuratore di
Palermo De Matteo, ndr). Mi sembra una impostazione inaccettabile». «Poi c’è
il caso di quei pubblici ministeri che a distanza di 20 anni dall’inizio dei
processi di mafia al Nord, dicono: ”Finalmente arrivo io e indago sulle
infiltrazioni di mafia al Nord”, oppure che continuamente fanno riferimenti a
entità esterne, ai poteri forti…Il vizio più pesante della magistratura è la
tendenza a porsi come moralisti, come storici, cioè pensare che tocca ai
magistrati moralizzare la società e ricostruire un pezzo di storia». «Non
sopporto più i colleghi che si propongono come gli unici eroi che lottano per il
bene, mentre tutto attorno c’è male, e loro sono una sorta di Giovanna D’Arco, e
sono alla continua denuncia dell’isolamento nel quale si trovano. Ma
l’isolamento del magistrato non ha niente di eccezionale, è una condizione
tipica del nostro lavoro. Non sopporto quelli che vanno in piazza per
raccogliere firme di solidarietà». «Se si dovesse fare una riforma della
Costituzione, vorrei che fosse inserita una norma che prevede l’indipendenza
della stampa dal potere politico. Anni fa feci un viaggio negli Stati Uniti e
chiesi al Procuratore federale di Chicago come facessero a mantenere
l’indipendenza visto che sono nominati dal presidente degli Stati Uniti. Lui mi
rispose: «Ma qui c’è la stampa», alludendo al ruolo della stampa e alla sua
assoluta indipendenza. In Italia invece abbiamo degenerazioni di ogni tipo:
magistrati che sfruttano il processo famoso per curare la propria icona,
avvocati che tendono a trasferire il processo in Tv per auto-promuoversi,
giornalisti che non cercano riscontri ma inseguono misteri, e ministri che
inseguono slogan e telecamere. «Quando arrestammo Mario Moretti, il capo delle
Br, non potrò mai scordarmi che mi telefonò l’allora ministro dell’Interno (Virginio
Rognoni ). Avevo 31 anni, mi emozionai ( in verità ne aveva 33…anche lui
bada un po’ alla sua immagine e si cala l’età…peccato veniale…, ndr). Il
ministro mi chiamò per dirmi: ”lei sa quanto è importante per noi diffondere la
notizia dell’arresto di Moretti, ma deve essere lei a dirmi che posso farlo,
perché prima vengono le indagini”. Oggi avviene esattamente il contrario:
notizie di operazioni contro il terrorismo internazionale vengono diffuse prima
ancora che si realizzino, abbiamo notizie che vengono riprese senza alcun potere
critico da parte della stampa, ad esempio quella sui terroristi che arrivano sui
barconi dei migranti in Sicilia. Veicolare questa informazione interessa alla
politica: possibile che non ci sia nessun giornalista che scriva che questa cosa
non sta né in cielo né in terra?…» Questa è la sintesi del discorso di Spataro.
Non mi è mai capitato di parlare bene di Spataro…Però questi suoi ragionamenti,
se fossero ripresi da qualche altro Pm, potrebbero essere un punto di partenza
per una discussione seria, no? Del resto sono convinto che la possibilità di
fermare l’aggressività politica della magistratura (e del patto di ferro tra
magistratura e giornalismo) , oggi esiste solo se la critica parte dall’interno
della magistratura.
Eppure,
ciononostante succede questo!
Della serie: subisci e taci…
"Assassini" ai pm di Mani Pulite: la Cassazione condanna Sgarbi a
risarcire 60mila euro. Le dichiarazioni dell'allora
deputato contro Davigo, Colombo e Greco si riferivano ai suicidi di Gabriele
Cagliari e Raul Gardini. La Cassazione: "Il diritto di critica è limitato dal
rispetto della dignità", scrive “Il Corriere della Sera". Confermata dalla
Cassazione la condanna nei confronti di Vittorio Sgarbi a risarcire con 60mila
euro tre ex pm del pool 'Mani pulite' di Milano, Piercamillo Davigo, Gherardo
Colombo e Francesco Greco, per averli definiti - in dichiarazioni riprese nel
luglio 1994 dai quotidiani Avvenire e Il Giornale, a un anno dai
suicidi di Gabriele Cagliari e Raul Gardini - come degli "assassini" che
"avevano fatto morire delle persone" e per questo dovevano "essere processati e
condannati" in quanto costituivano "una associazione a delinquere con libertà di
uccidere". Secondo la Terza sezione civile della Suprema Corte - sentenza
10276/2015 - "il diritto di critica è limitato dal rispetto della dignità
altrui, e la dignità altrui è violata quando la critica trascende il limite
della continenza verbale". E per quanto riguarda le espressioni usate da Sgarbi,
che all'epoca deputato, "nemmeno la più benevola concezione del limite della
continenza verbale - ritengono gli ermellini - potrebbe mai giungere ad
ammettere che tali espressioni non violino quel limite". La Cassazione, inoltre,
sottolinea che la condanna di Sgarbi a risarcire i pm con 60mila euro non può
considerarsi "esorbitante" se si considera il "lavoro svolto" dai tre magistrati
offesi, la "gravità degli addebiti loro mossi" e "l'impatto sociale di
affermazioni così drastiche". Senza successo Sgarbi ha protestato perché gli
editori delle due testate e i giornalisti che avevano riportato le sue
esternazioni non erano stati condannati in solido con lui a risarcire i danni ai
pm diffamati. Secondo Sgarbi, era compito dei giornalisti "verificare la
violazione del limite della continenza verbale". In proposito i supremi giudici
- con la sentenza - gli rispondono che questa richiesta lui l'ha avanzata ben
nove anni dopo l'apertura del procedimento a suo carico mentre avrebbe dovuto
proporla nella prima memoria di costituzione in giudizio. Quanto al fatto che
gli ex del pool hanno promosso azioni risarcitorie per le stesse dichiarazioni
di Sgarbi pubblicate, però, da altre testate, la Cassazione ha fatto presente
all'ex parlamentare che "una medesima dichiarazione diffamatoria diffusa da più
organi di stampa genera più danni. La lesione dell'onore consiste infatti nel
detrimento della reputazione che l'offeso vanta presso il pubblico dei lettori;
sicchè - conclude il verdetto - dovendo presumersi che ogni quotidiano abbia
lettori in gran parte diversi, a ogni pubblicazione corrisponderà un danno
differente". E' stata così interamente confermata la sentenza emessa dalla Corte
di appello di Milano il 14 aprile del 2011.
Criticare Mani pulite è reato. Sberla dei giudici a Sgarbi.
Il critico definì assassini i pm di Tangentopoli. Ora deve risarcire i
magistrati con 60mila euro, scrive Marcello Di Napoli su “La Notizia Giornale”.
Non c’è da meravigliarsi se la giustizia italiana ha perso ogni credibilità in
tutto il mondo. Un rispetto perduto a causa del protagonismo di alcuni pubblici
ministeri e dei tempi lunghissimi dei processi. Il tutto mentre centinaia di
giudici scrivono libri, vanno a ogni genere di conferenze e non si perdono un
vernissage. Insomma, purtroppo il discredito la magistratura se l’è cercato da
sé. A causa anche delle inchieste spettacolo. L’ultima è stata riservata a
Vittorio Sgarbi. Ieri (20 maggio 2015) il critico d’arte è stato condannato a
pagare un risarcimento di 60mila euro ai tre ex pm del pool di Milano:
Piercamillo Davigo, Gherardo Colombo e Francesco Greco. Si sa, il noto
opinionista è sempre stato contrario ai metodi usati dai magistrati milanesi
nella stagione di mani pulite. In particolare, ha sempre contrastato quello che
lui ritiene un abuso della carcerazione preventiva. Ma nel 1994, all’epoca dei
fatti, secono la Cassazione ha usato “espressioni lesive della dignità dei
magistrati”. L’allora deputato dell’appena nata Forza Italia definì “assassini”
i pm. Lo scrisse su due testate nazionali (“Il Giornale” e “Avvenire”) e lo
ribadì durante la trasmissione Sgarbi Quotidiani. Accuse che erano state
espresse in merito ai suicidi di Raul Gardini e di Gabriele Cagliari (che si
tolse la vita nelle docce del carcere di San Vittore). Dunque la Terza sezione
civile della Suprema Corte ha confermato la sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Milano, affermando che: “il diritto di critica è limitato dal
rispetto della dignità altrui, e la dignità altrui è violata quando la critica
trascende il limite della continenza verbale”. La Cassazione ha evidenziato che
la pena pecuniaria inflitta all’ex di Forza Italia non può essere considerata
esorbitante se si tengono in conto il “lavoro svolto” dai tre pm, “la gravità
degli addebiti loro mossi” e “l’impatto sociale di affermazioni così drastiche”.
Inoltre, la Corte ha fatto presente che “una medesima dichiarazione diffamatoria
diffusa da più organi di stampa genera più danni”. Sgarbi, a suo tempo, ha
protestato perché gli editori dei giornali che hanno riportato le sue
dichiarazioni non sono stati condannati in solido con lui a risarcire i danni ai
pm. Per il critico d’arte, inoltre, era compito delle testate quello di
“verificare la violazione del limite della continenza verbale”. Ma i giudici gli
hanno dato torto, perché questa richiesta è stata inoltrata solo nove anni dopo
l’apertura del procedimento, e non nella prima memoria di costituzione in
giudizio. Insomma, mentre mentre procedimenti vitali per tanta gente comune si
rimandano alla calende greche, i giudici scelgono di occuparsi, anche per molti
anni, di vicende paradossali come quella di Sgarbi (i morti ci furono per
davvero) o come il bunga bunga di Berlusconi. E poi non meravigliamoci se la
giustizia italiana ha perso ogni credibilità in tutto il mondo.
Appunto!!!
Fanciullacci, vigliacco assassino». Per la Cassazione non è
diffamazione. La Suprema Corte ha assolto, «perchè il
fatto non costituisce reato» Achille Totaro, dall’accusa di aver diffamato il
partigiano Bruno Fanciullacci, scrive “Il Corriere Fiorentino”. La quinta
sezione della corte di Cassazione ha assolto, «perchè il fatto non costituisce
reato» il senatore toscano del Pdl, Achille Totaro, dall’accusa di aver
diffamato il partigiano Bruno Fanciullacci, eroe della Resistenza, definendolo
«vigliacco assassino» riguardo all’omicidio del filosofo Giovanni Gentile
avvenuto nel 1944 a Firenze. Totaro aveva fatto ricorso in Cassazione dopo che
la corte d’appello di Firenze lo aveva condannato al risarcimento simbolico di
un euro verso gli eredi di Fanciullacci, avendo stabilito che il reato era
prescritto. «Stavolta invece la suprema Corte con questa sentenza - ha
commentato l’avvocato di Totaro, Paolo Florio - ha riconosciuto che Totaro aveva
esercitato, con le sue valutazioni, il diritto di critica politica nel giudicare
la condotta di Fanciullacci limitatamente a quella determinata circostanza
dell’assassinio di Gentile, e che quindi non espresse una valutazione generale
sull’uomo Fanciullacci». «Totaro - ha osservato ancora il legale - parlò di
Fanciullacci in una seduta del consiglio comunale di Firenze, e lo fece da
politico che si rivolgeva ad un consesso politico». I fatti risalgono al 2000.
Il 10 gennaio si tenne il consiglio comunale dove fu discussa una mozione su
Fanciullacci durante la quale Totaro, consigliere comunale di An, lo definì
«vigliacco assassino»; due giorni dopo lo stesso giudizio fu riportato in
un’intervista concessa a un quotidiano. La famiglia di Fanciullacci, in
particolare la sorella, denunciò per diffamazione non solo Totaro ma anche i
consiglieri comunali che firmarono un comunicato stampa di sostegno all’attuale
senatore del Pdl. Nel tempo, quattro di quei consiglieri sono stati assolti.
Invece, dopo esser stati assolti con formula piena in primo grado sia Totaro sia
un altro consigliere comunale di An, poi del Pdl, Stefano Alessandri, nel maggio
2009 la corte di appello cambiò l’orientamento della vicenda ravvisando per
entrambi il reato di diffamazione anche se prescritto e stabilendo il
risarcimento simbolico. Ora la Cassazione ha assolto alla stessa maniera di
Totaro anche Alessandri, che nello stesso procedimento era co-imputato con il
senatore.
Aldro, non è diffamazione dire assassino all’agente.
La motivazione del gip Tassoni che ha archiviato la denuncia di Paolo Forlani,
scrive “La Nuova Ferrara”. Un altro atto giudiziario va ad arricchire l’ormai
copioso archivio del caso Aldrovandi: è il decreto di archiviazione del gip
Piera Tassoni che ha annullato le accuse di diffamazione mosse da Paolo Forlani,
uno degli agenti condannati per la morte di Federico Aldrovandi, alla madre
Patrizia Moretti per aver detto nel blog che scrive ormai da 7 anni di aver
visto appunto il poliziotto in un bar cittadino, ossia «uno degli assassini di
Federico». Indicare Forlani come assassino, secondo il gip Tassoni che ha
accolto le tesi della pm Volta, non è diffamatorio: perchè con il termine
assassino Patrizia Moretti - scrive il gip - «aveva inteso indicare in Forlani
colui che era stato ritenuto responsabile in primo grado dell’omicidio di suo
figlio, non essendovi elementi per poter sostenere che si volle muovere
un’accusa di omicidio volontario». La decisione del giudice Tassoni è arrivata a
conclusione dell’ennesimo processo che Patrizia Moretti deve subire, come
strascico di sue dichiarazioni, o affermazioni in questi anni. Uno tra i tanti
lo ricordiamo, è il processo per diffamazione attivato dal pm Mariaemanuela
Guerra, processo aggiornato al 2 ottobre prossimo davanti al tribunale di
Mantova dove la Moretti comparirà con giornalisti de la Nuova Ferrara. Una
contesta giudiziaria tra il nostro giornale e il pm Mariaemanuela Guerra che si
è spostata ieri mattina ad Ancona: davanti al tribunale marchigiano è partito
infatti il processo civile in cui la pm Guerra chiede all’editore del nostro
giornale e a 7 tra giornalisti e direttori, un indennizzo per danni, di non meno
di 1 milione e mezzo di euro, per una campagna stampa (presunta) diffamatoria e
denigratoria nei suoi confronti.
ANTONIO
GIANGRANDE, GABRIELLA NUZZI, SILVIO BERLUSCONI: LE RITORSIONI DEI MAGISTRATI.
IO,
MAGISTRATO OLTRAGGIATA.
Gabriella Nuzzi: Come si uccide un’inchiesta. Da Il
Fatto Quotidiano del 6 Agosto 2010.
"Ho scelto di percorrere in questi mesi la strada della
riflessione e del silenzio. Non certo per timore, né per rassegnazione. L’esame
introspettivo degli eventi consente di trovare soluzioni, le migliori possibili,
per sé e per gli altri. Di fronte all’ingiustizia, e più di tutto se gli è
inflitta, un magistrato, che sia davvero tale, non cerca vie di fuga, né comodi
ripari. Perciò, ho continuato a credere nella magistratura e nel suo operato. La
Grande Bugia della guerra tra le procure di Salerno e Catanzaro, creata ad arte
per sottrarre a me e ai colleghi salernitani le inchieste sugli uffici
giudiziari calabresi e privarci delle funzioni inquirenti, non può non trovare
risposte giuridiche e giudiziarie. Macigni e ostacoli sulla verità. Quando il 2
dicembre 2008 furono eseguiti il sequestro probatorio del fascicolo “Why Not” e
le perquisizioni ai magistrati che l’avevano gestito a colpi di stralci e
archiviazioni, si accusarono i Pubblici ministeri salernitani di aver redatto
provvedimenti “abnormi” ed eversivi, manifestando in tal modo “un’eccezionale
mancanza di equilibrio, un’assoluta spregiudicatezza nell’esercizio delle
funzioni ed un’assenza del senso delle istituzioni e del rispetto dell’Ordine
giudiziario”. Con queste motivazioni, l’8 gennaio 2009, su proposta del capo
dell’Ispettorato Arcibaldo Miller (coinvolto nello scandalo P3), il ministro
della Giustizia Alfano richiese, in via d’urgenza, alla Sezione Disciplinare del
Csm, presieduta da Nicola Mancino, l’applicazione di “misure cautelari”
disciplinari nei miei confronti, del collega Verasani e del procuratore
Apicella. Intervento preannunciato in Parlamento dal sottosegretario alla
Giustizia Giacomo Caliendo (coinvolto nello scandalo P3) ai suoi amici di
partito On.li Amedeo Laboccetta & C., che, in difesa dei calabresi, chiedevano
la testa del dott. De Magistris e di noi altri suoi “sodali”. L’intero mondo
politico-giudiziario, spalleggiato dalla grande “libera” stampa, che scatenò una
tempesta mediatica, condannò la nostra scelta investigativa come un atto di
“terrorismo giudiziario”, un attacco “senza precedenti” alle istituzioni
democratiche, ispirato al perseguimento di fini personalistici e politici, di
pericolosità tale da esigere una repressione esemplare e immediata. La Prima
Commissione del Csm presieduta da Ugo Bergamo avviò il trasferimento d’ufficio
per incompatibilità ambientale, poi sospeso in attesa degli esiti disciplinari.
L’Associazione Nazionale Magistrati accettò di buon grado l’epurazione,
nell’illusione di una futura pace dei sensi. Dopo appena dieci giorni, con un
processo da Santa Inquisizione, ci strapparono le funzioni inquirenti,
allontanandoci dalla nostra Regione. Una cortina di silenzio e indifferenza
s’innalzò intorno al “caso Salerno”. I magistrati calabresi inquisiti, autori
del contro-sequestro del “Why Not”, instaurarono un procedimento penale a nostro
carico e del dott. De Magistris, trasmettendolo poi alla Procura di Roma che,
con l’Aggiunto Achille Toro (indagato sullo scandalo G8 Sardegna), si mise a
investigare liberamente sulle nostre vite private, senza alcun fondamento. Le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione presiedute dal dott. Vincenzo Carbone
(coinvolto nello scandalo P3) chiusero in gran fretta il capitolo disciplinare
con una pronuncia sommaria, storico esempio di come sia possibile, in tema di
etica giudiziaria, affermare tutto e il contrario di tutto. Si aprirono a nostro
carico ulteriori procedimenti penali e disciplinari, branditi come clave,
affinché ci sentissimo sotto perenne minaccia. Il 19 ottobre 2009, la stessa
Sezione Disciplinare, su relazione dell’avv. Michele Saponara, accolse l’azione
disciplinare promossa dal Procuratore generale della Cassazione Esposito,
infliggendo a me e al collega Verasani la sanzione della perdita di anzianità
(rispettivamente, sei e quattro mesi) e del trasferimento d’ufficio di sede e
funzione. Non è stato facile resistere a tanta violenza morale. Una violenza
frutto di arbitrio, che ha indecentemente calpestato ogni regola, senza
arretrare neppure di fronte al riconoscimento giurisdizionale della legalità e
necessità dei nostri comportamenti. La delegittimazione, l’isolamento,
l’eliminazione sono metodi di distruzione mafio-massonici. E noi abbiamo pagato
per aver osato far luce sulla massoneria politico-giudiziaria. Da allora,
pazientemente, ho atteso che a parlare fossero i fatti. E i fatti, nel tempo,
come tasselli di un incomprensibile puzzle, si stanno lentamente ricomponendo.
Logge, cappucci e grandi vecchi. Alcuni di coloro che hanno concorso alla nostra
epurazione pare avessero incontri con presunti appartenenti ad un’associazione
segreta. Dunque, di fronte a innegabili evidenze, parlare oggi di consorterie
massoniche interne anche agli apparati giudiziari non è più atto eversivo o
scandaloso. Ampi dibattiti si sono aperti sulla “questione morale” delle nostre
istituzioni. L’Associazione Nazionale Magistrati, rimembrando proprio la nostra
vicenda, ha stigmatizzato la “caduta nel vuoto” delle sue richieste di rigore,
gridate a gran voce. Sicché contro l’ennesima ipocrisia del “sistema” s’infrange
oggi il mio silenzio. Mi rivolgo agli illustri attivisti del correntismo
giudiziario, quelli che mai sono stati sfiorati da un dubbio o da un
ripensamento, trovando superfluo finanche articolare il pensiero. Esprimano,
nella loro purezza, e possibilmente con cognizione di causa, una posizione
precisa su ciò che di illecito è stato compiuto ai nostri danni, sull’“etica”
che l’avrebbe ispirato, sulle scandalose ingiustizie di un “sistema” che, ancora
oggi, incredibilmente, avalla l’impunità, lasciando che i potenti, corrotti o
collusi, continuino a rimanere ai loro posti o peggio, siano premiati. Non sono
i loro rappresentanti più degni a spartirsi gli scranni del nostro
“autogoverno”, a decidere nomine, promozioni, trasferimenti, punizioni
disciplinari? O forse l’associazionismo sta dissociandosi da se stesso? Non vi
sono oggi “questioni morali” che non lo fossero anche ieri. E allora occorre
ripartire da zero, passando attraverso un profondo mea culpa. Questa pericolosa
caduta libera di credibilità può arrestarsi soltanto con il ripristino del
primato del Diritto e il ripudio definitivo delle logiche di appartenenza e
protezionismo. Solo proponendosi tali obiettivi e scegliendo figure di guida
autorevoli, per integrità, indipendenza e competenza, l’Ordine giudiziario può
sperare in un autentico rinnovamento morale, nell’interesse supremo del popolo e
della democrazia."
Nubi minacciose si addensano sul futuro delle «toghe» coinvolte nell’inchiesta
romana sulla P3. Dopo il presidente della Corte d’Appello di Milano, Alfonso
Marra, tocca a un altro magistrato subire l’onta del procedimento disciplinare,
scrive Fulvio Milone su "La
Stampa".
L’inchiesta della procura romana ha provocato un terremoto nella magistratura.
Oltre alla Cassazione, si è mosso il Csm, che dopo avere avviato una procedura
di trasferimento per il giudice Marra, ha adottato un provvedimento analogo per
incompatibilità ambientale nei confronti di Umberto Marconi.
La Prima Commissione del Csm ha avviato una procedura di trasferimento d’ufficio
per incompatibilità ambientale a carico di Umberto Marconi, scrive "Il
Corriere della Sera", il
presidente della Corte di Appello di Salerno il cui nome compare nella mole
delle intercettazioni dell’inchiesta sulla cosiddetta P3. Anche il suo nome
compare nelle carte del procedimento. A lui i carabinieri attribuiscono un ruolo
determinante nella fabbricazione del dossier falso che avrebbe dovuto fare
affondare la candidatura a Governatore della Campania di Stefano Caldoro: una
faida all’interno del Pdl, organizzata da Carboni e soci che si muovevano per
favorire Nicola Cosentino. Marconi, però, ha anticipato le mosse del Csm: ha già
chiesto il trasferimento, anche se giura di essere «assolutamente estraneo» alla
vicenda. «Ho anche chiesto alla procura di Roma di essere sentito per quello che
ritengo essere un complotto ordito contro di me», ha detto.
Signor
Presidente, le comunico l'irrevocabile decisione di lasciare l'Associazione
Nazionale Magistrati. Il plauso da lei pubblicamente reso all'ingiustizia
subita, per mano politica, da noi magistrati della Procura della Repubblica di
Salerno è per me insopportabilmente oltraggioso. Oltraggioso per la mia dignità
di Persona e di essere Magistrato. Sono stata, nel generale vile silenzio,
pubblicamente ingiuriata; incolpata di ignoranza, negligenza, spregiudicatezza,
assenza del senso delle istituzioni; infine, allontanata dalla mia sede e
privata delle funzioni inquirenti, così, in un battito di ciglia, sulla base del
nulla giuridico e di un processo sommario. Per bocca sua e dei suoi amici e
colleghi, la posizione dell'Associazione era già nota, sin dall'inizio. Quale la
colpa? Avere, contrariamente alla profusa apparenza, doverosamente adottato ed
eseguito atti giudiziari legittimi e necessari, tali ritenuti nelle sedi
giurisdizionali competenti. Avere risposto ad istanze di verità e di giustizia.
Avere accertato una sconcertante realtà che, però, doveva rimanere occultata. Né
lei, né alcuno dei componenti dell'associazione che oggi degnamente rappresenta
ha sentito l'esigenza di capire e spiegare ciò che è davvero accaduto, la
gravità e drammaticità di una vicenda che chiama a riflessioni profonde l'intera
Magistratura, sul suo passato, su ciò che è, sul suo futuro; e non certo
nell'interesse personale del singolo o del suo sponsor associativo, ma in forza
di una superiore ragione ideale, che è - o dovrebbe essere - costantemente e
perennemente viva nella coscienza di ogni Magistrato: la ricerca della verità.
Più facile far finta di credere alla menzogna: il conflitto, la guerra tra
Procure, la isolata follia di "schegge impazzite". Il disordine desta scandalo:
immediatamente va sedato e severamente punito. Il popolo saprà che è giusto
così. E il sacrificio di pochi varrà la Ragion di Stato. L'Associazione non
intende entrare nel merito. Chiuso. Nel dolore di questi giorni, Signor
Presidente, il mio pensiero corre alle solenni parole che da Lei (secondo quanto
riportato dalla stampa) sarebbero state pubblicamente pronunciate pochi attimi
dopo l'esemplare "condanna": «Il sistema dimostra di avere gli anticorpi».
Dunque, il sistema, ancora una volta, ha dimostrato di saper funzionare. Mi
chiedo, allora, inquieta, a quale "sistema" Lei faccia riferimento. Quale il
"sistema" di cui si sente così orgogliosamente rappresentante e garante. Un
"sistema" che non è in grado di assicurare l'osservanza minima delle regole del
vivere civile, l'applicazione e l'esecuzione delle pene? Un "sistema" in cui
vana è resa anche l'affermazione giurisdizionale dei fondamentali diritti
dell'essere umano; ove le istanze dei più deboli sono oppresse e calpestato il
dolore di chi ancora piange le vittime di sangue? Un "sistema" in cui l'impegno
e il sacrificio silente dei singoli è schiacciato dal peso di una macchina
infernale, dagli ingranaggi vetusti ed ormai irrimediabilmente inceppati? Un
"sistema" asservito agli interessi del potere, nel quale è più conveniente
rinchiudere la verità in polverosi cassetti e continuare a costellare la
carriera di brillanti successi? Mi dica, Signor Presidente, quali sarebbero gli
anticorpi che esso è in grado di generare? Punizioni esemplari a chi è ligio e
coraggioso e impunità a chi palesemente delinque? E quali i virus? E mi spieghi,
ancora, quale sarebbe «il modello di magistrato adeguato al ruolo costituzionale
e alla rilevanza degli interessi coinvolti dall'esercizio della giurisdizione»
che l'Associazione intenderebbe promuovere? Ora, il "sistema" che io vedo non è
affatto in grado di saper funzionare. Al contrario, esso è malato, moribondo,
affetto da un cancro incurabile, che lo condurrà inesorabilmente alla morte. E
io non voglio farne parte, perché sono viva e voglio costruire qualcosa di buono
per i nostri figli. Ho giurato fedeltà al solo Ordine Giudiziario e allo Stato
della Repubblica Italiana. La repentina violenza con la quale, in risposta ad un
gradimento politico, si è sommariamente decisa la privazione delle funzioni
inquirenti e l'allontanamento da inchieste in pieno svolgimento nei confronti di
Magistrati che hanno solo adempiuto ai propri doveri, rende, francamente, assai
sconcertanti i vostri stanchi e vuoti proclami, ormai recitati solo a voi
stessi, come in uno specchio spaccato. Mentre siete distratti dalla visione di
qualche accattivante miraggio, faccio un fischio e vi dico che qui sono in gioco
i principi dell'autonomia e dell'indipendenza della Giurisdizione. Non gli
orticelli privati. Non vale mai la pena calpestare e lasciar calpestare la
dignità degli esseri umani. Per quanto mi riguarda, so che saprò adempiere con
la stessa forza, onestà e professionalità anche funzioni diverse da quelle che
mi sono state ingiustamente strappate, nel rispetto assoluto, come sempre, dei
principi costituzionali, primo tra tutti quello per cui la Legge deve essere
eguale per deboli e potenti. So di avere accanto le coscienze forti e pure di
chi ancora oggi, nonostante tutto, crede e combatte quotidianamente per
l'affermazione della legalità. Ed è per essa che continuerò sempre ad amare ed
onorare profondamente questo lavoro. Signor Presidente, continui a rappresentare
se stesso e questa Associazione. Io preferisco rappresentarmi da sola.
Gabriella Nuzzi, Sostituto Procuratore Salerno (tratta dall'edizione
salernitana de "Il Mattino).
Chi
spiegherà al pm Carbone di sinistra (espressione di Area: Magistratura
Democratica e Movimento per la Giustizia) che le leggi si applicano e si
rispettano, e non si contestano?
Scrive “Il Corriere del Giorno” il 6 luglio 2015.
“No comment e musi lunghi tra i magistrati tarantini all’indomani dell’ennesimo
decreto del governo salva Ilva, l’ottavo, che dissequestra l’altoforno 2
dell’Ilva di Taranto, azzerando il provvedimento cautelare era stato deciso
dalla procura dopo l’incidente dell’8 giugno scorso in cui ha perso la vita
l’operaio trentacinquenne, Alessandro Morricella, investito da una colata di
ghisa fusa. Per il magistrato inquirente prima, e per il gip dopo, l’impianto
non era sicuro pertanto doveva essere fermato per evitare altri incidenti
mortali. Questa presunta pericolosità è ora scomparsa per decreto” secondo
quanto racconta il Corriere del Mezzogiorno, cioè l’edizione barese del Corriere
della Sera – “Ad esprimere il malessere che serpeggia tra i magistrati
tarantini, ma non solo, è il segretario dell’Associazione nazionale
magistrati, Maurizio Carbone, egli stesso pubblico ministero presso la Procura
della Repubblica di Taranto.”. Il segretario dell’Associazione nazionale dei
magistrati, dimenticando che le Leggi si rispettano ed applicano, contesta
quanto deciso dal Governo ed avvallato dal Presidente della Repubblica
sostenendo che “Il caso ILVA – dice – è la dimostrazione di come il
legislatore tuteli l’interesse economico rispetto ad altri interessi come quelli
sulla sicurezza dei lavoratori e della tutela ambientale». Il segretario
dell’Anm– sempre secondo il Corriere del Mezzogiorno – mette in luce una
pericolosa spaccatura tra i due poteri dello Stato. “Tutto questo –
continua Carbone – crea una ulteriore contrapposizione tra potere giudiziario e
potere legislativo sulla base di una evidente e più volte dimostrata priorità di
quest’ultimo verso la tutela economiche rispetto ad altri diritti…. Ognuno –ha
concluso Carbone – valuta le situazioni a modo suo. Certo è che scelte come
questa sull’ ILVA, da parte della politica, non possono che lasciare perplessi e
destare preoccupazione e non soltanto tra gli operatori della giustizia». Il
dottor Carbone non spende nessuna parola però sulla circostanza che non risulta
che la Procura e tantomeno il gip abbiano richiesto a dei periti (da nominare)
una perizia tecnica sull’incidente mortale, nè tantomeno il magistrato si
sofferma sulla circostanza che i soliti giornalisti “ventriloqui” di Palazzo
Giustizia , abbiano censurato quanto circola in ambienti industriali interni
(fornitori e dipendenti) allo stabilimento siderurgico dell’ ILVA, e cioè che il
tragico incidente occorso all’operaio Alessandro Morricella sia stato provocato
e determinato in realtà da comportamenti operativi di alcuni operai, molto
lontani dalle note vigenti disposizioni aziendali in materia di sicurezza.
Comportamenti analoghi a quelli che proprio nei giorni scorsi hanno portato
alla condanna di alcuni operai dell’ILVA, responsabili di “scherzi” poco
piacevoli ad un loro collega. Secondo nostre fonti confidenziali infatti,
sembrerebbe che l’operaio deceduto non indossasse l’abbigliamento tecnico di
sicurezza necessario sul posto di lavoro, di cui infatti nei primi rilievi di
polizia giudiziaria dicono non ci sia alcuna traccia. Ma tutto questo nessuno lo
dice e racconta. Come nessuno in Procura si meraviglia che il marito di un
magistrato ricopra incarichi di gestione e rappresentanza societaria in aziende
municipali e pubbliche. O di altro “professionista” tarantino legato ad un altro
magistrato che vive, lavora e guadagna fior di quattrini (letteralmente) grazie
alle CTU cioè le “perizie” affidategli dal Tribunale di Taranto, come questo
quotidiano in un recente articolo ha già raccontato e denunciato. Di questi
conflitti d’interesse, l'Associazione Nazionale dei Magistrati ed il suo
segretario none parlano. Strano vero? Poi qualcuno si meraviglia che in un
recente passato a Taranto siano stati arrestati un magistrato ed un giudice!
Tutto ciò probabilmente spiega anche le ragioni per cui il dr.Cataldo Motta,
Procuratore della Repubblica di Lecce, che regge anche il vertice della Direzione
Distrettuale Antimafia che sovrintende per competenza sul territorio di
Taranto, ha ottenuto dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura con
parere favorevole del Ministro di Giustizia, la deroga a reggere il suo
incarico sino al 2017. Mentre invece per il dr. Franco Sebastio, procuratore
capo della repubblica di Taranto, la deroga non è arrivata. P.S. nel
frattempo attendiamo ancora risposta ad una richiesta “pubblica” al
dr. Sebastio di intervista da video filmare (invito che estendiamo anche al
dr. Carbone). O forse le nostre domande scomode danno un pò di fastidio…?
Perchè
leggere Antonio Giangrande?
Ultimo atto.
Esame di Avvocato 2015. A Lecce uno su quattro ce l’ha fatta. Sono partiti in
1.108: la prova scritta è stata passata da 275 praticanti. Preso atto.....
All'attenzione
dell'avv. Francesco De Jaco. Illustre avv. Francesco De Jaco, in qualità di
Presidente della Commissione di Esame di Avvocato 2014-2015, chi le scrive è il
dr Antonio Giangrande. E’ quel signore, attempato per i suoi 52 anni e ormai
fuori luogo in mezzo ai giovani candidati, che in sede di esame le chiese,
inopinatamente ed invano, Tutela. Tutela, non raccomandazione. Così come nel
2002 fu fatto inutilmente con l’avv. Luigi Rella, presidente di commissione e
degli avvocati di Lecce. Tutela perché quel signore il suo futuro lo ha sprecato
nel suo passato. Ostinatamente nel voler diventare avvocato ha perso le migliori
occasioni che la vita possa dare. Aspettava come tutti che una abilitazione,
alla mediocrità come è l’esame forense truccato, potesse, prima o poi, premiare
anche lui. Pecori e porci sì, lui no! Quel signore ha aspettato ben 17 anni per,
finalmente, dire basta. Gridare allo scandalo per un esame di Stato irregolare
non si può. Gridare al complotto contro la persona…e chi gli crede. Eppure a
Lecce c’è qualcuno che dice: “quello lì, l’avvocato non lo deve fare”. Qualcuno
che da 17 anni, infastidito dal mio legittimo operato anche contro i magistrati,
ha i tentacoli tanto lunghi da arrivare ovunque per potermi nuocere. Chi afferma
ciò è colui il quale dimostra con i fatti nei suoi libri, ciò che, agli
ignoranti o a chi è in mala fede, pare frutto di mitomania o pazzia. Guardi, la
sua presidenza, in sede di scritto, è stata la migliore tra le 17 da me
conosciute. Purtroppo, però, in quel di Brescia quel che si temeva si è
confermato. Brescia, dove, addirittura, l’ex Ministro Mariastella Gelmini chiese
scampo, rifugiandosi a Reggio Calabria per poter diventare avvocato. Il mio
risultato delle prove fa sì che chiuda la fase della mia vita di aspirazione
forense in bruttezza. 18, 18, 20. Mai risultato fu più nefasto e, credo,
immeritato e punitivo. Sicuro, però, che tale giudizio non è solo farina del
sacco della Commissione di esame di Brescia. Lo zampino di qualche leccese c’è!
Avvocato… o magistrato… o entrambi…: chissà? Non la tedio oltre. Ho tentato di
trovare Tutela, non l’ho trovata. Forse chiedevo troppo. Marcire in carcere da
innocente o pagare fio in termini professionali, credo che convenga la seconda
ipotesi. Questo è quel che pago nel mettermi contro i poteri forti
istituzionali, che io chiamo mafiosi. Avvocato, grazie per il tempo che mi ha
dedicato. Le tolgo il disturbo e, nel caso l’importasse, non si meravigli, se,
in occasione di incontri pubblici, se e quando ci saranno, la priverò del mio
saluto. Con ossequi.
Avetrana lì 26
giugno 2015. Dr Antonio Giangrande, scrittore per necessità.
LE RITORSIONI DEI MAGISTRATI.
Con procedimento n. 1833/13 il PM di Potenza d.ssa Daniela Pannone, chiedeva ed
otteneva il rinvio a giudizio da parte della d.ssa Rosa Larocca per il processo
tenuto dal dr Lucio Setola, ex PM.
Imputato: Antonio Giangrande, nato ad Avetrana (Ta) il 02.06.1963 ed ivi
elettivamente domiciliato, ex art. 161 c.p.p., alla via Manzoni, 41.
Persona Offesa: Rita Romano, nata a Roma il 30.05.1967, magistrato in servizio
presso il Tribunale di Taranto.
A) Reato previsto e punito dall’art. 595 comma 3 codice penale (diffamazione)
perché, nella qualità di imputato nel procedimento n° 8486/08 RGNR e n° 5089/05
r.g.n.r, nell’atto di avocazione delle indagini indirizzato al Procuratore
Generale di Taranto – depositata in data 27/01/2011 presso la Sezione Distaccata
di Manduria del Tribunale di Taranto – offendeva la reputazione della dott.ssa
Rita Romano, magistrato in servizio presso il Tribunale di Taranto, scrivendo
che il predetto magistrato “abusando dell’ufficio adottava atti con intento
persecutorio, lesivi degli interessi, dell’immagine e della sua persona,
motivati da pregiudizio ed inimicizia e non sostenute da prove” e che “nei
procedimenti che riguardavano direttamente o indirettamente il Giangrande
Antonio, quando questi esercitava la professione forense, essa ha condannato
quando le prove erano evidenti riguardo l’innocenza; ha assolto quando le prove
erano evidenti sulla colpevolezza”. In Manduria (TA) il 27/01/2011 – competenza
dell’A.G. di Potenza ex art. 11 c.p.p.
B) Reato previsto e punito dall’art. 368 Codice penale (calunnia) perché, nella
qualità di imputato nel procedimento n° 8486/08 RGNR e n° 5089 RGNR, nell’atto
di avocazione delle indagini indirizzato al Procuratore Generale di Taranto -
depositato in data 27/01/2011 presso la Sezione Distaccata di Manduria del
Tribunale di Taranto – autorità che ha l’obbligo di riferirne, pur sapendola
innocente, accusava la dott.ssa Rita Romano, magistrato in servizio presso il
Tribunale di Taranto, del reato di abuso d’ufficio, di falso in atto pubblico.
In particolare, accusava il predetto magistrato utilizzando le seguenti frasi:
“abusando dell’ufficio adottava atti con intento persecutorio, lesivi degli
interessi, dell’immagine e della sua persona, motivati da pregiudizio ed
inimicizia e non sostenute da prove” e “nei procedimenti che riguardavano
direttamente o indirettamente il Giangrande Antonio, quando questi esercitava la
professione forense, essa ha adottato quando le prove erano evidenti riguardo
l’innocenza; ha assolto quando le prove erano evidenti sulla colpevolezza”. In
Manduria (TA) il 27/01/2011 – competenza dell’A.G. di Potenza ex art. 11 c.p.p.
Il
procedimento penale su denuncia di Rita Romano. Denuncia per calunnia e
diffamazione, questa è l’accusa che mi si oppone. Calunnia per aver presentato
in data 27/01/2011 al Presidente del Tribunale di Taranto in allegato ed a
sostegno dell’atto di ricusazione, in procedimenti penali per il quale il
magistrato denunciato era decidente sulle mie sorti, una richiesta motivata e
circostanziata di avocazione delle indagini inviata al Procuratore Generale
presso la Corte d’Appello di Taranto, ma anche di Potenza. Avocazione delle
indagini presentata il 18 aprile 2008 a Taranto e Potenza. Magistrato già
precedentemente denunciato alle procure di Taranto e Potenza ben prima del 18
aprile 2008, sapendolo colpevole con prove a sostegno. Denunce presentate in
data 22/03/2006 e rimaste lettera morta.
Diffamazione
per aver presentato in data 27/01/2011 tale richiesta di avocazione delle
indagini al Presidente del Tribunale di Taranto in allegato ed a sostegno
dell’atto di ricusazione in procedimenti penali per il quale il magistrato
denunciato era decidente sulle mie sorti. Diffamazione perché denunciavo la
grave inimicizia causa di persecuzione. Diffamazione tardiva perché richiesta
simile di ricusazione era stata presentata già il 29/09/2010. Le ricusazioni
(erano tre per tre distinti procedimenti), poi, non sono state rese operative,
in quanto il magistrato ricusato ha presentato la denuncia contro di me per
giustificare la sua astensione. Cosa che rimarca ogni volta in tutti i
procedimenti nei quali, investita come magistrato titolare, sia costretta a
rinunciare: «Mi astengo dal procedimento a carico dell’imputato in quanto ho
presentato denuncia penale contro lo stesso per calunnia e diffamazione.»
Intanto per quei processi, sempre per diffamazione a mezzo stampa, con condanna
scontata se fossi rimasto inerte, sono stato successivamente prosciolto dagli
altri giudici subentranti.
La grave
inimicizia, causa della ricusazione di cui si pretendeva l’impedimento
dell’esercizio del diritto, era palesata dai precedenti giudizi di causa cui
tale magistrato era competente ed io sempre soccombente, quando io esercitavo la
professione forense, per le quali io ero imputato o difensore di parte. Dalla
lettura delle sentenze si evince tale pregiudizio.
In effetti, la
denuncia nei miei confronti, è un atto ritorsivo. Non tanto per la richiesta di
ricusazione ed avocazione delle indagini ed atti allegati, ma per la mia
attività di scrittore noto nel mondo che denuncia le malefatte dei magistrati a
Taranto e pubblica quanto gli altri non osano dire. Vedi caso killer delle
vecchiette, Sarah Scazzi, Ilva, ecc.
D'altronde la
calunnia non sussiste, sapendo il magistrato colpevole ed evidenziandolo in più
atti di denuncia, né sussiste la diffamazione, in quanto, ai sensi dell’art. 596
c.p., come pubblico Ufficiale la prova della verità del fatto determinato è
ammessa nel processo penale.
Oltretutto i
reati sono ampiamente prescritti e decaduti, ove vi fosse bisogno della querela.
Questa è la denuncia penale, così come richiesta in sede di avocazioni delle
indagini alla procura Generale della Corte di Appello di Potenza, e per la quale
è stata presentata (a dire di Rita Romano) denuncia per calunnia.
DENUNCIA ALLA S.V.
Rita Romano, giudice monocratico del Tribunale di Taranto, sezione staccata di
Manduria,
domiciliata in viale Piceno a Manduria,
per i reati di cui agli artt. 81, 323, 476, 479 c.p., con applicazione delle
circostanze aggravanti, comuni e speciali ed esclusione di tutte le attenuanti,
IN QUANTO
Essa, abusando del suo ufficio, ha adottato continuamente atti del suo ufficio,
con “INTENTO PERSECUTORIO”, lesivi degli interessi, dell’immagine e della
persona del sottoscritto, motivati da pregiudizio ed inimicizia e non sostenute
da prove.
Nei procedimenti che riguardavano direttamente o indirettamente il Giangrande
Antonio, quando questi esercitava la professione forense, essa ha condannato
quando le prove erano evidenti riguardo l’innocenza, o essa ha assolto quando le
prove erano evidenti sulla colpevolezza.
PREMESSO CHE:
Giangrande Antonio, da difensore, è stato vittima di un aggressione in casa da
parte del marito di una sua assistita in un procedimento di separazione, al fine
di impedirgli la presenza all’udienza del giorno successivo. Nel processo penale
n. 10354/03 RGD, in data 14 febbraio 2006, la Romano assolveva l’aggressore
Mancini Salvatore. In un processo istruito, in cui il PM non ha richiesto
l’ammissione di alcun testimone, pur indicanti in denuncia Giangrande Antonio,
sua moglie Petarra Cosima e il figlio Giangrande Mirko, la Romano sente solo i
coniugi ai sensi del’art. 507 c.p.p. su indicazione del Giangrande, ma rinuncia
alla testimonianza di Mirko, il vero testimone. Tale abnorme decisione di
assoluzione è stata assunta disattendendo i fatti, ossia le lesioni e le
testimonianze, e definendo testimoni inattendibili il Giangrande e la Petarra.
Giangrande Antonio era accusato di esercizio abusivo della professione forense e
per gli effetti di circonvenzione di incapace. Nel processo penale n. 7612/01
RGPM, in data 06/03/2007, nonostante lo stesso PM riteneva il reato di esercizio
abusivo della professione forense infondato e inesistente, essendovi regolare
abilitazione al patrocinio legale, chiedendone l’assoluzione, la Romano
condannava il Giangrande per circonvenzione di incapace. Tale abnorme decisione
è stata assunta, nonostante le tariffe forensi prevedevano l’obbligatorietà
dell’onorario per il mandato svolto. Tale abnorme decisione è stata assunta
nonostante più volte si sia denunciata la violazione del diritto di difesa per
mancata nomina del difensore, per impedimento illegittimo all’accesso al
gratuito patrocinio. E’ seguito appello. Da notare che il giorno della sentenza
era l’ultimo processo ed erano presenti solo il PM, il giudice Romano, il
cancelliere e il difensore dell’imputato. Dagli uffici giudiziari è partita la
velina. Il giorno dopo i giornali portavano la notizia evidenziando il fatto che
il condannato Giangrande Antonio era il presidente dell’Associazione Contro
Tutte le Mafie. Era la prima volte che le vicende del Tribunale di Manduria
avevano degna attenzione.
Giangrande Antonio era difensore di Natale Cosimo in una causa civile di
sinistro stradale. Il testimone Fasiello Mario dichiara di non sapere nulla del
sinistro. Esso era denunciato per falsa testimonianza. Nel processo penale n.
1879/02 PM , 1231/04 GIP, 10438/05 RGD, in data 27 novembre 2007, la Romano lo
assolveva. Tale abnorme decisione è stata assunta, nonostante lo stesso rendeva
testimonianza contrastante a quella contestata. Lo assolveva nonostante
affermava il vero e quindi il contrario di quanto falsamente dichiarato in
separata causa. Lo assolveva nonostante a difenderlo ci fosse un difensore,
Mario De Marco, impedito a farlo in quanto Sindaco pro tempore di Avetrana. Il
De Marco e Nadia Cavallo hanno uno studio legale condiviso.
Giangrande Antonio e Giangrande Monica erano accusati di calunnia, per aver
denunciato l’avv. Cavallo Nadia per un sinistro truffa, in cui definiva, in
reiterati atti di citazione, Monica “RESPONSABILE ESCLUSIVA” del sinistro. Atti
presentati due anni dopo la richiesta di risarcimento danni, che la compagnia di
assicurazione ha ritenuto non evadere. Il Giangrande Antonio non aveva mai
presentato denuncia. Antonio era fratello e difensore in causa di Monica. La
posizione del Giangrande Antonio era stralciata per lesione del diritto di
difesa e il fascicolo rinviato al GIP. Nel processo penale n. 10306/06 RGD, in
data 18 dicembre 2007, la Romano condannava Giangrande Monica e rinviava al PM
la testimonianza di Nigro Giuseppa per falsità. Tale abnorme decisione è stata
assunta, nonostante la presunta vittima del sinistro non abbia riconosciuto
l’auto investitrice, si sia contraddetto sulla posizione del guidatore, abbia
riconosciuto Nigro Giuseppa quale responsabile del sinistro, anziché Giangrande
Monica. Tale abnorme decisione è stata assunta, nonostante Nigro Giuseppa abbia
testimoniato che la presunta vittima sia caduta da sola con la bicicletta e che
con le sue gambe sia andato via, affermando di stare bene. E’ seguito appello.
Giangrande Antonio era difensore di Erroi Salvatore, marito di Giangrande
Monica, sorella di Antonio. In causa civile, in cui difensore della contro parte
era sempre Cavallo Nadia, tal Gioia Vincenzo ebbe a testimoniare sullo stato dei
luoghi, oggetto di causa. Il Gioia, in chiara falsità, palesava uno stato dei
luoghi, oggetto di causa, diverso da quello che con rappresentazione fotografica
si è dimostrato in sede civile e penale. Il Gioia, denunciato per falsa
testimonianza veniva rinviato a giudizio in proc. 24/6681/04 R.G./mod 21.
Difeso da Cavallo Nadia in proc. 10040/06 RGD. In data 16 aprile 2008 il giudice
Rita Romano, pur evidenti le prove della colpevolezza, assolveva il Gioia
Vincenzo.
"La pubblicazione della notizia relativa alla presentazione di una denuncia
penale e alla sua iscrizione nel registro delle notizie di reato, oltre a non
essere idonea di per sé a configurare una violazione del segreto istruttorio o
del divieto di pubblicazione di atti processuali, costituisce lecito esercizio
del diritto di cronaca ed estrinsecazione della libertà di pensiero previste
dall'art 21 Costituzione e dall'art 10 Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, anche se in conflitto con diritti e interessi della persona, qualora
si accompagni ai parametri dell'utilità sociale alla diffusione della notizia,
della verità oggettiva o putativa, della continenza del fatto narrato o
rappresentato. (Rigetta, App. L'Aquila, 10 Marzo 2006)". (Cass. civ. Sez. III
Sent., 22-02-2008, n. 4603; FONTI Mass. Giur. It., 2008).
Mallegni:
"Non chiamatemi più Massimo della pena".
Il sindaco di Pietrasanta dopo sei processi racconta la sua Odissea. Iniziata
con l’esposto di una vigilessa che Renzi ha portato a Palazzo Chigi, scrive
Maurizio Tortorella su “Panorama” il 6 luglio 2015. "Ho una sola preghiera: non
chiamatemi più Massimo della pena". Alla guida di una lista di
centrodestra, Massimo Mallegni è stato appena rieletto per la terza volta e a
furor di popolo sindaco di Pietrasanta, la città-gioiello della Versilia
lucchese. Il nomignolo gliel’hanno affibbiato le malelingue toscane e non hanno
tutti i torti: dal maggio 2001, pochi mesi dopo la prima elezione, Mallegni è
finito sotto processo ininterrottamente per 13 anni. I processi sono stati sei e
tutti duri, brutti e cattivi. Lui oggi scherza: "Silvio Berlusconi si lamentava
perché da presidente del Consiglio doveva dedicare un giorno a settimana ai suoi
processi. Io ero costretto ad andare in tribunale tre volte a settimana".
Sorride, Mallegni. Eppure è stato accusato di decine di reati, dalla A di abuso
fino alla T di truffa. Lo hanno perfino arrestato, ha fatto 39 giorni di carcere
e 119 agli arresti domiciliari. Ma tutto è sempre finito in nulla:
proscioglimenti in istruttoria, assoluzioni con formula piena. Per qualche reato
minore, prescritto, pende l’appello: "E solo perché mi sono sempre opposto alla
prescrizione". Dall’ultimo procedimento è uscito definitivamente assolto nel
febbraio 2014: un abuso d’ufficio ed edilizio per il quale, a lui albergatore
già nel cuore della stagione turistica, il 4 agosto 2010 la Procura di Lucca
aveva ordinato il sequestro della Spa dell’hotel. "Il sequestro"
sottolinea Sandro Guerra, che del sindaco è (come da nome) il battagliero
avvocato "l’aveva firmato un giudice che dopo l’arresto del 2006 aveva querelato
Mallegni per diffamazione. Sicuramente non ha collegato le due vicende, ci
mancherebbe". Era il momento in cui il già due volte sindaco era appena stato
sbattuto, con padre e cinque assessori, nel carcere di Lucca. «Sezione 4, cella
numero 17» dice Mallegni. «M’ha salvato la fede. Pensavo a mio figlio, a mia
moglie…». Tornato a casa, ebbe la cattiva idea di pronunciare parole di
sconforto, qualcosa sulla sua vita rovinata. Bastò a quel giudice per citarlo in
giudizio. Il sindaco ricorda la cella: "Ero in isolamento, come i mafiosi al 41
bis, e sempre controllato dal foro nella porta, anche quando andavo al
gabinetto. Ma gli agenti erano ottime persone". Questo va detto, di
Mallegni. Non porta rancore, né si ritiene un perseguitato. Anzi, continua a
ripetere che con lui "la giustizia ha funzionato". Un bel paradosso, non c’è
dubbio. "Ho incontrato una ventina di giudici" spiega "e sono stati
indipendenti. Hanno letto le carte, mi hanno ascoltato". L’avvocato Guerra è un
po’ meno conciliante. Ricorda soprattutto i duelli in aula con il pubblico
ministero "fratello". No, non massone, avete equivocato: fratello in senso
stretto, di sangue. Perché all’origine dei peggiori guai di Mallegni ci sono
stati gli esposti firmati da Antonella Manzione, ex comandante dei vigili urbani
di Pietrasanta, e gestiti a livello giudiziario dal pm lucchese Domenico
Manzione. Da allora fratello e sorella hanno fatto carriera. Domenico
nell’ottobre 2009 fu nominato procuratore di Alba e dal maggio 2013è
sottosegretario all’Interno, scelto da Enrico Letta e confermato da Matteo
Renzi; Antonella invece è divenuta prima comandante dei vigili urbani di
Firenze, con Renzi sindaco, e oggi è il suo capo dell’ufficio legislativo a
palazzo Chigi. Mallegni non ce l’ha nemmeno con loro: "Si vede che lei è brava e
lui è ancora più bravo" commenta. Ma torniamo alla querelle con la comandante
dei vigili. Tutto inizia quando il sindaco si è da poco insediato a Pietrasanta,
nel 2000. "Trovo una delibera firmata dal mio predecessore che riorganizza il
Comune". La delibera pone fine a un’anomalia: la comandante è anche capo dello
Sportello unico attività produttive, e le viene tolto il primo incarico.
Mallegni conferma la delibera: "La signora non perde un euro" dice "ma
evidentemente la cosa le provoca disagio. E presenta un esposto di 20 pagine
alla Procura di Lucca". È da quelle pagine che partono tre processi, con 51 capi
d’accusa. Manzione accusa Mallegni di avere abusato dell’auto di servizio ("Si
dimostrò che in realtà era l’auto civetta dei carabinieri della scorta: avevo
ricevuto 4 proiettili calibro 38 dal Partito comunista combattente"); di avere
inalberato un lampeggiante blu sulla sua auto ("Altro errore: era la vettura
di Gianfranco Fini, presidente della Camera"); di avere estorto a un vigile la
remissione di una multa ("Ma era un’auto del Comune"). L’esposto, firmato da
altri 5 vigili, si fa più delicato in campo urbanistico: qui Antonella Manzione
accusa il sindaco di avere fatto sperticati maneggi. Ed è su questo tema che
partono gli arresti del gennaio 2006, chiesti da Domenico Manzione per
associazione a delinquere, truffa, abuso d’ufficio, voto di scambio, estorsione…
"L’ex pm oggi nega di avere avuto un ruolo importante nel processo" polemizza
l’avvocato Guerra "ma non è così. Lo seguì fino al suo trasferimento ad Alba, e
ci sono i verbali delle udienze. Ricordo che, indispettito, uscì sbattendo la
porta dall’aula alla fine di un lungo interrogatorio nel quale ponevo a testi e
parti civili domande sul ruolo della sorella comandante dei vigili". Già nel
2006 la Cassazione stabilì che gli arresti erano stati illegittimi. "Intanto"
ricorda Mallegni "avevo ricevuto 755 lettere di solidarietà dai miei
concittadini". In Parlamento ci fu chi si rivolse al ministero della Giustizia,
allora retto dal leghista Roberto Castelli, segnalando l’anomalia di Lucca,
dove un pm agiva su esposti firmati da sua sorella: in procura arrivarono gli
ispettori, poi il governo cadde e tutto finì in niente. Sei anni dopo il
processo terminò allo stesso modo. Oggi Mallegni è di nuovo lì. Paura? "No"
risponde. "Fare il politico da imprenditore non è conveniente, ma si deve andare
avanti". E con il nuovo capo dei vigili urbani è tutto a posto? O si rischiano
nuovi guai? "È uno dei cinque che mi aveva denunciato con la sua comandante. Ma
è un tipo in gamba. E poi io non porto rancore".
Il Cav? È
l'unico corruttore al mondo.
La condanna di Silvio Berlusconi per il "tradimento" dell'ex senatore De
Gregorio mostra la totale parzialità di una giustizia che vede solo quel che
vuole vedere, scrive Maurizio Tortorella su “Panorama” il 9 luglio 2015. A che
cosa deve servire una sentenza di tribunale penale? A fare giustizia,
risponderete voi. Errato: serve “a offrire una funzione generalpreventiva". Così
ha detto ieri il pubblico ministero napoletano John Henry Woodcock nell'aula del
processo sulla presunta compravendita dell'ex senatore Sergio De Gregorio. Il
processo di primo grado si è concluso proprio ieri con la condanna di Silvio
Berlusconi, il presunto corruttore, a tre anni di reclusione (ma l'accusa ne
aveva chiesti cinque). L'altro condannato è Valter Lavitola, presunto tramite
del passaggio di denaro (tre milioni di euro, due dei quali in nero) che pure si
è visto assegnare tre anni. Strana maniera di vedere la giustizia, quella del pm
Woodcock. Il processo, destinato a concludersi per l'intervenuta prescrizione,
lascerà proprio per questo a metà ogni certezza giuridica. Non sarà quindi certa
né l'attribuzione del reato, né la sua configurazione storica. Parlare di
giustizia "generalpreventiva", in questo caso, è davvero improprio. Inoltre, la
questione di cui si è dibattuto a Napoli è decisamente controversa: non solo
nella verità storica dei fatti, negata con forza dagli imputati, ma anche in
punto di diritto. È infatti la prima volta in Italia (ma forse anche nel mondo)
che un "cambio di casacca" parlamentare viene punito con una condanna. In
Italia, peraltro, la Costituzione prevede all'articolo 67 che nessun deputato o
senatore possa essere soggetto a un "vincolo di mandato": questo vuol dire che è
libero di esprimersi nel voto parlamentare come meglio crede, e anche di
cambiare gruppo. Il procuratore di Napoli, Giovanni Colangelo, ha dichiarato
però che a essere punita in questo caso "non è l'insindacabilità del voto, ma il
condizionamento del voto: espresso non per libera scelta politica, ma per un
pagamento. E il reato di corruzione non si riferisce all'espressione di un voto,
ma alla promessa di un voto". Ma anche quella del procuratore Colangelo è una
ben strana maniera di vedere le cose. Perché l'alto magistrato pare dimenticare
le centinaia, migliaia di altri passaggi di campo che si sono verificati nella
Storia parlamentare italiana, e pare dimenticare soprattutto che molti di questi
hanno di certo avuto avuto alla loro base scambi di qualche utilità. Quante
volte si è saputo (e scritto sui giornali) delle prebende o dei vantaggi
ottenuti dal "traditore" di turno? Quanti senatori e deputati sono "migrati"
soltanto in virtù delle garanzie di una successiva elezione, o della promessa
del successivo ottenimento di posti importanti negli enti pubblici, o della
facile carriera garantita in altro settore? Certo, il trasformismo è purtroppo
costume trasversale, in questo Paese, fin dai tempi di Agostino Depretis. E non
è certo pratica commendevole. Ma allora perché per le altre centinaia e migliaia
di "cambi di casacca" parlamentari, comunque premiati con un vantaggio
evidente, non si è mai ipotizzato che potesse trattarsi di corruzione? Eppure
l'articolo 318 del Codice penale individua la corruzione nello scambio di un
atto con "denaro o altra utilità". Non dovrebbe allora essere punito chi ha
costretto decine di deputati berlusconiani a passare con il centrosinistra nelle
precedenti legislature, per poi ottenere in cambio un seggio più sicuro alle
successive elezioni?
Per di più, in
questo caso, la ricostruzione giudiziaria del passaggio di De Gregorio con il
centrodestra ha stravolto anche la verità storica. L'ex senatore infatti aveva
trascorso tutta la sua vita politica nel centrodestra, per poi passare da ultimo
(e strumentalmente) con il centrosinistra. Il suo "ritorno a casa" in
realtà avviene nel 2006, all'inizio della legislatura. Questa circostanza nega
con evidenza la "verità giudiziaria" uscita da Napoli, dove si è sentenziato che
il tradimento di De Gregorio avrebbe causato la caduta del governo di Romano
Prodi. In realtà il fragilissimo esecutivo di Prodi, che per lunghi mesi si era
sostenuto soltanto con l'aiuto dei senatori a vita, avvenne nel 2008 per
tutt'altro motivo: le crescenti turbolenze giudiziarie sul suo ministro della
Giustizia, Clemente Mastella, e la sua uscita dalla maggioranza.
E poi… Silvio
Berlusconi è decaduto da senatore e non è stato più candidabile per effetto
della legge Severino, scrive "Il Corriere della Sera". Malgrado la stessa legge,
il sindaco di Napoli Luigi De Magistris (eletto nelle fila dell’Idv) e il
neo-governatore della Campania Vincenzo De Luca del PD possono invece restare in
carica, per effetto di sentenze sospensive a loro favorevoli. Come
quella del 2 luglio 2015 che di fatto consente a De Luca di prendere
pieno possesso delle proprie funzioni dopo la
sua sospensione decretata nei giorni prima dal governo Renzi. Una
diversità di applicazione della norma che fa insorgere il centrodestra: «Dopo il
trattamento favorevole a de Magistris e De Luca, non chiamatela più legge
Severino ma con il suo vero nome: legge anti-Berlusconi - commenta la deputata
di Forza Italia, Elvira
Savino -. Ormai è chiaro a tutti che è una legge, applicata
addirittura retroattivamente, che è servita solo per estromettere
vergognosamente il presidente Berlusconi dal Senato». Stesso concetto ribadito
da Maria Stella
Gelmini, per la quale si è trattato di una legge «contra-personam»
(«visto che dopo il caso Berlusconi non è stata più applicata o, laddove
applicata, i suoi effetti sono stati cancellati con sentenze del Tar»), che
aggiunge: «Ora è chiaro perché il governo non ritiene utile una revisione della
legge Severino. Per la semplice ragione che essa viene interpretata per gli
amici e applicata ai nemici. Con buona pace dello stato di diritto». Il
capogruppo alla Camera di Forza Italia, Renato
Brunetta, fa notare via Twitter che «la decisione del Tribunale di Napoli
riabilita Berlusconi, ma il caso De Luca resta aperto. Sinistra giustizialista
chieda scusa a Cav. Severino da cambiare!». E con un paio di tweet interviene
anche Giorgia Meloni,
già ministro del governo Berlusconi, secondo cui la legge Severino è «l’unica
vera legge ad personam. #superioritamoraleuncorno». E ancora: «De Luca te lo
avevamo detto che potevi stare sereno: la Severino vale solo per Berlusconi e il
centrodestra. La sinistra è al di sopra della legge».
In una nota, i legali del leader FI, Franco Coppi, Piero Longo e Niccolò
Ghedini, parlano di «gravissima ingiustizia» osservando come siano «quasi due
anni che inascoltati sosteniamo la assoluta inapplicabilità della legge Severino
ai fatti precedenti, per il fondamentale principio di irretroattività.
Finalmente alcune decisioni stanno riconoscendo la evidente correttezza di
questa impostazione».
«Renzi può
intervenire con una modifica alla legge Severino, cosa che non ha ritenuto di
fare quando si è trattato di Silvio Berlusconi. - Così l’ex Cavaliere a Radio
anch’io, commentando la vicenda del candidato Pd alle regionali
campane Vincenzo De Luca, candidabile ma ineleggibile per la legge sulla
“repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione".
- Io chiedevo – ha sostenuto Berlusconi – una cosa semplice, cioè di aggiungere
una norma che dice che la presente legge si applica a fatti successivi alla sua
entrata in vigore. Cosa addirittura pleonastica ma che è stata dimenticata, e la
legge Severino con me è stata applicata retroattivamente. Così sono riusciti a
farmi decadere dal Senato e rendermi incandidabile per sei anni. Tuttavia sto
aspettando la Corte dei diritti di Strasburgo e spero che la sentenza verrà
ribaltata».
«Fino ad ieri
potevamo, politicamente, solo sospettare che la legge Severino fosse stata fatta
per espellere Berlusconi dal Senato. Da ieri, invece, dopo tre indizi abbiamo
raggiunto la prova “regina”, storica e politica al tempo stesso: la legge
Severino fu fatta contro e ad personam». Maria Stella Gelmini attacca nonostante
siano trascorsi ormai di due anni da quando, all’indomani della sentenza
Mediaset della Cassazione, il Senato espulse Silvio Berlusconi. Proprio per
effetto della legge Severino, scrive Antonio Manzo su “Il Mattino”.
Quali sono
i tre indizi, onorevole Gelmini, che la fanno raggiungere la prova?
«De Luca uno,
con il Governo che si guarda bene dal sospenderlo subito; De Luca due, con
l’ordinanza urgente del tribunale di Napoli; De Magistris tre, salvato sempre
dallo stesso giudice civile del caso De Luca. Abbiamo avuto così la
dimostrazione che tra ordinanze e sentenze, la legge Severino è stata
interpretata, favorevolmente, per gli amici ed è stata applicata,
implacabilmente, per i nemici. Altro che garantismo, qui è la morte dello stato
di diritto».
Scusi, ma
uno dei presupposti delle valutazioni dei magistrati è che sia nel caso di De
Luca, che in quello di de Magistris fossero in gioco valori costituzionalmente
protetti come quelli espressi da rappresentanti istituzionali eletti dal popolo?
«Se c’è un
leader politico che in Italia può dichiarare, a piena voce, di essere un eletto
dal popolo è Silvio Berlusconi. Che poi anche De Luca e de Magistris siano stati
eletti dal popolo per governare la Regione Campania ed il Comune di Napoli, è
altra storia. Nel caso di Silvio Berlusconi è stata minata, stracciata,
distrutta la volontà popolare e il valore elettivo, quello sì costituzionalmente
protetto ed universale, incarnato da un membro del Parlamento, massima
espressione della democrazia repubblicana. È un vulnus più grave. Non le pare?»
La legge
Severino fu votata anche da voi di Forza Italia. È mai possibile che nessuno si
sia accorto all’epoca dei fatti dei profili di incostituzionalità che oggi
vengono a più riprese evidenziati?
«Vogliamo
ricordare in che clima e in che contesto fu varata la legge Severino? Ebbene,
contestualizziamo l’epoca, è quella del Governo Monti che cacciò Berlusconi,
eletto dal popolo».
Governo
votato dal Parlamento, l’unità nazionale con lo spread in salita quotidiana...
«Quella fu la
cacciata di Silvio Berlusconi, eletto dal popolo, che inaugurò la stagione dei
nominati a Palazzo Chigi, Monti, Letta e Renzi».
Ma è anche
il tempo, ricorderà, degli scandali Fiorito, Lusi, Belsito, tutta gente che
aveva preso in ostaggio le casse dei rispettivi partiti rimpinguate dal
finanziamento pubblico come un bancomat personale.
«Non vorrà
mica farmi dire che la ricostruzione del contesto politico dell’epoca, con la
cacciata di Berlusconi da palazzo Chigi, annulli le responsabilità di chi aveva
fatto dei partiti un bancomat personale? E allora, che ci volesse una reazione
con norme più incisive alla corruzione, che facessero riguadagnare la faccia
alla politica, è cosa scontata ed ineludibile. Ma che quella della legge
Severino fosse una reazione emotiva è altrettanto vero. Anzi, come poi abbiamo
registrato, sottintendeva l’idea piuttosto obliqua di prefigurare una risposta
repressiva contro il leader dell’opposizione parlamentare, Silvio Berlusconi.
Altro che questione morale...».
La prova definitiva: in Italia la legge non è uguale per tutti,
scrive Maurizio Belpietro su “Libero Quotidiano”. La legge non è uguale per
tutti. Per qualcuno è più uguale di altri, nel senso che è più rigida,
soprattutto se ci si chiama Silvio Berlusconi. Ricordate la sentenza con cui
l’ex Cavaliere è stato condannato a quattro anni di detenzione e sospeso dai
pubblici uffici? Cioè quella misura che ha consentito la sua estromissione dal
Parlamento e ha stabilito la sua ineleggibilità? Per i giudici della Corte di
Cassazione il fondatore di Forza Italia fu l’artefice di una frode fiscale ai
danni dell’erario e per questo fu costretto non solo a lasciare il suo seggio da
senatore, ma anche a risarcire l’agenzia delle entrate. Peccato che in una
sentenza del 20 maggio 2014, cioè emessa dieci mesi dopo quella pronunciata
contro Berlusconi, la suprema corte si rimangi tutto, sostenendo che non si può
condannare un contribuente solo in base alla presunzione di colpevolezza. Per
stabilire che ha frodato il fisco ci vuole ben altro, ad esempio un atto
fondamentale, ossia che l’accusato abbia materialmente partecipato alla frode
compiendo l’atto finale: la dichiarazione dei redditi. Testuale: «I reati di
dichiarazione fraudolenta hanno natura istantanea e si consumano soltanto con la
presentazione della dichiarazione annuale». Ancor più esplicita: i reati di
frode non possono essere provati «dalla mera condotta di utilizzazione, ma da un
comportamento successivo e distinto, quale la presentazione della dichiarazione,
alla quale in base alla disciplina in vigore non dev'essere allegata alcuna
documentazione probatoria». Tradotto, tutto quel che succede prima, tutta la
fase di valutazione antecedente al fatto, non ha importanza, perché «il
comportamento precedente alla dichiarazione, quindi si configura come ante
factum meramente strumentale e prodromico per la realizzazione dell'illecito, e
perciò non punibile». La Cassazione, assolvendo nel maggio scorso un imputato di
frode fiscale, nega dunque la rilevanza penale delle violazioni «a monte» della
dichiarazione e lo fa facendosi forte di una serie di pronunciamenti passati. A
qualcuno il discorso potrà sembrare ostico e forse anche ininfluente, in quanto
la sentenza si riferisce a un caso diverso rispetto a quello di Silvio
Berlusconi e, come è a tutti noto, ogni processo fa caso a sé, anche perché ogni
giudice fa caso a sé. E per questo appunto c'è la Cassazione e le sezioni unite
che fissano i principi inderogabili. I principi valgono per tutti e non si
possono cambiare le carte in tavola a seconda di chi finisce alla sbarra. Dunque
«i comportamenti di un soggetto quando era ancora amministratore di una società
e che si era dimesso prima della presentazione della dichiarazione dei redditi,
non possono essere valorizzati neppure in termini di concorso con colui che,
rivestendo successivamente la carica di amministratore, aveva indicato nella
dichiarazione gli elementi fittizi». Tutto ciò messo nero su bianco da una
sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, un provvedimento che fa
giurisprudenza e al quale ci si deve attenere.
"Ora la revisione del processo Mediaset".
Una sentenza di assoluzione della Cassazione su un caso analogo a
quello di Berlusconi riapre la partita. L'annuncio di Ghedini, scrive Anna Maria
Greco su “Il Giornale”. C'è una sentenza della Cassazione che, dieci mesi dopo
quella Mediaset di condanna di Silvio Berlusconi, la bolla esplicitamente come
sbagliata. Si regge su una tesi, spiega la motivazione, «che non può essere qui
condivisa e confermata, perché contraria alla assolutamente costante e pacifica
giurisprudenza di questa Corte e al vigente sistema sanzionatorio dei reati
tributari». Il caso è del tutto analogo a quello Mediaset, frode fiscale, le
conclusioni opposte: sentenza di condanna confermata per il leader azzurro il
primo agosto 2013, sentenza di condanna annullata per il signor X il 20 maggio
2014. Colpisce che il relatore sia lo stesso, il giudice Amedeo Franco, che già
aveva firmato precedentemente altre sentenze «conformi» a quest'ultima. E che la
sezione sia la Terza penale, cui era naturalmente destinato il processo Mediaset
prima di venire dirottato a quella Feriale, presieduta da Antonio Esposito, per
il timore (poi, a quanto sembra, rivelatosi infondato) che nei mesi estivi
potesse scattare la prescrizione. «Questo dimostra - spiega il legale di
Berlusconi, Niccolò Ghedini - che la condanna Mediaset ha rappresentato un
unicum nella giurisprudenza della Cassazione. Che prima e dopo la legge è stata
interpretata in maniera diversa, con un orientamento univoco. Se il processo
Mediaset fosse arrivato alla Terza Sezione e non in quella Feriale, e con quello
stesso relatore, sarebbero cambiate le sorti di Berlusconi e del Paese, sarebbe
cambiata la storia. Questo sarà un elemento importante per la decisione della
Corte europea per i diritti dell'uomo, che attendiamo. Ma soprattutto, sulla
base di questa sentenza e delle nuove prove che abbiamo raccolto, chiederemo la
revisione del processo». La difformità nella giurisprudenza di per sé non
produce effetti sulla condanna Mediaset, ma potrebbe convalidare una violazione
del principio del giusto processo, tra le ipotesi che giustificano la revisione
del processo. E la strada sarebbe aperta se la Corte di Strasburgo, nella
pronuncia attesa dopo l'estate, affermasse appunto che questa violazione c'è
stata. È vero che ogni giudice e ogni collegio fa giurisprudenza a sé, ma è
anche vero che la Suprema Corte ha proprio la funzione di uniformare
l'interpretazione e l'applicazione del diritto. È lecito chiedersi perché prima
della sentenza Mediaset si è seguita una strada precisa per il reato di frode
fiscale e anche dopo è stato così, mentre in quel caso isolato ha prevalso
proprio la teoria rivelata dal presidente Esposito in un'intervista al Mattino
che gli ha procurato un processo disciplinare: Berlusconi fu condannato «perché
sapeva», fu informato da altri della frode, non per il principio astratto del
«non poteva non sapere», essendo il capo. Proprio qui sta il punto in cui la
sentenza depositata in Cassazione il 19 dicembre scorso contraddice quella
Mediaset, che cita esplicitamente, con data e numero di serie. Contestando la
condanna dell'imputato, i Supremi giudici scrivono: «In sostanza, la corte
d'appello appare aver adottato una interpretazione (analoga a quella poi seguita
dalla Sezione feriale 1-8-2013, n.35729) nel senso che per la sussistenza del
reato sarebbe sufficiente la prova di un "coinvolgimento diretto e consapevole
alla creazione del meccanismo fraudolento... che ha consentito... di avvalersi
della documentazione fiscale fittizia", al sottoscrittore della dichiarazione».
Invece, continua la sentenza, questo non è affatto sufficiente. E le massime che
l'accompagnano, quelle che per il futuro indicano ai giudici come interpretare
la legge, dicono chiaro che: «I reati di dichiarazione fraudolenta hanno natura
istantanea e si consumano soltanto con la presentazione della dichiarazione dei
redditi». Le fasi preparatorie, il sapere o non sapere, non contano.
La Cassazione si rimangia la sentenza su Berlusconi,
scrive Davide Giacalone su “Libero Quotidiano”. Il condannato Silvio
Berlusconi ha terminato di espiare la pena. E questo è noto a tutti.
Quel che non è noto, però, è che nel frattempo la corte di Cassazione ha
condannato la sentenza che lo condannava. La considera un’eccezione, da non
prendere ad esempio, perché sbagliata. Il nome del condannato agita le
tifoserie. Gli capitava da imprenditore, ancor più da politico. La condotta di
quelle trincee vocianti non è per nulla interessante. Talora neanche
ragionevole. La linea cui ci si deve attenere, quando si affrontano questioni di
giustizia, consiste nel non cedere alla contrapposizione fra innocentisti e
colpevolisti, ma di attenersi alla difesa del diritto e dei diritti. Solo in
questo modo non ci si limita a discutere casi personali, sollevando questioni
che, sempre, riguardano tutti. Il che vale anche questa volta. Ma non faccio il
falso ingenuo, so bene che il nome di Berlusconi è divisivo, capace, per i
simpatizzanti e gli antipatizzanti, di distorcere la percezione della realtà.
Chiedo uno sforzo, però: prima si capisca quel che è successo, poi si passi alle
considerazioni, anche politiche e personali, che se ne possono far discendere.
Con sentenza della Cassazione, emessa il primo agosto del 2013
(numero 35729), è stata confermata la condanna inflitta agli imputati in
appello. Per Berlusconi la Cassazione chiese anche il ricalcolo della pena
accessoria. Il reato contestato era la frode fiscale, con violazione (scusate la
pedanteria, ma fra poco ne sarà chiara la ragione) del decreto legislativo 10
marzo 2000, numero 74. Detto in soldoni: la dichiarazione dei redditi della
società (Mediaset) era mendace, giacché contenente riferimenti e
contabilizzazioni di documenti falsi (fatture). Il seguito lo conoscono tutti:
decadenza da parlamentare e affidamento ai servizi sociali. Il 20 maggio del
2014, quasi un anno dopo, quindi, la terza sezione della corte di Cassazione si
è trovata ad esaminare un caso del tutto analogo, emettendo una
sentenza, depositata in cancelleria il 19 dicembre successivo. L’imputato era
stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione. Osserva la Cassazione, a
pagina 10 della sentenza: «In sostanza, la corte d’appello appare aver adottato
una interpretazione (analoga a quella poi seguita dalla Sezione Feriale
1/8/2013, n. 35729) nel senso che per la sussistenza del reato sarebbe
sufficiente la prova di un “coinvolgimento diretto e consapevole alla creazione
del meccanismo fraudolento (…) che ha consentito (…) di avvalersi della
documentazione fiscale fittizia” al sottoscrittore della dichiarazione» (corsivo
e omissioni come da sentenza). Tenetevi forte, perché le parole che seguono
vanno valutate una per una. Scrive la Corte: «Si tratta però di una tesi che non
può essere qui condivisa e confermata, perché contraria alla assolutamente
costante e pacifica giurisprudenza di questa Corte ed al vigente sistema
sanzionatorio dei reati tributari introdotto dal legislatore con il decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74». Detto in altro modo: le ragioni per cui
Berlusconi, assieme ad altri, è stato condannato non solo sono difformi dalla
«contraria» e «assolutamente costante e pacifica giurisprudenza» della
Cassazione, ma sono in contrasto con quanto stabilisce la legge. Tanto che, quel
20 maggio dell’anno scorso, la Cassazione annullò la sentenza che le era stata
sottoposta. Il primo agosto del 2013, invece, la confermò. Non è finita. Alla
sentenza si accompagnano delle «massime», che sono delle brevi citazioni, utili
a fissare i principi di diritto che la sentenza afferma. La Cassazione, infatti,
esiste quale giudice di legittimità ed ha una funzione nomofilattica, che
significa: garantire l’uniformità dell’interpretazione e dell’applicazione del
diritto. Le massime aiutano i futuri giudici di merito (e gli avvocati,
naturalmente) ad attenersi a quell’uniforme interpretazione e applicazione.
Ebbene, la sentenza di cui parliamo è accompagnata da alcune massime, in calce
alle quali ci sono i riferimenti a varie sentenze, sempre della Cassazione,
«conformi», vale a dire che sostengono la stessa cosa. E c’è la difforme: la
numero 35729. Quella che condannò Berlusconi. Nelle motivazioni e nella massime
si legge la corretta interpretazione della legge: la frode fiscale nasce e si
concretizza nel momento in cui è firmata la dichiarazione mendace, mentre
nessuno degli atti preparatori può, in nessun caso, essere utilizzato per
dimostrarla e indicarne il colpevole. Tale, del resto, è chi firma il falso,
ovvero nessuno degli imputati allora condannati. Ma colpevole può anche essere
chi induce l’amministratore di una società in errore, mediante l’inganno.
Circostanza negata dalla sentenza d’appello, quindi, ove la si voglia
contestare, sarebbe stato un motivo di annullamento (con rinvio), non di
conferma. Colpevole può anche essere l’amministratore di fatto, ovvero la
persona che non figura come amministratore, ma che ne esercita le funzioni. Nel
qual caso, però, si deve dimostrarlo. Senza nulla di ciò non può esserci
condanna, questo stabilisce la Cassazione, con «assolutamente costante e
pacifica giurisprudenza». Vengo all’ultimo aspetto, che a sua volta ha un peso
dirompente. I contrasti di giurisprudenza esistono fin da quando esiste la
giurisprudenza. Per quanto la Cassazione s’affanni a perseguire l’uniformità,
agguantarla in modo assoluto è impossibile. Quindi, se due giudici emettono
sentenze diverse non è una cosa poi così terribile. Peccato, però, che la
Cassazione esiste proprio per correggere, non per produrre le difformità. E
peccato che, in questo caso, non ci sono due giudici, ma uno solo. I due
collegi, quello del 2013 e quello del 2014, si compongono complessivamente di
dieci giudici, ma, come si vede dal frontespizio delle due sentenze, il
«consigliere relatore» è uno solo. La stessa persona. Che ad agosto del 2013
scrive una cosa e a maggio del 2014 la demolisce. Anche in modo sprezzante, e
ben più a lungo e dettagliatamente di quanto qui riportato. Nessuno pensi di
cavarsela supponendo uno sdoppiamento della personalità. Meno ancora in un
cambio di opinione, perché ha messo nero su bianco che l’orientamento era
univoco sia prima che dopo. In quelle parole, dure e inequivocabili, io leggo il
dolore. Un cultore del diritto cui si è storto fra le mani. E siccome la legge
impedisce a un giudice di manifestare e rendere noto il proprio dissenso (in
altri sistemi di diritto si verbalizza il diverso parere e, anzi, lo si utilizza
pubblicamente per aiutare l’interpretazione della sentenza), quello ha preso la
forma di una sentenza successiva. Tutto questo dice una cosa terribile: s’è
scassata la Cassazione. La prova ce l’avete sotto gli occhi, contenuta nelle due
sentenze. Questo è il punto che considero più rilevante e, ovviamente, di valore
generale. Ma so benissimo che tutti guarderanno al nome del condannato, sicché
aggiungo un dettaglio, che le tifoserie interpreteranno da par loro, mentre a me
preme perché conferma quanto appena, tristemente, constatato: quel condannato,
quando ancora era imputato, sarebbe dovuto finire davanti alla terza sezione,
perché così stabilisce la Costituzione, affermando che il giudice non lo sceglie
nessuno, ma è precostituito per legge, invece finì davanti alla sezione feriale.
Perché accadde? Allora si disse, e ovunque si scrisse, perché i reati contestati
sarebbero andati in prescrizione di lì a qualche settimana. In questi casi,
giustamente, non si lascia che le ferie dei giudici mandino al macero le
sentenze. Ma l’autorità giudiziaria di Milano, dove si era svolto il processo e
dove risiedeva la procura che aveva sostenuto l’accusa, aveva inviato un fax con
il quale dimostrava che la prescrizione, correttamente conteggiata, non era così
imminente. Le tifoserie pro Berlusconi grideranno d’orrore, vedendoci il
complotto. Le tifoserie anti Berlusconi grideranno d’orrore, vedendoci la
delegittimazione di giudici e sentenza. Lasciatemi accudire l’orrore silente,
per una giustizia che si fatica a considerare tale.
I giudici Esposito e Berlusconi: il figlio gli chiedeva favori,
il padre lo condannava, scrive "Articolo 3". Si torna
a parlare degli anomali rapporti tra i giudici Esposito, padre e figlio, e l'ex
premier Silvio Berlusconi. Il motivo è chiaro: nell'agosto del
2013, il collegio della Corte di Cassazione, presieduta da Antonio Esposito,
aveva confermato la condanna di 4 anni per evasione fiscale nei confronti di
Berlusconi, nell'ambito del processo Mediaset. Nello stesso periodo, però, il
figlio di Antonio, Ferdinando Esposito, giudice a Brescia,
aveva avuto rapporti con l'ex premier. E non solo: ci sarebbero state anche
delle visite, ad Arcore, e regali. Il rapporto "sconveniente" è emerso
nell'ambito di un altro processo, che con quello Mediaset non c'entra niente:
Ferdinando Esposito è indagato per “tentata induzione indebita” e “tentata
estorsione”. Secondo gli inquirenti, avrebbe fatto pressioni indebite per
spingere un avvocato, oggi suo accusatore, a subentrare nell'affitto da 32mila
euro annui della casa in cui il pm abitava. L'accusatore di Esposito, nel
raccontare il tutto, aveva anche rivelato appunto i rapporti con Berlusconi. E
il giudice, da parte sua, li ha confermati: ha rivelato di aver conosciuto l'ex
premier attraverso la parlamentare di Forza Italia Michela Brambilla e, tra il
2009 e il 2013, vi furono anche delle visite ad Arcore che, secondo il pm,
riguardavano una sua «possibile entrata in politica», cosa che poi non è
avvenuta. "Io mai e poi mai nella maniera più assoluta ho trattato
questioni che avessero a che fare con i processi Ruby e Mediaset”, ha
precisato, pur confessando di aver anche ricevuto dei regali da Berlusconi:
«Soltanto regalie d’uso che è solito dare a tutti quando si presentano lì»,
ossia cravatte.
Perché
leggere Antonio Giangrande?
Più di 5 milioni di italiani con la tangente o la
raccomandazione, scrive Paolo Comi su “Il
Garantista”. C’è una ricerca del Censis, che è stata presentata a Roma, molto
interessante su svariati argomenti (la ricerca è sul rapporto tra mondo
produttivo e pubblica amministrazione) e che ci fornisce in particolare un dato
sul quale sarà giusto riflettere. Questo: quattro milioni e mezzo di italiani
ammettono di avere fatto ricorso a una raccomandazione per ottenere una maggior
velocità (e un buon esito) alle pratiche disperse nei meandri
dell’amministrazione pubblica. E addirittura 800 mila ammettono di avere fatto
un regalino a dirigenti e funzionari per avere in cambio un atto dovuto.
Regalino, a occhio, è qualcosa di simile alla tangente. Le cifre poi vanno lette
bene. Se quattro milioni e mezzo ammettono, è probabile che altri quattro
milioni e mezzo non ammettono. E così per gli 800 mila. Le cifre vere potrebbero
essere 9 milioni di raccomandazioni e un milione e seicentomila piccole
tangenti. Se consideriamo che non tutta la popolazione attiva (e cioè circa 40
milioni di persone) ha avuto bisogno di velocizzare pratiche nella pubblica
amministrazione (diciamo circa la metà) otteniamo questo rapporto: su 20 milioni
di persone che hanno avuto problemi con la pubblica amministrazione, 9 milioni
hanno fatto ricorso a una raccomandazione, perché conoscevano qualcuno, un
milione e seicentomila ha pagato una tangente, altri 9 milioni e
quattrocentomila se ne sono stati buoni buoni in fila ad aspettare. E’
abbastanza divertente intrecciare questi dati coi dati su coloro che chiedono
più rigore, più pene, severità e ferocia contro la corruzione. Corrotti,
corruttori e ”punitori” di corruttori e corrotti, spesso, sono la stessa
persona. La ricerca del Censis ci consegna una realtà nitida e
incontrovertibile: almeno la metà degli italiani fa uso di forme soft di
corruzione. E le forme, probabilmente, sono soft perché non esistono le
possibilità che siano hard. Perché questi nove milioni non hanno né potere né
soldi. Naturalmente di fronte a questo dato si può dire: colpa dei politici che
danno il cattivo esempio. Beh, questa è una stupidaggine. Non c’è un problema di
cattivo esempio, perché anzi, da almeno vent’anni, i politici e i giornalisti e
tutti i rappresentanti delle classi dirigenti, delle professioni, dei mestieri e
della Chiesa, non fanno altro che indicare la corruzione come il peggiore dei
mali che ammorba la nostra società. Il problema è che spesso, gli stessi,
ricorrono in qualche modo alla corruzione e non si sentono per questo
incoerenti. Qualche caso un po’ clamoroso di ipocrisia è saltato fuori
recentemente dalla cronaca, fior di imprenditori antimafia e anticorruzione
presi con le mani nel sacco. La gran parte dei casi però non emerge. Potete star
sicuri, ad esempio, che una buona parte degli opinionisti, dei giornalisti e dei
politici che tutti i giorni si impancano e vi fanno la lezione di moralità,
qualche mancetta l’hanno lasciata, qualche pagamentino in nero lo hanno
accettato, qualche rimborso spese di troppo… L’altro giorno, in una intervista
divertentissima, il vecchio Pippo Baudo raccontava, sorridendo, di quando il
principe dei moralizzatori, Beppe Grillo, si faceva pagare dalla Rai il rimborso
spese per il soggiorno a Roma, se lo metteva in tasca, e poi andava a mangiare e
a dormire a casa di Pippo. Il vecchio Baudo se la rideva, e ha anche raccontato
di quel giorno che Beppe gli ha detto: «Magari, per sdebitarmi, lascio una
mancia alla Nena». La Nena era la donna di servizio di Baudo, e Baudo subito ha
detto a Beppe che gli pareva un’ottima cosa, e gli ha chiesto quanto pensava di
lasciarle. Grillo, vecchio genovese, ha risposto: «Che dici, cinquemila?». «Non
sarà troppo?, gli ha ribattuto, ironico, Pippo Baudo. E allora Grillo ha
sentenziato: «No, meno di 5000 no, allora è meglio niente». E non gli ha
lasciato niente… Così il rimborso se l’è preso tutto intero. Non sarà colpa
dell’esempio, ma comunque è colpa dei politici. La raccomandazione e la tangente
sono un frutto del modo nel quale è organizzata la vita pubblica. E i politici
di questo sono responsabili. La mancata trasparenza (nella pubblica
amministrazione come negli appalti) è la causa vera della corruzione. Perché la
rende possibile e perché la rende indispensabile. Però di tutto questo frega
poco a tutti. Prendiamo la questione degli appalti. E’ chiaro come l’acqua che
il sistema complicatissimo vigente (in Italia ci sono oltre 30 mila stazioni
appaltanti, e non si sa a chi rispondano, e non si sa chi decide, e ognuna
adopera criteri tutti suoi per valutare, e non sia sa chi e come può controllare
ed eventualmente indagare) consegna poteri discrezionali enormi a un certo
numero di persone e -spesso – ad alcuni politici. Che naturalmente esercitano
questo potere. Alcuni, meritoriamente, in modo onesto – ma perché sono
disperatamente onesti loro, incorruttibili – alcuni in modo meno onesto, o
comunque traendone qualche utilità. Moltissime volte l’appalto viene assegnato
senza gara. Altre volte col sistema del ribasso dei prezzi, che è un sistema
assurdo perché consegna un potere immenso a chi decide e presuppone un rapporto
forte e sregolatissimo tra impresa e stazione appaltante. Dovrebbe essere
abbastanza chiaro che, in seguito a una perizia seria, si può stabilire che
costruire in quel luogo una scuola con certe caratteristiche e di una certa
grandezza costa una cifra tot. Diciamo 10 milioni. L’appalto non può essere dato
a chi chiede meno. Se uno mi offre di fare quella scuola a 5 milioni, mi sta
fregando. O pensa di fare la scuola con la carta pesta, o pensa di farla piano
piano e che tra due anni chiederà una revisione prezzi e otterrà 15 milioni ( e
poi magari la farà lo stesso di carta pesta…). L’appalto deve essere concesso a
una cifra fissa all’azienda che da le maggiori garanzie. E da un numero
ridottissimo e quindi controllabile di stazioni appaltanti. Se fosse così
sarebbe molto difficile corrompere qualcuno. E la stessa cosa per le pratiche
della pubblica amministrazione. Vanno semplificate, spesso abolite,
deburocratizzate e risolte in tempi certi. Ottenere qualcosa del genere sarebbe
una riforma seria. Una riforma dello Stato molto, molto più utile e profonda
dell’abolizione del Senato e roba simile. Perché nessuno le chiede queste leggi?
Perchè la politica e l’intellettualità italiana sono nelle mani di un cerchio
magico (che si è costruito, trasversale, attorno al triumvirato Anm-Travaglio-
Salvini) il quale se ne frega delle riforme e chiede solo pene severe. Per loro
non contano le leggi, le idee, contano gli anni di carcere e basta. Adesso hanno
stabilito che la pena massima per la corruzione sale da otto o dieci anni. E
sono felici, e brindano, e sentono le manette tintinnare allegre. Riforma
forcaiola e inutile. Il problema non è di tenere un povero cristo in prigione
per due anni di più, il problema è di rendergli impossibile la corruzione. Ma
questa idea non piace a nessuno. Non piace a Salvini, non piace a Travaglio, non
piace all’Anm, non piace, probabilmente, neanche a Renzi, e nemmeno ai 4 o 9 o
10 milioni di italiani delle raccomandazioni e dei regalini. A loro piace solo
sapere che impiccheranno Lupi con una corda d’oro.
«Generalmente
sono di piccola statura e di pelle scura. Molti puzzano perché tengono lo stesso
vestito per settimane. Si costruiscono baracche nelle periferie. Quando riescono
ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si
presentano in 2 e cercano una stanza con uso cucina. Dopo pochi giorni diventano
4, 6, 10. Parlano lingue incomprensibili, forse dialetti. Molti bambini vengono
utilizzati per chiedere l'elemosina; spesso davanti alle chiese donne e uomini
anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che
faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al
furto e, se ostacolati, violenti.
Le nostre
donne li evitano sia perché poco attraenti e selvatici, sia perché è voce
diffusa di stupri consumati quando le donne tornano dal lavoro. I governanti
hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non hanno
saputo selezionare tra coloro che entrano nel paese per lavorare e quelli che
pensano di vivere di espedienti o, addirittura, di attività criminali.
Propongo che
si privilegino i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti ma
disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli americani
rifiutano pur che le famiglie rimangano unite e non contestano il salario. Gli
altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa prima relazione,
provengono dal sud dell'Italia. Vi invito a controllare i documenti di
provenienza e a rimpatriare i più. La nostra sicurezza deve essere la prima
preoccupazione».
____________________________
Fonte: Relazione dell'Ispettorato per l'immigrazione
del Congresso degli Stati Uniti sugli immigrati italiani, ottobre 1919.
Razzismo, la gaffe di Germano: falso il testo letto ai bimbi rom.
Elio Germano, attore figo, impegnato e perciò di
sinistra, ha pensato bene di dare il suo contributo alla mobilitazione contro
Salvini. Ma ha fatto una clamorosa gaffe, scrive Giampaolo Rossi su “Il
Giornale”. Elio Germano, attore figo, impegnato e perciò di sinistra, ha pensato
bene di dare il suo contributo alla mobilitazione delle anime belle contro
Salvini e il pericolo della destra intollerante e, soprattutto, ignorante. Per
questo ha realizzato un video contro il razzismo; ha preso un gruppo di bambini
Rom sullo sfondo di una roulotte, si è seduto in mezzo a loro e ha iniziato a
leggere un documento con tono recitato (come si addice ai grandi attori) e
l’aria di chi sta svelando al mondo una verità nascosta ma scontata. Il testo è
una descrizione offensiva e razzista degli italiani emigrati in America agli
inizi del ‘900, definiti ladri, puzzolenti, stupratori, abituati a vivere dentro
baracche fatiscenti e organizzati secondo regole di clan. Elio Germano spiega
che quel testo è un documento dell’allora Ispettorato per l’Immigrazione degli
Stati Uniti. L’obiettivo dell’attore è ovvio: dimostrare che certi italiani di
oggi sono razzisti verso gli immigrati e i Rom, come lo erano gli americani
verso gli italiani all’inizio del secolo. Tutto molto bello e politically
correct, se non fosse che, a quanto pare, quel documento è una patacca, un
falso. Il testo, che gira da molti anni su internet, fu già utilizzato nel 2013
da Roberto Saviano (uno che di patacche se ne intende) nel salottino televisivo
di Fabio Fazio. Più recentemente, Carlo Giovanardi, l’agguerrito deputato di
centrodestra, ha pubblicato il vero documento originale della Commissione
Dillingham sull’Immigrazione, che non contiene nulla di quanto letto dagli
antirazzisti di mestiere, ma al contrario è un’attenta analisi dell’immigrazione
italiana del periodo. Che giudizi sprezzanti e spesso offensivi
contrassegnassero l’opinione pubblica americana nei confronti degli italiani
(soprattutto meridionali) è cosa appurata storicamente da diversi studi. Ma quel
documento che i fulgidi artisti di sinistra si passano di mano in ogni occasione
per dare del razzista a chiunque contesti l’immigrazione clandestina, è una
patacca degna della loro inutile demagogia.
Saviano va in tv a spiegare che una volta eravamo noi italiani
gli zingari d’America. Ma è una bufala. Giugno 12,
2013 Carlo Giovanardi. Ospite di Fabio Fazio, lo scrittore cita «un documento
dell’Ispettorato per l’immigrazione Usa» che tratta gli italiani come zecche.
Peccato che sia una patacca Domenica 26 maggio Roberto Saviano, intervistato da
Fabio Fazio nella trasmissione Che tempo che fa, per combattere quella da lui
definita l’ondata di «odio morale verso gli immigrati» ha letto un testo. Cito
testualmente le sue parole: «Avevo visto e trascritto qui alcune parole della
relazione dell’Ispettorato per l’immigrazione del Congresso americano, quindi un
documento ufficiale del governo americano del 1912, così descrive gli italiani».
Ecco il testo letto da Saviano: «Gli italiani sono generalmente di piccola
statura e di pelle scura, non amano l’acqua, molti di loro puzzano perché
tengono lo stesso vestito per molte settimane, si costruiscono baracche di legno
e alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri.
Si presentano di solito in due, cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi
giorni diventano quattro, sei, dieci, tra loro parlano lingue a noi
incomprensibili probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono
utilizzati per chiedere l’elemosina, fanno molti figli che poi faticano a
mantenere. Dicono siano dediti al furto, e le nostre donne li evitano non solo
perché poco attraenti e selvatici, ma perché si parla di stupri o agguati in
strade periferiche. Propongo che si privilegino le persone del nord, veneti e
lombardi, corti di comprendonio e ignoranti, ma disposti più degli altri a
lavorare». Concludeva poi Saviano: «Incredibile che il nostro paese tutto questo
non lo ricordi, non ne faccia memoria attiva, ma lo trasferisca quando si
rivolge ad altre comunità o “etnie”». Conosco bene la storia dell’emigrazione
italiana e delle terribili discriminazioni e umiliazioni di cui i nostri
connazionali sono stati vittime all’estero ma, trovandomi per caso quella sera
davanti alla tv di Stato, mi è parso del tutto evidente il fumus di “patacca”
che emanava da frasi così volgari ed offensive in un documento ufficiale del
Senato degli Stati Uniti nei confronti di un intero popolo. Una rapida ricerca
su Google mi ha permesso di scoprire che già Paolo Attivissimo sul sito del
CICAP (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale),
aveva a suo tempo verificato che di quel testo erano in circolazione varie
versioni, una delle quali, lanciata da Rainews24, citava come fonte il
giornalista e conduttore televisivo Andrea Sarubbi che nel 2009 aveva
pubblicato un articolo con quella citazione. Sarubbi, interpellato, aveva
precisato di non aver tratto la citazione direttamente dal documento
statunitense originale. La sua frase: «Ho fra le mani un documento
dell’Ispettorato per l’immigrazione», non era quindi letterale, ma derivava da
una fonte italiana, «un articolo pubblicato un anno fa sul giornale Il Verona
dall’avv. Guarenti». Guarenti, a sua volta, dichiarava di averlo trovato «in un
libro di un anno fa» ma non era in grado di citare il titolo del libro.
Insomma, concludeva Attivissimo: «Siamo di fronte ad una situazione almeno di
terza mano di cui non si sa la fonte intermedia». Sulla traccia di Attivissimo
ho interpellato pertanto formalmente l’ambasciata americana che mi ha risposto
il 30 maggio: «La commissione sull’immigrazione degli Stati Uniti conosciuta
come la Dillingham Commission dal nome del senatore del Vermont che l’ha
presieduta ha lavorato dal 1907 al 1911 e ha pubblicato 41 volumi di rapporti
contenenti dati statistici sull’immigrazione negli Stati Uniti, l’occupazione
degli immigrati, le condizioni di vita, la scolarizzazione dei bambini, le
organizzazioni sociali e culturali, delle comunità degli immigrati e la
legislazione sull’immigrazione a livello statale e federale». Continuava poi
l’ambasciata americana: «Questi sono gli unici rapporti ufficiali
sull’immigrazione elaborati in quegli anni e disponibili al pubblico. Da una
visione superficiale, la citazione da lei riportata nella sua mail non appare in
nessuno di questi rapporti, ma per esserne certi bisognerebbe eseguire una
ricerca più accurata, per la quale purtroppo noi non siamo in grado di aiutarla
in questo momento». Aiutati che Dio ti aiuta, ho consultato tramite la mail
inviatami dall’Ambasciata tutti i volumi senza trovar traccia del documento
citato da Saviano, ma viceversa una interessantissima disamina sull’immigrazione
dell’Italia che ho fatto tradurre dall’inglese e si può leggere sul sito
www.carlogiovanardi.it. Per il resto ringrazio Saviano che mi permette di
aggiungere il XII ed ultimo capitolo al libro intitolato Balle che sto
pubblicando, dove spiego come l’opinione pubblica italiana fonda le sue
convinzioni su vere e proprie bufale che vengono troppo spesso disinvoltamente
spacciate come verità.
61ª legislatura, Documento n. 662, RELAZIONI DELLA COMMISSIONE
SULL'IMMIGRAZIONE. DIZIONARIO DELLE RAZZE O POPOLI. Presentato da DILLINGHAM il
5 dicembre 1910 alla Commissione sull'immigrazione [...]
ITALIANO. La razza o il popolo dell'Italia. L'Ufficio dell'immigrazione [Bureau
of Immigration] divide questa razza in due gruppi: Italiani settentrionali e
Italiani meridionali. Fra i due gruppi vi sono delle differenze materiali,
riconducibili a lingua, aspetto fisico e carattere, e delle differenze relative,
rispetto alla distribuzione geografica. Il primo gruppo identifica gli italiani
nativi del bacino del Po (compartimenti del Piemonte, Lombardia, Veneto ed
Emelia [sic], i distretti italiani in Francia, Svizzera e Tirolo
(Austria) e i loro discendenti. Tutti i popoli della penisola geograficamente
definita e delle isole della Sicilia e della Sardegna sono Italiani meridionali.
Anche Genova è meridionale.
Linguisticamente, l'italiano
rappresenta una delle grandi divisioni del gruppo di lingue romanze derivate dal
ceppo latino della famiglia ariana. Esso è articolato in molti dialetti, la cui
separazione e conservazione è favorita dalla configurazione geografica
dell'Italia. Hovelacque divide questi dialetti in tre gruppi: superiore,
centrale ed inferiore. Il primo comprende i dialetti genovese, piemontese,
veneto, emiliano e lombardo; il gruppo centrale comprende toscano, romanesco e
còrso; il gruppo inferiore comprende napoletano, calabrese, siciliano e sardo.
Questi dialetti differiscono fra di loro molto più che i dialetti inglesi o
spagnoli. Si dice che è difficile per un Napoletano o un Sardo farsi capire da
un nativo della pianura padana. Forse più che in qualsiasi altro paese, le
classi colte restano tenacemente aggrappate all'uso del dialetto in àmbito
familiare, preferendolo alla forma letteraria nazionale della lingua. Tale forma
letteraria è rappresentata dal dialetto toscano di Firenze, come codificato
nella letteratura di Dante, Petrarca e Bocaccio [sic] nel XIV secolo.
Anche altri dialetti, tuttavia, hanno una considerevole letteratura, soprattutto
il veneto, il lombardo, il napoletano e il siciliano. Quest'ultimo ha una poesia
particolarmente ricca. Tutto il gruppo superiore di dialetti – per restare alla
definizione di Hovelacque – tranne il genovese, è settentrionale. Tali dialetti
contengono molti elementi gallici o celtici e mostrano affinità con le lingue
provenzali e retoromanze (ladino e friulano), con le quali confinano ovunque
tranne che al sud. Il genovese e i dialetti del gruppo centrale ed inferiore
sono parlati dagli Italiani meridionali.
Fisicamente, gli Italiani sono una
razza tutt'altro che omogenea. La catena montuosa degli Appennini forma una
linea geografica che costituisce un confine fra due gruppi etnici distinti. La
regione a nord di questa linea, la valle del Po, è abitata da persone – i
Settentrionali – abbastanza alte e con la testa larga (la razza "alpina"). Gli
abitanti delle zone orientali ed occidentali di questa regione mostrano apporti
teutonici in Lombardia ed un'infusione di sangue slavo in Veneto. Tutta l'Italia
a sud dell'Appennino e tutte le isole adiacenti sono occupate da una razza
"mediterranea", di bassa statura, scura di pelle e con il viso lungo. Si tratta
dei "Meridionali", che discenderebbero dall'antica popolazione italica dei
Liguri, strettamente imparentati con gli Iberici della Spagna e i Berberi del
Nordafrica. Il principale etnologo italiano, Sergi, li fa derivare dal ceppo
amitico (v. Semitico-Amitico) del Nordafrica. Bisogna ricordare che gli
Amitici non sono negritici, né veri africani, sebbene si possa rintracciare un
apporto di sangue africano in alcune comunità in Sicilia e in Sardegna, oltre
che in Nordafrica. L'Ufficio dell'immigrazione pone gli Italiani settentrionali
nella divisione "celtica" e quelli meridionali in quella "iberica". La
commistione fra i due gruppi etnici è stata relativamente scarsa, anche se molti
Italiani settentrionali hanno doppiato gli Appennini ad est, facendo ingresso
nell'Italia centrale. Pertanto, la linea di demarcazione fra Emiliani e Toscani
è molto meno netta che fra Piemontesi e Genovesi. Un sociologo italiano,
Niceforo, ha indicato che questi due gruppi etnici differiscono profondamente
fra di loro, da un punto di vista sia fisico sia caratteriale. Egli descrive il
Meridionale come irritabile, impulsivo, molto fantasioso, testardo; un
individualista poco adattabile ad una società ben organizzata. Al contrario,
descrive il Settentrionale come distaccato, risoluto, paziente, pratico e capace
di grandi progressi nell'organizzazione politica e sociale della civiltà
moderna. Sia i Settentrionali sia i Meridionali sono dediti alla famiglia,
d'animo buono, religiosi, artistici ed industriosi. Sono quasi tutti di
religione cattolica. La maggior parte dell'immigrazione italiana negli Stati
Uniti è reclutata fra le classi contadine ed operaie. In America, tuttavia, essi
non hanno conseguito successo come agricoltori, con l'eccezione della
frutticoltura e dell'enologia, soprattutto in California, dove figurano ai primi
posti.
L'esperto di statistica italiano Bosco ammette che l'Italia è tuttora al primo
posto in termini di numero di reati contro la persona, anche se questi sono
diminuiti notevolmente in seguito al miglioramento del sistema di istruzione e
all'ampio flusso di emigrazione. Su questo versante l'Italia è seguita nella
graduatoria dall'Austria, dalla Francia e, a una certa distanza, dall'Irlanda,
la Germania, l'Inghilterra e la Scozia. Niceforo indica, sulla base dei dati
statistici italiani, che tutti i reati, soprattutto i crimini violenti, sono
molto più numerosi tra i Meridionali che tra i Settentrionali. Il gioco
d'azzardo è diffuso. Il gioco del lotto è un'istituzione nazionale che viene
utilizzata per alimentare le casse dello Stato. Il brigantaggio è ormai
pressoché estinto, fatta eccezione per alcune parti della Sicilia. Le
organizzazioni segrete come la Mafia e la Comorra [sic], istituzioni
molto influenti tra la popolazione che esercitano la giustizia in proprio e sono
responsabili di molta parte della criminalità, prosperano nell'Italia
meridionale. La maggiore difficoltà nella lotta alla criminalità sembra
risiedere nella propensione degli Italiani a non testimoniare contro alcuno in
tribunale e a riparare i torti ricorrendo alla vendetta (v. Còrsi).
E' indicativo il fatto che l'Italia sia uno dei paesi con il maggiore tasso di
analfabetismo in Europa. Nel 1901 il 48,3% della popolazione dai sei anni in su
non sapeva leggere e scrivere. In quell'anno in Calabria, la parte più
meridionale della penisola, il tasso di analfabetismo tra le persone dai sei
anni in su era pari al 78,7%. Il tasso di analfabetismo più basso si registra
nella valle del Po, nell'Italia settentrionale. I Lombardi e i Piemontesi sono
gli italiani più istruiti. La situazione è tuttavia migliorata dopo che il
governo ha reso l'istruzione gratuita e obbligatoria tra i 6 e i 9 anni nei
comuni dove vi erano le sole scuole elementari e dai 6 ai 12 anni nei comuni
dove erano presenti scuole di più alto grado.
Tra le classi più umili la povertà è estrema; le persone vivono in alloggi
miseri e hanno accesso a un'alimentazione carente, basata principalmente su
granoturco mal conservato. Perfino a Venezia sembra che un quarto della
popolazione viva ufficialmente di carità.
I confini geografici della razza italiana sono più ampi di quelli dell'Italia.
Gruppi numerosi sono presenti in paesi vicini come Francia, Svizzera ed Austria.
Le province del Tirolo e dell'Istria, in Austria, sono per un terzo italiane.
Ampi gruppi sono inoltre presenti nel Nuovo Mondo. L'Italia stessa è quasi
interamente italiana. Ha una popolazione di 34 milioni di persone e comprende
solo piccoli bacini di altre razze (circa 80.000 Francesi nell'Italia
nordoccidentale, 30.000 Slavi nell'Italia nordorientale, circa 30.000 Greci
nell'Italia meridionale, circa 90.000 Albanesi in Italia meridionale e in
Sicilia e 10.000 Catalani (Spagnoli) in Sardegna. Un certo numero di Tedeschi,
forse meno di 10.000, è presente nelle Alpi italiane. Circa due quinti della
popolazione dell'Italia si trovano nella valle del Po, ovvero in meno di un
terzo della lunghezza del paese. Suddivisa approssimativamente in compartimenti,
la popolazione di quest'area, occupata da Italiani settentrionali, conta circa
14 milioni di persone. Questa cifra include i Friulani dell'Italia nordorientale
i quali, pur parlando una lingua latina distinta dall'italiano, sono
difficilmente distinguibili dagli Italiani settentrionali. Il loro numero si
situerebbe, a seconda delle diverse stime, tra 50.000 e 450.000. La popolazione
dei distretti meridionali è di circa 19.750.000 persone, di cui 125.000
appartengono ad altre razze. La maggior parte degli Italiani della Francia,
della Svizzera e dell'Austria sono sul piano della razza Italiani
settentrionali. Quelli della Corsica, isola appartenente alla Francia, sono
Italiani meridionali.
Distribuzione degli Italiani (stima riferita al 1901)
In Europa:
Italia 33.200.000
Francia 350.000
Svizzera 200.000
Austria 650.000
Corsica 300.000
Altre parti d'Europa 300.000
Totale 35.000.000
Altrove:
Brasile 1.000.000
Rep. Argentina 620.000
Altre parti del Sudamerica 140.000
Stati Uniti 1.200.000
Africa 60.000
Totale 3.020.000
Totale nel mondo (cifra approssimata) 38.000.000
A partire dal 1900, in alcuni anni oltre mezzo milione di italiani è emigrato
nelle diverse regioni del mondo. All'incirca la metà di tale flusso ha come
destinazione altri paesi europei ed è di carattere temporaneo, in quanto
riguarda sopratutto la popolazione maschile. Dal 1899 fino a tutto il 1910
negli Stati Uniti sono stati ammessi 2.284.601 immigrati italiani, ed è stata
altresì consistente l'immigrazione italiana verso l'America del Sud. La maggior
parte delle persone che giunge negli Stati Uniti rientra successivamente in
patria. Tuttavia, soprattutto a New York e negli altri Stati dell'Est il numero
di coloro che rimangono è elevato. Nel 1907 gli immigrati provenienti
dall'Italia meridionale sono stati oltre 240.000, un numero più che doppio
rispetto alla razza di immigrazione che come consistenza si colloca subito dopo
quella degli immigrati italiani meridionali. Il numero degli arrivi di Italiani
settentrionali è solo un quinto di tale cifra. La notevole capacità della razza
italiana di popolare altre parti del mondo risulta evidente dal fatto che la
presenza italiana supera numericamente quella degli Spagnoli nell'Argentina
spagnola e dei Portoghesi in Brasile, nonostante quest'ultimo sia un paese
"portoghese". (vedi Ispanoamericani). Attualmente, ai fini dello
studio del fenomeno dell'immigrazione il flusso migratorio degli Italiani verso
gli Stati Uniti è forse il più significativo, e non solo perché risulta essere
molto più consistente di ogni altro gruppo nazionale in qualunque anno di
riferimento e perché è elevata la percentuale degli Italiani per ogni mille
immigranti che entra sul territorio degli Stati Uniti. Ancora più significativo
è il fatto che questa razza è più numerosa di qualsiasi altra tra la decina di
razze che figurano ai primi posti come tasso di immigrazione. In altre parole,
in virtù di una popolazione di 35.000.000 e di un elevato tasso di natalità,
questa razza continuerà a primeggiare anche quando la spinta delle altre razze,
attualmente responsabili dell'ondata di immigrazione, tra cui gli Ebrei (8.000-
000[sic]), gli Slovacchi (2.250.000) e il gruppo Sloveno-Croato (3.600.000),
sarà esaurita, come di fatto sta già avvenendo per gli Irlandesi. Un fatto non
necessariamente noto è che nel decennio 1891-1900 l'Italia era il principale
paese di origine dell'immigrazione in America. All'inizio degli anni ottanta,
ovvero quasi trent'anni fa, l'Italia aveva già cominciato a guadagnare terreno
rispetto ai paesi dell'Europa settentrionale. Tuttavia bisognava attendere il
1890 per vedere gli Stati Uniti sorpassare l'America meridionale come
destinazione privilegiata dei flussi migratori provenienti dall'Italia. Nel
decennio precedente e nei periodi antecedenti il Brasile ha accolto più italiani
della Repubblica Argentina, sebbene si ritenga erroneamente che sia quest'ultima
ad ospitare la più grande comunità italiana dell'America meridionale. Nel 1907
gli Stati Uniti hanno accolto 294.000 dei 415.000 Italiani emigrati oltreoceano.
Nello stesso anno le persone emigrate, per lo più temporaneamente, dall'Italia
verso altri paesi europei sono state 288.774. L'immigrazione italiana negli
Stati Uniti è stata finora prevalentemente di carattere temporaneo. Mosso
calcola che il periodo medio di permanenza degli Italiani negli Stati Uniti sia
di otto anni. L'emigrazione più consistente verso oltreoceano dall'Italia ha la
sua origine nelle regioni a sud di Roma, abitate dagli Italiani meridionali. Gli
emigrati provengono soprattutto dalla Sicilia e dalla Calabria, ovvero dai
territori meno produttivi e meno sviluppati del paese. L'emigrazione dalla
Sardegna (Vedi) è scarsa. Il compartimento della Liguria, territorio di
provenienza dei Genovesi, anch'essi appartenenti alla razza degli Italiani
meridionali, registra più emigrazione di qualsiasi altra provincia dell'Italia
settentrionale. Il flusso complessivo dell'immigrazione verso l'America da
alcuni compartimenti italiani ha raggiunto proporzioni ingenti, al punto da
superare più volte il tasso di crescita naturale della popolazione. Questo ha
già causato il parziale spopolamento di alcuni distretti agricoli. Se
confrontati con altre razze di immigrati e con il numero assoluto degli arrivi,
gli Italiani meridionali sono i più numerosi: 1.911.933 nei dodici anni compresi
tra il 1899 e il 1910, seguiti dagli Ebrei, 1.074.442, dai Polacchi, 949.064,
dai Tedeschi, 754.375 e dagli Scandinavi, 586.306. I Settentrionali sono al
nono posto nell'elenco relativo allo stesso periodo: 372.668, subito dopo gli
Inglesi e gli Slovacchi, ma prima dei Magiari, dei Croati e degli Sloveni e dei
Greci. Per quanto riguarda il tasso del movimento transatlantico, è piuttosto
evidente un contrasto tra Settentrionali e Meridionali: ad esempio, nel 1905
l'emigrazione dalla Calabria è stata undici volte maggiore di quella proveniente
dal Veneto. Nel 1907 l'indice dello spostamento dei Settentrionali verso gli
Stati Uniti è stato di circa il 3 per 1000 della relativa popolazione presente
in Italia, mentre quello degli Italiani meridionali è stato del 12 per 1000.
L'indice di movimento dei Settentrionali è stato più o meno lo stesso di quello
degli Svedesi e dei Finlandesi, è stato il triplo di quello dei Tedeschi, ma
solo la metà di quello dei Ruteni provenienti dall'Austria-Ungheria. Il tasso di
movimento dei Meridionali verso gli Stati Uniti, d'altra parte, è superato solo
dal gruppo Croato-Sloveno, che nel 1907 è stato del 13 per mille della
popolazione, e dagli Ebrei e dagli Slovacchi che, nello stesso anno, è stato del
18 per mille della popolazione. Gli immigrati italiani giungono negli Stati
Uniti, oltre che dall'Italia, principalmente dai seguenti paesi: il Nordamerica
britannico (3.800 nel 1907), l'Austria-Ungheria (1.500), il Regno Unito (600),
il Sudamerica (600) e la Svizzera (200). Quelli provenienti dalla Svizzera e
dall'Austria-Ungheria generalmente sono Settentrionali.
Nei dodici anni tra il 1899 e il 1910, le principali destinazioni negli Stati
Uniti dei due gruppi di Italiani sono state le seguenti:
Settentrionali
New York 94.458
Pennsylvania 59.627
California 50.156
Illinois 33.525
Massachusetts 22.062
Connecticut 13.391
Michigan 13.355
New Jersey 12.013
Colorado 9.254
Meridionali
New York 898.655
Pennsylvania 369.573
Massachusetts 132.820
New Jersey 106.667
Illinois 77.724
Connecticut 64.530
Ohio 53.012
Louisiana 31.394
Rhode Island 30.182
West Virginia 23.865
Michigan 15.570
California 15.018
Una poesia per i pataccari di sinistra,
scrive “L’Anarca” (Giampaolo Rossi ) su “Il Giornale”. I discepoli intellettuali
del politically correct hanno l’abitudine di prendersi troppo sul serio; succede
sopratutto quando si cimentano nel nobile mestiere dell’impegno sociale mettendo
la loro fama e la loro arte a disposizione della lotta all’oscurantismo
reazionario. È successo anche a Elio Germano, l’attore militante che ha
realizzato il video-patacca contro il razzismo di cui abbiamo denunciato il
falso in questo articolo di ieri. Il video si conclude con l’attore che legge,
ad un gruppo di bambini Rom visibilmente annoiati e usati come scudi della sua
vanità ideologica, una poesia di Trilussa in romanesco. Per non essere da
meno, ho deciso di scrivere una poesia anche io, proprio nel dialetto di
Trilussa, dedicandola a Elio Germano, ai maestrini radical-chic e alle loro
false “verità assolute” diffuse come un virus. Un piccolo omaggio ironico
all’abitudine pataccara della sinistra intellettuale e artistica di spargere
scemenze spacciandole per verità.
L’ARTISTA DE SINISTRA
Il razzismo, se sa, è brutta robba.
È segno de incivile intolleranza tipica de chi ragiona co’ la panza.
Ma, di certo, ‘na cosa assai più brutta
è l’intellettuale quanno rutta.
Quanno se erge cor dito moralista
e come er Padreterno,
dei buoni e dei cattivi fa la lista.
Filosofo o scrittore, poeta o cantautore, attore o saltimbanco,
è come se la storia s’inchinasse all’astio livoroso e intelligente
de chi se crede sempre er più sapiente.
Spesso nun sa manco de che parla, ma parla per parla’
e per l’impegno preso e coltivato con lo sdegno
de chi è convinto che deve lascià un segno.
L’artista de sinistra in tracotanza,
dall’alto del suo ego trasformato,
diventa un drogato de arroganza.
Lui se convince de esse come un Faro,
invece, spesso, è solo un gran Cazzaro.
Con gli islamisti non si può dialogare.
Un cosa è combattere militarmente il terrorismo per ragioni di sicurezza;
un'altra è venire politicamente a patti con una teocrazia, scrive Piero
Ostellino su “Il Giornale”. Rispetto al fondamentalismo islamico, e all'esigenza
di conviverci senza danni per noi, alcuni studiosi americani suggeriscono che
l'Occidente prenda ad esempio la propria storia degli ultimi cinquecento anni.
Gli Asburgo, la maggior dinastia europea, «erano dei principi - scrive John M.
Owen in Confronting political Islam, Six lessons from the West's Past - non dei
preti». E si comportarono di conseguenza. Di fronte al radicalismo genericamente
anticattolico del protestantesimo, non fecero di ogni erba un fascio,
confondendo eretici estremisti ed eretici moderati e trattandoli allo stesso
modo, ma constatarono che il protestantesimo era diviso fin dalla nascita in
varie fazioni - luterani, calvinisti, anabattisti - e si acconciarono a
sfruttarne le divisioni. Fu un grosso rischio? L'approccio non era meno
rischioso di quello di fare la faccia feroce ad entrambi, ma ha funzionato.
Parimenti, nel XX secolo, gli Stati Uniti dovettero fronteggiare la moderna
sinistra politica, ostile alla democrazia liberale, al capitalismo e al libero
mercato. Ma non la considerarono, e per lo più non la trattarono, come faceva la
destra, come fosse un monolite, bensì utilizzarono ciò che divideva i socialisti
dai comunisti. E hanno avuto la meglio sul comunismo. L'islamismo moderato - a
differenza di quello fondamentalista, che ricorre volentieri alla violenza -
utilizza i mezzi pacifici e legali della democrazia liberale per diffondere la
sharia, la morale islamica. Non è liberale, ma rimane una teocrazia che ha fatto
una scelta strategica contro la violenza. Ciò non significa, ovviamente, che
l'Occidente possa, e debba, instaurare con esso «un dialogo», come suggeriscono
certe nostre anime belle. La stessa storia della cooperazione fra gli Asburgo,
cattolici, e i protestanti contro i calvinisti insegna che distinguere fra
fondamentalisti e moderati non è sempre facile e, se può rivelarsi positivo nel
breve termine, minaccia di essere fallimentare nel lungo. La prudenza non è mai
troppa. Un cosa è combattere militarmente il terrorismo per ragioni di
sicurezza; un'altra è venire politicamente a patti con una teocrazia; che,
rispetto alla democrazia liberale, rimane pur sempre una soluzione clericale.
Forse, c'è un altro esempio che l'Occidente dovrebbe seguire: quello di Edmund
Burke, il liberal-conservatore che difese il diritto delle colonie americane di
tassare i propri cittadini solo secondo i dettami delle proprie assemblee e non
secondo quelli del Parlamento di Londra. «I vostri affari - aveva scritto Burke
ai suoi amici francesi a proposito della Rivoluzione del 1789 - riguardano voi
soli; noi ce ne siamo occupati come uomini, ma ce ne teniamo alla larga perché
non siamo cittadini della Francia». È il linguaggio che, auspicabilmente,
l'Occidente dovrebbe usare nei confronti dell'islamismo...
Niente paura, leggete il Corano. Ci troverete le radici del Male.
Per 56 anni ho creduto che l'islam potesse essere riformabile grazie a musulmani
moderati come me. Mi sbagliavo. Il libro sacro è la negazione della civiltà,
scrive Magdi Cristiano Allam su “Il Giornale”. «Allah Akhbar! Allah Akhbar!
Ash-hadu an-la ilaha illa Allah, Ash-hadu anna Muhammad-Rasul Allah». «Allah è
Grande! Allah è Grande! Testimonio che non c'è altro dio all'infuori di Allah,
Testimonio che Maometto è il Messaggero di Allah». Per vent'anni la mia giornata
è stata cadenzata dall'adhan, l'appello alla preghiera diffuso dall'alto dei
minareti nella mia città natale, Il Cairo, ribattezzata la «Città dai mille
minareti». Per 56 anni mi sono impegnato più di altri, da musulmano moderato, ad
affermare un «islam moderato» in Italia, aderendo e sostenendo sostanzialmente
la tesi del Corano «creato», che per l'ortodossia islamica pecca ahimè di una
fragilità teologica che scade nell'eresia. Perché così come il cristianesimo è
la religione del Dio che si è fatto Uomo e che s'incarna in Gesù, l'islam è la
religione del loro dio Allah che si è fatto testo e che si «incarta» nel Corano
dopo essere stato rivelato a Maometto attraverso l'Arcangelo Gabriele. Per i
musulmani quindi il Corano è Allah stesso, è della stessa sostanza di Allah,
opera increata al pari di Allah, a cui ci si sottomette e che non si può
interpretare perché si metterebbe in discussione Allah stesso. Per contro, la
tesi del Corano «creato», che sottintende che solo Allah è increato, consente
l'uso della ragione per entrare nel merito dei contenuti del Corano, che possono
essere oggetto di culto da parte della fede ma anche oggetto di valutazione e
critica; così come consente la contestualizzazione nel tempo e nello spazio dei
versetti rivelati per distinguere ciò che è da considerarsi attuale e lecito da
ciò che è invece è da ritenersi prescritto e caduco; ci mette in ultima istanza
nella possibilità di poter affermare la dimensione «plurale» dell'islam e, in
questo contesto di pluralismo, ci consente di far primeggiare la scelta
dell'«islam moderato» che concili la prescrizione coranica con il rispetto dei
valori fondanti della nostra comune umanità. Per 56 anni ho scelto di battermi
in prima persona, costi quel che costi, per affermare la bontà del Corano quale
testo sacro dell'islam pur nella denuncia del terrorismo islamico. Nel 2003,
dopo aver conosciuto Oriana Fallaci ed aver instaurato con lei un rapporto che,
al di là della reciproca stima professionale, della condivisione della denuncia
del terrorismo islamico e della pavidità dell'Occidente, si fondava su un
affetto sincero e una solida amicizia, tuttavia il nostro rapporto fu turbato
dal mio rifiuto di abbandonare l'islam e di concepire che la radice dell'islam
risieda nel Corano. Mi sentivo contrariato quando scriveva: «L'islam è il
Corano, cari miei. Comunque e dovunque. E il Corano è incompatibile con la
Libertà, è incompatibile con la Democrazia, è incompatibile con i Diritti Umani.
È incompatibile col concetto di civiltà». Eppure, all'indomani della mia
conversione al cristianesimo il 22 marzo 2008, ho scritto: «Ho dovuto prendere
atto che, al di là della contingenza che registra il sopravvento del fenomeno
degli estremisti e del terrorismo islamico a livello mondiale, la radice del
male è insita in un islam che è fisiologicamente violento e storicamente
conflittuale». L'errore in cui incorsi fu di immaginare che l'islam potesse
essere riformabile al suo interno grazie all'impegno dei musulmani moderati.
Alla fine, dopo oltre cinque anni trascorsi da condannato a morte dai terroristi
islamici e reiteratamente minacciato dagli estremisti islamici, mi sono arreso
di fronte all'evidenza: si può essere musulmani moderati come persone, ma non
esiste un islam moderato come religione. Oggi più che mai dobbiamo avere l'acume
intellettuale e il coraggio umano di leggere ad alta voce il Corano e di
affermare pubblicamente i suoi contenuti. Non possiamo essere vittime, da un
lato, dei musulmani moderati che difendono aprioristicamente e acriticamente
l'islam pur di salvaguardare la loro credibilità ed onorabilità, dall'altro,
degli occidentali che per paura di offendere i musulmani sostengono in modo
altrettanto aprioristico e acritico che il Corano insegna l'amore e la pace, che
i terroristi islamici non centrano nulla con l'islam. Solo leggendo il Corano
scopriamo la specificità di una religione che condanna di eresia l'ebraismo e il
cristianesimo; la realtà di Allah che era il dio supremo del Pantheon politeista
arabo, clemente e misericordioso con chi si sottomette all'islam ma vendicativo
e violento con i miscredenti; la verità di Maometto che è stato un guerriero
vittorioso che ha fondato una «Nazione di credenti» combattendo e uccidendo i
suoi nemici per ordine di Allah. Solo leggendo il Corano potremo capire le
radici di un'ideologia che legittima l'odio, la violenza e la morte, che ispira
il terrorismo islamico ma anche la dissimulazione praticata dai «musulmani
moderati», perseguendo il comune obiettivo di sottomettere l'intera umanità
all'islam, che è fisiologicamente incompatibile con la nostra civiltà laica e
liberale negando la sacralità della vita di tutti, la pari dignità tra uomo e
donna, la libertà di scelta. Solo leggendo il Corano potremo capire chi siamo
veramente noi, se siamo ancora o non più in grado di riscattare la civiltà di
verità e libertà, di fede e ragione, di valori e regole. L'Italia non ha subito
gravi attacchi dal terrorismo islamista, ma non può considerarsi al sicuro se si
tiene conto che da anni diversi imam predicano odio, dozzine di centri islamici
sono impegnati nel proselitismo e nel finanziamento a gruppi terroristici e che
il Paese sta esportando combattenti nei teatri della jihad. Lo rileva un
rapporto del Centro militare di studi strategici del ministero della Difesa. La
comunità islamica italiana è composta da 1,6 milioni di persone, un terzo degli
stranieri presenti, cui si aggiungono 60-70mila convertiti. Sono una ventina le
organizzazioni principali, più di 100 le moschee, 159 i centri islamici, decine
le scuole coraniche, tanti i siti internet. Secondo il dossier, «la
radicalizzazione della comunità islamica rappresenta una potenziale seria
minaccia». Dal 2001 ad oggi, circa 200 persone sono state arrestate con l'accusa
di terrorismo. Milano è l'epicentro del radicalismo islamico in Italia.
Ecco l'Italia che trasforma il Tricolore in uno straccio.
La bandiera nazionale va esposta per legge davanti a scuole e uffici pubblici.
Ma nessuno se ne cura. E lo spettacolo è avvilente, scrive Nino Materi su “Il
Giornale”. L'Italia è l'unico Paese al mondo in cui la Bandiera nazionale,
invece che garrire al vento, rantola in aria. Come un impiccato sul pennone più
alto. Tanto in alto che nessuno si premura di prendersene cura. Triste,
tristissima la vita del nostro glorioso Tricolore: tradizionale simbolo di
(dis)amor di Patria. Un vessillo di cui ci ricordiamo solo in occasione dei
Mondiali di calcio, almeno quelli in cui gli Azzurri non fanno figuracce. Ma poi
nella vita di tutti i giorni il vessillo Bianco, Rosso e Verde tende a virare in
commedia, assumendo i toni del bianco, rosso e verdone. Un film tragicomico (più
tragico che comico) che va «in onda» quotidianamente su ogni edificio pubblico:
scuole, biblioteche e uffici. Da Nord a Sud l'Unità d'Italia è fatta, ma si
incarna in quel pezzo di stoffa che viene vergognosamente esposto alla stregua
di uno straccio con cui si è appena smesso di fare le pulizie. E dire che nella
Costituzione figura un preciso dettato normativo sancito dalla Legge 5-02-1998
n.22 e dal Dpr 07-04-2000 n. 121, il cui capo IV (punto 9) recita testualmente:
«Le Bandiere vanno esposte in buono stato e correttamente dispiegate». Roba che
se la violazione venisse effettivamente perseguita, dovrebbe essere denunciata
la maggior parte dei funzionari statali. Non fanno eccezione neppure gli edifici
sedi di istituzioni «prestigiose» come prefetture, questure, tribunali. Ma anche
qui il Tricolore sventolante appare in salute come un moribondo. Non c'è
spettacolo più avvilente per un cittadino orgoglioso di essere italiano che
vedere la Bandiera della propria nazione ansimare sporca e stracciata. Fateci
caso. Quando entrate in un ufficio alzate lo sguardo e, nove volte su dieci,
sulla vostra testa vedrete curvo su se stesso un Tricolore sdrucito e sozzo.
Nessun direttore, funzionario, dirigente, impiegato, segretario (fin giù a
all'ultimo degli inservienti) che si ponga il problema non dico di lavare una
bandiera annerita o sostituirne una a brandelli. No. Si cambiano con periodica
perizia le merendine dalle macchinette degli uffici, ma del Tricolore non frega
nulla a nessuno. Lui può morire d'inedia nell'indifferenza generale. Beh, quasi
generale. Considerato che, almeno una persona, ha deciso di levare un urlo di
dolore in difesa di un simbolo per il quale sono morti migliaia di soldati. Si
tratta del Maggiore Gennaro Finizio, dell'Unuci (Unione ufficiali in congedo)
che in una lettera aperta al sito Basilicata24 denuncia lo scandalo-Bandiera:
«Se si vuol valutare l'orgoglio di un Popolo e pesarne il livello di diffusione
e condivisione del concetto di identità nazionale, è sufficiente osservare se,
ed in quale modo, espone la propria Bandiera; nel nostro caso, il Tricolore.
Ebbene, le condizioni in cui sono esposte le nostre Bandiere, sulle facciate
degli edifici pubblici e sedi di Istituzioni, riflettono chiaramente il livello
di crisi sociale e di sfiducia, segnalando la dimensione di un Paese che ha
perso i suoi punti di riferimento; un Paese impoverito nei Valori». Chi disonora
il Tricolore, infanga la propria Storia. E poi: «Non sfuggirà, all'osservatore
attento, che un po' ovunque sono presenti Tricolori laceri, sporchi e, nella
migliore delle situazioni, esposti in modo errato; Bandiere offese
indecorosamente sino al punto da sembrare private della forza di sventolare.
Come si legge questo degrado sociale? Abbiamo, forse, perso la nostra dignità e
la volontà di sentirci orgogliosamente italiani? Forse non crediamo più nel
nostro simbolo, perché derubricato a semplice icona della Nazionale di calcio?».
Il Maggiore Finizio prova anche a dare delle risposte: «Temo che tutto questo
sia da ascrivere a semplice, ma deleteria, incuria e mancanza di sensibilità.
Quella stessa sensibilità che troviamo ad esempio negli statunitensi, negli
inglesi, francesi e tedeschi». Da noi, invece, fino a qualche tempo fa, l'ex
leader della Lega poteva impunemente urlare in piazza contro una signora che
esponeva il Tricolore alla finestra: «Signora, con quella bandiera può anche
pulirsi il culo...».
Un Paese invivibile, scrive Livio
Caputo su “Il Giornale”. Nei due mesi scorsi mi sono dedicato a un esercizio che
si è rivelato molto deprimente: ho chiesto a cinquanta amici e conoscenti quanti
di loro avessero subito, negli ultimi tre anni, scippi, furti in casa o in
strada, truffe, vandalismi, violenze,richieste di pizzi o tangenti, o altri
“attacchi” da parte dei vari tipi di delinquenza, organizzata e non. Ebbene, il
risultato è stato 47, cioè quasi il 95 cento. Tra i racconti che ho raccolto
c’era di tutto e di più, perfino quello di due sedicenti dipendenti comunali che
si sono introdotti con un pretesto nell’abitazione di una signora e, forse
ipnotizzandola, forse drogandola, l’hanno persuasa a consegnare “spontaneamente”
tutti i suoi preziosi. Comunque, il campionario dei reati subiti, che peraltro
avrei potuto mettere insieme anche compulsando attentamente la cronaca nera dei
giornali, era talmente vario da poterci scrivere un trattato di criminologia.
L’impressione complessiva, comunque, era che il Paese, nonostante le statistiche
che danno un certo numero di reati in calo, sia sempre più fuori controllo e
che un senso di insicurezza si sia ormai impadronito della maggioranza dei
cittadini. Un altro dato inquietante emerso dalla mia indagine è che buona parte
delle vittime ha ormai rinunciato a denunciare i reati subiti se non ci sono
esigenze assicurative di mezzo. Che senso, infatti, ha perdere tempo a
denunciare il furto di una bicicletta, lo scippo subito in un parco, una casa
svuotata dagli zingari, quando le possibilità di recuperare la refurtiva sono
pari a zero? E, comunque, che soddisfazione ricava il cittadino se l’autore del
reato, nell’ipotesi remota che venga individuato e arrestato, viene poi subito
messo in libertà, libero di reiterare il suo crimine anche l’indomani? O, se
anche viene processato, se la cava con pene lievi con la condizionale, o esce
comunque di galera assai prima di quanto dovrebbe per condoni, buona condotta,
eccessivo affollamento delle carceri o quant’altro? Una delle mie interlocutrici
si è particolarmente infuriata leggendo che una donna rom che l’aveva derubata è
stata arrestata – mi pare – una dozzina di volte e sempre rilasciata. In
effetti, una delle cause principali per cui non solo aumenta la delinquenza
nazionale, ma bande di ladri, rapinatori e scassinatori arrivano da ogni parte
d’Europa per operare nel nostro Paese è la quasi impunità di cui, alla
fine, finiscono di godere. Come reagiamo di fronte a questi fenomeni, che ci
rendono tutti più timorosi e insicuri? Riducendo i mezzi a disposizione delle
forze dell’ordine, abbastanza numerose se confrontate con quelle degli altri
grandi Paesi occidentali, ma spesso impegnate in altre funzioni, come le scorte
a politici, ex politici e compagnia cantante, che li distolgono dai loro compiti
primari. Depenalizzando una serie di reati cosiddetti minori, che in realtà
colpiscono la cittadinanza nella sua esistenza quotidiana anche peggio di altri.
Svuotando periodicamente le carceri perché eccessivamente affollate e non in
grado di garantire i diritti dei detenuti, invece di costruirne di nuove o
utilizzando quelle già esistenti, ma lasciate vuote per carenza di guardie
penitenziarie. Tenendoci gli innumerevoli stranieri che delinquono (la loro
percentuale tra i detenuti è molto superiore a quella degli italiani) invece di
espellerli appena espiata la pena. Se la percentuale di cittadini carcerati
rispetto alla popolazione è metà di quella della Francia e della Gran Bretagna e
addirittura un decimo di quella degli Stati Uniti non ci si può poi meravigliare
se il tasso di delinquenza, denunciata e non denunciata, è così alto. Un altro
scandalo è quello dello scarsissimo numero di cosiddetti colletti bianchi, e in
particolare di esponenti di rilievo della burocrazia e della finanza, anche
accusati di reati infamanti, di furti e truffe milionari o di reati
particolarmente dannosi per la comunità che finiscono effettivamente in galera.
Tra appelli, prescrizioni, condoni, sono pochissimi, e nei (rari) casi in cui
ciò avviene fa addirittura notizia. La maggior parte, anche se, sulla carta,
condannata ad anni di reclusione, continua a godersi la vita in perfetta
libertà, con un effetto negativo sulla credibilità della giustizia, specie tra i
giovani, che può riuscire devastante. La durata infinita dei processi, e i mille
cavilli che la nostra legislazione consente di usare agli avvocati difensori,
non fanno che rendere la situazione ancora più insostenibile. Potrei continuare
per pagine e pagine, riprendendo episodi incredibili che si incontrano quasi
ogni giorno sui giornali, ma sarebbe superfluo. La conclusione sarebbe comunque
la stessa, che la qualità della vita dei cittadini onesti va continuamente
peggiorando. Ricordo che, ormai molti anni fa, un mio amico inglese,
corrispondente di un grande giornale da Roma, soleva dirmi:”Il vostro è il Paese
in cui si vive meglio in Europa, basta non avere a che fare con l’autorità
(intendendo fisco, burocrazia, vigili, tribuanli, ecc.). Oggi non è più vero.
Bisogna aggiungere “….se si ha la fortuna, sempre più rara, di non imbattersi in
qualche malfattore”.
I nuovi mostri dei Soliti Idioti "L'Italia? Un inferno da
ridere". Biggio e Mandelli rivisitano Dante nel film:
«Abbiamo raccontato con affetto le deformità di ciascuno di noi», scrive Cinzia
Romani su “Il Giornale”. Nati non foste a viver come bruti. Lo rammentano i
Soliti Idioti con la rappresentazione plastica degli abominevoli peccati
italiani al giorno d'oggi. Tipo abbruttirsi al bar alle otto di mattina,
uccidere per questioni di traffico all'ora di punta, travolgere gli altri al
supermercato, stare sempre connessi o farsi irretire dalla pubblicità invasiva.
Per forza, poi, ci vuole il Ministero della Bruttezza a dirimere le controversie
dei consumatori di laidume. Così col loro terzo film, La solita Commedia.
Inferno (da giovedì in sala), Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli puntano alla
versione 2.0 de I nuovi mostri , accatastando sketch e personaggi come in pista
sul web, dal quale provengono. Pur essendo relativamente giovani (Biggio è
classe '74, Mandelli è del '79), gli infernali registi, qui in tandem con
Martino Ferro, nonché protagonisti e sceneggiatori d'un racconto corale,
rimpiangono il passato. Quando si usava il telefono a gettoni, come fa Minosse
(Mandelli) per chiamare il suo superiore, un Dio che tracanna whiskey e fuma. O
quando si picchiavano i tasti della macchina per scrivere, come fa un tenente
(Biggio), pronto a scagionare due poliziotti dal reato di abuso di potere nei
confronti d'una macchinetta che non dà resto. Perché prima era tutto più bello,
ancora non ci aveva invasi la Grande Bruttezza: altro che Isis. Siamo dalle
parti della surrealtà più dichiarata, con tanti attori che interpretano dai 21
ai 7 ruoli a testa per raccontare una società malata. E c'è pure Tea Falco, già
musa di Bertolucci, nei panni d'un Gesù tosto, quando sequestra a un precario di
nome Virgilio (ancora Biggio) i suoi attributi. Che riavrà se accompagnerà Dante
(ancora Mandelli) a catalogare i nuovi peccati commessi sulla terra,
segnatamente a Milano, postaccio caotico zeppo di hackers, pornomani e
tecno-incontinenti. «Volevamo raccontare con affetto l'Italia e gli italiani. E
la mostruosità di ognuno di noi, guardando a I nuovi mostri », dice Biggio.
Ironia a parte, alcune categorie vengono prese di petto. Quella dei poliziotti,
per esempio, raffigurati come paranoici violenti. Diverte l'interrogatorio stile
Csi della macchinetta del caffè, rea di non rendere gli spicci ai piedipiatti,
ma fa pensare a un certo tipo di giudizio. «Ci piace provocare e dar fastidio,
però non vogliamo descrivere tutta la polizia così. Come ci piace l'idea d'un
Dio indaffarato nei suoi casini. Il nostro padre Pio, non me ne voglia
Castellitto, è il migliore. Non temiamo le risposte dei cattolici», spiega
Mandelli. E in effetti, l'idea d'intruppare i santi in una specie di Camera, a
decidere come procedere per catalogare nuovi peccati terreni, non è male. «Ci
piace forzare il pubblico, vedere come rispondono i cattolici», butta lì Biggio.
Di sicuro, il duo comico è maturato e cerca un nuovo sbocco. «Ci avevano
proposto di fare il terzo film dei Soliti idioti , ma ci siamo messi alla prova
con una cosa diversa. Chi fa il nostro mestiere, cerca sempre di uscire dalla
zona comfort. Come abbiamo fatto a Sanremo: stare su quel palco, è stata una
sfida», puntualizza Mandelli. Colpisce, a ogni modo, che per smarcarsi
dall'ennesima commedia all'italiana, i Soliti Idioti abbiano realizzato un'idea
semplice e geniale: sciorinare i più brutti vezzi italioti contemporanei, in
stile Nanni Loy, dopo aver riferito tic e nevrosi del Bel Paese nei loro lavori
precedenti. È andato in questo senso pure Maccio Capatonda con Italiano medio e
non a caso il duo pensa a una collaborazione col comico abruzzese. Costato 3
milioni e finanziato pure dalla Film Commission del Lazio (la maggior parte
delle scene, tuttavia, si svolge a Milano),il film è prodotto dalla Wildside di
Mario Gianani, marito della Madia e di Lorenzo Mieli, figlio di Paolo. E non a
caso il Ministero della Bruttezza Biggio&Mandelli lo affiderebbero «a Gasparri,
Alfano e Salvini», che non è gente di sinistra.
L’italiano medio è volgare e squallido, ma diverte.
La recensione di Marita Toniolo su “Best Movie”. Sbarca al cinema
l’opera prima del comico Maccio Capatonda, che vuole farci ridere e vergognare
di come siamo diventati. Dopo i successi stratosferici di Zalone al botteghino,
si torna a puntare forte su un volto “televisivo” con Maccio Capatonda
e il suo Italiano medio, prossimo a sbarcare al cinema con 400 copie al
suo esordio (il 29 gennaio). Maccio Capatonda, al secolo Marcello Macchia, è un
fenomeno di culto del web amatissimo dai cinefili grazie ai suoi trailer
parodia: un centinaio di secondi e poco più in cui Capatonda riesce a comprimere
mirabilmente genio e follia, cinefilia e non-sense, giochi di parole e
travestimenti, raggiungendo una popolarità che lo ha portato a sbarcare anche su
MTV con la serie Mario. Lo attendeva al varco la sfida più
tosta: il lungometraggio. Riuscire a essere altrettanto esplosivo in un tempo
dilatato. Italiano medio, diretto, scritto e interpretato da Maccio, è infatti
lo sviluppo del finto trailer di Limitless con Bradley Cooper:
due minuti, in cui era un uomo intelligente e socialmente responsabile, che
assumeva una pillola che gli cambiava totalmente la vita. Parodisticamente,
rispetto alla Lucy di Besson che si ritrova ad avere a disposizione il 100% del
cervello, Maccio deve capire cosa riuscire a fare con solo il 2%… E proprio da
questa domanda prende il via il racconto. Giulio Verme è il
perfetto emblema dell’uomo socialmente impegnato: allergico alla televisione sin
da bambino, avverso a ogni massificazione, vegano convinto, sempre pronto ad
aiutare gli emarginati, con la fissa per l’ambiente e le scelte etiche ed
ecosostenibili. Addetto allo smistamento dei rifiuti a Milano, cerca di
inculcare un po’ di senso civico nei colleghi, che gli rispondono a suon di
scoregge. La radicalità delle sue scelte finisce per creare un muro tra lui e le
persone che lo circondano: i genitori in primis, gli amici, i vicini e persino
la fidanzata Franca, esasperata dal suo atteggiamento da uomo frustrato e
ostile, ma fondamentalmente passivo. Giulio si ritrova isolato e disperato,
sopraffatto dal “lerciume” che lo circonda, sempre più nevrotico e ansioso.
Finché nella sua vita non approda l’amico Alfonzo, un ex
compagno antipatico delle elementari che gli offre una pillola
straordinaria, che gli permetterà di usare solo il 2% del cervello,
invece che il 20%. La metamorfosi sarà da Dottor Jekyll e Mr Hyde:
da attivista rompiscatole e fanatico, Giulio diventerà un tronista beota con il
mantra fisso dello “scopare”, della disco e del lusso cafonal, volgare e
ignorante, carnivoro e menefreghista, guadagnandosi – impresa becera dopo
l’altra – il diritto alla partecipazione al reality show più di culto del
momento. L’apoteosi dell’italiano medio. Capatonda ha messo tutto se stesso in
questa opera prima e il primo punto a favore gli deriva dall’enorme cura del
dettaglio che il film mostra. Nulla è lasciato al caso, a partire dagli
esilaranti titoli di testa (Tratto da una storia finta), che
fanno partire in quinta il film e che denunciano da subito il pedigree cinefilo
dell’autore. Che ha di fatto disseminato tutto il film citazioni filmiche facili
da riconoscere via via. Tuttavia, il triplo salto carpiato dai video di 1/2
minuti al lungo di 100 equivalgono a passare dallo sguazzare in una piscina a
nuotare nell’oceano. C’è un traccia coerente di fondo, ma i raccordi tra una
scena comica e l’altra si stiracchiano troppo, portando con sé come conseguenza
negativa la reiterazione di situazioni e tormentoni per allungare il brodo (amechemmenefregame,
Sant’Iddio, Scopare…). Raccontare una metamorfosi in un video di 130
secondi risulta efficace, dilatarla con un continuo sdoppiamento di personalità
ed esplicitando la lotta interiore sempre più opprimente che Verme si ritrova a
combattere tra i suoi istinti primari da bifolco e gli intenti nobili, produce
l’effetto di frammenti anche geniali, ma non ben incollati in un mosaico
coerente. Se la struttura narrativa è il punto debole più evidente di
Italiano medio, va invece segnalata – come altro punto a suo favore –
il peso specifico delle riflessioni, per nulla superficiali. Lo sguardo di
Maccio sull’Italia e i suoi concittadini è amaro e disilluso, quasi crudele. Con
un disgusto e un disprezzo maggiore di quello dello storico Fantozzi
verso l’impiegato piccolo piccolo, Maccio non risparmia colpi a colti e
ignoranti, ricchi e poveri, impegnati e menefreghisti. Giulio Verme sdoppiato
sintetizza le sublimi vette dell’arte del compromesso toccate
dell’italiano, capace di essere vegano e mangiare il pollo fritto; andare in
chiesa e avere mogli e amanti; difendere il bio e inquinare. Opposti
apparentemente inconciliabili, che – come vedremo nel finale – invece, per gli
abitanti del Bel Paese sono assolutamente ricomponibili, abituati come siamo ad
accettare obbrobri edilizi che radono al suolo parchi bio, scandali
sexual-politici, indecenze cultural-mediatiche dei reality (memorabili lo
scandalo del bianchino nel privè, che ha portato all’esclusione di Kevin, e la
“prova pippotto”), come se fossero parte integrante e inalienabile del sistema.
Maccio non ce le manda a dire, ma stigmatizza tutti i nostri vizi,
costringendoci a ridere (amaramente) di essi. Come sempre, è circondato dai
soliti attori fidati: l’inseparabile Herbert Ballerina, che si
trasforma in tre personaggi diversi; Rupert Sciamenna,
imprenditore squalo con i capelli rosa; Ivo Avido, anche lui
triplice. Molti i colleghi che si sono prestati per differenti camei: lo
Zoo di 105, Raul Cremona, Andrea
Scanzi, Pierluigi Pardo e il principe assoluto del non
sense Nino Frassica. L’impiego degli stessi attori in più ruoli
e con costumi diversi, pur se giustificato dal surrealismo che ìmpera, genera
spesso un effetto cabaret innestato nel cinema che non giova alla dimensione
estetica del film. Sebbene gli vada anche riconosciuta una fotografia curata (di
Massimo Schiavon), che alterna colori diversi quando la personalità di Giulio
cambia, non abbiamo sempre la sensazione di trovarci di fronte a un film
tout court, limite più forte dei comici italiani importati dalla Tv.
Eppure, pensiamo che l’opera prima di Maccio vada premiata (anche per
incoraggiamento, affinché continui a perfezionarsi, per giungere a una scrittura
più equilibrata), perché regala sane risate, momenti di genio surreale (il folle
“piano” finale degli attivisti) ed è una satira feroce che invita alla
riflessione, come non accadeva da tempo in un film comico italiano. Da
Rodotà-tà-tà a onestà-tà-tà, viaggio pre-Quirinale nella spaesata piazza
grillina senza capo né nome, scrive Marianna Rizzini su “Il Foglio”. Da
Rodotà-ta-tà a onestà-tà-tà. Dopo quasi due anni di Parlamento e alla vigilia di
una nuova elezione presidenziale, la piazza a Cinque Stelle parla d'altro ( la
"mafia capitale" da non dimenticare: da cui la pubblica lettura delle
intercettazioni tratte dall'omonima inchiesta – per la gentile interpretazione
di Claudio Santamaria e Claudio Gioè, attori e volti da romanzi criminali su
piccolo e grande schermo). Onestà-tà-tà, dunque, al posto del nome che non si
farà, non si vuole fare e non si vuole neanche ascoltare (il deputato e membro
del direttorio a Cinque Stelle Alessandro Di Battista a un certo punto legge e
fa leggere alla pizza la dichiarazione-gran rifiuto: caro Renzi ecco la risposta
del popolo – e pare quasi di sentir parlare un robot, la famosa futuribile app
che renderà possibile conversare con amici virtuali come nel film "Her" con
Scarlett Johansson nella parte dell'amante fatta di web, solo che qui il tono
non è suadente: lei ha già deciso, Renzi, e al Nazareno non veniamo).
Onestá-tá-tá, e altre parole di un lessico chiama-applauso in una Piazza del
Popolo che all'inizio era mezza vuota e percorsa da interesse per l'altrove del
sabato pomeriggio: gente che faceva vedere l'acquisto da saldo e giovani rapper
-break dancer con tappeto di plastica per performance estemporanea sul selciato.
"La gente è arrivata", esclama una signora quando il suo wishful thinking,
finalmente, diventa realtá, e arriva pure Sabina Guzzanti comica non più comica,
ché, prevale, nel suo intervento, l'invettiva-imitazione in teoria civile in
realtá elitaria contro Maria De Filippi, emblema del paese in cui da vent'anni,
dice Guzzanti, si è perduto ogni " stimolo intellettuale", e sembra impossibile
fare qualcosa: le persone colte riescono a stare insieme per combinare qualcosa,
è il concetto espresso da Sabina, le persone ignoranti no. Colpa della tv, è la
sentenza che alla fine dell'invettiva tutti si aspettano, e le ragazze del bar
all'angolo della piazza si domandano perché mai "Sabina se la prenda con la De
Filippi". Ma gli applausi a quel punto sono già stati tributati alla divinità
nascosta che la piazza omaggia a intervalli regolari: l'onestà, rieccola, parola
buona per tutto e piena in fondo di niente, se non della generica riprovazione
per le altre bestie nere della serata (persino il rapper Fedez le dice e non le
canta: corruzione, resistenza, vergogna, marciume, e mafia mafia mafia). Tutto è
mafia, dicono i deputati, senatori e consiglieri comunali grillini che sfilano
sul palco (Roberta Lombardi, la veterana dei primi streaming a Cinque Stelle,
dice che una mattina si è svegliata e ha trovato non l'invasore ma una città che
diventa proprio quello che ora, chissà perchè, tutti evitano di ricordare: il
teatro della mafia capitale. La senatrice stornellista Paola Taverna, in strana
inversione di ruoli con Fedez, pare quasi una rapper quando intona lo slogan
degli slogan: fuori la mafia dallo Stato. Fedez invece, sempre senza cantare,
dice la frase che qualcuno nel pubblico trova "un po' cosi" nel giorno in cui
l'Isis decapita un altro ostaggio, di nazionalità giapponese: abbiamo il nemico
in casa ma non è di fede musulmana, dice Fedez, e le grandi stragi sono di
matrice italiana. Il più grande nemico dell'Italia sono gli italiani, continua,
e a quel punto l'applauso arriva, forse per riflesso condizionato (sono già due
ore che gli astanti sentono dire peste e corna dell'universo mondo nazionale).
"Fuori i nomi, Renzi"', grida il tribuno Di Battista, e alla fine Beppe Grillo
esce per dire la stessa cosa, ma con il marchio di fabbrica: vaffanculo!
(Vaffanculo e fate i nomi). Il resto è uso traslato (e a volte insensato) di
termini impossibili a odiarsi: valori, costituzione, libertà, partecipazione
(povero Gaber), cultura. Grillo invece parla di sottocultura, insultando qui e
lì Giorgio Napolitano per non aver riconosciuto "il miracolo" a cinque stelle,
anche se il miracolo Grillo se l'è sfasciato da solo. Resta solo da dire no al
"Nazareno", demone antropomorfo. Ed è subito sabato sera mentre gli attivisti
sbaraccano, e sulla piazza che si svuota si diffonde, incongrua, la più classica
canzone dei Pink Floyd ("another brick in the wall").
Chi non è raccomandato, scagli la prima pietra.
Essere raccomandati in un’azienda privata è una cosa lecita. Esser raccomandati
per vincere un concorso pubblico o un esame di Stato è reato. Spesso, però, per
indulgenza o per collusione, le cose si confondono.
Se non basta un muro di parole per vincer la resistenza degli scettici, allora è
solo mala fede in loro.
La Costituzione all'art. 3 non cita che siamo tutti uguali o tutti discendenti
di eccelsi natali, esplica solo che tutti siamo uguali, sì, ma di fronte alla
legge!!!
Calcio, politica e soldi. Tutti i luoghi comuni dell'italiano
medio. Da "i ricchi evadono" al "solito inciucio":
ormai le litanie dilagano. E chi le recita si sente un po' più onesto degli
altri, scrive Massimiliano Parente su “Il Giornale”. A cominciare dalla
considerazione «Solo in Italia». Solo in Italia ci sono mille parlamentari. Solo
in Italia non trovano i colpevoli dei delitti. Solo in Italia la giustizia
funziona male, ovviamente se per caso tocca noi, se tocca un altro «dovrebbero
metterlo dentro e buttare la chiave», come fanno all'estero. Tanto nessuno
conosce l'estero, per questo ogni legge elettorale te la propongono alla
francese, alla tedesca, all'americana, per mostrare di conoscere il mondo quando
non si sa un cavolo neppure di come si vota in Italia. Coltivando il mito di
paesi nordici come la Scandinavia o la Norvegia, dove i servizi funzionano a
meraviglia, dove lo tasse sono bassissime, basta che non domandi dove sta la
Norvegia perché non saprebbero neppure indicartela sulla carta geografica.
Sebbene abbiano sentito Grillo che ti spiega come lì si ricicli anche la pupù.
Ma perché non cerchi lavoro? Perché tanto «non c'è lavoro», perché «bisogna
andare fuori», e poi tutti sono sempre qui, mai che muovano il sederino, come
all'estero appunto. Tanto «è tutto un magna magna», e «tutti rubano», sempre a
sottintendere che chi lo dice non appartiene alla categoria, sempre a
sottolineare una propria specchiatissima onestà, perché solo in Italia «i ricchi
evadono lo tasse», l'hanno visto da Santoro e a Report, te lo dice il barista
che intanto non ti rilascia lo scontrino fiscale e il medico o l'idraulico che
senza fattura, se vuoi, paghi meno, e tu ci stai perché tanto mica te la
scarichi, come in America. Tanto «gli italiani so' tutti ignoranti», sbotta
quello che non ha mai aperto un libro e un quotidiano lo sfoglia a scrocco
mentre sbocconcella il cornetto, leggendo solo i titoli, non per altro quanto a
lettura di giornali veniamo dopo la Turchia, e l'editoria è in crisi qui più che
altrove, perché se si legge qualcosa «l'ho letto su internet». Che poi se cerchi
lavoro, è noto, «prendono solo raccomandati», e intanto non è che per caso
conosci qualcuno? In un paese dove «non c'è meritocrazia», e mica se ne lamenta
il laureato a Harvard, se ne lamentano tutti, un popolo di meritevoli,
informati, studiosi, sentono che c'è «la fuga dei cervelli» e si identificano
subito col cervello in fuga. Mai sentito nessuno che ammetta di non essere
all'altezza, di aver studiato poco, di non meritarsi nulla, tutti sanno tutti,
in qualsiasi campo, dalla medicina all'economia. Convintissimi che se i
parlamentari si tagliassero lo stipendio si abbasserebbe il debito pubblico. O
almeno potrebbero «dare l'esempio», quasi che i deputati fossero arrivati in
parlamento con un'astronave e non li avessero votati loro. Perché qui «è tutto
un inciucio», e nel frattempo pure a me scrittore, nel mio piccolo, arrivano in
posta sporte di manoscritti mediocri che vogliono essere letti da gente che non
ha mai letto niente, tanto meno me, ma se glielo fai notare rispondono «Mica
sarà peggio di tanti che pubblicano?». È il diritto alla mediocrità, solo in
Italia.
Eguaglianza «aritmetica» o «proporzionale», secondo la
distinzione di Aristotele? Nel punto d'arrivo o di
partenza? Verso l'alto o verso il basso, come vorrebbero le teorie della
decrescita? Se due mansioni identiche ricevono retribuzioni differenti, dovremmo
elevare la peggiore o abbassare la piú alta? Ed è giusto che una contravvenzione
per sosta vietata pesi allo stesso modo per il ricco e per il povero? Sono
giuste le gabbie salariali, il reddito di cittadinanza, le pari opportunità? E
davvero può coltivarsi l'eguaglianza fra rappresentante e rappresentato, l'idea
che «uno vale uno», come sostiene il Movimento 5 Stelle? In che modo usare gli
strumenti della democrazia diretta, del sorteggio e della rotazione delle
cariche per rimuovere i privilegi dei politici? Tra snodi teorici ed esempi
concreti Michele Ainis ci consegna una fotografia delle disparità di fatto,
illuminando la galassia di questioni legate al principio di eguaglianza.
Puntando l'indice sull'antica ostilità della destra, sulla nuova indifferenza
della sinistra verso quel principio. E prospettando infine una «piccola
eguaglianza» fra categorie e blocchi sociali, a vantaggio dei gruppi piú deboli.
Una proposta che può avere effetti dirompenti.
Siamo tutti bravi a sciacquarci la bocca sull'uguaglianza. Ecco il fenomeno dei
populisti.
Il largo uso che i politici e i media fanno del termine "populismo" ha
contribuito a diffonderne un’accezione fondamentalmente priva di significato: è
rilevabile infatti la tendenza a definire "populisti" attori politici dal
linguaggio poco ortodosso e aggressivo i quali demonizzano le élite ed esaltano
"il popolo"; così come è evidente che la parola viene usata tra avversari per
denigrarsi a vicenda – in questo caso si può dire che "populismo"
viene talvolta considerato dai politici quasi come un sinonimo di "demagogia".
Ritorsioni se dici la verità: sì, ma come si fa a tacere queste mascalzonate?
Equitalia, milioni di cartelle a rischio: 767 dirigenti nominati senza concorso,
scrive Blitz quotidiano.
La Corte Costituzionale abbatte Equitalia. I dirigenti? Tutti falsi, scrive
Angelo Greco su “Legge per Tutti”.
"Università, altro che merito. E' tutto truccato.
Vi racconto come funziona nei nostri atenei". Fondi sperperati, concorsi
pilotati, giovani sfruttati. Un ex dottorato spiega nel dettaglio come si muove
il mondo accademico tra raccomandazioni e correnti di potere. E qualcuno non
vuole che il libro in cui riporta tutti gli scandali venga pubblicato, scrive
Maurizio Di Fazio su “L’Espresso”.
Chi non è raccomandato scagli la prima pietra.
Più di quattro milioni di italiani sono ricorsi a una
raccomandazione per ottenere un'autorizzazione o accelerare una pratica. E
800mila hanno fatto un "regalino" a dirigenti pubblici per avere in cambio un
favore. Sono alcuni dati emersi da una ricerca realizzata dal Censis.
Non solo. Il coro di voci, che hanno chiesto le dimissioni al Ministro Lupi del
governo Renzi, è roboante. Tra i vari aspetti della vicenda Incalza che lo
vedono coinvolto, al ministro delle Infrastrutture non viene perdonata la
presunta raccomandazione per il figlio. Ma è davvero così peccaminoso prodigarsi
per il proprio figlio come ogni genitore farebbe, oltretutto, in un Paese dove
la raccomandazione è all'ordine del giorno?
E’ inutile negarlo, la pratica della raccomandazione è la sola che funziona
perfettamente nel nostro Paese, anche perché coinvolge ognuno di noi in maniera
democratica senza distinzione di genere, scrive “Panorama”. Ci sono gli italiani
che raccomandano e gli italiani che si fanno raccomandare, una sorta di catena
di Sant’Antonio che prosegue all’infinito. Almeno una volta nella vita bisogna
provare l’ebbrezza della spintarella, anche quando si è coscienti che questa non
servirà a nulla per raggiungere l’ambita destinazione, qualsiasi essa sia (il
posto di lavoro, la visita medica, l’esame all’università) e non importa se alla
meta arriverà un altro, perché la nostra osservazione sarà “chissà chi lo ha
raccomandato…!” E poi ci sentiamo a posto con la coscienza per due motivi,
il primo perché, comunque, il tentativo lo abbiamo fatto, il secondo perché la
volta successiva non ci faremo trovare impreparati, anzi ci organizzeremo meglio
cercando una spinta più potente. Forse un giorno potremo anche inserirla nel
curriculum vitae.
Il caso esemplare è lo scandalo di Catanzaro: oltre duemila compiti-fotocopia.
Su 2301 prove scritte per l’accesso all’albo degli avvocati consegnate a metà
dicembre del 1997 alla commissione d’esame di Catanzaro, ben 2295 risultano
identiche. Soltanto sei elaborati, cioè lo 0,13 per cento del totale, appare non
copiato. Compiti identici, riga per riga, parola per parola. Le tre prove di
diritto civile, diritto penale e atti giudiziari non mettono in risalto
differenze. Sono uguali anche negli errori: tutti correggono l’avverbio
«recisamente» in «precisamente». Una concorrente rivela che un commissario
avrebbe letteralmente dettato lo svolgimento dei temi ai candidati. Racconta:
«Entra un commissario e fa: “scrivete”. E comincia a dettare il tema, piano
piano, per dar modo a tutti di non perdere il filo». «Che imbecilli quelli che
hanno parlato, sono stati loro a incasinare tutto. Se non avessero piantato un
casino sarebbe andato tutto liscio», dice una candidata, che poi diventerà
avvocato e probabilmente commissario d’esame, che rinnegherà il suo passato e
che accuserà di plagio i nuovi candidati. L’indagine è affidata ai pm Luigi de
Magistris e Federica Baccaglini, che ipotizzano il reato di falso specifico e
inviano ben 2295 avvisi di garanzia. Catanzaro non è l’unica mecca delle toghe:
le fa concorrenza anche Reggio Calabria che, tra l’altro, nel 2001 promuove il
futuro ministro dell’Istruzione per il Pdl Mariastella Gelmini in trasferta da
Brescia. Ma Catanzaro è da Guinness dei primati. I candidati arrivano da tutta
Italia, e i veri intoccabili soprattutto dalle sedi del Nord dove gli esami sono
molto selettivi per impedire l’accesso di nuovi avvocati nel mercato saturo. Gli
aspiranti avvocati milanesi o torinesi risultano residenti a Catanzaro per i sei
mesi necessari per il tirocinio, svolto in studi legali del luogo, i quali
certificano il praticantato dei futuri colleghi. Frotte di giovani si fanno
consigliare dove e come chiedere ospitalità. In città esistono numerose pensioni
e alloggi, oltre a cinque alberghi, che periodicamente accolgono con pacchetti
scontati i pellegrini forensi. Tutti sanno come funziona e nessuno se ne
lamenta. L’omertà è totale. I magistrati interrogano gruppi di candidati
dell’esame del dicembre 1997, che rispondono all’unisono: «Mi portai sovente in
bagno per bisogni fisiologici […]. Non so spiegare la coincidenza tra gli
elaborati da me compilati e quelli esibiti. Mi preme tuttavia evidenziare che
qualcuno potrebbe avermi copiato durante la mia assenza». Mentre il procedimento
giudiziario avanza a fatica per la difficoltà di gestire un numero così grande
di indagati, tutti gli aspiranti avvocati dell’esame del 1997 rifanno le prove
nel 1998 nel medesimo posto e sono promossi. Dopo otto anni di indagini e
rinvii, nell’estate 2005 il pm Federico Sergi, nuovo titolare dell’indagine,
chiede e ottiene per ciascuno il «non luogo a procedere per avvenuta
prescrizione». Tutto finito. Questi avvocati esercitano.
La Calabria è bella perchè c’è sempre il sole, scrive Antonello Caporale su “La
Repubblica”. Milano invece spesso è velata dalla nebbia. E’ bella la Calabria
anche, per esempio, perchè il concorso per l’abilitazione alla professione di
avvocato sembra più a misura d’uomo. Non c’è il caos di Milano, diciamolo. E in
una delle dure prove che la vita ci pone resiste quel minimo di comprensione,
quell’alito di compassione… In Calabria c’è il sole, e l’abbiamo detto. Ma vuoi
mettere il mare? ”Avevo bisogno di un luogo tranquillo, dove poter concentrarmi
senza le distrazioni della mia città. Studiare e affrontare con serenità
l’esame”. Ecco, questo bisogno ha portato Antonino jr. Giovanni Geronimo La
Russa, il figlio di Ignazio, anch’egli avvocato ma soprattutto ministro della
Difesa, a trasferirsi dalla Lombardia in Calabria. Laureato a pieni voti
all’università Carlo Cattaneo, Geronimo si è abilitato con soddisfazione a
Catanzaro a soli ventisei anni. Due anni ha risieduto a Crotone. Dal 25 luglio
2005, in piazza De Gasperi, nella casa di Pasquale Senatore, l’ex sindaco
missino. E’ rimasto nella città di Pitagora fino al 18 gennaio 2007. E si è
rigenerato. Un po’ come capitò a Mariastella Gelmini, anche lei col bisogno di
esercitare al meglio la professione di avvocato prima di darsi alla politica, e
anche lei scesa in Calabria per affrontare con ottimismo l’esame. La scelta
meridionale si è rivelata azzeccata per lei e per lui. Il piccolo La Russa è
tornato in Lombardia con la forza di un leone. E dopo la pratica nello studio
Libonati-Jager, nemmeno trentenne è divenuto titolare dello studio di famiglia.
Quattordici avvocati a corso di porta Vittoria. Bellissimo. “Ma è tutto merito
mio. Mi scoccia di passare per figlio di papà”.
Ma guarda un po’, sti settentrionali, a vomitar cattiverie e poi ad agevolarsi
del…sole calabro.
Riguardo la magistratura, l’avvocato astigiano Pierpaolo Berardi, classe 1964,
per anni ha battagliato per far annullare il concorso per magistrati svolto nel
maggio 1992. Secondo Berardi, infatti, in base ai verbali dei commissari, più di
metà dei compiti vennero corretti in 3 minuti di media (comprendendo “apertura
della busta, verbalizzazione e richiesta chiarimenti”) e quindi non “furono mai
esaminati”. I giudici del tar gli hanno dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il
Csm, nel 2008, è stato costretto ad ammettere: “Ci fu una vera e propria
mancanza di valutazione da parte della commissione”. Giudizio che vale anche per
gli altri esaminati. In quell’esame divenne uditore giudiziario, tra gli altri,
proprio Luigi de Magistris, giovane Pubblico Ministero che si occupò inutilmente
del concorso farsa di abilitazione forense a Catanzaro: tutti i compiti
identici e tutti abilitati.
Al Tg1 Rai delle 20.00 del 1 agosto 2010 il conduttore apre un servizio: esame
di accesso in Magistratura, dichiarati idonei temi pieni zeppi di errori di
ortografia. La denuncia è stata fatta da 60 candidati bocciati al concorso 2008,
che hanno spulciato i compiti degli idonei e hanno presentato ricorso al TAR
per manifesta parzialità dei commissari con abuso del pubblico ufficio.
Risultato: un buco nell'acqua. Questi magistrati, nel frattempo diventati dei,
esercitano.
Quando si dà la caccia ai figli per colpire i padri,
scrive Lanfranco Caminiti su “Il Garantista”. E poi dicono, i potenti, povero
ministro Lupi. Un figlio laureato con 110 e lode al Politecnico di Milano, e
tutto quello che gli trova è un lavoretto su un cantiere Eni a partita iva da
1300 euro mese. Un precario aggiunto ai milioni di giovani senza posto fisso. E
sì che mica lo poteva infilare in una delle cooperative di Comunione e
liberazione, quelle ormai stanno nell’occhio del ciclone, e poi che fai, vai a
pulire il culo degli ammalati negli ospedali, dai i pasti alla mensa, ti sbatti
coi tossici, ricicli i libri usati, oh, c’ha una laurea al Politecnico. E però,
per i figli si farebbe tutto, certo. Anche mettendoti a rischio. I figli sono
pezzi di cuore, sono quello per cui ti sbatti, sono quello che rimarrà di te,
sono il punto debole. È una costante questa. Sarà che noi italiani c’abbiamo il
familismo amorale, c’abbiamo. Prima di tutto la famiglia, i figli.
Chissà se hanno telefonato per i loro figli in carriera.
Indignazione per Lupi jr, ma nessuno si chiede se i rampolli dei leader
democratici abbiano avuto l'aiutino. Dagli eredi dei presidenti alle ragazze di
Veltroni e D'Alema, scrive Paolo Bracalini su “Il Giornale”. «Mio figlio è
laureato al Politecnico con 110 e lode, gli faccio sempre questa battuta:
purtroppo ha fatto Ingegneria civile e si è ritrovato un padre ministro delle
Infrastrutture» si difende Maurizio Lupi, accusato di familismo all'italiana.
Quella è una sfortuna che capita spesso ai figli di potenti, quasi sempre dotati
di grande talento tanto da meritare posti prestigiosi, carriere formidabili,
magari in settori affini a quelli di papà o mammà. Così viene il sospetto,
malizioso e certamente infondato, che qualche telefonatina per lanciare i
rampolli, una sponsorizzazione paterna o materna, sia prassi diffusa. Anche a
sinistra, magari a partire da chi si indigna per Lupi jr. Avere parenti potenti
non serve, se si è bravi, però aiuta. Sempre che non li intercettino.
Caso Lupi, Giampiero Mughini su Dago critica Giuliano Ferrara:
"Tutti siamo stati raccomandati, anche tu", scrive “Libero Quotidiano”. Chi è
senza raccomandazione alzi il ditino da moralista. Giampiero
Mughini interviene a piedi uniti nel dibattito sul ministro
Maurizio Lupi e la sospetta
raccomandazione che avrebbe fatto al figlio ingegnere per farlo lavorare. A far
saltare la mosca al naso di Mughini è un pezzo di Giuliano
Ferrara sul Foglio che in un passaggio scrive:
"Non mi hanno ristrutturato case a buon prezzo, assunzioni di parenti no e poi
no, non li conosco. Le cricche mi sono lontane". Apri cielo: Mughini in una
lettera a Dagospia prima ricostruisce il suo ingresso nel mondo del
lavoro, ricordando la lettera di raccomandazione scrittagli da Gian Carlo
Pajetta per lavorare a Paese Sera. Poi passa proprio all'Elefantino, sulla cui
vita ha anche scritto un libro in passato: "Era stato Alberto Ronchey, negli
anni Cinquanta moscoviti collega di papà Maurizio Ferrara, a intercedere presso
il Corriere della Sera perché Giuliano potesse iniziarvi una sua
collaborazione". Con il ministro di Ncd, Mughini dice di non avere legami,
quindi nessuna difesa di ufficio. Se poi venisse confermata la telefonata con la
quale Lupi avrebbe chiesto un lavoro per il figlio: "Io - scrive Mughini -
altissimamente me ne strafotto. E tutti quelli che si stanno alzando con il
ditino puntato - continua - hanno a che vedere con la faziosità politica".
"La credibilità dello Stato oggi è ampiamente compromessa e il primo atto, lo
dico non per ragioni giudiziarie, ma per ragioni politiche, dovrebbe essere una
bonifica radicale del ministero delle Infrastrutture, e anche le dovute
dimissioni del ministro competente". Lo ha detto il leader di Sel e presidente
della Regione Puglia, Nichi Vendola, parlando il 17 marzo 2015 oggi a Bari con i
giornalisti in merito alla maxi operazione dei Cc del Ros sulla gestione
illecita degli appalti delle cosiddette Grandi opere. Certo che non vi è
vergogna nei nostri politici. Si parla delle dimissioni di Lupi che non è
indagato. Mentre chi le chiede, e gli esponenti del suo partito, nel processo a
Taranto "Ambiente Svenduto", per loro la Procura ha chiesto al giudice per
l'udienza preliminare Wilma Gilli il rinvio a giudizio. Chiesto dalla Procura il
rinvio a giudizio per il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, per il
sindaco di Taranto, Ezio Stefàno, per gli attuali assessori regionali
all'Ambiente, Lorenzo Nicastro, e alla Sanità, Donato Pentassuglia, quest'ultimo
all'epoca dei fatti presidente della commissione regionale Ambiente, nonché per
l'allora assessore regionale Nicola Fratoianni, oggi deputato di Sel.
Vittorio Feltri: “Se Santoro è giornalista la colpa è mia che l’ho promosso
all’esame. Si dà infatti il caso che Santoro sia diventato giornalista
professionista con il mio contributo, giacché facevo parte della commissione
all'esame di Stato che lo promosse e gli consentì l'iscrizione all'Ordine
nazionale dei giornalisti. Era il 1982. Me lo ricordo perché erano in corso i
Mondiali di calcio in Spagna, quelli vinti dall'Italia con Sandro Pertini in
tribuna d'onore. La vita del commissario esaminatore aveva qualche risvolto
piacevole. Feci comunella con Giuseppe Pistilli, vicedirettore del Corriere
dello Sport, il quale sedeva con me nel sinedrio. La sera andavamo a cena
insieme. Il ponentino e il Frascati ci aiutavano a dimenticare le miserie cui
avevamo assistito durante la giornata nel valutare i candidati. Ancora non avevo
maturato la convinzione che l'Ordine dei giornalisti fosse un ente inutile, anzi
peggio: dannoso. Pistilli contribuì a instillarmi qualche sospetto,
illustrandomi come funzionava la commissione d'esame. Esempio: un aspirante
scriba ti era stato raccomandato o ti stava a cuore? Bene, si trattava di farsi
dare da lui le prime righe dell'articolo che aveva steso durante la prova
scritta. Nessuno comincia un pezzo nella stessa maniera del compagno di banco,
chiaro no? Perciò, non appena s'iniziava la lettura ad alta voce e in forma
anonima degli elaborati, all'udire l'attacco familiare il commissario dava un
calcetto sotto il tavolo a chi gli stava accanto. Costui a sua volta sferrava un
calcetto al commissario più vicino, e avanti così. Con sei calcetti, il
candidato era promosso. Dopodiché ricevevi a tua volta altri colpi negli stinchi
e dovevi restituire il favore ricevuto. In questo modo passavano l'esame (e lo
passano tuttora) asini sesquipedali.”
Il tribunale del popolo guidato da Di Pietro,
scrive Tiziana Maiolo su "Il Garantista". Maurizio Lupi
non è un indagato. È un condannato dal Tribunale del Popolo composto di
giornalisti invidiosi, magistrati esibizionisti e una folla di tricoteuses
opportunamente istigata dai Paladini della Virtù che passeggiano per i talkshow
spargendo il proprio verbo, la propria “moralità”. Il 17 marzo 2015 mattina si è
svegliato presto Antonio Di Pietro, si è collegato subito con Radio24, poi è
corso in Rai per farsi intervistare ad Agorà sgusciando poi via velocemente per
planare su La7. Una fatica per chi ha tante lezioni di moralità da elargire al
ministro Maurizio Lupi. Che non è indagato, ma condannato perché “forse” si è
lasciato regalare un vestito da un imprenditore suo amico di famiglia, il quale
avrebbe anche donato un orologio costoso a suo figlio in occasione di una laurea
particolarmente brillante al Politecnico di Milano. Tra le imputazioni di stampo
moralistico c’è anche un posto di lavoro temporaneo al neo-ingegnere in un
cantiere. Giusto quindi che intervenga subito il Pm più famoso d’Italia. Un
plauso a tutti i conduttori che hanno pensato di invitare proprio Di Pietro a
commentare i comportamenti di Lupi. È uno che se ne intende.
Da quale pulpito vien la predica?
Si riportano vari articoli di stampa, a scanso di persecuzione personale.
L’incipit della confidenza di Elio Belcastro, parlamentare dell’Mpa di Raffaele
Lombardo, pubblicata su “Il Giornale”. Belcastro ci fa subito capire, scandendo
bene le parole, che Tonino non era nemmeno riuscito a prenderlo quel voto,
minimo. «Tempo fa l’ex procuratore capo di Roma, Felice Filocamo, che di quella
commissione d’esami era il segretario, mi ha raccontato che quando Carnevale si
accorse che i vari componenti avevano bocciato Di Pietro, lo chiamò e si
arrabbiò molto. Filocamo fu costretto a tornare in ufficio, a strappare il
compito del futuro paladino di Mani pulite e a far sì che, non saprei dire come,
ottenesse il passaggio agli orali, seppur con il minimo dei voti». Bocciato e
ripescato? Magistrato per un falso? Possibile? Non è l’unico caso. Era già stato
giudicato non idoneo, ma in una seconda fase sarebbero saltati fuori degli
strani fogli aggiuntivi che prima non c’erano. Ecco come sarebbe sorto il
sospetto che qualcuno li avesse inseriti per “salvare” il candidato già
bocciato, in modo da giustificare una valutazione diversa oppure da consentire
un successivo ricorso al TAR. I maggiori quotidiani nazionali e molti locali, ed
anche tanti periodici, si sono occupati di tale gravissimo fatto, e che è stato
individuato con nome e cognome il magistrato (una donna) in servizio a Napoli
quale autore del broglio accertato. Per tale episodio il CSM ha deciso di
sospendere tale magistrato dalle funzioni e dallo stipendio. In quella sessione
a fronte di 350 candidati ammessi alle prove orali pare che oltre 120 siano
napoletani, i quali sembrano avere particolari attitudini naturali verso le
scienze giuridiche e che sembrano essere particolarmente facilitati nel loro
cammino anche dalla numerosa presenza nella commissione di esami di magistrati e
professori napoletani.
Si riportano vari articoli di stampa, a scanso di persecuzione personale.
Corrado Carnevale: "Quell’aiutino a Di Pietro per diventare magistrato...",
scrive “Libero Quotidiano”. Corrado Carnevale: "Al concorso in magistratura, Di
Pietro ha avuto due aiutini". L'ex giudice Corrado Carnevale: "Era stato in
seminario ed era di famiglia povera. Fu così che chiusi un occhio", scrive
Rachele Nenzi su “Il Giornale”.
Quell’aiutino a Di Pietro per diventare magistrato. L’ex giudice Carnevale
sull’esame di Tonino a pm: «Era povero, mi commossi. E due 5 diventarono 6»,
scrive Valeria Di Corrado su “Il Tempo”.
Giancarlo De Cataldo su “L’Espresso”: L'Italia è una repubblica fondata sullo
scandalo. Dai tempi di Cavour a Mani Pulite: ogni vent’anni
un’indagine-choc. Corsi e ricorsi storici delle tangenti, specchio di un Paese
che non cambia. Il commento dello scrittore-magistrato. La fiction “1992” è
bella e coraggiosa. Racconta - ed è già questo un merito innegabile - la
controversa stagione di Mani Pulite. Lo fa con la disinvolta ferocia narrativa
che è il marchio di fabbrica delle grandi serie. “1992” è televisione avanzata.
Ma ha anche un altro merito. “1992” declina con linguaggio di oggi una vicenda
che affonda radici profonde nella storia d’Italia. Una storia antica: la storia
della nostra corruzione. Una storia cominciata tanti anni fa. Conquistato il Sud
grazie all’impresa dei Mille, il conte di Cavour si mette all’opera per
disegnare il futuro della nuova nazione. Giorgio Asproni, deputato sardo, alta
carica massonica, ex-prete, esponente dell’estrema sinistra mazziniana, nei suoi
impietosi diari annota disgustato l’incessante processione di faccendieri,
ufficiali, imprenditori che assediano l’ufficio di Cavour a Palazzo Carignano.
Tutti a vantare inesistenti meriti patriottici, tutti a implorare un incarico,
una commessa, un’onorificenza. Ciò che l’incendiario Asproni non può sapere è
che in quegli stessi momenti Cavour, il liberale, l’odioso tessitore di trame
che i democratici accusano di essersi impossessato per turpi fini della bandiera
della Patria, proprio Cavour, prova, nei confronti dei questuanti, sentimenti
non molto dissimili. Al punto da bollare i clientes con parole di fuoco. Asproni
e Cavour, ciascuno eroico a suo modo, divisi da visioni radicalmente
inconciliabili della Storia (e della natura umana) su un punto concordano: il
disprezzo per quei molli figuri che non versarono una sola goccia di sangue per
la “causa” e ora si avventano sulla greppia dell’Italia unita. Ma se Asproni li
metterebbe volentieri al muro, corrotti e corruttori, Cavour, secondo il suo
costume, pensa di poterne agevolmente “trarre partito”. Costruire dal nulla
un’identità nazionale è compito arduo, ai limiti dell’impossibile. Nella fase
d’avvio non si può andare tanto per il sottile. Anche gli affaristi servono, e
servono i faccendieri. Cavour opera una scelta di campo destinata a ipotecare
pesantemente il nostro futuro. Il destino fa il resto. Cavour, che forse sarebbe
riuscito a contenere le smanie predatorie nell’alveo della fisiologia
democratica, muore troppo presto. I suoi successori non si riveleranno
all’altezza. Quindici anni dopo l’Unità, nel 1875, un popolano trasteverino
accoltella a morte Raffaele Sonzogno, coraggioso giornalista calato a Roma dal
Nord, animatore di inchieste sul dilagante malaffare post-unitario. Il sicario
viene subito arrestato, ma è chiaro che, secondo uno schema destinato a
ripetersi drammaticamente negli anni, se il pugnale viene dalla strada, l’ordine
è partito dal Palazzo. Giancarlo De Cataldo Dietro l’uccisione di Sonzogno c’è
una colossale speculazione edilizia sui terreni espropriati al Vaticano. Sono
coinvolti banchieri, palazzinari, preti attenti al portafoglio, pezzi della
Destra storica, che uscirà sconfitta dalle elezioni dell’anno dopo, e pezzi
della Sinistra che già pregusta la vittoria, e persino un rampollo “agitato”
dell’eroe dei Due Mondi. Una pregevole compagnia di giro che ritroveremo spesso
nella cronaca del nostro Paese. Troppo, per una nazione appena nata.
L’inchiesta, abilmente pilotata, porta alla condanna del deputato Luciani.
Movente: una questione di corna. Luciani becca una condanna tombale, e invano,
per anni, minaccerà sconvolgenti rivelazioni. Dalla speculazione verranno poste
le basi per uno dei tanti, anch’essi ricorrenti, “sacchi” di Roma. Qualche anno
dopo, nel 1892, un giornale satirico della capitale, “Il carro di Checco”, svela
la vicenda finanziaria che passerà alla storia come “scandalo della Banca
Romana”. Incalzato dal battagliero Napoleone Colajanni, il governo è costretto a
nominare una commissione d’inchiesta. Emergono notevoli reati: si va dalla
fabbricazione e spaccio di monete false al falso in bilancio, dalle false
fatturazioni alla corruzione dei funzionari e deputati incaricati dei controlli,
passando per la costituzione di “fondi neri” riversati nelle tasche di
personaggi pubblici. Coinvolto il gotha politico del tempo, Giolitti in testa,
lambita Casa Savoia. Giolitti, anche se non è più ministro, pretende e ottiene
una giurisdizione “politica”. Il finale è deprimente, con la morte per suicidio
di un onorevole accusato di un reato minore e il proscioglimento generale.
Favorito, si disse, da un’attenta “gestione” dei materiali probatori concordata
fra Governo e vertici della magistratura. Grande e diffusa fu la frustrazione.
Un giurista scrisse che si era consacrata «l’immoralità di chi ha troppo
mangiato e che dopo il pasto pare abbia, come la lupa di Dante, più fame di
pria». La stampa, come sovente accade, deplorò. E tutto ricominciò come prima.
Fra l’altro, proprio mentre si dibatteva della Banca Romana, in Sicilia veniva
assassinato Emanuele Notarbartolo di San Giovanni. Un banchiere onesto che si
era messo di traverso alle speculazioni ordite da quella che, allora, si
chiamava “Alta Mafia”. Fu incriminato per questo omicidio l’onorevole Palizzolo,
poi assolto all’esito di un interminabile processo. Il vecchio liberale Gaetano
Mosca parlò di «disfatta morale». Gli amici festeggiarono la liberazione di
Palizzolo noleggiando una nave con tanto di gran pavese. In tempi più recenti,
sembra essersi affermata una paradossale “legge del venti”. Nel senso che ogni
vent’anni circa il Paese “scopre” uno o più colossali scandali a base di
corruzione. Si deplora, si invocano cambiamenti legislativi, emergono demagoghi
più o meno versati nell’arte di arringare le masse promettendo “pulizia”, si
adottano misure asseritamente restrittive, si fanno esami di coscienza, si va in
Tribunale. Nel 1974 alcuni giovani giudici, definiti con un certo risentimento
“pretori d’assalto” (l’anticamera del “giudici ragazzini” di qualche anno dopo),
scoprono che i petrolieri pagano i ministri per ottenere leggi favorevoli alla
propria lobby. Sandro Pertini, Presidente della Camera, li incoraggia a «non
guardare in faccia a nessuno», inclusi i suoi compagni del Partito Socialista.
Minaccia, in caso di insabbiamento, le dimissioni. Il governo cade. Gli imputati
sono giudicati dalla Commissione Parlamentare per i procedimenti di accusa.
Pertini non si dimette. Esito del giudizio: due ministri archiviati, due
prescritti, due assolti dopo qualche tempo. Mani Pulite, si è detto, esplode nel
1992, quindi a circa vent’anni dallo scandalo dei petroli. Fra il 1992 e il 1993
si consumano gli ultimi delitti eccellenti e le ultime stragi di mafia. Curiosa
coincidenza con quanto era accaduto esattamente un secolo prima. Ieri corruzione
a Roma e morte di un banchiere onesto in Sicilia, oggi corruzione a Milano e non
solo, piombo e tritolo per politici, giudici e inermi cittadini in Sicilia e non
solo. Quasi a voler sottolineare che gli inconfessabili legami e lo
spregiudicato uso della violenza e della corruttela, col tempo, invece di
attenuarsi, si sono rafforzati. Le stragi mafiose e Mani Pulite suscitarono
un’ondata di indignazione. Furono approvate leggi per favorire il fenomeno del
pentitismo e confiscare i beni dei mafiosi. Una nuova classe politica spazzò via
la precedente: e anche questo era accaduto, cent’anni prima. Poi, col tempo,
tutto si è sopito e troncato. I pentiti sono diventati più o meno degli
appestati. Mani Pulite è oggetto di revisione storiografica critica. Ritocchi
normativi bipartisan hanno reso sempre più disagevole l’operato degli
investigatori. A risvegliare i dormienti, guarda caso a vent’anni da Mani
Pulite, gli scandali Expo, Mose, e, infine, l’inchiesta “Mafia Capitale”. Che,
fra l’altro, come all’epoca del trapasso fra Destra storica e Sinistra, propone
uno spaccato di cointeressenze fra gente che dovrebbe, teoricamente, militare su
opposte sponde. Oggi la stampa deplora. Sono allo studio inasprimenti di pena.
Si nominano authority anticorruzione e assessori alla legalità. Intanto, si vara
una legge punitiva sulla responsabilità civile dei magistrati e si tuona contro
il loro “protagonismo”: senza mai riempire di contenuto questa parola dal suono,
si direbbe, gnostico. Si giura, soprattutto, che è venuto il momento di voltare
pagina. Come diceva Nino Manfredi: «Fusse ca fusse...». Dobbiamo dunque
ritenerci rassegnati e sfiduciati? Ci mancherebbe! A un ragazzo che si affaccia
alla vita non puoi trasmettere il messaggio del “tutto è perduto”. Sarebbe
delittuoso. Però un minimo di onestà intellettuale non disturba, anzi. Bisogna
spiegare che fra corruzione e legalità si combatte una guerra aspra, senza
esclusione di colpi. Che corrotti e corruttori offrono scorciatoie convincenti,
indossano maschere seducenti, vantano - e purtroppo sovente a ragione -
indiscutibili successi. Sono simpatici, mondani, ricchi di fascino, corrotti e
corruttori. “Legalità” è invece una parola astratta che ossessivi, abili
messaggi fanno apparire sempre più ostile, odioso patrimonio di arcigni, e
dunque antipatici, guardiani. “Moralista” fa oggi sorridere, “incorruttibile”
suscita panico. Bisogna spiegare che giudici e poliziotti sono patologi del
sistema, intervengono quando il danno è stato fatto. Bisogna insistere
sull’istruzione e sulla cultura, e persino sull’estetica: si può combattere,
consapevoli della disparità fra le forze in campo, anche per il solo gusto di
non darla vinta alla società dei magnaccioni. E dopo, a casa, magari, tutti a
vedere “1992”, la serie. Con Asproni che digrigna i denti e Cavour che perde un
po’ alla volta il suo ironico sorrisetto.
La caduta (parziale) degli Dei, scrive Piero Sansonetti su "Il Garantista". Il
segretario dell’Anm, il dottor Maurizio Carbone, dice che la riforma delle norme
sulla responsabilità civile dei magistrati, approvata l’altro ieri dal
Parlamento, «è un tentativo di normalizzare la magistratura». Lo ha dichiarato
ieri, durante la conferenza stampa dell’ Anm, che è su tutte le furie per questa
piccola riforma. Già: «normalizzare». Cioè rendere normale. Oggi la magistratura
non è normale: è l’unica istituzione dello Stato ad essere al di sopra dello
Stato, della legge, ad essere – nell’esercizio delle sue funzioni – immune dalla
legge, e insindacabile, e non dipendente dallo Stato ma sovraordinata allo
Stato. «Normalizzare» la magistratura, cioè toglierle la sua caratteristica di
”deità” (che non è la ”terzietà” di cui spesso l’Anm parla) non sarebbe una cosa
cattiva. Libererebbe forse l’Italia da un sovrappeso ”feudale” che ancora ne
condiziona profondamente la struttura democratica, e che probabilmente è in
contrasto con lo spirito della Costituzione, che è una Costituzione Repubblicana
e che prevede l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Alcuni
magistrati dicono: ma noi siamo magistrati, non cittadini. E su questa base
pretendono di non dover sottostare alla legge. Ritengono – temo in buona fede –
che la saldezza di una società, e la sua moralità, e il suo essere ”società
etica” (successivamente si passa all’idea dello ”Stato Etico”) non possono che
essere affidati ad una entità e ad un gruppo di persone migliori degli altri (”aristoi”)
i quali siano in grado di ”sapere” la vita degli altri, valutarla, giudicarla,
punirla. Non è questa una funzione – pensano – che possa essere affidata alla
democrazia, o al libero svolgimento delle relazioni umane e sociali, perché la
democrazia è un buon sistema di governo ma è viziato da corruzione. E l’eccesso
della libertà, della deregolamentazione, sono pericolose per la collettività. La
democrazia deve essere ”corretta”, o comunque controllata, e anche la società,
da qualcosa di superiore e di ”certamente morale”: e cioè da i giudici.
Contestare questa funzione dei giudici vuol dire contestare la loro
indipendenza. E mettere in discussione l’indipendenza dei giudici vuol dire
correre il rischio che la magistratura finisca per non essere più autonoma dalla
politica. L’autonomia dalla politica non è vista come una condizione di
funzionamento della magistratura, o come un elemento necessario nell’equilibrio
dei poteri, ma come un valore assoluto al quale una società ”morale” deve
sottomettersi, e in assenza del quale la società diventa ”immorale” e la
democrazia, e le istituzioni, scendono in una condizione di subalternità alla
politica. La politica è ”il male” , la giustizia (lo dice la parola stessa) è il
bene, e il bene può governare il male, e può redimerlo, correggerlo,
sottometterlo. Il male non solo non può governare il bene, ma non può aspirare
ad essere alla pari col bene. Ecco, questo ragionamento è alla base delle molte
dichiarazioni rilasciate ieri dal dottor Carbone, e anche dal presidente
dell’Anm Sabelli. Il quale ha rimproverato al governo di avere promesso una
riforma della Giustizia in 12 punti, e di avere realizzato invece l’unico punto
che non va bene, e cioè la riforma della responsabilità dei giudici. I
magistrati invece – ha spiegato – vogliono cose diverse: per esempio la
riduzione della prescrizione, l’estensione dei poteri speciali ”antimafia” anche
ad altri reati, il processo telematico (cioè la cancellazione del diritto
dell’imputato ad essere presente al suo processo), la riduzione dei gradi di
giudizio, eccetera. In sostanza, la proposta dell’Anm (che più o meno è stata
organicamente strutturata nella proposta di riforma del dottor Nicola Gratteri)
è quella di escludere norme che riportino alla normalità la magistratura,
ristabilendo la legittimità dello Stato liberale e dell’equilibrio dei poteri,
ma, viceversa, decidere un forte aumento dei poteri della magistratura, un
ridimensionamento drastico dei diritti dell’imputato, e un rafforzamento della
condizione di preminenza e di insindacabilità dei pubblici ministeri. Sabelli ha
anche annunciato che l’Anm ha chiesto un incontro al Presidente della
Repubblica. Per dirgli cosa? Per esprimere le proprie rimostranze contro il
Parlamento. Già nella richiesta dell’incontro c’è un elemento di scavalcamento
dell’idea (puramente platonica in Italia) dell’indipendenza dei poteri. La
magistratura ritiene che il suo compito non sia quello semplicemente di
applicare le leggi, ma di condizionarne il progetto e la realizzazione.
L’associazione magistrati chiede al Presidente della Repubblica di frenare, o
condizionare, o rimproverare il Parlamento. E vuole discutere nel merito delle
leggi. La magistratura considera inviolabile la propria indipendenza dagli altri
poteri, e inaccettabile la pretesa di indipendenza degli altri poteri dalla
magistratura. Devo dire che la passione con la quale i magistrati hanno reagito
alla miniriforma della responsabilità civile mi ha colpito soprattutto per una
ragione: questa riforma è quasi esclusivamente simbolica. La responsabilità dei
giudici resta limitatissima. L’unica vera novità è la rimozione del filtro che
in questi vent’anni aveva permesso solo a 4 cittadini di ottenere un
risarcimento per la mala-giustizia (nello stesso periodo sono stati processati e
condannati 600.000 medici). Tutte le altre barriere restano. I magistrati
saranno giudicati solo in caso che sia accertata una colpa grave, o addirittura
un dolo nel loro comportamento, saranno giudicati non da una autorità esterna ma
dai loro colleghi (visto che oltretutto non esiste una divisione delle carriere)
e se alla fine saranno ritenuti colpevoli pagheranno con una sanzione che in
nessun caso potrà superare la metà dell’ammontare di un anno di stipendio. Voi
conoscete qualche altra categoria professionale protetta fino a questo punto? La
probabilità di essere condannati per i magistrati è così bassa, e l’esiguità
della pena così forte, che chiunque può mettersi al riparo pagando una
assicurazione con poche decine di euro. Cosa che non vale per i medici, o gli
ingegneri (non parliamo dei giornalisti) che essendo espostissimi al rischio di
condanna (anche senza dolo e senza colpa grave) se vogliono sottoscrivere una
assicurazione devono pagare migliaia e migliaia di euro. Diciamo che il
privilegio non è affatto toccato da questa riformetta. Appena appena scalfito. E
allora? Il fatto è che comunque la riforma ha un valore ideale, è una specie di
metafora. Il Parlamento, per una volta, non si è inginocchiato davanti alla
magistratura. E’ questa la novità che ha messo in allarme i settori più
corporativi della magistratura. Il timore è che davvero possa cambiare il clima
politico e possa essere aperta una via alle riforme vere, e al ridimensionamento
della ”Divina Giustizia”. No, la riforma non comporterà la caduta degli Dei.
Solo che gli Dei non sopportano gli oltraggi. Sono permalosi. E’ sempre stato
così, dai tempi di Omero. E questa legge è uno sberleffo inaccettabile, anche se
innocuo.
Magistrati: ecco perché non pagheranno mai.
La nuova riforma della responsabilità civile dei magistrati? Non cambierà nulla.
Perché l’arma è già spuntata in partenza, scrive Maurizio Tortorella su
“Panorama”. Vi hanno detto che adesso cambia tutto? È un bluff. Non hanno pagato
un euro negli ultimi 26 anni e non pagheranno nemmeno domani. Il 25 febbraio la
Camera ha approvato la nuova legge sulla responsabilità civile, e da allora
magistrati e giudici gridano all’indipendenza violata, strepitano all’attentato
alla Costituzione. I più vittimisti ne parlano addirittura come di una «punitiva
ditata negli occhi». Tutti paventano «uno tsunami di ricorsi». Ma è solo una
pantomima. Ne sono convinti molti giuristi e ne sono certi soprattutto gli
avvocati, che continueranno a non utilizzare lo strumento. Perché non funziona e
non funzionerà. Sergio Calvetti, penalista di Vittorio Emanuele di Savoia, ha
appena incassato 39 mila euro dalla Corte d’appello di Roma che ha riconosciuto
al suo cliente l’ingiusta detenzione del 2006, più danni accessori e d’immagine.
Calvetti, però, non è riuscito nell’impresa invocando la responsabilità civile
del magistrato che a Potenza condusse l’indagine, quell’Henry John Woodcock che
fu star di cento inchieste tanto roboanti quanto avare di risultati: «Abbiamo
ottenuto questo risultato come risarcimento da ingiusta detenzione» spiega il
legale «e questo anche se subimmo la pervicace volontà di trattenere in quella
sede il processo, pur senza alcuna competenza territoriale». Francesco Murgia,
con Calvetti difensore storico di Vittorio Emanuele, aggiunge che in realtà una
citazione per responsabilità civile fu presentata nei confronti di Woodcock nel
dicembre 2011, quando cadde l’ultima accusa contro il loro cliente. Ma fu
dichiarata inammissibile perché il tribunale stabilì fosse «non tempestiva»:
avrebbe dovuto partire nel giugno 2006, ai tempi dell’ordine di custodia
cautelare. Perché questo, assurdamente, prevede la legge (e oggi viene
confermato dalla sua riforma): che per agire il cittadino aveva due anni, ora
tre in base alla riforma. Con il trucco, però: perché l’orologio scatta dal
momento in cui l’arresto o il primo provvedimento cautelare viene respinto. «Ma
come faccio a iniziare un’azione di responsabilità, se sono ancora sotto
scacco?» protesta Murgia. È con ostacoli come questo che la Legge Vassalli,
varata il 13 aprile 1988 come (inadeguata) risposta al referendum radicale che
un anno prima, con l’80 per cento di sì, aveva cancellato tre articoli del
codice che proteggevano come un castello medievale magistrati e giudici dalle
azioni civili dei cittadini, ha continuato a garantire piena protezione alla
categoria. Da allora sono state appena 410 le azioni intentate da vittime di
malagiustizia, e sono state più che decimate dalla valutazione di ammissibilità,
il cosiddetto «filtro»: un giudizio preventivo svolto nel tribunale competente
per territorio. C’è chi, come Piercamillo Davigo, giudice di Cassazione e
fondatore della nuova corrente giudiziaria Autonomia e indipendenza, nonché
nemico della riforma, analizza il dato con sarcasmo: «La responsabilità civile
dei magistrati non è un problema, visto che i cittadini fanno poche domande».
Altri numeri in realtà dimostrano che in Italia un problema di malagiustizia
esiste, ed è grave. Prima della Legge Vassalli, dal 1945 al 1988, l’Eurispes e
l’Osservatorio permanente sulle carceri calcolano 4,5 milioni di errori
giudiziari. Possibile che dopo il 1988 il fenomeno sia scomparso? Certo che no.
Il punto è che le citazioni per responsabilità civile sono state poche perché la
legge non ha mai funzionato. Dal 1988 a oggi la Cassazione ha stabilito sette
risarcimenti in tutto, uno ogni 7,5 milioni di processi penali aperti nel
periodo. C’è il caso di un’azienda agricola grossetana fallita nel 1998 per
l’errato sequestro di una tenuta, deciso in un’inchiesta per reati ambientali
(500 mila euro risarciti). C’è il caso di un pm siciliano che nel 2002 non tenne
nel debito conto una serie di lettere, acquisite dai Carabinieri, che avrebbero
potuto evitare un omicidio-suicidio di coppia: i familiari della donna uccisa,
nel 2009, hanno ottenuto 95 mila euro. Ma in nessun caso, mai, lo Stato si è
rivalso sui pm o sui giudici ritenuti colpevoli di dolo o colpa grave. Nessuno
di loro ha mai pagato nulla. L’ultima pronuncia, per ora ferma al primo grado,
riguarda un’inchiesta guidata nel 2004 dall’ex pm calabrese Luigi De Magistris,
poi migrato in politica. Lo scorso 3 dicembre il Tribunale di Roma ha condannato
lo Stato a pagare meno di 25 mila euro a Paolo Antonio Bruno, un magistrato di
Cassazione che nel 2004 fu ingiustamente accusato di associazione mafiosa da De
Magistris. Si vedrà come finirà il caso. Non ha mai nemmeno pensato di avvalersi
della Legge Vassalli, invece, l’imprenditore calabrese Antonio Saladino, che
pure dal 2006 si proclama vittima di un’altra, mitica inchiesta di De Magistris:
la «Why not», che nel 2006 piazzò Saladino al centro di una ragnatela di
presunte corruttele ma poi si risolse praticamente in nulla: «Citarlo in
giudizio? Quell’inchiesta mi ha rovinato economicamente» dice Saladino «però io
non ci ho mai nemmeno pensato. Sarebbe stata una povera battaglia contro i
mulini a vento, e credo lo sarebbe anche oggi». È così. Avvocati e presunte
vittime di giustizia hanno presto capito che la Legge Vassalli era utile come un
cucchiaio bucato e hanno scelto altre strade. Dal 1991, per esempio, cioè da
quando esistono i risarcimenti per l’ingiusta detenzione, in 23.326 hanno
ottenuto un risarcimento: in 23 anni lo Stato ha versato loro 581 milioni di
euro. La riforma, purtroppo, rischia di non cambiare nulla. «Oggi i magistrati
si lamentano, ma è lo stesso vacuo bla-bla di 26 anni fa, con le medesime parole
d’ordine» dice Gian Domenico Caiazza, penalista romano e presidente della
Fondazione Piero Calamandrei. Caiazza è un’autorità, in materia. Nell’aprile
1988 era nel collegio che, a nome di un Enzo Tortora morente di cancro, chiese
il risarcimento per il disastro giudiziario che cinque anni prima, a Napoli,
aveva coinvolto il giornalista in un’inchiesta su camorra e droga. Era stato
proprio il caso di Tortora, riconosciuto innocente dopo sette mesi di custodia
cautelare e una gogna aberrante, a dare il là al referendum e a garantirne il
successo. Nell’aprile 1988 la Legge Vassalli, appena varata, conteneva un
articolo che ne impediva l’applicazione retroattiva. Poiché il referendum aveva
abrogato le norme antecedenti, i difensori di Tortora si trovarono nella
peculiare situazione di agire senza limiti. «Per la prima e forse unica volta
nella storia di questo Paese facemmo causa ai magistrati come se fossero normali
cittadini» ricorda Caiazza. «Ma poi il Tribunale di Roma passò la palla alla
Consulta. Questa stabilì che l’articolo sulla irretroattività della Legge
Vassalli era incostituzionale nella sola parte che riguardava il filtro sulla
fondatezza delle nostre pretese: quella mancanza violava il principio
d’indipendenza e autonomia della magistratura». Insomma: il filtro del giudizio
di ammissibilità doveva esserci, per forza. Risultato? «A quel punto per il
risarcimento avremmo dovuto partire daccapo» dice Caiazza «ma con quella
pagliacciata avevamo perso due anni. Decidemmo di lasciar perdere». Il ricordo
dell’avvocato di Tortora è preciso (la sentenza della Consulta è la n. 468 del
22 dicembre 1990) e oggi fa scoppiare come una bolla di sapone la principale,
presunta innovazione della riforma appena varata. Caiazza ne è certo: «La
questione sull’abolizione del filtro potrà essere sottoposta in ogni momento
alla Corte costituzionale, che con tutta probabilità confermerà il suo
orientamento di 25 anni fa». Anche Davigo è d’accordo: «La Consulta si è già
pronunciata: l’eliminazione del filtro, con tutta evidenza, è costituzionalmente
illegittima». Suona quindi troppo ottimista il tweet di Gaia Tortora, che la
sera in cui è stata varata la riforma l’ha salutata come una vittoria alla
memoria di suo padre (e il premier Matteo Renzi si è subito appropriato di
quella generosa certificazione con un re-tweet). Anche perché intanto il
ministro della Giustizia, Andrea Orlando, si sbraccia per tranquillizzare
l’Associazione nazionale magistrati. Il Guardasigilli ha già garantito alla
categoria che non c’è nulla di cui preoccuparsi, che il governo «non ha alcun
intento punitivo», che «resterà deluso chi si aspetta che i giudici siano
condannati ogni due per tre», e addirittura che tra sei mesi sarà fatto «un
tagliando» per verificare «eventuali eccessi». Nella storia d’Italia non s’era
mai vista una legge con «retromarcia integrata». Beniamino Migliucci, presidente
dei penalisti, è critico: «Il tagliando è un’assurdità giuridica e politica. E
chi ipotizza una valanga di ricorsi fa disinformazione. Perché un imputato non
può citare il suo giudice: il ricorso è improcedibile, impossibile, fino a
quando non c’è una sentenza di Cassazione». Anche Giuseppe Di Federico, docente
emerito di diritto penale a Bologna e tra i maggiori giuristi italiani, è
scettico: «Non credo cambierà nulla. La nostra giustizia è del tutto
deresponsabilizzata: la valutazione delle carriere dei magistrati fa passare
tutti, al contrario di quanto accade in altri Paesi, e manca un vero sistema
sanzionatorio. E poi voglio proprio vederli, gli avvocati, che si espongono a
fare causa al loro giudice…». Una causa, oggi, non la farebbe nemmeno Pardo
Cellini, il penalista che pure ha scoperchiato il più grave errore giudiziario
italiano di tutti i tempi: quello che è costato 39 anni di processi a Giuseppe
Gulotta, un muratore trapanese che nel 1976, a 18 anni, fu arrestato per
l’omicidio di due carabinieri e solo dopo 22 anni di carcere, nel febbraio
2012, è stato riconosciuto innocente e liberato. Fin dalle prime udienze Gulotta
dichiarò che la confessione gli era stata estorta con violenze e torture da
parte dei Carabinieri. «E i suoi processi sono stati viziati da errori e lacune»
dice Cellini. «Però abbiamo preferito chiedere il risarcimento come danno da
errore giudiziario». Perché? Ma perché l’avvocato conosce a perfezione quali
siano le tortuosità della responsabilità civile: «È un sistema che non funziona
e non funzionerà» sospira. Il problema di Gulotta, che a 57 anni oggi vive della
carità di un parroco, è che sono trascorsi già 36 mesi dalla sua riabilitazione
ma non ha ancora visto un euro: l’avvocatura dello Stato si oppone, insiste
nella tesi paradossale che il processo fu originato dalla sua confessione, per
quanto estorta.«La vicenda Gulotta» conclude Cellini «mostra la resistenza dei
tribunali e il disinteresse delle istituzioni. E io non vorrei proprio dirlo, ma
temo che casi come il suo potrebbero accadere ancora. Per questo la
responsabilità civile va rivoluzionata». Più positivo, a sorpresa, è un
penalista che non ha mai simpatizzato con la magistratura: «La nuova legge è
equilibrata e migliorerà la situazione» dice Maurizio Paniz, ex deputato del Pdl
e avvocato di Elvo Zornitta, l’ingegnere veneto che fu ingiustamente accusato di
essere «Unabomber», l’autore di una serie di 30 attentati dinamitardi dal 1994
al 2004, con sei feriti. Scagionato nel 2009, oggi Zornitta sta per chiedere il
risarcimento allo Stato: non per responsabilità civile, però, ma ancora una
volta come riparazione di un errore giudiziario. Per partire, Paniz aspetta le
motivazioni della Cassazione che in dicembre ha condannato Ezio Zernar, il
poliziotto che confezionò false prove per incastrare Zornitta. «La nuova
responsabilità civile è migliore della vecchia» dice Paniz «perché specifica
come cause di punibilità la manifesta violazione della legge e il travisamento
delle prove. È un bene: a me sono capitati diversi processi in cui, a volte
dolosamente, una prova veniva valutata in modo errato». La morale? La tira
Grazia Volo, tra i più noti penalisti italiani: «Questa riforma arriva troppo
tardi, 28 anni dopo il referendum. È una riforme sfilacciata, scritta da un
legislatore superficiale e giustizialista, che intanto aumenta insensatamente le
pene. E non cambierà nulla». Una morale ancora più severa? Dice Carlo Nordio,
procuratore aggiunto di Venezia, da sempre controcorrente: «Il magistrato che
manda in galera un indagato contro la legge non deve pagare. Dev’essere buttato
fuori dalla magistratura». Chissà se il ministro Orlando ne terrà conto, nel suo
«tagliando».
Ma ora i magistrati saranno più responsabili?
La legge sulla responsabilità civile cambia poco. Con un rischio:
l'eliminazione del giudizio preventivo di ammissibilità potrà ingolfare i
tribunali, scrive Maurizio Tortorella su “Panorama”. Uno legge le cronache
giudiziarie di oggi, perse come sono tra gli altissimi lamenti sulla fine
dell'autonomia della magistratura e le infinite proteste di categoria, e pensa:
caspita, che rivoluzione dev'essere questa riforma della responsabilità civile.
Poi va a leggersi i 7 articoletti della legge e pensa: caspita, ma qui cambia
davvero poco. Perché, in base alla legge varata ieri in via definitiva dalla
Camera, da oggi in poi dovrebbe venire punito il magistrato che si macchia di
una "violazione manifesta della legge", oppure di un "travisamento del fatto o
delle prove". Ma questo cambia obiettivamente molto poco rispetto alla Legge
Vassalli dell'aprile 1988. Questa, fino a ieri, prevedeva che ogni cittadino
potesse chiedere i danni allo Stato se un magistrato adottava un atto o un
provvedimento giudiziario "con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue
funzioni, ovvero per diniego di giustizia"; e dava facoltà al cittadino "di
agire contro lo Stato" anche "per ottenere il risarcimento dei danni
patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della
libertà personale". Differenze? Mah... Ecco, sì, la nuova legge specifica meglio
che da oggi il cittadino può chiedere anche la punizione del magistrato che ha
sbagliato nell'emissione di "un provvedimento cautelare personale o reale fuori
dai casi consentiti dalla legge, oppure senza motivazione". Quanto al resto,
poco cambia. Sì, è vero, si allungano di un anno (da due a tre) i termini per
avviare l'azione legale. E oggi il governo è obbligato a esercitare l'azione di
rivalsa nei confronti del magistrato ritenuto colpevole. Aumenta anche la quota
di stipendio che il magistrato stesso dovrà restituire allo Stato: al massimo
metà del suo stipendio di un anno (prima era un terzo), senza però che si possa
superare un terzo del suo stipendio mensile nel caso di pagamenti mediante
trattenuta. Ma queste non sono certo modifiche sostanziali. E allora? Non cambia
davvero nulla? No: una modifica sostanziale riguarda il cosiddetto "filtro". La
Legge Vassalli all'art. 5 prevedeva infatti che la domanda di risarcimento
presentata dal cittadino dovesse ricevere una valutazione preventiva di
ammissibilità: in tre gradi di giudizio (fra tribunale, corte d'appello e
Cassazione) i giudici dovevano stabilire se la domanda fosse o no
"manifestamente infondata". Così, per stabilire se un magistrato dovesse
effettivamente pagare per un suo errore, servivano così nove gradi di giudizio:
tre per stabilire l'ammissibilità del giudizio, tre per stabilire il fatto in
sé, e altri tre per la rivalsa da parte dello Stato nei confronti del magistrato
che aveva agito con dolo o colpa grave. È per questo che pochissimi finora hanno
pagato. Per darvi un'idea: tra 1988 e 2014 tale è stata la fiducia degli
italiani nella Legge Vassalli che sono state presentate in tutto 410 domande,
davvero poche. Quelle ritenute "ammissibili" sono state appena 35, nemmeno una
su dieci, e di queste soltanto sette alla fine sono state accolte (per
l'esattezza 2 a Perugia e una a testa a Brescia, Caltanissetta, Messina, Roma,
Trento). La riforma, però, abolisce il giudizio di ammissibilità e l'art. 5.
Questo riduce a sei i gradi di giudizio. Secondo alcuni c'è il rischio che
questo possa esporre i tribunali italiani a una valanga di ricorsi. Tant'è vero
che i magistrati sono riusciti a strappare al governo l'impegno a fare un
"tagliando" della riforma tra sei mesi. Sul punto è abbastanza scettico invece
Giuseppe Di Federico, uno dei primi giuristi italiani (è docente emerito di
diritto penale a Bologna ed ex membro del Csm), che nel 1987 fu tra i promotori
del vittorioso referendum radicale sulla responsabilità civile, poi rintuzzato
dalla Legge Vassalli. "Non mi attendo uno tsunami di ricorsi" dice a Panorama.it
"perché mi domando quanti avvocati saranno disposti a esporsi in casi di questo
genere. E comunque prevedo un estremo rigore da parte dei tribunali".
Berlusconi, vent’anni di rapporti con la magistratura. Dalle
«toghe rosse» ai ringraziamenti per i giudici della Cassazione che hanno
confermato l’assoluzione nel processo Ruby. Dal 22
novembre 1994 - data in cui Berlusconi, capo del governo, riceve un invito a
comparire dalla Procura di Milano che sta indagando sulle tangenti alla Guardia
di finanza - fino a oggi, sono stati altalenanti e spesso conflittuali i
rapporti del leader di Forza Italia con la magistratura, scrive “Il Corriere
della Sera”.
1. Il pool «Mani Pulite» e l’avviso di garanzia del 1994.
Il primo interessamento della giustizia nei confronti di
Berlusconi risale al 1983 quando la Guardia di finanza segnalò un suo presunto
coinvolgimento in un traffico di droga con la Sicilia. L’inchiesta venne
archiviata. La prima condanna, invece, è del 1990: la Corte d’appello di
Venezia, dichiara Berlusconi colpevole di aver giurato il falso davanti ai
giudici, a proposito della sua iscrizione alla lista P2. Nel settembre 1988,
infatti, in un processo per diffamazione da lui intentato contro alcuni
giornalisti, Berlusconi aveva dichiarato al giudice: «Non ricordo la data esatta
della mia iscrizione alla P2, ricordo che è di poco anteriore allo scandalo».
Nonostante la Corte d’appello di Venezia dichiari Berlusconi colpevole (il
giudice era Luigi Lanza), il reato è considerato estinto per l’amnistia del
1989. Il 22 novembre del 1994 Berlusconi, capo del governo, mentre presiede la
Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla criminalità transnazionale, riceve
un invito a comparire dalla Procura di Milano che stava indagando sulle tangenti
alla Guardia di finanza. Le tangenti servivano per alleggerire le verifiche alle
società Mondadori, Mediolanum, Videotime, Telepiù: in primo grado Berlusconi è
stato condannato a 2 anni e 9 mesi; in appello, grazie alle attenuanti
generiche, è scattata la prescrizione.
2. All Iberian, dalle accuse alla prescrizione.
Il 12 luglio 1996 Silvio Berlusconi, l’ex segretario del Psi
Bettino Craxi, l’amministratore delegato di Mediaset Ubaldo Livolsi vengono
rinviati a giudizio con altre nove persone per l’ inchiesta sul presunto
finanziamento illecito della Fininvest, attraverso la società All Iberian, al
Psi nel 1991. Il processo inizia il 21 novembre 1996 davanti ai giudici della
seconda sezione penale del tribunale di Milano. Il pm Francesco Greco chiede per
Berlusconi 5 anni e 6 mesi di reclusione e 12 miliardi di multa poi, dopo lo
stralcio del reato di falso in bilancio, riformula la richiesta in due anni e
mezzo di reclusione e 12 miliardi di multa. Nel 1998 Berlusconi viene condannato
in primo grado (2 anni e 4 mesi). «I giudici hanno riscritto il codice penale
per allineare le norme alle esigenze repressive della procura» dichiara
Berlusconi. In appello però, nel 2000, sempre per le attenuanti generiche scatta
la prescrizione.
3. Colombo, il caso Lentini e la prescrizione.
C’e’ anche un capitolo «sportivo»: versamento in nero di una decina di miliardi
dalle casse del Milan a quelle del Torino, per l’acquisto di Gianluigi Lentini.
Il dibattimento si conclude con la dichiarazione che il reato è prescritto,
grazie alla legge che abolisce il falso in bilancio. È lo stesso pubblico
ministero Gherardo Colombo a chiedere l’applicazione della prescrizione, dopo
che il tribunale respinge la sua eccezione di incostituzionalità della normativa
varata nel marzo 2002 in materia di falso in bilancio.
4. Il tribunale civile e il risarcimento a De Benedetti.
Berlusconi è poi coinvolto in una lunga serie di processi per
la corruzione dei giudici romani in relazione al Lodo Mondadori e al caso Sme.
Sono i processi che hanno protagonista Stefania Ariosto, il teste «Omega» e
Cesare Previti. Condanne per Cesare Previti e il giudice Metta. Per quanto
riguarda il Lodo Mondadori, dopo una guerra durata vent’anni, si stabilisce che
Berlusconi deve risarcire De Benedetti. Luigi de Ruggiero, Walter Saresella e
Giovan Battista Rollero sono i tre giudici della seconda sezione civile della
Corte d’Appello di Milano che emettono la sentenza nell’ambito della vicenda del
Lodo Mondadori che condanna Fininvest al pagamento di circa 560 milioni di euro.
La cifra diventa 494 milioni dopo la Cassazione.
5. De Pasquale e l’accusa nel caso Mills, ma è prescrizione.
Le procure di Caltanissetta e Firenze che hanno indagato sui mandanti a volto
coperto delle stragi del 1992 e del 1993 hanno svolto indagini sull’eventuale
ruolo che Berlusconi e Dell’Utri possono avere avuto in quelle vicende.
L’inchiesta è stata chiusa con l’archiviazioni nel 1998 (Firenze) e nel 2002
(Caltanissetta). La procura di Palermo, inoltre, ha indagato su Berlusconi per
mafia: concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio di denaro sporco.
Nel 1998 l’indagine e’ stata archiviata per scadenza dei termini massimi
concessi per indagare. Definitiva la prescrizione per il caso Mills, l’avvocato
inglese che avrebbe ricevuto 600 mila euro da Berlusconi per testimonianze
reticenti ai processi per All Iberian e tangenti alla Gdf. A sostenere l’accusa
contro Berlusconi il pm Fabio De Pasquale.
6. Caso Ruby, Boccassini è pubblica accusa.
Il procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini, insieme al pm
Antonio Sangermano, rappresenta la pubblica accusa nel processo di primo grado
sul caso Ruby. I rapporti di Berlusconi con Boccassini sono conflittuali. L’ex
premier respinge le accuse e condanna l’operato dei pm di Milano.
7. Tre donne per la condanna in primo grado.
Il 24 giugno 2013, nel processo Ruby, Silvio Berlusconi viene
condannato in primo grado a 7 anni per entrambi i reati contestati: concussione
per costrizione e prostituzione minorile. Il collegio della quarta sezione
penale del Tribunale di Milano che giudica Berlusconi è composto da donne: la
presidente Giulia Turri, che nel marzo del 2007 firmò l’ordinanza di arresto per
il “fotografo dei vip” Fabrizio Corona; Carmen D’Elia, che già nel 2002 aveva
fatto parte del collegio di giudici del processo Sme che vedeva come imputato,
tra gli altri, proprio Silvio Berlusconi; Orsola De Cristofaro, la terza
componente del collegio, con un passato da pm e gip, già giudice a latere nel
processo che ha portato alla condanna a quindici anni e mezzo di carcere per
Pier Paolo Brega Massone, l’ex primario di chirurgia toracica, imputato con
altri medici per il caso della clinica Santa Rita.
8. L’assoluzione in appello. Il presidente si dimette.
Il processo d’appello per il caso Ruby si tiene davanti alla seconda Corte
d’Appello: Enrico Tranfa è il presidente, Concetta Lo Curto e Alberto Puccinelli
i giudici a latere. Berlusconi viene assolto dal reato di concussione «perché il
fatto non sussiste» e dal reato di prostituzione minorile «perché il fatto non
costituisce reato». L’ex Cavaliere commenta che «la maggioranza magistrati è
ammirevole». Enrico Tranfa, il presidente, si dimette subito dopo aver firmato
le motivazioni della sentenza, in dissenso con la sentenza presa a maggioranza
con il sì degli altri due giudici. E così, dopo 39 anni di servizio, a 15 mesi
dalla pensione, il magistrato lascia anzitempo la toga. Tranfa ha esercitato la
professione in gran parte a Milano. Negli anni 90 è stato all’ufficio Gip. Come
giudice delle indagini preliminari, nel periodo di Mani Pulite, si era occupato
di uno dei filoni dell’inchiesta sugli appalti Anas e di quella sulla centrale
dell’Enel a Turbigo per cui dispose l’arresto, tra gli altri, dell’ex assessore
lombardo in quota alla Dc Serafino Generoso. Nel 2002 è stato nominato
presidente del Tribunale del Riesame sempre di Milano. Come giudice d’appello ha
confermato, tra l’altro, la condanna a tre anni di carcere per Ubaldo Livolsi
per la bancarotta di Finpart. Concetta Lo Curto, entrata in magistratura nel
1990, è stata giudice al Tribunale di Milano, prima all’ottava sezione penale e
poi alla terza dal 1995 al 2013 quando poi è passata in Corte d’Appello. Nel
2010 assolse l’allora deputato del Pdl Massimo Maria Berruti, imputato per la
vicenda Mediaset (la sua posizione era stata stralciata da quella di Berlusconi
e degli altri). Puccinelli, entrato in magistratura nell’89, è stato il giudice
relatore al processo di appello che si è concluso con la prescrizione per
Berlusconi, imputato per la vicenda del «nastro Unipol».
9. Processo Ruby, il pg De Petris contro l’assoluzione.
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione confermato l’assoluzione, che
diventa definitiva, di Silvio Berlusconi nel processo Ruby. Il sostituto
procuratore della Corte d’Appello Pietro De Petris aveva fatto ricorso in
Cassazione contro l’assoluzione.
10. Processo Mediaset, l’accusa di De Pasquale e Spadaro.
Il 18 giugno 2012 i pm di Milano Fabio De Pasquale e Sergio
Spadaro chiedono una condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione per Silvio
Berlusconi, imputato di frode fiscale nel processo sulle presunte irregolarità
nella compravendita dei diritti tv da parte di Mediaset. Il 26 ottobre 2012
l’ex premier viene condannato a 4 anni di reclusione, cinque anni di
interdizione dai pubblici uffici e tre anni di interdizione dagli uffici
direttivi delle imprese.
11. Pena più severa di quanto richiesto.
Il presidente del collegio che condanna Berlusconi in primo grado è Edoardo
D’Avossa con i giudici a latere Teresa Guadagnino e Irene Lupo). La pena è
maggiore di quanto chiesto dai pm. Berlusconi commenta: «È una condanna
politica, incredibile e intollerabile. È senza dubbio una sentenza politica come
sono politici i tanti processi inventati a mio riguardo».
12. Il giudice Galli conferma in appello.
L’8 maggio 2013, dopo quasi sei ore di camera di consiglio, i
giudici della seconda Corte d’Appello di Milano, presieduti da Alessandra Galli
(nella foto Brandi/Fotogramma), confermano la condanna a 4 anni di reclusione,
di cui tre coperti da indulto, per Silvio Berlusconi, accusato di frode fiscale
nell’ambito del processo sulla compravendita dei diritti tv Mediaset. Berlusconi
parla di «persecuzione» da parte della magistratura che vuole eliminarlo dalla
scena politica.
13. Esposito, la Cassazione e l’intervista contestata.
Il primo agosto 2013 la Cassazione conferma la condanna a quattro anni di
carcere. A leggere la sentenza sul processo Mediaset è il presidente della
sezione feriale della corte di cassazione Antonio Esposito. Nei giorni
successivi, il giudice Esposito finisce nella bufera per un’intervista a «Il
Mattino» in cui parla della sentenza sul processo Mediaset-Berlusconi. Lo stesso
magistrato farà seguire una smentita riguardo ad alcuni passaggi. In
particolare, Esposito smentisce anche «di aver pronunziato, nel colloquio avuto
con il cronista - rigorosamente circoscritto a temi generali e mai attinenti
alla sentenza, debitamente documentato e trascritto dallo stesso cronista e da
me approvato - le espressioni riportate virgolettate: “Berlusconi condannato
perché sapeva non perché non poteva non sapere».
10 marzo 2015. La Corte di Cassazione assolve.
Questa donna (la Boccassini) ha distrutto il Paese Ma resterà impunita. Anche un
magistrato come Emiliano si indigna: "Chieda scusa". E nonostante tutto Ilda
Boccassini rimarrà al suo posto come sempre, scrive Alessandro Sallusti su “Il
Giornale”. Per La Repubblica, Berlusconi non è un innocente perseguitato ma un
«colpevole salvato», come si evince dal titolo che racconta con stizza
dell'assoluzione definitiva in cassazione sul caso Ruby. Il Corriere della Sera
affida invece al suo segugio Luigi Ferrarella la difesa senza se e senza ma
dell'operato dei pm milanesi. Un ufficio stampa della procura non avrebbe saputo
fare di meglio e, ovviamente, Ferrarella tace sul fatto che lui stesso e
autorevoli colleghi del suo giornale nel corso di questi anni avevano già emesso
la sentenza di colpevolezza in centinaia di articoli nei quali si spacciavano
per prove certe i farneticanti teoremi dell'accusa. Non sappiamo invece il
commento di Ilda Boccassini, la pm che ha fatto da redattore capo di quella
grande messa in scena truffaldina ed esclusivamente mediatica che è stata
l'inchiesta Ruby. Una cosa però conosciamo. E cioè che la Boccassini, grazie a
questa inchiesta, è stata inclusa dalla rivista statunitense Foreign Policy al
57esimo posto nella lista delle personalità che nel corso del 2011 hanno
influenzato l'andamento del mondo nella politica, nell'economia, negli
esteri.Non stiamo parlando di un dettaglio. Anche dall'altra parte dell'Oceano
erano giunti alla conclusione che le notizie costruite dalla procura di Milano e
spacciate da Corriere e Repubblica non costituivano un mero fatto giudiziario ma
avevano contribuito in modo determinante a modificare giudizi sull'Italia con
ricadute decisive financo sul piano internazionale. Oggi, grazie alla sentenza
di Cassazione, sappiamo che si trattò di una iniziativa scellerata,
completamente falsa, paragonabile a un complotto per destabilizzare un Paese
sovrano. Complotto ordito da magistrati e sostenuto da complici, o almeno utili
idioti, nelle redazioni dei giornali nazionali ed esteri, nelle stanze di
governi stranieri e in quelle della politica di casa. A partire da quella più
prestigiosa del Quirinale, allora abitata da Giorgio Napolitano. Il quale non
solo non mosse un dito per fermare il linciaggio del suo primo ministro, ma,
proprio sull'onda di quella destabilizzazione, ricevette in segreto banchieri,
editori e imprenditori di sinistra per organizzare un controgoverno (Monti, per
intenderci) nonostante quello in carica godesse ancora della piena fiducia del
Parlamento. Alla luce di tutto questo, e in attesa che la Corte europea faccia
giustizia di un'altra bufala giudiziaria (la condanna di Berlusconi per evasione
fiscale, avvenuta grazie al trucco di assegnare la sentenza non al giudice
naturale, ma a un collegio costruito ad hoc, guarda caso su sollecitazione del
Corriere della Sera ), ora si pongono problemi seri che meritano risposte veloci
e all'altezza di un Paese libero e democratico. Riguardano la permanenza nelle
loro delicate funzioni dei responsabili e la riabilitazione politica della
vittima Berlusconi. Nessuno, su questo, può permettersi di fare il pesce in
barile.
Il giallo Tranfa e quei Servizi rimasti muti,
scrive Giovanni Maria Jacobazzi su “Il Garantista”. Il processo Ruby non è stato
un processo come tanti. Molti aspetti, oscuri, hanno connotato questa vicenda
penale che ha portato alla caduta di un governo e allo sfascio di un partito.
Tralasciando lo sputtanamento internazionale e il ludibrio planetario che hanno
investito Silvio Berlusconi e, di riflesso, il Paese. Due, principalmente, sono
gli episodi che fanno riflettere e che ad oggi non hanno avuto risposta. Episodi
che riguardano proprio l’inizio e la fine dell’inchiesta. Il primo riguarda le
modalità con cui sono state condotte le indagini preliminari da parte della
Procura della Repubblica di Milano. Il secondo le dimissioni del giudice Enrico
Tranfa, il presidente del collegio che in appello ha assolto Silvio Berlusconi
dopo la condanna in primo grado a sette anni. Per scoprire cosa accadesse la
sera nella residenza di Arcore, la Procura di Milano non ha lesinato energie.
Con un dispiegamento di forze senza pari in relazione ai tipo di reato
perseguito, una ipotesi di prostituzione minorile e di concussione, i
pubblici ministeri milanesi hanno posto in essere un numero elevatissimo di
intercettazioni telefoniche. Tranne Silvio Berlusconi che, essendo parlamentare,
non poteva essere intercettato, chiunque entrasse in contatto con Villa San
Martino si ritrovava il telefono sotto controllo. Decine di ragazze, ma non
solo, furono intercettate per mesi. Ogni loro spostamento
accuratamente monitorato. Centinaia i servizi di osservazione, controllo e
pedinamento come si usa dire in gergo questurile. All’epoca dei fatti, il 2009,
Silvio Berlusconi era il presidente del Consiglio. Il suo uomo più fidato,
Gianni Letta, sottosegretario di Stato con delega ai Servizi. Come è stato
possibile effettuare una attività investigata di queste proporzioni, migliaia
le intercettazioni effettuate, senza che nessuno, in maniera
ovviamente riservata, facesse arrivare il “messaggio” all’indagato eccellente
di prestare attenzione alle persone frequentate ed ai comportamenti da tenere?
Nessuna indicazione dai gestori telefonici? Nessun dubbio circa questa anomala
concentrazione di utenze sotto controllo proprio nella residenza privata del
presidente del Consiglio, sottoposta a misure di massima sicurezza secondo la
legge 801 che disciplina il segreto di Stato? Ma il rapporto anomalo con
gli apparati di sicurezza è anche alla base dell’accusa più grave caduta sulla
testa di Berlusconi. Quella di concussione nei confronti del capo di gabinetto
della Questura di Milano. Come mai il presidente del Consiglio, residente a
Milano, città dove ha il centro dei suoi interessi e dove vive la sua famiglia,
non si rivolge, per motivi di opportunità e riservatezza, direttamente
al Questore ma passa attraverso il suo capo di gabinetto, peraltro chiamatogli
al telefono dal suo capo scorta? Essendo il Consiglio dei ministri preposto alla
nomina dei questori delle città, non si può proprio dire che l’allora premier
non conoscesse chi fosse al vertice della pubblica sicurezza del capoluogo
lombardo. E infine le dimissioni improvvise e inaspettate del giudice
Enrico Tranfa, il presidente del collegio di Appello che ha assolto
Silvio Berlusconi, subito dopo il deposito delle 330 pagine delle motivazioni
della sentenza. Come si ricorderà, dopo aver depositato la sentenza di
assoluzione, Enrico Tranfa fece domanda per essere collocato in pensione.
Poteva restare in servizio altri quindici mesi. Decise di anticipare l’uscita
dalla magistratura. Campano di Ceppaloni, il paese che ha dato i natali anche a
Clemente Mastella, collocabile nella corrente di Unicost, Tranfa era dal 2012 a
Milano in Corte d’Appello come presidente della seconda sezione penale.
Equilibrato, molto preparato, mai una parola fuori posto. Un persona mite. Nulla
che potesse far prevedere una reazione del genere. Le sue dichiarazioni, a chi
gli chiedeva il perché di una simile decisione, furono soltanto “è una decisione
molto meditata, perché in vita mia non ho fatto niente di impulso. Tutti
sono utili, nessuno è indispensabile”. Per poi aggiungere: “Il compito di un
giudice non è quello di cavillare con i tecnicismi, ma prendere un fatto,
valutarlo alla luce delle norme, e poi fare un atto di
volontà, decidendo. Altrimenti è la giustizia di Ponzio Pilato”. Sul caso montò
la contrapposta lettura politica: “Solidarietà” dal Pd e dure critiche da Forza
Italia. Le dimissioni in polemica con l’assoluzione scatenarono anche le ire del
presidente della Corte d’Appello Giovanni Canzio. “Se dettate da un personale
dissenso per l’assoluzione di Silvio Berlusconi non appaiono coerenti con le
regole ordinamentali e deontologiche che impongono l’assoluto riserbo sulle
dinamiche della Camera di consiglio”, disse Canzio, “trattasi di un gesto
clamoroso e inedito”. Se per ogni disaccordo in un collegio il magistrato
dovesse dimettersi, in magistratura rimarrebbero in pochi. Ma quell’anomalia,
come la prima, con ogni probabilità rimarrà senza risposta.
Processo Ruby, pool di Milano: le lettere segrete delle toghe
rosse alla giudice che assolse Silvio Berlusconi,
scrive “Libero Quotidiano”. Le toghe rosse di Milano si attendevano
l'annullamento dell'assoluzione in secondo grado. Volevano Silvio
Berlusconi di nuovo alla sbarra nel processo Ruby. Ma così non è
andata. Confermata l'assoluzione. E dopo la conferma, oltre al Cav, ci sono
state diverse persone che si sono levate dei sassolini dalle scarpe. Una di
queste era la giudice Concetta Locurto, toga stimata e
progressista, già coordinatrice milanese di Area, il cartello tra le correnti di
sinistra di Magistratura Democratica. Una, insomma, che aveva il "pedegree"
giusto per condannare Berlusconi in secondo grado. Già, perché la Locurto la
scorsa estate era la relatrice della sentenza di assoluzione del Cav nel
processo Ruby. L'assoluzione scatenò un vespaio di polemiche in
magistratura, culminate con le dimissioni del suo collega e presidente del
collegio, Enrico Tranfa, che con il passo indietro volle
dissociarsi da un verdetto che non condivideva. La Locurto, al tempo, non volle
commentare. E non ha voluto commentare neppure dopo la conferma dell'assoluzione
che, nei fatti, ha confermato la bontà del suo operato. E il silenzio le deve
essere costato, perché come spiega il Corriere della Sera la toga che
ha assolto Berlusconi ha vissuto mesi da incubo, tra "attacchi
e implicite insinuazioni di cosa di oscuro potesse essere accaduto attorno al
processo" per spingere Tranfa alle dimissioni. Ha taciuto, la Tranfa. Almeno in
pubblico. Già, perché secondo quanto scrive sempre il Corsera, la toga
avrebbe scritto una piccola lettera ai colleghi (agli stessi colleghi che nei
mesi precedenti tempestavano la sua email parlando di "torsione del diritto").
Il Corsera ha provato a chiederle del contenuto della lettera, ma la
Tranfa, fedele alla sua riservatezza, ha scelto di non parlare.
Eppure qualcosa è emerso. Nonostante il rifiuto della giudice, è stato
ricostruito quanto abbia detto interpellando i destinatari della missiva. La
Tranfa non giudicava la bontà della sentenza, ma metteva in guardia dai rischi
di "una malevola dietrologia faziosa", del "pregiudizio", dei
"pensieri in libertà da chiacchiera da bar" della quale è stata vittima per mesi
per aver fatto il suo lavoro, che nella fattispecie prevedeva di assolvere
Berlusconi. La Tranfa avrebbe scritto dei "magistrati che giudicano senza
conoscere, finendo - proprio loro - per partecipare al tiro al piccione
senza alcun rispetto per l'Istituzione e le persone". E il piccione, in quel
momento, era proprio lei. E il "piccione", ora, si toglie le sue soddisfazioni.
Nella missiva avrebbe aggiunto l'invito ai colleghi ad "andarsi a rileggere i
provvedimenti redatti nel corso dell'intera carriera, piccoli o grandi che
fossero, per avere certezza dell'identità di metro di valutazione
utilizzato indifferentemente per extracomunitari e potenti". Quel metro di
giudizio imparziale che però, i colleghi, le rimproverano: se c'è il Cav alla
sbarra deve essere condannato.
Filippo Facci su “Libero Quotidiano”: logica da pm. Se Silvio Berlusconi
conosce Noemi Letizia, è colpevole. La Cassazione doveva confermare o non
confermare l’assoluzione di Silvio Berlusconi (caso Ruby) per
concussione e prostituzione: dopodiché, lo schema era il solito. La Corte che si
riunisce nel primo pomeriggio, i giornalisti italiani e stranieri che ciacolano,
la consueta assicurazione che la sentenza arriverà «in serata» e che perciò
potranno scriverne, hurrà. Ma forse i giudici non erano aggiornati: non sapevano
che i quotidiani hanno le chiusure sempre più anticipate, mannaggia: come
possono non tener conto delle sacre esigenze mediatiche? Come possono aver
saltato i telegiornali della sera? I giudici (presidente Nicola Milo,
consiglieri Giorgio Fidelbo, Stefano
Mogini e Gaetano De
Amicis) dovevano prendere esempio dal procuratore generale Eduardo
Scardaccione, che nel pomeriggio aveva esposto una requisitoria mediaticamente
perfetta. Niente di strano che abbia chiesto di annullare - con rinvio in
Appello - l’assoluzione di Berlusconi per entrambi i reati: è ciò che ci si
attendeva da lui, un’apologia di quel processo che in primo grado aveva
condannato il Cav a sette anni. Mentre invece le assoluzioni di luglio scorso -
pochi mesi fa: la giustizia italiana sa essere velocissima - secondo
Scardaccione andavano polverizzate: altro che «il fatto non sussiste»
(concussione) e «il fatto non costituisce reato» (prostituzione minorile). Sin
qui tutto normale. Ma sono altri argomenti che ha adottato - poi - a farci
pensare ancora una volta che taccuini e telecamere andrebbero tenuti lontani dai
palazzi di giustizia. Scardaccione ha detto che le accuse sono «pienamente
provate» (vabbeh) e che la Corte d’appello non doveva riaprire il processo bensì
rideterminare la pena di primo grado: e ci sta anche questo. Poi lo show:
«L’episodio nel quale Berlusconi racconta che Ruby è la nipote di Mubarak è
degno di un film di Mel Brooks e tutto il
mondo ci ha riso dietro». Uhm. Purtroppo «il mondo» non ha testimoniato a
processo. E neppure Mel Brooks. A ogni modo il procuratore Scardaccione
ha proseguito spiegando che la concussione c’è stata, anzi «c’è stata una
violenza irresistibile» per ottenerla. Lo proverebbe il fatto che dal momento in
cui ha ricevuto la telefonata di intervento da Berlusconi il capo di gabinetto
della Questura di Milano «non capisce più nulla e fa ben 14 telefonate: c’è
spazio per ritenere che la pressione fosse resistibile?... No... L’intervento ha
avuto una potenza di fuoco tale da annullare le scelte autonome del
funzionario». Par di capire che qualsiasi telefonata di Berlusconi in quel
periodo - essendo lui premier ed essendo Berlusconi - avesse una potenziale
valenza concussoria: chiunque ne riceveva una andava praticamente in
palla e veniva annullato nella volontà, una forma di ipnosi. Il
procuratore generale non ha contemplato che i dirigenti della Questura fossero
banalmente eccitati all’idea di poter fare un favore al presidente del
Consiglio: cosa che avrebbe avuto una valenza più che ambigua se solo avessero
fatto qualcosa che non dovevano fare. Ma ciò che fecero (identificazione di
Ruby, foto segnalazione e ricerca di una comunità per l’affido) corrispondeva
alla prassi in vigore. Ma secondo Scardaccione no, c’è stata «una violenza
grave, perdurante e irresistibile anche a margine della consegna di Ruby a
Nicole Minetti». Il dettaglio è che l’idea di consegnare Ruby alla Minetti non
fu un’idea di Berlusconi bensì una soluzione escogitata in questura. Ma -
possiamo dirlo? - ci sta anche questo. È passando al reato di prostituzione
minorile che si giunge all’incredibile: perché Scardaccione ha tirato in ballo
Noemi Letizia, una ragazza che non c’entra un accidente - mai tirata in
ballo in nessun processo, in nessun modo - perché la circostanza che Noemi e
Ruby fossero due minorenni «non è una coincidenza» e rende «non
credibile» che Berlusconi non sapesse della minore età di Ruby. Scardaccione ha
ricordato quanto aveva detto Ruby in un’intercettazione: «Noemi è la sua pupilla
e io il suo culo». Cioè: il fatto che due amici di Berlusconi avessero una
figlia minorenne non poteva essere un caso. E chissà - aggiungiamo noi -
quanti milioni di elettori di Forza Italia, negli ultimi vent’anni,
hanno avuto figlie minori. Insomma: se Berlusconi sapeva che la figlia di due
suoi amici era minorenne, beh, doveva sapere anche l’età di tutta la carovana di
signorine che la sera gli portavano a casa con la carriola. Pagandole, certo:
perché Franco Coppi, l’avvocato di Berlusconi, ieri non l’ha negato: «La
sentenza d’appello ammetteva che ad Arcore avvenivano fatti di
prostituzione, cosa che non contestiamo nemmeno noi difensori: ma
manca, in fatto, la prova che Berlusconi prima del 27 maggio sapesse che Ruby
era minorenne». Sempre che i processi si facciano ancora con le prove.
Il caso Ruby c’è costato mezzo milione.
Per i pm le spese ammontano a 65mila euro, ma facendo altri calcoli si sfiorano
i 600mila, scrive Simone Di Meo su “Il Tempo”. Quanto è costata l'inchiesta Ruby
alle casse dello Stato? La classica domanda da un milione di dollari ha una
doppia risposta. La versione minimalista, accreditata dai conti della Procura
della Repubblica di Milano contenuti nel faldone 33 del procedimento, parla di
appena 65mila euro così suddivisi: in sei mesi sono stati pagati 26mila euro per
le intercettazioni e 39mila euro per trascrizioni di interrogatori, traduzioni
dall’arabo, per il noleggio auto, la più costosa delle quali - una Golf - è
stata pagata 4mila euro, e per l’acquisto di registratori digitali. Pochi
spiccioli anche per le trasferte dei poliziotti in alcuni hotel di Rimini: poco
meno di 200 euro per tre diversi viaggi. Insomma, per questa scuola di pensiero
il procedimento penale del pm Ilda Boccassini non ha prosciugato le casse del
ministero della Giustizia ma si è mantenuto addirittura al di sotto dello
standard della Direzione distrettuale antimafia. Questione risolta, allora? Mica
tanto perché a questa immagine light dell'inchiesta se ne contrappone una più
approfondita che zavorra con almeno uno zero la cifra iniziale portandola a
oltre mezzo milione di euro. Ci sono alcuni costi che, nel computo del pubblico
ministero, non vengono infatti elaborati. Sarà sicuramente una distrazione, ma
bisogna fare chiarezza. Stiamo parlando dei cosiddetti costi fissi che
riguardano l'utilizzo della polizia giudiziaria per condurre un'indagine fatta a
pezzi dalla Corte d'appello e dalla Cassazione dopo una prima condanna a sette
anni nei confronti di Silvio Berlusconi. Un'indagine fondata su due capi di
imputazione che tecnicamente non hanno retto al vaglio delle toghe. Perché è
vero che un poliziotto o un carabiniere viene ugualmente stipendiato dallo Stato
(e ci mancherebbe) ma c'è un particolare di cui non tutti si ricordano: il
poliziotto o il carabiniere in questione avrebbe potuto essere impiegato su un
altro versante giudiziario, magari più interessante e utile. E questo - dal
punto di vista aziendalistico - è un costo che non può essere omesso se si vuole
davvero fare una descrizione esatta del valore contabile del fascicolo Ruby.
Dare per scontate queste voci di costo è un errore. Così come è un errore non
calcolare il noleggio dell'apparecchiatura utilizzata per geolocalizzare i
cellulari che hanno agganciato la cella di Arcore alla ricerca delle utenze
delle partecipanti alle "cene eleganti". Un'attrezzatura che, secondo quanto
risulta a Il Tempo costa in media 1000 euro al giorno: è probabile che fosse già
in dotazione agli uomini del Servizio centrale operativo cui sono state delegate
le attività investigative, ma il suo utilizzo, in termini economici, dev'essere
adeguatamente riportato nello schema della Procura. I "target" di
intercettazioni e acquisizioni di traffico telefonico e di tabulati sono stati
circa trenta per oltre 115mila conversazioni monitorate. Nell'intera operazione
è presumibile che siano stati impegnati oltre cento poliziotti che, per la
durata delle indagini, sono stati distolti da altri fascicoli, ovviamente. Non
sbirri qualunque, ma uomini dello Sco, l'organo investigativo di punta del
Viminale che solitamente dà la caccia a mafiosi, narcotrafficanti e serial
killer. Per dire: i due superlatitanti del clan dei Casalesi, Antonio Iovine e
Michele Zagaria, sono stati presi anche con la collaborazione del Servizio
centrale. Che, nel caso in esame, è stato invece sguinzagliato sulle tracce
delle olgettine e del ragionieri Spinelli, lauto pagatore ufficiale del Cav.
Anche i loro stipendi, anche i loro straordinari, anche i loro ticket sono dei
costi a carico dello Stato (e quindi dei cittadini) che devono essere inseriti
nel bilancio Ruby. Alla fine, calcoli alla mano, l'indagine di "Ilda la rossa"
tra costi fissi (quelli appena descritti, che riguardano l'intera struttura) e
costi variabili (i famosi 65mila euro, che dipendono appunto dalle necessità
investigative del momento) ha gravato sulle casse dello Stato per circa 600mila
euro. È una stima prudenziale ma che ha un suo fondamento considerato che un
poliziotto viene pagato in media 100 euro lordi al giorno. Qualcuno ci
aggiungerebbe anche i costi dei processi (stipendi dei giudici, dei cancellieri,
del personale amministrativo, fotocopie) ma entriamo nel fantastico mondo delle
ipotesi e allora tutte le ricostruzioni sono possibili.
Signori del Csm, quell’inchiesta è senza ombre?
Scrive Tiziana Maiolo su “Il Garantista. Sono politici, non morali, i motivi per
cui è andato in onda per cinque anni il Pornofilm del Bungabunga che ha messo
nel tritacarne un presidente del Consiglio, preso a picconate il suo partito,
distrutto la sua reputazione nel mondo, insieme alla sua immagine personale e i
suoi affetti. Tutto nasce non tanto dal fermo, in una serata di maggio del 2010,
di una giovane marocchina. Né dalla successiva telefonata di Berlusconi alla
questura di Milano. Casomai dall’uso che dell’episodio venne fatto dalla Procura
della Repubblica più famosa e discussa d’Italia. E’ negli uffici del quarto
piano del palazzo di giustizia di Milano, già allenati dalla caccia
al cinghialone ai tempi di Craxi e di Tangentopoli, che parte la crociata di
stampo talebano che prende di mira il presidente del Consiglio per i suoi
costumi sessuali. Ma il Pornofilm è solo l’involucro, un uovo di pasqua con
sorpresa. La sorpresa è tutta politica. Se il Consiglio superiore della
magistratura volesse occuparsene, potrebbe rilevare parecchie anomalie, dentro
quell’uovo. Prima cosa: Ruby viene fermata e rilasciata in una notte di
fine maggio. Che cosa è successo tra quella data e quella in cui Silvio
Berlusconi viene iscritto nel registro degli indagati (21 dicembre 2010) e
in seguito raggiunto da un invito a comparire (14 gennaio 2011)? Succede che
Ruby viene ripetutamente interrogata, una serie di persone che frequentavano la
casa di Arcore viene monitorata e intercettata e si tende la tela del ragno che
deve catturare la preda. Che la preda sia un Arcinemico di certa magistratura e
certi Pubblici ministeri non è un segreto. Che dalle parti di Milano si usino
metodi disinvolti sulle competenze territoriali (un presidente del Consiglio non
dovrebbe essere giudicato dal Tribunale dei ministri?) è cosa altrettanto
nota. Ma quel che succede a Milano è qualcosa di ben più mostruoso: per
sette-otto mesi vengono fatte indagini su un contesto che ha al centro
una persona che non è indagata, vengono disposte intercettazioni a persone che
parlano al telefono con un parlamentare senza che sia chiesta, come prescrive la
legge, l’autorizzazione alla Camera di appartenenza. Nei fatti si indaga su
una persona in violazione delle normali procedure di legge. A nulla valgono le
proteste degli avvocati, le interrogazioni parlamentari del deputato di Forza
Italia Giorgio Stracquadanio, la curiosità che comincia a serpeggiare
nella stampa italiana e anche straniera. La Procura di Milano tira dritto.
Apparentemente arrogandosi il diritto di moralizzare i costumi altrui, in realtà
con obiettivi ben più ambiziosi. Ma un’altra anomalia esplode clamorosa a
un certo punto, la rissa da cortile tra il procuratore capo Bruti Liberati e il
suo aggiunto Robledo sulle competenze tematiche e le assegnazioni delle
inchieste. Perché le indagini su Berlusconi e il “caso Ruby” vengono assegnate a
Ilda Boccassini, titolare delle inchieste sulla mafia e non a Robledo che si
occupa di Pubblica Amministrazione? Berlusconi non è forse accusato di aver
abusato del suo potere di presidente del Consiglio, con quella famosa telefonata
in questura che gli costerà la condanna in primo grado per concussione? Questo
aspetto della vicenda giace nelle scartoffie (nei fatti archiviate) del Csm
sulla querelle Bruti-Robledo, che nessuno pare avere la curiosità di esaminare
più. Sarebbe bene, invece, che l’organo di autogoverno di Pm e giudici
riaprisse gli occhi, su questo punto, e si chiedesse “perché” fosse così
importante quella sostituzione di Robledo con Boccassini in un’inchiesta dal
sapore squisitamente politico. Questo è il succo della vicenda: forzature
e anomalie per il raggiungimento di uno scopo. Addirittura il procuratore
generale di Milano, pur di fare il ricorso in Cassazione, si è appellato a
questioni di merito, trascurando il fatto che il terzo grado di giudizio
può riguardare solo questioni di legittimità. Un’altra delle anomalie
“lombarde”, che la Cassazione avrebbe dovuto rilevare subito, rigettando
il ricorso in dieci minuti. Nove ore di discussione sono un bel tributo
alle tricoteuses di tutta Italia. In ogni caso,tutto il resto è contorno, il
Pornofilm, il Bungabunga, sparsi a piene pani tramite un ventilatore in funzione
permanente con lo scopo dello Sputtanamento. Oggi, con Berlusconi che porta
a casa con una certa velocità (quattro anni per tre gradi di giudizio
sono un’altra, piacevole, anomalia) l’assoluzione piena da due reati infamanti,
resta il reato di Sputtanamento ancora vivo e vegeto nelle immagini del
Pornofilm, tanto che gli avvocati sono stati costretti a dire (un po’ andando di
fantasia) che, in fondo si, forse un po’ di prostituzione ad Arcore c’è stata,
per rafforzare la realtà dei fatti sulla non conoscenza dell’età di una
quasi-diciottenne che dimostrava, a detta di tutti, almeno venticinque anni. E
che probabilmente era più una mantenuta che una prostituta. Anche in questo il
processo Ruby è stato speciale. Ma non può finire qui. Il Csm ci deve spiegare
se tutte queste violazioni sono consentite, se anche il nuovo corso
“renziano” ha intenzione di chiudere gli occhi, come già si fece 20 anni fa con
Tangentopoli, su questi metodi machiavellici, per cui la finalità politica può
fare a pezzi le regole dello Stato di diritto e prevale sempre la filosofia del
“tipo d’autore” (individuo la tipologia del colpevole, poi colpisco la persona),
per cui la responsabilità penale non è più personale ma esplicitamente politica.
Alla faccia dell’obbligatorietà dell’azione penale.
«Cittadini impotenti davanti ai magistrati»,
scrive Daniel Rustici su “Il Garantista”. «Il Csm cominci
a fare sul serio il suo lavoro che fino ad oggi ha svolto, per usare un
eufemismo, in modo deficitario. Sono stati puniti solo i magistrati fuori dal
coro, mai quelli che hanno sbagliato nell’esercizio della professione. Il
caso più emblematico è quello del processo Tortora dove i giudici di uno dei più
clamorosi casi di malagiustizia hanno fatto carriera. Il Csm dovrebbe essere
meno indulgente e ”perdonista” nei confronti dei magistrati che commettono gravi
errori». Chi parla è uno dei giudici più intransigenti e
celebri per le sue feroci polemiche contro pezzi del mondo politico, e a
difesa della magistratura: Antonio Ingroia. In un’intervista al nostro
giornale ha detto che bisogna difendere i cittadini che talvolta sono troppo
deboli di fronte ai magistrati e ai loro eventuali errori. Ha parlato anche di
carcerazione preventiva, e ha detto che «in un Paese in cui i tempi per
arrivare a una sentenza definitiva sono così lunghi, è facile che si arrivi ad
utilizzare la carcerazione preventiva come una sorta di anticipazione della pena
prevista in caso di condanna dopo i tre gradi di giudizio».
Ingroia, stanno facendo molto rumore le sue dichiarazioni sulla
responsabilità civile dei giudici. Ha parlato di cittadini «impotenti»
davanti al potere della magistratura. Detto da un’ex toga…
«Voglio precisare prima di
tutto che sono contrario alla responsabilità civile dei magistrati. Penso invece
che per garantire i diritti dei cittadini bisognerebbe che il Csm cominci a fare
sul serio il suo lavoro che fino ad oggi ha svolto, per usare un eufemismo, in
modo deficitario. Sono stati puniti solo i magistrati fuori dal coro, mai
quelli che hanno sbagliato nell’esercizio della professione. Il caso
più emblematico è quello del processo Tortora dove i giudici di uno dei più
clamorosi casi di malagiustizia hanno fatto carriera. La verità è che
all’interno della magistratura troppo spesso si va avanti sulla base
dell’appartenenza a questa o a quella corrente piuttosto che grazie al merito».
Cosa non la convince del disegno di legge del governo
sulla punibilità dei giudici?
«La responsabilità civile non
è uno strumento idoneo per difendere i cittadini. In primo luogo non lo è perché
può portare il magistrato ad assumere una posizione di soggezione
davanti all’imputato, specie se questo è ricco e potente. E non lo è
perché moltiplicherebbe il lavoro nei tribunali e quindi, dilatando ancora di
più i mostruosi tempi della nostra giustizia, paradossalmente andrebbe contro
gli interessi degli imputati stessi. Lo ripeto, il vero problema è il Csm che
dovrebbe essere meno indulgente e ”perdonista” nei confronti di chi commette
gravi errori».
Sparare sul Consiglio nazionale della magistratura ora che
ha smesso i panni di pm,non è troppo facile?
«Queste cose le ho sempre
dette. Qualcuno potrebbe anche dire che parli male del Csm per come sono stato
tratto io, per le parole contro le mie partecipazioni a manifestazioni
pubbliche. Allora non parliamo di me, ma di un altro magistrato:
Di Matteo. Perchè il Csm ostacola la sua nomina alla Procura nazionale antimafia
e favorisce invece personaggi obiettivamente con meno competenze in materia?»
Perché?
«La risposta è semplice: ci
si muove in base a logiche burocratiche e correntistiche invece che di sostanza».
Faceva prima riferimento alle sue contestate partecipazioni
a manifestazioni politiche quando era ancora magistrato. È una scelta che
rivendica?
«Sì. Mi è capitato di fare il
pm nella stagione sbagliata. Trent’anni fa nessuno si scandalizzava se Terranova
partecipava ai convegni del Pci e negli anni 70 nessuno si sognava di mettere in
discussione la professionalità di Borsellino perché andava a parlare di
giustizia nei consessi del Movimento sociale italiano. Resto convinto che un
magistrato vada giudicato per quello che fa nell’orario di lavoro e che
abbia tutto il diritto di esprimere le proprie opinioni. Io però sono stato
subissato da attacchi, sia da parte del mondo politico sia dalla magistratura
stessa…»
Nelle scorse settimane si è molto discusso delle ferie dei
giudici. Ha ragione Renzi a volerle tagliare?
«Penso si tratti di un falso
problema. Effettivamente 45 giorni sono tanti ma io, ad esempio, non ho mai
goduto dell’intero periodo di ferie e come me la maggior parte dei giudici.
Sostenere che la lentezza della giustizia italiana dipenda dalle
toghe fannullone è solo un modo di trovare un capro espiatorio».
Quali sono invece le ragioni di questa lentezza e come si
può intervenire per accelerare i tempi dei processi?
«Credo sia arrivata l’ora di
mettere in discussione l’esistenza del processo d’appello. Con un grado secco di
giudizio e un unico processo che decreti l’innocenza o la colpevolezza di un
imputato si risparmierebbero un sacco di soldi e di energie. Ritengo poi
necessario mettere fine alla corsa alla prescrizione, limitando l’abuso di
questo strumento».
A proposito di abusi, cosa pensa dell’uso molto disinvolto della
carcerazione preventiva che spesso viene fatto dai giudici?
«In un Paese in cui i tempi
per arrivare a una sentenza definitiva sono così lunghi, è facile che si arrivi
ad utilizzare la carcerazione preventiva come una sorta di anticipazione di
quella prevista in caso di condanna dopo i tre gradi di giudizi».
Sì, ma è incostituzionale: esiste la presunzione d’innocenza.
«Certo nessuno vuole mettere
in discussione la sacralità della presunzione d’innocenza ma ribadisco, finché i
tempi della giustizia saranno questi credo che la carcerazione preventiva verrà
ancora usata con questa frequenza».
Ora che esercita la professione di avvocato, come è cambiata
la sua prospettiva sul mondo giudiziario?
«Cambiando osservatorio,
sono rimasto delle mie opinioni: viviamo in un Paese profondamente ingiusto
perché indulgente con i potenti e forte con i deboli».
Cosa significa per lei la parola ” garantismo”?
«Garantismo significa dare la
garanzia a tutti i cittadini di un processo giusto e assicurare il diritto di
difesa. Chi vede il garantismo come un modo per disarmare i pm però sbaglia.
Essere garantisti significa anche fare in modo che la legge sia davvero uguale
per tutti e permettere di punire chi ha sbagliato».
Ha dichiarato di essere pronto a tornare in politica e di
guardare con attenzione a Landini. Pensa si aprirà davvero un nuovo spazio
politico a sinistra del Pd?
«Credo che il nostro Paese
abbia bisogno che emerga una nuova soggettività politica progressista, popolare
e di sinistra. Mi sento politicamente vicino a Landini e Rodotà, e sono pronto a
dare il mio contributo per la costruzione di una coalizione sociale per
l’equità, la lotta alla criminalità organizzata e ai reati dei colletti bianchi».
Ok, basta coi professionisti dell’Antimafia. Ma adesso chi
combatterà le mafie? E’ la domanda che si pone Gaetano
Savatteri su “Gli Stati Generali”. L’antimafia è morta. L’antimafia dei
movimenti, delle associazioni di categoria, dei bollini e dei certificati, ma
anche quella dei magistrati e della politica. L’antimafia, quella che abbiamo
visto e conosciuta fino ad oggi, è definitivamente sepolta. Perché le ultime
vicende – l’arresto di Roberto Helg per una mazzetta conclamata o l’indagine per
mafia sul presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante, per
dichiarazioni di pentiti ancora tutte da chiarire e che potrebbero nascondere
una manovra di delegittimazione – sanciscono in ogni caso e definitivamente la
fine di un modello che per molto tempo, e fino all’altro ieri, è stato visto con
favore e incoraggiato perché segno di una “rivoluzione” che metteva in prima
linea la cosiddetta società civile. Attilio Bolzoni su Repubblica, lo stesso
giornale che ha sparato per primo la notizia dell’indagine su Montante, ha posto
un interrogativo: “Forse è arrivato il momento di una riflessione su cos’è
l’Antimafia e dove sta andando”. Ma probabilmente la domanda più corretta è
un’altra: potrà esserci ancora un’antimafia? Peppino Di Lello, a lungo
magistrato del pool antimafia di Palermo, quello di Falcone e Borsellino, scrive
sul Manifesto che “i bollini, le autocertificazioni, gli elenchi incontrollati e
incontrollabili degli antimafiosi doc sono ormai ciarpame e bisogna voltare
pagina riappropriandosi di una qualche serietà nella scelta di esempi di
antimafia vera, scelta fondata sulla prassi, sui comportamenti che incidono
realmente in questa opera di contrasto”. Di Lello, giustamente, attacca la
retorica dell’antimafia, citando non a caso l’ormai storico articolo del 1987 di
Leonardo Sciascia sui “professionisti dell’antimafia”. Ma le ultime vicende e un
sottile veleno che percorre le vene del mondo delle associazioni e del movimento
antimafia (don Luigi Ciotti ha fornito qualche anticipazione: “Mi pare di
cogliere, e poi non sono in grado di dire assolutamente altro, che fra pochi
giorni avremo altre belle sorprese, che sono in arrivo, che ci fanno soffrire.
Perché riguardano personaggi che hanno sempre riempito la bocca di legalità, di
antimafia”) percuotono chi, per entusiasmo o per mestiere o, usiamo pure questa
parola, per “professionismo”, si è iscritto negli ultimi anni nel fronte
antimafia. Serpeggia il disorientamento tra quanti si chiedono: e adesso,
infranti alcuni simboli dell’antimafia, non si rischia di veder naufragare il
lavoro fatto in tanti anni, compresi i buoni esempi concreti realizzati?
L’indagine della Commissione parlamentare antimafia sull’antimafia, per
individuare quando questa sia stata reale o di facciata – paradosso segnalato da
Giuseppe Sottile sul Foglio – pone una questione centrale. Se molti movimenti,
associazioni, progetti nelle scuole, iniziative si sono riempiti, nella migliore
delle ipotesi, di un tot di vuota retorica e, nella peggiore, di piccoli o
grandi interessi economici sotto forma di finanziamenti, privilegi, guadagni,
chi dovrà stabilire da ora in poi la genuinità della natura antimafia? La
struttura dello Stato italiano, per oltre centosessant’anni, ha costruito
soggetti e ruoli incaricati di definire e individuare le mafie, arrivando a
darne nel 1982 perfino una definizione normativa con l’articolo 416bis del
codice penale. Ma l’Italia non ha, e forse non poteva avere, strumenti per
individuare con esattezza la natura antimafiosa di soggetti, singoli o plurali,
se non in termini di opposizione: in parole semplici, era antimafioso chi
combatteva la mafia. Con opere o parole. Così, per lungo tempo, l’antimafia
sociale – cioè quella non costituita da magistrati e poliziotti incaricati, per
ragioni d’ufficio, dell’azione di contrasto e repressione – finiva per
autodefinirsi. E’ bastata, per un lunghissimo periodo, la petizione di principio
di dichiararsi antimafia per essere considerati tali. In un Paese che fino a una
quarantina d’anni fa ancora sosteneva, spesso anche nelle sedi giudiziarie, che
la mafia non esisteva, già il fatto stesso di dichiararne l’esistenza e di porsi
in posizione alternativa a essa, era sufficiente per attribuirsi o vedersi
attribuita la patente antimafia. Se oggi questo non basta più, quale sarà il
criterio futuro per definire la nuova antimafia? I fatti, i comportamenti e la
prassi, dice Di Lello. Tutto ciò è facilmente verificabile, ad esempio,
nell’attività delle associazioni antiracket che convincono i loro associati a
testimoniare nei processi, li sorreggono, si costituiscono accanto a loro parte
civile. Ma questo principio può valere per associazioni culturali, singoli di
buona volontà, gruppi di opinione, insegnanti la cui unica forza risiede solo
nella dichiarazione d’intenti? E’ ovvio che laddove le parole non coincidano
con i fatti (come nel caso della tangente che ha fatto finire in galera Helg),
la contraddizione è talmente stridente che non ci sono dubbi. Ma anche in questo
caso, è una dimostrazione al contrario: il fatto (cioè la mazzetta) mostra la
non appartenenza di qualcuno al fronte autenticamente antimafioso. Ma quale può
essere il fatto che, giorno dopo giorno, possa dimostrarne invece
l’appartenenza? Per Confindustria Sicilia, ad esempio, sembrava già
rivoluzionario e significativo che un’associazione di categoria che per molto
tempo aveva ignorato la mafia o ci aveva convissuto, con molti casi di
imprenditori contigui o aderenti a Cosa Nostra, avviasse una inversione di rotta
pubblica, con l’annuncio di espulsioni dei propri soci che non avessero
denunciato le estorsioni. Era certamente un fatto capace di attribuire identità
antimafiosa a quell’associazione. Naturalmente, il movimento antimafia nel suo
complesso si è nutrito di errori e di eccessi. E questi nascono probabilmente
dall’evidenza che ogni movimento antimafioso, per sua natura, tende ad occupare
tutti gli spazi morali a sua disposizione. La discriminante etica, ragione
fondante, tende ad allargarsi e spostarsi sempre più avanti in nome della
purezza antimafia, escludendo altri soggetti e movimenti. Qualsiasi movimento
antimafia, poiché si costituisce e si struttura in alternativa e in opposizione
a qualcosa, in primo luogo la mafia e i comportamenti che possono favorirla o
sostenerla, non può tentare di includere tutto, ma deve per forza di cose
escludere. Ecco perché dentro il mondo dell’antimafia non c’è pace, e ciascun
gruppo di riferimento tende a vedere negli altri gruppi degli avversari, se non
dei nemici insidiosi o subdoli. L’antimafia spontaneistica e aggregativa dal
basso si contrappone a quella ufficiale in giacca e cravatta e viceversa, quella
sociale si contrappone a quella di Stato e viceversa. La vocazione alla
supremazia della leadership del mondo antimafioso, diventa allarmante quando
l’antimafia non è più esclusivo appannaggio di gruppi sociali d’opposizione (i
preti di frontiera contro la Chiesa ufficiale timorosa, le minoranze politiche
contro le maggioranze o i governi prudenti o contigui, gli studenti contro la
burocrazia scolastica troppo paludata, tanto per fare alcuni esempi), ma
comincia a diventare bandiera dei gruppi dominanti. Al potere economico o
politico, finisce così per sommarsi il potere di esclusione di potenziali
concorrenti, che può essere esercitato anche facendo baluginare legami oscuri o
poco trasparenti. L’antimafia può servire al politico di governo per demonizzare
gli avversari. Siamo di fronte a quel meccanismo che viene indicato come “la
mafia dell’antimafia”, definizione che non amo perché rischia di far dimenticare
che nel recente passato in Sicilia, e non solo, politici, imprenditori e
funzionari contigui o affiliati alla mafia facevano eliminare i loro avversari
direttamente a colpi di kalashnikov. In questi giorni, in queste ore, il mondo
dell’antimafia, soprattutto quello siciliano, il più antico e radicato, il più
organizzato e selezionato negli anni delle stragi e delle mattanze mafiose, si
trova davanti a molte domande. Chi dovrà stabilire, nel futuro prossimo, la
genuinità dei comportamenti antimafia? I giornali? La tv? Il governo? Il
Parlamento? Non esistono organismi o autorità morali in grado di fornire
garanzie valide per tutti. La domanda principale finisce per riguardare
l’esistenza stessa di un’antimafia diffusa. Se l’antimafia, per come è stata
fino ad oggi, è morta, potrà esserci ancora qualcosa o qualcuno in grado di
dichiararsi antimafia? Ma, soprattutto, chi potrà crederci ancora?
Imprenditori e giornalisti cantori dell’antimafia, non ci
mancherete per niente. Abbiamo letto su queste colonne
l’annuncio della morte dell’antimafia. Un annuncio articolato. Esteso,
ragionato, scrive Salvatore Falzone su “Gli Stati Generali”. Forse però vale la
pena allungare il necrologio, non foss’altro che per rispetto del de cuius
e delle sue gesta. Il decesso, diciamocelo, è stato causato da colpi di toga.
Ancora una volta, purtroppo. Perché se non spuntano i primi fascicoli con
l’intestazione “Procura della Repubblica”, nel Belpaese tutto è lecito e tutto
va bene. Prima di leggere paroline come “arresto”, “tangente”, “indagine”,
“pentiti”, nessuno s’interroga, nessuno ha dubbi. Succede così che da qualche
anno a questa parte un’antimafia che non è antimafia ha messo le mani sulla
città, per dirla con Rosi, per fare affari e costruire carriere. Nel nome della
legalità, s’intende, e con l’avallo di una torma di pensatori, magistrati,
prefetti, questori e alti ufficiali che non hanno fatto altro che alimentare una
colossale bugia (Giovanbattista Tona, consigliere della Corte d’Appello di
Caltanissetta: “Come il mafioso di paese otteneva rispetto perché passeggiava
col sindaco, col parroco, col maresciallo e col barbiere, l’antimafioso 2.0 può
esercitare potere su tutto sol perché in confidenza con ministri, magistrati e
autorità”. Giuseppe Pignatone, capo della Procura di Roma: “Bisogna fare l’esame
di coscienza: non è che tra magistrati e forze dell’ordine ci sono soltanto
santi, eroi e martiri. Ci sono, come in tutte le categorie, persone per bene e
persone meno perbene”). C’era bisogno di scoprire Helg con la mazzetta in mano?
Dovevamo leggere Bolzoni su Repubblica – che ha dato notizia di un’inchiesta per
mafia a carico del presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante – per
accorgerci che dalle parti di Caltanissetta l’antimafia ha i pennacchi impastati
di gel? E’ mai possibile che quel “cretino” del professor Laurana continua a
morire in una zolfara abbandonata, “sotto grave mora di rosticci”, senza sapere
ciò che tutti sanno? Già, perché tutti sanno, e tutti sapevano. Ecco perché la
meraviglia e il disorientamento del giorno dopo sono espressioni vuote, bianche
come quelle di certe statue. La Sicilia è un salone da barba. E anche Roma lo è.
E pure Milano. Mentre in questi anni si firmavano protocolli ai tavoli delle
prefetture, mentre si stilavano codici etici, mentre procuratori generali
inauguravano l’anno giudiziario magnificando le imprese dei nuovi paladini
dell’antimafia, dal barbiere si sussurrava e si rideva. Si rideva (con gli
occhi) e si facevano smorfie (con la bocca). Ora ci si chiede se, dopo le scosse
telluriche delle ultime settimane, possa esserci ancora un’antimafia. E perché
no? Un’antimafia ci sarà. Ma non questa. Non questa che ha mandato in
solluchero, da nord a sud, cronisti e narratori, i “cuntastorie – come ha
scritto Sergio Scandura su Gli Stati Generali – dello storytelling epopea
che danno voce ai Pupi: ora con la prodezza, la tenacia e l’enfasi di battaglia,
ora con l’incanto-disincanto e la passione della bella Angelica di carolingia
memoria”. Sì, ci sarà un’altra antimafia. Anzi, c’è già. C’è sempre stata da
quando esiste la mafia. Silenziosa, non remunerativa. E’ l’antimafia del proprio
dovere quotidiano, che non fa regali, che non compra e che non paga. Un
siciliano illuminato, Cataldo Naro, l’arcivescovo di Monreale scomparso nel
2006, parlava di legalità e santità nelle parrocchie tra Partinico e Corleone. A
proposito di Chiesa e mafia, diceva che il cristiano non può non vivere secondo
il Vangelo, e che il Vangelo è di per sé incompatibile con la mafia: il discorso
vale per tutti, spiegava il presule, per il carabiniere, per il politico, per il
professore, per il bidello, per il magistrato, per la guardia municipale… Ma
lasciamo stare i santi e torniamo ai diavoli. Adesso che succede, adesso che
l’antimafia in ghingheri traballa e che non ci sono ammortizzatori che tengono?
Il tema non è “il veleno che percorre le vene del mondo delle associazioni e del
movimento antimafia”, né l’esistenza o meno di una “manovra di delegittimazione”
ai danni del leader degli industriali siciliani. E neppure i progetti delle
scuole, le navi della legalità che attraccano a Palermo in un’esplosione di
cappellini o altre simpatiche pagliacciate. Il tema è molto più – come dire? –
terra terra: ed è quello del proverbio “predicare bene e razzolare male”. Il
tema è la trasparenza delle azioni di chi afferma di combattere il malaffare. E’
la concretezza – oltre che la qualità – dell’impegno sul fronte della legalità
(parola che Michele Costa, il figlio del procuratore di Palermo ucciso nel 1980,
propone giustamente di abolire). Da questo punto di vista non c’è bisogno di
attendere misure cautelari o sentenze definitive per mettere in discussione
l’operato non dei “professionisti” (lasciamolo in pace il maestro di Racalmuto)
ma degli “imprenditori dell’antimafia”: etichetta, quest’ultima, che ben si
attacca alle giacchette dei nostri eroi. Perché debbono scriverla i giudici la
storia di questa ennesima truffa? La scrivano gli artisti, se ce ne sono ancora.
O gli intellettuali, ma non quelli “col senno del poi”. La raccontino le
inchieste dei giornalisti e degli scrittori che non prendono soldi, i registi di
cinema e di teatro… Materiale ce n’è in abbondanza. Certo per raccoglierlo
bisogna superare lo Stretto, penetrare nell’entroterra incontaminato, fra
colline che d’inverno sono così verdi che sembra di stare in Irlanda, e fare un
salto nella “Piccola Atene”, la Caltanissetta dove la leggenda vuole che a metà
degli anni duemila sia nata la rivoluzione degli imprenditori (che qualcuno, con
parole misurate, ha definito copernicana). Ma va detto che nella Caltanissetta
delle mitologie c’è stato pure chi in questi anni ha lavorato sul serio
resistendo alle bordate sia dalla mafia che dall’antimafia. Il pm Stefano
Luciani, in una requisitoria a conclusione di un processo in cui la Procura
riteneva di avere scoperto estorsioni non denunciate dagli imprenditori e
accordi tra imprenditori e mafiosi proprio in terra nissena, aveva evidenziato
che ancora si aspettava l’effetto dell’impegno di Confindustria sul
comportamento della categoria. Era il 23 gennaio 2012. Bè, dopo pochi giorni il
giornalista Filippo Astone scriveva un pezzo intitolato “Le incredibili
dichiarazioni del pm nisseno Stefano Luciani”: l’accusa era che il magistrato,
non riconoscendo i meriti degli imprenditori antimafia, non si rendeva conto di
aiutare oggettivamente la mafia. Dunque l’antimafia è morta? Macché. Se
l’antimafia è quella di Helg e di Montante possiamo stracciare il necrologio e
stappare champagne. Perché non è morta l’antimafia. Ma un sistema di potere che
ha occupato tutti gli spazi (non morali), che controlla ogni angolo del
territorio, che dai tempi di Raffaele Lombardo gestisce nell’Isola il potente
assessorato alle Attività Produttive, che tiene in pugno giornali e giornalisti:
l’ordine di Sicilia ha aperto un’inchiesta sui finanziamenti elargiti dalla
Camera di Commercio di Caltanissetta, di cui Montante è presidente, a testate e
pubblicisti. “Potrà dunque esserci un’antimafia?” Sì. “Chi dovrà stabilire nel
futuro prossimo la genuinità dei comportamenti antimafia?”. Non certo questi
signori. Gaetano Savatteri, sempre su Gli Stati Generali, si è chiesto
chi potrà credere ancora all’antimafia… Ma la domanda va forse ribaltata: chi ci
ha mai creduto a questa antimafia? E se qualcuno ci ha creduto, perché?
Perché
leggere Antonio Giangrande?
Ognuno di noi
è segnato nella sua esistenza da un evento importante. Chi ha visto il film si
chiede: perché la scena finale de “L’attimo fuggente”, ogni volta, provoca
commozione? Il professor John Keating (Robin Williams), cacciato dalla scuola,
lascia l’aula per l’ultima volta. I suoi ragazzi, riabilitati da lui dalla
corruzione culturale del sistema, non ci stanno, gli rendono omaggio. Uno dopo
l’altro, salgono in piedi sul banco ed esclamano: «Capitano, mio capitano!».
Perché quella scena è così potente ed incisiva? Quella scena ci colpisce perché
tutti sentiamo d’aver bisogno di qualcuno che ci insegni a guardare la realtà
senza filtri. Desideriamo, magari senza rendercene conto, una guida che indichi
la strada: per di là. Senza spingerci: basta l’impulso e l’incoraggiamento. Il
pensiero va a quella poesia che il vate americano Walt Whitman scrisse dopo
l'assassinio del presidente Abramo Lincoln, e a lui dedicata. Gli stessi versi
possiamo dedicare a tutti coloro che, da diversi nell'omologazione, la loro vita
l’hanno dedicata per traghettare i loro simili verso un mondo migliore di quello
rispetto al loro vivere contemporaneo. Il Merito: Valore disconosciuto ed
osteggiato in vita, onorato ed osannato in morte.
Robin
Williams è il professor Keating nel film L'attimo fuggente (1989)
Oh!
Capitano, mio Capitano, il tremendo viaggio è compiuto,
La nostra
nave ha resistito ogni tempesta: abbiamo conseguito il premio desiderato.
Il porto è
prossimo; odo le campane, il popolo tutto esulta.
Mentre gli
occhi seguono la salda carena,
la nave
austera e ardita.
Ma o cuore,
cuore, cuore,
O stillanti
gocce rosse
Dove sul
ponte giace il mio Capitano.
Caduto
freddo e morto.
O Capitano,
mio Capitano, levati e ascolta le campane.
Levati, per
te la bandiera sventola, squilla per te la tromba;
Per te
mazzi e corone e nastri; per te le sponde si affollano;
Te
acclamano le folle ondeggianti, volgendo i Walt Whitman (1819-1892) cupidi
volti.
Qui
Capitano, caro padre,
Questo mio
braccio sotto la tua testa;
È un sogno
che qui sopra il ponte
Tu giaccia
freddo e morto.
Il mio
Capitano tace: le sue labbra sono pallide e serrate;
Il mio
padre non sente il mio braccio,
Non ha
polso, né volontà;
La nave è
ancorata sicura e ferma ed il ciclo del viaggio è compiuto.
Dal
tremendo viaggio la nave vincitrice arriva col compito esaurito,
Esultino le
sponde e suonino le campane!
Ma io con
passo dolorante
Passeggio
sul ponte, ove giace il mio Capitano caduto freddo e morto.
Antonio
Giangrande. Un capitano necessario. Perché in Italia non si conosce la verità.
Gli italiani si scannano per la politica, per il calcio, ma non sprecano un
minuto per conoscere la verità. Interi reportage che raccontano l’Italia di oggi
“salendo sulla cattedra” come avrebbe detto il professore Keating dell’attimo
fuggente e come ha cercato di fare lo scrittore avetranese Antonio Giangrande.
Chi sa:
scrive, fa, insegna.
Chi non sa:
parla e decide.
Chissà perché
la tv ed i giornali gossippari e colpevolisti si tengono lontani da Antonio
Giangrande. Da quale pulpito vien la predica, dott. Antonio Giangrande?
Noi siamo quel
che facciamo: quello che diciamo agli altri è tacciato di mitomania o pazzia.
Quello che di noi gli altri dicono sono parole al vento, perche son
denigratorie. Colpire la libertà o l’altrui reputazione inficia gli affetti e fa
morir l’anima.
La calunnia è
un venticello
un’auretta
assai gentile
che
insensibile sottile
leggermente
dolcemente
incomincia a
sussurrar.
Piano piano
terra terra
sotto voce
sibillando
va scorrendo,
va ronzando,
nelle orecchie
della gente
s’introduce
destramente,
e le teste ed
i cervelli
fa stordire e
fa gonfiar.
Dalla bocca
fuori uscendo
lo schiamazzo
va crescendo:
prende forza a
poco a poco,
scorre già di
loco in loco,
sembra il
tuono, la tempesta
che nel sen
della foresta,
va fischiando,
brontolando,
e ti fa
d’orror gelar.
Alla fin
trabocca, e scoppia,
si propaga si
raddoppia
e produce
un’esplosione
come un colpo
di cannone,
un tremuoto,
un temporale,
un tumulto
generale
che fa l’aria
rimbombar.
E il meschino
calunniato
avvilito,
calpestato
sotto il
pubblico flagello
per gran sorte
va a crepar.
E’ senza
dubbio una delle arie più famose (Atto I) dell’opera lirica Il Barbiere di
Siviglia del 1816 di Gioacchino Rossini (musica) e di Cesare Sterbini
(testo e libretto). E’ l’episodio in cui Don Basilio, losco maestro di musica di
Rosina (protagonista femminile dell’opera e innamorata del Conte d’Almaviva),
suggerisce a Don Bartolo (tutore innamorato della stessa Rosina) di screditare e
di calunniare il Conte, infamandolo agli occhi dell’opinione pubblica. Il brano
“La calunnia è un venticello…” è assolutamente attuale ed evidenzia molto bene
ciò che avviene (si spera solo a volte) nella quotidianità di tutti noi:
politica, lavoro, rapporti sociali, etc.
Alla fine di
noi rimane il nostro operato, checché gli altri ne dicano. E quello bisogna
giudicare. Nasco da una famiglia umile e povera. Una di quelle famiglie dove la
sfortuna è di casa. Non puoi permetterti di studiare, né avere amici che
contano. Per questo il povero è destinato a fare il manovale o il contadino. Mi
sono ribellato e contro la sorte ho voluto studiare, per salire nel mondo non
mio. Per 17 anni ho cercato di abilitarmi nell’avvocatura. Non mi hanno voluto.
Il mondo di sotto mi tiene per i piedi; il mondo di sopra mi calca la testa. In
un esame truccato come truccati sono tutti i concorsi pubblici in Italia: ti
abilitano se non rompi le palle. Tutti uguali nella mediocrità. Dal 1998 ho
partecipato all’esame forense annuale. Sempre bocciato. Ho rinunciato a
proseguire nel 2014 con la commissione presieduta dall’avv. Francesco De Jaco.
L’avvocato di Cosima Serrano condannata con la figlia Sabrina Misseri per il
delitto di Sarah Scazzi avvenuto ad Avetrana. Tutte mie compaesane. La
Commissione d’esame di avvocato di Lecce 2014. La più serena che io abbia
trovato in tutti questi anni. Ho chiesto invano a De Jaco di tutelare me, dagli
abusi in quell’esame, come tutti quelli come me che non hanno voce. Se per lui
Cosima è innocente contro il sentire comune, indotti a pensarla così dai media e
dai magistrati, perché non vale per me la verità che sia vittima di un sistema
che mi vuol punire per essermi ribellato? Si nega l’evidenza. 1, 2, 3 anni,
passi. 17 anni son troppi anche per il più deficiente dei candidati. Ma gli
effetti sono sotto gli occhi di tutti. Compiti non corretti, ma ritenuti tali in
tempi insufficienti e senza motivazione e con quote prestabilite di abilitati.
Così per me, così per tutti. Gli avvocati abilitati negano l’evidenza. Logico:
chi passa, non controlla. Ma 17 anni son troppi per credere alla casualità di
essere uno sfigato, specialmente perché i nemici son noti, specie se sono nelle
commissioni d’esame. In carcere o disoccupato. Tu puoi gridare a squarciagola le
ingiustizie, ma nessuno ti ascolta, in un mondo di sordi. Nessuno ti crede. Fino
a che non capiti a loro. E in questa Italia capita, eccome se capita! La tua
verità contro la verità del potere. Un esempio da raccontare. Ai figli non
bisogna chiedere cosa vogliono fare da grandi. Bisogna dir loro la verità.
Chiedergli cosa vorrebbero che gli permettessero di fare da grandi. Sono nato in
quelle famiglie che, se ti capita di incappare nelle maglie della giustizia, la
galera te la fai, anche da innocente. A me non è successo di andare in galera,
pur con reiterati tentativi vani da parte della magistratura di Taranto, ma sin
dal caso Tortora ho capito che in questa Italia in fatto di giustizia qualcosa
non va. Pensavo di essere di sinistra, perché la sinistra è garantismo, ma non
mi ritrovo in un’area dove si tollerano gli abusi dei magistrati per garantirsi
potere ed impunità. E di tutto questo bisogna tacere. A Taranto, tra i tanti
processi farsa per tacitarmi sulle malefatte dei magistrati, uno si è chiuso,
con sentenza del Tribunale n. 147/2014, con l’assoluzione perché il fatto non
sussiste e per non doversi procedere. Bene: per lo stesso fatto si è riaperto un
nuovo procedimento ed è stato emesso un decreto penale di condanna con decreto
del Gip. n. 1090/2014: ossia una condanna senza processo. Tentativo stoppato
dall’opposizione.
Zittirmi sia
mai. Pur isolato e perseguitato. Gli italiani son questi. Ognuno dia la sua
definizione. Certo è che gli italiani non mi leggono, mi leggono i forestieri.
Mi leggeranno i posteri. Tutto regolare: lo ha detto la tv, lo dicono i giudici.
Per me, invece, è tutto un trucco. In un mondo di ladri nessuno vien da Marte.
Tutti uguali: giudicanti e giudicati.
E’ da decenni che studio il sistema Italia, a carattere locale come a livello
nazionale. Da queste indagini ne sono scaturiti decine di saggi, raccolti in una
collana editoriale "L'Italia del Trucco, l'Italia che siamo", letti in tutto il
mondo, ma che mi sono valsi l’ostruzionismo dei media nazionali. Pennivendoli
venduti ai magistrati, all’economia ed alla politica, ma che non impediscono il
fatto che di me si parli su 200.000 siti web, come accertato dai motori di
ricerca. Book ed E-Book che si possono trovare su Amazon.it, Lulu.com.
CreateSpace.com e Google Libri, oltre che in forma di lettura gratuita e free
vision video su
www.controtuttelemafie.it,
mentre la promozione del territorio è su
www.telewebitalia.eu.
Ha la
preparazione professionale per poter dire la sua in questioni di giustizia?
Non sono un
giornalista, ma a quanto pare sono l’unico a raccontare tutti i fatti. Non sono
un avvocato ma mi diletto ad evidenziare le manchevolezze di un sistema
giudiziario a se stante. La mia emigrazione in piena adolescenza in Germania a
16 anni per lavorare; la mia laurea quadriennale in Giurisprudenza presa in soli
due anni all’Università Statale di Milano, lavorando di notte e con moglie e due
figli da mantenere, dopo aver conseguito il diploma da ragioniere in un solo
anno da privatista presso un Istituto tecnico Statale e non privato, per non
sminuirne l’importanza, portando tutti i 5 anni di corso; tutto ciò mi ha reso
immune da ogni condizionamento culturale od ambientale. I miei 6 anni di
esercizio del patrocinio legale mi hanno fatto conoscere le macagne di un
sistema che non è riuscito a corrompermi. Per questo dal 1998 al 2014 non mi
hanno abilitato alla professione di avvocato in un esame di Stato, che come
tutti i concorsi pubblici ho provato, con le mie ricerche ed i miei libri,
essere tutti truccati. Non mi abilitano. Perché non sono uguale agli altri, non
perché son meno capace. Non mi abilitano perché vedo, sento e parlo. Ecco perché
posso parlare di cose giuridiche in modo di assoluta libertà, senza
condizionamento corporativistico, anche a certezza di ritorsione. E’ tutta
questione di coscienza.
IL PARTITO
INVISIBILE. ASTENSIONISMO, VOTO MIGRANTE E VOTO DI PROTESTA: I MOTIVI DI UNA
DEMOCRAZIA INESISTENTE.
50% circa di
astensione al voto; 5% circa di schede bianche o nulle; 25% di voti di protesta
e non di proposta ai 5Stelle. Solo il 20% di voti validi (forse voti di
scambio). Chi governa ha solo un elettore su 10 che lo ha scelto e si vanta pure
di aver vinto. Che cazzo di democrazia è?
Elezioni
2015. Il partito invisibile,
scrive Alberto Puliafito, direttore responsabile di "Blogo.it" e Carlo Gubitosa
su “Polis Blog”. Un viaggio nel mondo di tutti coloro che non vengono raccontati
dalla comunicazione politica, che non vengono rappresentati, che non votano.
Dopo il voto regionale, la comunicazione politica si è concentrata, come al
solito, su "chi vince". E hanno vinto tutti, chi per un motivo chi per l'altro.
Noi, per un primo commento, ci siamo concentrati su chi ha perso. E fra i motivi
della sconfitta annoveravamo l'impressionante tasso di astensionismo. I dati che
proponiamo qui, grazie al lavoro di Carlo Gubitosa, dovrebbero, secondo chi
scrive, essere pubblicati ovunque. Il giornalismo dovrebbe, una volta per tutte,
dedicare i propri titoli alle rappresentazioni numeriche realistiche della
situazione della rappresentanza politica in Italia, invece di rincorrere le
dichiarazioni di Renzi, Grillo, Salvini o altri. Invece di pubblicare i tweet
con il presidente del consiglio che gioca ai videogiochi, sapientemente diffusi
da chi si occupa di comunicazione per conto di Palazzo Chigi, le gallery per
fare click potrebbero essere, senza alcun problema – lo sappiamo che i click
vanno fatti – gallery di grafici come questi. Guardare quelle fette grigie di
non rappresentati fa rabbrividire ma è necessario per impostare una narrazione
giornalistica corretta. Ecco perché, quando Carlo mi ha proposto questo lavoro,
ho accettato con entusiasmo. Per offrire un servizio ai nostri lettori e per
imparare io stesso. Questo è vero data journalism. Per i partiti contano
i propri voti, per la politica contano solo i voti validi, per il ministero
dell'interno contano solo gli elettori. E se invece provassimo a contare le
persone? I grafici che nessuna formazione politica vorrà mai mostrarvi rivelano
il peso numerico della "maggioranza invisibile", quella che non può, non vuole o
non sa indicare una rappresentanza nelle urne. Sono gli astensionisti, i delusi
dalla politica, ma anche gli stranieri e i minori, una fetta di popolazione che
diventa “invisibile” nei sondaggi, nel dibattito politico e nelle analisi
post-voto. Abbiamo provato ad analizzare i dati ufficiali del voto alle
regionali incrociandoli con i numeri dell’ISTAT e aggiungendoci una semplice
curiosità di partenza: scoprire cosa succede se oltre ai SEGGI ASSEGNATI e ai
VOTI VALIDI misurati dalle percentuali iniziamo a contare anche i VOTI TOTALI
(includendo anche chi ha votato scheda bianca, nulla o annullata), il NUMERO
TOTALE DI ELETTORI (includendo anche chi è stato a casa), e anche il NUMERO
TOTALE DI RESIDENTI, stranieri inclusi (per contare anche chi subisce le
conseguenze delle decisioni politiche senza esercitare il diritto di voto). Per
semplificare l’analisi del voto, operare una indispensabile sintesi sulla
varietà di liste e di coalizioni presenti nelle varie regioni, abbiamo
individuato sette macroblocchi politici per il conteggio dei voti validi:
Renzisti - Berlusconiani - Salviniani - Grillisti - Sinistra - Destra - Altri.
Sono state introdotte delle approssimazioni per eccesso che sovrastimano
l’affluenza alle urne, ad esempio contando come due elettori anche il “voto
doppio” espresso da una stessa persona per una lista e per il candidato
presidente. Anche con queste approssimazioni, tuttavia, la consistenza numerica
dei “non rappresentati” resta notevole. Trattandosi di nostre elaborazioni su
dati ufficiali (con la fatica di dover trasporre numeri strappati a fatica da
PDF, pagine web e ogni tipo di dato in formati non aperti che la pubblica
amministrazione e’ stata in grado di produrre) non possiamo escludere refusi ed
errori, e ringraziamo in anticipo tutti quelli che vorranno segnalarci eventuali
imprecisioni.
La Campania
e il partito della scheda bianca.
Nel disinteresse generale (tanto le poltrone si sono già spartite) a ben quattro
giorni dal voto arrivano i dati definitivi della Campania, dove chi conta le
persone e non le poltrone registra 170mila tra schede bianche e nulle, un
partito che vale il 7% dei voti validi, ben più del valore previsto dal sistema
elettorale campano come soglia di sbarramento per le liste. Potremmo chiederci
se questo 7% di Campani è composto da quella gente egoista, pigra e
disinteressata alla cosa pubblica descritta dai partiti che fomentano
l'astensionismo per poi demonizzare chi lo pratica, o più semplicemente si
tratta di persone a cui è negata rappresentanza politica e quel minimo di
alfabetizzazione necessaria a non farsi annullare la scheda. Un dettaglio
interessante per la Campania è quello della lista "SINISTRA AL LAVORO", l'unica
lista tra quelle esaminate finora ad avere un numero di preferenze inferiore a
quelle ricevute dal candidato governatore, presumibilmente frutto di un voto
disgiunto che ha indicato come candidato presidente quello di un grande partito
di massa con maggiori probabilità di vittoria, ma ha voluto comunque esprimere
un voto "ideologico" con preferenze di lista collocate nettamente a sinistra. A
quanto pare, quando si tratta di scegliere un candidato col voto "utile"
l'elettorato si sposta verso il centro e verso i partiti acchiappavoti, ma il
nostro panorama politico potrebbe essere ben più variegato se si potesse
esprimere un "voto di orientamento" per chi ci convince, in abbinamento al "voto
utile" per chi ci dà maggiori probabilità di vincere. E' quello che nell'era
pre-italicum e pre-porcellum avveniva col voto proporzionale di lista, che nel
vecchio sistema elettorale si affiancava al voto maggioritario come
"correttivo".
Il Veneto e
il suo invisibile "partito migrante".
In Veneto il dato di rilievo è il "partito dei senza voto", quel 21,9% di
persone che pur vivendo in quella regione non può votare perché non ne ha ancora
il diritto o perché essendo straniero quel diritto non ce l'ha mai avuto. Un
blocco di elettori pressoché equivalente al 22,9% di astensionisti, a sua volta
speculare al 22,9% di Salviniani, dove la componente migrante pesa per il 12,4%
della popolazione residente, più del consenso raccolto dal PD che in questa
regione si ferma al 12,1%. Il dibattito politico ci mostra a seconda degli
schieramenti il ritratto di una regione Leghista, o di una regione dove trionfa
il disimpegno e l'astensionismo, ma nessuna delle "fotografie politiche"
mostrate dai mezzi di comunicazione di massa si allarga ai dati sull'intero
insieme della popolazione, per mostrare la fotografia di una regione dove un
veneto su cinque non può esprimere rappresentanza politica, e il 12,4% della
popolazione residente con tutta probabilità sarebbe ben contento di prendere le
distanze sia dal blocco leghista che da quello astensionista, esprimendo un
"voto migrante" che molti temono, qualcuno auspica, ma nessuno si decide a
garantire. Nel frattempo un qualunque italiano che si trasferisce in uno dei
paesi dell'eurozona può istantaneamente godere di tutti i diritti civili e
politici del paese che lo ospita, anche se non vi aveva messo piede fino al
giorno prima, diritti che invece sono negati ai "veneti col passaporto
sbagliato", anche se vivono e lavorano in Italia da anni.
Elezioni
comunali 2015, l’Italia senza quorum: ecco i paesi allergici alle urne,
scrive “Il fatto Quotidiano”. A Castelvecchio Calviso, in provincia dell’Aquila,
si è registrato uno solo voto valido e quattro schede bianche a fronte di 277
potenziali elettori. A Platì e San Luca, due centri reggini sciolti per mafia
vince l'astensione: non si presentano candidati, figurarsi gli elettori. Nel
Vibonese, a Spilinga, solo uno su dieci va a votare. E il sindaco non viene
eletto. C’è un’Italia senza quorum. Mentre si affastellano analisi e reazioni
sul dopo voto un piccolo pezzo di Paese ha preso il largo dalla politica. Sono i
cittadini di piccoli e medi comuni che nel dieniego dell’urna hanno ingrossato
il dato dell’astensione, fino a produrre risultati emblematici e paradossali.
Tra i tanti spicca Castelvecchio Calviso, in provincia dell’Aquila, dove si è
registrato uno solo voto valido e quattro schede bianche a fronte di 277
potenziali elettori. Cinque voti in tutto. Quorum, non pervenuto. Accade anche
questo alle amministrative in Abruzzo: colui che, peraltro, era l’unico
candidato, Roberto Di Pietrantonio della lista civica “Tricolore”, ha incassato
un solo voto valido, a fronte di 2 schede bianche e 2 nulle. Il piccolo centro
montano dell’Aquilano dovrebbe quindi essere retto da un commissario prefettizio
reggente fino a nuove elezioni. Non è l’unico caso. Questa tornata è stata un
tripudio di candidati, con quasi mille aspiranti consiglieri solo in Puglia. Ci
sono comuni con numerosi candidati a sindaco, ma anche tanti comuni dove i
candidati si contano sulle dita di una mano e anche meno. In Sicilia, ad
esempio, c’è ne sono addirittura due con un unico candidato per comune. Si
tratta dei candidati di due comuni del palermitano: Domenico Giannopolo, a
Caltavuturo, e Giuseppe Abbate, a Lascari. Per potere essere eletti andava
superato il quorum dei due comuni. E il quorum è stato raggiunto in entrambi i
comuni del palermitano. Passando alla Lombardia il caso più strano, forse, è
quello dei quattro candidati unici nessuno dei quali ha raggiunto il quorum.
Sembrava una vittoria facile invece Daniele Boldrini, l’unico candidato sindaco
che si è presentato alle elezioni a Brezzo di Bedero, comune con circa 1.200
abitanti della provincia di Varese, non è stato eletto per mancanza del quorum.
E lo stesso è accaduto a Claudio Terzi che era l’unico in lizza a Filago nel
Bergamasco, a Mario Locatelli, che correva da solo a Locatello (Bergamo) e a
Massimiliano Sacchi a Giussago (Pavia). Vai a sapere il perché. Sono invece note
le ragioni che hanno portato in Calabria a un risultato pari a zero: nessun
sindaco è stato eletto in due comuni sciolti per mafia. Il turno elettorale del
31 maggio non ha portato all’elezione di un’amministrazione comunale a Platì e
San Luca, due dei diversi centri reggini dove si tornava alle urne dopo un
periodo di commissariamento a seguito dello scioglimento per infiltrazioni
mafiose. A Platì non sono state presentate liste, mentre a San Luca ne era stata
presentata una ma non ha raggiunto il quorum. Il 43,09 per cento dei cittadini
che si è recato alle urne non è stato sufficiente a decretare sindaco Giuseppe
Trimboli, a capo di una lista civica. Nell’unico comune capoluogo al voto, Vibo
Valentia, a poche sezioni da scrutinare alla fine, Elio Costa si impone con
oltre il 50 per cento sugli altri candidati, distaccando di oltre dodici punti
il candidato de Pd Antonio Lo Schiavo. Tra i comuni con oltre quindicimila
abitanti, a essere eletto con l’82,04 per cento è Pietro Fuda a Siderno (Reggio
Calabria). Politico di lungo corso, era sostenuto dal centrosinistra. Primo
partito nella cittadina jonica è il Centro Democratico che supera di poco il Pd.
Vince l’Italia senza quorum anche a Spilinga, secondo quanto riporta il sito del
Ministero dell’Interno, non si è raggiunto il quorum del votanti e le elezioni
comunali non sono valide. L’unico candidato sindaco era Francesco Dotro, con la
lista civica Insieme per Spilinga. Gli elettori complessivi sono 1.884 ed i
votanti sono stati 576, pari al 30,57%. Dotro ha ottenuto 552 voti. Dieci le
schede bianche e 14 le nulle. I cittadini, nonostante i movimenti estemporanei
come i 5 Stelle che attraggono i voti di protesta, non vanno a votare e molti di
quelli che ai seggi ci vanno presentano scheda bianca o, addirittura, annullano
la scheda con segni di disapprovazione e scherno. Il messaggio è chiaro. Perché
schifati dagli impresentabili presentati e/o da una democrazia ”virtuale”
costruita nei salotti televisivi e dai TG in barba a qualsiasi forma di
democraticità della comunicazione elettorale. Senza elettori non c’è democrazia
e l’attuale offerta politica che c’è sul campo non riesce ad attrarre e a
convincere gli elettori che non vanno più a votare. Altre offerte politiche sul
campo sono ignorati, pur avendo una specifica proposta politica utile – se solo
fosse possibile conoscerla e discuterla – a far uscire il Paese dalla sua
”flagranza criminale”. Vero è come «media di regime asserviti al governo» (ma io
direi al regime della partitocrazia), hanno la gravissima responsabilità di
negare – in modo sistematico – agli italiani di conoscere le proposte politiche
di riforma e le visioni di nuovi leader. Tutto ciò porta il singolo, non avendo
la forza dirompente, ad avere disgusto.
Il disgusto
che porta a non andare più a votare.
L'astensionismo è il vero vincitore delle elezioni regionali. E colpisce anche
le regioni rosse, ma sono sempre di più quelli che ritengono la politica
italiana impotente e incapace di risolvere i problemi. Mentre i flussi
elettorali spiegano che i travasi di voti tra i partiti sono limitati. Il vero
vincitore delle elezioni regionali 2015 è stata l’astensione, scrive Alessandro
D’Amato su Next Quotidiano”. Su quasi 19 milioni di elettori chiamati alle urne,
appena il 45%, 8 milioni e mezzo, ha espresso un voto valido ad una lista; oltre
9 milioni, il 48%, si sono astenuti. E la tendenza al non voto diventa sempre
più impressionante nella crescita dei numeri, e comincia a colpire anche le aree
più affezionate al rito elettorale. In queste tabelle pubblicate oggi da
Repubblica l’Istituto Cattaneo analizza storicamente la crescita dell’astensione
al voto dalle Regionali del 2010 fino a quelle del 2015 nelle regioni chiamate
al voto. I ricercatori dell’Istituto Cattaneo Dario Tuorti e Maria Regalia hanno
messo insieme le serie storiche del voto regionale confrontandolo con quello per
le politiche ed europee. E alla fine cifre e grafici rivelano che
l’astensionismo alle Regionali è ormai di lunga durata. Ma soprattutto che
domenica si è manifestato in maniera più forte nelle “regioni rosse”. Il primato
è della Toscana, dove rispetto alle politiche del 2013 c’è un calo
dell’affluenza del 30,9%. Il raffronto con le Europee dell’anno scorso dice meno
18%. Anche nelle Marche manca all’appello il 30% per cento dei votanti delle
politiche e il 15,8% delle Europee. E in Umbria le due percentuali dicono meno
24,1% e meno 15,1%. E anche in Liguria la disaffezione si è fatta sentire con un
meno 10 per cento rispetto alle due precedenti tornate elettorali. Tuorti spiega
che «il fenomeno si spiega con il fatto che in queste regioni c’erano
aspettative molto elevate che sono state tradite. Ovviamente incidono anche la
crisi che va avanti dal 2008 e gli scandali che hanno colpito i consigli
regionali, la delegittimazione complessiva dell’istituto regionale». E in
effetti, dicono al Cattaneo, anche se potrebbe sembrare un paradosso, gli
elettori oramai percepiscono più importanti le elezioni Europee che quelle
regionali. Interessante anche il ragionamento dei ricercatori dell’Istituto a
proposito delle regioni del sud: «Nel passato – spiega Tuorti . una certa
astensione esprimeva una forma di protesta verso il partito di appartenenza, un
messaggio di disapprovazione. C’era insomma una forma di partecipazione attiva
anche nell’astensione e si poteva tranquillamente tornare a votare al turno
successivo». Oggi, continua il ricercatore del Cattaneo «siamo di fronte ad una
massa di elettori che scivolano dall’astensionismo “attivo” verso l’altra forma,
quella dell’apatia che tende a tenerli costantemente lontano dai seggi. I
cittadini cominciano ad essere sempre di più disillusi davanti alla mancanza di
risposte».La cosa grave di questo fenomeno -continua il ricercatore del
Cattaneo, «è che l’astensionismo non è distribuito equamente fra le diverse
fasce degli elettori,ma rappresenta solo certe fasce sociali che coinvolge
disoccupati, marginali non garantiti». Ancora più interessante è l’analisi
dell’istituto Demopolis presentata ieri a Otto e Mezzo nel Punto di Paolo
Pagliaro. Nella prima tabella si nota che anche nel computo dei votanti c’è chi
ha scelto di votare solo per il governatore o ha espresso un voto non valido. Si
tratta del 7% del computo totale dei voti, e anche qui si tratta di persone che
hanno scientemente deciso di non votare per un partito pur presentandosi alle
urne. Ancora più interessante è la tabella delle motivazioni che fa parte
dell’analisi dell’istituto. Il 40% ha deciso di non andare a votare perché, a
suo parere, la politica in Italia non incide più sulla vita reale dei cittadini.
E qui sarebbe interessante chiedere a chi ha risposto in questo modo se invece
ritiene che la politica europea sia più incisiva di quella italiana nella vita
dei cittadini: la sintesi del ragionamento sarebbe stata più interessante. Il
27% invece dice che non si sente rappresentato dai partiti votati in precedenza,
mentre il 25% ha scarsa fiducia nei candidati a livello locale. Rimane un buon
8% che dice che l’esito delle elezioni appariva scontato, e quindi probabilmente
si presenterà alle urne in occasioni in cui ci sarà un maggiore equilibrio alle
urne o si voterà per le elezioni politiche. Infine,
l’istituto Demopolis analizza i flussi
elettorali del Partito Democratico, del MoVimento 5 Stelle e della Lega di
Salvini: Quasi tutte le liste sono risultate fortemente penalizzate
dall’astensione in termini di voti assoluti. Secondo l’analisi dei flussi
elettorali e sugli spostamenti del consenso, realizzata dall’Istituto Demopolis,
su 100 elettori che avevano scelto il PD alle Europee del maggio scorso, 62
hanno rivotato nelle 7 Regioni il partito di Renzi o le liste dei candidati
Presidenti; 8 hanno preferito altre liste, 3 elettori su 10 hanno optato per
l’astensione. Quadro non dissimile quello del Movimento 5 Stelle: 6 su 10, tra
quanti avevano votato Grillo alle Europee, hanno confermato il voto al Movimento
alle Regionali, 11 su 100 hanno scelto altre opzioni; 29 su 100 sono rimasti a
casa. L’Istituto diretto da Pietro Vento ha analizzato la composizione del
consenso al partito di Salvini in base al voto espresso alle Europee: su 100
elettori odierni alle Regionali (quasi un milione e 300 mila incluse le liste
Zaia), poco più di 500 mila avevano già scelto la Lega un anno fa. 8 su 100
avevano votato il M5S, 5 il PD, 14 altre liste o si erano astenuti. Secondo
l’analisi post voto di Demopolis, 33 su 100 degli attuali elettori leghisti
avevano scelto Forza Italia alle Europee. Un flusso che conferma, anche a
livello regionale, i mutati equilibri nell’area di Centro Destra.
Vince
l’astensione: siamo noi giovani a non votare più.
Il partito dell'astensione cresce a ogni elezione di più. Ma è un problema che
va affrontato, perché riguarda soprattutto i più giovani. Troppo lontani dalla
politica, scrive Michele Azzu su "Fan Page". “Il vero vincitore è
l’astensionismo”, anche a queste elezioni regionali ripeteremo questa solita
frase fatta per chissà quanto tempo. Frase che, elezione dopo elezione, sembra
sempre più veritiera. Alle elezioni regionali di Veneto, Campania, Marche,
Umbria, Toscana, Puglia, Liguria ha votato solo il 51.4 per cento degli aventi
diritto. Nel 2010 era il 64 per cento: si sono persi il 10 per cento di voti.
Una persona su due non ha votato, e questa volta non è stato certo per colpa del
bel tempo e delle gite di primavera: nel fine settimana ha piovuto in quasi
tutto il paese. È un dato che fa spavento. Confrontiamolo coi dati delle più
recenti votazioni del nostro paese. Lo scorso novembre si votava alle regionali
in Emilia Romagna e Calabria. Anche in quel caso l’affluenza al voto fu
bassissima: in Emilia Romagna votò il 37.7 per cento contro il 68 delle elezioni
precedenti, e contro il 70 per cento delle europee di solo sei mesi prima. Sono
30 punti percentuali in meno. In Calabria a votare furono il 43.8 per cento
degli aventi diritto contro il 59 per cento del 2010 (15 per cento in meno).
Alle scorse elezioni europee, invece, l’affluenza fu più alta: circa il 60 per
cento degli aventi diritto. E alle scorse elezioni politiche? Quelle del giugno
2013, in cui vinse per un soffio il PD guidato da Pierluigi Bersani che poi però
non andò mai al governo. In quell’occasione, votò il 55 per cento degli elettori
rispetto al 62.6 per cento di cinque anni prima, nel 2008. Le elezioni hanno
ormai imparato a convivere con alti tassi di astensionismo. E allora, se va così
dappertutto, forse è un segno dei tempi. Chi non vota rinuncia coscientemente a
un proprio diritto – dirà qualcuno – e allora perché porsi il problema?
L’astensionismo è un problema perché il dato della disaffezione al voto riguarda
principalmente i più giovani. Certo, è ancora presto per avere i dati precisi da
queste votazioni, ma sappiamo già che è a loro che riguarda questo 48 per cento
di astensione. Ce lo dicono i dati delle elezioni più recenti. Alle recenti
elezioni europee – quelle del tanto sbandierato 41% di consensi al PD – trionfò
proprio l’astensione dei giovani. Mentre, come dicevamo, il dato di affluenza
rimase discreto, con circa il 60% di votanti, in tutta Europa solo il 28% dei
giovani europei andò a votare. “Le elezioni europee del 2014” hanno mostrato che
esiste ancora un alto livello di astensione, con solo il 28% dei giovani fino ai
25 anni che si è recato a votare”, commentava Johanna Nyman, presidente
dell’European Youth Forum. In Italia solo il 40% dei giovani è andato a votare
alle europee. E alle politiche? Secondo il Centro Italiano di Studi Elettorali,
alle ultime politiche del 2013 l’astensione ha riguardato principalmente i
giovani. “Con l’eccezione di Torino, emerge che i neoelettori sono stati più
propensi all’astensione”, scrive l’ente accademico. “In misura marginale nella
capitale, più significativa a Milano e Firenze e ancor più spiccata a Palermo.
Nel capoluogo siciliano, quasi la metà dei cittadini fra i 18 e 24 anni ha
deciso di astenersi”. in foto: l'astensione dei giovani alle elezioni europee
2014 Anche il presidente del Senato Pietro Grasso si è rivolto in questi giorni
ai più giovani, invitandoli a votare: "Alcuni di voi domenica saranno chiamati
per la prima volta ad esprimere il proprio voto alle elezioni amministrative:
fatelo, non lasciate che siano altri a decidere per voi". Ma non c’è niente da
fare: ai più giovani votare non interessa. È davvero così difficile capire
perché? Così come per la elezione del Presidente della Repubblica, il momento
del voto non viene ritenuto capace di cambiare qualcosa di significativo nella
vita di tutti i giorni, e viene vissuto come una cosa lontana e irrilevante. Una
scocciatura. Ma cosa è ritenuto rilevante dai giovani d’oggi? Se è difficile
capire perché i giovani si disinteressano della politica, e del voto, forse
possiamo chiederci cosa interessa i giovani. Una recente ricerca del programma
Erasmus – che da ormai 20 anni permette ai giovani universitari di studiare per
un anno in un altro paese dell’Unione Europea – ha di recente pubblicato i
risultati di un sondaggio esteso alla popolazione di ex e attuali studenti
migranti. Giovani laureati e di respiro europeo, insomma, proprio quelli da cui
ci si aspetterebbe un interesse alla politica. Secondo i risultati del sondaggio
le priorità dei giovani Erasmus sono crescita e posti di lavoro, col 60 per
cento di preferenze. Al secondo posto vengono le preoccupazioni sui cambiamenti
climatici. Al terzo posto la lotta alla corruzione. Dati molto simili a quelli
raccolti durante le ultime elezioni politiche italiane dalla campagna “Io voto”,
realizzata dall’emittente televisiva Mtv. Secondo cui il 74 per cento dei
giovani associa la politica alla corruzione, il 67 per cento a una sensazione di
disgusto. Per il 60 per cento la classe dirigente italiana è considerata:
“anacronistica e incapace di rinnovarsi”. L’astensione al voto cresce ogni
elezione di più. E riguarda principalmente i giovani. Laureati, occupati,
disoccupati, nelle grandi città come alla provincia del sud. Cambia poco. Perché
ai giovani, oggi, interessa porre fine alla corruzione, interessa trovare
lavoro, e migliorare le condizioni in cui si lavora. Ai giovani interessa porre
riparo al riscaldamento globale che sta modificando la temperatura del pianeta,
e quindi la fuoriuscita dai carburanti fossili, la ricerca di stili di vita più
sani. Di tutte queste cose nei manifesti elettorali non si è trovata traccia:
non alle europee, non alle politiche più recenti, non a queste regionali. Perché
la politica non parla ai giovani, non è fatta dai giovani, e ai giovani non
pensa proprio. Non a caso il Movimento 5 Stelle rimane il primo partito fra i
giovani. Perché è un soggetto nuovo, che ha fatto della lotta alla corruzione la
propria bandiera, così come le battaglie per l’ambiente, e per il reddito di
cittadinanza – anche se sul lavoro latita. Ma questo dato di astensione, prima
ancora dell’esito negativo della Liguria, Campania e Veneto, non è una grande
sconfitta per Matteo Renzi, che ha solo 40 anni e che doveva rottamare la
politica dei vecchi e dei poteri forti? E riportare i giovani alla politica?
Dalle regioni, fino al governo, passando per le europee, insomma, dove diavolo è
la politica che dovrebbe interessare i giovani?
Votano
pochi anche in Germania. In Italia non si vota per disgusto,
in Germania per noia, scrive Roberto Giardina su
“Italia Oggi”. Perché preoccuparsi dell'astensione di domenica scorsa in Italia?
Avviene così altrove, perfino in Germania. Metà dei votanti è rimasta a casa?
Claudio Velardi cita la Baviera, ma, per la verità, qui in Germania, all'ultimo
appuntamento elettorale, l'astensione si è fermata al 46%. Comunque è vero, a
casa della Merkel gli elettori sono sempre più pigri, nelle elezioni dei Länder,
le regioni, si continua a calare, sfiorando il 50%. Soltanto che qui ci si
preoccupa della pigrizia elettorale. I nostri politici fanno finta di niente. Ma
le cause sono diverse: i tedeschi disertano le urne per noia, gli italiani,
temo, per disgusto e rassegnazione. Nel '72, al primo voto anticipato nella
storia della Repubblica Federale, che era una sorta di referendum su Willy
Brandt e la sua Ostpolitk, andò a votare oltre il 90%. Nel 2013, al terzo round
per Frau Angela, fu il 71,5, un 1,3 in meno rispetto a quattro anni prima. Ma
l'esito era scontato: una Grosse Koalition, una grossa coalizione. E se i due
grandi partiti si alleano dopo il voto, perché devo andare alle urne? Inoltre,
il programma della sinistra socialdemocratica e dei conservatori della Cdu-Csu è
diverso soltanto per sfumature. Quanti sperano che se nel 2017 ci sarà un
cancelliere socialdemocratico cambierà la politica europea di Berlino, avrà
un'amara sorpresa. Un'altra considerazione: la Germania è uno stato federale
basato sulla storia. In Italia, la riforma delle regioni è stata abborracciata
per populismo e per accontentare Bossi. I Länder corrispondono agli antichi
stati tedeschi prima che Bismarck riuscisse a creare il Reich. Alcune regioni
come la Baviera sono immense, e il Land meridionale ha un pil superiore a quello
di Olanda e Belgio messi insieme. Altre sono minuscole come di Amburgo o di
Brema, le città dell'Ansa. Da noi, le Repubbliche marinare hanno forse una
coscienza, come dire?, nazionale più antica di un Molise. Dovremmo avere una
regione delle Due Sicilie, e anche il Granducato di Toscana, mentre la Padania
non è mai esistita (quando lo scrisse mio fratello, lo storico, credendo di dire
un'ovvietà, fu minacciato di morte). Infine, le preferenze. Io, come ex abitante
di Roma, non ero chiamato alle urne domenica. Ma se avessi dovuto votare in
Liguria, o nel Veneto, o in Campania, sarei rimasto a godermi il weekend di
tarda primavera a Berlino. Non avrei mai potuto votare per la signora Moretti,
né per i suoi avversari. Neanche per la signora Paita a Genova, o per De Luca,
in Campania. Anch'io sarei entrato nel branco degli astensionisti, ma per
costrizione e non per libera scelta, per noia, o pigrizia. In Germania, a
livello nazionale, il sistema del doppio voto è geniale. Il primo, va al
partito, e con questo si eleggono i candidati presentati dai partiti, con una
lista chiusa come tanto piace ai nostri leader che non sopportano i gusti degli
elettori. Ma il secondo voto è personale per un candidato di nostro gradimento,
anche di un altro partito. Allora la Cdu o l'Spd devono stare molto attenti nel
compilare la loro lista, ed evitare di essere punite alle urne. Infine, il nuovo
Senato che Renzi sostiene sfacciatamente di aver copiato dal Bundesrat tedesco,
la camera delle regioni. Da noi sarà formato da senatori designati dall'alto,
scelti nelle regioni. In Germania vi partecipano i rappresentanti dei Länder,
che già fanno parte dei parlamenti regionali, in proporzione ai risultati
locali. Il Bundesrat ha diritto di veto su tutte le leggi del Bund, la
federazione, che hanno importanza locale. Quindi su quasi tutte, dai trattati
firmati a Bruxelles alla proroga o chiusura delle centrali atomiche. Votando
nelle regioni in momenti diversi, al Bundesrat si forma, di solito, una
maggioranza di segno opposto rispetto al Bundestag, il parlamento federale. Per
ogni legge, o quasi, il governo è dunque costretto a sentire il parere
dell'opposizione. Si crea una sorta di Grande coalizione non ufficiale. Un voto
di Land è influenzato ovviamente dalla situazione locale, ma nessun politico a
Berlino oserebbe commentare ciò che non riguarda il governo centrale. Quando
Schröder avviò la radicale riforma dello Stato sociale, dovette trattare con i
cristianodemocratici. E quando la Merkel lo battè e divenne cancelliera, non
poté, e neanche volle, riformare le riforme del predecessore, perché realizzate
con il consenso del suo partito. Un sistema che favorisce la continuità. In
Germania chi ha la maggioranza non fa quel che vuole, come si sostiene a parole
in Italia. Ma questo principio non può essere garantito dalla legge. Dipende
dalla coscienza democratica.
I GRILLINI
CANTANO VITTORIA. MA ANCHE LORO FAREBBERO BENE A CHIEDERSI PER CHI SUONA LA
CAMPANA,
scrive Antonio de Martini su “Il Corriere della Collera”. Un lettore mi ha
scritto ripetutamente invitandomi a commentare la vittoria del movimento cinque
stelle alle recenti elezioni. Turani nel suo giornale presenta questi
numeri:
1) Alle
elezioni politiche del 2013 , nelle stesse sette regioni in cui si è votato, il
movimento cinque stelle raccolse 3.274.571 suffragi.
2) Alle
elezioni Europee del 2014 , sempre nelle stesse regioni, gli elettori scesero a
2.211.384.
3) Alle
regionali appena trascorse i votanti 5 stelle sono stati 1.320.885.
Sempre che la
matematica non sia diventata di parte anch’essa, il movimento 5 stelle non ha
avuto un successo, ma una perdita di votanti che si sono dimezzati rispetto alla
prima apparizione sulla scena politica. Molti cittadini cercano di illudersi e
vedere in “ogni villan che parteggiando viene ” il messia salvatore che rimetta
le cose a posto senza che ci si scomodi più di tanto. Un voto, una richiesta di
favori e via….Ebbene, non è così. Non è più così. La tendenza chiara ogni giorno
di più è che dal 1976 in poi la sola cifra in crescita alle elezioni è quella
dei cittadini che si rifiutano di essere presi in giro da questi ladri di Pisa
che di giorno litigano e di notte rubano assieme. I cittadini che si astengono
dal voto e di cui tutti fingono di non capirne le motivazioni. Il Cardinale Siri
( arcivescovo di Genova, città che si appresta a subire l’ennesima delusione) –
mi dicono – ebbe un bon mot: ” esiste personale politico di due tipi:
quelli che rubano per fare politica e quelli che fanno politica per rubare. Da
un po' vedo in giro solo questi ultimi”. Appunto. Arrestarli? Inutile. Sono più
numerosi dei carabinieri e in costante crescita. Per uscire da questo maleolente
pantano è necessario che tutti i cittadini – dopo aver fatto il proprio dovere –
decidano di esercitare i loro diritti costituzionali partecipando alla vita
nazionale in forma attiva, propositiva e continuativa. Ad ogni livello. Fino a
che aspetteremo il “deus ex machina”, la “rigenerazione” ed altre minchiate
consimili resteremo dove siamo. Tra tutte le soluzioni miracolistiche proposte,
quella di far governare l’Italia da un gruppo di giovani somari è la più
stravagante. I dirigenti della Nuova Repubblica dovranno essere selezionati uno
a uno in base al sapere, all‘esperienza e sopratutto al carattere. Oggi si
scelgono in base alla fedeltà, l’ignoranza e alla disponibilità al compromesso.
La politica delle etichette (delle camicie, dei distintivi ecc) si addice ai
prodotti commerciali, non alle persone.
L'utopia
dell'onestà e la demagogia della proposta politica irrealizzabile, presentata
come panacea di tutti i mali, sono le prese per il culo che il cittadino non
tollera più.
Una
Repubblica fondata sulla trattativa.
Gli accordi tra Stato e criminalità vanno avanti da due secoli. Così i padrini
si sono visti riconoscere la loro forza. Che ora si è spostata nell’economia,
scrive Giancarlo De Cataldo su "L'Espresso". Ci sono in molti paesi delle
fratellanze, specie di sette che diconsi partiti, senza riunione, senz’altro
legame che quello della dipendenza da un capo, che qui è un possidente, là un
arciprete. Una cassa comune sovviene ai bisogni, ora di far esonerare un
funzionario, ora di proteggerlo, ora di conquistarlo, ora d’incolpare un
innocente. Il popolo è venuto a convenzione coi rei”. Così scriveva, nel 1838,
don Pietro Ulloa, Procuratore borbonico di Trapani. E Leonardo Sciascia poteva
annotare, sconsolato, oltre cent’anni dopo: “Leggeremo mai negli archivi della
commissione parlamentare antimafia attualmente in funzione, una relazione acuta
e spregiudicata come questa?”. Se il popolo sia “venuto a convenzione coi rei”,
e per mezzo di alcuni dei suoi più alti rappresentanti, lo stabiliranno i
giudici di Palermo, chiamati ad accertare se vi fu, fra il ’92 e il ’93, una
“trattativa” fra mafia e Stato, e se furono commessi dei reati. Ma la verità
giudiziaria è un conto, quella storica un altro, e non sempre le due verità
coincidono. I giudici sono obbligati ad attenersi agli atti, gli storici non
conoscono questo limite. La Storia è una grande risorsa, non foss’altro perché
quasi sempre, per comprendere il presente, è doveroso guardare al passato. E il
passato - a partire da don Pietro Ulloa - ci insegna che, sin dagli albori dello
Stato unitario fra settori dei pubblici poteri e organizzazioni criminali si
instaurarono accordi occulti e inconfessabili. “Patti scellerati”, li definisce
lo storico francese Jacques de Saint Victor. Non ne furono immuni i sovrani
assolutisti prima dell’Unità, i governanti che succedettero a Cavour,
appartenessero alla Destra o alla Sinistra storiche, e nemmeno qualche
rivoluzionario. Si avvalsero della “collaborazione” delle mafie coloro che
intendevano mantenere l’ordine e quanti auspicavano il cambiamento. E sempre,
costantemente, si potrebbe dire ossessivamente, costoro furono combattuti,
troppo spesso senza successo, da leali servitori dello Stato che, oltre a
fronteggiare il nemico dichiarato, dovevano guardarsi le spalle da quello
interno. Il termine mafia compare per la prima volta in un documento ufficiale
nella relazione redatta nel 1865 dal prefetto (orvietano) di Palermo, Filippo
Antonio Gualterio. “I liberali del 1848, i Borboni nella restaurazione, i
garibaldini nel 1860, ebbero tutti la necessità medesima, si macchiarono tutti
della istessa colpa”. Si legarono alla trista associazione malandrinesca,
determinando un legame indissolubile fra mafia e potere (o contro-potere)
politico. Gualterio lascia intendere che, infine, le cose dovranno cambiare,
grazie al nuovo governo: del quale egli, ovviamente, fa parte. Per Gualterio,
“mafioso” è chi si oppone al nuovo ordine, sia egli garibaldino, repubblicano,
nostalgico dei Borboni o autenticamente criminale. E le sue parole, per un verso
nobilmente allarmate, per un altro ambigue, sono l’ennesima rappresentazione di
un’altra costante del rapporto fra mafie e poteri in Italia: ciò che potremmo
definire “il buon uso della mafia”. È una partita che Gualterio ha giocato in
prima persona quand’era patriota, con la stessa spregiudicatezza di tutti gli
altri attori. Le bande di bonache e picciotti che scortano Garibaldi nella
trionfale impresa dei Mille sono, a un tempo, squadre a protezione dei
latifondisti improvvisamente convertiti al nuovo che avanza, aggregazioni
para-mafiose ma anche espressione di un sogno sociale di riscatto, quasi
rivoluzionario, che presto le fucilazioni sommarie di Nino Bixio e dei
piemontesi trasformeranno in incubo. Negli stessi giorni, a Napoli, mentre il
regime borbonico si sfarina, il ministro liberale Liborio Romano promuove la
camorra a Guardia Civica: per evitare disordini, dirà lui, e c’è da credergli.
Ma sta di fatto che Garibaldi, a Napoli, è accolto da una folla festante in cui
si mescolano allegramente democratici e tagliagole. La mossa di Romano sancisce,
ancora una volta, il ruolo “politico” del crimine organizzato e la necessità, da
parte dei pubblici poteri, di trovare un accordo. A proposito dei rapporti fra
politica e mafie nell’Italia postunitaria, c’è un paragrafo impressionante nella
“Storia della Mafia” di Salvatore Lupo: “Il partito governativo non escludeva il
delitto politico e il ricorso ad una sorta di strategia della tensione (...) con
la finalità di favorire la divisione della sinistra criminalizzandone l’ala
estrema e conquistando a una collaborazione subalterna il gruppo che
privilegiava la difesa delle conquiste risorgimentali dai pericoli reazionari”.
E per conseguire questo obbiettivo si agita lo spettro di congiure inesistenti,
oppure se ne impiantano di autentiche grazie al ricorso a spregiudicati agenti
provocatori. Si dà per scontato che, a fini politici, ci si possa avvalere di
metodi criminali in accordo con un sistema che di per sé è già criminale. Sembra
delinearsi, insomma, un copione che ricorrerà più volte: con i pubblici poteri
che cambiano e le mafie che restano sempre se stesse. Viene da pensare alla
repressione del movimento dei Fasci a fine Ottocento, alla collaborazione dei
mafiosi allo sbarco anglo-americano del ’43, agli ancora oscuri risvolti della
Strage di Portella della Ginestra del 1947, all’esecuzione taroccata del bandito
Giuliano, alle morti per avvelenamento di Pisciotta e Sindona, all’ascesa
cruenta dei Corleonesi, ai delitti eccellenti degli anni Ottanta, giù giù sino
alle stragi del ’92-’93. Tutti esempi di “buon uso della mafia” o ci si può
spingere oltre, e usarla, questa benedetta parola: trattativa? Nessuno, pure, la
pronuncia mai in sede ufficiale. Ma qualcosa di simile, grazie a un evidente
sinonimo, “transazione”, pure affiora, a scavare nel passato. È il 1875 quando
il deputato (ex-magistrato) calabrese Diego Tajani, durante un infocato
dibattito parlamentare, così definisce la situazione dell’ordine pubblico in
Sicilia: “Là il reato non è che una transazione continua, si fa il biglietto di
ricatto e si dice: potrei bruciare le vostre messi, le vostre vigne, non le
brucio ma datemi un tanto che corrisponda alle vostre sostanze. Si sequestra e
si fa lo stesso: non vi uccido, ma datemi un tanto e voi resterete incolume. Si
vedono dei capoccia della mafia che si mettono al centro di taluna proprietà e
vi dicono: vi garantisco che furti non ne avverranno, ma datemi un tanto per
cento dei vostri raccolti”. Transazione: come quella fra prefetti e comandanti
militari e banditi, ai quali, talora, si concedeva un salvacondotto perché
ripulissero il territorio. Da altri banditi. Transazione. Con le mafie si
possono fare affari, si può servirsene per l’ordine (o, alternativamente, per il
disordine), e la cosa è sotto gli occhi di tutti. Impensabile che i vecchi
malandrini non si siano resi conto, col tempo, di essere assurti, essi stessi,
da compagnia di raccogliticci accoliti a “forza politica”. E la stessa
sensazione di essere “potere”, o comunque di giocare un ruolo determinante negli
assetti strategici della nazione, magari a colpi di esplosivo, traspare da più
di un verbale degli odierni collaboratori di giustizia. Da qualche anno a questa
parte, le mafie sparano di meno, e quindi, verrebbe da dire, sono più forti.
L’accumulazione del capitale che garantiscono i proventi delle attività illecite
è un fattore di potente condizionamento del gioco economico. Le “transazioni”
sembrano essersi spostate dal piano dei rapporti con gli Stati a quello dei
mercati finanziari. Il governatore della Banca d’Italia ha denunciato l’enorme
danno arrecato dal fattore criminale agli investimenti stranieri in Italia. Ma
le mafie sono da tempo un fenomeno transnazionale, globalizzate più rapidamente,
e con esiti spesso più soddisfacenti, dell’economia “legale”. Bisognerebbe
girare il monito a quei santuari del denaro che periodicamente patteggiano
ingenti penali per aver chiuso un occhio (e a volte tutti e due) sui movimenti
sospetti di capitali. A quanto pare, non disdegnano di “venire a convenzione coi
rei”. Le mafie sono partite dalle campagne o dalle periferie, ma hanno risalito
il mondo, scalandolo con estrema facilità. Eppure, restano sempre mafie. Quelle
descritte da don Pietro Ulloa nel lontano 1838. È ancora Sciascia a rivendicare
l’ultima parola: “Gli elementi che distingueranno la mafia da ogni altro tipo di
delinquenza organizzata, l’Ulloa li aveva individuati. Questi elementi si
possono riassumere in uno: la corruzione dei pubblici poteri, l’infiltrazione
dell’occulto potere di un’associazione, che promuove il bene dei propri
associati contro il bene dell’intero organismo sociale, nel potere statale”.
Onestà (e
non solo) la risposta politica contro la corruzione.
Dopo tante inchieste sulle malefatte degli amministratori, bisogna chiedersi
perché nulla sia cambiato: come diceva Croce, non basta invocare le virtù
personali, occorrono strategie adeguate, scrive Giovanni Belardelli su “Il
Corriere della Sera”. «Di nuovo?». È questa la domanda che, di fronte agli
sviluppi giudiziari dell’inchiesta «Mafia capitale», molti cittadini si sono
fatti, sempre meno fiduciosi circa la possibilità che si possa ridurre
l’intreccio tra politica e malaffare. È uno stato d’animo comprensibile, ma da
superare: occorre chiedersi se non c’è stato anche qualcosa di sbagliato nel
modo in cui, per tanti anni, abbiamo evocato la questione morale. L’appello
all’onestà, tante volte ripetuto, non basta infatti di per sé a risolvere i mali
della politica: e il sentimento «anti casta», pur animato da giustificato
sdegno, ha diffuso nel Paese l’idea che della politica e dei partiti si possa
fare a meno, per affidarsi alla magistratura. Così non è. E anche se la qualità
del ceto dirigente, locale e nazionale, è evidentemente scadente (quanti sono
coinvolti nelle inchieste sembrano spinti solo da miserabili aspirazioni di
arricchimento), l’onestà personale non è, né sarà sufficiente a risolvere un
problema di grave inadeguatezza politica. Dopo vent’anni di inchieste
giudiziarie sulle malefatte dei politici e di denunce della corruzione formulate
anche in sedi autorevolissime (dai più alti scranni della Repubblica al soglio
di Pietro), ancora a questo punto siamo? Questo è ciò che mestamente devono
essersi domandati tanti italiani, sempre meno fiduciosi circa la possibilità che
si possa quanto meno ridurre l’intreccio tra politica e malaffare. È uno stato
d’animo comprensibile ma che andrebbe superato, per cominciare a chiedersi se
non ci sia stato anche qualcosa di sbagliato nel modo in cui per tanti anni
abbiamo evocato la «questione morale». Una parte del mondo politico e
dell’informazione, prevalentemente orientata a sinistra, lo ha fatto, ad
esempio, accreditando l’idea che ad essere disonesti fossero gli «altri», i
politici - e dietro di loro, si lasciava intendere, gli elettori - di
centrodestra. Era l’idea di una frattura antropologica tra destra e sinistra
che, prima ancora di Mafia Capitale, altri scandali bipartisan si sono
incaricati di dimostrare infondata; ma è tuttavia un’idea cui una parte del
Paese ha creduto a lungo, evitando anche per questo di riflettere seriamente
sulle ragioni per cui in Italia guardiamo spesso con indulgenza e comprensione a
certi comportamenti illegali. Osservò una volta Benedetto Croce che la
«petulante richiesta» di onestà nella vita politica è l’«ideale che canta
nell’anima di tutti gli imbecilli». Personalmente onestissimo, Croce non voleva
certo fare l’apologia della disonestà in politica ma segnalare come l’appello
all’onestà sia di per sé insufficiente a risolvere i mali della politica, che
hanno anzitutto bisogno di rimedi - appunto - politici. Invece - ecco un altro
errore di questi decenni - il sentimento «anticasta», pur animato da sdegno
giustificatissimo per i privilegi e le malefatte del ceto politico, ha diffuso
nel Paese l’idea che della politica e dei partiti si possa fare a meno, per
affidarsi ai controlli e alle inchieste della magistratura, magari con un
inasprimento delle pene cui pochi peraltro riconoscono una vera capacità
dissuasiva. Le notizie che si vanno pubblicando sull’inchiesta di Mafia Capitale
mostrano, al di là di quelle che saranno poi le risultanze finali dei processi e
al di là della congruità (per molti dubbia) del riferimento alla mafia, la
qualità scadente del ceto politico locale, romano e non solo. Come lasciano
trasparire anche altre inchieste di questi anni, si tratta spesso di un
personale politico (quasi esclusivamente maschile: sarà un caso?) privo di ogni
aspirazione od obiettivo di natura politica, come non era invece nella Prima
Repubblica, che avrà avuto molti difetti ma non questo. Quanti sono coinvolti
nelle inchieste di cui si occupano i giornali in questi giorni sembrano infatti
spinti in via esclusiva da miserabili aspirazioni di arricchimento personale: se
non è (solo) il denaro, sono magari le assunzioni di parenti e amici (chi ne
chiede due, chi tre, chi dieci). Il fatto è che un tempo l’accesso alle carriere
politiche locali operava dentro un quadro di relazioni e controlli nazionali che
ormai non esistono più o si sono indeboliti notevolmente. Tranne evidentemente
nel caso delle primarie per il Pd, che però hanno spesso finito con l’esaltare
proprio il potere e l’influenza dei «capibastone» (il termine era usato tre mesi
fa da Fabrizio Barca in quella sua diagnosi sul Pd romano «pericoloso e dannoso»
di cui forse i vertici del Nazareno avevano sottovalutato la drammaticità). Se
le cose stanno così, i partiti - e in primo luogo, il principale partito di
governo - non possono limitarsi alla (ovvia) esortazione affinché la giustizia
faccia il suo corso, ma dovrebbero prendere delle decisioni politiche adeguate.
Il Pd, in particolare, dovrebbe rendersi conto di quanto sia poco giustificabile
agli occhi dell’opinione pubblica continuare a sostenere il sindaco Marino solo
perché non personalmente coinvolto nell’inchiesta giudiziaria. Non c’è bisogno
di citare ancora Croce per osservare che l’onestà personale non è sufficiente a
risolvere un problema di grave inadeguatezza politica.
Nel paese
dove è inutile essere onesti.
La politica è da sempre incapace di fare pulizia prima che arrivino le inchieste
giudiziarie. Così si arriva alle liste compilate con criteri discutibili, scrive
Roberto Saviano su “L’Espresso”. Elezioni all'insegna del “in fondo sapevamo già
tutto”, le Regionali di domenica scorsa. Certo, banalizzare l’esito del voto
talvolta può essere un’operazione scontata, ma non in questo caso, in cui le
premesse dicevano già molto. Ma non le premesse dei sondaggi, non i dibattiti
sui giornali, non i comizi da talk show. Bensì gli umori in strada, i discorsi
tra le persone, la delusione da bar. Eh sì, perché ormai le “chiacchiere da bar”
è in questo che si sono mutate, in “delusione da bar”. Alla politica ormai si
applica la stessa “sindrome Trapattoni” che il nostro paese conosce per il
calcio: tutti allenatori e tutti delusi dalla classe politica. Abbiamo letto
ancora una volta titoli come “Il vero vincitore è l’astensionismo” che mette in
luce quel 52% di affluenza al voto che ormai non scandalizza più. E se in Italia
la politica, tutta, non cambia rotta - ma evidentemente non lo farà - è un dato
destinato a decrescere soprattutto se alle urne si è chiamati in una domenica di
sole, la prima dopo freddo e pioggia. Ma cosa significa cambiare rotta?
Significa forse non candidare “impresentabili”? Significa forse smetterla di
assecondare le pulsioni più ancestrali come la difesa del proprio nido dallo
straniero aggressivo ma soprattutto diverso? Significa smetterla di credere che
determinate regole valgano per gli altri e non per noi? Significa pesare ogni
parola, ogni esternazione pubblica, e farlo sul serio? Significa iniziare a
dialogare con la società civile e farlo non mettendosi alla lavagna, gessetto in
mano, a dare lezioni? Tutto questo, ma significa anche non dare per morta una
forza politica quando non lo è: per 20 anni in Italia abbiamo visto vincere il
berlusconismo senza davvero riuscire a spiegare al paese come potesse accadere.
Il voto di scambio non può essere un alibi che la parte “buona” della società,
dell’informazione e della politica trova ogni volta per giustificare le proprie
incapacità. La vittoria di Giovanni Toti in Liguria dimostra quanto abbiamo
visto ormai talmente tante volte da poterlo considerare in fondo un copione già
scritto: una forza politica data per morta può farcela contro una forza politica
data per viva, ma divisa. Ed ecco che Berlusconi è stato ancora una volta in
grado di unire, assecondando utili convenienze come ai bei tempi. Tutti quanti a
parole sono contro una fantomatica “Sinistra” che dal 1989 esiste solo nei
discorsi e nelle fantasie del satrapo di Arcore. Ed ecco il PD, ancora una
volta, ha consapevolmente perso in Veneto e la Liguria e ha vinto in Campania
chiudendo tutti e due gli occhi sulla candidatura di De Luca. Ed ecco il M5S,
che per la prima volta ha fatto campagna elettorale senza gli eccessi verbali di
Beppe Grillo, ha recuperato parte del voto moderato e si è attestata come terza
forza politica del Paese. A Napoli con un’unica lista ha sfidato due coalizioni
ottenendo risultati encomiabili con 20 mila euro di campagna elettorale
provenienti da donazioni private. Come accade che un movimento dato per defunto
risorga dalle proprie ceneri, o meglio, dalle ceneri con cui lo avevano
erroneamente ricoperto? Il M5S è nato come movimento di protesta e di
cambiamento. Non essendo ancora mutato nulla, nonostante la rottamazione, resta
un catalizzatore di consenso che si nutre di sfiducia verso tutto il resto. È
l’unica forza politica ad aver mantenuto fermo un punto essenziale: candidare
solo chi non abbia pendenze giudiziarie. Per un garantista come me non è
ammissibile pensare che se sono sotto processo perché il mio cane avrebbe morso
un passante e ancora non sono stato né assolto né condannato, questo possa
rappresentare motivo di incandidabilità. Ma l’umore in Italia è questo: “Se hai
problemi con la giustizia, senza entrare nel merito, noi non ti vogliamo a
rappresentarci. Punto”. Alla fine si è diventati più realisti del re, a causa
dell’incapacità che la politica italiana ha da sempre di fare pulizia prima che
arrivino inchieste giudiziarie o Commissioni parlamentari antimafia. Perché alla
fine non basta più il buon senso, ma occorre, per catalizzare fiducia, ricorrere
a metodi estremi. E ormai anche io, da osservatore, non so davvero se temere di
più la retorica dell’onestà o che si realizzi quanto disse Corrado Alvaro: «La
disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che
vivere onestamente sia inutile».
La finanza,
gli impresentabili e i parrucconi,
scrive Nicola Porro su “Il Giornale”. Questo paese di parrucconi è veramente una
schifezza. Parrucconi buoni solo a declamare principi favolosi di onestà,
correttezza ed eticità ci sono sempre stati per carità. Il problema è che
abbiamo sempre pensato che sotto queste profumate parrucche, si celassero solo
teste di rapa. Alzi la mano chi è a favore della disonestà? Faccia un passo
avanti chi è favore della corruzione? Nessuno è ovvio. Il nostro parruccone
moderno fa di più, questiona i quarti di nobiltà. Tipo alla Caccia. Vabbè tutti
sapete della genialata democratica della commissione antimafia, guidata da Rosy
Bindi. Non è pietanza da Zuppa, ma nel Giornale se ne parla. Eccome. Mentre la
Bindi e soci si incipriavano la parrucca, anzi il parruchino, pensando a chi
potesse entrare nella lista degli impresentabili, a Roma si teneva l’assemblea
dell’Enel. Una delle più importanti società italiane e tra i leader mondiali
dell’energia elettrica. Cosa decidevano gli azionisti dell’Enel? I soliti conti
e ricchi dividendi. Ma anche (brevina sui giornali) di allentare la cosiddetta
clausola di onorabilità dei propri amministratori. In sostanza, fino a ieri, se
un membro del cda dell’Enel fosse stato raggiunto da un avviso di garanzia e poi
rinviato a giudizio, si sarebbe dovuto dimettere subito dalla società.. Ebbene
ieri l’assemblea, quasi al 100 per cento, approvava l’allentamento della norma:
non basta il semplice rinvio a giudizio, ma è necessaria almeno una condanna in
primo grado. Tutto bene quel che finisce bene dunque. Mica tanto. E così
ritorniamo alle parrucche. Questa assurda clausola societaria non è stata
introdotta ai tempi del fascismo, ma l’anno scorso dal ministro del Tesoro di
Renzi. Gli uomini di Padoan, in rappresentanza appunto delle quote detenute in
Enel, Eni, Finmeccanica e Terna, si erano presentati nella primavera del 2014
nelle assemblee delle società partecipate proponendo l’introduzione negli
statuti della tagliola. Tutte le più importanti società avevano poi bocciato la
proposta del Tesoro in assemblea. All’Enel ciò non avvenne, anche perché in
quell’assemblea c’era rappresentato solo il 52% del capitale e il Tesoro da solo
ne deteneva più del 30. L’enel fu l’unica dunque a diventare il fenomeno della
legalità. La baggianata era talmente grande che i fondi internazionali, quelli
che una certa pubblicistica avrebbe voluto a favore di questa norma statutaria,
votarono in maggioranza contro alle volonta etiche del Tesoro. Chiunque abbia
parlato con questi investitori sa che sono più preoccupati del funzionamento
della giustizia italiana (che non nega un rinvio a giudizio a nessuno) che
dell’onorabilità dei manager delle grandi società quotate. L’Enel peraltro ha
poi applicato questa norma ad un suo consigliere rinviato a giudizio (Salvatore
Mancuso) che con il nuovo statuto approvato ieri non avrebbe dovuto fare alcun
passo indietro. Ora infatti serve come minimo una condanna. Qual è la morale di
questa storia? Da parrucconi. Perché il tesoro del governo Renzi l’anno scorso
fa il giustizialista con le sue partecipate (colpo che gli riesce solo all’Enel
dove i fondi internazionali non riescono ad opporsi) e dopo solo un anno fa
marcia indietro? Non che la norma fosse meno assurda nel 2014: da Scaroni,
all’epoca all’Eni, ai grandi gestori dei fondi, tutti avevano spiegato la
pericolosità della norma a Renzi&co. Eppure gli uomini di Padoan continuarono
per la loro strada, per poi cambiarla, alzando la manina in assemblea, un paio
di giorni fa. Ritornando al principio. Viene da pensare che il Tesoro nel 2014
si sia comportato come la Commissione Bindi (quella che si dovrebbe occupare di
mafia) si comporta oggi. La stessa commissione che dalla parti di Renzi oggi
viene così fortemente criticata. E vai con il cambio di parrucche. Olè.
Il rapporto
che fa tremare Angela Merkel: anche i tedeschi imbrogliano l'Europa,
scrive Libero Quotidiano”. Non siamo i soli nella lista dei Paesi europei in cui
si è registrato e perseguito il maggior numero di frodi a danno dei fondi
europei. Con noi ci sono anche Bulgaria, Spagna, Belgio e, sorpresa, la
Germania. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Ufficio europeo per la
lotta antifrode (Olaf) presentato a Bruxelles, dal direttore, Giovanni Kessler.
"Nel 2014 - si legge nel rapporto - si sono raggiunti risultati eccellenti nella
lotta contro le frodi nell'Unione: un anno record con il numero di
raccomandazioni più alto, ben 1417, dalla sua creazione. L'Olaf avvia, in media,
il 60% di indagini in più rispetto al 2012. Solo nel 2014 ha raccomandato alle
autorità nazionali della Ue il recupero di ben 901 milioni di euro, fondi che
dovrebbero essere progressivamente restituiti al bilancio europeo, contribuendo
a finanziare altri progetti". Complimenti da Kessler alla nostra Guardia di
Finanza: "La nostra struttura ha con la GdF una cooperazione eccellente, ormai
tradizionale, che ha portato ottimi risultati. Un rapporto molto forte e
proficuo che spiega anche i tanti casi di indagini. Con loro s'è stabilito un
circolo virtuoso di scambi di informazioni che purtroppo non troviamo in altri
Paesi". Dall'Italia sono arrivate 42 segnalazioni di frode. Ma l'Oscar delle
truffe spetta alla Romania, con 79 casi. In classifica Bulgaria (59), Spagna
(56), Belgio e Polonia (52), Germania (35), Slovacchia (12). In Estonia e in
Svezia non è stata invece riscontrata alcuna irregolarità è stata riscontrata.
"Me lo
merito un Rolex?".
Ancora: “Vado a vedere un po’ di Rolex per Antonia”. E tre: “Vuoi prendere il
Daytona?” E quattro: “Ma un orologio, ti prego, prendilo tu”. E cinque: “Un
Nautilus mi piace molto di più”. E sei: “Mamma mia che bello, segna le fasi
lunari, il quadrante è blu, vero? Sono eccitato”. E sette: “Mi scoccia darle il
Royal Oak (un Piguet ndr)”. L’amministratore delegato di Rolex non si affligga,
ma il migliore testimonial della portabilità, dell’eccellenza e della qualità
dell’investimento da polso si chiama Antonio Lollo, 46 anni, nato e residente a
Latina, capelli lunghi, dall’aspetto ambivalente: preso da destra assomiglia al
cantante Gianluca Grignani, solo un po’ più pienotto, da sinistra è goccia
d’acqua di Marzullo, ma meno crepuscolare. Sportivo e perennemente coperto da
una selezione di aromi profumati, scia chimica che avanzava prima di lui e
segnava il suo passo. L’apparenza inganna però. Il dottor Lollo fino al 22 marzo
scorso è stato giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Latina. Uomo
di diritto ma, come vedremo, soprattutto di rovescio. “Qua abbiamo mosso un
milione di euro, tra un cazzo e un altro”. Tra un orologio e un altro, un
braccialetto e un altro, un viaggetto e un altro, un fallimento e un altro,
Lollo e il suo complice, il commercialista Marco Viola, hanno raccolto un po’ di
quattrini. E hanno bisogno di spenderli: “A me frega solo dei soldi, e mia
moglie è della partita. Non mi sento affatto sporco”. Le cronache nazionali si
sono occupate con superbia di questo straordinario scandalo dell’agro pontino,
concedendogli pochi onori. Invece hanno sbagliato. Nell’agro pontino il caso
fatto giustamente registrare colonne umane alle edicole: “Abbiamo fatto un balzo
nelle vendite”, comunica entusiasta il direttore di Latina Oggi. E infatti
sembrano cronache marziane. Non già per la tipologia del reato commesso, ma per
le personalità coinvolte e soprattutto per i dialoghi che registrano come al
fondo non ci sia fondo. Mai. Il giudice arrestato, sua moglie arrestata, sua
suocera, già capo di gabinetto della Questura e presidente provinciale del
comitato Unicef (bambini di tutto il mondo, attenti al lupo!) arrestata. Deve
giustificare la presenza di 360 mila euro in contanti nella cassetta di
sicurezza. È stupefacente la narrazione che il giudice fa della sua opera di
delinquenza. E l’atteggiamento ossessivo verso l’acquisto degli orologi. Lui si
difende: “Pensi che se io avessi potuto mi andavo a comprare orologi?”. Parla
col complice e spiega che proprio non sa cosa combinare con i soldi che
acchiappa, imbosca, inguatta. Ha già la proprietà di case e auto e non può
derogare oltre nel codice etico. Quindi: orologi! Bisogna arraffare presto e
bene. Lui è il capobanda: “Il leader è il leader, la responsabilità è mia… loro
devono fa quel che dico io… con i colleghi me la vedo io”. Il giudice si fa
gangster e la legge diviene trappola per topi, il tribunale luogo dove si
scuciono soldi e si scuoiano anime. Un trattato perfetto di antropologia
criminale, un mix di gangsterismo di provincia, un unico sacro fuoco: li sordi!.
“Ho rischiato il culo fino a mò, che faccio me ne vado mò che devo raccoglie?
Rischio fino alla fine, no?”. Lollo intuiva di essere pedinato eppure insisteva
nell’agire da malfattore. “Ta ta ta. E pagano!”. Commovente il colloquio tra
moglie e marito. Lei: “Va bene così, fatti dà dodicimila euro e basta, su! Non
insiste, te rifai dopo”. Lui ascolta e decide di accogliere per il caso in
esame, piuttosto modesto nella sua entità economica, il consiglio alla prudenza:
solo dodicimila euro questa volta. Una tangentuzza piccola così. Cosa avesse in
testa questo giudice imbizzarrito sarà materia da psicologi del crimine e anche
tema di riflessione del Csm che purtroppo però non si occuperà del caso perchè
l’arrestato ha deciso di dimettersi dalla magistratura. Certo lui è un dandy.
Ama la bella, anzi bellissima vita. I viaggi. “Volevamo andare a maggio a
Londra, a giugno c’ho New York, a settembre Sardegna”. E ama soprattutto gli
orologi: i poliziotti lo pedinano fino a Roma, in via Cavour dove abitualmente
si approvvigiona. Rastrella ogni brand d’altura, memore che un Rolex vale nel
tempo “è moneta contante”. Può stare al polso o in una cassetta di sicurezza.
Chiuso e nascosto o lucente ed esibito. Vale soldi, non perde peso. Si distingue
tra gli altri. E conserva intatto il suo augusto segno di ricchezza. Certo,
all’uomo poi viene di fare “un tetris con orecchini e anello, o coi rubini. Mi
piacerebbe l’idea di un anello, di un diamante. E bracciali”. Oro che luccica
per la sua amata consorte. Del resto, “mica ci siamo comprati la villa
all’Eur?”. Già, si sono tenuti bassi. Questi soldi sono frutto dell’ingegno,
raccolti tra i fallimenti delle società che questa crisi ha fatto lievitare.
Quindi solo orologi, meravigliosi orologi. Con le fasi lunari e senza, col
quadrante blu o bianco, tondi o rettangolari. “Me lo merito un Rolex?”. da: Il
Fatto Quotidiano 13 maggio 2015.
Altri giudici
sapevano del sistema di tangenti messo in piedi da Antonio Lollo nella sezione
fallimentare del Tribunale di Latina. A confermarlo lo stesso ex magistrato
durante uno dei tre interrogatori ai quali è stato sottoposto durante la sua
detenzione tra il carcere romano di Rebibbia e l’Ospedale Pertini. Lollo avrebbe
vuotato il sacco e fatto nomi e cognomi. Ma i verbali sono pieni di omissis e
come al solito nient’altro è trapelato né dagli inquirenti né dalla difesa. In
una elaborazione di un articolo de Il Fatto Quotidiano del 31 Dicembre 2013
apparsa l’1 Gennaio 2014 sul sito malagiustiziainitalia.it, si parla di “Perizie
affidate a consulenti dall’ampio potere discrezionale e dai compensi
stratosferici, mazzette spartite anche con i giudici. Un crocevia affaristico in
cui è coinvolto il vertice dell’ufficio [quello di Roma]”, in riferimento alla
vicenda che ha visto coinvolta Chiara Schettini di cui abbiamo appena accennato.
La stessa Schettini, chiama in causa (è il caso di dire) anche la magistratura
umbra, passivamente prona ai desiderata di quella romana: insabbiare gli
esposti, far finta di nulla ed attendere che trascorrano i tempi era l’ordine da
eseguire. Sotto interrogatorio, la Schettini ha confessato al giudice (onesto e
che ringraziamo a nome di tutti i lettori e le lettrici di signoraggio.it): “Si
entrava in camera di consiglio e si diceva questo si fa fallire e questo no”.
Chi si esprime così non è un temibile boss della mala ma è sempre lei, il
veramente temibile giudice Schettini, lei sì appartenente al ramo pulito del
potere, proprio quello!!! Nella sua crassa arroganza venata di ottusa
prosaicità, ella ricorreva sovente ad uscite agghiaccianti, sfornando un gergo
truce da gangster matricolato. Intercettata telefonicamente mentre parlava col
curatore fallimentare Federico Di Lauro (anche lui in galera) minacciava di
farla pagare al suo ex compagno: “Guarda, gli ho detto, sono più mafiosa dei
mafiosi, ci metto niente a telefonare ai calabresi che prendono il treno, te
danno una corcata de botte e se ne vanno” (da Il Fatto, 8 Luglio 2013, R. Di
Giovacchino). Non finisce qui. Sempre questo giudice donna, in un’altra
intercettazione che ha lasciato di stucco gli inquirenti che l’hanno più e più
volte riascoltato il nastro, parlando con un ignoto interlocutore, minacciava il
“povero” Di Lauro in questi termini: “Io a Di Lauro l’avrei investito con la
macchina… Lui lavorava con la banda della Magliana”. Ciliegina sulla torta:
parlando al telefono con un perito del Tribunale, riferendosi all’insistenza di
un Avvocato che non aveva intenzione di piegarsi supinamente al comportamento
della Schettini, commentava: “Il suo amico Massimo ha chiesto la riapertura di
due procedimenti. Una rottura senza limiti. Gli dica di non insistere perché non
domani, né dopo domani ma fra 10 anni io lo ammazzo”. Alla faccia della
magistratura a cui tocca attenersi!
Pino
Maniaci: “Vi spiego la mafia dell’antimafia….”,
scrive Laura Bercioux per "Il sud online" il 28 maggio 2015. Laura Bercioux,
conduttrice e giornalista, si occupa di cronaca, di ambiente con un occhio
speciale al sociale e allo spettacolo. Ha collaborato con Telenorba, Stream
Tele+Inn, Rai Tre, Rai Uno. Ha lavorato a reportage televisivi per Rai Uno in
"Ladri di Vento"- Petrolio, inviata per la trasmissione di inchiesta di
Telenorba "Patto per Il Sud", ha condotto la trasmissione tv sociale per
Telelibera 63 "SoS Campania", ha condotto per Rai Tre con Fernando Balestra e
Tosca D'Aquino "Cocktail" e "Strano ma falso" di Fabrizio Mangoni, Francesco
Durante. Collabora anche per La Voce di New York. Nella Giornata della Legalità,
l’inchiesta di Pino Maniaci, giornalista siciliano di Tele Jato sui patrimoni
sequestrati e gli amministratori giudiziari, rimbalza sulle cronache dei
giornali. Noi avevamo già intervistato Maniaci sulla “Mafia dell’Antimafia” come
lui stesso definisce gli scandali della gestione dei beni sequestrati. Dove
indaga Pino? Pino Maniaci porta alla luce il malaffare della gestione dei beni
sequestrati (a Palermo sono gestiti quasi il 50% dei beni sequestrati in tutta
Italia): società, aziende, terreni, capitali immensi affidati a un pugno di
prescelti amministratori giudiziari, in barba ai 4000 iscritti all’albo che
puntualmente si vedono esclusi perché i 20 fortunati, e spesso in conflitto di
interesse, hanno un’esclusiva fuori legge. Come succede a Seminara Cappellano,
amministratore giudiziario di beni sequestrati, che acquista quote azionarie dei
beni di Massimo Ciancimino in Romania o, da gestore di albero gestisce alberghi
sequestrati. Maniaci descrive la storia nei dettagli, Seminara è sotto processo
ma continua a gestire questi beni. L’inchiesta giornalistica parte da un bene
sequestrato che è affidato da 7 anni dal Tribunale Sezione di Prevenzione sui
patrimoni sequestrati, secondo la legge Pio La Torre. Il sequestro deve
stabilire se la provenienza degli affari è illecita o meno, ci vogliono 3 anni
di giudizio e troppi per capire se il proprietario dei beni ha a che fare con la
mafia. Maniaci è sotto protezione dal 2008 per le sue inchieste e dichiara,
qualche giorno fa, a resapublica.it: “Ci sono casi di beni con anche 16 anni di
amministrazione giudiziaria. I danni che gli amministratori procurano al bene
che amministrano a volte sono devastanti e i loro compensi milionari. L’avvocato
Cappellano Seminara, in un solo incarico ha guadagnato 7 Milioni di euro”. La
mafia dell’antimafia, dunque, scatena polemiche dopo il sevizio andato in onda
alle Iene e, distanza di tre giorni dal servizio televisivo, i servizi segreti
avvertono che la d.ssa Saguto è “a rischio attentato per la sua attività”. Ci
sono troppi dubbi e punti di domanda, sentite cosa dichiara Pino Maniaci a
resapubblica.it: “Uno dei casi più eclatanti è quello del patrimonio dei Rappa
sottoposto a sequestro. Il patrimonio era stato sequestrato a Ciccio Rappa, ma
da allora a adesso sono trascorsi decenni e ancora non si sa se e quale parte
dell’immenso patrimonio che si stima in 800 milioni di euro, sia da confiscare.
Nel frattempo, scopriamo che la d.ssa Saguto ha nominato amministratore
giudiziario un giovane avvocato, Walter Virga, che è figlio di Vincenzo Virga,
giudice componente del Csm”. Pino parla di un giro devastante di comportamenti
al limite della legalità negli affidamenti o deontologicamente poco corretti.
“Finora non è arrivata nessuna querela da parte di nessuno – racconta Maniaci -,
nonostante le gravi accuse alla Saguto e al marito che lavora nello studio
dell’avvocato Cappellano Seminara, cioè l’amministratore giudiziario che
amministra un numero considerevole di beni posti sotto sequestro. Al Csm c’era
una richiesta di un provvedimento disciplinare nei confronti della Saguto,
riguardo proprio alle procedure di nomina dell’amministratore giudiziario di una
discarica in Romania, che appartiene al patrimonio di Massimo Ciancimino, e
affidata al solito Cappellano Seminara. Ma il giudice Vincenzo Virga, componente
del Csm e responsabile dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei
magistrati, archivia la richiesta e 15 giorni dopo il figlio diventata
amministratore giudiziario dell’impero dei Rappa. A me pare un comportamento
deontologicamente poco corretto”. La d.ssa Saguto è adesso nel mirino della
ritorsione mafiosa e Pino manifesta la sua solidarietà ma anche le sue
perplessità per una nota dei servizi pubblicata 3 giorni dopo il servizio delle
Iene. “A me – dice Maniaci – l’accostamento tra la Saguto e Falcone sembra
deprecabile. Noi puntiamo il dito sulle attività della sezione misure di
Prevenzione del Tribunale diretto dalla Saguto da un pò di tempo ma nessuno ci
ha mai querelato, mi chiedo perché. Ci sono tantissime associazioni che hanno
scoperto l’antimafia per guadagnare e fare soldi, e l’antimafia dovrebbe fare
parecchia introspezione dentro se stessa. Io posso dire che l’emittente Telejato
rischia sempre di chiudere per mancanza di fondi. La nostra antimafia è gratis.
Io vado in giro per l’Italia senza prendere un euro. Anzi, io non faccio
antimafia. Io considero un errore avere istituzionalizzato l’antimafia. Con il
Capo dello Stato antimafia, il Presidente del Senato antimafia, il politico
antimafia. A me da fastidio questa distinzione, perché l’antimafia e il rispetto
della legalità dovrebbero essere nel cuore di ogni cittadino onesto. A volte la
legalità è usata a proprio uso e consumo. Noi facciamo un lavoro giornalistico.
Denunciamo l’illegalità secondo la lezione di Pippo Fava. Una buona informazione
incide, corregge diventa determinante per un territorio. Diventa punto di
riferimento per chi non ha voce. Senza infingimenti politici e distinzioni tra
destra e sinistra. La merda può essere a destra ma a sinistra non si scherza
nemmeno e va pestata tutta”. Maniaci non si arrende e continua a battagliare, a
raccontare, i magistrati gli sono accanto e dice “C’è una sottoscrizione su
change.org, che ha già raggiunto 40.000 firme. Abbiamo chiesto al Csm di essere
ascoltati in merito ai comportamenti deontologici della d.ssa Saguto ma nessuno
vuole ascoltare e nessuno ci querela. Quello che noi abbiamo detto è soggetto a
un grave reato, vilipendio a corpo dello Stato. É previsto anche l’arresto
immediato per questo. Ma io sono ancora a piede libero. Io sono stato ascoltato
dai magistrati di Caltanissetta, perché c’è una loro inchiesta sulle misure di
prevenzione del Tribunale di Palermo che non ha ancora prodotto risultati. Mi
chiedo che fine abbia fatto quell’inchiesta”. Nella Giornata di Falcone, se ne
parla tra i colleghi, fuori dall’Aula Bunker di questa brutta storia, sembra che
una certa “antimafia” si beffi di quei morti, di quelle persone che, per
combatterla ci hanno rimesso la vita. Intervista a Fabio Nuccio – Giornalista
Mediaset.
Anche se
sembra non siamo un popolo di disonesti.
Facciamo di tutto per dimostrare di essere i peggiori, ma in altri Paesi la
corruzione non è inferiore a quella presente da noi, scrive Piero Ostellino su
"Il Giornale". Siamo il popolo più disonesto al mondo? Certamente non lo siamo,
anche se – a giudicare dalle cronache quotidiane - facciamo di tutto per
dimostrarlo. In altri Paesi la corruzione non è inferiore a quella presente da
noi. Ma è, come si suol dire, il contesto quello che, da noi, conta, cioè il
ruolo che la politica svolge anche nel campo dell'economia e delle transazioni
di mercato. Il fatto è che, da noi, l'intermediazione politica occupa un posto
di preminenza rispetto a quello che altrove occupa il mercato. E dove la
politica ha a che fare con i soldi è pressoché inevitabile che qualcuno ne
approfitti, perché la politica non va tanto per il sottile quando si tratta di
conquistare consenso e il consenso è spesso strettamente associato ai quattrini
di cui si può disporre. La regola politica è questa. Più quattrini hai da
spendere, maggiore è il consenso che puoi ottenere. Se, poi, i quattrini non
sono neppure i tuoi, ma di coloro i quali li usano e li spendono in funzione dei
loro interessi politici, allora, l'equazione «politica e quattrini uguale
corruzione» funzionerà alla perfezione. Le cronache parlano molto degli scandali
collegati a tale uso dei quattrini, peraltro senza spiegarne le ragioni, ma non
è un problema che preoccupi il mondo della politica perché in gioco non è
l'onestà personale dei politici, che non interessa nessuno, ma la natura
strutturale del nostro sistema. Non abbiamo la classe politica più corrotta al
mondo; abbiamo solo la classe politica più esposta alle tentazioni. E, come è
noto, sono le occasioni che fanno l'uomo ladro. Come ho detto, quando
l'intermediazione politica prevale sulle logiche del mercato e che qualcuno, sul
versante politico, ne approfitti è nella logica delle cose. Questa è anche la
ragione per la quale tutti i governi che si sono ripromessi di riformare il
Paese e i suo sistema politico non ce l'hanno fatta. Non ce l'ha fatta
Berlusconi; non ce la fa Renzi malgrado predichi ogni giorno l'intenzione di
cambiare l'Italia. Da mesi andavo scrivendo che l'immigrazione si era
trasformata nell'«industria dell'immigrazione» in quanto l'arrivo di migliaia di
immigrati era diventata l'occasione, per la politica, di utilizzare i quattrini
stanziati per l'accoglienza dei nuovi arrivati a proprio esclusivo beneficio e
delle proprie organizzazioni sociali. Sembrava una mia fissazione. Invece, gli
scandali scoppiati in successione ai margini del fenomeno hanno confermato che
non si è ancora regolamentata l'immigrazione perché non conviene a chi ci fa
sopra dei guadagni più o meno leciti. Lasciamo perdere gli scafisti – che sono
dei veri e propri criminali – e chiediamoci se la solidarietà di certi ambienti
cattolici e di sinistra non sia pelosa: gli immigrati sono manodopera a basso
costo che le cooperative che prosperano attorno al mondo cattolico e della
sinistra hanno finora utilizzato impedendo qualsiasi tentativo di regolamentarne
l'arrivo. È perfettamente inutile approvare marchingegni burocratici che
dovrebbero impedire la suddetta speculazione. Prima o poi diventano essi stessi
occasione di corruzione perché dove è possibile evitare monitoraggi e controlli
è pressoché certo che la politica troverà il modo di eluderli. Finora è quello
che è accaduto ed è probabile che l'andazzo non cambi. Potrebbe esserci qualche
speranza di cambiamento se i media facessero il loro mestiere di cani da guardia
del potere politico e, perché no, anche di quello economico. Se la proprietà, o
il controllo, dei media serve da moneta di scambio con la politica per goderne
del sostegno, è evidente che la politica prevarrà sempre a dispetto delle
migliori intenzioni perché eludere monitoraggi e controlli conviene a troppa
gente. Non è col moralismo a basso prezzo che si moralizza il Paese, bensì con
riforme che ne mutino radicalmente la struttura, eliminando l'eccesso di
intermediazione politica. Ma toglietevi dalla testa che Renzi le faccia.
Continuerà a prometterle, senza farle. La furba retorica del presidente del
Consiglio ha incominciato a deludere gli italiani, anche quelli che gli
credevano, e il consenso di cui ha goduto sta calando. C'è anche un'altra regola
che presiede a quest'ultimo fenomeno: non si possono imbrogliare tutti e sempre.
Chi è
Giuseppe Pignatone, l'uomo che ha scoperto Mafia Capitale.
"Scopritore di nuove mafie", il procuratore capo di Roma è conosciuto come un
"mastino gentile". Sue le principali inchieste di lotta a mafia e 'ndrangheta,
scrive Claudia Daconto su “Panorama”. Lo chiamano lo "scopritore di nuove
mafie". L'ultima è quella "Capitale". Giuseppe Pignatone, siciliano, classe
1949, in meno di 3 anni ha dato una scossa al “porto delle nebbie”, come
venivano chiamati gli uffici giudiziari della Procura di Roma fino al momento
del suo arrivo, e svelato la presenza di un “mondo di mezzo” in affari con uno
“di sopra” per conto di quello “di sotto”. Quando nel 2012 sbarcò a Roma da
procuratore capo, sindaco era ancora Gianni Alemanno. L'accoglienza fu calorosa:
“con lui – disse l'ex sindaco - la Capitale potrà giovarsi di un magistrato di
indiscussa competenza che grazie alla sua lunga esperienza nella lotta contro la
criminalità organizzata rappresenta un segnale importante per la sfida che
questa città è chiamata a vincere per la sicurezza dei suoi cittadini”.
Sentendosi chiamato in causa, Massimo Carminati non riuscì a nascondere la sua
preoccupazione: “ha già buttato all'aria la Calabria, butterà all'aria anche
Roma”. Magari “Cecato”, come viene soprannominato l'ex Nar della Banda della
Magliana e presunto capo di "Mafia Capitale", ma con la vista lunga. Due anni
dopo infatti, era il 4 dicembre scorso, i nomi di Alemanno e dello stesso
Carminati finiranno nell'elenco degli arrestati e indagati per associazione
mafiosa e altri innumerevoli reati insieme a quello del ras della cooperazione
sociale capitolina Salvatore Buzzi e di decine di dirigenti pubblici,
segretarie, ex amministratori delegati di municipalizzate, assessori,
consiglieri, portaborse, faccendieri, intermediari, passacarte, palazzinari,
esponenti politici di centrodestra e centrosinistra tutti membri di diritto del
grande partito del malaffare che per anni ha governato Roma arricchendosi sulle
spalle dei cittadini e sulla pelle dei più deboli tra i deboli: gli immigrati.
Entrato in magistratura già nel 1974, Giuseppe Pignatone è tra i più esperti di
lotta alla mafia senza aver mai voluto essere anche un professionista
dell'antimafia. Schivo, riservato, allergico alla mondanità, la ribalta se l'è
conquistata sempre e solo attraverso le sue inchieste. Dopo Caltanissetta e
Palermo, dal 2008 al 2012 Pignatone è a Reggio Calabria. Poi Roma. Nel capoluogo
siciliano collabora con Pietro Grasso, allora procuratore capo e poi procuratore
nazionale antimafia. Qui fa condannare numerosi capi e gregari dei clan; segue
l'indagine sulla Strage di Capaci che porterà all'arresto di Totò Riina,
coordina quella su Bernardo Provenzano; fa incriminare, negli anni '80, l'ex
sindaco Vito Ciancimino, poi condannato per mafia e firma l'inchiesta che
porterà alla condanna a 7 anni per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra
dell'ex presidente della regione Totò Cuffaro. In Calabria ha dato talmente
fastidio che il 3 gennaio del 2010 l'Ndrangheta gli ha fatto esplodere una
bombola a gas collegata a un panetto di tritolo proprio davanti all'ingresso
della Procura di Reggio Calabria. Anche lì, come poi nella Capitale, aveva
trovato una situazione di immobilismo quasi totale. Poi, a costo di minacce,
intimidazioni, proiettili, bazooka, è riuscito a fare luce sul nuovo volto e il
modo di operare di una delle organizzazioni criminali più potenti, ricche e
armate del mondo. Un'holding con sede centrale nel cuore della Calabria alla
quale rispondono le numerosissime succursali sparse nel Nord Italia, in
Germania, svizzera, Canada e fino in Australia svelata dalla famosa inchiesta
“Crimine”, condotta insieme alla Procura di Milano e che ha portato all'arresto
di oltre 300 persone. Rigorosissimo nella costruzione del quadro accusatorio,
pignolo nella ricerca delle prove, Pignatone è un mastino gentile. Nessuno è più
distante di lui dall'immagine dello “sceriffo” solo al comando. Gli piace e
ritiene più proficuo lavorare in team. Nella sua squadra romana ci sono
magistrati, investigatori, poliziotti, carabinieri e finanzieri che lo hanno
affiancato anche in passato: da Michele Prestipino (suo braccio destro a
Palermo) a Sara Ombra (sua l'inchiesta calabrese sull'ex governatore Giuseppe
Scopelliti), da Renato Cortese (ex capo della mobile di Reggio, poi di quella
romana, oggi capo dello Sco e già membro del gruppo che ha acciuffato
Provenzano) a Stefano Russo (capo dei Ros di Reggio Calabria e poi del Lazio).
Poche ore prima che il mondo intero sapesse che secondo la Procura di Roma a
Roma c'è la mafia e che da anni i politici di ogni schieramento ci fanno affari
insieme per farsi eleggere nelle amministrazioni e poi ripagare il favore con
gli appalti del verde, dei rifiuti, delle strade, degli immigrati, Pignatone lo
anticipò, tra le righe, al Pd riunito al Teatro Quirino per una conferenza
programmatica alla quale era stato invitato. Non disse, ovviamente, che a breve
la città sarebbe stata travolta da uno scandalo che avrebbe avuto risalto
planetario e che metà del partito di cui era ospite quel giorno sarebbe stato
spazzato via, ma descrisse così la situazione della criminalità in città. E
quando la notizia piombò come un macigno, lui preferì frenare l'enfasi: “Mafia
Capitale non è la Cupola di Roma”. Piuttosto continuò a lavorare. E infatti,
come lui stesso aveva annunciato, “nuove operazioni” sono arrivate e ieri altri
44 sono finiti in carcere. Sbagliato però pensare che Pignatone sia un
“manettaro”: piuttosto che sbattere un innocente in galera preferisce lasciare
un colpevole fuori. Nemmeno pensa che il compito dei magistrati sia altro che
quello di fare le inchieste. “Io faccio processi, non scrivo articoli sui
giornali”, ha ripetuto spesso. Il vero marziano a Roma è lui: Giuseppe
Pignatone.
Mafia
Capitale, i rapporti oscuri di Massimo Carminati con i servizi segreti.
Anche nell'ordinanza che ha portato agli ultimi arresti, il giudice sottolinea i
rapporti tra l'ex Nar e gli 007. Però poi l'affermazione non viene chiarita. E'
un modo per non pregiudicare il ramo più delicato delle indagini? Scrive
Gianluca Di Feo su “L’Espresso”. Il lato oscuro di Mafia Capitale, quel
capitolo di cui continua a comparire traccia nei documenti investigativi, ma che
resta sommerso con il suo carico di mistero: il ruolo degli 007. Anche
nell'ordinanza dei 44 arresti il giudice Flavia Costantini scrive: «Massimo
Carminati mantiene rapporti con appartenenti e ai servizi segreti».
Un'affermazione, non un'ipotesi. Che eppure poi non viene circostanziata nelle
centinaia di pagine che compongono l'atto d'accusa sul gruppo che aveva preso il
controllo di settori decisivi dell'amministrazione comunale e regionale. Un tema
sollevato anche da Matteo Orfini, presidente del Pd e commissario del Partito a
Roma: «È curioso che una persona come Carminati abbia potuto costruire un
sistema criminale di tale entità. Nei prossimi giorni chiederò al Copasir di
occuparsi di questa vicenda per capire come i servizi segreti non si siano
accorti di cosa stesse facendo una persona a loro evidentemente nota». Di
sicuro, l'attività di prevenzione non ha funzionato. E il provvedimento del
giudice ripropone il sospetto che il mancato allarme non sia stato casuale. Già
nello scorso ottobre, in occasione della prima retata, i magistrati avevano
sottolineato l'esistenza di un legame tra agenti dell'intelligence e l'ex
pistolero dei Nar. Ma nelle decine di relazioni investigative e nelle centinaia
di conversazioni intercettate depositate dopo quegli arresti, l'affermazione non
è mai approfondita. C'erano nomi di poliziotti che fornivano dritte sulle
inchieste in corso o offrivano i loro favori a Carminati, senza esplicitare in
cosa consistessero le relazioni pericolose con i servizi. Lo stesso procuratore
capo Giuseppe Pignatone, interpellato dalla Commissione antimafia e dal Copasir,
il comitato parlamentare di controllo sull'intelligence, aveva negato che questi
rapporti fossero provati. «Agli atti c’è – ha detto a dicembre il procuratore –
c’è una lunga conversazione tra Carminati e una persona non identificata con
certezza in cui lui si abbandona ai ricordi, risalenti agli anni ’70 e ’80 e
racconta di un viaggio in Libano, dove fu mandato da qualcuno dei Servizi a fare
attività di vario tipo e natura. Però questa è una traccia insignificante. Poi,
nelle conversazioni di altri, emerge la convinzione diffusa che lui mantenga
questo tipo di contatti, ma non vi è nulla di più». Sono elementi sufficienti
per indicare senza condizionali in un atto giudiziario «rapporti con i servizi
segreti»? Oppure si è trattato di una smentita tattica per non pregiudicare il
settore più delicato delle indagini? Tutta la biografia di Carminati è segnata
da accuse clamorose sempre seguite da assoluzioni, vicende che spesso si
intrecciano con le più oscure trame italiane: dal terrorismo neofascista dei Nar
alle esecuzioni per conto della Magliana, dall'omicidio di Mino Pecorelli alla
raid del caveau all'interno del palazzo di giustizia, fino alla frequentazione
con figure chiave di Finmeccanica, il colosso statale degli armamenti più
sofisticati. Eppure era riuscito sempre a uscirne a testa alta, costruendo
indisturbato la sua rete di potere nella capitale tra ricatti, corruzioni e
minacce. La malavita romana lucra sulla pelle dei più poveri, e gli ultimi
arresti dimostrano quanto il sistema fosse capillare. Per fortuna c'è anche chi
si ribella all'omertà che dilaga a Roma. Il nostro inviato spiega come si evolve
l'inchiesta "Mondo di mezzo". A dicembre due ex poliziotti della Squadra Mobile,
Gaetano Pascale e Piero Fierro, hanno dichiarato a SkyTg24 che nel 2003 le loro
indagini sulla nuova mafia di Roma erano state insabbiate. E questo – hanno
sostenuto – grazie alle coperture dei servizi vantate da Carminati e da un altro
boss del litorale laziale. Senza che però emergessero riscontri alle loro
parole.
Questa
volta ha ragione il Pd. Loro sono diversi: sono peggio.
Nonostante
Roma sia diventata una "cloaca massima, il Partito democratico insiste nel
riaffermare la propria diversità: "Non è vero che siamo tutti uguali". Almeno
questa volta ha ragione: il Pd è peggio, scrive Salvatore Tramontano su "Il
Giornale". Renzi doveva cambiare l'Italia, non ha cambiato nemmeno il suo
partito. Mezzo Pd romano è coinvolto nello scandalo di Mafia capitale, ma per
Orfini, presidente del Pd, la colpa è di Alemanno, Maroni e dei servizi segreti.
Guerini, vice segretario del Pd, ritiene addirittura strampalate le richieste di
dimissioni del sindaco: «Marino è considerato un nemico di chi vuole fare
affari». Sarà strampalato, ma due settimane prima degli arresti di Salvatore
Buzzi, Massimo Carminati & C., il capo della coop «29 giugno» replicava così ai
collaboratori che parlavano delle richieste di dimissioni per il sindaco Marino,
impelagato con la grana delle multe alla Panda rossa: «Ti dico una cosa -
annotano gli uomini del Ros - lui (Marino) se resta sindaco altri tre anni e
mezzo, con il mio amico capogruppo ci mangiamo Roma». Alla faccia di chi lo
considera un nemico degli affaristi. Per Renzi, però, paladino a parole della
legalità, il problema Marino non esiste. D'altra parte, come dimostra anche il
caso Campania, meglio una poltrona in più che un impresentabile in meno.
L'ordine, quindi, è blindare Marino, altrimenti addio sogni di gloria: ci
penserebbero i romani a rottamare quel che resta dei Democratici. «Falso»,
urlano quelli del Pd. Dimenticate che a Roma abbiamo Zingaretti, il governatore
della Regione Lazio. Forse sarebbe stato meglio dimenticarlo. Per evitare
strumentalizzazioni, citiamo cosa ha scritto ieri Fiorenza Sarzanini su Il
Corriere : «Un patto tra maggioranza e opposizione per spartirsi l'appalto più
remunerativo della Regione Lazio, quello sul Recup, il centro unico di
prenotazione. A siglarlo il consigliere del Pdl Luca Gramazio e Maurizio
Venafro, il capo di gabinetto del governatore Nicola Zingaretti. Il giudice lo
definisce un “accordo corruttivo” che ha consentito “all'organizzazione
riconducibile a Salvatore Buzzi e Massimo Carminati di inserirsi, divenendo
infine aggiudicataria del terzo lotto” in un affare da oltre 60 milioni». E dire
che sei mesi fa Renzi aveva nominato Orfini commissario straordinario per
ripulire Roma. Considerati i risultati, ha sbagliato mestiere: invece del
commissario, Orfini avrebbe dovuto fare l'avvocato d'ufficio. Anche se la sua
linea difensiva non brilla. Come si fa a dichiarare che: «Il Pd è il partito
dell'antimafia» quando De Luca, il candidato del Pd appoggiato da Renzi,
diventato governatore della Campania in barba alla legge Severino, denuncia il
presidente della commissione Antimafia? Eppure, nonostante Roma sia diventata
una «cloaca massima» (copywright Il manifesto ), il Partito democratico insiste
nel riaffermare la propria diversità: «Non è vero che siamo tutti uguali».
Mafia
Capitale: quello che la sinistra non vuole capire,
scrive Giampaolo Rossi su “Il Giornale”. Ridurre lo scandalo di Mafia Capitale
ad un derby tra destra e sinistra su chi ha rubato di più, è francamente
patetico; chi lo fa non si rende conto che la posta in gioco non è un titolo sui
giornali o un secchiello d’acqua al proprio mulino arrugginito. In gioco c’è ben
altro: la tenuta di una democrazia, la legittimità della politica come funzione
sovrana, il ruolo dei partiti come strumento fondante di partecipazione alla
res publica. Per questo, di fronte ad alcune dichiarazioni di esponenti del
Pd, sorge il dubbio che la sinistra italiana sia attraversata da un timor panico
di fronte alla consapevolezza di non poter più rivendicare la sua presunta
superiorità morale. Prendete per esempio Matteo Orfini, il commissario
straordinario del Pd romano ed esponente di spicco del partito nazionale; lui,
baldo giovane renziano, ex figgiciotto del Mamiani (il liceo romano dei fighetti
radical-chic) ed ex dalemiano, tra una dichiarazione alla stampa ed una partita
alla Playstation con Renzi, ha operato una medioevale reductio ad unum
della complessità dello scandalo: Mafia Capitale è “Carminati con un banda di
destra”. Sarà come dice lui ma se uno scorre l’elenco degli arrestati scopre
che la maggioranza dei politici coinvolti sono del suo partito: il Presidente
del consiglio comunale di Roma (del Pd), l’assessore alle Politiche Abitative
della giunta Marino (del Pd), il presidente della Commissione Patrimonio di Roma
(del Pd), il Presidente di uno dei più importanti Municipi di Roma (del Pd) e il
capogruppo di Scelta Democratica partito che appoggia la giunta Marino; senza
contare l’ex potentissimo vice-capo di Gabinetto di Veltroni già arrestato nel
giro precedente e un coinvolgimento totale di quel sistema delle cooperative
rosse da sempre fonte finanziaria, elettorale e spesso clientelare della
sinistra italiana. Sono questi i componenti della “banda di destra” di cui parla
Orfini? E non abbiamo dubbi che il sindaco di Roma Marino sia sincero quando
dice di voler eliminare monopoli che esistono da decenni; ma in questi decenni,
chi ha governato Roma? Tranne la breve, incolore ed inquietante esperienza della
destra romana, ad occhio e croce diremmo la sinistra; ergo, quella “politica
antica gravemente colpevole” che Marino si vanta di allontanare è quella dei
suoi compagni? La sinistra vive sotto una costante forma di rimozione della
realtà; non so se i suoi esponenti facciano uso di funghi allucinogeni, certò è
che sembrano vivere in un universo psichedelico. Forse sarebbe utile abbandonare
il tentativo di mostrarsi sempre migliori e provare a riflettere insieme sulla
crisi della politica e delle regole democratiche; sull’inadeguatezza di una
parte della classe politica, sulla fine dei partiti, sulla scomparsa delle
leadership, sull’eccesso di malaffare che nasce sicuramente da anime sporche ma
anche da un sistema sballato dove l’oppressione dello Stato (sotto forma di
dittatura burocratica) favorisce le pratiche illegali, secondo quell’assioma che
dai tempi di Tacito lega la corruzione all’eccesso di leggi (“Corruptissima
re publica plurimae leges”). Allora, cari amici e compagni del Pd, aprite
gli occhi: la narrazione degli “antropologicamente superiori” con cui vi hanno
bevuto il cervello i vostri intellettuali, è una balla, meno vera di una
striscia di fumetto. Siete come gli altri: tra voi albergano persone oneste e
farabutti, persone capaci e imbecilli, persone responsabili e miseri
intrallazzatori. La politica (e con essa la democrazia) non si aiuta alzando il
dito medio, come fa Grillo, ma neppure con il solito indice puntato da
maestrini, come fate voi. È ora che la classe politica capisca che la crisi di
legittimità democratica dei partiti è un punto di non ritorno che uccide la
partecipazione consente a poteri illegittimi di sostituirsi alla sovranità
popolare; e questo non è un problema di destra o di sinistra.
Onestà non
significa neanche mancanza di libertà.
"Vietato
esprimere opinioni autonome sui social": il regolamento del Partito comunista.
Il decalogo del partito di Marco Rizzo per il comportamento (di iscritti e
dirigenti) da seguire su Twitter e Facebook è un condensato di divieti e doveri:
dalle bandiere ai tag, scrive Matteo Pucciarelli su "La Repubblica". Bastava la
promessa per capire l'antifona: "La natura dei social network spinge
oggettivamente all'individualismo e alle peggiori performance di protagonismo.
Serve quindi regolamentare il loro uso, seguendo le ispirazioni della dottrina
leninista dell'organizzazione". Il Partito Comunista di Marco Rizzo (famoso per
l'esaltazione dello stalinismo e di esperienze di "socialismo" come la Corea del
Nord) ha varato una sorta di decalogo per l'utilizzo di Facebook, Twitter e
affini da parte dei propri dirigenti e militanti. Il risultato è una serie di
divieti e compiti che ricorda il settarismo comunista dei tempi andati, anche se
fuori tempo massimo: "È fatto assoluto divieto a ogni iscritto al partito (tanto
più se dirigente) a fare considerazioni e analisi politiche generali autonome",
è la prima regola, approvata dal Comitato centrale dell'organizzazione fondata
dall'ex europarlamentare di Rifondazione prima e del Pdci poi. Poi: "È vietato
taggare altri membri del partito sempre su questioni politiche, storiche,
filosofiche e culturali". Dopo: "È fatto assoluto divieto ad usare bandiere o
simboli del Partito nell'immagine del proprio account personale. Le bandiere ed
i simboli del partito sono esclusivamente rappresentate negli account di partito
ad ogni livello (da quello centrale sino a quello di cellula)". Per fortuna non
esistono solo divieti, ai quali vanno aggiunti i doveri: "È invece auspicabile
che i membri del partito e del comitato centrale promuovano, condividano e
tagghino i post degli organi nazionali". Detto questo, "tutti gli account di
partito (da quelli regionali a quelli della singola cellula) devono comunicare
riservatamente alla direzione centrale (nella persona del coordinatore) la
password". Al tutto va aggiunta una considerazione: "La pubblicazione di
fotografie e filmati di manifestazioni del partito devono esser improntate alla
massima efficacia propagandistica e consapevolezza politica dell'evento". E una
minaccia: "Qualunque violazione verrà da ora in poi deferita alla CCCG", con
quest'ultima parola che probabilmente significherà commissione di garanzia. Nel
preambolo della lettera pubblicata sul sito nazionale del movimento, c'è scritto
che "i pareri e le elaborazioni dei singoli compagni andranno ad arricchire la
linea elaborata collettivamente". L'importante è non esprimerli, perlomeno via
social...
Bufala
capitale n. 2, retate, arresti e foto,
scrive Errico Novi su “Il Garantista”. Ecco il sequel: Mafia Capitale 2. In
realtà l’inchiesta è la stessa, alcuni dei 44 nuovi provvedimenti cautelari sono
notificati a soggetti già colpiti dal primo uragano, ed è il caso di Salvatore
Buzzi. Ma questo secondo filone scoperto dalla Procura di Roma aggiunge al
vecchio romanzo criminale qualche tratto nuovo. Resta il primo teorema: i
consiglieri comunali ma anche regionali sono ordinariamente “in vendita”, pronti
a concedere piaceri, a spianare appalti per la Coop regina, la 29 Giugno, e non
solo. Secondo, che l’irresistibile e greve humor romanesco pervade ogni parola.
Soprattutto quando i responsabili delle società, che gestiscono il business dei
migranti come quello delle case popolari, si esprimono sui politici: trattati
ora con disprezzo, altre volte con considerazione per la «serietà» e la
«discrezione», in certi casi con rabbia. Gli inquirenti,e il gip di Roma Flavia
Costantini che firma le ordinanze, ci mettono il carico da novanta, soprattutto
per i personaggi più in vista. Il top della classifica spetta in questo senso a
Luca Gramazio, consigliere regionale eletto con il Pdl dopo esserne stato
capogruppo anche al Comune. Lui è tra i 19 che finiscono materialmente dietro le
sbarre (ad altri 25 toccano i domiciliari, mentre la lista dei 48 indagati si
completa con 4 nomi che non subiscono in questa tornata ulteriori provvedimenti
restrittivi). Gramazio sarebbe l’uomo capace di mettere in comunicazione la rete
di Carminati e Buzzi con le istituzioni. Tutte le istituzioni capitoline,
evidentemente. Un’opera diplomatica condotta con una competenza non limitata a
poche specializzazioni, dicono i pm. Secondo i quali l’esponente del
centrodestra sarebbe persona di «straordinaria pericolosità». Gramazio è una
delle icone di questa bufera, in effetti la più appariscente. Anche a lui
vengono contestate l’associazione a delinquere di stampo mafioso, la corruzione
e la turbativa d’asta. Altri reati che ricorrono nelle ordinanze eseguite ieri
sono la turbativa d’asta, le false fatturazioni e il trasferimento fraudolento
di valori, sempre con l’aggravante delle modalità mafiose. Ma se Gramazio è la
star di questa seconda puntata, c’è un esempio ancora più calzante, per
comprendere che considerazione avevano i capi delle coop dei loro interlocutori
politici. Si tratta dell’ex presidente del Consiglio comunale Mirko Coratti, del
Pd. Uno che insieme con il capo segreteria Franco Figurelli avrebbe ricevuto
soprattutto una promessa, 150mila euro, in pratica un modesto anticipo, 10mila
euro, e che soprattutto, secondo Buzzi, «non fa gioco di squadra». Da qui il
soprannome: «Balotelli». Ecco, pare di vederlo, il ghigno irridente tipico della
romanità un po’ triviale ma implacabile, geniale nel ritrarre le persone con un
nomignolo. In tutto questo la mafia non c’è. Ma nessuno tra il procuratore
aggiunto Michele Prestipino e i pm Giuseppe Cascini, Paolo Ielo e Luca
Tescaroli, si fa venire lo scrupolo di precisare che stavolta c’è sì tanta
”Capitale” ma di mafia davvero poca e collaterale. Peraltro resta ancora da
capire quale fosse la tara mafiosa del troncone principale, quello che
ripercorreva anche le gesta dell’eminenza grigia Massimo “ er cecato” Carminati.
Qui si incrocia appena una conversazione telefonica tra l’instancabile Buzzi e
un presunto ambasciatore della famiglia Mancuso, organizzazione ’ndranghetista.
In ballo il sostegno alla campagna elettorale di Gianni Alemanno per le Europee
di maggio 2014. Il capo della coop 29 Giugno dice a tale Giovanni Campennì:
«Basta che non sia voto di scambio… tutto è legale… uno po’ votà gli amici?!». E
quell’altro non si sottrae: «Va bene… allora… è qua la famiglia? La famiglia è
grande… un voto gli si dà». E poi però, come fa notare lo stesso Alemanno, «nei
due comuni controllati dalla famiglia Mancuso ho preso un numero ridicolo di
preferenze». Più che mafia calabrese, una classica sòla romana. Però lo spettro
del malaffare, della tangentopoli alla vaccinara, quello sì è amplissimo. Ci
sono di mezzo pure le coop bianche, in particolare una piuttosto nota, ”La
Cascina”, che si è vista arrivare ieri mattina i carabinieri per una
perquisizione. Quattro manager dell’azienda sono stati arrestati: si tratta di
Domenico Cammissa, Salvatore Menolascina, Carmelo Parabita e Francesco Ferrara.
Solo quest’ultimo finisce in carcere, gli altri tre vanno ai domiciliari. Questo
particolare segmento dell’inchiesta romana vede tornare in scena un altro nome
forte della prima ondata, Luca Odevaine. Che avrebbe ricevuto anche lui una
«promessa», così definita: «Una retribuzione di 10.000 euro mensili, aumentata a
euro 20.000 mensili dopo l’aggiudicazione del bando di gara del 7 aprile 2014».
La Cascina si occupa dell’accoglienza dei migranti. E si sarebbe messa d’accordo
con le coop rosse di Salvatore Buzzi su una «gara per l’individuazione dei
centri in cui accogliere 1278 migranti già presenti a Roma e altri 800 in
arrivo». Odevaine però è tra quelli per i quali il gip non accoglie la nuova
richiesta di custodia cautelare, per quanto l’ex vice capo di gabinetto di
Walter Veltroni sia comunque, da 6 mesi, in carcere a Torino. La vicenda sciocca
i politici e c’è da crederlo. In ore non semplici per il Pd Matteo Renzi
reagisce con uno stentoreo «in galera chi ruba». L’altro Matteo, Salvini, chiede
la testa di Marino, il quale si fa spalleggiare dall’assessore magistrato
Sabella per ricordare che da quando c’è lui è tutto diverso. Matteo Orfini dice
che è solo una «banda di destra». Copione prevedibile, e non troppo
appassionante. Sempre colorite sono invece le conversazioni tra Buzzi e
Carminati, di cui le ordinanze offrono nuovi estratti (in una l’ex Nar adombra
vaghe ipotetiche minacce, del tipo che se i politici non rispettano «gli
accordi» lui proromperebbe in un «ahò», seguito dall’ovvio «te ricordi da dove
vengo?». Ma stavolta la telefonata del giorno è tra Buzzi e Figurelli, quello
che stava nella segreteria del Coratti-Balotelli. Si parte sempre con un «ahò»,
seguito da un haiku: «Ma la sai la metafora? La mucca deve mangiare». Buzzi
rafforza: di’ al tuo capo (sempre quello che «non fa squadra» finché Buzzi nun
s’o compra) che «qui la mucca l’amo munta tanto». Quell’altro abbozza e media:
«Ahò, ma questa metafora io gliela dico sempre al mio amico, mi dice: non mi
rompere il cazzo perché se questa è la metafora lui ha già fatto, per cui non mi
rompere». Tradotto: Buzzi, che sarebbe grossomodo la mucca, aveva già avuto
appalti, favori e così via. Alla fine è una trattativa come tutte, è consisteva
nel tentativo di Coratti, per interposto Figurelli, di pagare un prezzo non
eccessivo per far assumere alla 29 Giugno una ragazza. In un’altra telefonata
Buzzi si sperticherebbe in complimenti non proprio da galantuomo per una «fica
da paura» che avrebbe preso in cooperativa. Secondo i pm è la stessa della
telefonata precedente. Di sicuro sono gli stessi il linguaggio e le scene della
prima volta.
Le immagini
dei blitz firmate dai Ros,
scrive Angela Azzaro su “Il Garantista”. Il copia e incolla i giornalisti ormai
non lo fanno solo rispetto alle ordinanze dei pm. È nata una nuova moda. Anche
le immagini vengono dalle procure e dalle questure. Gli arresti per mafia
capitale sono stati fatti a uso e consumo dei media e per evitare che qualche
giornalista avesse un guizzo di autonomia e facesse riprese non consentite,
hanno filmato tutto loro, i Carabinieri Ros. Le immagini che accompagnano le
notizie erano rimaste, fino a qualche mese fa, l’ultimo baluardo in difesa
dell’autonomia dei giornalisti. Sì, è vero quando ci sono rinvii a giudizio o
ancora meglio arresti, gli articoli sono il copia e incolla delle ordinanze. Da
tempo immemorabile ormai il lavoro dei giornalisti è diventato quello di
riportare ciò che dicono i magistrati: gli operatori dell’informazione si sono
dimenticati che il giornalismo nasce come contropotere non solo della politica e
degli affari, ma anche delle procure e dei tribunali. Ma anche se la situazione
era tragica, si poteva sperare in una rinascita legata alle immagini che
coraggiosi videomaker andavano a fare sul luogo del “delitto”. Adesso anche
questa piccola luce, questa flebile speranza si è dissolta. Non so se lo avete
notato, ma adesso anche le immagini vengono “passate” direttamente dalla
procura. Non sono fatte dai cameraman di Rai, Mediaset o La7 ma direttamente dai
carabinieri o dalla polizia che compiono gli arresti per poi distribuirle
insieme alle ordinanze. Copia e incolla anche per le immagini. Non vogliamo
essere a tutti i costi innocentisti o garantisti. È invece una questione di
metodo. Le accuse, non solo non sono una condanna come dice la Costituzione, ma
vanno sempre verificate… andrebbero sempre verificate facendo un lavoro di
inchiesta autonomo da quello dei pm e delle forze dell’ordine. Invece, anche nel
caso di mafia capitale, tutto ciò che esce dalla Procura viene considerato oro
colato, a tal punto da essere riportato senza nessuna distinzione o
considerazione autonoma. Ora si è aggiunto un nuovo tassello. Gli arresti
vengono fatti in diretta tv, filmati da coloro che dovrebbero avere un altro
ruolo. Non è un passaggio qualsiasi. E un ulteriore deterioramento del ruolo che
dovrebbe svolgere l’informazione. Ma non solo. In primo luogo testimoniano la
gestione spettacolare di un’inchiesta, la cui valenza stabiliranno i diversi
gradi di giudizio, ma che indubbiamente è stata condotta in modo da fare breccia
nei media. In questi anni è stato usato dalle procure ogni mezzo:
intercettazioni sbattute in prima pagina, vite private rovinate, avvisi di
garanzia che arrivano prima ai giornali che ai diretti interessati. L’aggiunta
delle immagini che sfociano direttamente da procure e forze dell’ordine incrina
ancora di più la nostra capacità di comprensione. L’immagine gode di uno status
di oggettività. Pur essendo un punto di vista sulla realtà ha un’immediatezza
che tende a confondersi con la “verità”. Ho visto quindi è. Per questa ragione
il lavoro sulle immagini è simile alle intercettazioni: lasciano poco spazio al
dubbio, alla verifica, alla possibilitàdi ricostruire il contesto. Ma finché
erano immagini che nascevano da un occhio terzo, quello dell’operatore
dell’informazione, si creava un’alterità che dava la possibilità di ragionare,
di usare il senso critico, di non fermarsi a una sola versione. Questo lavoro,
che è non il succo del garantismo ma del giornalismo, sta diventando sempre più
difficile, complicato per chi lo fa e per chi legge, sente o vede le notizie.
Ieri le immagini degli arresti che avete visto non godevano di questa alterità,
non provavano minimamente a essere un occhio terzo tra chi arresta e chi viene
arrestato. È vero che negli ultimi anni l’uso delle immagini è diventato sempre
più descrittivo rispetto al testo della voce fuori campo. Non un’aggiunta, non
uno strumento in più, ma quasi una sorta di sottofondo privo di vita propria.
Oggi è peggio. Anche quel poco di autonomia è perduta: ci dobbiamo accontentare
delle immagini con sopra il timbro Carabinieri-Ros.
Coltello e
tangente, la lingua della suburra.
Dalle minacce
alle battute sessiste, il romanesco criminale dei signori dell'arraffo. Nella
intercettazioni diventano protagonisti tangenti, appalti e volgarità. E il
rispetto che si deve a chi manovra denaro, scrive Francesco Merlo su “La
Repubblica”. Non bastano le manette. Roma, "'a mucca che amo munto tanto", va
espugnata e affidata allo Stato, come Berlino e come Washington. Ci vuole una
legge speciale che dia a Palazzo Chigi i pieni poteri sul cuore della capitale,
nel territorio dentro le mura aureliane per esempio, come Berlino appunto che è
Stato nell'ansa della Sprea, dalla Porta di Brandeburgo alla Siegessäule, e come
Washington, tra il Lincoln Memorial e il Congresso. Tocca insomma al governo
strappare Roma non solo ai Carminati, ai Buzzi agli Odevaine, alle cooperative
rosse come la "29 giugno" e a quelle simoniache di Cl che si chiamano piamente
Cascina e Domus Caritatis, ma anche ai Consigli comunali che "devono stare ai
nostri ordini perché li pago e vaffanculo ", e alle Giunte che sono "la mucca
che se non mangia non può essere munta". Da decenni queste istituzioni di Roma
sono corrotte o inadeguate, con i sindaci complici o ignavi: "Se Marino resta
sindaco altri tre anni e mezzo, col mio amico capogruppo ce magnamo Roma". Il
presidente del Consiglio come il papa re, dunque. Solo un'amministrazione
statale, infatti, può ridimensionare, nella città-universo ormai degradata a
suburra, i capibastone e i sovrastanti che marcano il territorio come il
consigliere comunale Giordano Tredicine, che è stato arrestato ieri: "Se non
t'arrestano - gli dice Buzzi - tu diventi primo ministro". E quello:
"Perché? Me possono arresta'? ". E Buzzi ridendo: "Li mortacci tua, se te
possono arrestà!". Fumantino e minaccioso Giordano Tredicine ha infatti portato
nelle istituzioni la selvaggia illegalità degli ambulanti sparsi per Roma, il
pittoresco delle roulotte che vendono cibo, con il loro minestrone di esseri
umani: pakistani e armeni, cingalesi e tailandesi e filippini, tutti sotto il
controllo di una sola grande famiglia, appunto. Dice di lui Carminati: "Quello
viene dalla strada! Lui è serio, e poi è uno che è poco chiacchierato,
nonostante faccia un milione di impicci ". Ed è degradato a mafia anche il
tradizionale romanesco criminale di "Er più" che era un capo brigante, ma non un
padrino. Il linguaggio d'amore e di coltello che Dumas racconta nel Conte di
Montecristo diventa infatti linguaggio di appalto e di tangente con "zozzo e
zozzone" al posto di "cornuto e sbirro". Mentre "l'elenco della mangiatoia"
sostituisce "gli amici degli amici". E "o li cacci o li compri" a proposito dei
consiglieri comunali è quel che dice don Mariano Arena a proposito dei
carabinieri. La mucca poi è un'ossessione perché è la cresta, il pizzo, la
ricotta, è keynesismo mafioso: "la mucca se non mangia non può essere munta",
"se la vuoi mungere gli devi dare da magnà", e "quanto l'amo munta", "la mucca
in tre mesi deve magnà...". Come si vede, più che una metafora è un'equazione, è
il saggio di profitto, non l'arraffo bruto ma un arraffo che è già impresa. Qui
è degradato a popolo di mafia anche il popolo dei quartieri. È stato per esempio
arrestato Luca Gramazio che, secondo l'accusa, con una mano dà alla mafia quello
che con l'altra prende dalla politica istituzionale "perché - dice Buzzi -
una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso". E questa sarebbe una frase
perfetta anche in bocca al padrino di Corleone. Buzzi racconta che "Gramazio ha
dato un milione di euro al comune di Ostia... per il verde. E ora il verde ce
deve tornà tutto a noi". E infatti "il presidente del Municipio, che io c'ero
andato a parlà, sta facendo gli atti per darceli tutti a noi". Anche Luca
Gramazio appartiene, come Tredicine, ai cani di razza che fiutano gli umori
grassi del territorio romano. È figlio di Domenico Gramazio detto "er pinguino"
che nel Msi era il popolano un po' goffo e intransigente, una specie di comparsa
del Rugantino, un fascista sociale di quelli moralisti e spaccamondo che
prendevano tantissimi voti. Partecipò al famoso lancio delle monetine contro
Craxi davanti all'hotel Raphael, gridava "ladri ladri" al tempo di Tangentopoli,
mostrava le manette in Parlamento. Ecco: la legge del contrappasso ha saltato
una generazione. Papà Gramazio non è indagato anche se, si racconta
nell'ordinanza, "andava con il figlio a trovate Carminati, er cecato". Chi ha
trascritto le intercettazioni nota che il nome Carminati "viene pronunziato, per
precauzione, a bassa voce", proprio come accade nella mafia siciliana con i nomi
degli uomini d'onore, della gente di rispetto: Totò Contorno persino arrossiva
quando, d'un fiato, diceva "don Masino". Ed è "il rispetto" che Carminati
pretende dai consiglieri comunali, "quei pezzi di merda" che "non vogliono
obbedire" anche se, dice Buzzi, "io li pago e dunque vaffanculo ". Ma cos'è il
rispetto secondo Buzzi e Carminati? "Se tu non rispetti gli accordi, tu lo sai
chi sò io. Te ricordi da dove vengo". Ed è la fedina penale che qui viene
esibita come stemma nobiliare, cicatrici non di guerra ma di malavita che
affascinano Gramazio junior a conferma che la destra missina, che pure aveva in
testa un progetto di società e nel cuore sentimenti e ideali, a Roma è diventata
mafia. Roba da far inorridire la buonanima di Almirante, che diceva: "Se
qualcuno ruba va in carcere, ma se ruba uno dei nostri bisogna dargli
l'ergastolo". E Teodoro Buontempo, er pecora, cercava un riscatto
nell'educazione dei figli: dormiva in una Cinquecento ma li mandava a studiare
nelle università inglesi. È un piccolo mondo antico che l'inchiesta Mafia
Capitale archivia per sempre. In questo copione, Gianni Alemanno, pugliese
sedotto dalla romanità, che posava a ideologo della destra sociale, è il primo
responsabile politico del sistema criminale, una sorta di Ciancimino de Roma. Ma
non è con le mille assunzioni clientelari che Alemanno ha seppellito il mondo
dei camerati missini. No, l'ex sindaco era arrivato a chiedere
all'organizzazione mafiosa un aiuto elettorale per le europee. E Buzzi si era
rivolto alla 'ndrangheta perché, come abbiamo già sentito, "una mano lava
l'altra e tutte e due lavano il viso". Gli chiede Alemanno: "Devo fare delle
telefonate? Devo fare qualcosa?". E Buzzi: "No, no, no, tranquillo, tranquillo.
Ora manderemo a... Milardi l'elenco di persone, nostri amici del sud, che stanno
al sud, che ti possono dare una mano cò parecchi voti". Davvero solo una legge
speciale e d'emergenza può riportare la criminalità romana a un livello
fisiologico e costringere a rifugiarsi nei loro covi i pregiudicati e gli
insospettabili come Luca Odevaine, quello - ricordate? - che si chiamava
Odovaine e cambiò nome per non farsi riconoscere, l'ex capo di gabinetto di
Veltroni formatosi in Legambiente. Dalla mafia romana percepiva uno stipendio di
20.000 euro mensili, regolarmente registrato nella contabilità da sottosuolo che
la segretaria di Buzzi appuntava sul libro nero. Lo stesso Carminati, notando la
copertina nera, disse: "Mamma mia, mi inquieta un po'". E non perché la
disonestà gli turbava la coscienza, ma perché il nero lo depistava. I libri neri
per il fascista Carminati sono quelli di Céline, di Guénon, di Evola e dei
giapponesi che raccontano la morte dei guerrieri e non le pretese di Odevaine
che voleva un euro per ogni rifugiato venduto: " Se me dai cento persone
facciamo un euro a persona.. . Non lo so, per dire: hai capito? Ti metto 200
persone a Roma, 200 a Messina, 50 là, e le quantifichiamo ". Il traffico è
odioso e il pervertimento è di ideali, questa volta, rossi. Ma c'è anche la fine
della natura bonaria e cinica di Roma che è la città più grande d'Italia (20
volte Napoli) e con il centro storico più esteso del mondo, la più popolosa (più
di tre milioni di abitanti censiti), la più bella ( ça va sans dire ), e ormai
purtroppo la più degradata, la più corrotta e la più perduta tra le capitali
dell'Occidente: un suk di illegalità, abusivismo, fogne a cielo aperto e
sporcizia per le strade, sottosviluppo nei cortili, l'asfalto tutto buche e
avvallamenti, il centro storico assediato dai mendicanti, le auto in terza fila,
la metropolitana senza decoro, i lavori pubblici eternamente incompiuti, la
cultura come enorme baraccone di incompetenze, le esecuzioni per strada ...
Insomma la scenografia è perfetta per le ordinanze di Mafia capitale che come ha
scritto il New York Times "sollevano nuove domande circa la capacità dell'Italia
di riformarsi". Non si può infatti continuare a fingere, come fa il sindaco
Marino, che Roma "città per bene" non somigli ogni giorno di più a Buzzi, a
Carminati e a Odevaine e sia solo vittima e non anche complice, forse qualche
volta persino peggiore di loro. Ecco perché questa seconda ordinanza della
Procura non è solo un atto giudiziario, un supplemento di certificazione,
l'aggiornamento della mappa dell'aporia e del sistema mafioso che controlla e
plasma tutto, strade e uomini, traffico e sporcizia. Questa ordinanza è
neorealismo ed è un trattato di linguistica moderna dove il codice più innocente
è quello di sporcizia banale sulle "dù zinne" della "fica da paura che abbiamo
preso a lavorà alla raccolta differenziata ". Questo in fondo è il Bagaglino,
volgarità ordinaria, intermezzo comico da vecchia Roma: "Si chiama Ilenia". "Già
si presenta bene" risponde Figurelli a Buzzi. "E se è un cesso la famo scopà da
M", e qui l'iniziale del nome di battesimo del presunto bruto sessuale potrebbe
aprire una faida da film di Tarantino. Con la M, per dire, comincia Massimo, che
è il nome di Carminati. Questa ordinanza è infine un documento storico e le sue
428 pagine ci rimangono dentro come una preghiera. Non sarà infatti il processo,
non saranno le condanne il Big Bang di una città che si prepara al Giubileo e
aspira ad ospitare le Olimpiadi. Non basteranno i giudici a farla scendere dal
taxi del sottosviluppo e della mafia perché, come dice Buzzi "bisogna stare
attenti a scenne dal taxi: con noi sali, ma non scenni più".
Il nero e i
bianchi, la torta delle coop. L'accordo globale di Mafia Capitale.
Concorrenza inesistente. Consiglieri comunali compiacenti. L'unico dirigente
"contro" allontanato. La squadra di Carminati godeva su appoggi trasversali per
ottenere milioni di euro nel gestire emergenze abitative e migratorie. Ora sono
finiti in carcere anche i rappresentanti delle reti cattoliche, scrive Francesca
Sironi su “L’Espresso”. «Noi che dovemo sta sul pezzo pe’ magnasse un po' de
caciotta». Ha ragione, il Nero. Il suo braccio destro Salvatore Buzzi è un
lavoratore instancabile. Non conosce domeniche o festivi: è sempre al telefono
per spartirsi affari, o impegnato in riunioni, incontri e strette di mano per
assicurare a sé o agli amici milioni di euro dal Campidoglio e dal ministero
dell'Interno. Mai una pausa. La frase la dice Massimo Carminati, “er Cecato”, ed
è riportata nell'ordinanza che ha scoperchiato la seconda parte dell'inchiesta
su Mafia Capitale, con 44 arresti e decine di indagati fra politici,
amministratori e imprenditori. Il piatto principale è sempre la gestione delle
emergenze abitative e dell'accoglienza dei migranti da parte di un ristretto
gruppo d'affari. La novità è che ora sono state arrestate le controparti di
Buzzi e Carminati: i rappresentanti di quelle coop “bianche” di cui l'Espresso
parla da tempo , e che nella Capitale spadroneggiavano nel settore degli aiuti
sociali, spalla spalla alla banda di Carminati. Il nero e i bianchi, il
neofascista delle trame e le onlus che facevano riferimento al vescovo e agli
ordini religiosi. Agli arresti sono finiti infatti Tiziano Zuccolo, della
cattolica Domus Caritatis, e Francesco Ferrara, Domenico Cammisa, Salvatore
Menolascina e Carmelo Parabita, rappresentanti del consorzio La Cascina, legata
a Comunione e Liberazione. Con Buzzi si intendevano alla perfezione. Il giudice
li ritiene infatti «partecipi agli accordi corruttivi con Luca Odevaine» - il
funzionario stipendiato per assegnare risorse e immigrati agli amici dal tavolo
del ministero dell'Interno – oltre che autori di «plurimi episodi di corruzione
e di turbativa d’asta dal 2011 al 2014», dimostrando «una spiccata attitudine a
delinquere, al fine di ottenere vantaggi economici nell’esercizio della loro
attività imprenditoriale». Negli atti si raccolgono così gli accordi e gli
intrecci che hanno intorpidito Roma per anni, chiudendola in una rete
indistricabile di cooperative – bianche, rosse, nere, incensurate o
indipendenti, non cambia – che si accordavano sui progetti prima ancora
venissero pubblicate le gare. Nessuna alternativa aveva spazio. C'era chi si
metteva d'accordo per quieto vivere, chi sotto minaccia. E chi semplicemente
traeva maggior guadagni grazie all'oligopolio. Come il gruppo dei consorzi
bianchi di Zuccolo e Ferrara. Uno degli episodi che meglio spiegano come sono
stati spesi in questi anni i fondi per i più poveri, a Roma, riguarda 580
persone - donne, uomini e bambini finiti per strada a cui bisognava trovare un
tetto per l'inverno del 2014. Il bando viene pubblicato il 14 luglio. Buzzi e
Zuccolo sono molto preoccupati, perché a gestirlo è tale Aldo Barletta, un
dirigente che a detta del socio di Carminati «è entrato da 10 giorni ed ha
applicato tutto quello che non avevano applicato fino ad adesso», uno che «non
cede nemmeno davanti a Gesù e Maria». Era un «pericolo», questo funzionario, per
le sue «resistenze ad assecondare le procedure sfavorevoli agli interessi della
pubblica amministrazione». E la procedura aperta da lui per trovare casa a quei
580 disperati era considerata un ostacolo: troppo trasparente e favorevole alla
concorrenza. Andava aggirata. Come? Con l'alacre attività di cui Buzzi si fa
coordinatore. E che consiste nel «far desistere» tutti i potenziali avversari
dal partecipare alla gara. Il funzionario “nemico” aveva invitato infatti 15
società a presentare un'offerta. Alcuni nomi, fra gli invitati, risultavano
nuovi a Salvatore Buzzi, ed è allora Angelo Scozzafava (indagato), direttore del
dipartimento per le Politiche Sociali di Roma, a dargli i contatti necessari.
Altri invece li conosceva bene. E inizia con gli sms e le chiamate. Contatta
anche a Gabriella Errico, la responsabile della coop “Un Sorriso” che gestiva il
centro per minori di Tor Sapienza diventato noto dopo l'aggressione e il caos
con gli abitanti del quartiere. Lei risponde «tranquillo», si dichiara «a
disposizione» e non partecipa al bando (ora è indagata). Altri fanno maggiori
resistenze. Alcuni chiedono favori in cambio, come Alberto Picarelli che desiste
dall'occasione ghiotta ma dice: «Salvato' spero che un giorno pure io ti
possa... quando ti chiedo qualcosa me ne venga accolta». Con questi piccoli
debiti o scambi Buzzi sistema la concorrenza. I colleghi competitor si
dissolvono tutti. Rimane la rete di Zuccolo e Ferrara, La Cascina. Ma tutto è
sistemato con una telefonata tra amici e un accordo che gli inquirenti
definiscono "globale": «Io su quello dei 580 preferirei che andasse
completamente deserto, che partecipassi solo io, capisci? Sugli altri dimme te,
io ti ci vengo e tu vieni sui miei», dice il braccio destro di Carminati. E
Ferrara conferma: «Secondo me tu vieni ed io vengo e poi hai capito, così almeno
più è... e poi sti cazzi, cioè hai capito?». Chi ha capito ha capito: tu mi
aiuti qui, io ti aiuto lì, e la spartizione è fatta. La manovra non fa una
piega. E il 25 agosto alla “manifestazione d'interesse” dei soggetti sul
territorio per accogliere quei 580 sfollati si presenta una sola società. La
cooperativa Eriches di Salvatore Buzzi. Che si aggiudica così indisturbata
l'affare da un milione e seicentomila euro. Turbativa d'asta in piena regola.
Ferrara è coinvolto anche in altre pratiche, fra cui la manomissione di una gara
indetta il 30 giugno del 2014 dalla prefettura di Roma per assicurare
l'accoglienza a 1.278 migranti, oltre a ulteriori 800 richiedenti asilo in
arrivo. Valore: 10 milioni di euro. Per ottenere le assegnazioni dei progetti, e
far approvare una delibera che assegnasse i fondi fuori bilancio, Ferrara
avrebbe partecipato alla «corruzione di consiglieri comunali mediante la
promessa della somma di complessivi 130mila euro». La situazione di Eriches e
Domus Caritatis/la Cascina era entrata infatti in crisi dopo un rapporto della
Finanza, che giudicava illegittime le assegnazioni dirette del Campidoglio a
quella ristretta cerchia di imprese sociali di milioni e milioni di euro. Ma né
rapporti né dirigenti specchiati sono riusciti a fermarli.
Cooperative
nere e cattoliche: il concordato di Carminati per il business della
disperazione.
Gli affaristi neofascisti e le santissime arciconfraternite pronte a spartirsi
una torta da quasi 30 milioni di euro l'anno solo per rispondere all'emergenza
abitativa Un servizio garantito grazie a fondi senza controllo. Nascosti in
delibere, proroghe, convenzioni, scrive ancora Francesca Sironi su "L'Espresso".
C'è un rapporto del gennaio 2014, firmato dagli ispettori della Ragioneria dello
Stato, che dice già tutto. Che porta alla luce le irregolarità degli appalti
garantiti dal comune di Roma a una maglia di tre cooperative: il consorzio
Eriches di Salvatore Buzzi, braccio destro dell' ex terrorista nero Massimo
Carminati, entrambi finiti in carcere per l'indagine che ha colpito la mafia
fascista della capitale; il “Consorzio casa della solidarietà” e “Domus
Caritatis”. Gli affaristi neofascisti e le santissime arciconfraternite pronte a
fare "stecca para" - per usare il lessico di Romanzo Criminale - trasformando la
disperazione in un business d'oro. Insieme, queste tre associazioni si
spartivano una torta da quasi 30 milioni di euro l'anno solo per rispondere
all'emergenza abitativa. Ovvero per dare un letto temporaneo a chi perde la
casa. Un servizio importante, garantito però grazie a fondi senza controllo.
Nascosti in delibere, proroghe, convenzioni. «Va rilevato come l'affidamento sia
avvenuto in via diretta, In assenza di qualsivoglia procedura concorrenziale»,
scrivono i funzionari dell'Ispettorato: «sebbene l'importo sia largamente
superiore al limite previsto dalla legge secondo cui il fornitore dovrebbe
essere individuato mediante una gara europea». Ma quali gare: nella capitale i
problemi si risolvevano fra amici, hanno rivelato le indagini della procura di
Roma. E anche quando c'erano dei bandi, loro riuscivano a pilotarli. Soldi
sicuri, che intascavano sempre, nonostante le casse indebitate del Campidoglio.
E non solo dal municipio: ma ottenevano finanziamenti pure dalla Prefettura e da
Bruxelles. I patti lateranensi di Carminati hanno resistito fino a pochi giorni
fa. Perché l'allarme della Ragioneria di Stato è stato ignorato? Nessun
esponente della giunta Marino lo ha letto? Nessuno si è insospettito? Grazie
alle procedure “straordinarie” dettate dalle “emergenze” (che potevano durare
anche anni, come quella “abitativa”, o “migratoria” o “dei Rom”) una cooperativa
quale quella di Salvatore Buzzi era riuscita a raggiungere il controllo di 2.965
posti letto: servizi per minori stranieri non accompagnati, adulti richiedenti
asilo, nomadi, famiglie italiane travolte dalla crisi, uomini senza tetto e
madri sole. È lo stesso “Gruppo 29 giugno” di Buzzi a vantare risultati
straordinari, soprattutto in termini economici, nel bilancio del 2013. L'Italia
era in crisi. Loro no: le intercettazioni dei magistrati svelano quanto fosse
profittevole lucrare sulle disgrazie della gente. Perché queste sofferenze,
garantiva Buzzi al telefono, «rendono più della droga». "Tu sai quanto ci
guadagno sugli immigrati? C'hai idea? Il traffico di droga rende meno", così al
telefono Salvatore Buzzi, braccio destro imprenditoriale di Massimo Carminati.
Il sistema ha funzionato alla perfezione fino all'intervento dei magistrati.
Nessuna denuncia ha fermato i nuovi padroni del business del sociale, capaci di
arricchirsi anche con gli sbarchi di Mare Nostrum, la marea umana di profughi
fuggiti dalle guerre in Siria e in Libia che ha raggiunto le coste italiane
negli ultimi mesi. A maggio del 2014 la “Eriches” dell'ex detenuto modello
Salvatore Buzzi gestiva solo a Roma 493 posti letto. Considerando una media di
40 euro di rimborso giornaliero a persona, gli stranieri portavano un introito
assicurato di 20mila euro al giorno. Anche qui, dalle tabelle pubblicate proprio
su Il Tempo, il quotidiano romano il cui direttore è stato intercettato dagli
inquirenti a colloquio con “il Nero”, si trovano altre due sigle ricorrenti:
Domus Caritatis e Casa della Solidarietà. Insieme controllano 1.436 ospiti. Un
giro di denaro fra i 50 e i 57mila euro al giorno. Il fatto è che queste tre
cooperative, Eriches, Domus Caritatis e Casa della Solidarietà, non sono
esattamente concorrenti. Da una parte c'è Salvatore Buzzi, il braccio aziendale,
secondo i pm, del fascista Massimo Carminati. Dall'altra c'è Tiziano Zuccolo
(non indagato): presidente della Casa della Solidarietà e rappresentante
dell'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e di San Trifone, la rete di
Domus Caritatis. Nelle intercettazioni riportate dai Pm, Buzzi e Zuccolo
commenterebbero fra loro “un patto” di divisione degli affari “al 50-50", metà e
metà.
Ma non è solo dalle conversazioni telefoniche che emergono
intrecci fra i due. C'è una società, la Maika Immobiliare. Fondata nel 2006 per
essere messa in liquidazione nel 2008. Era controllata dalla Sarim immobiliare,
srl appartenente all'organizzazione di Buzzi; da Sandro Coltellacci, anche lui
arrestato per l'indagine sul “Mondo di mezzo”; da altri due soci. E da Tiziano
Zuccolo in persona. Registrato come proprietario del 16 per cento del capitale.
Nel 2007, quando Report mandò in onda una puntata in cui i due giornalisti
autori del servizio interrogavano Buzzi su degli affidamenti inusuali ricevuti
dall'Università di Roma Tre, la Maika esisteva ancora. E aveva sede legale in
via Castrense 51. Dove fino al settembre del 2008 ha avuto domicilio anche
un'altra cooperativa emersa alle cronache negli ultimi tempi: “Un Sorriso”,
l'associazione che gestiva il centro per minori stranieri di viale Giorgio
Morandi, Tor Sapienza (che ha spiegato in un' intervista a Repubblica la
sua estraneità al consorzio, dal quale anzi avrebbe ricevuto ripetute e gravi
minacce per anni). Il luogo degli scontri. Degli scandali. Delle polemiche. Da
cui gli adolescenti sono stati portati via. Per finire in un'altra struttura. Di
chi? Di Domus Caritatis. «Nell’ambito dell’accoglienza, siamo cresciuti ed
abbiamo continuato la gestione delle attività assistenziali in favore di
immigrati, senza fissa dimora, mamme con bambini, ex detenuti, nomadi e famiglie
in difficoltà», vanta il consorzio Eriches di Salvatore Buzzi nel bilancio: «e
abbiamo vinto il bando promosso da Roma Capitale per 491 immigrati facenti parte
dello Sprar, (la rete nazionale dei comuni per la gestione dell'emergenza) una
commessa significativa che ci consentirà di stabilizzarci nel settore». La
“stabilizzazione” era garantita da rapporti stretti con le istituzioni: stando
agli atti, per trasferire "un numero imprecisato" di minori stranieri non
accompagnati, più di 100, da una comunità considerata inagibile, «Buzzi si
interessava a un edificio disabitato, nella disponibilità del Comune di Roma,
coinvolgendo un collaboratore nel progetto di occupazione abusiva
dell’edificio». Lo stabile, localizzato in via del Frantoio, avrebbe ospitato,
una volta "squattato", gli adolescenti. «In una conversazione intercettata, il 2
gennaio 2013, Buzzi riferiva, infatti, che avrebbe interessato “Caradonna”,
identificato, poi, nel presidente del V Municipio - Ivano Caradonna - competente
su via del Frantoio, affinché, dopo la loro occupazione, le autorità locali non
avessero provveduto allo sgombero». Nel segno della legalità. Ci sono anche
altri intrecci che aiutano la stabilità. E riguardano questa volta i servizi.
Nella primavera del 2013 il catering di una grande struttura per minori
stranieri gestita dal consorzio di Buzzi proprio in via del Frantoio 44 viene
sostituito da un momento all'altro. Al posto del fornitore precedente arriva la
Unibar di Giuseppe Ietto. Come mai questa decisione? «La scelta delle aziende
veniva operata da parte di Carminati», scrivono i Pm: «gli imprenditori di volta
in volta selezionati venivano messi a conoscenza degli interessi del sodalizio e
delle modalità con le quali ci si prefiggeva di raggiungere gli obiettivi,
sicché si veniva a generare un rapporto altamente fiduciario». Una gestione
interna, insomma. Poi la Unibar assume la figlia di Carminati. Il “Nero” aiuta
Giuseppe Ietto in un appalto. E il sodalizio si stringe. Anche grazie alla
ricchezza del business. Nel pomeriggio dell'otto gennaio del 2013, parlando con
un imprenditore, «Carminati espone le consistenti possibilità di guadagno
derivanti dalla fornitura del servizio di catering presso i centri di
accoglienza per famiglie», riportano i magistrati: «”Qua se guadagnà qualche
soldino ... cioè ...capito?"», dice: «"Siccome che stiamo a parlà di 8/900
pasti. Tre euro ciascuno. E per ogni pasto, visto che pagano in ritardo, ti
danno mezzo euro in più”». Continua il Guercio: «Praticamente se ritardano a
nove mesi a limite non ti frega un cazzo, ogni giorno prendi una cosa in più,
sai li parliamo di un migliaio di pasti al giorno, una cosa, una cosa … calcola
che st'amico mio, ogni giorno più che passa si prenderà, credo 600 Euro in più
al giorno, caricato sui pasti!» Gli operatori hanno provato a lamentarsi della
qualità del cibo: gli è stato detto che andava bene così. Ora sia Buzzi, che
Ietto che Carminati sono in carcere. E sì che avevano pronto un progetto
solidale proprio per i detenuti: «Un punto cottura per una mensa da allestire
all’interno del carcere femminile di Rebibbia», riportano i Pm: «Progetto ideato
da Carminati, il quale lo ha indicato a Buzzi e a Carlo Guarany (vicepresidente
della cooperativa “29 giugno”), come imprenditore di riferimento per
l’attuazione».
Chi specula
sui profughi.
Un miliardo e 300 milioni: è quello che ha speso finora lo Stato per assistere
le persone fuggite da Libia e Tunisia. Un fiume di denaro senza controllo. Che
si è trasformato in business per albergatori, coop spregiudicate e truffatori,
scrivono Michele Sasso e Francesca Sironi su "Espresso”. Erano affamati e
disperati, un'ondata umana in fuga dalla rivoluzione in Tunisia e dalla guerra
in Libia: fra marzo e settembre dello scorso anno l'esodo ha portato sulle
nostre coste 60 mila persone. Profughi, accolti come tali dall'Italia o emigrati
in fretta nel resto d'Europa: solo 21 mila sono rimasti a carico della
Protezione civile. Ma l'assistenza a questo popolo senza patria è stata gestita
nel caos, dando vita a una serie di raggiri e truffe. Con un costo complessivo
impressionante: la spesa totale entro la fine dell'anno sarà di un miliardo e
300 milioni di euro. In pratica: 20 mila euro a testa per ogni uomo, donna o
bambino approdato nel nostro Paese. Ma i soldi non sono andati a loro: questa
pioggia di milioni ha alimentato un suk, arricchendo affaristi d'ogni risma,
albergatori spregiudicati, cooperative senza scrupoli. Per ogni profugo lo Stato
sborsa fino a 46 euro al giorno, senza verificare le condizioni in cui viene
ospitato: in un appartamento di 35 metri quadrati nell'estrema periferia romana
ne sono stati accatastati dieci, garantendo un reddito di oltre 12 mila euro al
mese. Ancora una volta emergenza è diventata la parola magica per scavalcare
procedure e controlli. Gli enti locali hanno latitato, tutto si è svolto per
trattative privata: un mercato a chi si accaparrava più profughi. E il peggio
deve ancora arrivare. I fondi finiranno a gennaio: se il governo non troverà una
soluzione, i rifugiati si ritroveranno in mezzo alla strada. In Italia sono
rimaste famiglie africane e asiatiche che lavoravano in Libia sotto il regime di
Gheddafi. La prima ondata, composta soprattutto da giovani tunisini, ha preso la
strada della Francia grazie al permesso umanitario voluto dall'allora ministro
Roberto Maroni. Ma quando Parigi ha chiuso le frontiere, lo stesso Maroni ha
varato una strategia federalista: ogni regione ha dovuto accogliere un numero di
profughi proporzionale ai suoi abitanti (vedi grafico a pag. 39). A coordinare
tutto è la Protezione civile, che da Roma ha incaricato le prefetture locali o
gli assessorati regionali come responsabili del piano di accoglienza. Ma, nella
fretta, non ci sono state regole per stabilire chi potesse ospitare i profughi e
come dovessero essere trattati. Così l'assistenza si è trasformata in un affare:
bastava una sola telefonata per venire accreditati come "struttura
d'accoglienza" e accaparrarsi 1.200 euro al mese per ogni persona. Una manna per
centinaia di alberghi vuoti, ex agriturismi, case-vacanze disabitate, residence
di periferia e colonie fatiscenti. Dalle Alpi a Gioia Tauro, gli imprenditori
del turismo hanno puntato sui rifugiati. A spese dello Stato. Le convenzioni non
sono mai un problema: vengono firmate direttamente con i privati, nella più
assoluta opacità. Grazie a questo piano, ad esempio, 116 profughi sono stati
spediti, in pantaloncini e ciabatte, dalla Sicilia alla Val Camonica, a 1.800
metri di altezza. I proprietari del residence Le Baite di Montecampione non sono
stati i soli a fiutare l'affare. Anche nella vicina Val Palot un politico locale
dell'Idv, Antonio Colosimo, ne ha ospitati 14 nella sua casa-vacanze, immersa in
un bosco: completamente isolati per mesi, non potevano far altro che cercare
funghi. I più furbi hanno trattato anche sul prezzo. La direttiva ufficiale, che
stabilisce un rimborso di 40 euro al giorno per il vitto e l'alloggio (gli altri
6 euro dovrebbero essere destinati all'assistenza), è arrivata solo a maggio.
Nel frattempo, la maggior parte dei privati aveva già ottenuto di più. Gli
albergatori napoletani sono riusciti a strappare una diaria di 43 euro a testa.
Non male, se si considera che in 22 alberghi sono ospitate, ancora oggi, più di
mille persone. «La domanda turistica al momento degli sbarchi era piuttosto
bassa», ammette Salvatore Naldi, presidente della Federalberghi locale. La
Protezione civile prometteva che sarebbero state strutture temporanee. Non è
andata così: solo all'Hotel Cavour, in piazza Garibaldi, di fronte alla Stazione
centrale, dormono tutt'ora 88 nordafricani. Le stanze, tanto, erano vuote: i
viaggiatori si tengono alla larga, a causa dell'enorme cantiere che occupa tutta
la piazza. Ma grazie ai rifugiati i proprietari sono riusciti lo stesso a
chiudere la stagione: hanno incassato quasi 2 milioni di euro. I richiedenti
asilo però non sono turisti, ma persone che hanno bisogno di integrarsi. La
legge prevede che ci siano servizi di mediazione culturale, che sono rimasti
spesso un miraggio o sono stati appaltati a casaccio:«A Napoli sono spuntate in
pochi mesi decine di associazioni mai sentite nominare», denuncia Jamal
Qadorrah, responsabile immigrazione della Cgil Campania: «Ogni albergatore
poteva affidare i servizi a chi voleva, nonostante ci sia un albo regionale
degli enti competenti. Tutti, puntualmente, ignorati». Non solo. «A luglio di
quest'anno abbiamo organizzato un incontro fra il Comune e gli albergatori»,
racconta Mohamed Saady, sindacalista della Cisl: «Diverse strutture non avevano
ancora un mediatore». Ed era passato più di un anno dall'inizio dell'emergenza.
Il business dei nuovi arrivati non ha lasciato indifferenti nemmeno i
professionisti della solidarietà. Cooperative come Domus Caritatis, che gestisce
otto comunità solo a Roma. Anche i suoi centri sono finiti nel mirino di Save
The Children e del garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Lazio. Dopo
numerose segnalazioni l'ong è andata a controllare 14 strutture della capitale
che si fanno rimborsare 80 euro al giorno per l'accoglienza di minori stranieri
non accompagnati. Il risultato è un rapporto inquietante, presentato a maggio
alla Protezione civile e al Viminale, che "l'Espresso" ha esaminato. Si parla di
sovraffollamento, ma soprattutto di senzatetto quarantenni fatti passare per
ragazzini scappati dalla Libia. Durante l'indagine sono stati intervistati 145
profughi. «Più di cento erano palesemente maggiorenni», denuncia l'autrice del
rapporto, Viviana Valastro: «Quelli che avevo di fronte a me erano adulti. Altro
che diciassettenni. Non posso sbagliarmi». Non solo. «Molti di loro erano in
Italia da tempo, non da pochi mesi. Alcuni arrivavano dagli scontri di Rosarno».
Doppia truffa insomma: sull'età e sulla provenienza, per avere un rimborso più
che maggiorato e intascare milioni di euro. Tutto questo da parte di una
cooperativa strettamente legata all'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento
e di San Trifone e a La Cascina, la grande coop della ristorazione che tre anni
fa è stata al centro di un'inchiesta per il tentativo di entrare nella gestione
dei cpt. Save The Children non è stata la sola a denunciare la situazione
romana. Anche il presidente della commissione capitolina per la sicurezza,
Fabrizio Santori, esponente del Pdl, ha dovuto occuparsi di Domus Caritatis. La
cooperativa infatti gestiva una comunità che dava grossi problemi al vicinato,
da cui arrivavano continue proteste. Santori l'ha visitata e si è trovato
davanti ad alloggi di 35 metri quadri abitati da 10 persone. Peggio che in un
carcere. Eppure gli appartamentini di via Arzana, a metà strada fra Roma e
Fiumicino, più vicini all'aeroporto che alla città, permettevano di incassare
più di 12 mila euro al mese. Save The Children ha calcolato che in strutture di
questo tipo, nella capitale, vivono quasi 950 persone. Dati incerti, perché solo
cinque cooperative hanno accettato di fornirli. Domus Caritatis, dalla sua sede
all'abbazia trappista delle Tre Fontane, non ha voluto dare alcuna informazione.
Il dossier dell'ong internazionale descrive un caos assoluto: mancanza di
responsabili, nessun servizio di orientamento e accompagnamento legale,
strutture inadeguate. Al Nord la situazione non cambia. A Milano si registrano
casi come quello della ex scuola di via Saponaro, gestito dalla Fondazione
Fratelli di San Francesco d'Assisi, che ha accolto 150 rifugiati. Ospitati in
una comunità per la cura dei senzatetto, l'accoglienza dei minori e degli ex
carcerati: 400 persone, con esigenze diverse, costrette a vivere sotto lo stesso
tetto in una vecchia scuola. «Le condizioni sono orribili: 10-12 letti per ogni
camerata. E pieni di pidocchi e pulci», racconta un ragazzo ancora ospite. Le
stanze sono inadatte perché costruite per ospitare alunni, non profughi, né
tantomeno clochard che vivono in strada. «Un contenitore della marginalità
sociale dove sono frequenti le risse: nigeriani contro kosovari, ghanesi contro
marocchini e la lista dei ricoverati in ospedale si allunga ogni giorno»,
racconta chi è entrato tra quelle mura. Anche il personale è ridotto al minimo
con pochi mediatori culturali (che spesso sono ex ospiti che non disdegnano le
maniere forti per mantenere l'ordine), un solo assistente sociale e una
psicologa per dieci ore alla settimana. Troppo poche per chi ha conosciuto gli
orrori della guerra, le botte della polizia libica e porta sulla propria pelle i
segni delle violenze. Anche i disturbi psichici abbondano, insieme all'alcolismo
dilagante. A sette chilometri dai frati, 440 profughi hanno trovato alloggio a
Pieve Emanuele, estrema periferia Sud di Milano. Qui sono stati ospitati nel
residence Ripamonti, di proprietà del gruppo Fondiaria Sai, appena passata sotto
il controllo di Unipol ma all'epoca saldamente in mano a Salvatore Ligresti. I
clienti abituali dell'albergo sono poliziotti, guardie del vicino carcere di
Opera o postini, che non bastano a riempire i 4 mila posti letto dell'albergo.
Grazie all'emergenza però nelle settimane di massimo afflusso sono entrati nelle
casse di Fonsai oltre 600 mila euro al mese. Vacanze forzate in alloggi
confortevoli (le camere sono dotate anche di tivù satellitare) ma dove sono
mancati completamente i corsi per imparare l'italiano o l'assistenza legale e
psicologica. «Si poteva trovare una sistemazione più modesta e investire in
altri sussidi» dice, banalmente, un ragazzo del Ghana. Oggi a Pieve Emanuele
sono rimasti in 80. Ma nel frattempo al residence sono andati quasi sette
milioni di euro. Lo Stato ha speso per l'emergenza 797 milioni di euro nel 2011
e altri 495 milioni nel 2012. Solo una parte è servita per l'accoglienza:
centinaia di milioni di euro sono finiti in tendopoli, spostamenti, trasferte,
rimborsi agli uffici di coordinamento. Fondi di cui si è persa la traccia. E sì
che proprio per il buon uso dei soldi pubblici era stato istituito un "Gruppo di
monitoraggio e assistenza", con il compito di visitare le strutture e segnalare
i casi critici. Ma della task force degli ispettori dopo pochi mesi non si è
saputo più nulla. «Noi facevamo parte del progetto ma da ottobre 2011 non siamo
più stati convocati. Considerando che è partito ad agosto, il gruppo è durato
meno di tre mesi», spiega a "l'Espresso" Laura Boldrini, portavoce dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati: «È mancato completamente il
controllo da parte delle regioni e delle prefetture». La Corte dei conti della
Calabria è andata oltre: ha messo nero su bianco che le convenzioni sottoscritte
nella regione sono illegittime, perché non sono state sottoposte al controllo
preventivo della Corte, obbligatorio anche nell'emergenza. Non solo. I giudici
contabili di Catanzaro definiscono "immotivata" la diaria: 46 euro al giorno
sono troppi. E pensare che in provincia di Latina sono riusciti a intascarseli
quasi tutti spendendo solo 5 euro al giorno, per garantire a 75 profughi un
misero piatto di riso. I cinque avidi gestori della cooperativa Fantasie sono
stati arrestati dai carabinieri di Roccagorna. Insospettiti dall'aumento di
stranieri in paese, i militari sono arrivati ad un casolare dove hanno trovato
46 persone alloggiate in 70 metri quadri. Nonostante il blitz la cooperativa ha
continuato a ricevere i contributi della Regione Lazio per altri sei mesi: una
truffa da 400 mila euro. Con le stesse risorse Aurelio Livraghi, volontario
della Caritas di Magenta, in provincia di Milano, è riuscito a fare tutt'altro.
«Milioni di italiani vivono con 1.200 euro al mese, perché loro no?».
Osservazione semplice. Di un pensionato, che ha dedicato ai 35 profughi arrivati
in paese le sue giornate. Persone oggi indipendenti: pagano un affitto, fanno la
spesa, quattro di loro hanno già un lavoro. Recitano anche in teatro. Una vita
normale: altro che emergenza. E quando finiranno i fondi? «Potranno andare
avanti almeno un po' perché sono riuscito a fargli mettere da parte dei
risparmi». Non era difficile, sarebbe bastato un minimo di organizzazione. E di
umanità.
Mafia
Capitale atto secondo: "Veltroni bene, ma co' Alemanno se pija de più".
Mafia Capitale nella città corrotta. La politica capitolina al servizio de "er
Cecato" e del suo braccio destro Buzzi. E le mazzette come chiave per entrare
nei business che contano, scrive Giovanni Tizian su “L’Espresso”. Massimo
Carminati e Riccardo Brugia Rutelli? «Noi abbiamo cominciato a cresce con lui».
E Veltroni? «Diciamo con Veltroni siamo andati bene noi». Alemanno? «co Alemanno
sotto certi aspetti se pija molti di più.. specialmente sul sociale». La
consolidata infiltrazione di “mafia capitale” nell’amministrazione capitolina
spiegata a un emissario della 'ndrangheta. Un'infiltrazione «essenziale ai fini
dell’assegnazione dei lucrosi appalti pubblici indetti dal comune di Roma».
L'atto secondo di Mafia Capitale è soprattutto la narrazione di un città in cui
la corruzione è il concime che fa crescere piccoli o grandi fortune personali.
Roma corrotta da capi bastone e da manutengoli del potere locale. Roma corrotta
dall'ambizione di un uomo, Massimo Carminati “er Cecato”, che da delinquente
della malavita romana con il mito del Duce è diventato modello, risorsa e valore
aggiunto per molti imprenditori che grazie a lui hanno piegato pezzi importanti
dell'amministrazione pubblica ottenendo così «un sacco di lavori», come ha
ammesso, intercettato, il manager delle coop e braccio destro di Carminati,
Salvatore Buzzi. Nell'ultima retata sono stati arrestate 44 persone (tra carcere
e domiciliari) e altre 21 sono indagate dalla procura antimafia di Roma che
coordina i carabinieri del Ros della Capitale in questa seconda tranche
dell'indagine Mondo di mezzo. Un sistema governato dal clan di Massimo
Carminati. «I fatti corruttivi spiegano e sono spiegati dal contesto in cui si
muove l’organizzazione a seguito del mutamento della compagine politica di
maggioranza nel consiglio comunale di Roma e la conseguente rimodulazione delle
attività corruttive», si legge nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal
giudice per le indagini preliminari, che aggiunge: «In effetti, a seguito del
mutamento nella maggioranza del Comune di Roma sortito dalle consultazioni
elettorali, mafia capitale investe nell’acquisizione di nuovo capitale
istituzionale, decisione strategica mimeticamente rappresentata dall’espressione
di Carminati, a suo dire rivolta a Buzzi, del seguente tenore: “E allora mettiti
la minigonna e vai a batte co' questi amico mio, eh... capisci”». Il lessico
dell'organizzazione di Carminati rappresenta l'essenza del clan dall'animo
trasformista e dalle pelle camaleontica. «Poi ce pigliamo e misure con Marino»,
è ancora Buzzi che detta la linea politica da intraprendere una volta chiusa
l'era di Alemanno al Comune. Ma sempre «nel solco della linea strategica
tracciata da Carminati di una rimodulazione dell’attività corruttiva in
relazione ai diversi decisori pubblici». Il primo obiettivo raggiunto
dall'imprenditore del clan è il Pd Mirko Coratti, in quel periodo presidente del
Consiglio comunale. C'è anche Franco Figurelli, ex capo segreteria
dell'assemblea capitolina, a libro paga della cosca. «Figurelli veniva
retribuito con 1.000 euro mensili, oltre a 10.000 euro pagati per poter
incontrare il Presidente Coratti, mentre a quest’ultimo venivano promessi
150.000 euro qualora fosse intervenuto per sbloccare un pagamento di 3 milioni
sul sociale». Insomma, per usare le parole del re delle coop, «so’ tutti a
stipendio...». I politici disposti al compromesso in fondo non sono altro che
bovini da foraggiare: «La mucca che se non mangia non può essere munta», una
metafora che Buzzi ricorda a Figurelli, il quale promettendo di ricordare il
detto a Coratti, ne approffitta per chiedergli un favore: l'assunzione di un
amica. Dell'assuzione si sarebbe interessato proprio Coratti, attivato a sua
volta dal compagno della madre della ragazza, un consigliere dell'VIII
municipio. Per sistemare due nipoti anche un dirigente del Comune, ha accettato
di scendere a patti con Buzzi. Ma oltre ai favori e ai piaceri personali, questa
vicenda è anche una storia di soldi. Gli investigatori del Ros guidati dal
colonnello Stefano Russo rintracciano alcuni versamenti effettuati dalla
cooperativa 29 giugno di Buzzi all'associazione che faceva capo a Coratti. Una
sorta di fondazione, di quelle che oggi vanno tanto di moda tra gli esponenti
dei partiti, per canalizzare le donazioni. D'altronde »il finanziamento pubblico
è destinato a finire», osservano due fedelissimi di Buzzi. L'ex presidente
dell'assemblea in cambio del denaro ricevuto ha, secondo gli inquirenti,
abbracciato la causa del clan. In che modo? Appalti per i rifiuti, fondi
pubblici e certezza che il Comune pagherà i debiti verso la coop. Oltre a
Coratti e Figurelli, tra gli indagati c'è anche Massimo Caprari consigliere
comunale del Centro democratico. Per lui l'organizzazione di Carminati aveva
previsto mille euro al mese più benefit: «la promessa di erogazioni continuative
di denaro, tra le quali quella costante di una percentuale dei lavori ottenuti
dal Comune da parte delle cooperative riconducibili al Buzzi». La corruzione è
servita a Buzzi & Co per ingraziarsi oltre che uomini del Pd anche alcuni del
centrodestra. Il nome che spicca in questo nuovo capitolo di Mafia Capitale è
Giordano Tredicine, 33 anni, consigliere comunale e vice coordinatore di Forza
Italia nel Lazio. Rampollo della famiglia di venditori ambulanti che gestisce la
massima parte dei camion bar della città. «Buzzi lamenta, in una conversazione
con Gammuto, che se avesse vinto la maggioranza di centrodestra la sua scuderia
sarebbe stata pronta e in essa indicava un ruolo specifico di Tredicine, oggi
consigliere di minoranza all’Assemblea Capitolina». Insomma, il giovane era uno
della scuderia, uno dei cavalli pregiati a cui il clan poteva affidare alcuni
compiti. Secondo il ras della coop 29 giugno a destra pescavano a piene mani:
«se vinceva Alemanno ce l’avevamo tutti comprati, partivamo a razzo,... c’amo
l’assessore ai lavori pubblici, Tredicine doveva sta’ assessore ai servizi
sociali, Cochi andava al verde, Cochi non è comprato però è un amico,
Alemanno... che cazzo voi di più». Buzzi e il clan avevano istaurato con
Tredicine "un rapporto di remunerazione corruttiva". Buzzi a Carmninati: «A
Giordà se non te arrestano diventerai primo Ministro» me fa’ dice: ...li
mortacci tua...te possono arresta’ (ride). Però come sto sul pezzo a
Giordano non c’ho mai visto nessuno ehh.. credimi, mai nessuno». Persino nel
feudo dei clan del litorale romano, Fasciani e Spada in primis, Mafia capitale è
riuscita a comprare politici. «Le indagini svolte hanno consentito di verificare
l’esistenza, nel X dipartimento, di decisori pubblici remunerati
dall’organizzazione riconducibile a Buzzi, Carminati e Testa. Le risorse
economiche pubbliche erano originariamente stanziate dalla regione, attribuite
al comune, che, in parte, li smistava ai municipi», scrive il gip. Nella lista
degli inquirenti è così finito il mini sindaco di Ostia, Andrea Tassone del
Partito democratico, che nei mesi precedenti agli arresti si era lanciato in
campagne per la legalità e contro le cosche. Stando all'inchiesta, un'antimafia
di facciata. «Significativa, circa la individuazione in Tassone del capo di
Solvi (faccendiere del politico), è la circostanza che egli sia stato delegato
dal medesimo al controllo di voti e preferenze per conto della lista civica
Marino alle elezioni comunali, secondo quanto si desume da fonti aperte»,
annotano gli investigatori. E sempre Solvi a «raccordare Buzzi e Tassone in
vista dei loro incontri». Ma è proprio Buzzi a confessare il rapporto con
Tassone: «Tassone è nostro, eh…è solo nostro..non c’è maggioranza e opposizione,
è Mio». E poco dopo aggiunge: «perché noi pagamo tutti come vedi”...noi
nell’ambito de ste cose..nell’ambito di questa monnezza pe tenè (fonetico) i
voti gia semo arrivati a 43 mila euro, eh...Tassone 30...10 Alemanno 40».
Tassone stipendiato? Secondo l'imprenditore legato al boss Carminati sì, e non
sembra, a suo dire, accontentarsi: «Remunerazioni che evidentemente non
bastavano, posto che Buzzi, qualche giorno dopo, riceve da Tassone una ulteriore
richiesta di denaro, pari al 10% del valore di un affidamento. Uno dei motivi
della sua visita ad Ostia veniva svelato dallo stesso Buzzi che, si lamentava
che il “Presidente” (del X Municipio, Andrea Tassone) gli avesse chiesto il “10%
in nero”». Le richieste a Tassone, per il tramite del faccendiere Solvi, sono
tutte finalizzate a ottenere favori e agevolazioni dal X municipio. Anche qui le
«mucche» hanno bisogno di cibo per poi ottenere più latte. Secondo Buzzi
l'accoglienza dei migranti è un business più remunerativo della droga. E anche
meno rischioso. Tra gli espisodi di corruzione elencati negli atti della procura
antimafia di Roma diversi riguardano proprio l'emergenza abitativa e
l'accoglienza dei migranti. Uno degli episodi raccolti dagli inquirenti ruota
attorno alla Società Cooperativa Deposito locomotive di Roma San Lorenzo,
«oberata di debiti, assillata dalla necessità di dover pagare cambiali, con
asset invenduti costituiti da 14 appartamenti in zona Case Rosse – Settecamini».
Il politico di riferimento del clan è in questo caso Daniele Ozzimo, ex
assessore comunale alla Casa, in quota Pd, mentre il dirigente comunale è Guido
Magrini, Direttore del dipartimento delle Politiche Abitative. Il sospetto dei
magistrati è che l'assessore abbia chiesto a Buzzi «150. mila euro per
risollevare le sorti di una cooperativa, in cambio del mantenimento di una
convenzione relativa all’emergenza alloggiativa assai remunerativa per Buzzi».
«Tocca vede’, nei limiti del possibile, salva’ sta cooperativa. Stamo a parla’
di centocinquantamila euro entro venerdì», riferisce l'imprenditore a un sodale,
che chiede chiarimenti: «Senti, ma in cambio di centocinquanta, qual è il
beneficio o l’opzione per noi?». E Buzzi risponde: «che tu opzioni gli
appartamenti, no? Loro c’hanno quattordici appartamenti invenduti». Luca
Odevaine invece (già arrestato nel primo filone d'inchiesta), era l'esperto
dell'affare immigrazione. «Aveva instaurato rapporti di natura corruttiva con
esponenti del gruppo imprenditoriale “La Cascina” mettendo a disposizione di
tale gruppo il suo ruolo istituzionale di appartenente al Tavolo di
Coordinamento Nazionale sull’accoglienza per i richiedenti e titolari di
protezione internazionale, nonché il suo ruolo di componente delle tre
commissioni di gara per l’aggiudicazione dei servizi di gestione del C.a.r.a. di
Mineo, ricevendo in cambio la promessa di una retribuzione fissa mensile
determinata in una prima fase in 10 mila euro ed elevata a 20mila dopo
l’aggiudicazione della gara del 7 aprile 2014». La cooperativa vicina a
Comunione e Liberazione è una holindg con un fatturato enorme. Partita come
mensa per gli studenti ora gestisce ospedali, hotel, pasticcerie, catering.
Odevaine era dunque stipendiato da Buzzi e dalla Cascina. Interrogato dopo
l'arresto ai pm ha dichiarato: «Quello che facevo io …. era di facilitare il
Ministero da una parte nella ricerca degli immobili che potessero essere messi a
disposizione per l'emergenza abitativa». E Le somme di denaro (anche nella forma
di pagamento dell'affitto di immobili) che ha ammesso aver percepito da Buzzi?
Semplice. Li riceveva per l'attività che svolgeva per conto della sua
cooperativa, di «facilitatore dei rapporti con la pubblica amministrazione … in
ragione delle mie conoscenze maturate nel tempo». Il centro per richiedenti
asilo di Mineo è una gallina dalle uova d'oro per gli imprenditori
dell'accoglienza. Hanno capito che speculare è possibile sul villaggio della
solidarietà inventato dal governo Berlusconi e dall'allora ministro dell'Interno
Roberto Maroni. Odevaine nei dialoghi intercettati spiega ai suoi interlocutori
il metodo per mascherare le tangenti. Attraverso i subappalti affidati a ditte
amiche che poi avrebbero gonfiato le fatture oppure attraverso la
sovrafatturazione sfruttando una società di import export dello stesso Odevaine:
«Altra ipotesi può darsi, può essere con la ... con l'impresa questa mia di
import export, loro comprano alcune cose all'estero, tipo il caffè per
esempio...quei soldi rimangono fuori e lì non ce l'ho le rotture di coglioni che
ci sono qua, nel senso che se i soldi stanno lì, stanno nella società e io li
prendo personalmente non succede un cazzo». E' sempre l'esperto di immigrazione,
poi, a spiegare come versare le mazzette: «fallo... in più tranche però lo puoi
fare, dici questi ce l'avevo in cassa». Per avere successo servono le relazioni.
Odevaine conosce a fondo gli equilibri politici. Sostiene di essere stato lui a
mettere in contatto La Cascina con il sottosegretario Giuseppe Castiglione. «Per
cui ho conosciuto loro gliel'ho presentati a Castiglione... Castiglione si è
avvicinato molto a Comunione e Liberazione, insieme ad Alfano e adesso loro ...
Comunione e Liberazione di fatto sostiene strutturalmente tutta questa roba di
Alfano e del Centro Destra ...Castiglione». Il suo interlocutore a questo punto
gli chiede: «Comunione e Liberazione appoggia Alfano?». Odevaine ribatte: Sì,
stanno proprio finanziando ... sono tra i principali finanziatori di tutta
questa...questa roba si ... e Lupi è infatti è il Ministro delle Opere
Pubbliche e Castiglione fa il sottosegretario ... all'Agricoltura ed è il loro
principale referente in Sicilia ... cioè quello che poi gli porta i voti ...
perché poi i voti loro ce li hanno tutti in Sicilia». Per vincere le gare
sull'accoglienza il gruppo di Carminati non badava a spese. E pagava chiunque
potesse agevolare i propri interessi. Secondo gli inquirenti anche il sindaco
Fabio Stefoni di Castelnuovo di Porto avrebbe ottenuto una lauta ricompensa. Il
patto, secondo gli investigatori, consisteva nel pagamento di una somma « a
titolo di contributo elettorale e dalla promessa di dazione di 0,50 Euro per
immigrato al giorno, da parte di Buzzi per indurre Stefoni a consentire o,
comunque, a non opporsi all’apertura di un centro di accoglienza a Borgo del
Grillo, nel comune di Catelnuovo di Porto».
Capitale
corrotta, nazione infetta. Il celebre titolo de “l'Espresso” ha compiuto 60 anni
ma continua a essere di un'attualità sconcertante.
Per il Pd a
rubare sono sempre gli altri.
Renzi si erge
a paladino della legalità: "Chi viola le regole, deve pagare tutto". Ma il Pd
non fa mea culpa. Marino: "Vado avanti, ho fatto pulizia". E Orfini chiama in
causa i servizi segreti, scrive Sergio Rame su “Il Giornale”. Mafia Capitale,
si sa, è cosa di tutti. Gli arresti riguardato l'intero spettro politico. Ci
mangiavano tutti. Pochi erano gli esclusi dal banchetto. Ma alla mangiatoia, per
usare la metafora di Salvatore Buzzi, un posto privilegiato ce l'aveva proprio
il Partito democratico con i suoi esponenti locali, i suoi amministratori e le
sue cooperative. Diciannove persone in carcere, 25 ai domiciliari, altre 21
indagate a piede libero e altrettante perquisizioni. Provoca l’ennesimo
terremoto la seconda tranche dell’inchiesta denominata "Mafia Capitale" che già
lo scorso dicembre aveva fatto scattare le manette ai polsi di 37 indagati, con
il coinvolgimento di altri 40. Ancora una volta, l’ex terrorista dei Nar Massimo
Carminati e il presidente della cooperativa "29 giugno" Salvatore Buzzi
risultano i pezzi da novanta dell’ordinanza di custodia cautelare del gip Flavia
Costantini, eseguita all’alba dai carabinieri del Ros. La novità è che sono
stati chiamati in causa esponenti delle istituzioni, di destra e di sinistra,
del Campidoglio a della Regione Lazio: risultano tutti a libro paga
dell’organizzazione di stampo mafioso che a Roma faceva affari di ogni tipo e si
aggiudicava i migliori appalti. "Un Paese solido è quello che combatte la
corruzione come sta avvenendo in Italia con decisione e forza - commenta il
premier Matteo Renzi - mandando chi ruba in galera, perchè è giusto che
chi ha violato le regole paghi tutto e fino all’ultimo giorno". Ma sono solo
dichiarazioni di circostanza. Perché, come dice anche il commissario del Pd
romano Matteo Orfini, al Nazareno sono convinti che a rubare siano sempre glia
altri. "Le amministrazioni di Marino e Zingaretti - commenta Orfini in
conferenza stampa - sono state un baluardo della legalità". Eppure, aldilà di
Luca Gramazio, ex consigliere capogruppo Pdl in consiglio comunale e poi in
Regione, la seconda "retata" di Mafia Capitale ha fatto scattare le manette ai
polsi di numerosi esponenti dem. Tra questi spiccano Mirko Coratti, ex
presidente del consiglio comunale in quota Pd, dimessosi a dicembre dopo la
prima ondata di arresti, e il suo capo segreteria, Franco Figurelli. Per i pm,
avrebbero ricevuto la promessa di 150mila euro, la somma di 10mila e
l’assunzione di una persona segnalata da Coratti in cambio di una serie di
favori da fare alle cooperative di Buzzi. In cella anche Daniele Ozzimo, ex
assessore piddì alla Casa, Angelo Scozzafava, ex capo del quinto dipartimento
Promozione dei Servizi Sociali e della salute di Roma, e Pierpaolo Pedetti,
anche lui eletto consigliere comunale nel 2013 con il Pd, presidente della
Commissione Patrimonio. Insomma, al pari di altre forze politiche, il Pd
continua a comparire nelle carte dell'inchiesta. Eppure Orfini resta ancora
convinto che non ci siano le condizioni per sciogliere il Comune di Roma,
"perché questo significherebbe andare incontro alle richieste della
criminalità". Dal canto suo, il sindaco di Roma Ignazio Marino rivendica il
"cambiamento epocale" della sua giunta e si dice soddisfatto "della legalità
contabile che abbiamo portato nella nostra città". "Continuiamo in questo modo -
commenta il primo cittadino di Roma - la linea amministrativa che abbiamo
assunto in questi due anni di governo sta dimostrando che veramente stiamo
cambiando tutto". Per difenderlo, Orfini chiama addirittura in causa i servizi
segreti: "Chiederò al Copasir di occuparsi della vicenda per capire come i
servizi segreti non si siano accorti di cosa stesse facendo una persona a loro
evidentemente nota come Carminati» e di come «abbia potuto costruire un sistema
criminale di tale entità". Ma il teorema non regge proprio. "Che cos’altro deve
accadere perché Marino se ne vada e si torni alle urne?", replica il leader
della Lega Nord Matteo Salvini che vede proprio nel sindaco piddì il primo
responsabile. Anche il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni di Marino:
"Questa è l’ennesima prova che il sistema dei partiti è totalmente marcio, ivi
incluso il Pd romano".
Fuoriluogo,
scrive Franco Corleone su “L’Espresso”. L'onestà politica secondo Benedetto
Croce. L’invocazione ossessiva dell’onestà è ben giustificata da mille episodi
della cronaca del malaffare e però un bagno di razionalità può essere utile.
Leggere il saggio di Benedetto Croce presente nel volume Etica e politica
appare dissacrante di tanti luoghi comuni. “Un’altra manifestazione della
volgare inintelligenza circa le cose della politica è la petulante richiesta che
si fa dell’onestà nella vita politica”, così esordisce il filosofo e prosegue
contestando la deriva per un Paese di affidare la cosa pubblica a onesti uomini
tecnici. Croce definisce strana la pretesa che nelle cose della politica si
chiedano non uomini politici ma onest’uomini. “Ma che cosa è, dunque, l’onestà
politica?- si domanderà. L’onestà politica non è altro che la capacità politica:
come l’onestà del medico e del chirurgo, è la sua capacità di medico e di
chirurgo, che non rovina e assassina la gente con la propria insipienza condita
di buone intenzioni e di svariate e teoriche conoscenze”. Vale la pena di
leggere gli esempi della storia che presenta Croce per giustificare la sua
posizione, ma soprattutto è istruttiva la sua conclusione: la disonestà coincide
con la cattiva politica, con l’incapacità politica. Una tesi paradossale che
esalta la politica e in tempi di crisi, di vero abisso della politica,
rappresenta una lezione aristocratica.
Mafia Capitale, la Procura: "Rubano tutti".
Gli arresti posticipati per non influenzare il voto delle regionali, scrive
Claudia Fusani su L'Huffington Post. "Rubano tutti, ecco il filo rosso di questa
seconda parte dell'inchiesta....". A piazzale Clodio, sede della procura
capitolina, il procuratore Pignatone non riceve i giornalisti e tutti i pm
coinvolti, l'aggiunto Prestipino, i pm Luca Tescaroli, Giuseppe Cascini e Paolo
Ielo, declinano gentilmente dichiarazioni e commenti. "Rubano tutti" resta
l'amara constatazione dopo mesi di indagine e dopo aver riscontrato le
dichiarazioni a verbale di numerosi manager e imprenditori che hanno spiegato
"il sistema di potere trasversale ad ogni partito e maggioranza" che ha gestito
ogni affare nella Capitale almeno negli ultimi dieci anni. Proprio per questa
trasversalità, è stato chiaro a tutti che la seconda parte di Mafia capitale
avrebbe avuto ricadute pesanti nelle settimane prima del voto già infuocate da
una campagna elettorale durissima. "Abbiamo ritenuto necessario, per non
influire sul voto, attendere la chiusura delle urne prima di procedere agli
arresti" afferma una fonte in procura. Lo dimostrano le date: la richiesta della
procura risale a marzo, l'ordinanza è stata firmata il 29 maggio, venerdì,
quando già imperversava sul voto la lista dell'Antimafia. Attendere qualche
giorno non avrebbe cambiato nulla. E così è stato deciso. Se in Mafia capitale
parte Prima è stato protagonista Il sistema delle cooperative rosse che faceva
capo a Salvatore Buzzi, nella parte Seconda la parte del leone la fanno le
cooperative bianche. Al centro di molti passaggi dell'ordinanza lunga 500 pagine
c'è infatti La Cascina, cooperativa bianca che fa riferimento a Comunione e
Liberazione. Tra i 44 arresti di questa mattina per corruzione e concussione
aggravati dalla modalità mafiosa, anche Menolascina, manager della cooperativa.
Secondo l'accusa, la cooperativa garantiva un premio mensile di 10 mila a Lica
Odevaine in quanto il tecnico che garantiva, dal tavolo nazionale per
l'emergenza immigrazione, la gestione degli appalti per i centri profughi e
immigrati. Una volta che La Cascina ha ottenuto l'appalto del Cara di Mineo (7
aprile 2014), il premio per Odevaine è stato raddoppiato (20 mila euro mensili).
La cooperativa è emersa anche in un'altra delicata inchiesta del Ros dei
Carabinieri: quella che ha portato in carcere Ettore Incalza, il super direttore
generale del ministero delle Infrastrutture, e ha costretto alle dimissioni l'ex
ministro Lupi (che non è mai stato indagato).
Il tariffario delle tangenti: “Un euro a migrante”,
scrive “La Stampa”. Le intercettazioni del Ros svelano le mazzette. Il ras delle
coop sociali Buzzi al telefono: «La mucca deve mangiare per essere munta».
Mucche da mungere solo se ben foraggiate. Salvatore Buzzi, presidente della
Cooperativa 29 giugno e in carcere per l’inchiesta di Mafia Capitale dello
scorso anno, così si esprimeva al telefono con altri indagati. A pagina 21
dell’ordinanza del gip Flavia Costantini, che conta 500 pagine, si legge che «ha
ricevuto l’eloquente risposta che la mucca era stata ben foraggiata
dall’attività di Coratti (ex presidente del consiglio comunale ndr)
considerazione alla quale altrettanto eloquentemente Buzzi ribadiva che «la
mucca era stata munta tanto». Nell’ordinanza, che riporta appunto le
intercettazioni telefoniche, viene evidenziato che ciò «è un’eloquente
dimostrazione di un rapporto corruttivo continuativo nel tempo». «Le erogazioni
di utilità di Buzzi, esecuzione della linea strategica delineata di concerto con
Massimo Carminati - si legge nel provvedimento - avevano l’evidente funzione di
asservire agli interessi del gruppo politici che gravitavano nei segmenti delle
istituzioni maggiormente interessati ai rapporti con il gruppo medesimo». Ma la
29 giugno non è l’unica cooperativa interessata dalla «mungitura della mucca»,
il giudice scrive, infatti, ancora: «Gli esponenti del gruppo La Cascina (coop
attiva, dal 2012, anche nel settore dei servizi per l’immigrazione, e oggetto
questa mattina di perquisizione da parte dei carabinieri del Ros, ndr) avevano
promesso a Luca Odevaine una retribuzione fissa mensile, concordata prima in
10mila euro al mese e poi aumentata a 20mila euro e commisurata al numero di
immigrati ospitati dai centri gestiti dal gruppo». La cifra - spiega il Gip - è
il «prezzo per lo stabile asservimento della sua funzione di pubblico ufficiale
componente del Tavolo di Coordinamento sull’immigrazione istituito presso il
ministero degli Interni» e «per il compimento di atti contrari ai doveri
d’ufficio come componente delle commissioni di aggiudicazione delle gare indette
per la gestione dei servizi presso il Cara di Mineo». L’effettiva, periodica
consegna delle somme pattuite, sarebbe confermata dalle intercettazioni
ambientali e, «con certezza», in «almeno cinque episodi», dalle indagini
tecniche. La conferma arriva dalle stesse parole di Odevaine, intercettato
nell’ambito dell’inchiesta: «...altre cose in giro per l’Italia... possiamo pure
quantificare, guarda ... se me dai ... cento persone facciamo un euro a persona
... non lo so, per dire, hai capito? E ...e basta, uno ragiona così dice va be’
... ti metto 200 persone a Roma, 200 a Messina ... 50 là ... e ... le
quantifichiamo, poi...». Questo è lo stralcio di una conversazione con alcuni
suoi collaboratori intercettata nella sua stanza negli uffici della Fondazione
IntegraAzione, grazie al quale il gip Flavia Costantini prospetta l’esistenza di
«un vero e proprio tariffario per migrante ospitato». A titolo esplicativo
Odevaine parla dell’accordo stretto, tra gli altri, con Salvatore Buzzi,
presidente della Cooperativa 29 giugno e spiega: «Gli ho fatto avere altri
centri, in Sicilia... in provincia di Roma e quant’altro, quindi su tutto
quella... quella parte là ci mettiamo d’accordo dovremo..., più o meno, stiamo
concordando una cifra tipo come 1 euro a persona, ci danno, calcolando che so’
almeno un migliaio di persone, dovrebbero essere grosso modo un migliaio di
persone, insomma so’ 1000 euro al giorno quindi 30.000 euro al mese che
entrano...». Costantini sottolinea come Le indagini dei carabinieri del Ros
abbiano evidenziato «la straordinaria pericolosità di Luca Gramazio».
L’amministratore di centrodestra «potrebbe sfruttare la rete ampia dei
collegamenti per fornire nuova linfa alle attività delittuose e agli interessi
dell’associazione» capeggiata da Massimo Carminati, «nonostante lo stato
detentivo di numerosi sodali». In un altro passaggio viene evidenziato come per
le elezioni al parlamento europeo del maggio 2014, Gianni Alemanno, chiese
l’appoggio a Salvatore Buzzi. Quest’ultimo si sarebbe mosso per ottenere il
sostegno alla candidatura anche con gli uomini della cosca `ndranghetista dei
Mancuso di Limbadi. «Un ulteriore tassello idoneo a corroborare il rapporto di
reciproco riconoscimento tra le due organizzazioni - scrive il giudice - è
costituito dai riscontri intercettivi effettuati in occasione delle elezioni del
Parlamento Europeo 2014, che hanno visto il politico Giovanni Alemanno,
candidato nella lista «Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale», nella
circoscrizione Sud». Buzzi, in una conversazione con Massimo Carminati,
intercettata il 21 marzo del 2014, riferiva l’esito di un incontro avuto poco
prima con Alemanno negli uffici della «Commissione Commercio» a Roma. «Buzzi -
scrive il gip - riferiva del sostegno richiesto in quell’occasione dall’ex primo
cittadino («no, no era pe’ la campagna elettorale ... una sottoscrizione e poi
se candida al sud») e rappresentava al sodale come avesse individuato Campennì,
indicato con il solo nome di battesimo, quale strumento idoneo per assecondare
tale richiesta (».. da Giovanni ... gli famo fa ..«). Buzzi, il giorno seguente
contattava «Giovanni Campennì, al fine di interessarlo per «da ’na mano a
Alemanno ... in campagna elettorale ...«. Il tentativo «di Buzzi di mascherare,
in maniera evidentemente strumentale con l’interlocutore («sto numero è
intercettato ... però so telefonate legali ..»), l’illecita richiesta
pervenutagli, facendola passare come innocua e legittima istanza volta ad
ampliare il consenso elettorale (»? basta che non sia voto di scambio .... tutto
è legale ... uno po’ vota’ gli amici???!!!»), nell’ambito di una circoscrizione
elettorale particolarmente ampia («? mica può venire li!!! Scusa ... no perché
la circoscrizione è grandissima .... è Abruzzo .... Campania .... la Calabria
.... Puglia .... Basilicata ..... come cazzo fa? ... èèè ....»), veniva
perfettamente compreso da Campennì, il quale, avendo evidentemente ben inteso il
vero senso della richiesta («ah ste chiamate so legali??? ...»), aderiva
prontamente alla richiesta, non potendo evitare, tuttavia, di sottolineare la
propria capacità di poter attingere a un ampio bacino di consensi pilotabili,
facendo ricorso a una metafora particolarmente espressiva («va bene .... allora
.... è qua la famiglia è grande ... un voto gli si dà»).
Mafia Capitale, 44 arresti tra politica e affari. In manette
anche big di Pd e Forza Italia.
Seconda ondata di provvedimenti cautelari nell'inchiesta sulla malavita romana.
Tra i reati contestati associazione mafiosa, corruzione, turbativa d’asta e
false fatturazioni. Tanti i nomi della politica locale coinvolti, scrive Lirio
Abbate su L’Espresso”. Il clan mafioso di Massimo Carminati aveva in pugno
politici regionali e comunali attraverso i quali riusciva a gestire appalti e
incassare milioni di euro di soldi pubblici. Su Roma si abbatte così il secondo
atto giudiziario di mafia Capitale, con 44 arresti eseguiti stamani dai
carabinieri del Ros che hanno condotto le indagini, coordinate dalla procura
antimafia di Roma. E così, accanto al cecato, compaiono nel provvedimento
cautelare il capogruppo prima del Pdl e poi Forza Italia alla Regione, Luca
Gramazio, ma anche l'ex presidente del consiglio comunale Mirko Coratti e l'ex
minisindaco di Ostia Andrea Tassone, entrambi del Pd. Ma c'è anche l'ex
consigliere comunale del Pdl Gerardo Tredicine. E poi soci e amministratori di
cooperative bianche che si erano aggiudicati incarichi per l'emergenza
immigrati. Mafia Capitale secondo atto: i carabinieri del Ros hanno eseguito 44
nuovi arresti tra Lazio, Abruzzo e Sicilia. I reati contestati sono associazione
di tipo mafioso, corruzione, turbativa d'asta, false fatturazioni, trasferimento
fraudolento di valori ed altro. Il blitz è scatato all'alba nelle province di
Rieti, Frosinone, l'Aquila, Catania ed Enna. Altre 21 persone risultano
indagate. Su di loro sono in corso perquisizioni. uesta seconda tornata di
arresti, secondo gli inquirenti, "conferma l'esistenza di una struttura mafiosa,
operante nella capitale, cerniera tra ambiti criminali ed esponenti degli
ambienti politici, amministratori ed imprenditori locali". Tra gli arrestati ci
sono anche il consigliere regionale di Fi, Luca Gramazio, l'ex presidente del
consiglio comunale di Roma, Mirko Coratti, l'ex assessore Daniele Ozzimo,
Giordano Tredicine e l'ex presidente del municipio di Ostia, Andrea Tassone.
Sono dunque 44 le persone arrestate (fra detenzione in carcere e quella
domiciliare) con le accuse a vario titolo di associazione mafiosa, corruzione,
turbativa d’asta, false fatturazioni, con l’aggravante delle modalità mafiose. E
poi ci sono altre 21 persone indagate per le quali sono scattate stamani le
perquisizione. Gli interventi dei carabinieri sono stati effettuati nelle
province di Roma, Rieti, Frosinone, L’Aquila, Catania e Enna.Salvatore Buzzi
parla con Massimo Carminati e gli dice che i consiglieri comunali dovevano stare
ai loro ordini poiché vengono pagati e, pertanto, devono rispettare gli accordi
perché "se non rispetti gli accordi, lo sai da dove vengo". Le indagini
coordinate dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, in questa nuova fase,
hanno permesso di acquisire ulteriori elementi sul metodo mafioso attuato dal
clan Carminati, confermato anche dalle testimonianze rese da diversi
imprenditori vittime. È questa un'altra grande sorpresa: la collaborazione di
molte delle vittime del clan. Gli imprenditori chiamati nei mesi scorsi dagli
investigatori non hanno negato di aver subito pressioni o violenza ed hanno
parlato, facendo cadere lo strano di omertà che aveva avvolto molti altri. E
grazie alle indagini è stata confermata la centralità nel clan Carminati di
Salvatore Buzzi, che era a capo di una rete di cooperative sociali che si sono
assicurate, nel tempo, mediante pratiche corruttive e rapporti collusivi,
numerosi appalti e finanziamenti della Regione Lazio, del Comune di Roma e delle
aziende municipalizzate. Un giro di affari per 150 milioni di euro solo con il
Campidoglio. Il consigliere Luca Gramazio è accusato di associazione mafiosa «in
qualità di esponente della parte politica che interagiva, secondo uno schema
tripartito, con la componente imprenditoriale e quella propriamente
criminale».La malavita romana lucra sulla pelle dei più poveri, e gli ultimi
arresti dimostrano quanto il sistema fosse capillare. Per fortuna c'è anche chi
si ribella all'omertà che dilaga a Roma. Il nostro inviato spiega come si evolve
l'inchiesta "Mondo di mezzo". Gramazio prima nella carica di capogruppo Pdl al
Consiglio comunale di Roma ed in seguito come capogruppo Pdl (poi Forza Italia)
presso il Consiglio Regionale del Lazio, sfruttando la propria appartenenza alle
due assemblee amministrative e la conseguente capacità di influenza
nell’ambiente istituzionale «poneva in essere condotte strumentali al
conseguimento degli scopi del sodalizio».
Mafia Capitale, le nuove telefonate. «La mucca tu la devi
mungere, però gli devi dà da mangià».
La metafora di Buzzi per spiegare il sistema delle tangenti, scrive Giovanni
Bianconi su “Il Corriere della Sera”. Sono ancora una volta le intercettazioni
telefoniche e ambientali nelle quali Salvatore Buzzi racconta il suo ruolo di
corruttore a comporre il secondo capitolo di Mafia Capitale, che arriva dritto
nel governo di Roma (cinque consiglieri comunali arrestati e altri indagati,
insieme a funzionari di vari livelli finiti anch’essi in carcere), della Regione
dove pure sarebbero stati siglati “accordi spartitori”, e del sistema di
gestione dell’emergenza immigrati. Secondo i pubblici ministeri della Procura di
Roma e il giudice dell’indagine preliminare che ha concesso i nuovi arresti –
basati su ulteriori accertamenti e verifiche svolte dai carabinieri del Ros –
l’organizzazione guidata dal “signore delle cooperative” Buzzi e dall’ex
estremista nero Massimo Carminati ha esteso la propria rete corruttiva in
maniera sempre più trasversale, passando senza problemi dall’amministrazione
capitolina di centro-destra, quando era sindaco Gianni Alemanno, a quella di
centro-sinistra, guidata da Ignazio Marino. Continuando a comprare, attraverso
consistenti somme di denaro e “altre utilità”, gli amministratori e i funzionari
che servivano a pilotare le gare e ottenere l’assegnazione degli appalti. E
così, per un buon numero dei nuovi inquisiti è scattata l’aggravante di aver
favorito, grazie alla “vendita” delle proprie funzioni, “l’associazione mafiosa
diretta da Carminati”, già riconosciuta come tale da una pronuncia della corte
di cassazione. Secondo il giudice Flavia Costantini che ha firmato la nuova
ordinanza d’arresto, le frasi pronunciate da Buzzi nei dialoghi con Carminati e
altri personaggi coinvolti nei “di mezzo”, “di sopra” e “di sotto” scoperchiati
dall’inchiesta, rivelano “circostanze veritiere”, che peraltro hanno trovato
riscontro nelle indagini degli investigatori del Ros. In una telefonata del 15
ottobre 2014 – un mese e mezzo prima degli arresti del 2 dicembre – il manager
delle cooperative parlava con Franco Figurelli, all’epoca appartenente alla
segreteria del presidente del consiglio comunale Mirko Coratti, e prendendo
spunto dalla richiesta di assunzione per una ragazza avanzata da Figurelli,
rendeva chiara la sua filosofia.
Buzzi:
“Ahò ma, scusa ma lo sai... la sai la metafora?
Figurelli:
“Eh…”.
Buzzi:
“La mucca deve mangiare”.
Figurelli:
“Ahò, questa metafora io glielo dico sempre al mio amico, mi dice: ‘non mi
rompere, perché se questa è la metafora lui ha già, già fatto, quindi non mi
rompere’...”.
Buzzi:
“Ma... fai fa... fagli un elenco...
Figurelli:
“Salvatò…”
Buzzi:
“Fagli un elenco della mangiatoia, digli, oh” (ridono)
Figurelli:
“Salvatò, te voglio be... già me rompe… dice: ‘E’ possibile che Salvatore a noi
ce risponde così?’, ho detto: ‘Ahò, che te devo di’, gli ho detto, ‘questa è la
metafora che me dà il cammello e della cosa… quindi che te devo fà?’” (…)
Buzzi:
“Sì, ma io investo su di te, lo sai che investo su di te”.
Figurelli
“Eh, meno male” (…)
Buzzi:
“Ahò, però diglielo: ‘guarda che ha detto Buzzi che qui la mucca l’avemo munta
tanto… (sovrapposizione di voci)”.
In altre
occasioni, e parlando con altri personaggi, Buzzi tornava spesso sulla stessa
metafora, per spiegare – nell’interpretazione dell’accusa – che politici e
funzionari dovevano foraggiare le sue cooperative (attraverso gli appalti) per
poi ricavarne qualcosa anche per loro (le tangenti): “Se la mucca non mangia non
può essere munta”; “La mucca tu la devi mungere, però gli devi dà da mangià”;
“La mucca può essere munta solo se mangia”. Secondo l’accusa che ora li ha
portati in carcere, Figurelli e Coratti (i quali hanno cambiato incarico dopo la
retata di dicembre) ricevevano un vero e proprio “stipendio” per mettere le
proprie funzioni al servizio del gruppo guidato da Buzzi e Carminati. I quali,
con il cambio di maggioranza in Campidoglio, hanno dovuto “investire
nell’acquisizione di nuovo capitale istituzionale”. In un’altra conversazione
intercettata, dopo un lungo elenco di nomi e di cifre lo stesso Buzzi, afferma:
“Perché noi pagamo tutti, come vedi”. E il 17 novembre scorso, appena 15 giorni
prima di essere arrestato nell’operazione del 2 dicembre, faceva proclami
agguerriti, che nel linguaggio evocano espressioni da Romanzo criminale: “Noi
comunque … ti dico una cosa… lui (Marino ndr) se resta sindaco altri tre
anni e mezzo, con il mio amico capogruppo ci mangiamo Roma”.
Secondo
capitolo dell'inchiesta Mondo di Mezzo della procura di Roma e dei
carabinieri del Ros: 44 gli arresti in corso di esecuzione in Sicilia, Lazio e
Abruzzo per associazione per delinquere ed altri reati. Ventuno gli indagati a
piede libero. Sullo sfondo il business legato ai flussi migratori e alla
gestione dei campi di accoglienza per migranti, scrive Panorama. Il blitz dei
carabinieri è scattato all'alba nelle province di Roma, Rieti, Frosinone,
L'Aquila, Catania ed Enna. Nell'ordinanza di custodia cautelare, emessa su
richiesta della procura distrettuale antimafia di Roma, e del gip Claudia
Costantini, vengono ipotizzati a vario titolo i reati di associazione di tipo
mafioso, corruzione, turbativa d'asta, false fatturazioni, trasferimento
fraudolento di valori ed altro. Contestualmente agli arresti altre 21 persone
sono state perquisite in quanto indagate per gli stessi reati. I provvedimenti
riguardano gli sviluppi delle indagini condotte dal Ros nei confronti di
Mafia Capitale, il gruppo mafioso riconducibile a Massimo Carminati, ora in
carcere. Secondo gli investigatori, gli accertamenti successivi a quella tornata
di arresti hanno confermato "l'esistenza di una struttura mafiosa operante nella
Capitale, cerniera tra ambiti criminali ed esponenti degli ambienti politici,
amministrativi ed imprenditoriali locali". In particolare le indagini hanno
documentato quello che gli inquirenti definiscono un "ramificato sistema
corruttivo finalizzato a favorire un cartello d'imprese, non solo riconducibili
al sodalizio, interessato alla gestione dei centri di accoglienza e ai
consistenti finanziamenti pubblici connessi ai flussi migratori. Secondo il
magistrato, Luca Gramazio "svolge un ruolo di collegamento tra l'organizzazione
da un lato e la politica e le istituzioni dall'altro, ponendo al servizio della
stessa il suo 'munus publicum' e il suo ruolo politico". Un collegamento che,
sul piano politico, si traduce nella costruzione del consenso necessario ad
assecondare gli affari del sodalizio; sul piano istituzionale, si materia di
iniziative formali e informali intese per un verso a collocare nei plessi -
sensibili per l'organizzazione - dell'amministrazione pubblica soggetti graditi,
per altro verso nell'orientare risorse pubbliche in settori nei quali il
sodalizio, in ragione del capitale istituzionale di cui dispone, ha maggiori
possibilità di illecito arricchimento. Egli, inoltre, "elabora insieme ai
vertici dell'organizzazione le strategie di penetrazione della pubblica
amministrazione". Infine, sostiene ancora il gip, il consigliere regionale,
"riceve dall'organizzazione per un verso una costante erogazione di utilità, per
altro verso protezione e sicurezza in tutti quei casi in cui si rende
necessario". Secondo gli inquirenti della Procura di Roma sarebbero state
versate a Luca Gramazio mazzette per oltre 100mila euro dal gruppo guidato da
Massimo Carminati. In particolare nella contestazione presente nell'ordinanza
del gip Costantini si spiega che il consigliere regionale avrebbe avuto "98mila
euro in contanti in tre tranches (50.000-28.000-20.000)"; ma anche "15mila euro
con bonifico per finanziamento al comitato Gramazio". Inoltre, anche per
"l'assunzione di 10 persone, cui veniva garantito nell'interesse di Gramazio uno
stipendio; la promessa di pagamento di un debito per spese di tipografia". A
carico di Gramazio jr è ipotizzata "l'aggravante di aver agito al fine di
agevolare l'associazione di tipo mafioso indicata al capo 23". "Il ruolo di Luca
Gramazio, quale personaggio vicino all'associazione in esame, era già emerso, ma
è stato possibile solo successivamente, con un ulteriore e più approfondito
vaglio del materiale investigativo, delineare il ruolo dello stesso all'interno
dell'associazione, che può ricondursi al capitale istituzionale di Mafia
Capitale" ha affermato Costantini, nell'ordinanza di custodia cautelare che
riguarda anche il consigliere regionale. Delle perquisizioni in corso
nell'ambito di Mafia Capitale, una riguarda la cooperativa "La Cascina", vicina
al mondo cattolico. Gestisce tra l'altro il Cara di Mineo, in Sicilia. La
perquisizione rientra nel quadro degli accertamenti sulla gestione degli appalti
per i rifugiati. I Ros hanno poi perquisito anche gli uffici della Manutencoop a
Zola Predosa (Bologna). Secondo quanto si apprende i militari del comando
emiliano-romagnolo agiscono su delega della Procura di Roma e oggetto del loro
interesse è il sequestro della documentazione in un ufficio, un faldone relativo
ad una singola gara che si è tenuta a Roma e che coinvolge il colosso
cooperativo. "Credo che la politica nel passato abbia dato un cattivo esempio ma
oggi sia in Campidoglio che in alcune aree come Ostia abbiamo persone perbene
che vogliono ridare la qualità di vita e tutti i diritti e la dignità che la
Capitale merita". Così il sindaco di Roma Ignazio Marino sulla nuova ondata di
arresti per l'inchiesta su Mafia Capitale. E a chi gli chiede notizie riguardo
sue possibili dimissioni, taglia corto: "Dimissioni? Continuiamo in questo modo.
Stiamo cambiando tutto. Una politica antica non solo nei metodi ma anche nei
contenuti, e in alcuni casi gravemente colpevole è stata allontanata da me".
Mafia
capitale 2: ecco chi sono i politici arrestati.
Nell'operazione Mondo di Mezzo bis dei Carabinieri del Ros finiscono in carcere
44 persone, la maggior parte esponenti della politica romana, scrive Nadia
Francalacci su "Panorama". L'operazione Mondo di Mezzo Bis. Mondo di Mezzo,
secondo atto. Non è stata certo una novità. Le indagini condotte dai Carabinieri
del Ros e gli arresti effettuati a dicembre scorso facevano intuire che
all'inchiesta di Mafia capitale ci sarebbe stato un seguito. E ,a distanza di
meno di sei mesi, altre decine di arresti spaccano il mondo politico e
imprenditoriale romano, abruzzese e siciliano. Il blitz dei carabinieri è
scattato all'alba nelle province di Roma, Rieti, Frosinone, L'Aquila, Catania ed
Enna. Nell'ordinanza di custodia cautelare, emessa su richiesta della procura
distrettuale antimafia di Roma, vengono ipotizzati a vario titolo i reati di
associazione di tipo mafioso, corruzione, turbativa d'asta, false fatturazioni,
trasferimento fraudolento di valori ed altro. Contestualmente agli arresti, in
tutto 44 e che per la maggior parte riguardano politici, ci sono state
perquisizioni a carico di altre 21 persone indagate per gli stessi reati. Gli
sviluppi delle indagini condotte dal Ros sono legati al gruppo mafioso
riconducibile a Massimo Carminati, ora in carcere. In particolare, le ultime
indagini, hanno documentato quello che gli inquirenti definiscono un ramificato
sistema corruttivo finalizzato a favorire un cartello d'imprese, non solo
riconducibili al sodalizio, interessato alla gestione dei centri di accoglienza
e ai consistenti finanziamenti pubblici connessi ai flussi migratori.
Manette per Luca Gramazio.
Tra i 44 arresti del Ros nel nuovo filone di Mafia Capitale c'è anche Luca
Gramazio. Questi è accusato di partecipazione all'associazione mafiosa
capeggiata da Carminati, che avrebbe favorito sfruttando la sua carica politica:
prima di capogruppo Pdl al Consiglio di Roma Capitale ed in seguito quale
capogruppo Pdl (poi FI) presso il Consiglio Regionale del Lazio. Luca Gramazio
è figlio dello storico senatore di An Domenico. E' stato consigliere comunale
Pdl a Roma nella maggioranza di Gianni Alemanno.
Carcere per l'ex presidente Coratti.
In carcere c'è anche l'ex presidente del Consiglio comunale di Roma, Mirko
Coratti, candidato come Consigliere del Municipio III a soli 24 anni e nel 2001
entrato a far parte del Consiglio. Successivamente ha assunto la carica di
Presidente del Consiglio comunale mentre era sindaco Veltroni.
In cella anche Daniele Ozzimo.
In manette anche l'ex assessore alla Casa del Campidoglio, Daniele Ozzimo. Viene
eletto nel 2008 al Consiglio del Comune di Roma nelle liste del Partito
Democratico ricoprendo la carica di vice Presidente della Commissione Politiche
Sociali e diventando membro della Commissione Lavori Pubblici, Scuola e Sanità.
Arrestato anche il consigliere comunale Giordano Tredicine.
I Ros hanno posto in arresto anche il consigliere comunale Giordano Tredicine.
Nel 2006, Tredicine diventa consigliere al IX Municipio con 1.576 preferenze ed
è nominato Presidente Gruppo Consiliare Forza Italia. Nel 2008 è eletto in
Consiglio Comunale con 5.284 preferenze, risultando il consigliere più giovane
del Gruppo Consiliare del Comune di Roma. Viene nominato Presidente della
Commissione Politiche Sociali e Famiglia e Vicecapogruppo del Pdl in Consiglio
Comunale.
In manette anche Massimo Caprari.
Gli arresti sono scattati anche per il consigliere comunale Massimo Caprari, dal
giugno 2013 Consigliere dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale e membro
nelle seguenti Commissioni: Lavori Pubblici, di cui è Vice Presidente
Vicario, Patrimonio - Politiche Abitative e Progetti Speciali, Urbanistica, Roma
Capitale e Riforme Istituzionali, Commissione Speciale Politiche Comunitarie e
Commissione di Indagine Amministrativa sull’ATAC, di cui è Presidente.
In carcere anche Andrea Tassone.
Le porte del carcere si sono aperte anche per l'ex presidente del X Municipio
(Ostia), Andrea Tassone.
In carcere anche il responsabile anti-corruzione degli ospedali
laziali, Angelo Scozzafava.
Tra gli arrestati di questa mattina anche Angelo Scozzafava, ex assessore
comunale a Roma alle Politiche Sociali. Dirigente azienda ospedaliera S. Andrea,
Scozzafava era il responsabile anti-corruzione e trasparenza della S.Andrea, una
delle principali aziende ospedaliere del Lazio.
Colpita anche
la Regione Lazio. I provvedimenti hanno riguardato anche alti dirigenti della
Regione Lazio come Daniele Magrini nella veste di responsabile del
dipartimento Politiche Sociali... Ancora manette al Campidoglio. In manette
anche Mario Cola, dipendente del dipartimento Patrimonio del Campidoglio
e Franco Figurelli che lavorava presso la segreteria di Mirko Coratti. In
manette anche un costruttore. Arresti domiciliari anche per il costruttore
Daniele Pulcini. L'imprenditore era già finito sotto la lente
d'ingrandimento della procura di Roma per una maxi-inchiesta sulle tangenti
Enpam. Secondo gli investigatori avrebbe pagato una "bustarella" da un milione e
800 mila euro al parlamentare del Pd Marco Di Stefano quando era assessore al
Demanio della giunta regionale guidata da Piero Marrazzo. Nuove accuse anche per
la Chiaravalle. Nuove accuse per l'indagata marsicana Pierina Chiaravalle,
31 anni, nell'ambito del secondo filone dell'inchiesta. Originaria di Avezzano e
agli arresti domiciliari da dicembre 2014.
Migranti, il business dell'emergenza.
Dalla primavera del 2014 le prefetture stanno affidando i servizi d'accoglienza
per stranieri con procedure "straordinarie". Che permettono di lucrare. E
aumentano il rischio di bombe sociali, scrive Francesca Sironi su
“L’Espresso”. Il centro d'accoglienza di Corcolle da cui erano partite
proteste violente Dopo gli scandali, forse per pudore, non è più definita
“emergenza”. Il risultato però è lo stesso: fiumi di soldi, controlli
inesistenti, sprechi accertati. Dalla primavera del 2014 le prefetture di tutta
Italia stanno affidando per vie “straordinarie” i servizi d’accoglienza per
migranti. L’impegno economico per lo scorso anno supera i 480 milioni di
euro, considerando vitto, alloggio e una minima assistenza. Le altre
spese (organizzazione, trasporti) non è dato saperle: il ministero dell’Interno
non ha risposto a “l‘Espresso”. Intanto, grazie alle procedure direttissime del
Viminale una pletora di hotel, agriturismi, bed and breakfast e
persino officine si sono riempite di richiedenti asilo, con rimborsi giornalieri
dai 30 ai 35 euro pro capite. Una ricca occasione: le strutture temporanee non
devono rendicontare le spese; se riescono a risparmiare, tagliando magari sulle
attività per i rifugiati, è tutto guadagno. I prefetti, dicono, pagano pure
puntualmente. In questa rete rabberciata sono raccolte oggi 33mila
persone. E se la fretta di trovare alloggi è giustificata dall’aumento
choc degli sbarchi, meno comprensibile è la nebbia che circonda i contratti, a
partire dal gran numero di prefetture (Calabria in testa) che dimenticano di
pubblicare online affidatari e importi, come impone la legge. «L’emergenzialità
favorisce chi lucra e rischia di provocare bombe sociali», sintetizza
Berardino Guarino, dirigente del Centro Astalli di Roma, il ricovero
per migranti fondato dai gesuiti. Il suo più che un teorema è una constatazione:
nella Capitale il fiume di soldi dell’emergenza (quella sì chiamata così anche
nei documenti ufficiali), dichiarata nel 2011 per le rivolte del Nord Africa ,
ha rimpinguato le casse del consorzio Eriches di Salvatore Buzzi , il braccio
destro di Massimo Carminati. Il business ha significato anche
altro. I maxi-condomini affittati di corsa nelle periferie hanno trasformato
spesso l’accoglienza in disperazione, quindi in disagio, infine in scontri, come
è successo a Corcolle o a Tor Sapienza . «La lezione non è servita», scuote la
testa Guarino: «A Roma ci sono ancora 3500 posti “straordinari”. E manca un
piano per l’integrazione». Ad approfittare dell’Emergenza Nord Africa
– un miliardo e 300 milioni fra il 2011 e febbraio 2013 - e poi di Mare Nostrum
non è stata solo la società di Buzzi, aderente alla rossa Lega Coop. La
cattolica Domus Caritatis , che gestisce decine di centri a Roma e ha una
partecipazione al Cara di Mineo, ha raddoppiato il fatturato: da 18 a 36
milioni. Come lei si sono ingranditi i gruppi di cui fa parte: il
Consorzio Casa della Solidarietà, rappresentato da Tiziano
Zuccolo (intercettato al telefono con Buzzi: «L’accordo è al 50 per
cento, dividiamo da buoni fratelli», dicevano degli appalti) e La
Cascina, vicina a Cl. Rispetto agli sprechi dell’Emergenza Nord Africa,
denunciati da “l’Espresso”, qualcosa è cambiato. I costi sono
più contenuti: si è passati da 45 a circa 30 euro al giorno. E il governo ha
aumentato i posti “ordinari” prima di aprire il suk di quelli extra. I vantaggi
sono quattro: i soldi per i servizi (denominati Sprar) arrivano
in gran parte dall’Europa, non dallo Stato. Le coop sono costrette a
rendicontare le spese. I controlli sono (in teoria) maggiori. E soprattutto sono
coinvolti gli enti locali. L’ampliamento d’urgenza però - i Comuni sono passati
in un anno da 3mila a 20mila posti – ha intaccato la qualità
generale di un sistema considerato d’eccellenza, come nota Gianfranco
Schiavone di Asgi (associazione studi giuridici per l’immigrazione).
«Metà dei progetti finanziati per i prossimi tre anni ha ricevuto una
valutazione molto bassa, lontanissima dal punteggio riconosciuto al primo, che è
del comune di Parma». Su 446 progetti, poi, 226 sono in Sicilia, Puglia,
Calabria e Basilicata. «Per questo insistiamo sulla necessità di un
piano nazionale», conclude il giurista. Ma con i piani si fanno meno soldi.
Mentre l’emergenza è un affare d’oro. Tanto paga il prefetto.
Chi specula sui profughi. Un miliardo e
300 milioni: è quello che ha speso finora lo Stato per assistere le persone
fuggite da Libia e Tunisia. Un fiume di denaro senza controllo. Che si è
trasformato in business per albergatori, coop spregiudicate e truffatori,
scrivono Michele Sasso e Francesca Sironi su “L’Espresso”. Erano
affamati e disperati, un'ondata umana in fuga dalla rivoluzione in Tunisia e
dalla guerra in Libia: fra marzo e settembre dello scorso anno l'esodo ha
portato sulle nostre coste 60 mila persone. Profughi, accolti come tali
dall'Italia o emigrati in fretta nel resto d'Europa: solo 21 mila sono rimasti a
carico della Protezione civile. Ma l'assistenza a questo popolo senza patria è
stata gestita nel caos, dando vita a una serie di raggiri e truffe. Con un costo
complessivo impressionante: la spesa totale entro la fine dell'anno sarà di un
miliardo e 300 milioni di euro. In pratica: 20 mila euro a testa per ogni uomo,
donna o bambino approdato nel nostro Paese. Ma i soldi non sono andati a loro:
questa pioggia di milioni ha alimentato un suk, arricchendo affaristi d'ogni
risma, albergatori spregiudicati, cooperative senza scrupoli. Per ogni profugo
lo Stato sborsa fino a 46 euro al giorno, senza verificare le condizioni in cui
viene ospitato: in un appartamento di 35 metri quadrati nell'estrema periferia
romana ne sono stati accatastati dieci, garantendo un reddito di oltre 12 mila
euro al mese. Ancora una volta emergenza è diventata la parola magica per
scavalcare procedure e controlli. Gli enti locali hanno latitato, tutto si è
svolto per trattative privata: un mercato a chi si accaparrava più profughi. E
il peggio deve ancora arrivare. I fondi finiranno a gennaio: se il governo non
troverà una soluzione, i rifugiati si ritroveranno in mezzo alla strada. In
Italia sono rimaste famiglie africane e asiatiche che lavoravano in Libia sotto
il regime di Gheddafi. La prima ondata, composta soprattutto da giovani
tunisini, ha preso la strada della Francia grazie al permesso umanitario voluto
dall'allora ministro Roberto Maroni. Ma quando Parigi ha chiuso le frontiere, lo
stesso Maroni ha varato una strategia federalista: ogni regione ha dovuto
accogliere un numero di profughi proporzionale ai suoi abitanti (vedi grafico a
pag. 39). A coordinare tutto è la Protezione civile, che da Roma ha incaricato
le prefetture locali o gli assessorati regionali come responsabili del piano di
accoglienza. Ma, nella fretta, non ci sono state regole per stabilire chi
potesse ospitare i profughi e come dovessero essere trattati. Così l'assistenza
si è trasformata in un affare: bastava una sola telefonata per venire
accreditati come "struttura d'accoglienza" e accaparrarsi 1.200 euro al mese per
ogni persona. Una manna per centinaia di alberghi vuoti, ex agriturismi,
case-vacanze disabitate, residence di periferia e colonie fatiscenti. Dalle Alpi
a Gioia Tauro, gli imprenditori del turismo hanno puntato sui rifugiati. A spese
dello Stato. Le convenzioni non sono mai un problema: vengono firmate
direttamente con i privati, nella più assoluta opacità. Grazie a questo piano,
ad esempio, 116 profughi sono stati spediti, in pantaloncini e ciabatte, dalla
Sicilia alla Val Camonica, a 1.800 metri di altezza. I proprietari del residence
Le Baite di Montecampione non sono stati i soli a fiutare l'affare. Anche nella
vicina Val Palot un politico locale dell'Idv, Antonio Colosimo, ne ha ospitati
14 nella sua casa-vacanze, immersa in un bosco: completamente isolati per mesi,
non potevano far altro che cercare funghi. I più furbi hanno trattato anche sul
prezzo. La direttiva ufficiale, che stabilisce un rimborso di 40 euro al giorno
per il vitto e l'alloggio (gli altri 6 euro dovrebbero essere destinati
all'assistenza), è arrivata solo a maggio. Nel frattempo, la maggior parte dei
privati aveva già ottenuto di più. Gli albergatori napoletani sono riusciti a
strappare una diaria di 43 euro a testa. Non male, se si considera che in 22
alberghi sono ospitate, ancora oggi, più di mille persone. «La domanda turistica
al momento degli sbarchi era piuttosto bassa», ammette Salvatore Naldi,
presidente della Federalberghi locale. La Protezione civile prometteva che
sarebbero state strutture temporanee. Non è andata così: solo all'Hotel Cavour,
in piazza Garibaldi, di fronte alla Stazione centrale, dormono tutt'ora 88
nordafricani. Le stanze, tanto, erano vuote: i viaggiatori si tengono alla
larga, a causa dell'enorme cantiere che occupa tutta la piazza. Ma grazie ai
rifugiati i proprietari sono riusciti lo stesso a chiudere la stagione: hanno
incassato quasi 2 milioni di euro. I richiedenti asilo però non sono turisti, ma
persone che hanno bisogno di integrarsi. La legge prevede che ci siano servizi
di mediazione culturale, che sono rimasti spesso un miraggio o sono stati
appaltati a casaccio:«A Napoli sono spuntate in pochi mesi decine di
associazioni mai sentite nominare», denuncia Jamal Qadorrah, responsabile
immigrazione della Cgil Campania: «Ogni albergatore poteva affidare i servizi a
chi voleva, nonostante ci sia un albo regionale degli enti competenti. Tutti,
puntualmente, ignorati». Non solo. «A luglio di quest'anno abbiamo organizzato
un incontro fra il Comune e gli albergatori», racconta Mohamed Saady,
sindacalista della Cisl: «Diverse strutture non avevano ancora un mediatore». Ed
era passato più di un anno dall'inizio dell'emergenza. Il business dei nuovi
arrivati non ha lasciato indifferenti nemmeno i professionisti della
solidarietà. Cooperative come Domus Caritatis, che gestisce otto comunità solo a
Roma. Anche i suoi centri sono finiti nel mirino di Save The Children e del
garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Lazio. Dopo numerose segnalazioni
l'ong è andata a controllare 14 strutture della capitale che si fanno rimborsare
80 euro al giorno per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Il
risultato è un rapporto inquietante, presentato a maggio alla Protezione civile
e al Viminale, che "l'Espresso" ha esaminato. Si parla di sovraffollamento, ma
soprattutto di senzatetto quarantenni fatti passare per ragazzini scappati dalla
Libia. Durante l'indagine sono stati intervistati 145 profughi. «Più di cento
erano palesemente maggiorenni», denuncia l'autrice del rapporto, Viviana
Valastro: «Quelli che avevo di fronte a me erano adulti. Altro che
diciassettenni. Non posso sbagliarmi». Non solo. «Molti di loro erano in Italia
da tempo, non da pochi mesi. Alcuni arrivavano dagli scontri di Rosarno». Doppia
truffa insomma: sull'età e sulla provenienza, per avere un rimborso più che
maggiorato e intascare milioni di euro. Tutto questo da parte di una cooperativa
strettamente legata all'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e di San
Trifone e a La Cascina, la grande coop della ristorazione che tre anni fa è
stata al centro di un'inchiesta per il tentativo di entrare nella gestione dei
cpt. Save The Children non è stata la sola a denunciare la situazione romana.
Anche il presidente della commissione capitolina per la sicurezza, Fabrizio
Santori, esponente del Pdl, ha dovuto occuparsi di Domus Caritatis. La
cooperativa infatti gestiva una comunità che dava grossi problemi al vicinato,
da cui arrivavano continue proteste. Santori l'ha visitata e si è trovato
davanti ad alloggi di 35 metri quadri abitati da 10 persone. Peggio che in un
carcere. Eppure gli appartamentini di via Arzana, a metà strada fra Roma e
Fiumicino, più vicini all'aeroporto che alla città, permettevano di incassare
più di 12 mila euro al mese. Save The Children ha calcolato che in strutture di
questo tipo, nella capitale, vivono quasi 950 persone. Dati incerti, perché solo
cinque cooperative hanno accettato di fornirli. Domus Caritatis, dalla sua sede
all'abbazia trappista delle Tre Fontane, non ha voluto dare alcuna informazione.
Il dossier dell'ong internazionale descrive un caos assoluto: mancanza di
responsabili, nessun servizio di orientamento e accompagnamento legale,
strutture inadeguate. Al Nord la situazione non cambia. A Milano si registrano
casi come quello della ex scuola di via Saponaro, gestito dalla Fondazione
Fratelli di San Francesco d'Assisi, che ha accolto 150 rifugiati. Ospitati in
una comunità per la cura dei senzatetto, l'accoglienza dei minori e degli ex
carcerati: 400 persone, con esigenze diverse, costrette a vivere sotto lo stesso
tetto in una vecchia scuola. «Le condizioni sono orribili: 10-12 letti per ogni
camerata. E pieni di pidocchi e pulci», racconta un ragazzo ancora ospite. Le
stanze sono inadatte perché costruite per ospitare alunni, non profughi, né
tantomeno clochard che vivono in strada. «Un contenitore della marginalità
sociale dove sono frequenti le risse: nigeriani contro kosovari, ghanesi contro
marocchini e la lista dei ricoverati in ospedale si allunga ogni giorno»,
racconta chi è entrato tra quelle mura. Anche il personale è ridotto al minimo
con pochi mediatori culturali (che spesso sono ex ospiti che non disdegnano le
maniere forti per mantenere l'ordine), un solo assistente sociale e una
psicologa per dieci ore alla settimana. Troppo poche per chi ha conosciuto gli
orrori della guerra, le botte della polizia libica e porta sulla propria pelle i
segni delle violenze. Anche i disturbi psichici abbondano, insieme all'alcolismo
dilagante. A sette chilometri dai frati, 440 profughi hanno trovato alloggio a
Pieve Emanuele, estrema periferia Sud di Milano. Qui sono stati ospitati nel
residence Ripamonti, di proprietà del gruppo Fondiaria Sai, appena passata sotto
il controllo di Unipol ma all'epoca saldamente in mano a Salvatore Ligresti. I
clienti abituali dell'albergo sono poliziotti, guardie del vicino carcere di
Opera o postini, che non bastano a riempire i 4 mila posti letto dell'albergo.
Grazie all'emergenza però nelle settimane di massimo afflusso sono entrati nelle
casse di Fonsai oltre 600 mila euro al mese. Vacanze forzate in alloggi
confortevoli (le camere sono dotate anche di tivù satellitare) ma dove sono
mancati completamente i corsi per imparare l'italiano o l'assistenza legale e
psicologica. «Si poteva trovare una sistemazione più modesta e investire in
altri sussidi» dice, banalmente, un ragazzo del Ghana. Oggi a Pieve Emanuele
sono rimasti in 80. Ma nel frattempo al residence sono andati quasi sette
milioni di euro. Lo Stato ha speso per l'emergenza 797 milioni di euro nel 2011
e altri 495 milioni nel 2012. Solo una parte è servita per l'accoglienza:
centinaia di milioni di euro sono finiti in tendopoli, spostamenti, trasferte,
rimborsi agli uffici di coordinamento. Fondi di cui si è persa la traccia. E sì
che proprio per il buon uso dei soldi pubblici era stato istituito un "Gruppo di
monitoraggio e assistenza", con il compito di visitare le strutture e segnalare
i casi critici. Ma della task force degli ispettori dopo pochi mesi non si è
saputo più nulla. «Noi facevamo parte del progetto ma da ottobre 2011 non siamo
più stati convocati. Considerando che è partito ad agosto, il gruppo è durato
meno di tre mesi», spiega a "l'Espresso" Laura Boldrini, portavoce dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati: «È mancato completamente il
controllo da parte delle regioni e delle prefetture». La Corte dei conti della
Calabria è andata oltre: ha messo nero su bianco che le convenzioni sottoscritte
nella regione sono illegittime, perché non sono state sottoposte al controllo
preventivo della Corte, obbligatorio anche nell'emergenza. Non solo. I giudici
contabili di Catanzaro definiscono "immotivata" la diaria: 46 euro al giorno
sono troppi. E pensare che in provincia di Latina sono riusciti a intascarseli
quasi tutti spendendo solo 5 euro al giorno, per garantire a 75 profughi un
misero piatto di riso. I cinque avidi gestori della cooperativa Fantasie sono
stati arrestati dai carabinieri di Roccagorna. Insospettiti dall'aumento di
stranieri in paese, i militari sono arrivati ad un casolare dove hanno trovato
46 persone alloggiate in 70 metri quadri. Nonostante il blitz la cooperativa ha
continuato a ricevere i contributi della Regione Lazio per altri sei mesi: una
truffa da 400 mila euro. Con le stesse risorse Aurelio Livraghi, volontario
della Caritas di Magenta, in provincia di Milano, è riuscito a fare tutt'altro.
«Milioni di italiani vivono con 1.200 euro al mese, perché loro no?».
Osservazione semplice. Di un pensionato, che ha dedicato ai 35 profughi arrivati
in paese le sue giornate. Persone oggi indipendenti: pagano un affitto, fanno la
spesa, quattro di loro hanno già un lavoro. Recitano anche in teatro. Una vita
normale: altro che emergenza. E quando finiranno i fondi? «Potranno andare
avanti almeno un po' perché sono riuscito a fargli mettere da parte dei
risparmi». Non era difficile, sarebbe bastato un minimo di organizzazione. E di
umanità.
Mineo, la mangiatoia da duecento milioni. "Creiamo un gruppo e lo
facciamo vincere". La procedura avviata a Ferragosto
invitando pochissime aziende. Per aggiudicarsela c'era bisogno di una cucina da
duemila pasti che aveva solo il consorzio vicino a Odevaine. La gara venne
bandita dall'attuale sottosegretario Ncd Castiglione, allora presidente della
provincia di Catania col Pdl, scrive Alessandra Ziniti su “La Repubblica”.
"A 30 chilometri deve sta da Mineo... e noi quello l'abbiamo messo
praticamente per fargli vincere la gara", dice Luca Odevaine vantandosi di
quella trovata che gli aveva consentito di pretendere dai vincitori un raddoppio
del suo stipendio-tangente: da 10 a 20 mila euro al mese. Una cucina da duemila
pasti entro 30 chilometri dal Cara, una cucina in più, d'emergenza, perché
all'interno del residence degli Aranci dove ha sede il più grande centro
richiedenti asilo d'Europa, una cucina capace di sfornare 4000 pasti caldi due
volte al giorno c'è già. Eccola la "condizione di gara idonea a condizionare la
scelta del contraente", come i pm della Procura di Catania definiscono,
nell'avviso di garanzia inviato al sottosegretario Giuseppe Castiglione e ad
altre cinque persone tra cui Luca Odevaine, consulente del Cara, il "trucco" con
il quale il mega-appalto da cento milioni di euro è stato sempre assegnato
all'unico concorrente in grado di rispondere a tutti i requisiti richiesti. Un
bando che il presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone definisce un "abito
su misura". Al raggruppamento temporaneo d'imprese "Casa della Solidarietà"
(composto dal consorzio Sisifo di Legacoop, Senis Hospes e La Cascina vicine a
Comunione e Liberazione, dal consorzio Sol Calatino e dalla Pizzarotti di Parma
proprietaria del residence) è bastato presentare l'offerta con un ribasso
dell'uno per cento per assicurarsi la continuità in quella gestione che, a forza
di proroghe, ha in mano da settembre 2011 e che, forte dell'appoggio del
prefetto Mario Morcone, ha resistito ostinatamente alla "censura" di Cantone che
ora annuncia l'avvio delle procedure di commissariamento.
Milioni sulla pelle dei rifugiati. Un
dossier segreto commissionato dal Viminale svela il meccanismo attraverso il
quale i soldi del pocket money, destinati agli ospiti dei centri d'accoglienza,
non vengono distribuiti e spariscono nel nulla. La mancata erogazione dei 2,50
euro quotidiani cui ha diritto ogni migrante, nel solo Cara calabrese di Isola
Capo Rizzuto, vale 3.750 euro al giorno che, moltiplicati per i 21 mesi di
permanenza media dei richiedenti asilo, arrivano a superare i due milioni. Se si
considera poi che la distribuzione della quota non avviene in modo regolare
anche in altri centri italiani, le cifre lievitano ulteriormente. Si tratta di
denaro che lo Stato versa agli enti gestori. RE Inchieste è entrata in
possesso del documento che il ministero dell'Interno tiene in un cassetto da
mesi, scrivono Raffaele Cosentino ed Alessandro Mezzaroma su “La Repubblica”.
Illeciti e irregolarità nell'erogazione del "pocket money", la paga giornaliera
ai richiedenti asilo, nell'impiego di mediatori culturali, interpreti e
psicologi. E poi mancato rispetto delle procedure legali da parte di molte
questure, come nel caso di quelle di Roma, Caltanissetta e Crotone che non
rilasciano il permesso di soggiorno per richiesta d'asilo allo scadere dei 35
giorni di permanenza nel centro. E ancora, un quadro impietoso e desolante degli
alloggi in cui i migranti, in particolare i richiedenti asilo, sono costretti a
vivere, da Gorizia a Trapani. È quanto emerge da un rapporto riservato rimasto
nei cassetti, o meglio, nei computer perché si tratta di file Excel, del
ministero dell'Interno, mai reso pubblico, di cui Repubblica.it è entrata
in possesso. Presenza di armi bianche, di scarafaggi nei container, mancanza di
docce e di acqua calda, servizi igienici in comune per uomini e donne, lavandini
otturati, rubinetti e vetri rotti, pulizia scarsa, bambini senza assistenza
pediatrica. Sono alcuni degli esiti di un doppio monitoraggio che le
organizzazioni del progetto Praesidium, l'Organizzazione internazionale per le
migrazioni, l'Unhcr (Alto commissariato Onu per i rifugiati), Save The Children
e la Croce Rossa hanno realizzato nel corso del 2013 su 18 centri italiani, nove
Centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) e nove Centri di
identificazione e di espulsione (Cie), su mandato ispettivo del Viminale.
Migliaia di persone costrette a vivere anche per due anni dentro un Centro di
accoglienza - il tempo effettivo per l'esame della richiesta d'asilo contro i 35
giorni previsti dalla legge - senza poter avere neanche una bacinella e il
sapone per fare il bucato. Perché il capitolato d'appalto del ministero prevede
una serie di servizi come la lavanderia e la barberia, che spesso sono disattesi
dagli enti gestori. Profughi segregati a chilometri di distanza dalle città,
senza mezzi di trasporto, e dunque costretti a fare anche cinque chilometri a
piedi su strade pericolose per raggiungere il primo centro abitato. Giovani
rifugiati che alla fine del lungo periodo passato nei Cara, ne escono senza
possibilità di inclusione sociale perché non hanno neanche imparato l'italiano.
I corsi di lingua, quando ci sono, sono scarsi o mal strutturati. Sotto il
profilo della gestione, merita attenzione quanto è scritto sul centro di
accoglienza di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto, vicino a Crotone, dove gli
operatori del progetto Praesidium presenti all'interno del Cara hanno rilevato
lo scorso settembre che "l'erogazione del pocket money avviene tramite la
distribuzione di due pacchetti di 10 sigarette a settimana. Il migrante non ha
la possibilità di acquistare nessun altro bene né gli viene fornita una
chiavetta elettronica o una carta moneta per poter spendere l'importo rimanente.
Da settembre 2011 a maggio 2013, gli ospiti riferiscono che il buono economico
non è stato erogato". La denuncia dei migranti è stata presa sul serio da chi ha
scritto il rapporto che, nella parte riservata alle raccomandazioni, chiede in
caratteri maiuscoli di "riattivare immediatamente l'erogazione del pocket money"
e di "costituire un sistema informatizzato che permetta di rilevare l'effettiva
tracciabilità dell'erogazione del buono economico". Il pocket money è la quota
di due euro e cinquanta centesimi che spetta al migrante sull'importo
giornaliero pagato per ogni ospite dallo Stato ai gestori del centro. Nel caso
di Isola Capo Rizzuto, la cifra complessiva erogata è pari a circa 21 euro, con
i quali devono essere garantiti tutti i servizi. Il centro ha una capienza
ufficiale di 729 posti, ma come gli altri Cara è solitamente sovraffollato. Al
momento del monitoraggio erano presenti 1497 persone, oltre il doppio dei posti
disponibili. Gli ospiti erano 1600 quando Repubblica ha visitato il Cara
lo scorso 3 settembre (il rapporto porta la data del 25 settembre 2013 ma non è
mai stato reso pubblico). Facendo un calcolo approssimativo di 2,50 euro per una
media di 1500 persone, si arriva alla somma di 3.750 euro al giorno che
moltiplicato per 21 mesi, cioè 630 giorni, fa oltre due milioni di euro. Anche
con un numero di ospiti pari alla capienza, si raggiunge una cifra a sei zeri
che, leggendo questo documento, sembra non sia stata erogata ai suoi legittimi
destinatari, cioè i profughi fuggiti da guerre e persecuzioni ospitati nel Cara
calabrese. Nel rapporto c'è scritto che andrebbe predisposto un paniere di beni
da poter acquistare all'interno del centro o previste soluzioni alternative,
come la possibilità di accumulare l'importo mensile del buono per pagare le
marche da bollo necessarie al rilascio del primo permesso di soggiorno e del
documento di viaggio. Nel file si sottolinea che quando il pocket money è stato
erogato, ai migranti sarebbero stati consegnati solo due pacchetti di sigarette
da 10 a settimana come equivalente di tutto l'importo settimanale pari a 17 euro
e cinquanta centesimi. Il centro è gestito da dieci anni dalla confraternita
della Misericordia fondata dal parroco di Isola Capo Rizzuto, il rosminiano don
Edoardo Scordio, e dal suo uomo di fiducia Leonardo Sacco, attuale
vicepresidente delle Misericordie d'Italia. L'ultima gara d'appalto triennale
vinta dalle Misericordie (nel 2012 contratto valido fino al 2015) è stata di
28.021.050 euro iva esclusa. Nello stesso periodo in cui le organizzazioni di
Praesidium realizzavano il rapporto, Repubblica aveva chiesto al
direttore del Cara, Francesco Tipaldi, come venisse distribuito il pocket money.
"Diamo l'equivalente dei 2 euro e cinquanta centesimi giornalieri in beni", è
stata la risposta. "Dividiamo i 1600 ospiti in diversi giorni per poter accedere
al pocket money, non lo diamo con cadenza quotidiana perché questa attività
durerebbe 24 ore, ma lo suddividiamo in maniera settimanale". I disservizi
riscontrati nel centro crotonese sono anche altri. "La distribuzione dei beni
consumabili avviene ogni 20-30 giorni circa, fatto salvo per i nuclei
familiari", si legge nel rapporto. "Il personale del servizio socio-psicologico
non sembra essere proporzionale al numero degli ospiti presenti nel centro: ci
sono tre psicologhe per circa 1400 ospiti. Il servizio di mediazione culturale
non garantisce la copertura delle principali lingue parlate dagli ospiti
presenti nel centro. Ad esempio non vi sono mediatori per gli ospiti provenienti
dalla Somalia e dal Bangladesh. L'ente gestore ha fornito un organigramma
assolutamente inadeguato perché troppo generico". Ma sono state riscontrate
anche carenze sanitarie: "Non è garantita l'assistenza pediatrica ed è difficile
eseguire vaccinazioni; le condizioni dei servizi igienici del centro
d'accoglienza sono assolutamente inadeguate a causa della mancanza di pulizia e
del danneggiamento dei sanitari". Infine, gli alloggi nei container
sovraffollati e l'impianto di condizionamento non funziona. Il rapporto
evidenzia problemi nella gestione del pocket money anche nel Cara di Restinco, a
Brindisi, gestito dal consorzio Connecting People di Castelvetrano. I vertici
del Consorzio sono stati coinvolti in un'inchiesta della magistratura su fatture
gonfiate in un altro Cara, quello di Gradisca d'Isonzo. Tredici i rinviati a
giudizio dal tribunale di Gorizia, di cui 11 del consorzio trapanese, fra cui
Giuseppe Scozzari, ex presidente del consiglio di amministrazione, per
associazione per delinquere, truffa e frode in pubbliche forniture, e due
funzionari della prefettura tra cui un vice prefetto, per falso in atti
pubblici. Il consorzio si è difeso affermando che esiste una relazione della
prefettura di Gorizia che attesta la correttezza delle fatturazioni. L'inizio
del processo è previsto per giugno. A Restinco, rileva il dossier, "l'ammontare
giornaliero di 2,50 euro del pocket money può essere speso dagli ospiti
nell'acquisto di beni presenti al corner shop o nell'acquisto di
bibite/snack/bevande calde nei distributori automatici presenti nel centro. Gli
ospiti non possono accumulare l'importo giornaliero del pocket money e devono
consumarlo nel giro di due giorni, pena la cancellazione dell'importo residuo
non speso". Non è specificato però che fine fanno le somme cancellate. Nel Cara
brindisino: "Non sono presenti mediatori che coprano tutte le lingue parlate
dagli ospiti. L'ente gestore non organizza nessuna attività ludico-ricreativa ad
eccezione di partite di calcio. L'ambulatorio medico del centro presenta gravi
condizioni di precarietà igienica". A Bari, in un centro che ospita 1400
richiedenti asilo, pari al doppio della capienza, gestito dalla cooperativa
Auxilium "è stata riscontrata la presenza di scarafaggi in tutti i moduli
visitati" e anche qui "l'ente gestore non organizza nessuna attività
ludico-ricreativa ad eccezione di partite di calcio. L'attesa per l'inserimento
dei migranti nei corsi è molto lunga e la durata degli stessi è scarsa". Nel
cara di Borgo Mezzanone (Fg) gestito in quel momento dalla Croce Rossa, è stata
rilevata "insicurezza per la presenza di ospiti senza titolo e il possesso di
armi rudimentali quali coltelli da cucina e barre in legno o ferro". I migranti
hanno riferito che gli alloggi non vengono mai puliti e l'igiene è
insufficiente. Non c'è il servizio di lavanderia e non vengono distribuite
bacinelle né stenditoi. Anche a Gradisca d'Isonzo, nel centro ancora gestito da
Connecting People, "le condizioni igieniche dei servizi igienico sanitari sono
piuttosto scarse. La qualità dei vestiti forniti è molto bassa e il cambio di
vestiario avviene ogni 3 mesi. L'ente gestore ha attivato un corso di lingua
italiana solo qualche settimana prima della visita di monitoraggio. Il corso
risulta, però, inadeguato poiché i posti disponibili sono pochi e i tempi di
attesa per l'acceso troppo lunghi (anche fino a due mesi)". A Caltanissetta, un
Cara da 500 persone è fatto di container vecchi "in cattivo stato, e in
condizione di evidente sovraffollamento", con i bagni in condizioni igieniche
"estremamente carenti, soprattutto a causa della ruggine e dell'allagamento
continuo del pavimento provocato dalle frequenti otturazioni dei lavandini che
vengono condivisi da un elevato numero di persone". A questo contribuisce la
mancanza di un servizio di lavanderia, per cui "gli ospiti lavano i vestiti nei
lavabi dei bagni, con lo stesso sapone che usano per l'igiene personale". L'ente
gestore era in quel momento la cooperativa Albatros (a cui è poi subentrata
Auxilium dal primo ottobre) che "si è rifiutata di fornire l'organigramma
dettagliato del personale". Ma, secondo il documento, "i servizi di supporto
socio-psicologico e legale sono apparsi insufficienti per il numero complessivo
di stranieri presenti. I corsi di lingua italiana vengono erogati dai mediatori
culturali e non da personale qualificato. Nessuno degli ospiti intervistati era
in grado di parlare la lingua italiana nonostante fossero ospiti del centro già
da diversi mesi". Inoltre, "i migranti intervistati hanno riferito di non aver
ricevuto tutti i beni che spettavano loro e che gli asciugamani non sono mai
stati sostituiti durante tutta la loro permanenza al Cara". Il monitoraggio
evidenzia anche alcuni elementi positivi che sono un po' ovunque la buona
disponibilità degli operatori, l'adeguatezza dei pasti e l'iscrizione a scuola
dei bambini.
Quelle regole non applicate su cui adesso il Viminale deve fare
luce. Secondo il capitolato d'appalto dei Centri
dell'immigrazione, pubblicato sul sito del ministero dell'Interno, dovrebbero
essere le prefetture a controllare che i contratti stipulati con gli enti
gestori vengano rispettati. Dai file, però, emergono irregolarità gestionali e
procedurali, oltre che strutture fatiscenti. Ne sono responsabili, nell'ordine:
le cooperative che sono gli enti gestori, le questure e il Viminale. Le
organizzazioni che hanno monitorato i centri non hanno diffuso pubblicamente
queste informazioni. Si tratta comunque di realtà che operano con il ministero
dell'Interno. Nel caso della Croce Rossa che ha ispezionato l'ambito sanitario,
c'è anche un conflitto di interessi, essendo la Cri a sua volta gestore di
diversi centri nel momento in cui è stato realizzato il dossier, come i Cie di
Torino e di Milano e il Cara di Foggia. Alla luce di tutto questo restano alcune
domande. Sono passati sette mesi da quando il Viminale ha avuto i risultati del
monitoraggio realizzato con l'uso di soldi pubblici: perché i risultati non sono
stati pubblicati? Quali misure intende utilizzare per migliorare l'accoglienza?
Sempre secondo il capitolato d'appalto, gli enti gestori devono garantire i
servizi di barberia e lavanderia, una dotazione minima di personale per
l'assistenza 24 ore su 24 e figure professionali adeguate al relativo compito. I
kit igienici forniti agli ospiti (sapone, shampoo, dentifricio) devono essere
costantemente sostituiti sulla base di una dose monouso giornaliera. I
disservizi per "mancata o inesatta esecuzione dei servizi presenti nel
contratto", rilevati in sede ispettiva, di controllo e di monitoraggio o
lamentati dagli utenti con riscontri fondati, devono portare a una penale di
almeno il 3% del corrispettivo mensile ma è prevista anche la possibilità di un
risarcimento dei danni più alto. È stata mai applicata questa norma del
contratto d'appalto? E se non lo è stata, quale è il motivo? Infine, i soldi del
pocket money, che nel solo Cara di Isola Capo Rizzuto ammontano a due milioni di
euro, stanziati dallo Stato e non erogati a chi ne aveva diritto, dove sono
finiti?
Sulla pelle dei rifugiati bambini.
Garantire un alloggio ai minori che sbarcano in Italia senza genitori, così come
a quelli che vengono sottratti alle famiglie, costa alle casse pubbliche oltre
30 milioni di euro l'anno. Una massa di denaro che ha messo in moto vasti
appetiti criminali: dal giro delle solite coop legate ai boss di Mafia Capitale
agli intermediari senza scrupoli che spacciano per ragazzini giovani di oltre 30
anni. E destano dubbi anche alcune sentenze di affidamento al centro di una
guerra legale con il governo dell'Ecuador. L'Inchiesta di “La Repubblica”.
Decine di milioni che fanno gola a molti,
scrivono Daniele Autieri e Roberta Rei. Al mercato delle anime battezzato da
Mafia Capitale con i centri di accoglienza, c'è una merce che vale più delle
altre: gli immigrati minorenni. Nel 2014 i comuni italiani hanno dato alloggio a
10.536 stranieri under 18, un esercito di solitudini accolto da poche centinaia
di associazioni e cooperative e trasformato, in molti casi, in una cambiale da
riscuotere. L'articolo 403 del codice civile prevede infatti che i Msna (minori
stranieri non accompagnati) debbano essere accolti ed economicamente sostenuti
dal sindaco del Comune in cui vengono identificati. Ed è nelle pieghe della
legge che si addensano le vischiosità di un sistema che drena denari pubblici
senza un reale controllo. Ad esclusivo vantaggio dei protagonisti delle
inchieste giudiziarie degli ultimi mesi, dalle cooperative di Mafia Capitale
alle associazioni vicine a Comunione&Liberazione. Tutti pronti a reclamare una
fetta del ricco business dei minori. Fare affari con i rifugiati bambini. Il
sistema, prima di tutto. A spiegare come funziona è una qualificata fonte delle
forze di polizia. "Quando i minori stranieri arrivano, i dirigenti del
dipartimento politiche sociali di un qualsiasi comune italiano contattano le
cooperative con cui collaborano. L'affare è grosso e queste si organizzano. Se
non hanno alloggi li trovano in una notte: acquistano villette, affittano,
chiedono palazzetti in prestito a costruttori amici. Pochi giorni dopo la
macchina è pronta ad accogliere i ragazzi". Un banchetto ricco, distribuito
lungo un tavolo dove c'è spazio per tutti. Nell'inchiesta Mafia Capitale le
cimici del Ros dei carabinieri intercettano una conversazione tra Tiziano
Zuccolo, consigliere e vice presidente della cooperativa Domus Caritatis, e
Salvatore Buzzi, l'uomo della "29 Giugno" sodale di Massimo Carminati. "Eh bravo
- dice Zuccolo - l'accordo è al cinquanta per cento, dividiamo da bravi
fratelli". Lo spirito ecumenico è condensato in poche parole che spiegano come i
protagonisti del sistema si preparino a spartirsi i rifugiati siriani in arrivo
a Roma. Intervenendo sulle generalità anagrafiche dei soggetti coinvolti, il
palcoscenico cambia, ma gli attori restano gli stessi e il copione scritto per i
rifugiati viene replicato tale e quale con i minorenni. La cooperativa Osa Mayor
è sconosciuta ai più, eppure analizzando i suoi bilanci si scopre che la sede è
nello stesso stabile della Domus Caritatis e che a dirigerla c'è ancora una
volta lui, Tiziano Zuccolo. La Domus Caritatis non è roba da poco. Fattura 36
milioni di euro, ha 15 milioni di debiti accumulati verso i fornitori e al 31
dicembre del 2013 vantava partecipazioni nel Cara di Mineo e nella Cascina, il
colosso della ristorazione vicino a Comunione&Liberazione. Dalle carte
dell'inchiesta di Firenze sulle grandi opere che ha portato in cella Ercole
Incalza, emergono alcuni pagamenti per prestazioni poco chiare fatti dalla Domus
Caritatis alla Capa srl di Francesco Cavallo, il faccendiere legatissimo
all'ex-ministro Maurizio Lupi. Del resto, gli interessi del gruppo spaziano un
po' dappertutto, e arrivano fino alla Osa Mayor, la piccola cooperativa che
ottiene dal dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma il compito di
accogliere circa 60 stranieri, tutte famiglie con minori al seguito. Gli ospiti
vengono alloggiati in un villino alle porte di Roma, in via Casal Morena. Per
loro il Campidoglio paga la retta completa, ma cosa offre in cambio la Osa
Mayor? Una cucina di fortuna allestita nel garage con un forno a microonde,
impianti non a norma, letti accatastati, mancato rispetto delle normative
antincendio e soprattutto continua a dichiarare la presenza di tutti gli ospiti
anche quando parte di loro ha lasciato la casa. Nessuno controlla. Il Comune
paga. E la cooperativa si arricchisce. La vicenda è un puntino rispetto al
grande mare dei 10.536 minori stranieri che nel corso del 2014 sono arrivati in
Italia. Il loro peso economico grava soprattutto sulle casse degli enti locali.
Lo scorso anno il ministero del Lavoro ha stanziato appena 14,8 milioni di euro
per sostenere i comuni, mentre la fetta più grossa esce direttamente dalle casse
degli enti locali. I trasferimenti statali sono stati effettuati sui conti di
Tesoreria comunale, ma solo 4 amministrazioni hanno presentato i certificati di
corretto utilizzo del contributo pubblico, per un valore irrisorio di 21.240
euro. Al 31 dicembre del 2014 non vi era ancora traccia di come i restanti 313
comuni abbiano usato gli altri 14,7 milioni. E in questa confusione, non sempre
casuale, i mercanti di bambini si sono organizzati e hanno messo in piedi il
business più redditizio. Non solo rifugiati. L'altra faccia del dramma minorile
non riguarda ragazzi soli, ma famiglie comuni. Il tema è molto delicato ed è
stato più volte denunciato perché tocca il sistema tradizionale degli
affidamenti: un assistente sociale dichiara che il nucleo familiare non è sicuro
per il bambino e questo viene immediatamente assegnato alle cure di una casa
famiglia. A quel punto interviene il tribunale minorile che conferma l'affido e
ne stabilisce la durata. Statistiche ufficiali non esistono, ma gli organi
impegnati nel settore parlano di 30.000 minori in Italia. La macchina è
complessa e, a fronte di tantissimi casi virtuosi, permangono alcuni elementi di
criticità che arrivano a coinvolgere anche alcuni giudici onorari dei tribunali
minorili. Secondo "Finalmente Liberi", l'associazione legata a Federcontribuenti
che monitora il fenomeno, circa 200 sui 1.082 giudici onorari italiani avrebbero
maturato conflitti d'interesse rispetto alla circolare del Csm che ne individua
le incompatibilità, ottenendo incarichi personali dalle case famiglia mentre
svolgono la loro attività all'interno dei tribunali minorili. Le inefficienze
del sistema sono tali che alcuni Stati stranieri hanno avviato contenziosi
legali per tutelare legalmente i cittadini stranieri residenti nel nostro Paese.
È quanto ha fatto la Repubblica dell'Ecuador. "L'indicazione di avviare cause
contro il sistema italiano degli affidi - spiega l'ambasciatore dell'Ecuador a
Roma, Juan F. Holguìn - arriva direttamente dal Presidente della Repubblica,
che segue questa vicenda in prima persona. Sono moltissimi i bambini della
nostra comunità presente in Italia che vengono tolti alle loro famiglie. E a
nostro parere questo avviene ingiustamente. Abbiamo quindi costituito un'equipe
legale e avviato una serie di cause. Ad oggi, grazie alla nostra assistenza
legale, già 10 bambini sono tornati dalle loro madri".
Il muro del pianto dei ragazzi di Termini,
continuano Autieri e Rei. Stazione Termini: una ragnatela ferroviaria
attraversata da 480.000 persone al giorno, 150 milioni l'anno. Molte di esse
costeggiano via Giolitti, il bordo multietnico che confina con l'Esquilino.
Passano e non si fermano. Sul muro di marmo che fa da argine alla scalinata del
sottopassaggio un gruppo di ragazzi egiziani attende. Sono tutti minorenni.
Passa qualche minuto, e un uomo di mezza età si avvicina. Ne abborda uno. Poche
parole, una veloce trattativa e spariscono insieme sotto le scale. A volte il
cliente arriva in macchina, carica il prescelto e lo riconsegna al "muro del
pianto" solo di sera, dopo averlo portato a casa e avergli offerto un pasto
caldo. Lui, come tutti gli altri, non è un clandestino. Anzi. Si prostituisce
per mandare i soldi alla famiglia d'origine e quando arriva la sera torna alle
cooperative dove il Comune di Roma lo ha alloggiato. Chi ha potuto parlare e
passare del tempo con questi ragazzi racconta chi li ospita: "Sono sempre i
soliti - confessa - Istituto Sacra Famiglia, Eriches (controllata dalla "29
Giugno" di Buzzi), Domus Caritatis, Riserva Nuova di Morena, Best House, Eta
Beta. Alveari che in passato sono stati capaci di ammassare anche 100 ragazzi. E
per ognuno di loro il Comune di Roma può arrivare a sborsare fino a 100 euro al
giorno". Molti dei giovani di Termini vengono dal Car, il Centro agrolimentare
di Guidonia dove hanno lavorato per mesi con paghe da fame. In quell'occasione
il giro d'affari venne svelato da un'indagine del Corpo di Polizia di Roma
Capitale guidato dal vice comandante Antonio Di Maggio (e rivelata da
"REInchieste"). Anche allora, quando gli agenti della Polizia Municipale si
imbatterono nel fenomeno, scoprirono che molti giovani egiziani impegnati nel
lavoro nero erano affidati a case famiglia. All'interno di un'informativa
riservata depositata in Procura si legge che le associazioni dove i ragazzi del
Car alloggiavano erano l'Istituto Sacra Famiglia, la Eriches, la Domus Caritatis
e la Virtus Italia.
Barba e capelli per sembrare più giovani,
continuano Autieri e Rei. La storia di Ullah è molto simile a quella delle
centinaia dei falsi minorenni alloggiati in case famiglia che, nel corso del
2013, sono stati smascherati dagli uomini della Polizia di Roma Capitale. Una
volta arrivati in città i ragazzi finivano in una rete criminale che prima
interveniva sul look (barbe tagliate, capelli tinti, ecc.), poi li indirizzava
ad alcuni uffici comunali o ai commissariati del centro storico spiegandogli
come denunciare la minore età e assicurarsi così l'alloggio nelle comunità
pagate dal Campidoglio. Ullah, a differenza di molti altri, ha deciso di
collaborare con la giustizia e testimoniare contro i criminali che lo avevano
inserito nel giro. "Mi hanno abbordato sulla linea A della metropolitana -
ricorda - e mi hanno portato a casa loro. Ho dormito lì per 8 giorni, poi mi
hanno spiegato come avrei potuto ottenere il permesso di soggiorno". I
trafficanti gli tolgono il passaporto e in cambio gli danno un falso
certificato, rilasciato da un ospedale romano, che indica la minore età. "Mi
hanno accompagnato fino alla questura - prosegue Ullah - dicendomi come avrei
dovuto fare. Lì sono stato riconosciuto minorenne e spedito in una casa famiglia
a Morena". Un mese dopo, quando i Vigili fanno irruzione nella casa del
trafficante, scoprono decine di documenti falsi che dimostrano l'esistenza di un
vero e proprio business dei falsi minorenni. Da quel momento Ullah collabora con
la giustizia, ma due anni dopo attende ancora che la procura di Civitavecchia e
l'ufficio immigrazione del ministero gli rinnovino il permesso di soggiorno.
Come lui, tanti altri immigrati sono finiti nel giro. E oggi sono diverse le
inchieste aperte su un fenomeno tutt'altro che superato. La novità è che, per la
prima volta, al centro di alcune indagini è finito il presunto scambio
affaristico tra le organizzazioni che garantiscono la "materia prima" e alcune
cooperative conniventi. Un patto criminale, siglato in nome del denaro.
E per chi fa qualcosa arriva il taglio dei soldi,
scrivono Monica D'Ambrosio ed Anna Di Russo. Il Sacrai è uno di quei posti dove
ogni giorno neuropsichiatri e psicologi infantili seguono minori abusatori e
abusati per sottrarli al carcere o alle case famiglia. Eppure le attività del
centro, che opera all’interno dell’Università la Sapienza di Roma, hanno
rischiato di concludersi insieme ai fondi governativi stanziati a favore di
progetti pilota per minori svantaggiati. Con la grave conseguenza che
l’interruzione della terapia vanificasse il lavoro fatto fin lì e aggravasse le
condizioni dei minori presi in cura. Ora, dopo mesi d’incertezza, proprio il
Sacrai è l’unico centro ad aver ottenuto un rifinanziamento (100mila euro)
grazie ad un emendamento all’articolo 7 del Milleproproghe firmato dall’ex
ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna. Ma il principio al momento
sembra valere solo per il centro universitario. Non per le altre 26 strutture,
anch’esse finanziate dalle Pari Opportunità, che a ottobre 2014 hanno esaurito
la copertura economica. Eppure tutti i 27 destinatari dei fondi hanno fornito
con il loro lavoro la risposta italiana alla convenzione di Lanzarote e al
richiamo dell’Europa che sollecitava gli Stati membri a fare di più per
l’infanzia e l’adolescenza. “L’Europa - precisa Vincenzo Spadafora, Garante per
l’infanzia - ha fissato degli obiettivi economici che dobbiamo perseguire:
l’Italia ha precisi obblighi anche riguardo ai piani per l’infanzia e
l’adolescenza”. “Sottovalutare i traumi subiti dai minori – aggiunge – è un
grave errore anche in termini di spesa pubblica. In Italia il costo sociale
complessivo del maltrattamento è di circa 13 miliardi di euro, con un’incidenza
annuale in incremento di nuovi casi pari a 910 milioni”. Eppure quanto un
servizio psicologico integrato e multidisciplinare può fare per enti locali e
aziende sanitarie lo ha dimostrato il centro Vatma in Molise, che non solo ha
limitato l’ingresso di alcuni minori in case famiglie o in altre strutture ad
hoc, con un risparmio di oltre 30mila euro all’anno a bambino (circa 85 euro al
giorno), ma ha anche tagliato tutti quei costi diretti che gli enti locali
devono sostenere. Pochi, confusi e spesi male. I finanziamenti per l’infanzia e
l’adolescenza esistono, ma per capirci qualcosa bisogna districarsi tra una
serie di fondi statali, regionali ed europei che non sempre vengono destinati
davvero ai minori. Perché oltre a non esserci un monitoraggio a livello
istituzionale, non esiste neanche una programmazione chiara e una visione di
lungo periodo sull’utilizzo di queste risorse. Così, oltre ai tagli – il Fondo
nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza dal 2001 al 2015 ha perso oltre il 43%
dei finanziamenti, mentre non si riesce a quantificare quanto del Fondo per le
politiche sociali sia stato dedicato ai minori – molte regioni, in particolare
al sud, hanno difficoltà a programmare e spendere i soldi disponibili. La
Campania, ad esempio, non ha ancora programmato, richiesto e utilizzato le
risorse statali del 2009, 2010 e 2011, per un totale di oltre 34 milioni di
euro. Eppure oggi la copertura dei suoi servizi regionali non raggiunge il 3%.
Va meglio invece con i fondi europei con 227 milioni di euro (Fondo di aiuti
agli indigenti 2014-2020) che nei prossimi anni saranno utilizzati per
assicurare materiale scolastico e accesso gratuito alla mensa a bambini e
adolescenti in condizioni di povertà e all’apertura pomeridiana delle scuole in
contesti deprivati.
Dal ministero delle Pari Opportunità riceviamo e pubblichiamo
.Sostegno ai minori, la precisazione del governo: Gentile Direttore,
nell'articolo pubblicato sul vostro sito dal titolo "E per chi fa qualcosa
arrivo il taglio dei soldi", a firma Monica D'Ambrosio e Anna Di Russo,
nell'ambito di una inchiesta sui bambini rifugiati, appaiono alcune inesattezza
circa il ruolo del Dipartimento delle Pari Opportunità e delle decisioni che è
chiamato ad adottare, colgo dunque l'occasione per fare chiarezza sull'intera
questione. Gli autori dell'articolo sostengono che dei 27 progetti pilota -
finanziati con Avviso pubblico n.1/2011 per la concessione di contributi per il
sostegno a progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e
sfruttamento sessuale - soltanto uno ha avuto la proroga dei fondi scaduti a
fine 2014, il Sacrai, che opera all'interno dell'Università la Sapienza di Roma.
E' vero, ma questo non per decisione del Dipartimento, quanto piuttosto, come
riportato nell'articolo, grazie ad un emendamento all'articolo 7 del
Milleproroghe, firmato dall'ex ministra Mara Carfagna. Senza mettere in dubbio
il lavoro svolto da Sacrai, va sottolineato che con quell'emendamento,
presentato per un'unica struttura, di fatto non si è provveduto ad un
intervento sistemico nei confronti di tutte le strutture coinvolte nei progetti
pilota i cui finanziamenti erano relativi a 18 mesi di attività. Ecco perché il
Dipartimento, che a questo fine dispone di propri fondi, ha avviato un
monitoraggio per individuare quanti sono i minori attualmente in carico alla
varie strutture e di conseguenza formulare un piano di finanziamento ad hoc per
i progetti sperimentali ancora attivi. Occorre, però, precisare che la presa
in carico di minori non è tra le competenze di questo Dipartimento, a cui spetta
la prevenzione del fenomeno e quindi a tal fine, per gli interventi strutturali
e i relativi fondi, sono altri soggetti istituzionali a doversene fare carico,
come prevede la legge. Ancora qualche precisazione: l'avviso pubblico da cui
nascono i progetti pilota ha avuto come obiettivo strategico quello di
promuovere interventi sperimentali e innovativi a favore dei minori vittime di
abuso e sfruttamento sessuale caratterizzati dalla capacità di raccordare tutte
le risorse operative e istituzionali del sistema locale. Ma il nostro impegno è
mirato anche all'individuazione di livelli minimi di assistenza che siano
applicabili e applicati su tutto il territorio nazionale sopperendo a quella
disomogeneità che ancora purtroppo persiste. L'esperienza delle strutture
impegnate nel progetto pilota, è dunque diventata una base conoscitiva anche
per la redazione di apposite linee guida, come previsto dal III Piano biennale
nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei
soggetti in età evolutiva per l'individuazione delle quali è stata attivata
un'azione di monitoraggio, in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di
Firenze, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio il servizio delle
attività a tale scopo finalizzate. Ma il Dipartimento sull'intera materia ha
inteso superare la logica emergenziale, mettendo a punto politiche in grado di
contrastare su più fronti il fenomeno. Due gli strumenti a cui si sta
lavorando: il Piano nazionale di contrasto alla tratta e al grave sfruttamento
(dove si dedica grande attenzione al fenomeno dei minori non accompagnati che
molto spesso finiscono nelle mani di organizzazioni criminali per essere poi
destinati al mercato del sesso a pagamento e alla segregazione) e il Piano
nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale
dei minori. Entro il prossimo 9 giugno, a tal riguardo, si concluderà il giro di
consultazioni che il Dipartimento ha avviato non solo con i soggetti
istituzionali coinvolti nella materia ma anche e soprattutto con le associazioni
del settore in vista della stesura finale del Piano antipedofilia nel quale è
previsto un rafforzamento del ruolo di coordinamento unico in capo al
Dipartimento stesso al fine di evitare sovrapposizioni e spacchettamenti di
deleghe. Il nostro obiettivo finale è quello di mettere a sistema misure e
interventi multi-livello e multi-agenzia in grado di rendere efficaci le azioni
programmate e di raccordare l'operato di tutti i soggetti e gli enti coinvolti
nel contrasto di tali fenomeni garantendo un servizio omogeneo sull'intero
territorio nazionale. Uno degli strumenti individuati nel Piano antipedofilia
è quello di centri pilota regionali per la cura e la presa in carico di minori
autori e vittime di abusi valorizzando il ruolo e il lavoro delle ong e delle
associazioni di settore. Altro strumento fondamentale sarà un monitoraggio
costante di tutta la fase di attuazione degli interventi perché qualunque legge
o progetto deve poi poter essere valutato alla luce dei risultati che
effettivamente produce in ogni suo aspetto. Lo sfruttamento e l'abuso dei minori
sono gravi violazione dei diritti dell'infanzia, una vera e propria forma di
schiavitù che va combattuta su più fronti, un fenomeno che si alimenta sia
dentro circoscritti ambiti sociali (rapporti famigliari, scolastici, amicali)
sia in ambito sovranazionale (pedopornografia, pedofilia, turismo sessuale,
tratta di esseri umani). Come risulta dai dati della Campagna del Consiglio
d'Europa contro la violenza sessuale nei confronti dei bambini, in Europa il
fenomeno riguarda quasi un minore su cinque che almeno una volta nell'infanzia
subisce abusi sessuali: vittime sono i minori di entrambi i sessi anche se la
maggioranza sono bambine, di ogni età con percentuali più alte a partire dalla
pre-adolescenza e non ci sono particolari differenze tra etnie. L'articolazione
e la dimensione stessa del fenomeno indicano la complessità degli interventi
necessari, il Dipartimento sta facendo la sua parte e lo sta facendo nel
rispetto della normativa nazionale ed europea, ma soprattutto garantendo in ogni
passaggio la trasparenza e il rigore a cui è chiamata ogni azione della Pubblica
amministrazione. Distinti saluti. Giovanna Martelli, consigliera del Presidente
del Consiglio per le Pari Opportunità.
"Gli immigrati rendono più della droga". La mafia nera nel
business accoglienza. Così i fascio-mafiosi di Massimo
Carminati si sarebbero spartiti secondo i Pm i soldi per i richiedenti asilo.
Milioni di euro. Senza controlli, grazie alla logica dell'emergenza. E a
rapporti privilegiati con le autorità. La parte delle indagini che riguarda il
consorzio Eriches e Salvatore Buzzi, scrive Francesca Sironi su “L’Espresso”.
Uno sbarco a Brindisi«Rendono più della droga». Per la mafia nera che comandava
su Roma gli immigrati erano un business favoloso. Messi da parte gli ideali
politici, la banda fascista che rispondeva agli ordini di Massimo Carminati,
arrestato questa mattina insieme ad altre 36 persone, aveva trovato
nell'accoglienza dei profughi l'occasione per intascare milioni. Il regista
dell'operazione è Salvatore Buzzi, anche lui finito in carcere.
L'idea di trasformare il sociale in un business gli è venuta negli anni '80
proprio in prigione, mentre scontava una pena per omicidio doloso. Oggi come
presidente del consorzio di cooperative Eriches guidava un
gruppo capace di chiudere il bilancio 2013 con 53 milioni di euro di fatturato.
Gli incassi arrivano da servizi per rifugiati e senza fissa dimora, oltre che da
lavori di portineria, manutenzione del verde e gestione dei rifiuti per la
Capitale. Un colosso nel terzo settore. Che secondo gli atti delle indagini
rispondeva agli interessi strategici del “Nero” di Romanzo
Criminale. Buzzi infatti, secondo i pm, sarebbe «un organo apicale della mafia
capitale», rappresentante dello «strumento imprenditoriale attraverso cui viene
realizzata l'attività economica del sodalizio in rapporto con la pubblica
amministrazione». I documenti dell'operazione che ha portato in carcere
referenti politici e operativi della mafia fascista svelata da Lirio Abbate su “
l'Espresso ” in numerose inchieste, mostrano nuovi dettagli sull'attività della
ramificazione nera di Roma. A partire appunto dall'attività per gli stranieri in
fuga da guerra e povertà. «Tu c'hai idea quanto ce guadagno sugli
immigrati?», dice Buzzi al telefono in un'intercettazione: «Non c'ho
idea», risponde l'interlocutrice. «Il traffico di droga rende di meno»,
spiega lui. E in un'altra conversazione aggiunge: «Noi quest’anno abbiamo chiuso
con quaranta milioni di fatturato ma tutti i soldi, gli utili li abbiamo fatti
sui zingari, sull’emergenza alloggiativa e sugli immigrati, tutti gli altri
settori finiscono a zero». "Tu sai quanto ci guadagno sugli immigrati? C'hai
idea? Il traffico di droga rende meno", così al telefono Salvatore Buzzi,
braccio destro imprenditoriale di Massimo Carminati. Più chiaro di così. Il suo
consorzio, Eriches, dentro cui si trova anche la "Cooperativa sociale 29
giugno", nel 2011 riesce ad entrare a pieno titolo nella gestione dell'Emergenza
Nord Africa: un fiume di soldi (1 miliardo e 300 milioni) gestiti a
livello nazionale dalla Protezione Civile e dalle prefetture per l'accoglienza
straordinaria delle persone in fuga dalla guerra in Libia e dalle rivolte della
Primavera Araba. È in quel periodo che le cooperative di Buzzi, nate come
progetto durante la sua permanenza in carcere negli anni '80, arrivano a
fatturare oltre 16 milioni di euro solo con l'accoglienza degli stranieri.
Business che continueranno a seguire. Anche che sono proseguiti fino ad oggi con
la marea umana di Mare Nostrum. Per ottenere immigrati da ospitare, intascando
rimborsi che vanno dai 30 ai 45 euro al giorno a persona, Buzzi s'impone nelle
trattative. E può contare, stando alle indagini, su referenti di primo piano.
Come Luca Odevaine, presidente di Fondazione IntegrAzione ed ex
vice capo di Gabinetto di Walter Veltroni al comune di Roma. In
qualità di rappresentanza dell'Upi, l'unione delle province italiane, Odevaine
seide al “Tavolo di coordinamento nazionale sull'accoglienza”, da cui, spiega in
diversi incontri con Buzzi e i suoi colleghi, può «orientare i flussi
che arrivano», favorendo le cooperative amiche, perché ricevano più
immigrati e quindi più soldi dallo Stato. In un'altra intercettazione sostiene
di poter controllare le decisioni del prefetto Rosetta Scotto Lavina «che è in
difficoltà, ha troppi sbarchi, non sa dove mettere le persone», e per questo lui
può aiutarla indicandole a chi affidare i fondi. Per questa attenzione, spiega
Buzzi in una serie di intercettazioni riportate negli atti, Odevaine avrebbe
ricevuto dal clan di Carminati uno stipendio da 5mila euro al mese.
Ma non era l'unico riferimento politico del consorzio. Anche l'assessore alle
politiche sociali Angelo Scozzafava in una telefonata assicura:
«su Roma quanti posti c'hai? Perché me sa che sta per arrivà l'ondata...». Per
controllare l'accoglienza degli stranieri, Buzzi avrebbe avuto un accordo «al
50/50», ovvero per dividersi a metà tutti gli appalti, con la rete dell'Arciconfraternita
del Santissimo Sacramento e di San Trifone, network di coop cattoliche in cui
rientra anche Domus Caritatis, la cooperativa di cui “
l'Espresso ” aveva raccontato le politiche spregiudicate durante l'Emergenza
Nord Africa del 2012, quando barboni e adulti furono fatti passare per minorenni
pur di ottenere rimborsi duplicati dal ministero (malagestione denunciata da
Save The Children e dal Garante per l'Infanzia). Stando agli atti dei Pm,
l'accordo per la spartizione del business dei profughi sarebbe stato sancito con
Tiziano Zuccolo, rappresentante della rete
dell'Arciconfraternita, con cui ancora nel maggio del 2013 Buzzi parlava del
“Patto” in riferimento all'arrivo dei siriani scappati dalla guerra. «Va be’, a
Salvato’, noi l’accordo, l’accordo è quello al cinquanta, no?», chiedeva
Zuccolo, e Buzzi confermava: «Ok, io sto premendo per riceverne altri 140» e
Zuccolo ribadiva: «Eh, bravo, l’accordo è al cinquanta per cento,
dividiamo da buoni fratelli, ok?» Grazie a queste poltiche la holding
dominata da Buzzi, che condivideva tutte le scelte, secondo le indagini, con il
boss Carminati, è riuscito a ricevere anche fondi europei. Nel
2011 ad esempio ha avuto dal Fondo Europeo per i Rifugiati ben
234mila e 400 euro, di cui 130 direttamente da Bruxelles e gli altri dallo
Stato. Nel 2012 le cooperative che rispondevano alla “mafia capitale” hanno
assistito 1320 famiglie per conto del Comune di Roma nell'ambito di un'altra
emergenza, quella abitativa. Ma è stato il 2013 l'anno migliore per il consorzio
Eriches, come si legge nel bilancio, chiuso con un margine
netto di quasi tre milioni di euro. «Nell’ambito dell’accoglienza, siamo
cresciuti ed abbiamo continuato la gestione delle attività assistenziali in
favore di immigrati, senza fissa dimora, mamme con bambini, ex detenuti, nomadi
e famiglie in difficoltà», spiega il presidente, Salvatore Buzzi: «e abbiamo
vinto il bando promosso da Roma Capitale per 491 immigrati
facenti parte dello SPRAR, una commessa significativa che ci
consentirà di stabilizzarci nel settore», con rimborsi garantiti da 35 euro al
giorno. E pochi controlli sulla qualità degli aiuti. Nel 2013 Eriches ha vinto
anche il bando della prefettura di Roma per il Cara di Castelnuovo di
Porto, ovvero il centro per richiedenti asilo di Roma: centinaia di
posti, continue proteste per le condizioni indegne di vita. L'appalto da 21
milioni di euro è stato però bloccato dal Tar. E nel bilancio Buzzi si lamenta,
evocando il conflitto d'interessi: «nonostante le nostre giustificazioni siano
state accettate dalla Prefettura, non siamo riusciti ad iniziare il servizio
peralcuni “dubbi” provvedimenti adottati della Terza Sezione Ter del TAR Lazio»,
scrive: «presieduta da Linda Sandulli, la quale, per inciso, è proprietaria
insieme al marito di una ditta edile (PROETI Srl) che effettua manutenzioni
proprio all’interno del CARA; un enorme conflitto di interessi». «Siamo
fiduciosi che il Consiglio di Stato possa a breve ripristinare legalità e
diritto», conclude. Forse con un senso, implicito, dell'ironia.
Il nero e i bianchi, la torta delle coop. L'accordo globale di
Mafia Capitale. Concorrenza inesistente. Consiglieri
comunali compiacenti. L'unico dirigente "contro" allontanato. La squadra di
Carminati godeva su appoggi trasversali per ottenere milioni di euro nel gestire
emergenze abitative e migratorie. Ora sono finiti in carcere anche i
rappresentanti delle reti cattoliche, scrive Francesca Sironi su
“L’Espresso”. «Noi che dovemo sta sul pezzo pe’ magnasse un po' de
caciotta». Ha ragione, il Nero. Il suo braccio destro Salvatore Buzzi è un
lavoratore instancabile. Non conosce domeniche o festivi: è sempre al telefono
per spartirsi affari, o impegnato in riunioni, incontri e strette di mano per
assicurare a sé o agli amici milioni di euro dal Campidoglio e dal ministero
dell'Interno. Mai una pausa. La frase la dice Massimo Carminati, “er Cecato”, ed
è riportata nell'ordinanza che ha scoperchiato la seconda parte dell'inchiesta
su Mafia Capitale, con 44 arresti e decine di indagati fra politici,
amministratori e imprenditori. Il piatto principale è sempre la gestione delle
emergenze abitative e dell'accoglienza dei migranti da parte di
un ristretto gruppo d'affari. La novità è che ora sono state arrestate le
controparti di Buzzi e Carminati: i rappresentanti di quelle coop “bianche” di
cui l'Espresso parla da tempo , e che nella Capitale spadroneggiavano nel
settore degli aiuti sociali, spalla spalla alla banda di Carminati. Il
nero e i bianchi, il neofascista delle trame e le onlus che facevano riferimento
al vescovo e agli ordini religiosi. Agli arresti sono finiti infatti
Tiziano Zuccolo, della cattolica Domus Caritatis, e Francesco
Ferrara, Domenico Cammisa, Salvatore Menolascina e Carmelo Parabita,
rappresentanti del consorzio La Cascina, legata a Comunione e
Liberazione. Con Buzzi si intendevano alla perfezione. Il giudice li ritiene
infatti «partecipi agli accordi corruttivi con Luca Odevaine» - il funzionario
stipendiato per assegnare risorse e immigrati agli amici dal tavolo del
ministero dell'Interno – oltre che autori di «plurimi episodi di corruzione e di
turbativa d’asta dal 2011 al 2014», dimostrando «una spiccata attitudine a
delinquere, al fine di ottenere vantaggi economici nell’esercizio della loro
attività imprenditoriale». Negli atti si raccolgono così gli accordi e gli
intrecci che hanno intorpidito Roma per anni, chiudendola in una rete
indistricabile di cooperative – bianche, rosse, nere, incensurate o
indipendenti, non cambia – che si accordavano sui progetti prima ancora
venissero pubblicate le gare. Nessuna alternativa aveva spazio. C'era
chi si metteva d'accordo per quieto vivere, chi sotto minaccia. E chi
semplicemente traeva maggior guadagni grazie all'oligopolio. Come il gruppo dei
consorzi bianchi di Zuccolo e Ferrara. Uno degli episodi che meglio spiegano
come sono stati spesi in questi anni i fondi per i più poveri, a Roma, riguarda
580 persone - donne, uomini e bambini finiti per strada a cui bisognava trovare
un tetto per l'inverno del 2014. Il bando viene pubblicato il 14 luglio. Buzzi e
Zuccolo sono molto preoccupati, perché a gestirlo è tale Aldo Barletta,
un dirigente che a detta del socio di Carminati «è entrato da 10 giorni ed ha
applicato tutto quello che non avevano applicato fino ad adesso», uno che «non
cede nemmeno davanti a Gesù e Maria». Era un «pericolo», questo funzionario, per
le sue «resistenze ad assecondare le procedure sfavorevoli agli interessi della
pubblica amministrazione». E la procedura aperta da lui per trovare casa a quei
580 disperati era considerata un ostacolo: troppo trasparente e favorevole alla
concorrenza. Andava aggirata. Come? Con l'alacre attività di cui Buzzi si fa
coordinatore. E che consiste nel «far desistere» tutti i
potenziali avversari dal partecipare alla gara. Il funzionario “nemico” aveva
invitato infatti 15 società a presentare un'offerta. Alcuni nomi, fra gli
invitati, risultavano nuovi a Salvatore Buzzi, ed è allora Angelo Scozzafava
(indagato), direttore del dipartimento per le Politiche Sociali di Roma, a
dargli i contatti necessari. Altri invece li conosceva bene. E inizia con gli
sms e le chiamate. Contatta anche a Gabriella Errico, la responsabile della coop
“Un Sorriso” che gestiva il centro per minori di Tor Sapienza diventato noto
dopo l'aggressione e il caos con gli abitanti del quartiere. Lei risponde
«tranquillo», si dichiara «a disposizione» e non partecipa al
bando (ora è indagata). Altri fanno maggiori resistenze. Alcuni chiedono favori
in cambio, come Alberto Picarelli che desiste dall'occasione ghiotta ma dice:
«Salvato' spero che un giorno pure io ti possa... quando ti chiedo qualcosa me
ne venga accolta». Con questi piccoli debiti o scambi Buzzi sistema la
concorrenza. I colleghi competitor si dissolvono tutti. Rimane la rete di
Zuccolo e Ferrara, La Cascina. Ma tutto è sistemato con una telefonata tra amici
e un accordo che gli inquirenti definiscono "globale": «Io su quello dei 580
preferirei che andasse completamente deserto, che partecipassi solo io, capisci?
Sugli altri dimme te, io ti ci vengo e tu vieni sui miei», dice il braccio
destro di Carminati. E Ferrara conferma: «Secondo me tu vieni ed io vengo e poi
hai capito, così almeno più è... e poi sti cazzi, cioè hai capito?». Chi ha
capito ha capito: tu mi aiuti qui, io ti aiuto lì, e la spartizione è fatta. La
manovra non fa una piega. E il 25 agosto alla “manifestazione d'interesse” dei
soggetti sul territorio per accogliere quei 580 sfollati si presenta una sola
società. La cooperativa Eriches di Salvatore Buzzi. Che si aggiudica così
indisturbata l'affare da un milione e seicentomila euro. Turbativa d'asta in
piena regola. Ferrara è coinvolto anche in altre pratiche, fra cui la
manomissione di una gara indetta il 30 giugno del 2014 dalla prefettura di Roma
per assicurare l'accoglienza a 1.278 migranti, oltre a ulteriori 800 richiedenti
asilo in arrivo. Valore: 10 milioni di euro. Per ottenere le assegnazioni dei
progetti, e far approvare una delibera che assegnasse i fondi fuori bilancio,
Ferrara avrebbe partecipato alla «corruzione di consiglieri comunali mediante la
promessa della somma di complessivi 130mila euro». La situazione di Eriches e
Domus Caritatis/la Cascina era entrata infatti in crisi dopo un rapporto della
Finanza, che giudicava illegittime le assegnazioni dirette del Campidoglio a
quella ristretta cerchia di imprese sociali di milioni e milioni di euro. Ma né
rapporti né dirigenti specchiati sono riusciti a fermarli.
Denuncia la "miseria ladra" col vitalizio da consigliere.
Il coordinatore di Libera e braccio destro di don Ciotti invoca il reddito
minimo, poi intasca 2.600 euro al mese, scrive Giuseppe Alberto Falci su “Il
Giornale”. Da animatore delle campagne contro la povertà al vitalizio da 2.619
euro netti al mese il passo è breve. Addirittura brevissimo se il soggetto
interessato si chiama Enrico Fontana ed è anche il coordinatore nazionale di
Libera, l'associazione fondata da Don Luigi Ciotti. Associazione nata nel marzo
del 1995 «con l'intento - si legge nel sito internet di Libera - di sollecitare
la società civile nella lotta alle mafie e promuovere la legalità e la
giustizia». Nessun imbarazzo insomma per i venerabili maestri della sinistra
benpensante quando si tratta di arricchire la cassaforte di famiglia. A Fontana,
classe '58, giornalista professionista, ideatore del termine «ecomafie», che fa
il maestrino a destra e a sinistra pubblicando libri per Einaudi e inchieste per
l'Espresso , è bastato farsi eleggere alla Regione Lazio nel 2006. Anzi,
subentra ad Angelo Bonelli che nel frattempo diventa capogruppo a Montecitorio
del Sole che ride, gruppo a sostegno dell'ex premier Romano Prodi. Sono gli anni
di Piero Marrazzo a governatore della Pisana. Anni in cui Fontana pungola
l'esecutivo sui temi più disparati, dai rifiuti passando ai beni confiscati,
continuando a presenziare in convegni dal titolo «Il sole sul tetto, energie
rinnovabili e risparmio energetico». Ovviamente, non perdendo mai di vista il
tema della povertà, cruccio della carriera dell'attuale braccio destro di Don
Luigi Ciotti. Ma la legislatura finisce con qualche mese di anticipo per le
dimissioni del governatore Marrazzo, coinvolto in uno scandalo a base di festini
e trans. Ciò ovviamente consente al nostro Fontana di ottenere un lauto
vitalizio. Dopo cinque anni scarsi in Regione e dopo aver versato circa 90mila
euro di contributi, dal 2011 Fontana ricevo un assegno mensile di 3.187 euro
che, a causa delle recenti sforbiciata apportate dalla modifica della normativa
sui vitalizi, si è ridotto a 2.616,32 netto (dato che è possibile reperire
all'interno del sito del M5s Lazio che monitora giornalmente le evoluzioni dei
vitalizi). In sostanza, facendo un calcolo di massima, Fontana ha già incassato
più di 150mila euro recuperando i 90mila euro versati di contributi. Ma non
finisce certo qui. Perché dal settembre del 2013 Fontana è il coordinatore
nazionale di Libera. E dalla casa di Don Ciotti, non è uno scherzo, Fontana
lancia e anima la campagna «Miseria ladra». Gira ogni angolo del Belpaese per
diffondere il verbo del padre nobile di Libera. Ma il vero paradosso è il
seguente: il 15 aprile di quest'anno - insieme a Giuseppe De Marzo, coordinatore
di «Miseria Ladra» - invia una lettera a tutti i parlamentari «per
calendarizzare in aula entro cento giorni una legge per il reddito minimo o di
cittadinanza, per contrastare povertà e disuguaglianza, così come da tempo ci
chiede l'Europa». Il virtuoso della «legalità e della giustizia» incalza
Montecitorio e Palazzo Madama ma intanto incassa, senza batter ciglio, il
vitalizio. D'altronde è nello stile dei vertici di Libera. Nando Dalla Chiesa,
presidente onorario dell'associazione, riceve mensilmente un assegno di 4.581,48
euro. Insomma, «miseria ladra» per gli altri, non per i venerabili maestri.
Il prete delle coop fustiga tutti ma salva gli amici che lo
finanziano. Questa volta don Ciotti, di fronte a
scandali e corruzione, non ha lanciato scomuniche come nel suo stile. Nessuna
sorpresa: sono le cooperative rosse che danno soldi alla sua associazione,
scrive Stefano Filippi su "Il Giornale". Cacciate i ladri: è un vasto programma
quello che don Luigi Ciotti, il sacerdote dell'antimafia, ha assegnato alla Lega
delle cooperative. Era lo scorso dicembre, i giorni dello scandalo romano di
«Mafia capitale». Degli arresti tra i «buoni». Dei cooperatori che sfruttano i
disperati. Dei volontari (o pseudo tali) che intascano soldi da Stato e Regioni
pontificando che invece li avevano usati per accogliere gli extracomunitari. Dei
portaborse Pd che facevano da intermediari tra enti pubblici e malaffare. Del
ministro Poletti fotografato a tavola con i capi di Legacoop poi indagati.
Dell'ipocrisia di una certa parte della sinistra pronta a denunciare le
pagliuzze negli occhi altrui senza accorgersi delle proprie travi. Ma don
Ciotti, il custode della legalità, il campione della lotta contro le mafie, il
prete che marcia in testa a qualsiasi corteo anti-corruzione e pro-Costituzione,
ha trattato con i guanti le coop rosse. «Bisogna sempre vigilare - ha detto -
non c'è realtà che si possa dire esente». E ancora: «Non possiamo spaventarci di
alcune fragilità. Ve lo dico con stima, gratitudine e affetto: dobbiamo imparare
sempre di più a fare scelte scomode». E poi: «Siate sereni, cacciate le cose che
non vanno. Le notizie sulle tangenti non possono lasciarci tranquilli - ha
proseguito -. Molti con la bocca hanno scelto la legalità ma dobbiamo evitare
che ci rubino le parole. Non si sconfiggono le mafie se non si combatte la
corruzione». Un appello generico, parole di circostanza davanti a un sistema
smascherato dalla magistratura. Nulla a confronto delle scomuniche lanciate
contro i mafiosi, i sì-Tav, i «nemici della Costituzione», i «guerrafondai», e
naturalmente Silvio Berlusconi. D'altra parte, difficile per lui usare un tono
diverso. Perché il prete veneto cresciuto a Torino è anche il cappellano di
Legacoop. Il rapporto è organico. Le coop rosse (con la Torino-bene, la grande
finanza laica e le istituzioni pubbliche) sono tra i maggiori finanziatori del
Gruppo Abele e di Libera. L'associazione antimafia ha tre partner ufficiali: le
coop della grande distribuzione, il gruppo Unipol e la loro fondazione,
Unipolis. Nei bilanci annuali c'è una voce fissa: un contributo di 70mila euro
da Unipolis. Legacoop collabora con il progetto «Libera terra», che si occupa di
mettere a reddito i terreni confiscati ai mafiosi. «Un incubatore per la
legalità», lo definiscono i cooperatori rossi che grazie a questa partnership
aprono sempre nuove coop al Centro-Sud che sfornano prodotti «solidali». Don
Ciotti si scomoda perfino per le aperture di qualche punto vendita, com'è
successo quando le coop inaugurarono la loro libreria davanti all'Università
Statale di Milano. L'agenda del prete è fittissima. Firma appelli, presenta
libri di Laura Boldrini, promuove manifestazioni, guida cortei, interviene a
tavole rotonde (a patto che non odorino di centrodestra), appare in tv,
commemora le vittime della mafia, incontra studenti, ritira premi: l'ultimo è il
Leone del Veneto 2015, ma nel 2010 fu insignito, tra gli altri, del premio
Artusi «per l'originale contributo dato alla riflessione sui rapporti fra uomo e
cibo». E poi inaugura mostre fotografiche e fa addirittura da padrino a rassegne
di pattinaggio (è successo a Modena lo scorso 7 febbraio per il 19° trofeo
intitolato a Mariele Ventre). In questo turbine di impegni, don Luigi non ha
trovato il tempo di condannare apertamente le infiltrazioni della malavita
organizzata nella galassia della cooperazione rossa. E non esistono soltanto
«Mafia capitale» a Roma o le mazzette per il gas a Ischia; ci sono le indagini
per la Tav, i lavori al porto di Molfetta, gli appalti di Manutencoop, le
aziende legate al «Sistema Sesto» che coinvolgeva Filippo Penati, i cantieri
Unieco in Emilia Romagna dove lavoravano famiglie della 'ndrangheta. Nei bilanci
delle associazioni di don Ciotti i finanziamenti di Unipolis sono tra i pochi di
cui è chiara la provenienza. Libera e Gruppo Abele rappresentano realtà
consolidate. L'organizzazione antimafia ha chiuso il 2013 con entrate per 4
milioni 770mila euro raccolti in gran parte da enti pubblici: mezzo milione per
la gestione dei beni confiscati, altrettanti per progetti e convenzioni
internazionali, ulteriori 766mila per attività di formazione; 645mila euro
arrivano grazie all'8 per mille, 200mila dalle tessere, 700mila dai campi estivi
e 900mila da campagne di raccolta fondi. Maggiori problemi ha il Gruppo Abele,
che ha chiuso il 2013 (ultimo bilancio disponibile) con una perdita di 273mila
euro, e il 2012 era andato pure peggio: un buco di quasi due milioni su uno
stato patrimoniale di circa 10. La situazione finanziaria è disastrosa, con
debiti verso le banche per 5 milioni e altri 800mila verso fornitori garantiti
da un cospicuo patrimonio immobiliare valutato in circa 6 milioni 300mila euro:
la sede di Corso Trapani è un ex immobile industriale donato a don Ciotti
dall'avvocato Agnelli. Affrontare il disagio sociale costa e molte attività
assistenziali non possono essere soggette a «spending review». Indebitarsi è
oneroso: 261mila euro (quasi tutta la perdita di esercizio) se ne vanno in
anticipi e interessi su prestiti principalmente verso Banca Etica, Unicredit e
Unipol banca. I ricavi non seguono l'andamento dei costi. Le rette delle persone
ospitate in comunità e i proventi per corsi di formazione o vendita di libri e
riviste fruttano 2.838.000 euro. Più consistenti sono le entrate da contributi:
quasi 3.700.000 euro. Oltre tre milioni piovono da Commissione europea,
ministeri, regioni ed enti locali, fondazioni imprecisate; altri generici
«terzi» hanno donato 731mila euro mentre istituti bancari senza nome hanno
erogato quasi 350mila euro. Don Ciotti è un campione nel fare incetta di
finanziamenti pubblici. Ma non bastano. Ecco perché deve girare l'Italia e
sollecitare la grande finanza progressista a essere generosa con i
professionisti dell'antimafia e dell'antidroga. È uno dei preti di frontiera più
famosi, con don Virginio Colmegna e don Gino Rigoldi. Dai convegni coop alle
telecamere Mediaset (è andato da Maria De Filippi, ma nessuno si è indignato
come per Renzi e adesso Saviano), dagli appelli per la Costituzione (con Rodotà,
Zagrebelsky, Ingroia, Landini) perché «l'Italia è prigioniera del berlusconismo»
fino alle manifestazioni no-Tav, don Ciotti è in perenne movimento. Non lo
frenano gli incidenti di percorso: il settimanale Vita ha segnalato («legalità
parolaia») che Libera e Gruppo Abele figurano tra i firmatari di un accordo con
i gestori del business delle sale gioco mentre il loro leader si è sempre
scagliato contro l'azzardo. Dopo che Papa Francesco l'anno scorso l'ha
abbracciato e tenuto per mano alla commemorazione delle vittime di mafia, don
Ciotti vive anche una sorta di rivincita verso la Chiesa «ufficiale» che a lungo
l'aveva tenuto ai margini. Lo scorso Natale ha promosso un appello per «fermare
gli attacchi a Papa Francesco»: è l'ultimo manifesto, per ora, proposto da don
Ciotti. Ma non passerà troppo tempo per il prossimo.
LA PATRIA DELLA CORRUZIONE.
La vittoria di Pirro dei nostri politicanti. Con la metà dell'elettorato che va
a votare, che è poi lo zoccolo duro della sinistra che voterebbe pecore e porci,
chi vince governa con solo con il 30% dei consensi, tanto basta per non cambiare
le cose...e poi la chiamano democrazia. La gente non vota perché non si sente
rappresentata da quei personaggi che la notorietà mediatica, per essere eletti,
l’hanno conquistata per mezzo dei loro gaglioffi che hanno occupato le redazioni
di Tv e Carta stampata. Il web può solo produrre un’accozzaglia di personaggi in
cerca di autore. Coacervo di idee sinistroidi che si fa movimento e che guarda
solo all’aspetto finanziario-economico della debacle della società italiana.
Giampaolo Pansa su “Libero Quotidiano”: "Elezioni? No, inutile delirio. io a
votare non ci vado più". Ma si tengono ancora le elezioni in Italia? Se devo
stare a quel che leggo sui giornali, sembra di no. Tra due domeniche si dovrebbe
votare in sette regioni, ma la battaglia tra i partiti assomiglia sempre di più
a un inutile delirio. Sento parlare di futuri presidenti in teoria eccellenti,
ma circondati da un corteo di impresentabili. Le cronache politiche diventano
bollettini di cronaca nera. Emergono scandali a ripetizione. Dopo il voto,
scommetto che in tanti urleranno ai brogli commessi dagli avversari. Se fossi un
reduce delle Brigate rosse, mi fregherei le mani: quello che non siamo riusciti
a fare noi, l’hanno realizzato i partiti. E senza neppure lasciarsi alle spalle
qualche morto ammazzato e un po’ di gambizzati. Ma sono sempre state così le
elezioni? Un signore che si chiamava Benito Mussolini le definiva «ludi
cartacei». Però lui non aveva bisogno delle urne. Una volta varata la legge
Acerbo, la nonna dell’Italicum di Matteo Renzi, inchiodò gli italiani al suo
regime. E tirò diritto lungo una strada che avrebbe portato l’Italia verso la
catastrofe della seconda guerra mondiale. Dove ci porterà il premier oggi in
carica non lo sa nessuno, tanto meno il suo imponente staff di Palazzo Chigi.
Dunque voglio rimanere con i piedi per terra. E rievocare le prime elezioni del
dopoguerra. Quelle che videro una novità rivoluzionaria: l’irrompere sulla scena
politica di una forza strapotente che avrebbe cambiato il volto dell’Italia e
deciso a chi sarebbe andato il governo del paese. Questa forza erano le donne.
In casa nostra, per secoli non avevano mai votato. Andare alle urne era
prerogativa dei maschi, «come il pisciare in piedi», rognava la più giovane
delle mie zie. Poi un decreto firmato da Umberto di Savoia il 1° febbraio 1945,
tre mesi prima della Liberazione, stabilì che anche le signore potevano
presentarsi ai seggi. Il primo effetto fu il raddoppio del corpo elettorale, da
11 a 23 milioni di iscritti alle liste. Un notorio dongiovanni della mia città
bofonchiò a una delle sue amanti: «Non immaginavo che foste così tante. Adesso
vi monterete la testa, comincerete a fare le preziose e ce la mostrerete con il
lanternino!». La più spavalda delle sue morose, gli replicò: «Adesso dovrai
votare il partito che ti dirò io. Altrimenti scordati il mio indirizzo». Un
altro effetto fu di consentire a mia madre di andare al seggio come non aveva
mai fatto. Erano le prime elezioni dell’Italia liberata. Accadde il 31 marzo
1946 e lo scopo era di decidere chi avrebbe amministrato le città. Le urne si
aprirono in cinque domeniche diverse e per grandi raggruppamenti. Il motivo era
semplice: occorreva presidiare i seggi, ma siccome la forza pubblica era molto
scarsa, bisognava lasciarle il tempo di spostarsi da una zona all’altra. Fu una
corsa a tappe e si svolse nella più assoluta normalità. Con un’affluenza alle
urne assai alta per l’epoca: il 71,6 per cento, un’utopia nell’Italia del 2015.
Nella mia città, un comune di 35 mila abitanti in Monferrato, si presentò al
voto addirittura l’88 per cento del corpo elettorale. Contribuirono a quel
record anche mio padre Ernesto e mia madre Giovanna. Lei era una femminista
inconsapevole perché guadagnava più di papà. Lui un uomo dolce, operaio
guardafili del telegrafo. L’arrivo di Giovanna al seggio, aperto nelle scuole
elementari di via Cavour, fu memorabile. Si era messa in ghingheri come per
andare a un matrimonio. In più si fece accompagnare da due giovani clienti che
erano uno schianto. Disse alle ragazze: «Tiratevi su le calze, donne, perché
dobbiamo mandare al tappeto gli scrutatori, soltanto maschi e di quelli
stagionati!». L’ingresso in sezione del Trio Lescano lasciò tutti a bocca
aperta. E non avevano ancora visto il cartello che Giovanna aveva appeso alla
saracinesca abbassata del suo negozio. Diceva: «La proprietaria di questa
modisteria finalmente va a votare per la prima volta. Alla bella età di 42
anni!». Mio padre Ernesto osservò: «Non ti sembra di agitarti un po’ troppo?».
Giovanna gli replicò: «Mio caro Netu, oggi il troppo o il poco lo decido io!».
Di quelle prime elezioni del dopoguerra ricordo un’armonia sociale che nel 1948
sarebbe svanita a causa dello scontro all’ultimo voto tra la Dc e il Fronte
democratico popolare. Pur essendo una tifosa di De Gasperi, mia madre stravedeva
per una nipote, figlia dell’ultimo fratello di mio padre, Francesco. Dopo essere
andato a lavorare in Argentina, era tornato in Italia e aveva sposato la
tredicesima figlia di un pescatore del Po, Giuseppina, detta Pinota. Piccola,
mora, occhi vivaci, carattere da comandante, portava in dote soltanto una cosa
di valore: la licenza per aprire una trattoria. Nacque così l’Osteria del Ponte,
di fronte al Po. Francesco era comunista e quando si trattò di inaugurare la
bandiera della sezione di Porta Po, lo fece in pompa magna. E chi era la
madrina? Mia cugina Luigina, sedici anni, un viso incantevole, capelli neri
lunghi sulle spalle, labbra perfette, sguardo da stendere tre giovanotti.
Indossava un vestito intero, con la gonna plissettata che lasciava intuire una
silhouette da sballo. Giovanna le aveva suggerito di tenere in mano un bouquet
di fiori. Insieme all’armonia, c’era anche molto pragmatismo. Alle comunali del
1946 vinsero i socialisti con sette mila voti. I democristiani ne ebbero appena
trecento in meno. Terzi i comunisti. Sindaco della città divenne il socialista
Paolo Angelino, professore di inglese, con una data di nascita impossibile da
scordare: 1° gennaio 1900. Giovanna confessò a mio padre: «Anch’io ho votato per
Angelino». Sorpreso, lui osservò: «Ma non sei una tifosa di De Gasperi?». Lei
alzò le spalle: «Che c’entra? Adesso si tratta di rimettere in ordine la città,
dopo tanti anni di guerra. Il professor Angelino è l’uomo giusto per riuscire a
farlo. Sai come lo chiamano? Pietrischetto Bitumato. E sai perché?». Ernesto
sbuffò: «Sei tu quella che sa sempre tutto». Allora mia madre gli spiegò: «Il
sindaco controlla di nascosto che i cantonieri lavorino a dovere sulle strade.
Arriva a nascondersi dietro le piante o nei portoni e si accerta della
consistenza dell’asfalto con la punta della scarpa. Ho fatto bene a votarlo.
Quando sceglieremo il Parlamento mi comporterò in un modo diverso».
Pietrischetto Bitumato era di un’onestà a tutta prova. Voleva il bilancio sempre
in pareggio. Ci teneva al buon nome del municipio di fronte agli elettori che
continuarono a votarlo, anche quando si presentò alla Camera dei deputati. Era
un socialista colto, ottimo parlatore, lettore infaticabile di buoni libri.
Com’era fatale, teneva molto alle sue tre cariche: sindaco, deputato, capo dei
socialisti cittadini. Per noi ragazzacci era il Califfo. Quando gli chiedemmo la
tessera del Psi, ci cacciò dal suo studio strillando: «Non sono mica matto! In
un mese voi mi distruggete il partito!». Che cosa è rimasto di quel tempo?
Nulla. Tanto che mi domando se devo ritornare a votare. La mia risposta è che
non ci andrò più. Non ho niente da spartire con i partiti di oggi, se non i
torti che potrebbero farmi. E adesso il compagno Renzi mi iscriva pure nella
lista nera dei gufi e dei rosiconi. Non me ne potrebbe fregare di meno.
Giampaolo Pansa.
E' possibile avere un po' meno corruzione?
Si Chiede Bruno Manfellotto su "L'Espresso". Non bastano leggi
più severe o l’Autorità di Cantone. Questo rimane il paese dell’impunità. Tocca
alla politica fare pulizia al suo interno. È luogo comune o verità che l'Italia
sia il paese più corrotto d'Europa? Insomma, ciò che continuiamo a vedere, da
Roma mafiosa a Ischia mazzettara, passando per il Mose, l'Expo, e un Pd percorso
da bande, è ordinario tasso di corruttela - che ci vuoi fa', è la politica - o
straordinaria quotidianità criminale? E qualora record fosse, perché? Prima di
tutto, però, un paio di osservazioni. A dispetto delle statistiche, in Italia
c'è ancora tanta stampa libera che pubblica ogni notizia che trova senza
guardare in faccia a nessuno. Voi che leggete "l'Espresso" lo sapete bene. E
così, se si smazzetta a Procida o a Venezia, si scrive, magari talvolta
rinunciando a quella prudenza necessaria quando si fa informazione: ma davanti a
certe notizie forse è meglio rischiare che tacere, no? Anche i magistrati fanno
il loro mestiere e dispongono di uno strumento formidabile, le intercettazioni,
capaci di svelare mondi inimmaginabili. Pure qui ci sono abusi, si sa, e grande
è la responsabilità di pm e giornalisti nel distinguere il grano dal loglio
senza calpestare i diritti di nessuno. E certo si può sbagliare, ma non è un
caso che a ogni governo - e quello di Matteo Renzi non fa eccezione -
corrisponda una riforma della giustizia che, immancabilmente, mette in
discussione poteri dei magistrati e intercettazioni. Il procuratore aggiunto di
Venezia, Carlo Nordio, le vorrebbe addirittura abolire. Come se nascondere i
reati significasse cancellarli, un po' come fanno i bambini quando si tappano
gli occhi convinti che così nessuno li veda. Già, ma perché la corruzione è così
diffusa? Perché la politica ha perso le motivazioni che la muovono, ha risposto
Marcello Veneziani in una lettera al "Corriere della Sera", quelle motivazioni
politiche, civili e religiose che formano il sostrato di ogni civiltà. E con
queste, ha aggiunto, si sono esaurite anche le spinte più personali, cioè
l’ambizione di distinguersi e la voglia di veder riconosciuti i propri meriti.
Infatti la corruzione dilaga lì dove non c'è meritocrazia. Osservazione
condivisibile, ma allora bisogna chiedersi come si è arrivati a questa generale
demotivazione politica e personale. Intendiamoci, che la corruzione possa essere
sconfitta è impensabile, essa è insita nella natura umana e da che mondo è mondo
appartiene alla politica, perfino come strumento necessario a conseguire i
propri obiettivi. Ma da noi non è più questo. Già trent'anni fa Rino Formica,
socialista, lamentava che «il convento è povero, ma i frati sono ricchi»; oggi,
addirittura, si comincia a fare politica solo per affermare il proprio personale
potere e, appunto, arricchirsi. Tra le tante cause del decadimento c'è, prima
fra tutte, la mancata selezione della classe politica, viziata da liste
elettorali bloccate - che riservano il potere di scelta a pochi ras - e da
partiti squagliati, più che liquidi. E l'idea che la politica appartenga dunque
a ristrette oligarchie autoreferenziali demotiva e allontana gli uomini di buona
volontà. Devastante è stato poi il cattivo esempio di leader e dirigenti, anche
di antica militanza, soliti camminare sul filo del rasoio, bravi a muoversi con
arroganza in un'area grigia dove favoritismi e trattamenti di riguardo si
mescolano a finanziamenti occulti, appalti pilotati, tangenti in natura. L'idea
generalizzata che così fan tutti e che non ci sia altro modo per emergere,
trovare un lavoro, avere successo ha prodotto incredibili fenomeni imitativi a
tutti i livelli e cancellato quelle forme di controllo sociale con le quali ogni
comunità pone un argine al degrado morale e civile. E non basta. Se qualche
passo avanti è stato fatto con l'approvazione della legge Severino, con
l'istituzione di un'autorità anticorruzione (Raffaele Cantone) e il ripristino
del falso in bilancio, questo ahimè è ancora il paese non della certezza della
pena, ma dell'impunità: come riassume Piercamillo Davigo, una volta si
minacciava «ti faccio causa», oggi la sfida è «fammi causa». Non c'è un giudice
a Berlino. Facile che, con tali premesse, prevalgano cinismo e rassegnazione. E
però non c'è altro modo per ridare credibilità alla politica e alle istituzioni
che impegnarsi a fondo per arginare il fenomeno. Prima che siano i corrotti a
rottamare gli innovatori.
Ecco la mappa della corruzione disegnata dagli studenti.
Il progetto coinvolge mille ragazzi: per mesi hanno raccolto dati e
testimonianze sulla corruzione in Lazio, Campania e Lombardia. Produrranno un
"Atlante" che la fotografa nei loro quartieri, scrive Manuel Massimo su “La
Repubblica”. Da discenti a docenti: gli studenti del progetto per la legalità
"Piccolo Atlante della corruzione", dopo aver indagato il fenomeno sul campo e
raccolto in forma anonima le testimonianze dei soggetti a rischio, si stanno
preparando alla lezione conclusiva di fine maggio che li vedrà protagonisti.
Saranno proprio loro a salire in cattedra per "insegnare" quello che hanno
imparato dai tutor e agli esperti che li hanno seguiti nel corso del laboratorio
- ideato e promosso da Beatrice Ravaglioli del circolo "Libertà e Giustizia" di
Roma, finanziato dal Miur, sostenuto attivamente dall'Autorità nazionale
anticorruzione, dall'Associazione nazionale magistrati e in collaborazione con
l'Università di Pisa e con Repubblica.it. I materiali prodotti dalle 15 scuole
aderenti al progetto confluiranno nel "Piccolo Atlante della corruzione": una
pubblicazione scaricabile gratuitamente online che potrà essere utilizzata anche
dagli addetti ai lavori che ogni giorno combattono per la legalità. Questa
seconda edizione del progetto (2015) - partito lo scorso anno in via
sperimentale solo a Roma e nel Lazio e allargato quest'anno anche alla Campania
e alla Lombardia - ha visto la partecipazione di oltre mille ragazzi, studenti
delle scuole superiori, che hanno mappato la percezione del fenomeno
"corruzione" nei territori accanto ai loro istituti grazie a questionari
(somministrati anonimamente a una varietà di soggetti potenzialmente interessati
dal problema, ndr) messi a punto seguendo le indicazioni del professor Alberto
Vannucci, politologo e direttore del Master anticorruzione presso l'Università
di Pisa. Non si è trattato di un modello di didattica calata dall'alto, ma
piuttosto di un processo attivo di raccolta ed elaborazione dei dati, come
spiega Vannucci: "Nelle fasi iniziali noi docenti ed esperti abbiamo fornito ai
ragazzi gli strumenti d'indagine: poi sono stati loro a elaborare da soli il
questionario mappando i settori più a rischio e diventando protagonisti". Dopo
aver ascoltato dal vivo le testimonianze di giornalisti sotto scorta come
Federica Angeli, cronista di nera e giudiziaria per Repubblica, gli
studenti hanno intrapreso un percorso di studio sul campo, indagando nei meandri
del sommerso e diventando giovani "sentinelle della legalità" anche in contesti
difficili dove la presenza della criminalità organizzata è forte e si fa
sentire. Ogni scuola ha elaborato autonomamente un questionario specifico,
partendo da una base comune ma modellandolo sulle peculiarità del proprio
territorio. Un'operazione che fornirà una mappa diversificata e territoriale
della corruzione, partendo anche da casi concreti. L'elemento della comparazione
è fondamentale in questo tipo di studi, ne è convinto il professor Vannucci che
auspica un ulteriore allargamento del progetto: "Dopo l'esperienza-pilota dello
scorso anno e questa seconda edizione che ha coinvolto anche altre due Regioni,
da studioso del fenomeno spero che il progetto possa crescere ancora. I ragazzi
coinvolti hanno sviluppato gli anticorpi per la legalità e maturato una fiducia
critica nelle Istituzioni, perché troppo spesso la sfiducia radicale nasce
dall'ignoranza ed è lì che bisogna andare a stimolare la presa di coscienza su
determinati temi". Il "Piccolo Atlante della corruzione" sarà composto da 15
parti - una per ciascuna delle scuole coinvolte nel progetto itinerante per la
legalità - e scatterà un'istantanea del fenomeno che potrà essere utilizzata
come base di ulteriori indagini e approfondimenti della magistratura. Uno
strumento utile, soprattutto oggi che la corruzione si è "smolecolarizzata" e
troppo spesso riesce a passare inosservata, come sottolinea Vannucci con tre
aggettivi: "Sotterranea, invisibile, impercettibile". Portare a galla il
sommerso rappresenta dunque il primo passo per guardare dritto negli occhi il
problema, prenderne coscienza e impegnarsi in prima persona per cercare di
risolverlo. I tre incontri finali - uno in Lombardia, uno nel Lazio e uno in
Campania - si stanno avvicinando e gli studenti sono pronti a salire in
cattedra: l'appuntamento di Napoli è fissato per mercoledì 20 maggio a partire
dalle ore 10 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Sannino-Petriccione";
già calendarizzato anche l'incontro di Roma, che si terrà la mattina di venerdì
29 maggio nell'aula magna dell'Università Sapienza, alla presenza tra gli altri
del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone e con la
partecipazione dell'attore Elio Germano. I ragazzi, sentinelle di legalità,
hanno studiato la corruzione nelle strade che percorrono tutti i giorni per
andare a scuola e ora sono pronti a salire in cattedra per parlarne in pubblico:
un piccolo passo individuale per ciascuno, ma un grande esempio collettivo per
tutti nella lotta alla corruzione.
Corruzione? Tutto il mondo è paese,
scrive Alessandro Bertirotti su “Il Giornale”. È tutta questione di… disonestà.
Abbiamo letto in molte classifiche che la nostra meravigliosa nazione è fra gli
ultimi posti rispetto alla capacità di combattere la corruzione, e dunque ai
primi per il numero di casi in cui tale reato è presente. E questo, ovviamente,
assieme a molte altre cose non positive rappresenta per noi tutti un disonore,
specialmente quando i rappresentanti di questo reato sono persone che vengono
definite “onorevoli”. Scritto questo, è interessante sapere che anche nel mondo
islamico esiste un divieto a procurare corruzione, come ad accettare di essere
corrotti, e lo si legge nella seconda Sura. I corrotti sono coloro che non
rispettano le leggi che Allah ha fornito agli uomini per vivere in pace fra
loro; sono coloro che al posto di conciliare spargono divisioni e male per il
prossimo; coloro che rubano, non sono leali e sfruttano la fiducia degli altri
per il proprio personale tornaconto. Insomma, anche per il Corano questo
comportamento viene profondamente sanzionato ed è considerato un vero e proprio
oltraggio ad Allah, il quale giungerà a vendicarsi con questi suoi figli
fedifraghi. Ebbene, qualche giorno fa, ho incontrato una persona che mi
raccontava di essersi recato a Roma in una ambasciata di un Paese arabo,
imbattendosi in un funzionario che per un documento ha rilasciato una ricevuta
di Euro 25,00, chiedendone però 50,00. La motivazione è stata che, avendo la
richiesta le caratteristiche dell’urgenza, vi era il costo aggiuntivo di 25,00
euro, fuori ricevuta, ovviamente. Bere oppure affogare, proprio come accade da
noi quando andiamo da un professionista che non ci rilascia la ricevuta con il
giusto prezzo pagato. Ho l’impressione che le classifiche che vengono stilate su
questo tipo di comportamento umano, non tengano conto di quanto il concetto di
corruzione sia diventato pervasivo, anche all’interno di quei paesi che ci
sembrano tanto diversi da noi. E sono anche convinto che tale situazione sia
rinvenibile in altri paesi, ad esempio in quelli del Nord Europa, perché la
questione non è legata solo alla morale religiosa, ma anche a quello che ogni
individuo pensa di se stesso. In sostanza, non lamentiamoci dei nostri ladri
perché i ladri abitano l’intero mondo e non dipende dalla religione professata
se una persona si comporta male con il mondo intero, quanto dall’asservimento
che la mente umana, di qualsiasi cultura essa appartenga, accorda al dio denaro.
È il dio denaro che governa come un Principe questo mondo, e servirlo significa
dedicare molti atti della propria vita a comportamenti come questi, dimenticando
che il libero arbitrio lo possiamo esercitare in tutte le cose della vita
quotidiana, anche nelle più piccole.
LE BUGIE
DEI POLITICANTI CHE SCHIAVIZZANO I NOSTRI GIOVANI.
Ecco come i
politici manipolano i numeri.
Da Berlusconi a Renzi, 20 anni di bugie. Dal milione di posti di lavoro
al bonus di 80 euro, passando per tesoretti che appaiono e scompaiono e stime
(come quelle Istat) su contratti e disoccupazione: sondaggi, tabelle e
statistiche hanno invaso media e tv, e sono usate dai politici come strumento di
propaganda. Così anche la matematica è diventata un'opinione, scrive Emiliano
Fittipaldi su “L’Espresso”. Quando dà i numeri, Matteo Renzi sembra ispirarsi
alla leggendaria lezione di economia di “The Wolf of Wall Street”. «Regola
numero uno: nessuno (ok, se sei Warren Buffett allora forse sì), nessuno sa se
la Borsa va su, va giù, di lato o in circolo», ragiona il broker Matthew
McConaughey mentre spiega strafatto di coca a Leonardo DiCaprio come fare soldi
e fregare i clienti. I dati e le cifre? «Sono tutto un “fughesi”, un “fugasi”,
cioè falso, volante... polvere di stelle, non esiste, non tocca terra, non ha
importanza, non è sulla tavola degli elementi, non è reale cazzo!». Ecco. A
vedere le statistiche snocciolate dal premier e dai suoi ministri nelle ultime
settimane, sembra che in Italia, come nel film di Martin Scorsese, la matematica
sia diventata un’opinione, un luogo dove 2 più 2 può fare anche 5, 7 o 39, a
secondo delle esigenze e degli esegeti del numero. Così, se un tesoretto da «1,6
miliardi» può apparire improvvisamente in un bel giorno di primavera e
scomparire 48 ore dopo, per rinascere ancora (accresciuto o sgonfiato, a seconda
dell’economista che ne scrive) in qualche dichiarazione al tg, e se le
previsioni di crescita del Pil piazzate nel Documento di programmazione
economica sembrano scientifiche quanto una partita a dadi, i dati sugli effetti
del nuovo Jobs Act sono metafora perfetta dell’affidabilità delle tabelle che
dominano il dibattito pubblico. Già: sia a fine marzo che a fine aprile il
ministro Giuliano Poletti ha annunciato il miracolo, spiegando che la nuova
legge aveva creato 79 e 92 mila contratti in più. Dopo una settimana l’Istat ha
però certificato che il tasso di disoccupazione, proprio a marzo, ha raggiunto
il suo massimo storico, toccando il 13 per cento. «I numeri non sono
confrontabili», hanno spiegato fuori di sé da Palazzo Chigi. Oggi l'Istituto ha
rilasciato un'altra sfilza di dati, stavolta trimestrali, che evidenzierebbero
un boom (grazie al taglio delle tasse per chi assume) di contratti a tempo
indeterminato. Insomma, ce più o meno lavoro di prima? Nemmeno i chiromanti e
gli economisti più quotati finora ci hanno ancora capito nulla. Dal milione di
posti di lavoro promessi da Silvio Berlusconi nel 1994 fino agli 80 euro del
bonus Renzi, passando per l’ossessione europea del 3 per cento nel rapporto tra
deficit e Pil, sono più di vent’anni che la dittatura dei numeri condiziona le
elezioni, il confronto politico e, conseguentemente, l’evoluzione della società.
La passione per le tabelle è diventata una moda e poi una malattia, un diluvio
di cifre ci piove in testa tutti i santi giorni. «È vero. Il boom delle cifre è
un fenomeno evidente, tangibile, ed è contestuale alla fine delle ideologie»,
spiega Ilvo Diamanti, ordinario all’università di Urbino che con dati e sondaggi
ci lavora da sempre. «Durante la Prima Repubblica politica e partiti erano
fondati su certezze granitiche, ma la fine della contrapposizione tra
democristiani e comunisti, sommata al declino della fede religiosa, ha cambiato
tutto. Le statistiche rappresentano una risposta alla crisi dei valori
tradizionali, hanno riempito un vuoto, e sono diventate un totem». Scomparsi i
fondamenti culturali e le visioni etico-morali su cui si disegnavano gran parte
delle misure politiche e delle strategie sociali, dunque, la matematica e la
statistica sono diventate il filtro più usato per rappresentare e analizzare la
realtà. I politici, ovviamente, ci sguazzano dappertutto, ma sotto le Alpi lo
fanno con accanimento e modalità che altrove non hanno attecchito: non è un caso
che nel “Grande dizionario della lingua italiana” la locuzione «dare i numeri»
vuol dire anche «apparire insincero, suscitare il sospetto di tramare un
inganno, di agire con doppiezza, con fini reconditi». Di sicuro i numeri sono
diventati un corredo indispensabile a ogni strategia comunicativa. Ma, oltre a
dare sostegno alle chiacchiere e una parvenza di concretezza alle parole, in
Italia vengono usati soprattutto per impressionare, suggestionare, muovere
passioni, speranze e paure. Se nel contratto con gli italiani Berlusconi
prometteva «l’innalzamento delle pensioni minime ad almeno un milione di lire al
mese» e «la riduzione delle imposte al 23 per cento per i redditi fino a 200
milioni di lire annui», nel 2013 Bersani spiegò di voler restituire alle imprese
«50 miliardi in 5 anni» in modo da diminuire i debiti della pubblica
amministrazione. Il cavallo di battaglia di Beppe Grillo è, da sempre, il
reddito minimo di cittadinanza «da mille euro al mese», mentre Matteo Salvini
afferma, da giorni, che «un milione di immigrati è pronto a salpare dalla Libia
per le nostre coste». Secondo il linguista Michele Porcaro, dell’università di
Zurigo, c’è anche una strategia precisa nel dare i numeri, a seconda di cosa si
vuole comunicare: la cifra tonda (un milione, un miliardo) «è in funzione di
aggressione verbale», scrive l’esperto, «serve non a essere credibili, ma a
suggestionare. Se si vuole suonare affidabili, invece, si usa la cifra esatta».
In quest’ultimo caso, però, l’eccesso di pignoleria può causare effetti comici,
come quando Berlusconi annunciò che durante il suo mandato a Palazzo Chigi «gli
sbarchi di clandestini si sono ridotti del 247 per cento». Fosse stato vero,
sarebbe addirittura un saldo negativo, sotto zero. Già nel 1954 Darrell Huff nel
best seller “Mentire con le statistiche” spiegava che i politici hanno una
tendenza innata alla manipolazione della matematica. Che in sé è oggettiva e non
opinabile, ma la sua interpretazione è assai discutibile. Prendiamo il tasso di
disoccupazione: un dato che dovrebbe essere obiettivo e invece dipende da decine
di parametri: hai risultati diversi se consideri o meno gli scolarizzati,
l’ampiezza della popolazione che misuri, puoi decidere se dare il tasso annuale,
mensile, tendenziale. «Alla fine il politico sceglie quello che gli conviene
maggiormente. L’ambizione primaria dei partiti non è quella di riformare il
Paese, ma costruire consenso», spiega ancora Diamanti. «E i numeri sono invece
facili da strumentalizzare. Io per primo, quando faccio sondaggi elettorali, so
che il mio lavoro può essere usato come mezzo di condizionamento delle masse.
Bisogna, proprio per questo, che gli studi siano autorevoli, e che i media
sappiano discernere tra fatti e fattoidi». La propaganda non è l’unico modo in
cui i politici e gli opinionisti stuprano le cifre. Altra caratteristica
nazionale è quella di commentare fenomeni che non si conoscono a fondo, e
imbastire analisi con numeri orecchiati al volo. «Nessuno studia, nessuno sa
nulla, e così gli errori non si contano più. Anche perché ministri e deputati
hanno mutuato dalla Borsa, sempre affamata di previsioni, una tendenza a
pubblicare dati provvisori, che dopo poco tempo possono subire enormi
revisioni», ragiona Giacomo Vaciago, economista all’Università Cattolica di
Milano. «Questo avviene soprattutto in Italia, dove i politici hanno ormai una
veduta non corta, come diceva Tommaso Padoa-Schioppa, ma cortissima: se esce un
dato sull’occupazione o sul Pil, un sondaggio o uno studio dell’ultima
associazione dei consumatori, il politico vuole subito commentarlo, in modo da
comparire sui telegiornali delle 20, sui siti, sulla stampa e nei talk show.
Pazienza se il dato è solo una stima che può cambiare dopo qualche giorno: mal
che vada si fa sempre in tempo a tornare in tv e ricommentarlo, dicendo il
contrario di quanto affermato prima. È tutta fuffa, una bolla, numerologia
irrazionale. La cosa incredibile è che tutti noi ci viviamo in mezzo, a questa
panna montata, come fossero sabbie mobili». Così non deve stupire che esperti
vari, economisti, e persino i cervelloni di Bankitalia abbiano prodotto decine
di interventi per spiegare come spendere al meglio il tesoretto da 1,6 miliardi
di euro che dopo un po’ si è ridotto della metà, e che oggi rischia di
scomparire mangiato da un nuovo buco miliardario causato dalla sentenza della
Consulta che ha bocciato come incostituzionale quella parte della riforma
Fornero sul blocco delle pensioni (anche qui si è passati da 5 a 13 miliardi di
euro in due giorni appena). Un provvedimento che angosciò anche i cosiddetti
esodati, lavoratori finiti in un limbo tra lavoro e pensione. Per mesi non si
capì quanti fossero davvero: se il governo Monti li quantificò in 65 mila
persone, l’Inps parlò inizialmente di 130 mila casi, lievitati in una seconda
relazione tecnica a 390 mila, mentre il sindacato ne contò 300 mila. Nemmeno
fossimo alla tombola di Natale. Se fin dalle scuole elementari i numeri danno ai
futuri contribuenti un’illusoria garanzia di precisione, oggi gli italiani non
riescono a sapere con certezza nemmeno quante tasse pagano: se il ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan ha annunciato che il 2014 s’è chiuso con una
riduzione della pressione fiscale, l’Istat - classificando il bonus da 80 euro
come spesa sociale e non come riduzione del peso fiscale - ha fotografato invece
un nuovo picco, arrivato al 43,5 per cento del Pil. Anche i numeri ballerini
sulla spending review hanno intasato per mesi tv e giornali: se l’ex commissario
Carlo Cottarelli parlò di tagli «per 8-14 miliardi», il governo Renzi ha
recentemente ipotizzato «tagli per 10 miliardi». Alla fine, visto che gran parte
degli impegni è rimasta solo su carta, la spesa pubblica ha continuato a
crescere. Almeno così sostiene la Ragioneria dello Stato. Se le cifre hanno
sostituito le ideologie, coloro che le maneggiano sono diventati i nuovi guru, i
sacerdoti della modernità. «E i numeri», aggiunge Diamanti, «sono il nuovo dio:
peccato che, per definizione, siano molto meno obiettivi e infallibili di quanto
si creda». La voglia incontenibile di tabelle e grafici ha fatto esplodere la
domanda di cifre e sondaggi già da qualche lustro, ma oggi, nell’era dei Big
Data, la tendenza è ancora più evidente. La società chiede ai numeri le risposte
alle domande che pone: decisioni aziendali, personali, politiche vengono prese
innanzitutto su dati statistici. I numeri fanno ascolto, piacciono alla gente, e
non è un caso che economisti ed esperti, veri o presunti, siano diventati star
assolute della tv e del web: sondaggisti come Renato Mannheimer, Nicola Piepoli
e Nando Pagnoncelli sono ospiti fissi nei talk, ascoltati e riveriti da politici
e giornalisti come fossero la Sibilla Cumana (e pazienza se a ogni elezione le
loro previsioni si dimostrano distanti dalla realtà); economisti come Tito Boeri
hanno fondato siti di successo come lavoce.info e hanno fatto carriere
importanti (Renzi l’ha nominato presidente dell’Inps, mentre cinque suoi
redattori sono in aspettativa dopo aver ottenuto incarichi politici); piccole
associazioni di artigiani, come la Cgia di Mestre, hanno pure creato un inedito
business delle tabelle, grazie a un ufficio studi che macina centinaia di
analisi e classifiche l’anno, riprese quotidianamente da agenzie di stampa e
giornali. «Per fortuna non ho beccato neppure una smentita», disse il segretario
Giuseppe Bortolussi in un’intervista a “Panorama”, dimenticando però le critiche
arrivate da Asl, assessori comunali, Regioni ed economisti assortiti. «Questa
associazione ha una buona notorietà, ma a volte dà i numeri», notò pure Marco
Ponti, ordinario di Economia a Milano. «Non che i numeri che dà siano
tecnicamente sbagliati, ma confonde tra di loro dati che non c’entrano affatto».
Bortolussi, per la cronaca, ha ottenuto un ritorno d’immagine straordinario, e
nel 2010 è stato anche candidato del Pd in Veneto alle regionali contro Luca
Zaia. Il doping informativo ha travolto tutto, e non c’è fenomeno che non venga
misurato e quantificato. Dal presunto boom dei suicidi degli imprenditori
(bufala di cui i media si sono occupati per mesi) all’«inflazione percepita» in
voga dopo il passaggio dalla lira all’euro, non c’è organismo o consorteria che
non abbia un suo centro studi che macina dati e fornisce tabelle facendo
concorrenza a Istat, Ocse e Eurostat: dai sindacati alla Confcommercio, da
Confindustria al Codacons di Carlo Rienzi, dalle banche al Censis, il delirio di
cifre su Pil, fatturati industriali, tasse, stime per la ripresa e crisi dei
consumi non lascia tregua a nessuno, ventiquattro ore su ventiquattro. Vittima
predestinata dell’overdose è ovviamente l’opinione pubblica, intontita da dati
che alla lunga perdono di senso e di valore, in uno tsunami di matematica che,
se da un lato allontana dalla verità, dall’altro distanzia le masse dalla
politica, dalla televisione e dai giornali. Perché in tanti, ormai, cominciano a
comprendere l’aforisma dell’ex primo ministro inglese Benjamin Disraeli:
«Esistono tre tipi di bugie: le bugie, le bugie sfacciate e le statistiche».
Così sono
aumentate le tasse sul lavoro. Ecco chi paga di più. E dove conviene emigrare.
La pressione fiscale nel nostro Paese non vuole saperne di ridursi e ha
raggiunto ormai una cifra record. Ma non tutte le categorie dei lavoratori sono
vessate allo stesso modo. E il confronto con alcuni paesi europei è impietoso,
scrive Davide Mancino su “L’Espresso”. La teoria è semplice - quasi banale: lo
stato esiste per servire i propri cittadini. A volte invece succede il
contrario, soprattutto nei momenti di difficoltà. Dall'inizio della crisi
economica il conto è diventato sempre più salato, e a pagarlo sono state le
tasse dei cittadini: anche quelle sul lavoro. I dati Ocse mostrano che rispetto
al 2007, ultimo anno prima della crisi economica, tasse sul lavoro e contributi
sono aumentate per quasi tutti i tipi di famiglie - per alcune molto più di
altre. Prendiamo una famiglia con un solo coniuge che lavora e guadagna uno
stipendio nella media - intorno ai 30mila euro lordi l'anno. Per loro, due figli
e spina dorsale della classe media italiana, in sette anni il cuneo fiscale è
passato dal 35,7 percento al 39 percento. Non ci vuole molto neppure per essere
considerati ricchi: il secondo incremento più consistente è per i single senza
figli con un reddito lordo sui 50mila euro - per un guadagno di circa 2.500 euro
netti al mese -, che fra tasse e contributi passano al 53,8 percento contro il
51,4 percento del 2007. Aumentano le pretese dello stato anche verso i
lavoratori single senza figli, nonché per le coppie in cui un coniuge ha reddito
medio e l'altro invece molto basso, sui 10mila euro. Unica eccezione, i single
con un reddito medio-basso, per i quali invece il cuneo fiscale è diminuito -
anche se di poco. Eppure tassare il lavoro ha due effetti collaterali. Il primo
- più evidente - è che sottrae reddito alle persone, così che ogni mese hanno
meno da spendere o risparmiare. Il secondo è più sottile ma non meno importante:
tanto più un datore di lavoro si trova costretto a pagare contributi elevati,
tanto più sarà difficile mantenere i dipendenti che ci sono già - per non
parlare di assumerne nuovi. È una cosa che può succedere a chiunque. Poniamo di
aver bisogno di una persona che si occupi delle pulizie, qualcuno che badi a un
anziano in famiglia. Se aumentano le tasse sul lavoro non ci sono molte
alternative: o troviamo qualcuno che si accontenta di guadagnare poco - magari
meno bravo -, oppure è necessario dargli uno stipendio più alto per compensare.
E se salgono i contributi il risultato non cambia. Ma noi non siamo ricchi, né
possiamo spendere troppo, soprattutto in tempi incerti come questi. Forse
abbiamo soltanto qualcuno che dia una mano ogni tanto, senza troppe pretese.
Così, invece di prendere qualcuno, lasciamo perdere e facciamo noi uno sforzo in
più. Risultato: meno lavoro. L'esatto contrario di quanto sarebbe necessario
mentre la disoccupazione cresce. Se invece confrontiamo l'Italia con altre
nazioni europee la troviamo nel gruppo di quelle che il lavoro lo tassano di
più. Allora forse non è un caso che tanti italiani decidano di trasferirsi a
Londra, visto proprio in Gran Bretagna per un single senza figli e con un
reddito medio-basso - una situazione comune per tanti giovani espatriati - tasse
e contributi incidono per il 26 percento. Nella stessa identica situazione, per
una persona nel nostro paese ammontano invece al 42 percento: un differenza che
vale diverse migliaia di euro - ogni anno. Non sono l'unico gruppo: in generale
nel Regno Unito il cuneo fiscale è più ridotto per tutti i tipi di famiglie e
risulta generoso soprattutto verso i single con due figli a basso reddito, per i
quali non arriva neppure al 6 percento. Anche in Spagna le famiglie sono meno
pressate dalle tasse. Qui però la differenza maggiore con il nostro paese
riguarda le coppie con figli e reddito medio basso, che sono più tutelate. Ma
poiché in Europa il paese iberico è il più simile all'Italia - sotto tutti i
punti di vista - sorprende trovare un sistema fiscale tanto diverso dal nostro.
Francia e Germania, d'altra parte, hanno livelli di tassazione sul lavoro
pressappoco equivalenti all'Italia. Non identici, però: se Londra sembra essere
un rifugio per i giovani lavoratori, Parigi va in senso opposto - lì il cuneo
fiscale per quel tipo di persone è persino più elevato che in Italia. La
Germania è un caso a parte, e riesce ad avere allo stesso tempo tasse elevate e
un livello di disoccupazione molto basso, anche per i giovani. Certo tasse e
contributi sul lavoro sono una parte importante dei balzelli che cittadini e
datori di lavoro devono versare allo stato, ma certo non gli unici. In realtà il
loro aumento, negli ultimi anni, è andato di pari passo con una crescita
generalizzata della pressione fiscale. Mentre la crisi imperversava già da
tempo, Berlusconi rassicurava il paese. “I ristoranti sono pieni”, diceva ancora
nel 2011, evitando di prendere misure - anche minime - per attenuare la gravità
degli eventi. Così la situazione è diventata ancora più grave. Dopo di lui il
governo tecnico di Monti, la cui manovra economica ha pesato di più proprio dal
lato delle imposte: in questo modo l'Italia arriva ad avere una pressione
fiscale pari al 43,5 percento del prodotto interno lordo. Ogni dieci euro
prodotti dai 60 milioni di abitanti della penisola, quattro e 35 centesimi si
trasformano in tasse dovute allo stato. È un livello mai raggiunto prima durante
la Seconda Repubblica. Il governo guidato da Enrico Letta, più avanti, non
modifica questo rapporto in maniera sostanziale. Né le cose cambiano con Renzi e
il suo bonus di 80 euro, che secondo le convenzioni statistiche internazionali
vale come ulteriore spesa pubblica - anch'essa a livelli record. Così si torna
al punto di partenza mentre l'economia resta ferma, e con lei il reddito degli
italiani - soprattutto di chi ha meno.
Cervelli in
fuga, un problema non solo italiano. Ecco chi sono e dove vanno i nostri
emigranti.
Il nostro paese continua a "esportare" laureati, ma ha difficoltà ad attrarne.
Scopri con le nostre infografiche interattive quali sono le mete principali e
dove preferiscono andare quelli con la tua età e titolo di studio, scrive Davide
Mancino su “L’Espresso”. Di italiani in giro per il mondo ce ne sono sempre di
più, e su questo non c'è dubbio. Ma chi sono, e dove vanno esattamente? Secondo
le stime prodotte dall'Ocse e aggiornate al 2010, con 450mila migranti gli Stati
Uniti sono risultati come prima meta degli espatriati italiani. Seguono Francia
(350mila), Germania (340mila), Canada (260mila), Svizzera e Australia (entrambe
185mila). Il flusso verso il Regno Unito si ferma a 140mila persone, mentre
quello diretto in Spagna a 80mila. Altri gruppi più piccoli sono andati a
cercare fortuna in Polonia, Irlanda o persino in Grecia, meno ancora
nell'esotico Giappone. Anche i dati Istat, aggiornati fino al 2013, mostrano che
negli ultimi anni i flussi di italiani che vanno via sono in aumento. Dal 2010
le cose non sembrano essere cambiate troppo e le destinazioni preferite restano,
nell'ordine, Regno Unito, Germania, Svizzera e Francia e Stati Uniti. Se però
andiamo a guardare più in dettaglio, emergono preferenze molto specifiche a
seconda dell'età, del sesso e del proprio titolo di studio. Per esempio paesi
come Stati Uniti o Gran Bretagna sono le mete preferiti dei giovani laureati,
soprattutto maschi. Chi ha un'istruzione inferiore tende invece a dirigersi
spesso verso Germania, Spagna e Svizzera. Discorso diverso per la Francia, più
in alto fra le destinazioni delle giovani donne laureate. Anche Australia e
(soprattutto) Canada risaltano per ospitare un nutrito gruppo di italiani. Di
questi buona parte è composta da anziani a bassa scolarizzazione: due mete molto
diffuse per le migrazioni del dopoguerra, e che però ora sembrano attrarre meno
chi decide di andare via. Quando si parla di emigrazione proprio i laureati sono
una delle categorie cui prestare più attenzione. Una maggiore cultura è in sé un
valore aggiunto, impossibile negarlo, e poi c'è un elemento in più. Tracciarne
le migrazioni è un utile indizio per capire quali sono i paesi più dinamici,
aperti al cambiamento e alle nuove idee: da dovunque esse vengano. Il discorso
vale anche al contrario, per stabilire i luoghi più ambiti da parte di chi
lascia il proprio paese natale. Qual è allora la situazione in Italia? Sono
pochi, pochissimi gli arrivi di laureati. E in effetti proprio l'Ocse, in uno
studio preliminare , conferma che in quanto a capacità di attirare talenti
l'Italia fa peggio di tutti gli altri paesi con cui, in teoria, vorrebbe
confrontarsi. Senza neppure voler citare Regno Unito e Stati Uniti, dove
rispettivamente il 46 e il 30 per cento dei migranti sono laureati, anche il 24
per cento della Spagna sembra un miraggio e all'Italia tocca invece fermarsi
appena sopra il 10 per cento. Da notare anche Francia (24 per cento) e Germania
(20 per cento), che in questo gioco riescono meno bene di quanto ci si potrebbe
aspettare. Un altro modo di guardarla è contare quanti sono i laureati che
arrivano rispetto a quelli che vanno via – il loro “ricambio”, se così lo
vogliamo chiamare. Qui gli Stati Uniti restano la calamita globale: nessuno
vuole andare via, mentre molti altri arrivano. Anche l'Australia, seconda in
classifica e che pure non se la cava male, resta comunque molto più indietro,
mentre altre mete attraenti per i laureati sono Israele, il Canada e la Spagna.
E l'Italia? Il bilancio è appena positivo, e comunque molto inferiore a Francia,
Germania e Regno Unito. Altrove però va peggio e si verifica una perdita
complessiva di laureati: in Irlanda e Giappone, per esempio, oppure in Finlandia
o Islanda dove per ogni due titolati che hanno lasciato il paese ne è arrivato
solo uno a sostituirli. Attirare cervelli è come cercare di riempire una
piscina: conta l'acqua nuova che arriva dall'esterno, attraverso i rubinetti, ma
anche quella che scappa via dalle crepe. Per l'Italia il problema non sembra
essere tanto il liquido che sfugge: le analisi Ocse mostrano che il tasso di
emigrazione dei laureati nel 2010 era dell'8,4 per cento, più elevato di quello
spagnolo (2,5 per cento) o francese (5,7 per cento), ma molto inferiore a quello
inglese (10,5 per cento) e in linea con la Germania (8,8 per cento). Pare
piuttosto che qualcuno ci abbia tagliato le forniture perché venire a nuotare,
alla fine, non interessava a nessuno.
Nota: i
dati
sono stime che fanno riferimento all'immigrazione nei paesi Ocse fino al
2010. In alcuni casi le statistiche escludono coloro di cui non è stato
possibile rilevare età, paese di provenienza o titolo di studio. È del tutto
probabile, dunque, che i valori reali siano leggermente più elevati.
"Schiavi"
italiani in Australia? Sì, ma legali. E invece di indignarci dovremmo imitarli.
Un'inchiesta tv ha denunciato casi di schiavismo nelle campagne
dell'isola oceanica. Gli sfruttati sono però solo una piccola parte del totale e
il sistema di Canberra offre ai migranti molte più garanzie del nostro, scrive
Stefano Vergine su “L’Espresso”. «L'odissea dei giovani schiavi italiani. Undici
ore a notte, a raccogliere cipolle». L'articolo pubblicato dal “Corriere della
Sera” racconta il risultato di un'inchiesta giornalistica condotta dalla
popolare trasmissione televisiva australiana “Four Corners”. Un programma che ha
squarciato il velo, nella terra dei canguri, sulle migliaia di giovani europei
che finiscono a lavorare gratis nelle fattorie. Tutto vero. Per gli australiani
meno informati è stato sicuramente uno shock scoprire che nel loro Paese ci sono
persone praticamente schiavizzate, raccoglitori di quei prodotti che finiscono
poi nei supermercati di Sydney, Melbourne, Brisbane, Darwin e delle altre
cittadine sparse per l'immensa isola dell'Oceania. Ma le cose sono un po' più
complicate di come appaiono. Ovvero: per tanti che hanno denunciato condizioni
di sfruttamento, ce ne sono almeno altrettanti contenti dei loro tre mesi di
vita agreste. Perché, a differenza di quanto succede in Italia con gli
extracomunitari, di fatto costretti all'illegalità oltre che talvolta
schiavizzati, in Australia i tre mesi di lavoro in campagna danno diritto a un
regolare permesso di soggiorno. L'inchiesta in questione si è concentrata sul
visto vacanza-lavoro, il “working holiday visa” . Rilasciato solo a cittadini di
alcune nazioni industrializzate, con età compresa tra i 18 e i 31 anni, costa
poche centinaia di euro e permette di stare in Australia per un anno lavorando a
tempo pieno, estendendo la permanenza di un altro anno se il migrante è disposto
a svolgere per tre mesi alcune mansioni come l'agricoltore o l'allevatore. Si
può decidere di farlo percependo uno stipendio (le paghe variano dai 10 ai 25
dollari australiani all'ora), oppure prestare la propria opera gratuitamente, in
cambio di vitto e alloggio. Nel 2014, scrive il “Corriere” della Sera citando i
dati del dipartimento per l'Immigrazione australiana, nel Paese c'erano più di
145 mila giovani con questo tipo di visto, oltre 11 mila dei quali italiani. I
casi di sfruttamento sono stati ben documentati dalla tv australiana. E pure il
"Corriere" ha dato conto di alcuni esempi, come quello di due ragazze che,
impiegate in un'azienda agricola, raccoglievano cipolle rosse «dalle sette di
sera alle sei di mattina, anche quando pioveva o faceva freddo». Il fatto è che
quelli evidenziati da “Four Corners” sono solo i casi sfortunati. Chi scrive ha
potuto sperimentare in prima persona il working holiday visa australiano. E può
assicurare che molti europei, fra cui parecchi italiani, non hanno subìto alcun
tipo di sfruttamento. Certo, con questo sistema le aziende locali beneficiano
della manodopera straniera a basso costo, ma c'è un altro lato della medaglia da
considerare. Grazie a questa politica migratoria, gli italiani e i tanti altri
cittadini stranieri che vogliono emigrare in Australia possono farlo legalmente.
Fanno la richiesta di visto online, vanno a lavorare per tre mesi in campagna,
pagati oppure solo compensati con il vitto e l'alloggio, e in questo modo si
guadagnano la possibilità di restare nel Paese per un secondo anno (in realtà,
come ricorda il “Corriere”, il governo di Canberra ha recentemente deciso di
concedere l'estensione del visto solo a chi viene pagato per lavorare). La
sostanza però non cambia. Invece di costringerli ad entrare illegalmente, come
avviene oggi per i tanti extracomunitari che continuano ad arrivare sulle nostre
coste, adottando una politica migratoria simile a quella del "working holiday
visa" si permetterebbe ai migranti di avere due anni di visto per stare nel
Paese, tempo utile per imparare la lingua e trovarsi un lavoro. Al contempo, le
aziende italiane beneficerebbero di manodopera a basso costo, come peraltro già
avviene. Ma tutto questo avverrebbe in modo legale, mentre oggi da noi le
campagne sono ancora teatro di uno sfruttamento ben più pesante rispetto a
quello visto nei casi raccontati dalla tv australiana.
Australia,
ecco i giovani «schiavi» italiani: undici ore a notte, a raccogliere cipolle nei
campi. 15 mila giovani italiani si trovano nel Paese con un visto di «Vacanza
Lavoro» rinnovabile dopo un anno. Molti subiscono ricatti, abusi e perfino
violenze sessuali, scrive di Roberta Giaconi su “Il Corriere della Sera”. Oltre
15.000 giovani italiani si trovano attualmente in Australia con un visto
temporaneo di «Vacanza Lavoro». Hanno meno di 31 anni e, spesso, una laurea in
tasca. Alla partenza, molti di loro neppure immaginano di rischiare condizioni
di aperto sfruttamento, con orari di lavoro estenuanti, paghe misere, ricatti,
vere e proprie truffe. Perlopiù finiscono nelle «farm», le aziende agricole
dell’entroterra, a raccogliere per tre lunghi mesi patate, manghi, pomodori,
uva. L’ultima denuncia arriva da un programma televisivo australiano, «Four
Corners», durante il quale diversi ragazzi inglesi e asiatici hanno raccontato
storie degradanti di molestie, abusi verbali e persino violenze sessuali. Gli
italiani non sono esclusi da questa moderna «tratta». Ne sa qualcosa Mariangela
Stagnitti, presidente del Comitato italiani all’estero di Brisbane. «In un solo
anno ho raccolto 250 segnalazioni fatte da giovani italiani sulle condizioni che
avevano trovato nelle “farm” australiane. Alcune erano terribili», spiega. Due
ragazze le hanno raccontato la loro odissea in un’azienda agricola che produceva
cipolle rosse. Lavoravano dalle sette di sera alle sei di mattina, anche quando
pioveva o faceva freddo. «Non potevano neanche andare in bagno, dovevano
arrangiarsi sul posto», dice Stagnitti. Un ragazzo, invece, era stato mandato
sul tetto a pulire una grondaia piena di foglie. «È scivolato ed è caduto giù,
ferendosi gravemente. L’ospedale mi ha chiamata perché il datore di lavoro
sosteneva che aveva fatto tutto di sua iniziativa». Secondo i dati del
dipartimento per l’Immigrazione, nel giugno dell’anno scorso in Australia
c’erano più di 145.000 ragazzi con il visto «Vacanza Lavoro», oltre 11.000 dei
quali italiani. E il nostro è uno dei Paesi da cui arriva anche il maggior
numero di richieste per il rinnovo del visto per un secondo anno. Per ottenerlo,
questi «immigrati temporanei» hanno bisogno di un documento che attesti che
hanno lavorato per tre mesi nelle zone rurali dell’Australia. E questo li rende
vulnerabili ai ricatti. «Ho sentito di tutto», dice Stagnitti. «Alcuni datori di
lavoro pagano meno di quanto era stato pattuito e, se qualcuno protesta,
minacciano di non firmare il documento per il rinnovo del visto. Altri invece
fanno bonifici regolari per sembrare in regola, ma poi obbligano i ragazzi a
restituire i soldi in contanti. E poi ci sono i giovani che accettano,
semplicemente, di pagare in cambio di una firma sul documento». Non sono in
molti a denunciare la situazione. «Quando mi chiedono cosa fare, io consiglio
loro di non accettare quelle condizioni e di chiamare subito il dipartimento per
l’Immigrazione, ma i ragazzi non lo fanno perché hanno paura di rimetterci.
Tanti mi dicono che ormai sono abituati: anche in Italia, quando riuscivano a
lavorare, lo facevano spesso in nero e sottopagati». Stagnitti alza le spalle.
«La verità è che spesso questi giovani in Italia sono disoccupati, senza molte
opzioni, per questo vengono a fare lavori che gli australiani non vogliono più
fare». Sulla scia della denuncia di «Four Corners», il governo dello stato di
Victoria ha annunciato che darà il via a un’inchiesta sulle condizioni di lavoro
nelle «farm», con l’obiettivo di stroncare gli abusi e trovare nuove forme di
regolamentazione che mettano fine allo sfruttamento. Intanto, proprio nei giorni
scorsi, il Dipartimento per l’Immigrazione ha deciso che il cosiddetto
«WWOOFing», una forma di volontariato nelle azienda agricole in cambio di vitto
e alloggio, non darà più la possibilità di fare domanda per il secondo anno di
visto «Vacanza Lavoro». «Nonostante la maggior parte degli operatori si sia
comportata correttamente - si legge in un comunicato stampa - è inaccettabile
che alcuni abbiano sfruttato lavoratori stranieri giovani e vulnerabili».
MINISTRI. UNA IMPUNITA' TUTTA PER LORO.
Indagare i ministri è diventato impossibile. Così una legge
vergogna difende la Casta. Tremonti e Matteoli sono
sotto accusa per corruzione, ma una norma soccorre i politici di governo. E le
uniche condanne risalgono a Tangentopoli, scrive Paolo Biondani su "L'Espresso".
Altero Matteoli e Giulio Tremonti Vietato indagare sulla casta di governo.
Nell’Italia saccheggiata da una corruzione enorme, c'è uno scudo legale che
protegge proprio i politici con più poteri: i ministri che controllano le casse
centrali della spesa pubblica. In questi mesi di crisi e lotta agli sprechi, i
magistrati di Venezia e di Milano hanno rimesso in moto la speciale procedura
per i reati commessi dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni. Giulio
Tremonti e Altero Matteoli, esponenti di spicco dei governi di Silvio
Berlusconi, sono accusati di corruzione. Come tutti gli indagati, fino a prova
contraria vanno considerati innocenti. Anche perché la legge in vigore non
impone più rigore e più controlli per chi conta di più, ma il contrario: come
parlamentari, non possono essere intercettati, perquisiti e tantomeno arrestati;
e come ministri, godono di privilegi speciali, tutti per loro. Che nella storia
italiana hanno quasi sempre salvato i governanti. I condannati per reati
ministeriali sono pochissimi. E gli ultimi casi risalgono ai tempi di Mani
Pulite. Prima e dopo quel periodo eccezionale, decine di accuse sono state
azzerate da un veto politico: stop alle indagini, con tanti saluti alla
giustizia. Le inchieste sui ministri sono regolate da una disciplina che alcuni
giuristi paragonano a un «fossile legale» dei tempi del vecchio codice: la legge
costituzionale numero 1 del 16 gennaio 1989. «È una normativa tecnicamente
incredibile: sembra fatta apposta per garantire l'impunità», sintetizza uno dei
magistrati che hanno condotto le nuove inchieste. Il privilegio più vistoso è
l'autorizzazione a procedere: il ministro può essere processato solo con il
permesso della Camera, se è un onorevole, o del Senato. Dietro questo muro
legale, trovano riparo anche i coimputati di ogni sorta: imprenditori,
burocrati, faccendieri, eventuali complici mafiosi. Se il Parlamento nega
l'autorizzazione, si salvano tutti. «Una vera assurdità tecnica», secondo
diversi magistrati, è il comma di legge che regola l'avvio dell'inchiesta.
Quando una Procura scopre un ipotetico reato ministeriale, non può fare niente:
«omessa ogni indagine», come prescrive l'articolo 6, i pm devono liberarsi del
fascicolo «dandone immediata comunicazione» a tutti i sospettati. Per i normali
cittadini le Procure possono, anzi devono tenere segreta l'inchiesta almeno nei
primi sei mesi, per evitare che l'indagato possa far sparire i soldi o inquinare
le prove. Per i ministri e i loro complici, la regola è rovesciata: preavviso
immediato a tutti gli indagabili, fosse anche un caso di omicidio, mafia o
droga. Messi così in allarme i sospettati, l'inchiesta va affidata a tre giudici
estratti a sorte tra tutti i magistrati del distretto, anche se non hanno mai
fatto indagini, riuniti nel cosiddetto tribunale dei ministri: un collegio che
ricorda i vecchi giudici istruttori, aboliti da un quarto di secolo. Il collegio
ha solo 90 giorni per concludere tutta l'inchiesta, prorogabili di altri 60 al
massimo. In tempi così brevi è praticamente impossibile fare rogatorie, ad
esempio, per trovare l'eventuale bottino nascosto all'estero. Alla fine, se il
tribunale archivia, il verdetto è «inoppugnabile». Se invece chiede
l'autorizzazione al processo, il Parlamento può negarla anche se il reato è
provato, «qualora reputi che l'inquisito abbia agito per la tutela di un
interesse dello Stato»: un alibi politico «insindacabile», per cui regge anche
se è falso. Con regole del genere, non meraviglia che i ministri condannati si
riducano a pochi sfortunati. Il primo e per anni unico fu Mario Tanassi,
socialdemocratico, condannato a due anni e quattro mesi, il primo marzo 1979,
dalla Corte Costituzionale con il vecchio rito: una sola sentenza
autorevolissima e inappellabile. Era il fronte italiano dello scandalo Lockheed,
innescato da un'inchiesta degli Stati Uniti che il nostro Paese non poteva
ignorare: come ministro della Difesa, Tanassi fu corrotto con 560 milioni di
lire per sbloccare l'acquisto di 14 aerei militari costosissimi. La legge del
1989 è nata proprio per garantire a ministri come lui i soliti tre gradi di
giudizio. E così è toccato al tribunale dei ministri, appena creato, indagare
sulle "carceri d'oro": le tangenti confessate a Milano, dopo l'arresto,
dall'imprenditore Bruno De Mico. Il suo processo si è chiuso nel 1994 con la
condanna definitiva a cinque anni, per concussione, dell'ex ministro Franco
Nicolazzi, anche lui del Psdi, che aveva intascato 2,5 miliardi di lire. In quel
periodo era diventato normale concedere l'autorizzazione a procedere, che nel
1993, al culmine di Tangentopoli, è stata abolita per i semplici parlamentari.
Tra i ministri, il condannato più illustre è Francesco De Lorenzo, liberale,
titolare della sanità dal 1989 al 1992, condannato a cinque anni e quattro mesi
per decine di tangenti, per un totale accertato di 4,5 milioni di euro, sborsate
dalle industrie farmaceutiche da lui favorite. Dopo Mani Pulite, invece, le
indagini sui governi sembrano fermarsi. Per tutto il ventennio dominato da
Berlusconi, la procedura per i reati ministeriali diventa un muro di gomma.
Alcune procure archiviano sul nascere decine di fascicoli. E quando il tribunale
dei ministri conferma qualche accusa, interviene il Parlamento. Tra i casi più
clamorosi spicca il salvataggio politico di Pietro Lunardi, l'ex ministro delle
grandi opere, accusato di corruzione con il cardinale Crescenzio Sepe. Nel 2010
il tribunale dei ministri conclude che Lunardi ha acquistato a prezzo bassissimo
un palazzo di lusso dall’ente religioso Propaganda Fide, che intanto otteneva
cinque milioni di euro dal governo«in assoluta carenza dei presupposti». I
magistrati invocano per quattro volte l'autorizzazione a procedere, ma il
parlamento le blocca una dopo l'altra chiedendo sempre «approfondimenti». Nello
stesso periodo beneficia dello stop politico al processo anche il ministro
Matteoli, accusato di favoreggiamento per aver rivelato a un amico prefetto che
era sotto intercettazione per tangenti su speculazioni edilizie all'Isola
d'Elba. Dopo la bocciatura del lodo Alfano, (che avrebbe sospeso i processi al
premier) l'immunità ministeriale è stata invocata pure nel caso Ruby:
Berlusconi, secondo la sua maggioranza, telefonò in questura per far rilasciare
la minorenne marocchina agendo da premier, perché credeva veramente che fosse la
nipote di Mubarak. Quindi la Camera ha votato un conflitto di attribuzioni, ma
la Corte Costituzionale, il 12 aprile 2012, ha dato ragione alla Procura di
Milano, scrivendo che «era obbligata a indagare». Pochi ricordano che anche
Giulio Andreotti, dopo una carriera costellata di mancate autorizzazioni a
procedere, tentò di sottrarsi allo storico processo di Palermo per complicità
con la mafia (poi chiuso con la prescrizione fino al 1980 e l'assoluzione per
gli anni successivi) accampando la competenza del tribunale dei ministri di
Roma. Ma i giudici hanno replicato che Andreotti era sotto accusa solo come
capo-corrente della Dc. Ora si ricomincia da due. La nuova Camera ha già
autorizzato il processo a Matteoli: i padroni del Mose di Venezia hanno
confessato di avergli versato 550 mila euro, oltre a dover inserire una sua
società, intestata secondo l'accusa a un prestanome, nei maxi-finanziamenti per
disinquinare Porto Marghera. E al Senato pende la richiesta di procedere contro
Tremonti per una presunta corruzione targata Finmeccanica: 2,6 milioni di euro
mascherati da parcella per il suo studio professionale. Il tribunale dei
ministri ha firmato un atto d’accusa che sembra quasi una sentenza di condanna.
Ma l’affare è del 2008/2009, per cui Tremonti potrà comunque approfittare della
vecchia, cara legge sulla prescrizione.
PER GLI ONOREVOLI...NON C'E' FRETTA.
Onorevole inquisito? Non c'è fretta. La melina delle Camere che
rallenta i giudici. Due anni di attesa per le
intercettazioni di Verdini. Quasi uno per quelle dell'Ncd Azzollini. Sei mesi
(finora) per l'autorizzazione nei confronti dell'ex ministro Matteoli e tempi
ancora vaghi per le offese di Calderoli alla Kyenge. Quando è indagato un suo
componente, il Parlamento se la prende comoda, scrive Paolo Fantauzzi su
"L'Espresso". Paragonare un ministro di origini congolesi a un orango è
un'opinione insindacabile espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari?
Comunque la pensiate, sappiate ci vuole molto tempo prima di stabilirlo. Pure
se, dopo un'istruttoria durata settimane e settimane, per decidere ci vorrebbe
assai poco. E per autorizzare la magistratura a procedere nei confronti di un ex
ministro accusato di aver intascato mezzo milione di euro? Possono volerci anche
sei mesi. Troppo? Sciocchezze, perché come niente si può arrivare anche a un
anno o due di attesa. Parafrasando Bogart, sono i tempi dell'immunità
parlamentare, bellezza. Un istituto pensato per proteggere deputati e senatori
dal rischio di intenti persecutori della magistratura, trasformatosi col tempo
in un tribunale preventivo preoccupato più che altro di salvarli dai processi.
Ma a regalare anzitempo generose assoluzioni non c'è solo questo scudo
giudiziario, che ha trasformato l'immunità in impunità e portato a respingere
nella Seconda repubblica il 90 per cento delle richieste di arresto avanzate dai
giudici . Prima ancora di arrivare a un verdetto, qualunque sia, si assiste
infatti puntualmente a una sorta di "melina" calcistica che dilata a dismisura i
tempi. Il caso di Denis Verdini è emblematico: il Parlamento ci ha messo due
anni prima di concedere l'uso delle sue intercettazioni nell'inchiesta sulla P4,
in cui è accusato di corruzione. Era maggio 2012 quando il gup Cinzia Parasporo
ha trasmesso alla Camera la richiesta di usare una trentina di telefonate
captate indirettamente tra l'allora deputato, che in quanto tale non poteva
essere intercettato, e la "cricca" delle Grandi opere (Angelo Balducci, Fabio De
Santis e Riccardo Fusi). La Giunta delle autorizzazioni di Montecitorio aveva
anche espresso parere positivo e nel giro di un mese era tutto pronto. Bastava
solo trovare uno spazio nel calendario dei lavori d'Aula. Invece, nonostante ci
fossero mesi e mesi a disposizione, niente da fare. Risultato: la legislatura è
finita, Verdini è stato eletto senatore e ad aprile 2013 il gup ha dovuto di
nuovo trasmettere gli atti, stavolta a Palazzo Madama. Dove, come al gioco
dell'oca, si è ripartiti da zero. E prima del via libera è trascorso un altro
anno. Grosso modo lo stesso lasso di tempo necessario a rispondere "no" al gip
di Trani che chiedeva di usare una decina di intercettazioni indirette del
senatore Ncd Antonio Azzollini, inquisito per la presunta truffa
dell'ampliamento del porto di Molfetta . Una vicenda che mostra la mera ragion
politica che si cela a volte dietro alcune scelte: per salvare il potente
parlamentare alfaniano e in questo modo la stabilità del governo, con una
decisione senza precedenti il Pd - come ha rivelato l'Espresso - ha addirittura
convocato una riunione d'emergenza. E dire che in Giunta si era già visto di
tutto: 11 sedute in 7 mesi, due richieste di integrazioni istruttorie chieste al
giudice e altrettante audizioni del senatore, perfino una disputa sulle date in
cui erano iniziati gli ascolti. Alla fine, dopo dieci mesi di passione, il
Senato ha negato l’autorizzazione: era chiaro che mettendo sotto controllo i
telefoni degli altri indagati i pm avrebbero intercettato anche il parlamentare,
ha motivato nella sua relazione il senatore Pd Claudio Moscardelli. Ma se quelli
di Verdini e Azzollini sono i più eclatanti, i casi sono numerosissimi. Sono
passati sei mesi, ad esempio, da quando è arrivata in Senato la richiesta di
autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Ambiente Altero
Matteoli, che secondo i pm dell’inchiesta sul Mose avrebbe ricevuto tangenti per
550 mila euro fra il 2001 e il 2012. Sarebbe bastata qualche ora per votare,
visto che la relazione istruttoria sulla vicenda è pronta dal 10 febbraio. Solo
che per settimane nessuno si è preoccupato di farla mettere all'ordine del
giorno dell’Aula. Che si è occupata di tutt’altro, fra decreti in scadenza da
convertire, emergenze, mozioni varie e perfino la richiesta di dimissioni di
fuoriusciti del Movimento cinque stelle. Adesso, dopo qualche pressing
informale, il presidente Piero Grasso ha finalmente fissato la data: il 2
aprile. Intanto, nel corso di un'audizione sugli appalti, si è assistito al
paradosso di un presidente di commissione accusato di corruzione (Matteoli)
seduto accanto al presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone. Ancora tempi
lunghi si prevedono invece per gli epiteti di Roberto Calderoli rivolti nel
luglio 2013 all’allora ministro dell’Integrazione: «Ogni tanto, smanettando con
internet, apro il sito del governo e quando vedo venire fuori la Kyenge io resto
secco. Io sono anche un amante degli animali per l’amore del cielo. Ho avuto le
tigri, gli orsi, le scimmie e tutto il resto. Però quando vedo uscire delle
sembianze di un orango, io resto ancora sconvolto». Diffamazione aggravata da
finalità di discriminazione razziale, secondo i pm bergamaschi Maria Cristina
Rota e Gianluigi Dettori. Ma non per la Giunta di Palazzo Madama, che col voto
determinante di alcuni senatori Pd si è espressa per lo stop al processo. Adesso
resta da vedere se, dopo le polemiche, l'Aula ( e soprattutto il Pd ) confermerà
o ribalterà il parere espresso. Intanto le cose vanno per le lunghe: la
relazione, affidata al forzista Lucio Malan, è pronta dal 25 febbraio ma la
questione non ha ancora trovato posto nel calendario dei lavori.. «Calderoli -
vi si legge - ha utilizzato, all'interno di un articolato intervento
sull'immigrazione fortemente critico, un'espressione forte, ma fatta
esclusivamente come battuta ad effetto, visto che il contesto, oltre che
politico, era anche ludico e cioè quello di una festa estiva organizzata».
Insomma, uno scherzo. Quindi niente processo. Non sono state poste all'ordine
del giorno nemmeno le 13 telefonate e 68 sms dell’ex senatore Pd Antonio Papania
che secondo la Procura di Trapani proverebbero la corruzione per un atto
contrario ai doveri di ufficio: tra il 2010 e il 2012 l’allora parlamentare
avrebbe ricevuto “in più occasioni utilità consistite nell’assunzione di
numerose persone a lui gradite e da lui segnalate”. Ma la vicenda è oggetto di
un ping pong che si trascina da mesi. Le carte sono arrivate a Palazzo Madama a
giugno ma se ne è iniziato a discutere solo a ottobre. A dicembre il caso è
approdato in Aula ma per una questione formale il fascicolo è stato rimandato in
Giunta. Sono trascorsi altri tre mesi e da qualche settimana è tutto pronto per
il voto dell’Assemblea. Ma tutto è ancora fermo. Va riconosciuto che quando si
tratta di arrestare un parlamentare le Camere riescono a essere più celeri: per
acconsentire a mandare dietro le sbarre i deputati Giancarlo Galan (Forza
Italia) e Francantonio Genovese (Pd), come chiesto dai giudici, ci sono voluti
“solo” due mesi. In ogni caso moltissimo se si considerano le motivazioni che
richiedono la carcerazione: pericolo di fuga, inquinamento delle prove e
reiterazione del reato. Insomma, se i rischi sono tali, a ben vedere neppure
otto settimane sono così poche. Tanto più che, a giudicare dalle date, nemmeno
in queste circostanza di estrema urgenza il Parlamento pare essere stato
particolarmente solerte nella rispondere alla magistratura. La relazione che
concedeva l'arresto di Galan per corruzione, ad esempio, è rimasta ferma una
dozzina di giorni prima di arrivare in Aula: dal 10 al 22 luglio 2014. Nel caso
di Genovese - accusato di peculato, truffa aggravata, riciclaggio, emissione di
fatture false e associazione a delinquere - le carte sono arrivate da Messina il
18 marzo 2014 ma la Giunta delle autorizzazioni di Montecitorio ha iniziato
l’esame solo il 26 e la seconda seduta si è tenuta il 10 aprile, dopo altre due
settimane. Poi, siccome c'è stata Pasqua di mezzo, altre due settimane di stop.
Casi eccezionali? Non proprio. Nella scorsa legislatura, quando fu raggiunto il
record di 11 richieste di arresto nei confronti di parlamentari, i tempi sono
stati grosso modo gli stessi. Nel 2008 ci vollero tre mesi e mezzo prima di
votare (contro) la richiesta di domiciliari per il pidiellino Nicola Di
Girolamo. E oltre due mesi prima di respingere l'arresto dell'imprenditore
Antonio Angelucci, di Vincenzo Nespoli, del consigliere del ministro Tremonti,
Marco Milanese, e consentire quello di Alfonso Papa (tutti del Pdl). Due mesi
per arrestare Alberto Tedesco (Pd) e un mese e mezzo per mandare ai domiciliari
Sergio De Gregorio (Pdl) e in carcere Luigi Lusi (Pd). Unica eccezione, quella
del deputato Pd Salvatore Margiotta: nel 2008 la Camera impiegò appena due
giorni per respingere la richiesta di arresti domiciliari, avanzata dal pm Henry
John Woodcock nell'ambito dell'inchiesta per la realizzazione del Centro oli
della Total in Basilicata. Per quelle accuse (turbativa d’asta e corruzione) lo
scorso dicembre il parlamentare dem, adesso senatore, è stato condannato in
Appello a un anno e sei mesi.
Casta, così l'immunità parlamentare è diventata lo scudo contro
arresti e processi. Dal 1994 Montecitorio e Palazzo
Madama hanno respinto il 90 per cento delle richieste di carcerazione o di
domiciliari avanzate dai giudici. E negato spesso l’uso di intercettazioni e
tabulati, sempre per un presunto fumus persecutionis nelle indagini. Una
“protezione” che con il nuovo Senato sarà estesa a sindaci e consiglieri
regionali, scrive Paolo Fantauzzi su "L'Espresso". Immunità anche per i “nuovi”
senatori. Dopo critiche, proteste, smentite e pressioni varie, alla fine lo
scudo giudiziario sarà esteso anche ai sindaci e ai consiglieri regionali che
approderanno a Palazzo Madama. E come avviene per i deputati, servirà
un’autorizzazione per arrestarli, intercettarli ed effettuare perquisizioni nei
loro riguardi. Eppure, se vorrà evitare che finisca col lancio di monetine come
durante Tangentopoli, il governo farebbe bene ad approfittare della riforma
costituzionale per congegnare un sistema che eviti gli abusi degli ultimi due
decenni. Senza contare il caso Galan , in merito al quale Montecitorio non si è
ancora espresso, su 31 richieste di arresto avanzate dai giudici nell’arco di
questo ventennio - ha ricostruito l’Espresso - 28 sono state respinte. Nove
volte su dieci, in pratica, Camera e Senato hanno ritenuto viziate da fumus
persecutionis le istanze della magistratura di mandare in carcere o ai
domiciliari un parlamentare. Un dato che mostra come la riforma dell’articolo 68
della Costituzione varata nel 1993 sull’onda di Mani pulite non sia servita a
granché. Così se nella Prima Repubblica, senza il via libera della Camera di
appartenenza, un onorevole non poteva essere inquisito e nemmeno arrestato dopo
una condanna definitiva, dal ’94 in poi l’immunità ha continuato a rappresentare
un formidabile scudo dalle vicende giudiziarie. Peraltro con una significativa
recrudescenza negli ultimi anni, visto che oltre un terzo delle richieste di
arresto sono state inoltrate nella scorsa legislatura (2008-2013). Il
berlusconiano Alfonso Papa e i democratici Luigi Lusi e Francantonio Genovese ,
arrestati negli ultimi tre anni, sono gli unici a essere finiti dietro le
sbarre. Ma fino al 2011 ogni richiesta è stata puntualmente respinta. Spesso
grazie anche al voto segreto. Come nel caso del deputato Pdl Nicola Cosentino,
accusato di concorso esterno in associazione camorristica: secondo l’istruttoria
svolta dai deputati della Giunta delle autorizzazioni di Montecitorio,
l’onorevole andava spedito in carcere come chiedeva il gip di Napoli. Ma nel
segreto dell’urna, nel 2009 l’Aula lo ha graziato , impedendo anche l’utilizzo
di alcune sue intercettazioni telefoniche. Idem nel 2011 per Alberto Tedesco
(Pd) e nel 2012 per il senatore Sergio De Gregorio (Pdl), accusato di truffa e
false fatturazioni nell’inchiesta sui fondi pubblici all’editoria e per il quale
erano stati chiesti i domiciliari. In altri casi, invece, il Parlamento si è
trasformato in una sorta di Corte di Cassazione. E anziché limitarsi ad appurare
un eventuale intento persecutorio dei pm (come previsto dalla legge), si è
spinto a dare giudizi di merito sulle inchieste. Nel 1997, ad esempio, il
deputato Carmelo Carrara (Ccd-Cdu), relatore della richiesta d’arresto di Cesare
Previti - salvato dal carcere nell’inchiesta Imi-Sir, in cui l’avvocato fu poi
condannato per corruzione in atti giudiziari - ravvisava «un’esasperazione
accusatoria del gip di Milano». Due anni dopo anche il relatore Filippo Berselli
(An) motivò il suo “no” alla richiesta di carcerazione nei confronti di Marcello
Dell’Utri per la «evidente sproporzione tra la misura cautelare adottata e i
reati contestati», ovvero tentata estorsione e calunnia. Quando il gip di Bari
nel 2006 chiese i domiciliari per Raffaele Fitto nell’ambito di un’inchiesta
sulla sanità, la Giunta della Camera stabilì all’unanimità che il pericolo di
reiterazione del reato “non appare motivato”. E quindi l’ex governatore pugliese
- poi condannato a 4 anni in primo grado - doveva restare libero. La richiesta
di carcerazione nei confronti del deputato Udc Remo Di Giandomenico, anche lui
accusato di corruzione nel 2006, era invece “connotata da fumus persecutionis,
specie in rapporto all’attualità delle esigenze cautelari”. E siccome
l’onorevole in una sua memoria difensiva alla Giunta aveva “offerto concreti
elementi di contestazione nei confronti delle accuse”, “si affievolisce la
esigenza custodiale”. Tradotto: niente arresto. Il fumo della persecuzione
Montecitorio l’aveva ravvisato anche nel 1998, nelle due diverse richieste di
carcerazione dell’ex sindaco di Taranto Giancarlo Cito (poi condannato sia per
l’una che l’ altra vicenda): entrambe furono infatti respinte. Si dirà: se
l’inchiesta è debole, è comprensibile una levata di scudi. Eppure nemmeno
un’indagine riconosciuta come fondata dagli stessi onorevoli ha portato a un
esito diverso. Quando nel 2006 il gip di Roma chiese il carcere per il deputato
Giorgio Simeoni (Forza Italia) per il pericolo d'inquinamento delle prove in
un’inchiesta sulla sanità, la maggioranza dei suoi colleghi in Giunta
osservarono che “il pericolo mancherebbe perché il quadro indiziario è tutto
sommato abbastanza solido”. Risultato: l’autorizzazione a procedere non fu
concessa nemmeno in questo caso. Il diniego agli arresti non è l’unico aspetto
significativo. Grosso modo una volta su due (in totale 26 su 58), il Parlamento
ha negato anche l’uso di uno strumento fondamentale d’indagine come le
intercettazioni. Ma le Camere non hanno solo impedito l’utilizzo delle
conversazioni captate indirettamente. In qualche caso hanno negato perfino la
semplice acquisizione dei tabulati, che consentono di ricostruire le chiamate
ricevute ed effettuate, per “tutelare la sfera di riservatezza del
parlamentare”. Pure l’insindacabilità, vero cuore dell’immunità, si è prestata a
qualche interpretazione di manica assai larga. Si tratta dello “scudo” nei
confronti delle opinioni espresse dagli eletti, una prerogativa fondamentale per
assicurare la loro indipendenza e autonomia senza il timore di essere trascinati
in tribunale. Su oltre 700 casi, il 92 per cento delle volte Montecitorio e
Palazzo Madama hanno ritenuto che i giudizi di deputati e senatori sfociati in
una causa per diffamazione erano stati espressi nell’esercizio delle funzioni
parlamentari, come prevede la legge. Pertanto gli onorevoli non erano
processabili. Un “ombrello” sotto il quale - solo per citare alcuni degli
episodi più celebri - sono finite le critiche di Francesco Storace a Giorgio
Napolitano (dalla «disdicevole storia personale», la «evidente faziosità
istituzionale» e «indegno di una carica usurpata a maggioranza»), le accuse di
Maurizio Gasparri a John Woodcock («un bizzarro pm, che spara a vanvera accuse
ridicole») oppure le intemerate di Vittorio Sgarbi contro i pm del pool di
Milano («vanno processati ed arrestati: sono un’associazione a delinquere con
libertà di uccidere che mira al sovvertimento dell'ordine democratico»). Proprio
Sgarbi, peraltro, in questi anni si è dimostrato una sorta di record-man: oltre
150 delibere di insindacabilità (un quinto del totale) hanno riguardato proprio
lui. Un dilagare generalizzato contestato dalla Corte costituzionale, che in
questi 20 anni - a seguito di conflitti di attribuzione sollevati dai giudici -
ha annullato 84 concessioni di immunità: per la Consulta si trattava di
affermazioni che nulla avevano a vedere con l’attività parlamentare. E quindi
deputati e senatori andavano processati come normali cittadini.
LA MAFIA DELL'ANTIMAFIA.
Mafia: pm Teresi, nell'antimafia ci sono persone senza scrupoli.
L'antimafia è rappresentata anche "da persone senza scrupoli che vogliono
sfruttare questo palcoscenico per potere ricevere vantaggi che sono tipici di
persona senza scrupoli". Lo denuncia il 30/04/2015 all'Adnkronos il
Procuratore aggiunto di Palermo, Vittorio Teresi. "Probabilmente esiste davvero
la mafia dell'antimafia - dice il magistrato a margine della commemorazione di
Pio La Torre e di Rosario Di Salvo - Ormai esistono non solo rischi ma anche
concreti esempi di infiltrazioni nella cultura e nella pratica giornaliera
dell'antimafia che è fatto da persone che vogliono sfruttare questo palcoscenico
per potere emergere e potere ricevere dei vantaggi che sono tipici di persone
senza scrupoli". "Non parlerei di mafia dell'antimafia, ma di mancanza di
scrupoli di una certa antimafia che esiste certa", aggiunge. Poi, parlando
dell'ex segretario del Pci La Torre ucciso il 30 aprile di 33 anni fa,
l'aggiunto dice: "Pio La Torre è stato un pioniere non solo della lotta alla
mafia, ma anche della lotta alla miseria e alla vera lotta di classe in Sicilia
- dice - La questione meridionale scissa dalla questione mafiosa era un
esercizio culturale inutile. Lui ha intuito che erano la stessa cosa e l'ha
pagata con la vita, perché ha individuato la mafia come la vera responsabile del
distacco della Sicilia dal resto della crescita della nazione. Quindi, un
esempio di capacità di vedere avanti veramente straordinario". "Ora si parla più
di lotta alla mafia come esercizio di abitudine che andrebbe rivisto e si parla
meno di questione meridionale, cioè abbiamo di nuovo scisso le due cose -
aggiunge Teresi - Continuiamo a fare finta che la storia non esista e che le due
vicende siano separate. Dobbiamo capire che la questione economica siciliana è
questione di mafia".
Giustizia:
il pm di Palermo Vittorio Teresi "nell'antimafia ci sono persone senza scrupoli",
scrive Vincenzo Vitale su "Il Garantista". In occasione della commemorazione di
Pio La Torre, l'affondo di Vittorio Teresi, Procuratore Aggiunto di Palermo.
Dopo tanti anni, si da ragione a Sciascia. Nella mitologia greca, Cronos - il
Tempo - divora i figli che esso stesso ha fatto nascere: e ne rimane un celebre
e perfino impressionante olio di Goya, dove appunto si mostra un essere
mostruoso che letteralmente prende a morsi poveri omiciattoli in sua totale
balia. Ne facciamo esperienza ogni giorno: tutto ciò che ci affatichiamo a fare
e a disfare, non appena entra nell'ambito della vita, delle cose, è già
candidato a scomparire, a dissolversi. Appena nato, il piccolo già principia ad
invecchiare. Tuttavia, in un'altra prospettiva - che è quella che qui davvero
interessa - il Tempo si fa cogliere come un potente coefficiente di
chiarificazione delle realtà più complesse: esso serve a far capire ciò che
prima non si capiva, a semplificare ciò che sembrava complicato, perfino a
dissolvere la nebbia dell'ideologia. Si pensi per esempio a come Emile Zola
abbia affidato al tempo la marcia inesorabile di quella verità che condusse poi,
dopo anni, alla definitiva riabilitazione del capitano Dreyfus, ingiustamente
accusato di spionaggio a favore dei tedeschi. È questo il caso che oggi si
registra in virtù delle dichiarazioni di Vittorio Teresi, Procuratore Aggiunto
di Palermo, il quale ha affermato all'Adnkronos che l'antimafia è rappresentata
anche "da persone senza scrupoli che vogliono sfruttare questo palcoscenico per
poter ricevere vantaggi che sono tipici di persone senza scrupoli", e che
aggiunto: "...non parlerei di mafia dell'antimafia, ma di mancanza di scrupoli
di una certa antimafia che esiste". Ebbene, ricordate un celebre articolo
pubblicato a firma di Leonardo Sciascia, nel gennaio del 1987, sul Corriere
della Sera, dal titolo (che, peraltro, non era a lui dovuto) "I professionisti
dell'antimafia", e che tante polemiche suscitò? Ricordate che il coordinamento
antimafia di Palermo, in quel tempo, inveì contro lo scrittore siciliano,
affermando che egli si era posto "ai margini della società civile"? Ricordate
che gli intellettuali di casa nostra s'indignarono profondamente alla
pubblicazione di quel pezzo e che nel nome della lotta alla mafia criticarono
aspramente Sciascia, ergendosi a difesa di Orlando e Borsellino? Basti pensare a
Eugenio Scalari. Ne nacquero poi polemiche annose ed astiose che travagliarono
dalle pagine dei giornali e di riviste di politica e di costume l'intera società
italiana, insomma una vera tempesta mediatica e ideale. E perché? Semplicemente
perché lo scrittore siciliano aveva individuato come esistesse il concreto
pericolo che, per come veniva organizzata l'antimafia, per le strategie che
usava, per il tipo di consenso a volte cieco e privo di capacità critica che
essa riusciva a capitalizzare, dietro di essa si muovesse un interesse di altro
tipo, assai meno nobile e socialmente utile, un interesse inconfessabile
destinato a costruire un vantaggio proprio o dei propri sodali, fosse esso
politico, sociale, morale, perfino economico e che perciò si trattava di
demistificarlo, portandolo a conoscenza di tutti. E ciò non certo per indebolire
la lotta alla mafia, effetto che, tradotto quale accusa mossa allo scrittore,
suonava già semplicemente insulso, ma, al contrario, per depurarla da indebite
contaminazioni che sarebbero state in grado di degradarla, di renderla dominio
di pochi invece che patrimonio di tutti. Già. Ma ciò Sciascia scriveva e
denunciava - "spirito critico mancando e retorica aiutando" - ventotto anni e
quattro mesi or sono. Ci son voluti tutti, per capire che le cose stavano
proprio così, che davvero nell'antimafia son presenti anche persone che, prive
di scrupoli, ne sfruttano il palcoscenico per lucrare vantaggi personali, come
ha efficacemente dichiarato il dott. Teresi. E, a pensarci bene, perché dovrebbe
o come potrebbe essere diversamente? Perché mai l'antimafia dovrebbe far
eccezione a tutte le altre organizzazioni umane - dal circolo degli Ufficiali
alla bocciofila - nessuna delle quali è - né pretende di esserlo - perfetta,
senza macchia, tutta ed interamente composta da persone probe, incontaminate,
incorruttibili. Del resto, come è noto, "l'incorruttibile" finì col perdere la
testa sotto la medesima lama alla quale egli stesso aveva destinato migliaia di
teste. L'antimafia, perciò, non fa al riguardo eccezione. Solo che - ed è qui la
vera differenza che, come un crinale, distingue il profetismo letterario dello
scrittore dalla pigrizia coscienziale - Sciascia ebbe la preveggenza di vederlo
ed il coraggio civile di denunciarlo quasi trent'anni or sono: e ne ebbe
rampogne e contumelie. Oggi, anche altri non solo lo comprendono, ma lo
dichiarano pubblicamente e si spera si tratti ormai di un dato definitivamente
acquisito dalla coscienza sociale. E dunque, meglio tardi che mai: il Tempo in
questo caso è stato galantuomo.
E’ TUTTA
QUESTIONE DI COSCIENZA.
A’ Cuscienza
di Antonio de Curtis-Totò
La coscienza
Volevo sapere
che cos'è questa coscienza
che spesso ho
sentito nominare.
Voglio esserne
a conoscenza,
spiegatemi,
che cosa significa.
Ho chiesto ad
un professore dell'università
il quale mi ha
detto: Figlio mio, questa parola si usava, si,
ma tanto tempo
fa.
Ora la
coscienza si è disintegrata,
pochi sono
rimasti quelli, che a questa parola erano attaccati,
vivendo con
onore e dignità.
Adesso c'è
l'assegno a vuoto, il peculato, la cambiale, queste cose qua.
Ladri, ce ne
sono molti di tutti i tipi, il piccolo, il grande,
il gigante,
quelli che sanno rubare.
Chi li
denuncia a questi ?!? Chi si immischia in questa faccenda ?!?
Sono pezzi
grossi, chi te lo fa fare.
L'olio lo
fanno con il sapone di piazza, il burro fa rimettere,
la pasta, il
pane, la carne, cose da pazzi, Si è aumentata la mortalità.
Le medicine
poi, hanno ubriacato anche quelle,
se solo compri
uno sciroppo, sei fortunato se continui a vivere.
E che vi posso
dire di certe famiglie, che la pelle fanno accapponare,
mariti, mamme,
sorelle, figlie fatemi stare zitto, non fatemi parlare.
Perciò questo
maestro di scuola mi ha detto, questa conoscenza (della coscienza)
perchè la vuoi
fare, nessuno la usa più questa parola,
adesso arrivi
tu e la vuoi ripristinare.
Insomma tu
vuoi andare contro corrente, ma questa pensata chi te l'ha fatta fare,
la gente di
adesso solo così è contenta, senza coscienza,
vuole stentare
a vivere. (Vol tirà a campà)
SE NASCI IN ITALIA…
Quando si nasce nel posto sbagliato e si continua a far finta di niente.
Steve Jobs è cresciuto a Mountain View, nella contea di Santa Clara, in
California. Qui, con il suo amico Steve Wozniak, fonda la Apple Computer, il
primo aprile del 1976. Per finanziarsi, Jobs vende il suo pulmino Volkswagen, e
Wozniak la propria calcolatrice. La prima sede della nuova società fu il garage
dei genitori: qui lavorarono al loro primo computer, l’Apple I. Ne vendono
qualcuno, sulla carta, solo sulla base dell’idea, ai membri dell’Homebrew
Computer Club. Con l’impegno d’acquisto, ottengono credito dai fornitori e
assemblano i computer, che consegnano in tempo. Successivamente portano l’idea
ad un industriale, Mike Markkula, che versa, senza garanzie, nelle casse della
società la somma di 250.000 dollari, ottenendo in cambio un terzo di Apple. Con
quei soldi Jobs e Wozniak lanciano il prodotto. Le vendite toccano il milione di
dollari. Quattro anni dopo, la Apple si quota in Borsa.
Io sono Antonio Giangrande, noto autore di saggi pubblicati su Amazon, che
raccontano questa Italia alla rovescia. A tal fine tra le tante opere da me
scritte vi è “Italiopolitania. Italiopoli degli italioti”. Di questo,
sicuramente, non gliene fregherà niente a nessuno. Fatto sta che io non faccio
la cronaca, ma di essa faccio storia, perché la quotidianità la faccio
raccontare ai testimoni del loro tempo. Certo che anche di questo non gliene può
fregar di meno a tutti. Ma una storiella raccontata da Antonio Menna che spiega
perché, tu italiano, devi darti alla fuga dall’Italia, bisogna proprio leggerla.
Mettiamo che Steve Jobs sia nato in Italia. Si chiama Stefano Lavori. Non va
all’università, è uno smanettone. Ha un amico che si chiama Stefano Vozzini.
Sono due appassionati di tecnologia, qualcuno li chiama ricchioni perchè stanno
sempre insieme. I due hanno una idea. Un computer innovativo. Ma non hanno i
soldi per comprare i pezzi e assemblarlo. Si mettono nel garage e pensano a come
fare. Stefano Lavori dice: proviamo a venderli senza averli ancora prodotti. Con
quegli ordini compriamo i pezzi. Mettono un annuncio, attaccano i volantini,
cercano acquirenti. Nessuno si fa vivo. Bussano alle imprese: “volete
sperimentare un nuovo computer?”. Qualcuno è interessato: “portamelo, ti pago a
novanta giorni”. “Veramente non ce l’abbiamo ancora, avremmo bisogno di un
vostro ordine scritto”. Gli fanno un ordine su carta non intestata. Non si può
mai sapere. Con quell’ordine, i due vanno a comprare i pezzi, voglio darli come
garanzia per avere credito. I negozianti li buttano fuori. “Senza soldi non si
cantano messe”. Che fare? Vendiamoci il motorino. Con quei soldi riescono ad
assemblare il primo computer, fanno una sola consegna, guadagnano qualcosa. Ne
fanno un altro. La cosa sembra andare. Ma per decollare ci vuole un capitale
maggiore. “Chiediamo un prestito”. Vanno in banca. “Mandatemi i vostri genitori,
non facciamo credito a chi non ha niente”, gli dice il direttore della filiale.
I due tornano nel garage. Come fare? Mentre ci pensano bussano alla porta. Sono
i vigili urbani. “Ci hanno detto che qui state facendo un’attività commerciale.
Possiamo vedere i documenti?”. “Che documenti? Stiamo solo sperimentando”. “Ci
risulta che avete venduto dei computer”. I vigili sono stati chiamati da un
negozio che sta di fronte. I ragazzi non hanno documenti, il garage non è a
norma, non c’è impianto elettrico salvavita, non ci sono bagni, l’attività non
ha partita Iva. Il verbale è salato. Ma se tirano fuori qualche soldo di
mazzetta, si appara tutto. Gli danno il primo guadagno e apparano. Ma il giorno
dopo arriva la Finanza. Devono apparare pure la Finanza. E poi l’ispettorato del
Lavoro. E l’ufficio Igiene. Il gruzzolo iniziale è volato via. Se ne sono andati
i primi guadagni. Intanto l’idea sta lì. I primi acquirenti chiamano entusiasti,
il computer va alla grande. Bisogna farne altri, a qualunque costo. Ma dove
prendere i soldi? Ci sono i fondi europei, gli incentivi all’autoimpresa. C’è un
commercialista che sa fare benissimo queste pratiche. “State a posto, avete una
idea bellissima. Sicuro possiamo avere un finanziamento a fondo perduto almeno
di 100mila euro”. I due ragazzi pensano che è fatta. “Ma i soldi vi arrivano a
rendicontazione, dovete prima sostenere le spese. Attrezzate il laboratorio,
partire con le attività, e poi avrete i rimborsi. E comunque solo per fare la
domanda dobbiamo aprire la partita Iva, registrare lo statuto dal notaio, aprire
le posizioni previdenziali, aprire una pratica dal fiscalista, i libri contabili
da vidimare, un conto corrente bancario, che a voi non aprono, lo dovete
intestare a un vostro genitore. Mettetelo in società con voi. Poi qualcosa per
la pratica, il mio onorario. E poi ci vuole qualcosa di soldi per oliare il
meccanismo alla regione. C’è un amico a cui dobbiamo fare un regalo sennò il
finanziamento ve lo scordate”. “Ma noi questi soldi non ce li abbiamo”. “Nemmeno
qualcosa per la pratica? E dove vi avviate?”. I due ragazzi decidono di chiedere
aiuto ai genitori. Vendono l’altro motorino, una collezione di fumetti. Mettono
insieme qualcosa. Fanno i documenti, hanno partita iva, posizione Inps, libri
contabili, conto corrente bancario. Sono una società. Hanno costi fissi. Il
commercialista da pagare. La sede sociale è nel garage, non è a norma, se
arrivano di nuovo i vigili, o la finanza, o l’Inps, o l’ispettorato del lavoro,
o l’ufficio tecnico del Comune, o i vigili sanitari, sono altri soldi. Evitano
di mettere l’insegna fuori della porta per non dare nell’occhio. All’interno del
garage lavorano duro: assemblano i computer con pezzi di fortuna, un po’
comprati usati un po’ a credito. Fanno dieci computer nuovi, riescono a
venderli. La cosa sembra poter andare. Ma un giorno bussano al garage. E’ la
camorra. Sappiamo che state guadagnando, dovete fare un regalo ai ragazzi che
stanno in galera. “Come sarebbe?”. “Pagate, è meglio per voi”. Se pagano,
finiscono i soldi e chiudono. Se non pagano, gli fanno saltare in aria il
garage. Se vanno alla polizia e li denunciano, se ne devono solo andare perchè
hanno finito di campare. Se non li denunciano e scoprono la cosa, vanno in
galera pure loro. Pagano. Ma non hanno più i soldi per continuare le attività.
Il finanziamento dalla Regione non arriva, i libri contabili costano, bisogna
versare l’Iva, pagare le tasse su quello che hanno venduto, il commercialista
preme, i pezzi sono finiti, assemblare computer in questo modo diventa
impossibile, il padre di Stefano Lavori lo prende da parte e gli dice “guagliò,
libera questo garage, ci fittiamo i posti auto, che è meglio”. I due ragazzi si
guardano e decidono di chiudere il loro sogno nel cassetto. Diventano garagisti.
La Apple in Italia non sarebbe nata, perchè saremo pure affamati e folli, ma se
nasci nel posto sbagliato rimani con la fame e la pazzia, e niente più.
AVVOCATI. ABILITATI COL TRUCCO
Facile dire: sono avvocato. In Italia dove impera la corruzione e la mafiosità,
quale costo intrinseco può avere un appalto truccato, un incarico pubblico
taroccato, od una falsificata abilitazione ad una professione?
Ecco perché dico: italiani, popolo di corrotti! Ipocriti che si scandalizzano
della corruttela altrui.
Io sono Antonio Giangrande, noto autore di saggi pubblicati su Amazon, che
raccontano questa Italia alla rovescia. A tal fine tra le tante opere da me
scritte vi è “Concorsopoli ed esamopoli” che tratta degli esami e dei concorsi
pubblici in generale. Tutti truccati o truccabili. Nessuno si salva. Inoltre,
nel particolare, nel libro “Esame di avvocato, lobby forense, abilitazione
truccata”, racconto, anche per esperienza diretta, quello che succede all’esame
di avvocato. Di questo, sicuramente, non gliene fregherà niente a nessuno,
neanche ai silurati a quest’esame farsa: la fiera delle vanità fasulle. Fatto
sta che io non faccio la cronaca, ma di essa faccio storia, perché la
quotidianità la faccio raccontare ai testimoni del loro tempo. Certo che anche
di questo non gliene può fregar di meno a tutti. Ma la cronistoria di questi
anni la si deve proprio leggere, affinchè, tu italiano che meriti, devi darti
alla fuga dall’Italia, per poter avere una possibilità di successo.
Anche perché i furbetti sanno come cavarsela. Francesco Speroni
principe del foro di Bruxelles. Il leghista Francesco Speroni,
collega di partito dell’ing. Roberto Castelli che da Ministro della Giustizia ha
inventato la pseudo riforma dei compiti itineranti, a sfregio delle commissioni
meridionali, a suo dire troppo permissive all’accesso della professione forense.
È l’ultima roboante voce del curriculum dell’eurodeputato leghista, nonché
suocero del capogruppo alla Camera Marco Reguzzoni, laureato nel 1999 a
Milano e dopo 12 anni abilitato a Bruxelles. Speroni ha avuto un
problema nel processo di Verona sulle camicie verdi, ma poi si è salvato grazie
all’immunità parlamentare. Anche lui era con Borghezio a sventolare bandiere
verdi e a insultare l’Italia durante il discorso di Ciampi
qualche anno fa, quando gli italiani hanno bocciato, col referendum
confermativo, la controriforma costituzionale della devolution.
E così commentò: “Gli italiani fanno schifo, l’Italia fa schifo perché non vuole
essere moderna!”. Ecco, l’onorevole padano a maggio 2011 ha ottenuto
l’abilitazione alla professione forense in Belgio (non come il
ministro Gelmini che da Brescia ha scelto Reggio Calabria) dopo
ben 12 anni dalla laurea conseguita a Milano. Speroni dunque potrà difendere
“occasionalmente in tutta Europa” spiega lo stesso neoavvocato raggiunto
telefonicamente da Elisabetta Reguitti de “Il Fatto quotidiano”.
Perché Bruxelles?
Perché in Italia è molto più difficile mentre in Belgio l’esame, non dico sia
all’acqua di rose, ma insomma è certamente più facile. Non conosco le
statistiche, ma qui le bocciature sono molte meno rispetto a quelle dell’esame
di abilitazione in Italia”.
In quei mesi di tormenti a cavallo tra il 2000 e il 2001 Mariastelalla Gelmini
si trova dunque a scegliere tra fare l’esame a Brescia o scendere giù in
Calabria, spiegherà a Flavia Amabile: «La mia famiglia non poteva permettersi di
mantenermi troppo a lungo agli studi, mio padre era un agricoltore. Dovevo
iniziare a lavorare e quindi dovevo superare l'esame per ottenere l'abilitazione
alla professione». Quindi? «La sensazione era che esistesse un tetto del 30% che
comprendeva i figli di avvocati e altri pochi fortunati che riuscivano ogni anno
a superare l'esame. Per gli altri, nulla. C'era una logica di casta, per fortuna
poi modificata perché il sistema è stato completamente rivisto». E così,
«insieme con altri 30-40 amici molto demotivati da questa situazione, abbiamo
deciso di andare a fare l'esame a Reggio Calabria». I risultati della sessione
del 2000, del resto, erano incoraggianti. Nonostante lo scoppio dello scandalo,
nel capoluogo calabrese c'era stato il primato italiano di ammessi agli orali:
93,4%. Il triplo che nella Brescia della Gelmini (31,7) o a Milano (28,1), il
quadruplo che ad Ancona. Idonei finali: 87% degli iscritti iniziali. Contro il
28% di Brescia, il 23,1% di Milano, il 17% di Firenze. Totale: 806 idonei.
Cinque volte e mezzo quelli di Brescia: 144. Quanti Marche, Umbria, Basilicata,
Trentino, Abruzzo, Sardegna e Friuli Venezia Giulia messi insieme. Insomma, la
tentazione era forte. Spiega il ministro dell'Istruzione: «Molti ragazzi
andavano lì e abbiamo deciso di farlo anche noi». Del resto, aggiunge, lei ha
«una lunga consuetudine con il Sud. Una parte della mia famiglia ha parenti in
Cilento». Certo, è a quasi cinquecento chilometri da Reggio. Ma sempre
Mezzogiorno è. E l'esame? Com'è stato l'esame? «Assolutamente regolare». Non
severissimo, diciamo, neppure in quella sessione. Quasi 57% di ammessi agli
orali. Il doppio che a Roma o a Milano. Quasi il triplo che a Brescia. Dietro
soltanto la solita Catanzaro, Caltanissetta, Salerno. Così facevan tutti, dice
Mariastella Gelmini.
La Calabria è bella perchè c’è sempre il sole, scrive Antonello Caporale su “La
Repubblica”. Milano invece spesso è velata dalla nebbia. E’ bella la Calabria
anche, per esempio, perchè il concorso per l’abilitazione alla professione di
avvocato sembra più a misura d’uomo. Non c’è il caos di Milano, diciamolo. E in
una delle dure prove che la vita ci pone resiste quel minimo di comprensione,
quell’alito di compassione… In Calabria c’è il sole, e l’abbiamo detto. Ma vuoi
mettere il mare? ”Avevo bisogno di un luogo tranquillo, dove poter concentrarmi
senza le distrazioni della mia città. Studiare e affrontare con serenità
l’esame”. Ecco, questo bisogno ha portato Antonino jr. Giovanni Geronimo La
Russa, il figlio di Ignazio, anch’egli avvocato ma soprattutto ministro della
Difesa, a trasferirsi dalla Lombardia in Calabria. Laureato a pieni voti
all’università Carlo Cattaneo, Geronimo si è abilitato con soddisfazione a
Catanzaro a soli ventisei anni. Due anni ha risieduto a Crotone. Dal 25 luglio
2005, in piazza De Gasperi, nella casa di Pasquale Senatore, l’ex sindaco
missino. E’ rimasto nella città di Pitagora fino al 18 gennaio 2007. E si è
rigenerato. Un po’ come capitò a Mariastella Gelmini, anche lei col bisogno di
esercitare al meglio la professione di avvocato prima di darsi alla politica, e
anche lei scesa in Calabria per affrontare con ottimismo l’esame. La scelta
meridionale si è rivelata azzeccata per lei e per lui. Il piccolo La Russa è
tornato in Lombardia con la forza di un leone. E dopo la pratica nello studio
Libonati-Jager, nemmeno trentenne è divenuto titolare dello studio di famiglia.
Quattordici avvocati a corso di porta Vittoria. Bellissimo. “Ma è tutto merito
mio. Mi scoccia di passare per figlio di papà”. Geronimo è amante delle auto
d’epoca, ha partecipato a due storiche millemiglia. E infatti è anche
vicepresidente dell’Aci di Milano. “Sono stato eletto, e allora?”. Nutre
rispetto per il mattone. Siede nel consiglio di amministrazione della Premafin,
holding di Ligresti, anche della Finadin, della International Strategy. altri
gioiellini del del costruttore. Geronimo è socio dell’immobiliare di famiglia,
la Metropol srl. Detiene la nuda proprietà dei cespiti che per parte di mamma ha
nel centro di Riccione. Studioso e s’è visto. Ricco si è anche capito.
Generoso, pure. Promuove infatti insieme a Barbara Berlusconi, Paolo Ligresti,
Giulia Zoppas e tanti altri nomi glamour Milano Young, onlus benefica. Per
tanti cervelli che fuggono all’estero, eccone uno che resta.
Geronimo, figlio di cotanto padre tutore di lobby e caste, che sa trovare le
soluzioni ai suoi problemi.
Vittoria delle lobby di avvocati e commercialisti:
riforma cancellata, scrive Lucia Palmerini. “…il
governo formulerà alle categorie proposte di riforma.” con questa frase è stata
annullata e cancellata la proposta di abolizione degli ordini professionali. Il
Consiglio Nazionale Forense ha fatto appello ai deputati-avvocati per modificare
la norma del disegno di legge del Ministero dell’Economia che prevedeva non solo
l’eliminazione delle restrizioni all’accesso, ma la possibilità di diventare
avvocato o commercialista dopo un praticantato di 2 anni nel primo caso e 3 nel
secondo, l’abolizione delle tariffe minime ed il divieto assoluto alla
limitazione dello svolgimento della professione da parte degli ordini. La presa
di posizione degli avvocati del PdL ha rischiato di portare alla bocciatura la
manovra economica al cui interno era inserita la norma su avvocati e
commercialisti. Tra questi, Raffaello Masci, deputato-avvocato che ha preso in
mano le redini della protesta, ha ottenuto l’appoggio del Ministro La Russa e
del Presidente del Senato Schifani, tutti accomunati dalla professione di
avvocato. La norma, apparsa per la prima volta ai primi di giugno,
successivamente cancellata e nuovamente inserita nei giorni scorsi è stata
definitivamente cancellata; il nuovo testo quanto mai inutile recita: “Il
governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di
liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche si legge nel testo, e
inoltre – trascorso il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente
regolamentato sarà libero.” La situazione non cambia e l’Ordine degli
avvocati può dormire sogni tranquilli. Ancora una volta gli interessi ed i
privilegi di una casta non sono stati minimamente scalfiti o messi in
discussione.
GLI ANNI PASSANO, NULLA CAMBIA ED E’ TUTTO TEMPO PERSO.
Devo dire, per onestà, che il mio calvario è iniziato nel momento in cui ho
incominciato la mia pratica forense. A tal proposito, assistendo alle udienze
durante la mia pratica assidua e veritiera, mi accorgevo che il numero dei
Praticanti Avvocato presenti in aula non corrispondeva alla loro reale entità
numerica, riportata presso il registro tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Taranto. Mi accorsi, anche, che i praticanti, per l’opera prestata a
favore del dominus, non ricevevano remunerazione, o ciò avveniva in nero, né per
loro si pagavano i contributi. Chiesi conto al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Taranto. Mi dissero “Fatti i fatti tuoi. Intanto facci vedere il
libretto di pratica, che poi vediamo se diventi avvocato”. Controllarono il
libretto, contestando la veridicità delle annotazioni e delle firme di
controllo. Non basta. Nonostante il regolare pagamento dei bollettini di
versamento di iscrizione, a mio carico venne attivata procedura di riscossione
coattiva con cartella di pagamento, contro la quale ho presentato opposizione,
poi vinta. Di fatto: con lor signori in Commissione di esame forense, non sono
più diventato avvocato. A dar loro manforte, sempre nelle commissioni d’esame,
vi erano e vi sono i magistrati che io ho denunciato per le loro malefatte.
Sessione d’esame d’avvocato 1998-1999.
Presidente di Commissione, Avv. Antonio De Giorgi, Presidente Consiglio Ordine
degli Avvocati di Lecce. Sono stato bocciato. A Lecce mi accorgo di alcune
anomalie di legalità, tra cui il fatto che 6 Avetranesi su 6 vengono bocciati,
me compreso, e che molti Commissari suggerivano ai candidati incapaci quanto
scrivere nell’elaborato. Chi non suggeriva non impediva che gli altri lo
facessero. Strano era, che compiti simili, copiati pedissequamente, erano
valutati in modo difforme.
Sessione d’esame d’avvocato 1999-2000.
Presidente di Commissione, Avv. Gaetano De Mauro, Principe del Foro di Lecce.
Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie aumentano. Sul Quotidiano di Lecce il
Presidente della stessa Commissione d’esame dice che: “il numero degli avvocati
è elevato e questa massa di avvocati è incompatibile con la realtà socio
economica del Salento. Così nasce la concorrenza esasperata”. L’Avv. Pasquale
Corleto nello stesso articolo aggiunge: “non basta studiare e qualificarsi,
bisogna avere la fortuna di entrare in determinati circuiti, che per molti non
sono accessibili”. L’abuso del potere della Lobby forense è confermato
dall’Antitrust, che con provvedimento n. 5400, il 3 ottobre 1997 afferma: “ E'
indubbio che, nel controllo dell'esercizio della professione, si sia pertanto
venuto a determinare uno sbilanciamento tra lo Stato e gli Ordini e che ciò
abbia potuto favorire la difesa di posizioni di rendita acquisite dai
professionisti già presenti sul mercato.”
Sessione d’esame d’avvocato 2000-2001.
Presidente di Commissione, Avv. Antonio De Giorgi, Presidente Consiglio Ordine
degli Avvocati di Lecce. Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie aumentano. La
percentuale di idonei si diversifica: 1998, 60 %, 1999, 25 %, 2000, 49 %, 2001,
36 %. Mi accorgo che paga essere candidato proveniente dalla sede di esame,
perché, raffrontando i dati per le province del distretto della Corte D’Appello,
si denota altra anomalia: Lecce, sede d’esame, 187 idonei; Taranto 140 idonei;
Brindisi 59 idonei. Non basta, le percentuali di idonei per ogni Corte D’Appello
nazionale variano dal 10% del Centro-Nord al 99% di Catanzaro. L’esistenza degli
abusi è nel difetto e nell’eccesso della percentuale. Il TAR Lombardia, con
ordinanza n.617/00, applicabile per i compiti corretti da tutte le Commissioni
d’esame, rileva che i compiti non si correggono per mancanza di tempo. Dai
verbali risultano corretti in 3 minuti. Con esperimento giudiziale si accerta
che occorrono 6 minuti solo per leggere l’elaborato. Il TAR di Lecce,
eccezionalmente contro i suoi precedenti, ma conforme a pronunzie di altri TAR,
con ordinanza 1394/00, su ricorso n. 200001275 di Stefania Maritati, decreta la
sospensiva e accerta che i compiti non si correggono, perché sono mancanti di
glosse o correzioni, e le valutazioni sono nulle, perché non motivate. In sede
di esame si disattende la Direttiva CEE 48/89, recepita con D.Lgs.115/92, che
obbliga ad accertare le conoscenze deontologiche e di valutare le attitudini e
le capacità di esercizio della professione del candidato, garantendo così
l'interesse pubblico con equità e giustizia. Stante questo sistema di
favoritismi, la Corte Costituzionale afferma, con sentenza n. 5 del 1999: "Il
legislatore può stabilire che in taluni casi si prescinda dall'esame di Stato,
quando vi sia stata in altro modo una verifica di idoneità tecnica e sussistano
apprezzabili ragioni che giustifichino l'eccezione". In quella situazione,
presento denuncia penale contro la Commissione d’esame presso la Procura di Bari
e alla Procura di Lecce, che la invia a Potenza. Inaspettatamente, pur con prove
mastodontiche, le Procure di Potenza e Bari archiviano, senza perseguirmi per
calunnia. Addirittura la Procura di Potenza non si è degnata di sentirmi.
Sessione d’esame d’avvocato 2001-2002.
Presidente di Commissione, Avv. Antonio De Giorgi, Presidente Consiglio Ordine
degli Avvocati di Lecce. Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie aumentano.
L’on. Luca Volontè, alla Camera, il 5 luglio 2001, presenta un progetto di
legge, il n. 1202, in cui si dichiara formalmente che in Italia gli esami per
diventare avvocato sono truccati. Secondo la sua relazione diventano avvocati
non i capaci e i meritevoli, ma i raccomandati e i fortunati. Tutto mira alla
limitazione della concorrenza a favore della Lobby. Addirittura c’è chi va in
Spagna per diventare avvocato, per poi esercitare in Italia senza fare l’esame.
A questo punto, presso la Procura di Taranto, presento denuncia penale contro la
Commissione d’esame di Lecce con accluse varie fonti di prova. Così fanno altri
candidati con decine di testimoni a dichiarare che i Commissari suggeriscono.
Tutto lettera morta.
Sessione d’esame d’avvocato 2002-2003.
Presidente di Commissione, Avv. Luigi Rella, Principe del Foro di Lecce.
Ispettore Ministeriale, Giorgino. Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie
aumentano. Lo stesso Ministero della Giustizia, che indice gli esami di
Avvocato, mi conferma che in Italia gli esami sono truccati. Non basta, il
Ministro della Giustizia, Roberto Castelli, propone il decreto legge di modifica
degli esami, attuando pedissequamente la volontà del Consiglio Nazionale Forense
che, di fatto, sfiducia le Commissioni d’esame di tutta Italia. Gli Avvocati
dubitano del loro stesso grado di correttezza, probità e legalità. In data
03/05/03, ad Arezzo si riunisce il Consiglio Nazionale Forense con i
rappresentanti dei Consigli dell’Ordine locali e i rappresentanti delle
associazioni Forensi. Decidono di cambiare perché si accorgono che in Italia i
Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati abusano del loro potere per essere
rieletti, chiedendo conto delle raccomandazioni elargite, e da qui la loro
incompatibilità con la qualità di Commissario d’esame. In data 16/05/03, in
Consiglio dei Ministri viene accolta la proposta di Castelli, che adotta la
decisione del Consiglio Nazionale Forense. Ma in quella sede si decide, anche,
di sbugiardare i Magistrati e i Professori Universitari, in qualità di
Commissari d’esame, prevedendo l’incompatibilità della correzione del compito
fatta dalla stessa Commissione d’esame. Con D.L. 112/03 si stabilisce che il
compito verrà corretto da Commissione territorialmente diversa e i Consiglieri
dell’Ordine degli Avvocati non possono essere più Commissari. In Parlamento, in
sede di conversione del D.L., si attua un dibattito acceso, riscontrabile negli
atti parlamentari, dal quale scaturisce l’esistenza di un sistema concorsuale
marcio ed illegale di accesso all’avvocatura. Il D.L. 112/03 è convertito nella
Legge 180/03. I nuovi criteri prevedono l’esclusione punitiva dei Consiglieri
dell’Ordine degli Avvocati dalle Commissioni d’esame e la sfiducia nei
Magistrati e i Professori Universitari per la correzione dei compiti. Però,
acclamata istituzionalmente l’illegalità, si omette di perseguire per abuso
d’ufficio tutti i Commissari d’esame. Non solo. Ad oggi continuano ad essere
Commissari d’esame gli stessi Magistrati e i Professori Universitari, ma è
allucinante che, nelle nuove Commissioni d’esame, fanno parte ex Consiglieri
dell’Ordine degli Avvocati, già collusi in questo stato di cose quando erano in
carica. Se tutto questo non basta a dichiarare truccato l’esame dell’Avvocatura,
il proseguo fa scadere il tutto in una illegale “farsa”. Il Ministero, alla
prova di scritto di diritto penale, alla traccia n. 1, erroneamente chiede ai
candidati cosa succede al Sindaco, che prima nega e poi rilascia una concessione
edilizia ad un suo amico, sotto mentite spoglie di un’ordinanza. In tale sede i
Commissari penalisti impreparati suggerivano in modo sbagliato. Solo io rilevavo
che la traccia era errata, in quanto riferita a sentenze della Cassazione
riconducibili a violazioni di legge non più in vigore. Si palesava l’ignoranza
dell’art.107, D.Lgs. 267/00, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, in
cui si dispongono le funzioni dei dirigenti, e l’ignoranza del D.P.R. 380/01,
Testo Unico in materia edilizia. Da molti anni, con le varie Bassanini, sono
entrate in vigore norme, in cui si prevede che è competente il Dirigente
dell’Ufficio Tecnico del Comune a rilasciare o a negare le concessioni edilizie.
Rilevavo che il Sindaco era incompetente. Rilevavo altresì che il Ministero dava
per scontato il comportamento dei Pubblici Ufficiali omertosi, che lavorando con
il Sindaco e conoscendo i fatti penalmente rilevanti, non li denunciavano alla
Magistratura. Per non aver seguito i loro suggerimenti, i Commissari mi danno 15
(il minimo) al compito esatto, 30 (il massimo) agli altri 2 compiti. I candidati
che hanno scritto i suggerimenti sbagliati, sono divenuti idonei. Durante la
trasmissione “Diritto e Famiglia” di Studio 100, lo stesso Presidente
dell’Ordine di Taranto, Egidio Albanese, ebbe a dire: “l’esame è blando,
l’Avvocatura è un parcheggio per chi vuol far altro, diventa avvocato il
fortunato, perché la fortuna aiuta gli audaci”. Si chiede copia del compito con
la valutazione contestata. Si ottiene, dopo esborso di ingente denaro, per
vederlo immacolato. Non contiene una correzione, né una motivazione alla
valutazione data. Intanto, il Consiglio di Stato, VI sezione, con sentenza
n.2331/03, non giustifica più l’abuso, indicando l’obbligatorietà della
motivazione. Su queste basi di fatto e di diritto si presenta il ricorso al TAR.
Il TAR, mi dice: “ dato che si disconosce il tutto, si rigetta l’istanza di
sospensiva. Su queste basi vuole che si vada nel merito, per poi decidere sulle
spese di giudizio?”
Sessione d’esame d’avvocato 2003-2004.
Presidente di Commissione, Avv. Francesco Galluccio Mezio, Principe del Foro di
Lecce. Sono stato bocciato. A Lecce le anomalie aumentano. I candidati
continuano a copiare dai testi, dai telefonini, dai palmari, dai compiti passati
dai Commissari. I candidati continuano ad essere aiutati dai suggerimenti dei
Commissari. I nomi degli idonei circolano mesi prima dei risultati. I candidati
leccesi, divenuti idonei, come sempre, sono la stragrande maggioranza rispetto
ai brindisini e ai tarantini. Alla richiesta di visionare i compiti, senza
estrarre copia, in segreteria, per ostacolarmi, non gli basta l’istanza orale,
ma mi impongono la tangente della richiesta formale con perdita di tempo e
onerose spese accessorie. Arrivano a minacciare la chiamata dei Carabinieri se
non si fa come impongono loro, o si va via. Le anomalie di regolarità del
Concorso Forense, avendo carattere generale, sono state oggetto della denuncia
formale presentata presso le Procure Antimafia e presso tutti i Procuratori
Generali delle Corti d’Appello e tutti i Procuratori Capo della Repubblica
presso i Tribunali di tutta Italia. Si presenta l’esposto al Presidente del
Consiglio e al Ministro della Giustizia, al Presidente della Commissione
Parlamentare Antimafia e Giustizia del Senato. La Gazzetta del Mezzogiorno, in
data 25/05/04, pubblica la notizia che altri esposti sono stati presentati
contro la Commissione d’esame di Lecce (vedi Michele D’Eredità). Tutto lettera
morta.
Sessione d’esame d’avvocato 2004-2005.
Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Marcello Marcuccio, Principe
del Foro di Lecce. Sono stato bocciato. Durante le prove d’esame ci sono gli
stessi suggerimenti e le stesse copiature. I pareri motivati della prova scritta
avvenuta presso una Commissione d’esame vengono corretti da altre Commissioni.
Quelli di Lecce sono corretti dalla Commissione d’esame di Torino, che da anni
attua un maggiore sbarramento d’idoneità. Ergo: i candidati sanno in anticipo
che saranno bocciati in numero maggiore a causa dell’illegale limitazione della
concorrenza professionale. Presento l’ennesima denuncia presso la Procura di
Potenza, la Procura di Bari, la Procura di Torino e la Procura di Milano, e
presso i Procuratori Generali e Procuratori Capo di Lecce, Bari, Potenza e
Taranto, perché tra le altre cose, mi accorgo che tutti i candidati provenienti
da paesi amministrati da una parte politica, o aventi Parlamentari dello stesso
colore, sono idonei in percentuale molto maggiore. Tutto lettera morta.
Sessione d’esame d’avvocato 2005-2006.
Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Raffaele Dell’Anna. Principe
del Foro di Lecce. Sono stato bocciato. Addirittura i Commissari dettavano gli
elaborati ai candidati. Gente che copiava dai testi. Gente che copiava dai
palmari. Le valutazioni delle 7 Sottocommissioni veneziane non sono state
omogenee, se non addirittura contrastanti nei giudizi. Il Tar di Salerno,
Ordinanza n.1474/2006, conforme al Tar di Lecce, Milano e Firenze, dice che
l’esame forense è truccato. I Tar stabiliscono che i compiti non sono corretti
perché non vi è stato tempo sufficiente, perché non vi sono correzioni, perché
mancano le motivazioni ai giudizi, perché i giudizi sono contrastanti, anche in
presenza di compiti copiati e non annullati. Si è presentata l’ulteriore
denuncia a Trento e a Potenza. Tutto lettera morta.
Sessione d’esame d’avvocato 2006-2007.
Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Giangaetano Caiaffa. Principe
del Foro di Lecce. Presente l’Ispettore Ministeriale Vito Nanna. I posti a
sedere, negli anni precedenti assegnati in ordine alfabetico, in tale sessione
non lo sono più, tant’è che si sono predisposti illecitamente gruppi di ricerca
collettiva. Nei giorni 12,13,14 dicembre, a dispetto dell’orario di convocazione
delle ore 07.30, si sono letti i compiti rispettivamente alle ore 11.45, 10.45,
11.10. Molte ore dopo rispetto alle ore 09.00 delle altre Commissioni d’esame.
Troppo tardi, giusto per agevolare la dettatura dei compiti tramite cellulari,
in virtù della conoscenza sul web delle risposte ai quesiti posti. Commissione
di correzione degli scritti è Palermo. Per ritorsione conseguente alle mie lotte
contro i concorsi forensi truccati e lo sfruttamento dei praticanti, con
omissione di retribuzione ed evasione fiscale e contributiva, dopo 9 anni di
bocciature ritorsive all’esame forense e ottimi pareri resi, quest’anno mi danno
15, 15, 18 per i rispettivi elaborati, senza correzioni e motivazioni: è il
minimo. Da dare solo a compiti nulli. La maggior parte degli idonei è leccese,
in concomitanza con le elezioni amministrative, rispetto ai tarantini ed ai
brindisini. Tramite le televisioni e i media nazionali si promuove un ricorso
collettivo da presentare ai Tar di tutta Italia contro la oggettiva invalidità
del sistema giudiziale rispetto alla totalità degli elaborati nel loro
complesso: per mancanza, nelle Sottocommissioni di esame, di tutte le componenti
professionali necessarie e, addirittura, del Presidente nominato dal Ministero
della Giustizia; per giudizio con motivazione mancante, o illogica rispetto al
quesito, o infondata per mancanza di glosse o correzioni, o incomprensibile al
fine del rimedio alla reiterazione degli errori; giudizio contrastante a quello
reso per elaborati simili; giudizio non conforme ai principi di correzione;
giudizio eccessivamente severo; tempo di correzione insufficiente. Si presenta
esposto penale contro le commissioni di Palermo, Lecce, Bari, Venezia, presso
le Procure di Taranto, Lecce, Potenza, Palermo, Caltanissetta, Bari, Venezia,
Trento. Il Pubblico Ministero di Palermo archivia immediatamente, iscrivendo il
procedimento a carico di ignoti, pur essendoci chiaramente indicati i 5 nomi dei
Commissari d’esame denunciati. I candidati di Lecce disertano in modo assoluto
l’iniziativa del ricorso al Tar. Al contrario, in altre Corti di Appello vi è
stata ampia adesione, che ha portato a verificare, comparando, modi e tempi del
sistema di correzione. Il tutto a confermare le illegalità perpetrate, che
rimangono impunite.
Sessione d’esame d’avvocato 2007-2008.
Tutto come prima. Presidente di Commissione Avv. Massimo Fasano, Principe del
Foro di Lecce. Addirittura uno scandalo nazionale ha sconvolto le prove scritte:
le tracce degli elaborati erano sul web giorni prima rispetto alla loro lettura
in sede di esame. Le risposte erano dettate da amici e parenti sul cellulare e
sui palmari dei candidati. Circostanza da sempre esistita e denunciata dal
sottoscritto nell’indifferenza generale. Questa volta non sono solo. Anche il
Sottosegretario del Ministero dell’Interno, On. Alfredo Mantovano, ha presentato
denuncia penale e una interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia,
chiedendo la nullità della prova, così come è successo per fatto analogo a Bari,
per i test di accesso alla Facoltà di Medicina. Anche per lui stesso risultato:
insabbiamento dell’inchiesta.
Sessione d’esame d’avvocato 2008-2009.
Tutto come prima. Presidente di Commissione Avv. Pietro Nicolardi, Principe del
Foro di Lecce. E’ la undicesima volta che mi presento a rendere dei pareri
legali. Pareri legali dettati ai candidati dagli stessi commissari o dai
genitori sui palmari. Pareri resi su tracce già conosciute perché pubblicate su
internet o perché le buste sono aperte ore dopo rispetto ad altre sedi, dando il
tempo ai candidati di farsi passare il parere sui cellulari. Pareri di 5 o 6
pagine non letti e corretti, ma dichiarati tali in soli 3 minuti, nonostante vi
fosse l’onere dell’apertura di 2 buste, della lettura, della correzione, del
giudizio, della motivazione e della verbalizzazione. Il tutto fatto da
commissioni illegittime, perché mancanti dei componenti necessari e da giudizi
nulli, perché mancanti di glosse, correzioni e motivazioni. Il tutto fatto da
commissioni che limitano l’accesso e da commissari abilitati alla professione
con lo stesso sistema truccato. Da quanto emerge dal sistema concorsuale
forense, vi è una certa similitudine con il sistema concorsuale notarile e
quello giudiziario e quello accademico, così come le cronache del 2008 ci hanno
informato. Certo è che se nulla hanno smosso le denunce del Ministro
dell’Istruzione, Gelmini, lei di Brescia costretta a fare gli esami a Reggio
Calabria, e del Sottosegretario al Ministero degli Interni, Mantovano, le
denunce insabbiate dal sottoscritto contro i concorsi truccati, mi porteranno,
per ritorsione, ad affrontare l’anno prossimo per la dodicesima volta l’esame
forense, questa volta con mio figlio Mirko. Dopo essere stato bocciato allo
scritto dell’esame forense per ben 11 volte, che ha causato la mia indigenza ho
provato a visionare i compiti, per sapere quanto fossi inetto. Con mia
meraviglia ho scoperto che il marcio non era in me. La commissione esaminatrice
di Reggio Calabria era nulla, in quanto mancante di una componente necessaria.
Erano 4 avvocati e un magistrato. Mancava la figura del professore
universitario. Inoltre i 3 temi, perfetti in ortografia, sintassi e grammatica,
risultavano visionati e corretti in soli 5 minuti, compresi i periodi di
apertura di 6 buste e il tempo della consultazione, valutazione ed estensione
del giudizio. Tempo ritenuto insufficiente da molti Tar. Per questi motivi,
senza entrare nelle tante eccezioni da contestare nel giudizio, compresa la
comparazione di compiti identici, valutati in modo difforme, si appalesava la
nullità assoluta della decisione della commissione, già acclarata da precedenti
giurisprudenziali. Per farmi patrocinare, ho provato a rivolgermi ad un principe
del foro amministrativo di Lecce. Dal noto esponente politico non ho meritato
risposta. Si è di sinistra solo se si deve avere, mai se si deve dare. L’istanza
di accesso al gratuito patrocinio presentata personalmente, dopo settimane,
viene rigettata. Per la Commissione di Lecce c’è indigenza, ma non c’è motivo
per il ricorso!!! Nel processo amministrativo si rigettano le istanze di
ammissione al gratuito patrocinio per il ricorso al Tar per mancanza di “fumus”:
la commissione formata ai sensi della finanziaria 2007 (Governo Prodi) da 2
magistrati del Tar e da un avvocato, entra nel merito, adottando una sentenza
preventiva senza contraddittorio, riservandosi termini che rasentano la
decadenza per il ricorso al Tar.
Sessione d’esame d’avvocato 2009-2010.
Tutto come prima. Presidente di Commissione Avv. Angelo Pallara, Principe del
Foro di Lecce. Nella sua sessione, nonostante i candidati fossero meno della
metà degli altri anni, non ci fu notifica postale dell’ammissione agli esami. E’
la dodicesima volta che mi presento. Questa volta con mio figlio Mirko.
Quantunque nelle sessioni precedenti i miei compiti non fossero stati corretti e
comunque giudicate da commissioni illegittime, contro le quali mi è stato
impedito il ricorso al Tar. Le mie denunce penali presentate a Lecce, Potenza,
Catanzaro, Reggio Calabria, e i miei esposti ministeriali: tutto lettera morta.
Alle mie sollecitazioni il Governo mi ha risposto: hai ragione, provvederemo. Il
provvedimento non è mai arrivato. Intanto il Ministro della Giustizia nomina
ispettore ministeriale nazionale per questa sessione, come negli anni
precedenti, l’avv. Antonio De Giorgi, già Presidente di commissione di esame di
Lecce, per gli anni 1998-99, 2000-01, 2001-02, e ricoprente l’incarico di
presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. Insomma è tutta
una presa in giro: costui con la riforma del 2003 è incompatibile a ricoprire
l’incarico di presidente di sottocommissione, mentre, addirittura, viene
nominato ispettore su un concorso che, quando lui era presidente, veniva
considerato irregolare. Comunque è di Avetrana (TA) l’avvocato più giovane
d’Italia. Il primato è stabilito sul regime dell’obbligo della doppia laurea. 25
anni. Mirko Giangrande, classe 1985. Carriera scolastica iniziata direttamente
con la seconda elementare; con voto 10 a tutte le materie al quarto superiore
salta il quinto ed affronta direttamente la maturità. Carriera universitaria nei
tempi regolamentari: 3 anni per la laurea in scienze giuridiche; 2 anni per la
laurea magistrale in giurisprudenza. Praticantato di due anni e superamento
dell’esame scritto ed orale di abilitazione al primo colpo, senza l’ausilio
degli inutili ed onerosi corsi pre esame organizzati dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati. Et Voilà, l’avvocato più giovane d’Italia. Cosa straordinaria:
non tanto per la giovane età, ma per il fatto che sia avvenuta contro ogni
previsione, tenuto conto che Mirko è figlio di Antonio Giangrande, noto
antagonista della lobby forense e della casta giudiziaria ed accademica. Ma
nulla si può contro gli abusi e le ritorsioni, nonostante che ogni anno in sede
di esame tutti coloro che gli siedono vicino si abilitano con i suoi
suggerimenti. Volontariato da educatore presso l’oratorio della parrocchia di
Avetrana, e volontariato da assistente e consulente legale presso l’Associazione
Contro Tutte le Mafie, con sede nazionale proprio ad Avetrana, fanno di Mirko
Giangrande un esempio per tanti giovani, non solo avetranesi. Questo
giustappunto per evidenziare una notizia positiva attinente Avetrana, in
alternativa a quelle sottaciute ed alle tante negative collegate al caso di
Sarah Scazzi. L’iscrizione all’Albo compiuta a novembre nonostante
l’abilitazione sia avvenuta a settembre, alla cui domanda con allegati l’ufficio
non rilascia mai ricevuta, è costata in tutto la bellezza di 650 euro tra
versamenti e bolli. Ingenti spese ingiustificate a favore di caste-azienda, a
cui non corrispondono degni ed utili servizi alle migliaia di iscritti.
Oltretutto oneri non indifferenti per tutti i neo avvocati, che non hanno mai
lavorato e hanno sopportato con sacrifici e privazioni ingenti spese per anni di
studio. Consiglio dell’Ordine di Taranto che, come riportato dalla stampa sul
caso Sarah Scazzi, apre un procedimento contro i suoi iscritti per
sovraesposizione mediatica, accaparramento illecito di cliente e compravendita
di atti ed interviste (Galoppa, Russo e Velletri) e nulla dice, invece, contro
chi, avvocati e consulenti, si è macchiato delle stesse violazioni, ma che,
venuto da lontano, pensa che Taranto e provincia sia terra di conquista
professionale e tutto possa essere permesso. Figlio di famiglia indigente ed
oppressa: il padre, Antonio Giangrande, perseguitato (abilitazione forense
impedita da 12 anni; processi, senza condanna, di diffamazione a mezzo stampa
per articoli mai scritti e di calunnia per denunce mai presentate in quanto
proprio le denunce presentate sono regolarmente insabbiate; dibattimenti in cui
il giudice è sempre ricusato per grave inimicizia perché denunciato).
Perseguitato perché noto antagonista del sistema giudiziario e forense
tarantino, in quanto combatte e rende note le ingiustizie e gli abusi in quel
che viene definito “Il Foro dell’Ingiustizia”. (insabbiamenti; errori giudiziari
noti: Morrone, Pedone, Sebai; magistrati inquisiti e arrestati). Perseguitato
perché scrive e dice tutto quello che si tace.
Sessione d’esame d’avvocato 2010-2011.
Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Maurizio Villani, Principe del
Foro di Lecce. Compresa la transumanza di candidati da un'aula all'altra per
fare gruppo. Presente anche il Presidente della Commissione Centrale Avv.
Antonio De Giorgi, contestualmente componente del Consiglio Nazionale Forense,
in rappresentanza istituzionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del
distretto della Corte di Appello di Lecce. Tutto verificabile dai siti web di
riferimento. Dubbi e critica sui modi inopportuni di nomina. Testo del
Decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina
degli esami di abilitazione alla professione forense, è convertito in legge con
le modificazioni coordinate con la legge di conversione 18 Luglio 2003, n. 180:
“Art. 1-bis: ….5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per
ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti
avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in
sostituzione di qualsiasi membro effettivo. 6. Gli avvocati componenti della
commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale
forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto,
assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno
un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere
designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine…”. Antonio De
Giorgi è un simbolo del vecchio sistema ante riforma, ampiamente criticato tanto
da riformarlo a causa della “Mala Gestio” dei Consiglieri dell’Ordine in ambito
della loro attività come Commissari d’esame. Infatti Antonio De Giorgi è stato a
fasi alterne fino al 2003 Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Lecce e contestualmente Presidente di sottocommissioni di esame di quel
Distretto. Oggi ci ritroviamo ancora Antonio De Giorgi, non più come Presidente
di sottocommissione, ma addirittura come presidente della Commissione centrale.
La norma prevede, come membro di commissione e sottocommissione, la nomina di
avvocati, ma non di consiglieri dell’Ordine. Come intendere la carica di
consigliere nazionale forense indicato dal Consiglio dell’Ordine di Lecce, se
non la sua estensione istituzionale e, quindi, la sua incompatibilità alla
nomina di Commissario d’esame. E quantunque ciò non sia vietato dalla legge, per
la ratio della norma e per il buon senso sembra inopportuno che, come presidente
di Commissione centrale e/o sottocommissione periferica d’esame, sia nominato
dal Ministro della Giustizia non un avvocato designato dal Consiglio Nazionale
Forense su proposta dei Consigli dell'Ordine, ma addirittura un membro dello
stesso Consiglio Nazionale Forense che li designa. Come è inopportuno che sia
nominato chi sia l’espressione del Consiglio di appartenenza e comunque che sia
l’eredità di un sistema osteggiato. Insomma, qui ci stanno prendendo in giro: si
esce dalla porta e si entra dalla finestra. Cosa può pensare un candidato che si
sente dire dai presidenti Villani e De Giorgi, siamo 240 mila e ci sono
quest’anno 23 mila domande, quindi ci dobbiamo regolare? Cosa può pensare
Antonio Giangrande, il quale ha denunciato negli anni le sottocommissioni
comprese quelle presiedute da Antonio De Giorgi (sottocommissioni a cui ha
partecipato come candidato per ben 13 anni e che lo hanno bocciato in modo
strumentale), e poi si accorge che il De Giorgi, dopo la riforma è stato
designato ispettore ministeriale, e poi, addirittura, è diventato presidente
della Commissione centrale? Cosa può pensare Antonio Giangrande, quando verifica
che Antonio De Giorgi, presidente anche delle sottocommissioni denunciate,
successivamente ha avuto rapporti istituzionali con tutte le commissioni d’esame
sorteggiate, competenti a correggere i compiti di Lecce e quindi anche del
Giangrande? "A pensare male, spesso si azzecca..." disse Giulio Andreotti. Nel
procedimento 1240/2011, in cui si sono presentati ben 8 motivi di nullità dei
giudizi (come in allegato), il TAR rigetta il ricorso del presente istante,
riferendosi alla sentenza della Corte Costituzionale, oltre ad addurre,
pretestuosamente, motivazioni estranee ai punti contestati (come si riscontra
nella comparazione tra le conclusioni e il dispositivo in allegato). Lo stesso
TAR, invece, ha disposto la misura cautelare per un ricorso di altro candidato
che contestava un solo motivo, (procedimento 746/2009). Addirittura con
ordinanza 990/2010 accoglieva l’istanza cautelare entrando nel merito
dell’elaborato. Ordinanza annullata dal Consiglio di Stato, sez. IV, 22 febbraio
2011, n. 595. TENUTO CONTO CHE IN ITALIA NON VI E' GIUSTIZIA SI E' PRESENTATO
RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI. Qui si rileva che la Corte di
Cassazione, nonostante la fondatezza della pretesa, non ha disposto per motivi
di Giustizia e di opportunità la rimessione dei processi dell’istante ai sensi
dell’art. 45 ss. c.p.p.. Altresì qui si rileva che la Corte di Cassazione,
sistematicamente, rigetta ogni istanza di rimessione da chiunque sia presentata
e qualunque ne sia la motivazione. Inoltre qui si rileva che la Corte
Costituzionale legittima per tutti i concorsi pubblici la violazione del
principio della trasparenza. Trasparenza, da cui dedurre l’inosservanza delle
norme sulla legalità, imparzialità ed efficienza.
Sessione d’esame d’avvocato 2011-2012.
Tutto come prima. Spero che sia l'ultima volta. Presidente di Commissione, Avv.
Nicola Stefanizzo, Principe del Foro di Lecce. Foro competente alla correzione:
Salerno. Dal sito web della Corte d’Appello di Lecce si vengono a sapere le
statistiche dell'anno 2011: Totale Candidati iscritti 1277 di cui Maschi 533
Femmine 744. Invece le statistiche dell'anno 2010: Totale Candidati inscritti
1161 di cui Maschi 471 Femmine 690. Ammessi all'orale 304; non Ammessi dalla
Commissione di Palermo 857 (74%). Si è presentata denuncia penale a tutte le
procure presso le Corti d'Appello contro le anomalie di nomina della Commissione
centrale d'esame, oltre che contro la Commissione di Palermo, in quanto questa
ha dichiarato falsamente come corretti i compiti del Dr Antonio Giangrande,
dando un 25 senza motivazione agli elaborati non corretti. Contestualmente si è
denunciato il Tar di Lecce che ha rigettato il ricorso indicanti molteplici
punti di nullità al giudizio dato ai medesimi compiti. Oltretutto motivi
sostenuti da corposa giurisprudenza. Invece lo stesso Tar ha ritenuto
ammissibili le istanze di altri ricorsi analoghi, per giunta valutando il merito
degli stessi elaborati. Antonio Giangrande, l’alfiere contro i concorsi
truccati, che per gli ipocriti è un mitomane sfigato, presenta il conto. Anzi il
rendiconto di un'Italia da schifo dove tutti si ergono a benpensanti e poi sono
i primi a fottere la legge ed i loro conterranei. Un giudizio sull’operato di un
certo giornalismo lo debbo proprio dare, tenuto conto che è noto il mio giudizio
su un sistema di potere che tutela se stesso, indifferente ai cambiamenti
sociali ed insofferente nei confronti di chi si ribella. Da anni sui miei siti
web fornisco le prove su come si trucca un concorso pubblico, nella fattispecie
quello di avvocato, e su come si paga dazio nel dimostrarlo. Nel tempo la
tecnica truffaldina, di un concorso basato su regole di un millennio fa, si è
affinata trovando sponda istituzionale. La Corte Costituzionale il 7 giugno
2011, con sentenza n. 175, dice: è ammesso il giudizio non motivato, basta il
voto. Alla faccia della trasparenza e del buon andamento e della legalità.
Insomma dove prima era possibile contestare ora non lo è più. D'altronde la
Cassazione ammette: le commissioni sbagliano ed il Tar può sindacare i loro
giudizi. Ad affermare l’importante principio di diritto sono le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione con sentenza n. 8412, depositata il 28 maggio 2012.
L’essere omertosi sulla cooptazione abilitativa di una professione od incarico,
mafiosamente conforme al sistema, significa essere complici e quindi poco
credibili agli occhi dei lettori e telespettatori, che, come dalla politica, si
allontana sempre più da un certo modo di fare informazione. Il fatto che io non
trovi solidarietà e sostegno in chi dovrebbe raccontare i fatti, mi lascia
indifferente, ma non silente sul malaffare che si perpetra intorno a me ed è
taciuto da chi dovrebbe raccontarlo. Premiale è il fatto che i miei scritti sono
letti in tutto il mondo, così come i miei video, in centinaia di migliaia di
volte al dì, a differenza di chi e censorio. Per questo è ignorato dal cittadino
che ormai, in video o in testi, non trova nei suoi servizi giornalistici la
verità, se non quella prona al potere. Dopo 15 anni, dal 1998 ancora una volta
bocciato all’esame di avvocato ed ancora una volta a voler trovare sponda per
denunciare una persecuzione. Non perché voglia solo denunciare l’esame truccato
per l’abilitazione in avvocatura, di cui sono vittima, ma perché lo stesso esame
sia uguale a quello della magistratura (con i codici commentati vietati, ma
permessi ad alcuni), del notariato (tracce già svolte), dell’insegnamento
accademico (cattedra da padre in figlio) e di tanti grandi e piccoli concorsi
nazionali o locali. Tutti concorsi taroccati, così raccontati dalla cronaca
divenuta storia. Per ultimo si è parlato del concorso dell’Agenzia delle Entrate
(inizio dell’esame con ore di ritardo e con il compito già svolto) e del
concorso dell’Avvocatura dello Stato (con i codici commentati vietati, ma
permessi ad alcuni). A quest’ultimi candidati è andata anche peggio rispetto a
me: violenza delle Forze dell’Ordine sui candidati che denunciavano l’imbroglio.
Non che sia utile trovare una sponda che denunci quanto io sostengo con prove,
tanto i miei rumors fanno boato a sè, ma si appalesa il fatto che vi è una certa
disaffezione per quelle categorie che giornalmente ci offrono con la cronaca il
peggio di sé: censura ed omertà. Per qualcuno forse è meglio che a me non sia
permesso di diventare avvocato a cause delle mie denunce presentate a chi,
magistrato, oltre che omissivo ad intervenire, è attivo nel procrastinare i
concorsi truccati in qualità di commissari. Sia chiaro a tutti: essere uno dei
10mila magistrati, uno dei 200mila avvocati, uno dei mille parlamentari, uno dei
tanti professori o giornalisti, non mi interessa più, per quello che è il loro
valore reale, ma continuerò a partecipare al concorso forense per dimostrare
dall’interno quanto sia insano. Chi mi vuol male, per ritorsione alle mie lotte,
non mi fa diventare avvocato, ma vorrebbe portarmi all’insana esasperazione di
Giovanni Vantaggiato, autore della bomba a Brindisi. Invece, questi mi hanno
fatto diventare l’Antonio Giangrande: fiero di essere diverso! Antonio
Giangrande che con le sue deflagrazioni di verità, rompe l’omertà mafiosa.
L’appoggio per una denuncia pubblica non lo chiedo per me, che non ne ho
bisogno, ma una certa corrente di pensiero bisogna pur attivarla, affinché
l’esasperazione della gente non travolga i giornalisti, come sedicenti operatori
dell’informazione, così come già avvenuto in altri campi. E gli operatori
dell’informazione se non se ne sono accorti, i ragazzi di Brindisi sono stati lì
a ricordarglielo. Si è visto la mafia dove non c’è e non la si indica dove è
chiaro che si annida. Tutti gli altri intendono “Tutte le Mafie” come un
insieme orizzontale di entità patologiche criminali territoriali (Cosa Nostra,
‘Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita, ecc.). Io intendo “Tutte le Mafie”
come un ordinamento criminale verticale di entità fisiologiche nazionali
composte, partendo dal basso: dalle mafie (la manovalanza), dalle Lobbies, dalle
Caste e dalle Massonerie (le menti). La Legalità è il comportamento umano
conforme al dettato della legge nel compimento di un atto o di un fatto. Se
l'abito non fa il monaco, e la cronaca ce lo insegna, nè toghe, nè divise, nè
poteri istituzionali o mediatici hanno la legittimazione a dare insegnamenti e/o
patenti di legalità. Lor signori non si devono permettere di selezionare secondo
loro discrezione la società civile in buoni e cattivi ed ovviamente si devono
astenere dall'inserirsi loro stessi tra i buoni. Perchè secondo questa cernita
il cattivo è sempre il povero cittadino, che oltretutto con le esose tasse li
mantiene. Non dimentichiamoci che non ci sono dio in terra e fino a quando
saremo in democrazia, il potere è solo prerogativa del popolo. Quindi abolizione
dei concorsi truccati e liberalizzazione delle professioni. Che sia il libero
mercato a decidere chi merita di esercitare la professione in base alle capacità
e non in virtù della paternità o delle amicizie. Un modo per poter vincere la
nostra battaglia ed abolire ogni esame truccato di abilitazione, c'è! Essere in
tanti a testimoniare il proprio dissenso. Ognuno di noi, facente parte dei
perdenti, inviti altri ad aderire ad un movimento di protesta, affinchè possiamo
essere migliaia e contare politicamente per affermare la nostra idea.
Generalmente si è depressi e poco coraggiosi nell'affrontare l'esito negativo di
un concorso pubblico. Se già sappiamo che è truccato, vuol dire che la
bocciatura non è a noi addebitale. Cambiamo le cose, aggreghiamoci, contiamoci
attraverso facebook. Se siamo in tanti saremo appetibili e qualcuno ci
rappresenterà in Parlamento. Altrimenti ci rappresenteremo da soli. Facciamo
diventare questo dissenso forte di migliaia di adesioni. Poi faremo dei convegni
e poi delle manifestazioni. L'importante far sapere che il candidato perdente
non sarà mai solo e potremo aspirare ad avere una nuova classe dirigente capace
e competente.
Sessione d’esame d’avvocato 2012-2013.
Tutto come prima. Presidente di Commissione, Avv. Francesco Flascassovitti,
Principe del Foro di Lecce, il quale ha evitato la transumanza di candidati da
un'aula all'altra per fare gruppo con una semplice soluzione: il posto
assegnato. Ma ciò non ha evitato l’espulsione di chi è stato scoperto a copiare
da fonti non autorizzate o da compiti stilati forse da qualche commissario,
oppure smascherato perché scriveva il tema sotto dettatura da cellulare munito
di auricolare. Peccato per loro che si son fatti beccare. Tutti copiavano, così
come hanno fatto al loro esame gli stessi commissari che li hanno cacciati. Ed è
inutile ogni tentativo di apparir puliti. Quattromila aspiranti avvocati si sono
presentati alla Nuova Fiera di Roma per le prove scritte dell'esame di
abilitazione forense 2012. I candidati si sono presentati all'ingresso del
secondo padiglione della Fiera sin dalle prime ore del mattino, perchè a Roma
c'è l'obbligo di consegnare i testi il giorno prima, per consentire alla
commissione di controllare che nessuno nasconda appunti all'interno. A Lecce
sono 1.341 i giovani (e non più giovani come me) laureati in Giurisprudenza.
Foro competente alla correzione: Catania. Un esame di Stato che è diventato un
concorso pubblico, dove chi vince, vince un bel niente. Intanto il mio ricorso,
n. 1240/2011 presentato al Tar di Lecce il 25 luglio 2011 contro la valutazione
insufficiente data alle prove scritte della sessione del 2010 adducente
innumerevoli nullità, contenente, altresì, domanda di fissazione dell’udienza di
trattazione, non ha prodotto alcun giudizio, tanto da farmi partecipare, nelle
more ed in pendenza dell’esito del ricorso, a ben altre due sessioni successive,
il cui esito è identico ai 15 anni precedenti: compiti puliti e senza
motivazione, voti identici e procedura di correzione nulla in più punti. Per
l’inerzia del Tar è stati costretti di presentare istanza di prelievo il
09/07/2012. Dall’udienza fissata e tenuta del 7 novembre 2012 non vi è stata
alcuna notizia dell’esito dell’istanza, nonostante altri ricorsi analoghi
presentati un anno dopo hanno avuto celere ed immediato esito positivo di
accoglimento. Ormai l’esame lo si affronta non tanto per superarlo, in quanto
dopo 15 anni non vi è più soddisfazione, dopo una vita rovinata non dai singoli
commissari, avvocati o magistrati o professori universitari, che magari sono
anche ignari su come funziona il sistema, ma dopo una vita rovinata da un intero
sistema mafioso, che si dipinge invece, falsamente, probo e corretto, ma lo si
affronta per rendere una testimonianza ai posteri ed al mondo. Per raccontare,
insomma, una realtà sottaciuta ed impunita. A Lecce sarebbero solo 440 su 1258 i
compiti ritenuti validi. Questo il responso della Commissione di Catania,
presieduta dall’Avvocato Antonio Vitale, addetta alla correzione degli
elaborati. Più di cento scritti finiscono sul tavolo della Procura della
Repubblica con l’accusa di plagio, per poi, magari, scoprire che è tutta una
bufala. Copioni a parte, sarebbe, comunque, il 65% a non superare l’esame:
troppi per definirli asini, tenuto conto che, per esperienza personale, so che
alla fase di correzione non si dedicano oltre i 5 minuti, rispetto ai 15/20
minuti occorrenti. Troppo pochi per esprimere giudizi fondati. Da 20 anni
denuncio che in Italia agli esami tutti si copia ed adesso scoprono l’acqua
calda. E copiano tutti. Si ricordi il “Vergogna, Vergogna” all’esame per
magistrato o il “Buffoni, Buffoni” all’esame di notaio, o le intemperanze agli
esami per l’avvocatura di Stato o la prova annullata per l’esame di notaio nel
2010 o di magistrato nel 1992. Sarebbe il colmo dei paradossi se tra quei 100 ci
fosse il mio nome. A parlar di sé e delle proprie disgrazie in prima persona,
oltre a non destare l’interesse di alcuno pur nelle tue stesse condizioni, può
farti passare per mitomane o pazzo. Non sto qui a promuovermi, tanto chi mi
conosce sa cosa faccio anche per l’Italia e per la sua città. Non si può, però,
tacere la verità storica che ci circonda, stravolta da verità menzognere
mediatiche e giudiziarie. Ad ogni elezione legislativa ci troviamo a dover
scegliere tra: il partito dei condoni; il partito della CGIL; il partito dei
giudici. Io da anni non vado a votare perché non mi rappresentano i nominati in
Parlamento. A questo punto mi devono spiegare cosa centra, per esempio, la
siciliana Anna Finocchiaro con la Puglia e con Taranto in particolare.
Oltretutto mi disgustano le malefatte dei nominati. Un esempio per tutti, anche
se i media lo hanno sottaciuto. La riforma forense, approvata con Legge 31
dicembre 2012, n. 247, tra gli ultimi interventi legislativi consegnatici
frettolosamente dal Parlamento prima di cessare di fare danni. I nonni avvocati
in Parlamento (compresi i comunisti) hanno partorito, in previsione di un loro
roseo futuro, una contro riforma fatta a posta contro i giovani. Ai fascisti che
hanno dato vita al primo Ordinamento forense (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 -
Ordinamento della professione di avvocato e di procuratore convertito con la
legge 22 gennaio 1934 n.36) questa contro riforma reazionaria gli fa un baffo.
Trattasi di una “riforma”, scritta come al solito negligentemente, che non viene
in alcun modo incontro ed anzi penalizza in modo significativo i giovani. Da
venti anni inascoltato denuncio il malaffare di avvocati e magistrati ed il loro
malsano accesso alla professione. Cosa ho ottenuto a denunciare i trucchi per
superare l’esame? Insabbiamento delle denunce e attivazione di processi per
diffamazione e calunnia, chiusi, però, con assoluzione piena. Intanto ti
intimoriscono. Ed anche la giustizia amministrativa si adegua. A parlar delle
loro malefatte i giudici amministrativi te la fanno pagare. Presento l’oneroso
ricorso al Tar di Lecce (ma poteva essere qualsiasi altro Tribunale
Amministrativo Regionale) per contestare l’esito negativo dei miei compiti
all’esame di avvocato: COMMISSIONE NAZIONALE D'ESAME PRESIEDUTA DA CHI NON
POTEVA RICOPRIRE L'INCARICO, COMMISSARI (COMMISSIONE COMPOSTA DA MAGISTRATI,
AVVOCATI E PROFESSORI UNIVERSITARI) DENUNCIATI CHE GIUDICANO IL DENUNCIANTE E
TEMI SCRITTI NON CORRETTI, MA DA 15 ANNI SONO DICHIARATI TALI. Ricorso, n.
1240/2011 presentato al Tar di Lecce il 25 luglio 2011 contro il voto numerico
insufficiente (25,25,25) dato alle prove scritte di oltre 4 pagine cadaune della
sessione del 2010 adducente innumerevoli nullità, contenente, altresì, domanda
di fissazione dell’udienza di trattazione. Tale ricorso non ha prodotto alcun
giudizio nei tempi stabiliti, salvo se non il diniego immediato ad una istanza
cautelare di sospensione, tanto da farmi partecipare, nelle more ed in pendenza
dell’esito definitivo del ricorso, a ben altre due sessioni successive, i cui
risultati sono stati identici ai temi dei 15 anni precedenti (25,25,25): compiti
puliti e senza motivazione, voti identici e procedura di correzione nulla in più
punti. Per l’inerzia del Tar si è stati costretti a presentare istanza di
prelievo il 09/07/2012. Inspiegabilmente nei mesi successivi all’udienza fissata
e tenuta del 7 novembre 2012 non vi è stata alcuna notizia dell’esito
dell’istanza, nonostante altri ricorsi analoghi presentati un anno dopo hanno
avuto celere ed immediato esito positivo di accoglimento. Eccetto qualcuno che
non poteva essere accolto, tra i quali i ricorsi dell'avv. Carlo Panzuti e
dell'avv. Angelo Vantaggiato in cui si contestava il giudizio negativo reso ad
un elaborato striminzito di appena una pagina e mezza. Solo in data 7 febbraio
2013 si depositava sentenza per una decisione presa già in camera di consiglio
della stessa udienza del 7 novembre 2012. Una sentenza già scritta, però, ben
prima delle date indicate, in quanto in tale camera di consiglio (dopo aver
tenuto anche regolare udienza pubblica con decine di istanze) i magistrati
avrebbero letto e corretto (a loro dire) i 3 compiti allegati (più di 4 pagine
per tema), valutato e studiato le molteplici questioni giuridiche presentate a
supporto del ricorso. I magistrati amministrativi potranno dire che a loro
insindacabile giudizio il mio ricorso va rigettato, ma devono spiegare non a me,
ma a chi in loro pone fiducia, perché un ricorso presentato il 25 luglio 2011,
deciso il 7 novembre 2012, viene notificato il 7 febbraio 2013? Un'attenzione
non indifferente e particolare e con un risultato certo e prevedibile, se si
tiene conto che proprio il presidente del Tar era da considerare incompatibile
perchè è stato denunciato dal sottoscritto e perché le sue azioni erano oggetto
di inchiesta video e testuale da parte dello stesso ricorrente? Le gesta del
presidente del Tar sono state riportate da Antonio Giangrande, con citazione
della fonte, nella pagina d'inchiesta attinente la città di Lecce. Come per
dire: chi la fa, l'aspetti? QUANTO SONO ATTENDIBILI LE COMMISSIONI D’ESAME?
Ogni anno a dicembre c’è un evento che stravolge la vita di molte persone.
Il Natale? No! L’esame di avvocato che si svolge presso ogni Corte di Appello ed
affrontato da decine di migliaia di candidati illusi. La domanda sorge
spontanea: c’è da fidarsi delle commissioni dei concorsi pubblici o degli esami
di Stato? «Dai dati emersi da uno studio effettuato: per nulla!». Così opina
Antonio Giangrande, lo scrittore, saggista e sociologo storico, che sul tema ha
scritto un libro “CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. L’Italia dei concorsi e degli esami
pubblici truccati” tratto dalla collana editoriale “L’ITALIA DEL TRUCCO,
L’ITALIA CHE SIAMO”. E proprio dalle tracce delle prove di esame che si inizia.
Appunto. Sbagliano anche le tracce della Maturità. “Le parole sono importanti”,
urlava Nanni Moretti nel film Palombella Rossa alla giornalista che,
senza successo, provava a intervistarlo. E’ proprio dalla commissione dell’esame
di giornalismo partiamo e dalle tracce da queste predisposte. Giusto per
saggiare la sua preparazione. La commissione è quella ad avere elaborato le
tracce d’esame. In particolare due magistrati (scelti dalla corte d’appello di
Roma) e cinque giornalisti professionisti. Ne dà conto il sito de l’Espresso,
che pubblica sia i documenti originali consegnati ai candidati, sia la versione
degli stessi per come appare sul sito dell’Ordine, cioè con le correzioni (a
penna) degli errori. Ossia: “Il pubblico ministero deciderà se convalidare o
meno il fermo”. Uno strafalcione: compito che spetta al giudice delle indagini
preliminari. Seguono altre inesattezze come il cognome del pm (che passa da
Galese a Galesi) e una citazione del regista Carlo Lizzani, in cui “stacco la
chiave” diventa “stacco la spina”. Sarà per questo che Indro Montanelli decise
di non affrontare l’esame e Milena Gabanelli di non riaffrontarlo? Sarà per
questo che Paolo Mieli è stato bocciato? E che dire di Aldo Busi il cui compito
respinto era considerato un capolavoro e ricercato a suon di moneta? È in buona
compagnia la signora Gabanelli & Company. Infatti si racconta che anche Alberto
Moravia fu bocciato all’esame da giornalista professionista. Poco male. Sono le
eccezioni che confermano la regola. Non sono gli esami giudicate da siffatte
commissioni che possono attribuire patenti di eccellenza. Se non è la
meritocrazia ha fare leva in Italia, sono i mediocri allora a giudicare. Ed a un
lettore poco importa sapere se chi scrive ha superato o meno l'esame di
giornalismo. Peccato che per esercitare una professione bisogna abilitarsi ed
anche se eccelsi non è facile che i mediocri intendano l'eccellenza.
L’esperienza e il buon senso, come sempre, sono le qualità fondamentali che
nessuno (pochi) può trasmettere o sa insegnare. Del resto, si dice che anche
Giuseppe Verdi fu bocciato al Conservatorio e che Benedetto Croce e Gabriele
D’Annunzio non si erano mai laureati. Che dire delle Commissioni di esame di
avvocato. Parliamo della sessione 2012. Potremmo parlarne per le sessioni
passate, ma anche per quelle future: tanto in questa Italia le cose nefaste sono
destinate a durare in eterno. A Lecce sarebbero solo 440 su 1258 i compiti
ritenuti validi. Questo il responso della Commissione di Catania, presieduta
dall’Avvocato Antonio Vitale, addetta alla correzione degli elaborati. Più di
cento scritti finiscono sul tavolo della Procura della Repubblica con l’accusa
di plagio, per poi, magari, scoprire che è tutta una bufala. Copioni a parte,
sarebbe, comunque, il 65% a non superare l’esame: troppi per definirli asini,
tenuto conto che, per esperienza personale, so che alla fase di correzione non
si dedicano oltre i 5 minuti, rispetto ai 15/20 minuti occorrenti. Troppo pochi
per esprimere giudizi fondati. Oltretutto l’arbitrio non si motiva nemmeno
rilasciando i compiti corretti immacolati. Prescindendo dalla caccia mirata alle
streghe, c’è forse di più? Eppure c’è chi queste commissioni li sputtana. TAR
Lecce: esame forense, parti estratte da un sito? Legittimo se presenti in un
codice commentato. È illegittimo l’annullamento dell’elaborato dell’esame di
abilitazione forense per essere alcune parti estratte da un sito, se tali parti
sono presenti all’interno di un codice commentato. (Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima, Ordinanza 19 settembre 2013, n.
465). E’ lo stesso Tar Catania che bacchetta la Commissione d’esame di Avvocato
della stessa città Esame di avvocato...Copiare non sempre fa rima con annullare
- TAR CATANIA ordinanza n. 1300/2010. Esame avvocato: Qualora in sede di
correzione dell'elaborato si accerta che il lavoro sia in tutto o in parte
copiato da altro elaborato o da qualche manuale, per condurre all’annullamento
della prova, deve essere esatto e rigoroso. Tale principio di diritto è
desumibile dall’ordinanza in rassegna n. 1300/2010 del TAR Catania che ha
accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale avanzata avverso la
mancata ammissione del ricorrente alla prova orale dell’esame di avvocato. In
particolare, per il Tar etneo “il ricorso appare fondato, in quanto la
Commissione si è limitata ad affermare apoditticamente che il compito di diritto
penale della ricorrente conteneva “ampi passi del tutto identici all’elaborato
di penale contenuto” in altra busta recante il n. 459 senza alcuna
specificazione, anche sul compito, che consenta di appurare che questa presunta
“identità” vada oltre la semplice preparazione sui medesimi testi, o la
consultazione dei medesimi codici”. Per il TAR siciliano, inoltre, “l’elaborato
di penale del candidato contraddistinto dal n. 459 era stato corretto da una
diversa sottocommissione durante la seduta del 19 marzo 2010, e tale elaborato
non risulta essere stato parimenti annullato”. E a sua volta è la stessa
Commissione d’esame di Avvocato di Lecce ad essere sgamata. Esami di avvocato.
Il Tar di Salerno accoglie i ricorsi dei bocciati. I ricorsi accolti sono già
decine, più di trenta soltanto nella seduta di giovedì 24 ottobre 2013,
presentati da aspiranti avvocati bocciati alle ultime prove scritte da un
giudizio che il Tar ha ritenuto illegittimo in quanto non indica i criteri sui
cui si è fondato. Il Tribunale amministrativo sta quindi accogliendo le domande
cautelari, rinviando al maggio del 2014 il giudizio di merito ma indicando, per
sanare il vizio, una nuova procedura da affidare a una commissione diversa da
quella di Lecce che ha deciso le bocciature. Il numero dei bocciati, reso noto
lo scorso giugno 2013, fu altissimo. Soltanto 366 candidati, su un totale di
1.125, passarono le forche caudine dello scritto e furono ammessi alle prove
orali. Una percentuale del 32,53: quasi 17 punti in meno del 49,16 registrato
alla sessione dell’anno precedente. Numeri, questi ultimi, in linea con una
media che, poco più o poco meno, si è attestata negli ultimi anni
sull’ammissione della metà dei partecipanti. Nel 2012, invece, la ghigliottina è
caduta sul 64,09 per cento degli esaminandi. In numeri assoluti i bocciati
furono 721, a cui vanno aggiunti i 38 compiti (3,38 per cento) annullati per
irregolarità come il rinvenimento di svolgimenti uguali. Adesso una parte di
quelle persone ha visto accogliere dal Tar i propri ricorsi. I criteri usati dai
commissari per l’attribuzione del punteggio, hanno spiegato i giudici, «non si
rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle
ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della
Sottocommissione locale». La valutazione, quindi, «deve ritenersi
l'illegittima». Che ne sarà di tutti coloro che quel ricorso non lo hanno
presentato. Riproveranno l’esame e, forse, saranno più fortunati. Anche perché
vatti a fidare dei Tar. Ci si deve chiedere: se il sistema permette da sempre
questo stato di cose con il libero arbitrio in tema di stroncature dei
candidati, come mai solo il Tar di Salerno, su decine di istituzioni simili, vi
ha posto rimedio? Esami di Stato: forche caudine, giochi di prestigio o giochi
di azzardo? Certo non attestazione di merito. Sicuramente nell’affrontare
l’esame di Stato di giornalismo sarei stato bocciato per aver, questo articolo,
superato le 45 righe da 60 caratteri, ciascuna per un totale di 2.700 battute,
compresi gli spazi. Così come previsto dalle norme. Certamente, però, si leggerà
qualcosa che proprio i giornalisti professionisti preferiscono non dire: tutte
le commissioni di esame sono inaffidabili, proprio perché sono i mediocri a
giudicare, in quanto in Italia sono i mediocri a vincere ed a fare carriera!
Sessione d’esame d’avvocato 2013-2014. Tutto come prima.
Presidente di Commissione, Avv. Luigi Covella, Principe del
Foro di Lecce. Presidente coscienzioso e preparato. Compiti come sempre uguali
perché la soluzione la forniva il commissario, il compagno di banco od i testi
non autorizzati. Naturalmente anche in questa sessione un altro tassello si
aggiunge ad inficiare la credibilità dell’esame forense. "La S.V. ha superato le
prove scritte e dovrà sostenere le prove orali dinanzi alla Sottocommissione".
"Rileviamo che sono state erroneamente immesse nel sistema le comunicazioni
relative all’esito delle prove scritte e le convocazioni per le prove orali".
Due documenti, il secondo contraddice e annulla il primo (che è stato un
errore), sono stati inviati dalla Corte di Appello di Lecce ad alcuni
partecipanti alla prova d’esame per diventare avvocato della tornata 2013,
sostenuta nel dicembre scorso. Agli esami di avvocato della Corte di Appello di
Lecce hanno partecipato circa mille praticanti avvocati e gli elaborati sono
stati inviati per la correzione alla Corte di Appello di Palermo. (commissari da
me denunciati per concorsi truccati già in precedente sessione). L’errore ha
provocato polemiche e critiche sul web da parte dei candidati. La vicenda sembra
avere il sapore di una beffa travestita da caos burocratico, ma non solo. Che in
mezzo agli idonei ci siano coloro che non debbano passare e al contrario tra gli
scartati ci siano quelli da far passare? E lì vi è un dubbio che assale i
malpensanti. Alle 17 del 19 giugno nella posta di alcuni candidati
(nell’Intranet della Corte di Appello) è arrivata una comunicazione su carta
intestata della stessa Corte di Appello, firmata dal presidente della
commissione, avvocato Luigi Covella, con la quale si informava di aver superato
"le prove scritte" fissando anche le date nelle quali sostenere le prove orali,
con la prima e la seconda convocazione. Tre ore dopo, sul sito ufficiale
corteappellolecce.it, la smentita con una breve nota. "Rileviamo – è scritto –
che sono state erroneamente immesse nel sistema le comunicazioni relative
all’esito delle prove scritte e le convocazioni per le prove orali. Le predette
comunicazioni e convocazioni non hanno valore legale in quanto gli esiti delle
prove scritte non sono stati ancora pubblicati in forma ufficiale. Gli esiti
ufficiali saranno resi pubblici a conclusione delle operazioni di inserimento
dei dati nel sistema, attualmente ancora in corso". Sui forum animati dai
candidati sul web è scoppiata la protesta e in tanti si sono indignati.
"Vergogna", scrive Rosella su mininterno.net. "Quello che sta accadendo non ha
precedenti. Mi manca soltanto sapere di essere stato vittima di uno scherzo!",
puntualizza Pier. Un candidato che si firma Sicomor: "un classico in Italia...
divertirsi sulla sorte della povera gente! poveri noi!". Un altro utente
attacca: "Si parano il c... da cosa? L’anno scorso i risultati uscirono il
venerdì sera sul profilo personale e poi il sabato mattina col file pdf sul sito
pubblico della Corte! La verità è che navighiamo in un mare di poca
professionalità e con serietà pari a zero!". Frank aggiunge: "Ma come è
possibile una cosa simile stiamo parlando di un concorso!". Il pomeriggio di
lunedì 23 giugno 2014 sono stati pubblicati i nomi degli idonei all’orale.
Quelli “giusti”, questa volta. E dire che trattasi della Commissione d’esame di
Palermo da me denunciata e della commissione di Lecce, da me denunciata. Che
consorteria tra toghe forensi e giudiziarie. Sono 465 i candidati ammessi alla
prova orale presso la Corte di Appello di Lecce. E' quanto si apprende dalla
comunicazione 21 giugno 2013 pubblicata sul sito della Corte di Appello
di Lecce. Il totale dei partecipanti era di 1.258 unità: la percentuale degli
ammessi risulta pertanto pari al 36,96%. Una percentuale da impedimento
all’accesso. Percentuale propria delle commissioni d’esame di avvocato nordiste
e non dell’insulare Palermo. Proprio Palermo. Il
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Termini Imerese, in primo
grado fu condannato a 10 mesi. L’accusa: truccò il concorso per avvocati. Non fu
sospeso. Da “La
Repubblica” di Palermo del 10/01/2001: Parla il giovane aspirante avvocato, che
ha portato con sé una piccola telecamera per filmare “palesi irregolarità”. «Ho
le prove nel mio video del concorso truccato. Ho un’altra cassetta con sette
minuti di immagini, che parlano da sole. Oggi sarò sentito dal magistrato. A lui
racconterò tutto ciò che ho visto. La giornata di un concorsista, aspirante
avvocato, comincia alle quattro e mezza del mattino. Alle sei devi esser in
prima fila. Ed è quello il momento in cui capisci come vanno le cose. Tutti lo
sanno, ma nessuno ne parla». I.D.B., 38 anni, ha voluto rompere il silenzio. Nei
giorni dell’esame scritto per l’abilitazione forense si è portato dietro una
piccola telecamera e ha documentato quelle che lui chiama “palesi irregolarità”.
E’ stato bloccato dai commissari e la cassetta con le immagini è stata
sequestrata. Ma lui non si perde d’animo: «in fondo io cerco solo la verità».
Intanto, I.D.B. rompe il silenzio con “La Repubblica” perché dice «è importante
cercare un movimento d’opinione attorno a questa vicenda ». E ha già ricevuto la
solidarietà dell’associazione Nazionale Praticanti ed avvocati. «Vorrei dire –
racconta – delle sensazioni che ho provato tutte le volte che ho fatto questo
esame. Sensazioni di impotenza per quello che senti intorno. Ed è il segreto di
Pulcinella. Eccone uno: basta comunicare la prima frase del compito a chi di
dovere. Io ho chiesto i temi che avevo fatto nelle sessioni precedenti: non
c’era una correzione, una motivazione, solo un voto». Il primo giorno degli
esami scritti il giovane si è guardato intorno. L’indomani era già dietro la
telecamera: «Ho filmato circa sette minuti, in lungo ed in largo nel padiglione
20 della Fiera del Mediterraneo, dove c’erano più di novecento candidati. A casa
ho rivisto più volte il filmato e ho deciso che avrei dovuto documentare ancora.
Così è stato. Il secondo filmato, quello sequestrato, dura più del primo. A un
certo punto una collega si è accorta di me e ha chiamato uno dei commissari. Non
ho avuto alcun problema, ho consegnato la cassetta. E sin dal primo momento ho
detto: Mi sono accorto di alcune irregolarità e ho documentato. Allora mi hanno
fatto accomodare in una stanza. E insistevano: perché l’ha fatto?. Tornavo a
parlare delle irregolarità. Poi mi chiedevano chi le avesse fatte. Lo avrei
detto al presidente della commissione, in disparte. Davanti a tutti, no!» Il
giovane si dice stupito per il clamore suscitato dal suo gesto: «Non dovrebbe
essere questo a sorprendere, ho avuto solo un po’ più di coraggio degli altri».
Ma cosa c’è in quelle videocassette? L’aspirante avvocato non vuole dire di più,
fa cenno ad un commissario sorpreso in atteggiamenti confidenziali con alcuni
candidati: «Francamente non capisco perché non siano stati presi provvedimenti
per il concorso. Quei capannelli che ho ripreso sono davvero troppo da
tollerare. Altro che piccoli suggerimenti!».
Sessione
d’esame d’avvocato 2014-2015. Tutto come prima.
Presidente di
Commissione, Avv. Francesco De Jaco, Principe del Foro di Lecce. Presidente
coscienzioso e preparato. Compiti come sempre uguali perché la soluzione la
forniva il commissario, il compagno di banco od i testi non autorizzati. Sede di
Corte d’appello sorteggiata per la correzione è Brescia. Mi tocca, non come il
ministro Gelmini che da Brescia ha scelto Reggio Calabria, dopo
ben 12 anni dalla laurea conseguita a Milano. In quei mesi di tormenti a cavallo
tra il 2000 e il 2001 Mariastella Gelmini si trova dunque a scegliere tra fare
l’esame a Brescia o scendere giù in Calabria, spiegherà a Flavia Amabile: «La
mia famiglia non poteva permettersi di mantenermi troppo a lungo agli studi, mio
padre era un agricoltore. Dovevo iniziare a lavorare e quindi dovevo superare
l'esame per ottenere l'abilitazione alla professione». Quindi? «La sensazione
era che esistesse un tetto del 30% che comprendeva i figli di avvocati e altri
pochi fortunati che riuscivano ogni anno a superare l'esame. Per gli altri,
nulla. C'era una logica di casta, per fortuna poi modificata perché il sistema è
stato completamente rivisto». E così, «insieme con altri 30-40 amici molto
demotivati da questa situazione, abbiamo deciso di andare a fare l'esame a
Reggio Calabria». I risultati della sessione del 2000, del resto, erano
incoraggianti. Nonostante lo scoppio dello scandalo, nel capoluogo calabrese
c'era stato il primato italiano di ammessi agli orali: 93,4%. Il triplo che
nella Brescia della Gelmini (31,7) o a Milano (28,1), il quadruplo che ad
Ancona. Idonei finali: 87% degli iscritti iniziali. Contro il 28% di Brescia, il
23,1% di Milano, il 17% di Firenze. Totale: 806 idonei. Cinque volte e mezzo
quelli di Brescia: 144. Quanti Marche, Umbria, Basilicata, Trentino, Abruzzo,
Sardegna e Friuli Venezia Giulia messi insieme. Insomma, la tentazione era
forte. Spiega il ministro dell'Istruzione: «Molti ragazzi andavano lì e abbiamo
deciso di farlo anche noi». Del resto, aggiunge, lei ha «una lunga consuetudine
con il Sud. Una parte della mia famiglia ha parenti in Cilento». Certo, è a
quasi cinquecento chilometri da Reggio. Ma sempre Mezzogiorno è. E l'esame?
Com'è stato l'esame? «Assolutamente regolare». Non severissimo, diciamo, neppure
in quella sessione. Quasi 57% di ammessi agli orali. Il doppio che a Roma o a
Milano. Quasi il triplo che a Brescia. Dietro soltanto la solita Catanzaro,
Caltanissetta, Salerno. Così facevan tutti, dice Mariastella Gelmini. Io dal
1998 ho partecipato all’esame forense annuale. Sempre bocciato. Ho rinunciato a
proseguire nel 2014 con la commissione presieduta dall’avv. Francesco De Jaco.
L’avvocato di Cosima Serrano condannata con la figlia Sabrina Misseri per il
delitto di Sarah Scazzi. Tutte mie compaesane. La Commissione d’esame di
avvocato di Lecce 2014. La più serena che io abbia trovato in tutti questi anni.
Ho chiesto invano a lui di tutelare me, dagli abusi in quell’esame, come tutti
quelli come me che non hanno voce. Se per lui Cosima è innocente contro il
sentire comune, indotti a pensarla così dai media e dai magistrati, perché non
vale per me la verità che sia vittima di un sistema che mi vuol punire per
essermi ribellato? Si nega l’evidenza. 1, 2, 3 anni, passi. 17 anni son troppi
anche per il più deficiente dei candidati. Ma gli effetti sono sotto gli occhi
di tutti. Compiti non corretti, ma ritenuti tali in tempi insufficienti e senza
motivazione e con quote prestabilite di abilitati. Così per me, così per tutti.
Gli avvocati abilitati negano l’evidenza. Logico: chi passa, non controlla. Ma
17 anni son troppi per credere alla casualità di essere uno sfigato,
specialmente perché i nemici son noti, specie se sono nelle commissioni d’esame.
A Bari avrebbero tentato di agevolare la prova d'esame di cinque aspiranti
avvocati ma sono stati bloccati e denunciati dai Carabinieri, scrive “La
Gazzetta del Mezzogiorno”. È accaduto nella Fiera del Levante di Bari dove è in
corso da tre giorni l'esame di abilitazione professionale degli avvocati baresi.
In circa 1500 hanno sostenuto le prove scritte in questi giorni ma oggi, ultimo
giorno degli scritti, i Carabinieri sono intervenuti intercettando una busta
contenente i compiti diretti a cinque candidati. Un dipendente della Corte di
Appello, con il compito di sorvegliante nei tre giorni di prova, avrebbe
consegnato ad una funzionaria dell'Università la busta con le tracce. Lei, dopo
alcune ore, gli avrebbe restituito la busta con all'interno i compiti corretti e
un biglietto con i cinque nomi a cui consegnare i temi. Proprio nel momento del
passaggio sono intervenuti i Carabinieri, che pedinavano la donna fin dal primo
giorno, dopo aver ricevuto una segnalazione. Sequestrata la busta i militari
hanno condotto i due in caserma per interrogarli. Al momento sono indagati a
piede libero per la violazione della legge n. 475 del 1925 sugli esami di
abilitazione professionali, che prevede la condanna da tre mesi a un anno di
reclusione per chi copia. Le indagini dei Carabinieri, coordinate dal pm Eugenia
Pontassuglia, verificheranno nei prossimi giorni la posizione dei cinque
aspiranti avvocati destinatari delle tracce e quella di altre persone
eventualmente coinvolte nella vicenda. Inoltre tre aspiranti avvocatesse (una è
figlia di due magistrati), sono entrate nell’aula tirandosi dietro il telefono
cellulare che durante la prova hanno cercato di utilizzare dopo essersi
rifugiate in bagno. Quando si sono rese conto che sarebbero state scoperte, sono
tornate in aula. Pochi minuti dopo il presidente della commissione d’esame ha
comunicato il ritrovamento in bagno dei due apparecchi ma solo una delle due
candidate si è fatta avanti, subito espulsa. L’altra è rimasta in silenzio ma è
stata identifica. Esame per avvocati, la banda della truffa: coinvolti tre
legali e due dirigenti pubblici. Blitz dei carabinieri nella sede della
Finanza. E la potente funzionaria di Giurisprudenza sviene, scrive Gabriella De
Matteis e Giuliana Foschini su “La Repubblica”. Un ponte telefonico con
l'esterno. Tre avvocati pronti a scrivere i compiti. Un gancio per portare il
tutto all'interno. Sei candidati pronti a consegnare. Era tutto pronto. Anzi era
tutto fatto. Ma qualcosa è andato storto: quando la banda dell'"esame da
avvocato" credeva che tutto fosse andato per il verso giusto, sono arrivati i
carabinieri del reparto investigativo a fare saltare il banco. E a regalare
l'ennesimo scandalo concorsuale a Bari. E' successo tutto mercoledì 17 dicembre
2014 pomeriggio all'esterno dei padiglioni della Guardia di finanza dove stava
andando in scena la prova scritta per l'esame da avvocato. Mille e cinquecento
all'incirca i partecipanti, divisi in ordine alfabetico. Commissione e steward
per evitare passaggi di compiti o copiature varie. Apparentemente nulla di
strano. Apparentemente appunto. Perché non appena vengono aperte le buste e
lette le tracce si comincia a muovere il Sistema scoperto dai carabinieri.
Qualcuno dall'interno le comunica a Tina Laquale, potente dirigente
amministrativo della facoltà di Giurisprudenza di Bari. E' lei a girarle, almeno
questo hanno ricostruito i Carabinieri, a tre avvocati che avevano il compito di
redigere il parere di civile e di penale e di scrivere l'atto. Con i compiti in
mano la Laquale si è presentata all'esterno dei padiglioni. All'interno c'era un
altro componente del gruppo, Giacomo Santamaria, cancelliere della Corte
d'Appello che aveva il compito di fare arrivare i compiti ai sei candidati che
all'interno li aspettavano. Compiti che sarebbero poi stati consegnati alla
commissione e via. Ma qui qualcosa è andato storto. Sono arrivati infatti i
carabinieri che hanno bloccato tutto. Laquale è svenuta, mentre a lei e a tutte
quante le altre persone venivano sequestrati documenti e soprattutto supporti
informatici, telefoni in primis, che verranno analizzati in queste ore. Gli
investigatori devono infatti verificare se, come sembra, il sistema fosse da
tempo organizzato e rodato, se ci fosse un corrispettivo di denaro e la vastità
del fenomeno. Ieri si è tenuta la convalida del sequestro davanti al sostituto
procuratore, Eugenia Pontassuglia. Ma com'è chiaro l'indagine è appena
cominciata. Per il momento viene contestata la truffa e la violazione di una
vecchia legge del 1925 secondo la cui "chiunque in esami o concorsi, prescritti
o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di
lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per
l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il
rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi,
pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non
può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito". È molto
probabile infatti che l'esame venga invalidato per tutti. Concorso truccato
per aspiranti avvocati, gli indagati sono 5. Scatta l'accertamento sui
telefonini della dirigente dell'ateneo e del cancelliere della Corte d'appello.
Al momento si esclude ci sia stato passaggio di denaro, forse si tratta di uno
scambio di favori, scrive Gabriella De Matteis su “La Repubblica”. Un
accertamento sulle chiamate in entrata e in uscita e ancora sugli sms ricevuti
ed inviati sui telefonini del cancelliere della Corte di Appello Giacomo
Santamaria e della dirigente dell'università di Bari Tina Laquale. E' il nuovo
passo dell'inchiesta sul tentativo di truccare le prove per il conseguimento
dell'abilitazione alla professione di avvocato, scoperto dai carabinieri il 19
dicembre scorso. L'attività istruttoria, quindi, va avanti. Il fascicolo si
allarga e ora conta nuovi indagati. Sono tre candidati al concorso al quale
Giacomo Santamaria, segretario di una delle commissioni d'esame, avrebbe dovuto
passare gli elaborati, passatigli da Tina Laquale. Gli aspiranti avvocati
(Nicola Colasuonno, Rosa Chiapparino e Giuseppina Rosa Laccone, di 32, 30 e 31
anni) hanno ricevuto l'avviso di conferimento dell'incarico per l'accertamento
irripetibile sui due telefonini. Anche loro tre sono indagati e per questo hanno
diritto a nominare un proprio consulente. In questi giorni la procura ha
analizzato le informative dei carabinieri del reparto operativo. Ai cinque
vengono contestati due reati: il primo riguarda la violazione dell'articolo uno
della legge 475 del 1925. Il secondo invece è un concorso in abuso d'ufficio,
accusa che è possibile muovere perché Santamaria aveva le funzioni di pubblico
ufficiale. L'accertamento sui due telefonini, sequestrati dai carabinieri nel
terzo ed ultimo giorno di prove dell'esame, è fondamentale per capire per conto
di chi Tina Laquale abbia ideato questo tentativo di truccare il concorso o se
sia stata pagata per passare gli elaborati. Al momento si esclude ci sia stato
un passaggio di denaro, più semplicemente pensano che la truffa sia stata
organizzata in un più ampio scambio di favori. Il numero degli indagati, quindi,
è destinato a crescere. I carabinieri stanno anche cercando di capire in che
misura siano coinvolti nella vicenda tre avvocati che avrebbero redatto i tre
elaborati e soprattutto Angelo L., un altro dipendente dell'università. Agli
atti dell'inchiesta c'è, infatti, il verbale reso da Santamaria poche ore dopo
il blitz. Il cancelliere ha raccontato di essere stato contattato da Tina
Laquale che dopo un incontro nel suo ufficio gli avrebbe chiesto di aiutarla nel
tentativo di passare gli elaborati delle tre prove ad alcuni candidati. E così è
stato. E se nel primo e nel secondo giorno di prove, non ci sono stati intoppi,
Santamaria è uscito dalle aule per prendere due buste bianche consegnate dalla
Laquale, giovedì 18 dicembre sono intervenuti i carabinieri. Il cancelliere ha
aggiunto un altro particolare: il secondo giorno la dirigente dell'ateneo era
con un uomo che ha presentato come "Angelo, autista del rettore". L'autista,
assegnato formalmente al rettore dell'ateneo di Bari, si chiama Nicola, ma
all'interno dell'università c'è un altro dipendente che talvolta può ricoprire
le stesse mansioni. Ed il suo nome è Angelo. Autista e factotum all'università è
venuto a contatto con i plichi contenenti i test di Medicina, uno dei quali,
nell'aprile scorso, manomesso in circostanze che non sono mai state chiarite.
Certo è facile prendersela con i poveri cristi. Le macagne nelle segrete stanze
delle commissioni di esame, in cui ci sono i magistrati, nessuno va ad indagare:
perché per i concorsi truccati nessuno va in galera. Concorsi, i figli di
papà vincono facile: "E noi, figli di nessuno, restiamo fuori". L’inchiesta
sul dottorato vinto dal figlio del rettore della Sapienza nonostante l'uso del
bianchetto ha raccolto centinaia di commenti e condivisioni. E ora siamo noi a
chiedervi di raccontarci la vostra storia di candidati meritevoli ma senza
parenti eccellenti. Ecco le prime due lettere arrivate, scrive Emiliano
Fittipaldi su “L’Espresso”. A chi figli, e a chi figliastri: è questa la legge
morale che impera in Italia, il Paese della discriminazione e delle
corporazioni. Dove va avanti chi nasce privilegiato, mentre chi non vanta
conoscenze e relazioni rischia, quasi sempre, di arrivare ultimo. Alla Sapienza
di Roma l’assioma è spesso confermato: sono decine i parenti di professori
eminenti assunti nei dipartimenti, con intere famiglie (su tutte quella dell’ex
rettore Luigi Frati) salite in cattedra. A volte con merito, altre meno. La
nostra inchiesta sullo strano concorso di dottorato vinto dal rampollo del nuovo
magnifico Eugenio Gaudio, al tempo preside di Medicina, ha fatto scalpore: la
storia del compito “sbianchettato” (qualsiasi segno di riconoscimento è vietato)
e la notizia del singolare intervento dei legali dell’università (hanno chiesto
un parere all’Avvocatura dello Stato, che ha invitato la Sapienza a “perdonare”
il candidato ) hanno fatto il giro del web. Il pezzo è stato condiviso decine di
migliaia di volte, con centinaia di commenti (piuttosto severi) di ex studenti e
docenti dell’ateneo romano. Tra le decine di lettere arrivate in redazione, due
sono metafora perfetta di come la sorte possa essere diversa a seconda del
cognome che si porta. Livia Pancotto, 28 anni, laureata in Economia con 110 e
lode, spiega che la storia del pargolo di Gaudio le ha fatto «montare dentro una
rabbia tale da farmi scrivere» poche, infuriate righe. «Nel 2012, dopo la
laurea, decisi di partecipare al concorso per il dottorato in Management,
Banking and Commodity Sciences, sempre alla Sapienza», scrive in una lettera a
“l’Espresso”. «Dopo aver superato sia l’esame scritto che l’orale ricevetti la
buona notizia: ero stata ammessa, sia pure senza borsa». Dopo un mese, però, la
mazzata. «Vengo a sapere dal professore che il mio concorso è stato annullato,
visto che durante lo scritto ho utilizzato il bianchetto. Come nel caso del
figlio del rettore Gaudio, nessuno aveva specificato, prima dell’inizio del
compito, che il bando prevedesse che si potesse usare solo una penna nera». Se
per il rampollo dell’amico che prenderà il suo posto il rettore Frati mobiliterà
i suoi uffici legali, la Pancotto viene silurata subito, senza pietà. Oggi la
giovane economista vive in Galles, dove ha vinto un dottorato con borsa
all’università di Bangor. Anche la vicenda di Federico Conte, ora tesoriere
dell’Ordine degli psicologi del Lazio, è paradossale. Dopo aver completato in un
solo anno gli esami della laurea specialistica nel 2009, la Sapienza tentò di
impedire la discussione della sua tesi. «Mi arrivò un telegramma a firma di
Frati, dove mi veniva comunicato l’avvio di una “procedura annullamento esami”:
il magnifico non era d’accordo nel farmi laureare in anticipo, ed era
intenzionato a farmi sostenere gli esami una seconda volta». Conte domandò
all’ateneo di chiedere un parere all’Avvocatura, ma senza successo. Il giovane
psicologo fu costretto a ricorrere al Tar, che gli diede ragione permettendogli
di laurearsi. «Leggendo la vostra inchiesta ho la percezione di un’evidente
diversità di trattamento rispetto al figlio del rettore. Provo un certo disgusto
nel constatare come le nostre istituzioni siano così attente e garantiste con
chi sbianchetta, mentre si accaniscano su chi fa il proprio dovere». Magari pure
più velocemente degli altri. Ma tant’è. Nel paese dove i figli “so’ piezz’ e
core”, la meritocrazia e l’uguaglianza restano una chimera. Anche nelle
università, luogo dove - per antonomasia - l’eccellenza e il rigore dovrebbero
essere di casa. Se poi l’Esame di Avvocato lo passi, ti obbligano a lasciare.
Giovani avvocati contro la Cassa Forense. Con la campagna "'Io non pago e non mi
cancello". I giuristi più giovani in rivolta sui social network per la regola
dei minimi obbligatori, che impone contributi previdenziali intorno ai 4 mila
euro annui alla cassa indipendentemente dal reddito. Così c'è chi paga più di
quello che guadagna. E chi non paga si deve cancellare dall'Albo, venendo
escluso dalla categoria, scrive Antonio Sciotto su “L’Espresso”. Chi pensa
ancora che la professione di avvocato sia garantita e ben retribuita dia in
questi giorni uno sguardo attento ai social network. Twitter e Facebook da
qualche giorno sono inondati da 'selfie' che raccontano tutta un'altra storia.
"Io non pago e io non mi cancello" è lo slogan scelto dai giovani legali per la
loro rivolta contro i colleghi più anziani e in particolare contro la regola dei
"minimi obbligatori", che impone di pagare i contributi previdenziali alla Cassa
forense in modo del tutto slegato dal reddito. Molti spiegano che la cifra
minima richiesta – intorno ai 4 mila euro annui - è pari o a volte anche
superiore ai propri redditi. E visto che se non riesci a saldare, devi
cancellarti non solo dalla Cassa, ma anche dall'albo professionale. Il risultato
è che ad esercitare alla fine restano tendenzialmente i più ricchi, mentre chi
fa fatica ad arrivare a fine mese viene di fatto espulso dalla categoria. E'
vero che per i primi 8 anni è prevista una buona agevolazione per chi guadagna
sotto i 10 mila euro l'anno, ma al pari le prestazioni vengono drasticamente
ridotte. Per capirci: è come se l'Inps chiedesse a un operaio e a un dirigente
una stessa soglia minima di contributi annui, non calcolata in percentuale ai
loro redditi. Mettiamo 5 mila euro uguali per tutti: salvo poi imporre la
cancellazione dall'ente a chi non riesce a saldare. "Dovrei salassarmi oggi per
ricevere un'elemosina domani – protesta Antonio Maria - mentre i vecchi tromboni
ottantenni si godono le loro pensioni d'oro, non pagate, conquistate avendo
versato tutta la vita lavorativa (ed erano altri tempi) il 10 per cento ed
imponendo a me di pagare il 14 per cento". "Il regime dei cosiddetti minimi è
vergognoso – aggiunge Rosario - Pretendere che si paghi 'a prescindere' del
proprio reddito è una bestemmia giuridica. Basta furti generazionali. Basta
falsità". Uno dei selfie addirittura viene da un reparto di emodialisi, a
testimoniare la scarsa copertura sanitaria assicurata ai giovani professionisti.
La protesta si è diffusa a partire dal blog dell'Mga - Mobilitazione generale
avvocati , ha un gruppo facebook pubblico dove è possibile postare i selfie,
mentre su Twitter naviga sull'onda dell'hashtag #iononmicancello. La
battaglia contro le casse previdenziali non è nuova, se consideriamo gli
avvocati una parte del più vasto mondo delle partite Iva e degli autonomi: già
da tempo Acta, associazione dei freelance, ha lanciato la campagna #dicano33,
contro il progressivo aumento dei contributi Inps dal 27 per cento al 33 per
cento, imposto dalla legge per portarli al livello dei lavoratori dipendenti. Il
regime dei minimi obbligatori della Cassa forense non solo darebbe luogo a una
vera e propria "discriminazione generazionale", ma secondo molti giovani
avvocati sarebbe anche incostituzionale, come spiega efficacemente Davide Mura
nel suo blog: "E' palesemente in contrasto con l'articolo 53 della Costituzione,
che sancisce il principio della progressività contributiva. Ma si viola anche
l'articolo 3, quello sull'uguaglianza davanti alla legge, perché le condizioni
cambiano a seconda se stai sopra o sotto i 10 mila euro di reddito annui". La
soluzione? Secondo l'Mga sarebbe quella di eliminare l'obbligo dei minimi e
passare al sistema contributivo, come è per tutti gli altri lavoratori. Vietando
possibilmente agli avvocati già in pensione di poter continuare a esercitare. Un
modo insomma per far sì che i "tromboni" lascino spazio ai più giovani.
I MEDIA ED
I LORO PECCATI: DISINFORMAZIONE, CALUNNIA, DIFFAMAZIONE.
Per il
pontefice “il clima mediatico ha le sue forme di inquinamento, i suoi veleni. La
gente lo sa, se ne accorge, ma poi purtroppo si abitua a respirare dalla radio e
dalla televisione un’aria sporca, che non fa bene. C’è bisogno di far circolare
aria pulita. Per me i peccati dei media più grossi sono quelli che vanno sulla
strada della bugia e della menzogna, e sono tre: la disinformazione, la calunnia
e la diffamazione. Dare attenzione a tematiche importanti per la vita delle
persone, delle famiglie, della società, e trattare questi argomenti non in
maniera sensazionalistica, ma responsabile, con sincera passione per il bene
comune e per la verità. Spesso nelle grandi emittenti questi temi sono
affrontati senza il dovuto rispetto per le persone e per i valori in causa, in
modo spettacolare. Invece è essenziale che nelle vostre trasmissioni si
percepisca questo rispetto, che le storie umane non vanno mai
strumentalizzate”. Infatti nessuno delle tv ed i giornali ne hanno parlato di
questo intervento.
"Evitare i tre
peccati dei media: la disinformazione, la calunnia e la diffamazione". E'
l'esortazione che rivolge al mondo dell'informazione e della comunicazione Papa
Francesco, cogliendo l'occasione dell'udienza del 15 dicembre 2014 in Aula Paolo
VI dei dirigenti, dipendenti e operatori di Tv2000, la televisione della Chiesa
italiana. «Di questi tre peccati, la calunnia sembra il più grave perché
colpisce le persone con giudizi non veri. Ma in realtà il più grave e pericoloso
è la disinformazione, perché ti porta all'errore, ti porta a credere solo a una
parte della verità. La disinformazione, in particolare spinge a dire la metà
delle cose e questo porta a non potersi fare un giudizio preciso sulla realtà.
Una comunicazione autentica non è preoccupata di colpire: l'alternanza tra
allarmismo catastrofico e disimpegno consolatorio, due estremi che continuamente
vediamo riproposti nella comunicazione odierna, non è un buon servizio che i
media possono offrire alle persone. Occorre parlare alle persone “intere”, alla
loro mente e al loro cuore, perché sappiano vedere oltre l'immediato, oltre un
presente che rischia di essere smemorato e timoroso del futuro. I media
cattolici hanno una missione molto impegnativa nei confronti della comunicazione
sociale cercare di preservarla da tutto ciò che la stravolge e la piega ad altri
fini. Spesso la comunicazione è stata sottomessa alla propaganda, alle
ideologie, a fini politici o di controllo dell'economia e della tecnica. Ciò che
fa bene alla comunicazione è in primo luogo la “parresia”, cioè il coraggio di
parlare con franchezza e libertà. Se siamo veramente convinti di ciò che abbiamo
da dire, le parole vengono. Se invece siamo preoccupati di aspetti tattici, il
nostro parlare sarà artefatto e poco comunicativo, insipido. La libertà è anche
quella rispetto alle mode, ai luoghi comuni, alle formule preconfezionate, che
alla fine annullano la capacità di comunicare. Risvegliare le parole: ecco il
primo compito del comunicatore. La buona comunicazione in particolare evita sia
di "riempire" che di "chiudere". Si riempie quando si tende a saturare la
nostra percezione con un eccesso di slogan che, invece di mettere in moto il
pensiero, lo annullano. Si chiude quando alla via lunga della comprensione
si preferisce quella breve di presentare singole persone come se fossero in
grado di risolvere tutti i problemi, o al contrario come capri espiatori, su cui
scaricare ogni responsabilità. Correre subito alla soluzione, senza concedersi
la fatica di rappresentare la complessità della vita reale è un errore frequente
dentro una comunicazione sempre più veloce e poco riflessiva. La libertà è anche
quella rispetto alle mode, ai luoghi comuni, alle formule preconfezionate, che
alla fine annullano la capacità di comunicare».
Questa sub
cultura artefatta dai media crea una massa indistinta ed omologata. Un gregge di
pecore. A questo punto vien meno il concetto di democrazia e prende forma
l’esigenza di un uomo forte alla giuda del gregge che sappia prendersi la
responsabilità del necessario cambiamento nell’afasia e nell’apatia totale.
Sembra necessario il concetto che è meglio far decidere al buon e capace pastore
dove far andare il gregge che far decidere alle pecore il loro destino rivolto
all’inevitabile dispersione.
Francesco di
Sales, appena ordinato sacerdote, nel 1593, lo mandarono nel Chablais, che poi
sarebbe il Chiablese, dato che sta nell’Alta Savoia, ma l’avevano invaso gli
Svizzeri e tutti si erano convertiti al calvinismo, scrive Lanfranco Caminiti su
“Il Garantista”. Insomma, doveva essere proprio tosto predicare il cattolicesimo
lì. Però, lui aveva studiato dai Gesuiti e poi si era laureato a Padova, perciò
poteva con capacità d’argomentazione affrontare qualunque disputa teologica. Era
uno che lavorava di fino, Francesco di Sales. Solo che tutto quello che diceva
dal pulpito non sortiva grande effetto in quei cuori e quelle menti montanare, e
allora per raggiungerli e scaldarli meglio con le sue parole gli venne l’idea di
far affiggere nei luoghi pubblici dei “manifesti”, composti con uno stile agile
e di grande efficacia, e di far infilare dei “volantini” sotto le porte. Il
risultato fu straordinario. È per questo che san Francesco di Sales è il santo
patrono dei giornalisti. Per lo stile e l’efficacia, per la capacità di
argomentare la verità. Almeno fino a ieri. Perché da ieri c’è un altro Francesco
che ha steso le sue mani benedette sul giornalismo, ed è papa Bergoglio.
«Evitare i tre peccati dei media: la disinformazione, la calunnia e la
diffamazione». È l’esortazione che papa Francesco ha rivolto al mondo
dell’informazione e della comunicazione, cogliendo l’occasione dell’udienza in
Aula Paolo VI di dirigenti, dipendenti e operatori di Tv2000, la televisione
della Cei, conferenza episcopale italiana. In realtà, ne aveva già parlato il 22
marzo, incontrando nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, i
membri dell’Associazione ”Corallo”, network di emittenti locali di ispirazione
cattolica presenti in tutte le regioni italiane. Ora c’è tornato sopra, ora ci
batte il chiodo. Si vede che gli sta a cuore la cosa, e come dargli torto.
Evidentemente non parlava solo ai giornalisti cattolici, papa Francesco, e
quindi siamo tutti chiamati in causa. «Di questi tre peccati, la calunnia – ha
continuato Francesco – sembra il più grave perché colpisce le persone con
giudizi non veri. Ma in realtà il più grave e pericoloso è la disinformazione,
perché ti porta all’errore, ti porta a credere solo a una parte della verità».
Era stato anche più dettagliato nell’argomentazione il 22 marzo: «La calunnia è
peccato mortale, ma si può chiarire e arrivare a conoscere che quella è una
calunnia. La diffamazione è peccato mortale, ma si può arrivare a dire: questa è
un’ingiustizia, perché questa persona ha fatto quella cosa in quel tempo, poi si
è pentita, ha cambiato vita. Ma la disinformazione è dire la metà delle cose,
quelle che sono per me più convenienti, e non dire l’altra metà. E così, quello
che vede la tv o quello che sente la radio non può fare un giudizio perfetto,
perché non ha gli elementi e non glieli danno».
Sono i falsari
dell’informazione, i peccatori più gravi.
«E io a lui:
“Chi son li due tapini
che fumman
come man bagnate ’l verno,
giacendo
stretti a’ tuoi destri confini?”.
L’una è la
falsa ch’accusò Gioseppo;
l’altr’è ’l
falso Sinon greco di Troia:
per febbre
aguta gittan tanto leppo».
Così Dante
descrive nel Canto XXX dell’Inferno la sorte di due “falsari”, la moglie di
Putifarre e Sinone. Sinone è quello che convinse i Troiani raccontando un sacco
di panzane che quelli si bevvero come acqua fresca e fecero entrare il cavallo
di legno, dentro cui si erano nascosti gli Achei che così presero la città. La
moglie di Putifarre, ricco signore d’Egitto – così si racconta nella Genesi –,
invece, s’era incapricciata del giovane schiavo Giuseppe, cercando di sedurlo.
Solo che Giuseppe non ci sentiva da quell’orecchio. Offesa dal rifiuto del
giovane, la donna si vendicò accusandolo di aver tentato di farle violenza. Per
questa falsa accusa Giuseppe fu gettato nelle prigioni del Faraone. Eccolo, il
“leppo” dantesco, che è un fumo puzzolente. E fumo puzzolente si leva dalle
pagine dei giornali di disinformacija all’italiana.
Durante la
Guerra fredda i russi si erano specializzati nel diffondere informazioni false e
mezze verità: raccontavano un sacco di balle sui propri progressi, o
magnificavano le sorti delle nazioni che erano sotto l’orbita del comunismo, e
nello stesso tempo imbrogliavano le carte su quello che succedeva nell’Occidente
maledettamente capitalistico. Pure gli americani avevano la loro disinformacija.
Le loro porcherie diventavano battaglie di libertà e le puttanate che compivano
erano gesti necessari per difendere la democrazia dall’orso russo e dai cavalli
cosacchi. Fare disinformaciija non è banale, non è che ti metti a strillare le
stronzate, è un lavoro sottile. Quel cervellone di Chomsky – e ne capisce della
questione, visto che è un linguista – riferendosi alle falsificazioni delle
prove e delle fonti l’ha definita “ingegneria storica”. Devi orientare
l’opinione pubblica, mescolando verità e menzogna; devi sminuire l’importanza e
l’attenzione su un evento dandogli una scarsa visibilità e, all’opposto,
ingigantire gli spazi informativi su questioni di secondaria importanza; devi
negare l’evidenza inducendo al dubbio e all’incredulità. Insomma, è un
lavoraccio, che presuppone una vera e propria “macchina disinformativa”. Cioè, i
giornali. «Ciò che fa bene alla comunicazione è in primo luogo la parresia, cioè
il coraggio di parlare con franchezza e libertà», ha aggiunto papa Francesco. Ha
ragione papa Francesco, ragione da vendere. Qualunque direttore di giornale,
qualunque editore, qualunque comitato di redazione, qualunque corso dell’ordine
dei giornalisti, ti dirà che questi, della franchezza e della libertà, sono i
cardini del lavoro dell’informazione. Ma sono chiacchiere. Francesco, invece,
non fa chiacchiere. E magari succede che domani troveremo in qualche piazza dei
dazebao o dei volantini sotto le nostre porte con la sua firma.
Dalla prova
scientifica a quella dichiarativa, passando per il legame tra magistratura e
giornalismo. Il dibattito sul processo penale organizzato il 12 dicembre 2014 a
Palmi, in provincia di Reggio Calabria, nell’auditorium della Casa della Cultura
intitolata a Leonida Repaci dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con la
collaborazione del Comune e della Camera penale, è stato molto più di un
semplice dibattito, andato oltre gli aspetti prettamente giuridici, scrive
Viviana Minasi su “Il Garantista”. Si è infatti parlato a lungo del legame che
esiste tra la magistratura e il giornalismo, quel giornalismo che molto spesso
trasforma in veri e propri eventi mediatici alcuni processi penali o fatti di
cronaca nera. Se ne è parlato con il direttore de Il Garantista Piero
Sansonetti, il Procuratore di Palmi Emanuele Crescenti, il presidente del
Tribunale di Palmi Maria Grazia Arena, l’onorevole Armando Veneto, presidente
della Camera penale di Palmi e con il presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati Francesco Napoli. Tanti gli ospiti presenti in questa due giorni
dedicata al processo penale. Al direttore Sansonetti il compito di entrare nel
vivo del dibattito, puntando quindi l’attenzione su quella sorta di “alleanza”
tra magistratura e giornalismo, a volte tacita. «Mi piacerebbe apportare una
correzione alla locandina di questo evento, ha detto ironicamente Sansonetti –
scrivendo “Giornalismo è giustizia”, invece che “Giornalismo e giustizia”.
Perché? Perché molto spesso, soprattutto negli ultimi decenni, è successo che i
processi li ha fatti il giornalismo, li abbiamo fatti noi insieme ai
magistrati». Fatti di cronaca quali il disastro della Concordia, Cogne, andando
indietro negli anni anche Tangentopoli, fino a giungere all’evento che ha
catalizzato l’attenzione dei media nazionali negli ultimi giorni, l’inchiesta su
Mafia Capitale, sono stati portati alla ribalta dal giornalismo, magari a danno
di altri eventi altrettanto importanti che però quasi cadono nell’oblio. «Ci
sono eventi di cronaca che diventano spettacolo – ha proseguito il direttore
Sansonetti – e questo accade quando alla stampa un fatto interessa, quando noi
giornalisti fiutiamo “l’affare”». Sansonetti ha poi parlato di un principio
importante tutelato dall’articolo 111 della Costituzione, l’articolo che parla
del cosiddetto “giusto processo”, che in Italia sarebbe sempre meno applicato,
soprattutto nella parte in cui si parla dell’informazione di reato a carico di
un indagato. «Sempre più spesso accade che l’indagato scopre di essere indagato
leggendo un giornale, o ascoltando un servizio in televisione, e non da un
magistrato». Su Mafia Capitale, Sansonetti ha lanciato una frecciata al
Procuratore capo di Roma Pignatone, definendo un «autointralcio alla giustizia»
la comunicazione data in conferenza stampa, relativa a possibili altri blitz
delle forze dell’ordine, a carico di altri soggetti che farebbero parte della
“cupola”. Suggestivo anche l’intervento di Giuseppe Sartori, ordinario di
neuropsicologia forense all’università di Padova, che ha relazionato su
“tecniche di analisi scientifica del testimone”. Secondo quanto affermato da
Sartori, le testimonianze nei processi, ma non solo, sono quasi sempre
inattendibili. Il punto di partenza di questa affermazione è uno studio
scientifico condotto su circa 1500 persone, che ha dimostrato come la
testimonianza è deviata e deviabile, sia dal ricordo sia dalle domande che
vengono poste al testimone. Un caso che si sarebbe evidenziato soprattutto nelle
vicende che riguardano le molestie sessuali, nelle quali il ricordo è fortemente
suggestionabile dal modo in cui vengono poste le domande. Il convegno era stato
introdotto dall’ex sottosegretario del primo governo Prodi ed ex
europarlamentare Armando Veneto, figura di primo piano della Camera penale di
Palmi. L’associazione dei penalisti da anni è in prima linea per
controbilanciare il “potere” (secondo gli avvocati) che la magistratura
inquirente avrebbe nel distretto giudiziario di Reggio Calabria e il peso
preponderante di cui la pubblica accusa godrebbe nelle aule di giustizia. Le
posizione espresse da Veneto, anche all’interno della camera penale di Palmi,
sono ormai state recepite da due generazioni di avvocati penalisti.
Purtroppo,
però, in Italia non cambierà mai nulla.
Mamma
l’italiani, canzone del 2010 di Après La Class
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
nei secoli dei
secoli girando per il mondo
nella pizzeria
con il Vesuvio come sfondo
non viene
dalla Cina non è neppure americano
se vedi uno
spaccone è solamente un italiano
l'italiano
fuori si distingue dalla massa
sporco di
farina o di sangue di carcassa
passa
incontrollato lui conosce tutti
fa la bella
faccia fa e poi la mette in culo a tutti
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
a suon di
mandolino nascondeva illegalmente
whisky e
sigarette chiaramente per la mente
oggi è un po'
cambiato ma è sempre lo stesso
non smercia
sigarette ma giochetti per il sesso
l'italiano è
sempre stato un popolo emigrato
che guardava
avanti con la mente nel passato
chi non lo
capiva lui lo rispiegava
chi gli andava
contro è saltato pure in a...
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
l'Italia agli
italiani e alla sua gente
è lo stile che
fa la differenza chiaramente
genialità
questa è la regola
con le idee
che hanno cambiato tutto il corso della storia
l'Italia e la
sua nomina e un alta carica
un eredità
scomoda
oggi la
visione italica è che
viaggiamo
tatuati con la firma della mafia
mafia mafia
mafia
non mi
appartiene none no questo marchio di fabbrica
aria aria aria
la gente è
troppo stanca è ora di cambiare aria
mafia mafia
mafia
non mi
appartiene none no questo marchio di fabbrica
aria aria aria
la gente è
troppo stanca è ora di cambiare aria
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
vacanze di
piacere per giovani settantenni
all'anagrafe
italiani ma in Brasile diciottenni
pagano pesante
ragazze intraprendenti
se questa
compagnia viene presa con i denti
l'italiano è
sempre stato un popolo emigrato
che guardava
avanti con la mente nel passato
chi non lo
capiva lui lo rispiegava
chi gli andava
contro è saltato pure in a...
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
spara la
famiglia del pentito che ha cantato
lui che viene
stipendiato il 27 dallo Stato
nominato e
condannato nel suo nome hanno sparato
e ricontare le
sue anime non si può più
risponde la
famiglia del pentito che ha cantato
difendendosi
compare tutti giorni più incazzato
sarà guerra
tra famiglie
sangue e
rabbia tra le griglie
con la fama
come foglie che ti tradirà
mafia mafia
mafia
non mi
appartiene none no questo marchio di fabbrica
aria aria aria
la gente è
troppo stanca è ora di cambiare aria
mafia mafia
mafia
non mi
appartiene none no questo marchio di fabbrica
aria aria aria
la gente è
troppo stanca è ora di cambiare aria
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li cani
Mamma
l'italiani mamma l'italiani mancu li cani mancu li ca
A proposito
degli avvocati, si può dissertare o credere sulla irregolarità degli esami
forensi, ma tutti gli avvocati sanno, ed omertosamente tacciono, in che modo,
loro, si sono abilitati e ciò nonostante pongono barricate agli aspiranti della
professione. Compiti uguali, con contenuto dettato dai commissari d’esame o
passato tra i candidati. Compiti mai o mal corretti. Qual è la misura del merito
e la differenza tra idonei e non idonei? Tra iella e buona sorte?
Noi siamo
animali. Siamo diversi dalle altre specie solo perché siamo viziosi e ciò ci
aguzza l’ingegno.
La
Superbia-Vanità (desiderio irrefrenabile di essere superiori, fino al
disprezzo di ordini, leggi, rispetto altrui);
L’Avarizia
(scarsa disponibilità a spendere e a donare ciò che si possiede);
La Lussuria
(desiderio irrefrenabile del piacere sessuale fine a sé stesso);
L’Invidia
(tristezza per il bene altrui, percepito come male proprio);
La Gola
(meglio conosciuta come ingordigia, abbandono ed esagerazione nei piaceri della
tavola, e non solo);
L’Ira
(irrefrenabile desiderio di vendicare violentemente un torto subito);
L’Accidia-Depressione
(torpore malinconico, inerzia nel vivere e nel compiere opere di bene).
Essendo
viziosi ci scanneremmo l’un l’altro per raggiungere i nostri scopi. E
periodicamente lo facciamo.
Vari
illuminati virtuosi, chiamati profeti, ci hanno indicato invano la retta via. La
via indicata sono i precetti dettati dalle religioni nate da questi
insegnamenti. Le confessioni religiose da sempre hanno cercato di porre rimedio
indicando un essere superiore come castigatore dei peccati con punizioni postume
ed eterne. Ecco perché i vizi sono detti Capitali.
I
vizi
capitali
sono un elenco di inclinazioni profonde, morali e comportamentali, dell'anima
umana, spesso e impropriamente chiamati peccati capitali. Questo elenco
di vizi (dal latino vĭtĭum = mancanza, difetto, ma anche abitudine
deviata, storta, fuori dal retto sentiero) distruggerebbero l'anima umana,
contrapponendosi alle virtù, che invece ne promuovono la crescita. Sono ritenuti
"capitali" poiché più gravi, principali, riguardanti la profondità della natura
umana. Impropriamente chiamati "peccati", nella morale filosofica e cristiana i
vizi sarebbero già causa del peccato, che ne è invece il suo relativo effetto.
Una sommaria
descrizione dei vizi capitali comparve già in Aristotele, che li definì gli
"abiti del male". Al pari delle virtù, i vizi deriverebbero infatti dalla
ripetizione di azioni, che formano nel soggetto che le compie una sorta di
"abito" che lo inclina in una certa direzione o abitudine. Ma essendo
vizi, e non virtù, tali abitudini non promuovono la crescita interiore, nobile e
spirituale, ma al contrario la distruggono.
In questo
mondo vizioso tutto ha un prezzo e quasi tutti sono disposti a svendersi per
ottenerlo e/ o a dispensare torti ai propri simili. Ciclicamente i nomi degli
aguzzini cambiano, ma i peccati sono gli stessi.
In questa
breve vita senza giustizia, vissuta in un periodo indefinito, vincono loro: non
hanno la ragione, ma il potere. Questo, però, non impedirà di raccontare la
verità contemporanea nel tempo e nello spazio, affinché ai posteri sia delegata
l’ardua sentenza contro i protagonisti del tempo trattato, per gli altri ci sarà
solo l’ignominia senza fama né gloria o l’anonimato eterno.
“La superficie
della Terra non era ancora apparsa. V’erano solo il placido mare e la grande
distesa di Cielo... tutto era buio e silenzio". Così inizia il Popol Vuh, il
libro sacro dei Maya Quiché che narra degli albori dell’umanità. Il Popol Vuh
descrive questi primi esseri umani come davvero speciali: "Furono dotati di
intelligenza, potevano vedere lontano, riuscivano a sapere tutto quel che è nel
mondo. Quando guardavano, contemplavano ora l'arco del cielo ora la rotonda
faccia della Terra. Contrariamente ai loro predecessori, gli esseri umani
ringraziarono sentitamente gli dei per averli creati. Ma anche stavolta i
creatori si indispettirono. "Non è bene che le nostre creature sappiano tutto, e
vedano e comprendano le cose piccole e le cose grandi". Gli dei tennero dunque
consiglio: "Facciamo che la loro vista raggiunga solo quel che è vicino,
facciamo che vedano solo una piccola parte della Terra! Non sono forse per loro
natura semplici creature fatte da noi? Debbono forse anch'essi essere dei?
Debbono essere uguali a noi, che possiamo vedere e sapere tutto? Ostacoliamo
dunque i loro desideri... Così i creatori mutarono la natura delle loro
creature. Il Cuore del Cielo soffiò nebbia nei loro occhi, e la loro vista si
annebbiò, come quando si soffia su uno specchio. I loro occhi furono coperti, ed
essi poterono vedere solo quello che era vicino, solo quello che ad essi
appariva chiaro."
E’ comodo
definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’
facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia.
In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano.
Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte
dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per
farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando
si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale.
Le vittime,
vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt
Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Ha mai pensato, per un momento, che c’è qualcuno
che da anni lavora indefessamente per farle sapere quello che non sa? E questo
al di là della sua convinzione di sapere già tutto dalle sue fonti? Provi a
leggere un e-book o un book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede
veramente nella sua regione o in riferimento alla sua professione. Cose che
nessuno le dirà mai. Non troverà le cose ovvie contro la Mafia o Berlusconi o i
complotti della domenica. Cose che servono solo a bacare la mente. Troverà
quello che tutti sanno, o che provano sulla loro pelle, ma che nessuno ha il
coraggio di raccontare. Può anche non leggere questi libri, frutto di anni di
ricerca, ma nell’ignoranza imperante che impedisce l’evoluzione non potrà dire
che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti uguali. “Pensino ora i miei
venticinque lettori che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto,
quello che s'è raccontato”. Citazione di Alessandro Manzoni.
Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio
i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Antonio
Giangrande, perché è diverso dagli altri?
Perché lui
spiega cosa è la legalità, gli altri non ne parlano, ma ne sparlano.
La legalità è
un comportamento conforme alla legge ed ai regolamenti di attuazione e la sua
applicazione necessaria dovrebbe avvenire secondo la comune Prassi legale di
riferimento.
Legge e Prassi
sono le due facce della stessa medaglia.
La Legge è
votata ed emanata in nome del popolo sovrano. I Regolamenti di applicazione sono
predisposti dagli alti Burocrati e già questo non va bene. La Prassi, poi, è
l’applicazione della Legge negli Uffici Pubblici, nei Tribunali, ecc., da parte
di un Sistema di Potere che tutela se stesso con usi e consuetudini consolidati.
Sistema di Potere composto da Caste, Lobbies, Mafie e Massonerie.
Ecco perché
vige il detto: La Legge si applica per i deboli e si interpreta per i forti.
La
correlazione tra Legge e Prassi e come quella che c’è tra il Dire ed il Fare:
c’è di mezzo il mare.
Parlare di
legge, bene o male, ogni leguleio o azzeccagarbugli o burocrate o boiardo di
Stato può farlo. Più difficile per loro parlar di Prassi generale, conoscendo
loro signori solo la prassi particolare che loro coltivano per i propri
interessi di privilegiati. Prassi che, però, stanno attenti a non svelare.
Ed è
proprio la Prassi che fotte la Legge.
La giustizia
che debba essere uguale per tutti parrebbe essere un principio che oggi
consideriamo irrinunciabile, anche se non sempre pienamente concretizzabile
nella pratica quotidiana. Spesso assistiamo a fenomeni di corruzione,
all’applicazione della legge in modo diverso secondo i soggetti coinvolti. E
l’la disfunzione è insita nella predisposizione umana.
Essa vien da
lontano.
E’ lo stesso
Alessandro Manzoni che parla di “Azzeccagarbugli” genuflessi ai mafiosi del
tempo al capitolo 3 dei “Promessi Sposi”. Ma non sarebbe stato il Manzoni a
coniare l’accoppiata tra il verbo “azzeccare” e il sostantivo “garbuglio” stante
che quando la parola entrò nei “Promessi Sposi”, aveva un’età superiore ai tre
secoli. Il primo ad usarla fu Niccolò Machiavelli che, in un passo delle
"Legazioni" (1510), scrive: “Voi sapete che i mercatanti vogliono fare le cose
loro chiare e non azzeccagarbugli”. Questa spiegazione si trova nel Dizionario
italiano ragionato e nel Dizionario etimologico di Cortelazzo-Zolli mentre gli
altri vocabolari si limitano a indicare soltanto la matrice manzoniana. È giusto
dare a Niccolò quello che è di Niccolò, ricordando inoltre che il Manzoni era un
conoscitore dell’opera di Machiavelli ed è probabile che sia stato ispirato dal
citato passo. Non si dimentichi, infatti, che nella prima stesura dei “Promessi
Sposi” il personaggio si chiamava “dotor Pe’ ttola” e non Azzeccagarbugli.
La legge non
era uguale per tutti anche nel Seicento, secolo di soprusi e di prepotenze da
parte dei potenti. Renzo cerca giustizia recandosi da un noto avvocato del
tempo, ma, allora come oggi, la giustizia non sta dalla parte degli oppressi,
bensì da quella degli oppressori.
Azzecca-garbugli è
un personaggio del romanzo storico ed è il soprannome di un avvocato di Lecco,
chiamato, nelle prime edizioni del romanzo, dottor Pettola e dottor Duplica
(nell'edizione definitiva il nome non viene mai detto, ma solo il soprannome).
Il nome costituisce un'italianizzazione del termine dialettale milanese zaccagarbùj che
il Cherubini traduce "attaccabrighe". Viene chiamato così dai popolani per la
sua capacità di sottrarre dai guai, non del tutto onestamente, le persone.
Spesso e volentieri aiuta i Bravi, poiché, come don Abbondio, preferisce stare
dalla parte del più forte, per evitare una brutta fine.
Renzo
Tramaglino giunge da lui, nel capitolo III, per chiedere se ci fosse una grida
che avrebbe condannato don Rodrigo, ma lui sentendo nominare il potente signore,
respinge Renzo perché non avrebbe potuto contrastare la sua potente autorità.
Egli rappresenta quindi un uomo la cui coscienza meschina è asservita agli
interessi dei potenti. Compare anche nel capitolo quinto quando fra Cristoforo
va al palazzotto di don Rodrigo e lo trova fra gli invitati al banchetto che si
sta tenendo a casa appunto di don Rodrigo.
Apparentemente, è un uomo di legge molto erudito, e nel suo studio è presente
una notevole quantità di libri, il cui ruolo principale, però, è quello di
elementi decorativi piuttosto che di materiale di studio. Il suo tavolo invece è
cosparso di fogli che impressionano gli abitanti del paese che vi si recano. In
realtà non consulta libri da molti anni addietro, quando andava a Milano per
qualche causa d'importanza.
Il suo nome
Azzeccagarbugli è dovuto dal fatto che Azzecca significa "indovinare" e garbugli
"cose non giuste", quindi: Indovinare cose non giuste.
Azzeccagarbugli è la figura centrale del Capitolo 3°, è un avvocato venduto, è
un miserabile e il Manzoni pur non dicendolo apertamente ce lo fa capire
descrivendocelo appunto negli aspetti più negativi. Di questo personaggio emerge
una grande miseria morale: ciò che preme all'avvocato è di assicurarsi il favore
di don Rodrigo anche se per ottenere questo deve calpestare quella giustizia
della quale dovrebbe essere servitore. Il Dottor Azzeccagarbugli è una figurina
vista di scorcio, ma pur limpida e interessante. E' un leguleio da strapazzo, ma
abile la sua parte a ordire garbugli per imbrogliare le cose, come lui stesso
confessa a Renzo. Ci vuole la conoscenza del codice, è necessario saper
interpretare le gride, ma per lui valgono sopra tutto le arti per ingarbugliare
i clienti. Tale è la morale di questo tipo di trappolone addottorato,
comunissimo in ogni società. Il Manzoni lo ha ricreato di una specifica
individualità esteriore, nell'eloquio profuso, a volte enfatico e sentenzioso, a
volte freddo e cavilloso, grave e serio nella posa di uomo di alte cure, pieno
di sussiego nella sua mimica istrionica. Don Rodrigo lo ha caro, come complice
connivente nei suoi delittuosi disegni, mentre il dottore accattando protezione
col servilismo e l'adulazione, scrocca lauti pranzi. Alcuni osservano, e non a
torto, che in questo personaggio il Manzoni abbia voluto farsi beffe dei legulei
dalla coscienza facile.
"«Non
facciam niente, – rispose il dottore, scotendo il capo, con un sorriso, tra
malizioso e impaziente. – Se non avete fede in me, non facciam niente. Chi dice
le bugie al dottore, vedete figliuolo, è uno sciocco che dirà la verità al
giudice. All’avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca poi a
imbrogliarle. Se volete ch’io v’aiuti, bisogna dirmi tutto, dall’a fino alla
zeta, col cuore in mano, come al confessore. Dovete nominarmi la persona da cui
avete avuto il mandato: sarà naturalmente persona di riguardo; e, in questo
caso, io anderò da lui, a fare un atto di dovere. Non gli dirò, vedete, ch’io
sappia da voi, che v’ha mandato lui: fidatevi. Gli dirò che vengo ad implorar la
sua protezione, per un povero giovine calunniato. E con lui prenderò i concerti
opportuni, per finir l’affare lodevolmente. Capite bene che, salvando sé,
salverà anche voi. Se poi la scappata fosse tutta vostra, via, non mi ritiro: ho
cavato altri da peggio imbrogli… Purché non abbiate offeso persona di riguardo,
intendiamoci, m’impegno a togliervi d’impiccio: con un po’ di spesa,
intendiamoci. Dovete dirmi chi sia l’offeso, come si dice: e, secondo la
condizione, la qualità e l’umore dell’amico, si vedrà se convenga più di tenerlo
a segno con le protezioni, o trovar qualche modo d’attaccarlo noi in criminale,
e mettergli una pulce nell’orecchio; perché, vedete, a saper ben maneggiare le
gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente. In quanto al curato, se è persona
di giudizio, se ne starà zitto; se fosse una testolina, c’è rimedio anche per
quelle. D’ogni intrigo si può uscire; ma ci vuole un uomo: e il vostro caso è
serio, vi dico, serio: la grida canta chiaro; e se la cosa si deve decider tra
la giustizia e voi, così a quattr’occhi, state fresco. Io vi parlo da amico: le
scappate bisogna pagarle: se volete passarvela liscia, danari e sincerità,
fidarvi di chi vi vuol bene, ubbidire, far tutto quello che vi sarà suggerito.»
Mentre il
dottore mandava fuori tutte queste parole, Renzo lo stava guardando con
un’attenzione estatica, come un materialone sta sulla piazza guardando al
giocator di bussolotti, che, dopo essersi cacciata in bocca stoppa e stoppa e
stoppa, ne cava nastro e nastro e nastro, che non finisce mai. Quand’ebbe però
capito bene cosa il dottore volesse dire, e quale equivoco avesse preso, gli
troncò il nastro in bocca, dicendo: – oh! signor dottore, come l’ha intesa? l’è
proprio tutta al rovescio. Io non ho minacciato nessuno; io non fo di queste
cose, io: e domandi pure a tutto il mio comune, che sentirà che non ho mai avuto
che fare con la giustizia. La bricconeria l’hanno fatta a me; e vengo da lei per
sapere come ho da fare per ottener giustizia; e son ben contento d’aver visto
quella grida.
- Diavolo!
– esclamò il dottore, spalancando gli occhi. – Che pasticci mi fate? Tant’è;
siete tutti così: possibile che non sappiate dirle chiare le cose?
- Ma mi
scusi; lei non m’ha dato tempo: ora le racconterò la cosa, com’è. Sappia dunque
ch’io dovevo sposare oggi, – e qui la voce di Renzo si commosse, – dovevo
sposare oggi una giovine, alla quale discorrevo, fin da quest’estate; e oggi,
come le dico, era il giorno stabilito col signor curato, e s’era disposto ogni
cosa. Ecco che il signor curato comincia a cavar fuori certe scuse… basta, per
non tediarla, io l’ho fatto parlar chiaro, com’era giusto; e lui m’ha confessato
che gli era stato proibito, pena la vita, di far questo matrimonio. Quel
prepotente di don Rodrigo…
- Eh via! –
interruppe subito il dottore, aggrottando le ciglia, aggrinzando il naso rosso,
e storcendo la bocca, – eh via! Che mi venite a rompere il capo con queste
fandonie? Fate di questi discorsi tra voi altri, che non sapete misurar le
parole; e non venite a farli con un galantuomo che sa quanto valgono. Andate,
andate; non sapete quel che vi dite: io non m’impiccio con ragazzi; non voglio
sentir discorsi di questa sorte, discorsi in aria.
- Le giuro…
- Andate,
vi dico: che volete ch’io faccia de’ vostri giuramenti? Io non c’entro: me ne
lavo le mani -. E se le andava stropicciando, come se le lavasse davvero. –
Imparate a parlare: non si viene a sorprender così un galantuomo.
- Ma senta,
ma senta, – ripeteva indarno Renzo: il dottore, sempre gridando, lo spingeva con
le mani verso l’uscio; e, quando ve l’ebbe cacciato, aprì, chiamò la serva, e le
disse: – restituite subito a quest’uomo quello che ha portato: io non voglio
niente, non voglio niente.
Quella
donna non aveva mai, in tutto il tempo ch’era stata in quella casa, eseguito un
ordine simile: ma era stato proferito con una tale risoluzione, che non esitò a
ubbidire. Prese le quattro povere bestie, e le diede a Renzo, con un’occhiata di
compassione sprezzante, che pareva volesse dire: bisogna che tu l’abbia fatta
bella. Renzo voleva far cerimonie; ma il dottore fu inespugnabile; e il giovine,
più attonito e più stizzito che mai, dovette riprendersi le vittime rifiutate, e
tornar al paese, a raccontar alle donne il bel costrutto della sua spedizione."
A Parlar di
azzeccagarbugli non vi pare che si parli dei nostri contemporanei legulei
togati, siano essi magistrati od avvocati?
Additare i
difetti altrui è cosa che tutti sanno fare, più improbabile è indicare e
correggere i propri.
Non abbiamo
bisogno di eroi, né, tantomeno, di mistificatori con la tonaca (toga e divisa).
L’abito non fa il monaco. La legalità non va promossa solo nella forma, ma va
coltivata anche nella sostanza. E’ sbagliato ergersi senza meriti dalla parte
dei giusti.
Se scrivi e
dici la verità con il coraggio che gli altri non hanno, il risultato non sarà il
loro rinsavimento ma l’essere tu additato come pazzo. Ti scontri sempre con la
permalosità di magistrati e giornalisti e la sornionità degli avvocati avvezzi
solo ai loro interessi. Categorie di saccenti che non ammettono critiche. Se
scrivi e sei del centro-nord Italia, i conterranei diranno: che bel libro,
bravo, è uno di noi. Se scrivi e sei del centro-sud Italia i conterranei
diranno: quel libro l’avrei scritto anch’io, anzi meglio, ma sono solo cazzate.
Chi siamo noi?
Siamo i
“coglioni” che altri volevano che fossimo o potessimo diventare.
Da bambini i
genitori ci educavano secondo i loro canoni, fino a che abbiamo scoperto che era
solo il canone di poveri ignoranti.
Da studenti i
maestri ci istruivano secondo il loro pensiero, fino a che abbiamo scoperto che
era solo il pensiero di comunisti arroganti. Prima dell’ABC ci insegnavano
“Bella Ciao”.
Da credenti i
ministri di culto ci erudivano sulla confessione religiosa secondo il loro
verbo, fino a che abbiamo scoperto che era solo la parola di pedofili o
terroristi.
Da lettori e
telespettatori l’informazione (la claque del potere) ci ammaestrava all’odio per
il diverso ed a credere di vivere in un paese democratico, civile ed avanzato,
fino a che abbiamo scoperto che si muore di fame o detenuti in canili umani.
Da elettori i
legislatori ci imponevano le leggi secondo il loro diritto, fino a che abbiamo
scoperto che erano solo corrotti, mafiosi e massoni.
Ecco, appunto:
siamo i “coglioni” che altri volevano che fossimo o potessimo diventare.
E se qualcuno
non vuol essere “coglione” e vuol cambiare le cose, ma non ci riesce, vuol dire
che è “coglione” lui e non lo sa, ovvero è circondato da amici e parenti
“coglioni”.
Ho vissuto una
breve vita confrontandomi con una sequela di generazioni difettate condotte in
un caos organizzato. Uomini e donne senza ideali e senza valori succubi del
flusso culturale e politico del momento, scevri da ogni discernimento tra il
bene ed il male. L’Io è elevato all’ennesima potenza. La mia Collana editoriale
“L’Italia del Trucco, l’Italia che siamo” composta da decine di saggi, riporta
ai posteri una realtà attuale storica, per tema e per territorio, sconosciuta ai
contemporanei perché corrotta da verità mediatiche o giudiziarie.
Per la Conte
dei Conti è l’Italia delle truffe. È l'Italia degli sprechi e delle frodi
fotografata in un dossier messo a punto dalla procura generale della Corte dei
Conti che ha messo insieme le iniziative più rilevanti dei procuratori
regionali. La Corte dei Conti ha scandagliato l'attività condotta da tutte le
procure regionali e ha messo insieme «le fattispecie di particolare interesse,
anche sociale, rilevanti per il singolo contenuto e per il pregiudizio economico
spesso ingente».
A parlar di sé
e delle proprie disgrazie in prima persona, oltre a non destare l’interesse di
alcuno pur nelle tue stesse condizioni, può farti passare per mitomane o pazzo.
Non sto qui a promuovermi. Non si può, però, tacere la verità storica che ci
circonda, stravolta da verità menzognere mediatiche e giudiziarie. Ad ogni
elezione legislativa ci troviamo a dover scegliere tra: il partito dei condoni;
il partito della CGIL; il partito dei giudici. Io da anni non vado a votare
perché non mi rappresentano i nominati in Parlamento. Oltretutto mi disgustano
le malefatte dei nominati. Un esempio per tutti, anche se i media lo hanno
sottaciuto. La riforma forense, approvata con Legge 31 dicembre 2012, n. 247,
tra gli ultimi interventi legislativi consegnatici frettolosamente dal
Parlamento prima di cessare di fare danni. I nonni avvocati in Parlamento
(compresi i comunisti) hanno partorito, in previsione di un loro roseo futuro,
una contro riforma fatta a posta contro i giovani. Ai fascisti che hanno dato
vita al primo Ordinamento forense (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 -
Ordinamento della professione di avvocato e di procuratore convertito con la
legge 22 gennaio 1934 n.36) questa contro riforma reazionaria gli fa un
baffo. Trattasi di una “riforma”, scritta come al solito negligentemente, che
non viene in alcun modo incontro ed anzi penalizza in modo significativo i
giovani. Da anni inascoltato denuncio il malaffare di avvocati e magistrati ed
il loro malsano accesso alla professione. Cosa ho ottenuto a denunciare i
trucchi per superare l’esame? Insabbiamento delle denunce e attivazione di
processi per diffamazione e calunnia, chiusi, però, con assoluzione piena.
Intanto ti intimoriscono. Ed anche la giustizia amministrativa si adegua.
La mafia
cos'è? La risposta in un aneddoto di Paolo Borsellino: "Sapete che cos'è la
Mafia... faccia conto che ci sia un posto libero in tribunale..... e che si
presentino 3 magistrati... il primo è bravissimo, il migliore, il più
preparato.. un altro ha appoggi formidabili dalla politica... e il terzo è un
fesso... sapete chi vincerà??? Il fesso. Ecco, mi disse il boss, questa è la
MAFIA!"
"La vera
mafia è lo Stato, alcuni magistrati che lo rappresentano si comportano da
mafiosi. Il magistrato che mi racconta che Andreotti ha baciato Riina io lo
voglio in galera". Così Vittorio Sgarbi il 6 maggio 2013 ad “Un Giorno Da
Pecora su Radio 2.
«Da noi
-
ha dichiarato Silvio Berlusconi ai cronisti di una televisione
greca il 23 febbraio 2013 - la magistratura è una mafia più pericolosa della
mafia siciliana, e lo dico sapendo di dire una cosa grossa». «In Italia
regna una "magistocrazia". Nella magistratura c'è una vera e propria
associazione a delinquere» Lo ha detto Silvio Berlusconi il 28 marzo 2013
durante la riunione del gruppo Pdl a Montecitorio. Ed ancora Silvio Berlusconi
all'attacco ai magistrati: «L'Anm è come la P2, non dice chi sono i loro
associati». Il riferimento dell'ex premier è alle associazioni interne ai
magistrati, come Magistratura Democratica. Il Cavaliere è a Udine il 18 aprile
2013 per un comizio.
Abbiamo una
Costituzione catto-comunista predisposta e votata dagli apparati politici che
rappresentavano la metà degli italiani, ossia coloro che furono i vincitori
della guerra civile e che votarono per la Repubblica. Una Costituzione fondata
sul lavoro (che oggi non c’è e per questo ci rende schiavi) e non sulla libertà
(che ci dovrebbe sempre essere, ma oggi non c’è e per questo siamo schiavi). Un
diritto all’uguaglianza inapplicato in virtù del fatto che il potere, anziché
essere nelle mani del popolo che dovrebbe nominare i suoi rappresentanti
politici, amministrativi e giudiziari, è in mano a mafie, caste, lobbies e
massonerie.
Siamo un
popolo corrotto: nella memoria, nell’analisi e nel processo mentale di
discernimento. Ogni dato virulento che il potere mediatico ci ha propinato,
succube al potere politico, economico e giudiziario, ha falsato il senso etico
della ragione e logica del popolo. Come il personal computer, giovani e vecchi,
devono essere formattati. Ossia, azzerare ogni cognizione e ripartire da zero
all’acquisizione di conoscenze scevre da influenze ideologiche, religiose ed
etniche. Dobbiamo essere consci del fatto che esistono diverse verità.
Ogni fatto
è rappresentato da una verità storica; da una verità mediatica e da una verità
giudiziaria.
La verità
storica è conosciuta solo dai responsabili del fatto. La verità mediatica è
quella rappresentata dai media approssimativi che sono ignoranti in
giurisprudenza e poco esperti di frequentazioni di aule del tribunale, ma
genuflessi e stanziali negli uffici dei pm e periti delle convinzioni
dell’accusa, mai dando spazio alla difesa. La verità giudiziaria è quella che
esce fuori da una corte, spesso impreparata culturalmente, tecnicamente e
psicologicamente (in virtù dei concorsi pubblici truccati). Nelle aule spesso si
lede il diritto di difesa, finanche negando le più elementari fonti di prova, o
addirittura, in caso di imputati poveri, il diritto alla difesa. Il gratuita
patrocinio è solo una balla. Gli avvocati capaci non vi consentono, quindi ti
ritrovi con un avvocato d’ufficio che spesso si rimette alla volontà della
corte, senza conoscere i carteggi. La sentenza è sempre frutto della libera
convinzione di una persona (il giudice). Mi si chiede cosa fare. Bisogna, da
privato, ripassare tutte le fasi dell’indagine e carpire eventuali errori dei
magistrati trascurati dalla difesa (e sempre ve ne sono). Eventualmente svolgere
un’indagine parallela. Intanto aspettare che qualche pentito, delatore, o
intercettazione, produca una nuova prova che ribalti l’esito del processo.
Quando poi questa emerge bisogna sperare nella fortuna di trovare un magistrato
coscienzioso (spesso non accade per non rilevare l’errore dei colleghi), che
possa aprire un processo di revisione.
Ognuno di noi antropologicamente ha un limite, non dovuto al sesso, od alla
razza, od al credo religioso, ma bensì delimitato dall’istruzione ricevuta ed
all’educazione appresa dalla famiglia e dalla società, esse stesse influenzate
dall’ambiente, dalla cultura, dagli usi e dai costumi territoriali. A differenza
degli animali la maggior parte degli umani non si cura del proprio limite e si
avventura in atteggiamenti e giudizi non consoni al loro stato. Quando a causa
dei loro limiti non arrivano ad avere ragione con il ragionamento, allora
adottano la violenza (fisica o psicologica, ideologica o religiosa) e spesso con
la violenza ottengono un effimero ed immeritato potere o risultato. I più
intelligenti, conoscendo il proprio limite, cercano di ampliarlo per risultati
più duraturi e poteri meritati. Con nuove conoscenze, con nuovi studi, con nuove
esperienze arricchiscono il loro bagaglio culturale ed aprono la loro mente,
affinché questa accetti nuovi concetti e nuovi orizzonti. Acquisizione
impensabile in uno stato primordiale. In non omologati hanno empatia per i
conformati. Mentre gli omologati sono mossi da viscerale egoismo dovuto
all’istinto di sopravvivenza: voler essere ed avere più di quanto effettivamente
si possa meritare di essere od avere. Loro ed i loro interessi come ombelico del
mondo. Da qui la loro paura della morte e la ricerca di un dio assoluto e
personale, finanche cattivo: hanno paura di perdere il niente che hanno e sono
alla ricerca di un dio che dal niente che sono li elevi ad entità. L'empatia
designa un atteggiamento verso gli altri caratterizzato da un impegno di
comprensione dell'altro, escludendo ogni attitudine affettiva personale
(simpatia, antipatia) e ogni giudizio morale, perché mettersi nei panni
dell'altro per sapere cosa pensa e come reagirebbe costituisce un importante
fattore di sopravvivenza in un mondo in cui l'uomo è in continua competizione
con gli altri uomini. Fa niente se i dotti emancipati e non omologati saranno
additati in patria loro come Gesù nella sua Nazareth: semplici figli di
falegnami, perchè "non c'è nessun posto dove un profeta abbia meno valore che
non nella sua patria e nella sua casa". Non c'è bisogno di essere cristiani per
apprezzare Gesù Cristo: non per i suoi natali, ma per il suo insegnamento e,
cosa più importante, per il suo esempio. Fa capire che alla fine è importante
lasciar buona traccia di sè, allora sì che si diventa immortali nella
rimembranza altrui.
Tutti vogliono avere ragione e tutti pretendono di imporre la loro verità agli
altri. Chi impone ignora, millanta o manipola la verità. L'ignoranza degli altri
non può discernere la verità dalla menzogna. Il saggio aspetta che la verità
venga agli altri. La sapienza riconosce la verità e spesso ciò fa ricredere e
cambiare opinione. Solo gli sciocchi e gli ignoranti non cambiano mai idea, per
questo sono sempre sottomessi. La Verità rende liberi, per questo è importante
far di tutto per conoscerla.
Tutti gli altri intendono “Tutte le Mafie” come un insieme orizzontale di
entità patologiche criminali territoriali (Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Camorra,
Sacra Corona Unita, ecc.).
Io intendo “Tutte le Mafie” come un ordinamento criminale verticale di entità
fisiologiche nazionali composte, partendo dal basso: dalle mafie (la
manovalanza), dalle Lobbies, dalle Caste e dalle Massonerie (le menti).
La Legalità è il comportamento umano conforme al dettato della legge nel
compimento di un atto o di un fatto. Se l'abito non fa il monaco, e la cronaca
ce lo insegna, nè toghe, nè divise, nè poteri istituzionali o mediatici hanno la
legittimazione a dare insegnamenti e/o patenti di legalità. Lor signori non si
devono permettere di selezionare secondo loro discrezione la società civile in
buoni e cattivi ed ovviamente si devono astenere dall'inserirsi loro stessi tra
i buoni. Perchè secondo questa cernita il cattivo è sempre il povero cittadino,
che oltretutto con le esose tasse li mantiene. Non dimentichiamoci che non ci
sono dio in terra e fino a quando saremo in democrazia, il potere è solo
prerogativa del popolo.
Non sono conformato ed omologato, per questo son fiero ed orgoglioso di essere
diverso.
PER UNA
LETTURA UTILE E CONSAPEVOLE CONTRO L’ITALIA DEI GATTOPARDI.
Recensione di
un’opera editoriale osteggiata dalla destra e dalla sinistra. Perle di saggezza
destinate al porcilaio.
I giornalisti
della tv e stampa, sia quotidiana, sia periodica, da sempre sono tacciati di
faziosità e mediocrità. Si dice che siano prezzolati e manipolati dal potere e
che esprimano solo opinioni personali, non raccontando i fatti. Lo dice Beppe
Grillo e forse ha ragione. Ma tra di loro vi sono anche eccellenze di gran
valore. Questo vale per le maggiori testate progressiste (Il Corriere della
Sera, L’Espresso, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano), ma anche per le testate
liberali (Panorama, Oggi, Il Giornale, Libero Quotidiano). In una Italia,
laddove alcuni magistrati tacitano con violenza le contro voci, questi eccelsi
giornalisti, attraverso le loro coraggiose inchieste, sono fonte di prova
incontestabile per raccontare l’Italia vera, ma sconosciuta. L’Italia dei
gattopardi e dell’ipocrisia. L’Italia dell’illegalità e dell’utopia. Tramite
loro, citando gli stessi e le loro inchieste scottanti, Antonio Giangrande ha
raccolto in venti anni tutto quanto era utile per dimostrare che la mafia vien
dall’alto. Pochi lupi e tante pecore. Una selezione di nomi e fatti articolati
per argomento e per territorio. L’intento di Giangrande è rappresentare la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Questa è
sociologia storica, di cui il Giangrande è il massimo cultore. Questa è la
collana editoriale “L’Italia del Trucco, l’Italia che siamo” pubblicata su
www.controtuttelemafie.it
ed altri canali web, su Amazon in E-Book e su Lulu in cartaceo. 40 libri scritti
da Antonio Giangrande, presidente della “Associazione Contro Tutte le Mafie” e
scrittore-editore dissidente. Saggi pertinenti questioni che nessuno osa
affrontare. Opere che i media si astengono a dare loro la dovuta visibilità e le
rassegne culturali ad ignorare. In occasione delle festività ed in concomitanza
con le nuove elezioni legislative sarebbe cosa buona e utile presentare ai
lettori una lettura alternativa che possa rendere più consapevole l’opinione dei
cittadini. Un’idea regalo gratuita o con modica spesa, sicuramente gradita da
chi la riceve. Non è pubblicità gratuita che si cerca per fini economici, né
tanto meno è concorrenza sleale. Si chiede solo di divulgare la conoscenza di
opere che già sul web sono conosciutissime e che possono anche esser lette
gratuitamente. Evento editoriale esclusivo ed aggiornato periodicamente. Di
sicuro interesse generale. Fa niente se dietro non ci sono grandi o piccoli
gruppi editoriali. Ciò è garanzia di libertà.
Grazie per
l’adesione e la partecipazione oltre che per la solidarietà.
POLITICA,
GIUSTIZIA ED INFORMAZIONE. IN TEMPO DI VOTO SI PALESA L’ITALIETTA DELLE
VERGINELLE.
Politica,
giustizia ed informazione. In tempo di voto si palesa l’Italietta delle
verginelle.
Da scrittore
navigato, il cui sacco di 50 libri scritti sull’Italiopoli degli italioti lo sta
a dimostrare, mi viene un rigurgito di vomito nel seguire tutto quanto viene
detto da scatenate sgualdrine (in senso politico) di ogni schieramento politico.
Sgualdrine che si atteggiano a verginelle e si presentano come aspiranti
salvatori della patria in stampo elettorale.
In Italia dove
non c’è libertà di stampa e vige la magistratocrazia è facile apparire
verginelle sol perché si indossa l’abito bianco.
I nuovi
politici non si presentano come preparati a risolvere i problemi, meglio se
liberi da pressioni castali, ma si propongono, a chi non li conosce bene, solo
per le loro presunti virtù, come verginelle illibate.
Ci si atteggia
a migliore dell’altro in una Italia dove il migliore c’ha la rogna.
L’Italietta è
incurante del fatto che Nicola Vendola a Bari sia stato assolto in modo
legittimo dall’amica della sorella o Luigi De Magistris sia stato assolto a
Salerno in modo legale dalla cognata di Michele Santoro, suo sponsor politico.
L’Italietta
che non batte ciglio quando a Bari Massimo D’Alema in modo lecito esce pulito da
un’inchiesta penale. Accogliendo la richiesta d’archiviazione avanzata dal pm,
il gip Concetta Russi il 22 giugno ’95 decise per il proscioglimento, ritenendo
superfluo ogni approfondimento: «Uno degli episodi di illecito finanziamento
riferiti – scrisse nelle motivazioni - e cioè la corresponsione di un contributo
di 20 milioni in favore del Pci, ha trovato sostanziale conferma, pur nella
diversità di alcuni elementi marginali, nella leale dichiarazione dell’onorevole
D’Alema, all’epoca dei fatti segretario regionale del Pci (...). L’onorevole
D’Alema non ha escluso che la somma versata dal Cavallari fosse stata proprio
dell’importo da quest’ultimo indicato». Chi era il titolare dell’inchiesta che
sollecitò l’archiviazione? Il pm Alberto Maritati, eletto coi Ds e
immediatamente nominato sottosegretario all’Interno durante il primo governo
D’Alema, numero due del ministro Jervolino, poi ancora sottosegretario alla
giustizia nel governo Prodi, emulo di un altro pm pugliese diventato
sottosegretario con D’Alema: Giannicola Sinisi. E chi svolse insieme a Maritati
gli accertamenti su Cavallari? Chi altro firmò la richiesta d’archiviazione per
D’Alema? Semplice: l’amico e collega Giuseppe Scelsi, magistrato di punta della
corrente di Magistratura democratica a Bari, poi titolare della segretissima
indagine sulle ragazze reclutate per le feste a Palazzo Grazioli, indagine
«anticipata» proprio da D’Alema.
L’Italietta
non si scandalizza del fatto che sui Tribunali e nella scuole si spenda il nome
e l’effige di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino da parte di chi, loro
colleghi, li hanno traditi in vita, causandone la morte.
L’Italietta
non si sconvolge del fatto che spesso gli incriminati risultano innocenti e
ciononostante il 40% dei detenuti è in attesa di giudizio. E per questo gli
avvocati in Parlamento, anziché emanar norme, scioperano nei tribunali,
annacquando ancor di più la lungaggine dei processi.
L’Italietta
che su giornali e tv foraggiate dallo Stato viene accusata da politici corrotti
di essere evasore fiscale, nonostante sia spremuta come un limone senza ricevere
niente in cambio.
L’Italietta,
malgrado ciò, riesce ancora a discernere le vergini dalle sgualdrine, sotto
l’influenza mediatica-giudiziaria.
Fa niente se
proprio tutta la stampa ignava tace le ritorsioni per non aver taciuto le
nefandezze dei magistrati, che loro sì decidono chi candidare al Parlamento per
mantenere e tutelare i loro privilegi.
Da ultimo è la
perquisizione ricevuta in casa dall’inviato de “La Repubblica”, o quella
ricevuta dalla redazione del tg di Telenorba.
Il re è nudo:
c’è qualcuno che lo dice. E’ la testimonianza di Carlo Vulpio sull’integrità
morale di Nicola Vendola, detto Niki. L’Editto bulgaro e l’Editto di Roma (o di
Bari). Il primo è un racconto che dura da anni. Del secondo invece non si deve
parlare.
I giornalisti
della tv e stampa, sia quotidiana, sia periodica, da sempre sono tacciati di
faziosità e mediocrità. Si dice che siano prezzolati e manipolati dal potere e
che esprimano solo opinioni personali, non raccontando i fatti. La verità è che
sono solo codardi.
E cosa c’è
altro da pensare. In una Italia, laddove alcuni magistrati tacitano con violenza
le contro voci. L’Italia dei gattopardi e dell’ipocrisia. L’Italia
dell’illegalità e dell’utopia.
Tutti hanno
taciuto "Le mani nel cassetto. (e talvolta anche addosso...). I giornalisti
perquisiti raccontano". Il libro, introdotto dal presidente nazionale
dell’Ordine Enzo Jacopino, contiene le testimonianze, delicate e a volte
ironiche, di ventuno giornalisti italiani, alcuni dei quali noti al grande
pubblico, che hanno subito perquisizioni personali o ambientali, in casa o in
redazione, nei computer e nelle agende, nei libri e nei dischetti cd o nelle
chiavette usb, nella biancheria e nel frigorifero, “con il dichiarato scopo di
scoprire la fonte confidenziale di una notizia: vera, ma, secondo il magistrato,
non divulgabile”. Nel 99,9% dei casi le perquisizioni non hanno portato “ad
alcun rinvenimento significativo”.
Cosa pensare
se si è sgualdrina o verginella a secondo dell’umore mediatico. Tutti gli
ipocriti si facciano avanti nel sentirsi offesi, ma che fiducia
nell’informazione possiamo avere se questa è terrorizzata dalle querele sporte
dai PM e poi giudicate dai loro colleghi Giudici.
Alla luce di
quanto detto, è da considerare candidabile dai puritani nostrani il buon
“pregiudicato” Alessandro Sallusti che ha la sol colpa di essere uno dei pochi
coraggiosi a dire la verità?
Si badi che a
ricever querela basta recensire il libro dell’Ordine Nazionale dei giornalisti,
che racconta gli abusi ricevuti dal giornalista che scrive la verità, proprio
per denunciare l'arma intimidatoria delle perquisizioni alla stampa.
Che
giornalisti sono coloro che, non solo non raccontano la verità, ma tacciono
anche tutto ciò che succede a loro?
E cosa ci si
aspetta da questa informazione dove essa stessa è stata visitata nella loro sede
istituzionale dalla polizia giudiziaria che ha voluto delle copie del volume e i
dati identificativi di alcune persone, compreso il presidente che dell'Ordine è
il rappresentante legale?
La
Costituzione all’art. 104 afferma che “la magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere.”
Ne conviene
che il dettato vuol significare non equiparare la Magistratura ad altro potere,
ma differenziarne l’Ordine con il Potere che spetta al popolo. Ordine
costituzionalizzato, sì, non Potere.
Magistrati.
Ordine, non potere, come invece il più delle volte si scrive, probabilmente
ricordando Montesquieu; il quale però aggiungeva che il potere giudiziario é
“per così dire invisibile e nullo”. Solo il popolo è depositario della
sovranità: per questo Togliatti alla Costituente avrebbe voluto addirittura che
i magistrati fossero eletti dal popolo, per questo sostenne le giurie popolari.
Ordine o potere che sia, in ogni caso è chiaro che di magistrati si parla.
Allora io ho
deciso: al posto di chi si atteggia a verginella io voterei sempre un
“pregiudicato” come Alessandro Sallusti, non invece chi incapace, invidioso e
cattivo si mette l’abito bianco per apparir pulito.
E facile dire
pregiudicato. Parliamo del comportamento degli avvocati. Il caso della condanna
di Sallusti. Veniamo al primo grado: l’avvocato di Libero era piuttosto
noto perché non presenziava quasi mai alle udienze, preferendo mandarci sempre
un sostituto sottopagato, dice Filippo Facci. E qui, il giorno della sentenza,
accadde un fatto decisamente singolare. Il giudice, una donna, lesse il
dispositivo che condannava Sallusti a pagare circa 5mila euro e Andrea Monticone
a pagarne 4000 (più 30mila di risarcimento, che nel caso dei magistrati è sempre
altissimo) ma nelle motivazioni della sentenza, depositate tempo dopo, lo stesso
giudice si dolse di essersi dimenticato di prevedere una pena detentiva.
Un’esagerazione? Si può pensarlo. Tant’è, ormai era andata: sia il querelante
sia la Procura sia gli avvocati proposero tuttavia appello (perché in Italia si
propone sempre appello, anche quando pare illogico o esagerato) e la sentenza
della prima sezione giunse il 17 giugno 2011. E qui accadeva un altro fatto
singolare: l’avvocato di Libero tipicamente non si presentò in aula e
però neppure il suo sostituto: il quale, nel frattempo, aveva abbandonato lo
studio nell’ottobre precedente come del resto la segretaria, entrambi stufi di
lavorare praticamente gratis. Fatto sta che all’Appello dovette presenziare un
legale d’ufficio – uno che passava di lì, letteralmente – sicché la sentenza
cambiò volto: come richiesto dall’accusa, Monticone si beccò un anno con la
condizionale e Sallusti si beccò un anno e due mesi senza un accidente di
condizionale, e perché? Perché aveva dei precedenti per l’omesso controllo
legato alla diffamazione. Il giudice d’Appello, in pratica, recuperò la
detenzione che il giudice di primo grado aveva dimenticato di scrivere nel
dispositivo.
Ma anche il
Tribuno Marco Travaglio è stato vittima degli avvocati. Su Wikipedia si legge
che nel 2000 è stato condannato in sede civile, dopo essere stato citato in
giudizio da Cesare Previti a causa di un articolo in cui Travaglio ha definito
Previti «un indagato» su “L’Indipendente”. Previti era effettivamente indagato
ma a causa dell'impossibilità da parte dell' avvocato del giornale di presentare
le prove in difesa di Travaglio in quanto il legale non era retribuito, il
giornalista fu obbligato al risarcimento del danno quantificato in 79 milioni di
lire. Comunque lui stesso a “Servizio Pubblico” ha detto d’aver perso una
querela con Previti, parole sue, «perché l’avvocato non è andato a presentare le
mie prove». Colpa dell’avvocato.
Ma chi e
quando le cose cambieranno?
Per fare
politica in Italia le strade sono poche, specialmente se hai qualcosa da dire e
proponi soluzioni ai problemi generali. La prima è cominciare a partecipare a
movimenti studenteschi fra le aule universitarie, mettersi su le stellette di
qualche occupazione e poi prendere la tessera di un partito. Se di sinistra è
meglio. Poi c'è la strada della partecipazione politica con tesseramento magari
sfruttando una professione che ti metta in contatto con molti probabili
elettori: favoriti sono gli avvocati, i medici di base ed i giornalisti. C'è una
terza via che sempre più prende piede. Fai il magistrato.
Se puoi occupati di qualche inchiesta che abbia come bersaglio un soggetto
politico, specie del centro destra, perché gli amici a sinistra non si toccano.
Comunque non ti impegnare troppo. Va bene anche un'archiviazione. Poi togli la
toga e punta al Palazzo. Quello che interessa a sinistra è registrare questo
movimento arancione con attacco a tre punte: De
Magistris sulla fascia, Di
Pietro in regia e al centro
il nuovo bomber Antonio
Ingroia. Se è un partito dei magistrati e per la corporazione dei
magistrati. Loro "ci stanno".
Rivoluzione
Civile è una formazione improvvisata le cui figure principali di riferimento
sono tre magistrati: De Magistris, Di Pietro e Ingroia. Dietro le loro spalle si
rifugiano i piccoli partiti di Ferrero, Diliberto e Bonelli in cerca di presenza
parlamentare. E poi, ci mancherebbe,
con loro molte ottime persone di sinistra critica all’insegna della purezza.
Solo che la loro severità rivolta in special modo al Partito Democratico, deve
per forza accettare un’eccezione: Antonio Di Pietro. La rivelazione dei metodi
disinvolti con cui venivano gestiti i fondi dell’Italia dei Valori, e dell’uso
personale che l’ex giudice fece di un’eredità cospicua donata a lui non certo
per godersela, lo hanno costretto a ritirarsi dalla prima fila. L’Italia dei
Valori non si presenta più da sola, non per generosità ma perchè andrebbe
incontro a una sconfitta certa. Il suo leader però viene ricandidato da Ingroia
senza troppi interrogativi sulla sua presentabilità politica. “Il Fatto”,
solitamente molto severo, non ha avuto niente da obiettare sul Di Pietro
ricandidato alla chetichella. Forse perchè non era più alleato di Bersani e
Vendola? Si chiede Gad Lerner.
Faceva una
certa impressione nei tg ascoltare Nichi Vendola (che, secondo Marco Ventura su
“Panorama”, la magistratura ha salvato dalle accuse di avere imposto un primario
di sua fiducia in un concorso riaperto apposta e di essere coinvolto nel
malaffare della sanità in Puglia) dire che mentre le liste del Pd-Sel hanno un
certo profumo, quelle del Pdl profumano “di camorra”. E che dire di Ingroia e il
suo doppiopesismo: moralmente ed eticamente intransigente con gli altri,
indulgente con se stesso. Il candidato Ingroia, leader rivoluzionario, da pm
faceva domande e i malcapitati dovevano rispondere. Poi a rispondere, come
candidato premier, tocca a lui. E lui le domande proprio non le sopporta, come
ha dimostrato nella trasmissione condotta su Raitre da Lucia Annunziata. Tanto
da non dimettersi dalla magistratura, da candidarsi anche dove non può essere
eletto per legge (Sicilia), da sostenere i No Tav ed avere come alleato
l'inventore della Tav (Di Pietro), da criticare la legge elettorale, ma
utilizzarla per piazzare candidati protetti a destra e a manca. L'elenco sarebbe
lungo, spiega Alessandro Sallusti. Macchè "rivoluzione" Ingroia le sue liste le
fa col manuale Cencelli. L'ex pm e i partiti alleati si spartiscono i posti
sicuri a Camera e Senato, in barba alle indicazioni delle assemblee
territoriali. Così, in Lombardia, il primo lombardo è al nono posto. Sono tanti
i siciliani che corrono alle prossime elezioni politiche in un seggio lontano
dall’isola. C’è Antonio Ingroia capolista di Rivoluzione Civile
un po' dappertutto. E poi ci sono molti "paracadutati" che hanno ottenuto un
posto blindato lontano dalla Sicilia. Pietro Grasso, ad
esempio, è capolista del Pd nel Lazio: "Non mi candido in Sicilia per una scelta
di opportunità", ha detto, in polemica con Ingroia, che infatti in Sicilia non è
eleggibile. In Lombardia per Sel c'è capolista Claudio Fava,
giornalista catanese, e non candidato alle ultime elezioni regionali per un
pasticcio fatto sulla sua residenza in Sicilia (per fortuna per le elezioni
politiche non c'è bisogno di particolare documentazione....). Fabio
Giambrone, braccio destro di Orlando, corre anche in Lombardia e in
Piemonte. Celeste Costantino, segretaria provinciale di
Sel a Palermo è stata candidata, con qualche malumore locale, nella
circoscrizione Piemonte 1. Anna Finocchiaro, catanese e con il
marito sotto inchiesta è capolista del Pd, in Puglia. Sarà lei in caso di
vittoria del Pd la prossima presidente del Senato. Sempre in Puglia alla Camera
c'è spazio per Ignazio Messina al quarto posto della lista di
Rivoluzione civile. E che dire di Don Gallo che canta la canzone partigiana
"Bella Ciao" sull'altare, sventolando un drappo rosso.
"Serve una
legge per regolamentare e limitare la discesa in politica dei magistrati, almeno
nei distretti dove hanno esercitato le loro funzioni, per evitare che
nell'opinione pubblica venga meno la considerazione per i giudici". Lo afferma
il presidente della Cassazione, nel suo discorso alla cerimonia di inaugurazione
del nuovo anno giudiziario 2013. Per Ernesto Lupo devono essere "gli stessi pm a
darsi delle regole nel loro Codice etico". Per la terza e ultima volta - dal
momento che andrà in pensione il prossimo maggio - il Primo presidente della
Cassazione, Ernesto Lupo, ha illustrato - alla presenza del Presidente della
Repubblica e delle alte cariche dello Stato - la «drammatica» situazione della
giustizia in Italia non solo per la cronica lentezza dei processi, 128 mila dei
quali si sono conclusi nel 2012 con la prescrizione, ma anche per la continua
violazione dei diritti umani dei detenuti per la quale è arrivato l’ultimatum
dalla Corte Ue. Sebbene abbia apprezzato le riforme del ministro Paola Severino
- taglio dei “tribunalini” e riscrittura dei reati contro la pubblica
amministrazione - Lupo ha tuttavia sottolineato che l’Italia continua ad essere
tra i Paesi più propensi alla corruzione. Pari merito con la Bosnia, e persino
dietro a nazioni del terzo mondo. Il Primo presidente ha, poi, chiamato gli
stessi magistrati a darsi regole severe per chi scende in politica e a
limitarsi, molto, nel ricorso alla custodia in carcere. «È auspicabile - esorta
Lupo - che nella perdurante carenza della legge, sia introdotta nel codice etico
quella disciplina più rigorosa sulla partecipazione dei magistrati alla vita
politica e parlamentare, che in decenni il legislatore non è riuscito ad
approvare». Per regole sulle toghe in politica, si sono espressi a favore anche
il Procuratore generale della Suprema Corte Gianfranco Ciani, che ha criticato i
pm che flirtano con certi media cavalcando le inchieste per poi candidarsi, e il
presidente dell’Anm Rodolfo Sabelli. Per il Primo presidente nelle celle ci sono
18.861 detenuti di troppo e bisogna dare più permessi premio. Almeno un quarto
dei reclusi è in attesa di condanna definitiva e i giudici devono usare di più
le misure alternative.
"Non possiamo
andare avanti così - lo aveva già detto il primo presidente della Corte di
Cassazione, Vincenzo Carbone, nella relazione che ha aperto la cerimonia dell’
inaugurazione dell’ Anno Giudiziario 2009 - In più, oltre a un più rigoroso
richiamo dei giudici ai propri doveri di riservatezza, occorrerebbe
contestualmente evitare la realizzazione di veri e propri 'processi mediatici',
simulando al di fuori degli uffici giudiziari, e magari anche con la
partecipazione di magistrati, lo svolgimento di un giudizio mentre è ancora in
corso il processo nelle sedi istituzionali". "La giustizia - sottolinea Carbone
- deve essere trasparente ma deve svolgersi nelle sedi proprie, lasciando ai
media il doveroso ed essenziale compito di informare l'opinione pubblica, ma non
di sostituirsi alla funzione giudiziaria".
Questo per far
capire che il problema “Giustizia” sono i magistrati. Nella magistratura sono
presenti "sacche di inefficienza e di inettitudine". La denuncia arriva
addirittura dal procuratore generale della Cassazione, Vitaliano Esposito,
sempre nell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2009.
Ma è questa la
denuncia più forte che viene dall'apertura dell'anno giudiziario 2013 nelle
Corti d'Appello: «Non trovo nulla da eccepire sui magistrati che abbandonano la
toga per candidarsi alle elezioni politiche - ha detto il presidente della Corte
di Appello di Roma Giorgio Santacroce. Ma ha aggiunto una stoccata anche ad
alcuni suoi colleghi - Non mi piacciono - ha affermato - i magistrati che non si
accontentano di far bene il loro lavoro, ma si propongono di redimere il mondo.
Quei magistrati, pochissimi per fortuna, che sono convinti che la spada della
giustizia sia sempre senza fodero, pronta a colpire o a raddrizzare le schiene.
Parlano molto di sè e del loro operato anche fuori dalle aule giudiziarie,
esponendosi mediaticamente, senza rendersi conto che per dimostrare quell'
imparzialità che è la sola nostra divisa, non bastano frasi ad effetto, intrise
di una retorica all'acqua di rose. Certe debolezze non rendono affatto il
magistrato più umano. I magistrati che si candidano esercitano un diritto
costituzionalmente garantito a tutti i cittadini, ma Piero Calamandrei diceva
che quando per la porta della magistratura entra la politica, la giustizia esce
dalla finestra».
Dove non
arrivano a fare le loro leggi per tutelare prerogative e privilegi della casta,
alcuni magistrati, quando non gli garba il rispetto e l’applicazione della
legge, così come gli è dovuto e così come hanno giurato, disapplicano quella
votata da altri. Esempio lampante è Taranto. I magistrati contestano la legge,
anziché applicarla, a scapito di migliaia di lavoratori. Lo strapotere e lo
straparlare dei magistrati si incarna in alcuni esempi. «Ringrazio il Presidente
della Repubblica, come cittadino ma anche di giudice, per averci allontanati dal
precipizio verso il quale inconsciamente marciavamo». Sono le parole con le
quali il presidente della Corte d'appello, Mario Buffa, ha aperto, riferendosi
alla caduta del Governo Berlusconi, la relazione per l'inaugurazione dell'anno
giudiziario 2012 nell'aula magna del palazzo di giustizia di Lecce. «Per fortuna
il vento sembra essere cambiato – ha proseguito Buffa: la nuova ministra non
consuma le sue energie in tentativi di delegittimare la magistratura, creando
intralci alla sua azione». Ma il connubio dura poco. L’anno successivo, nel
2013, ad aprire la cerimonia di inaugurazione è stata ancora la relazione del
presidente della Corte d’appello di Lecce, Mario Buffa. Esprimendosi sull’Ilva
di Taranto ha dichiarato che “il Governo ha fatto sull’Ilva una legge ad
aziendam, che si colloca nella scia delle leggi ad personam inaugurata in Italia
negli ultimi venti anni, una legge che riconsegna lo stabilimento a coloro che
fingevano di rispettare le regole di giorno e continuavano a inquinare di
notte”. Alla faccia dell’imparzialità. Giudizi senza appello e senza processo.
Non serve ai magistrati candidarsi in Parlamento. La Politica, in virtù del loro
strapotere, anche mediatico, la fanno anche dai banchi dei tribunali. Si vuole
un esempio? "E' una cosa indegna". Veramente mi disgusta il fatto che io debba
leggere sul giornale, momento per momento, 'stanno per chiamare la dottoressa
Tizio, la stanno chiamando...l'hanno interrogato...la posizione si aggrava'". E
ancora: "Perchè se no qua diamo per scontato che tutto viene raccontato dai
giornali, che si fa il clamore mediatico, che si va a massacrare la gente prima
ancora di trovare un elemento di colpevolezza". E poi ancora: "A me pare molto
più grave il fatto che un cialtrone di magistrato dia indebitamente la notizia
in violazione di legge...". Chi parla potrebbe essere Silvio Berlusconi, che
tante volte si è lamentato di come le notizie escano dai tribunali prima sui
giornali che ai diretti interessati. E invece, quelle che riporta il Corriere
della Sera, sono parole pronunciate nel giugno 2010 nientemeno che del capo
della polizia Antonio Manganelli, al telefono col prefetto Nicola Izzo, ex
vicario della polizia. Ed allora “stronzi” chi li sta a sentire.
«L'unica
spiegazione che posso dare è che ho detto sempre quello che pensavo anche
affrontando critiche, criticando a mia volta la magistratura associata e gli
alti vertici della magistratura. E' successo anche ad altri più importanti e
autorevoli magistrati, a cominciare da Giovanni Falcone. Forse
non è un caso - ha concluso Ingroia - che quando iniziò la sua attività di
collaborazione con la politica le critiche peggiori giunsero dalla magistratura.
E' un copione che si ripete». «Come ha potuto Antonio Ingroia paragonare la sua
piccola figura di magistrato a quella di Giovanni Falcone? Tra loro esiste una
distanza misurabile in milioni di anni luce. Si vergogni». È il commento del
procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini, ai microfoni del TgLa7
condotto da Enrico Mentana contro l'ex procuratore aggiunto di Palermo Antonio
Ingroia, ora leader di Rivoluzione civile. Non si è fatta attendere la replica
dell'ex procuratore aggiunto di Palermo che dagli schermi di Ballarò respinge le
accuse della sua ex collega: «Probabilmente non ha letto le mie parole,
s'informi meglio. Io non mi sono mai paragonato a Falcone, ci mancherebbe.
Denunciavo soltanto una certa reazione stizzita all'ingresso dei magistrati in
politica, di cui fu vittima anche Giovanni quando collaborò con il ministro
Martelli. Forse basterebbe leggere il mio intervento» E poi. «Ho atteso finora
una smentita, invano. Siccome non è arrivata dico che l'unica a doversi
vergognare è lei che, ancora in magistratura, prende parte in modo così
indecente e astioso alla competizione politica manipolando le mie dichiarazioni.
La prossima volta pensi e conti fino a tre prima di aprire bocca. Quanto ai suoi
personali giudizi su di me, non mi interessano e alle sue piccinerie siamo
abituati da anni. Mi basta sapere cosa pensava di me Paolo Borsellino e cosa
pensava di lei. Ogni parola in più sarebbe di troppo». «Sì, è vero. È stato
fatto un uso politico delle intercettazioni, ma questo è stato l’effetto
relativo, la causa è che non si è mai fatta pulizia nel mondo della politica».
Un'ammissione in piena regola fatta negli studi di La7 dall'ex procuratore
aggiunto di Palermo Antonio Ingroia. Che sostanzialmente ha ammesso l'esistenza
(per non dire l'appartenenza) di toghe politicizzate. Il leader di
Rivoluzione civile ha spiegato meglio il suo pensiero: «Se fosse stata
pulizia, non ci sarebbero state inchieste così clamorose e non ci sarebbe state
intercettazioni utilizzate per uso politico». L’ex pm ha poi affermato che «ogni
magistrato ha un suo tasso di politicità nel modo in cui interpreta il suo
ruolo. Si può interpretare la legge in modo più o meno estensiva, più o meno
garantista altrimenti non si spiegherebbero tante oscillazione dei giudici nelle
decisioni. Ogni giudice dovrebbe essere imparziale rispetto alle parti, il che
non significa essere neutrale rispetto ai valori o agli ideali, c’è e c’è sempre
stata una magistratura conservatrice e una progressista». Guai a utilizzare il
termine toga rossa però, perché "mi offendo, per il significato deteriore
che questo termine ha avuto", ha aggiunto Ingroia. Dice dunque Ingroia,
neoleader dell'arancia meccanica: «Piero Grasso divenne procuratore nazionale
perché scelto da Berlusconi grazie a una legge ad hoc che escludeva Gian Carlo
Caselli». Come se non bastasse, Ingroia carica ancora, come in un duello nella
polvere del West: «Grasso è il collega che voleva dare un premio, una medaglia
al governo Berlusconi per i suoi meriti nella lotta alla mafia». Ma poi, già che
c'è, Caselli regola i conti anche con Grasso: «È un fatto storico che ai tempi
del concorso per nominare il successore di Vigna le regole vennero modificate in
corso d'opera dall'allora maggioranza con il risultato di escludermi. Ed è un
fatto che questo concorso lo vinse Grasso e che la legge che mi impedì di
parteciparvi fu dichiarata incostituzionale». Dunque, la regola aurea è sempre
quella. I pm dopo aver bacchettato la società tutta, ora si bacchettano fra di
loro, rievocano pagine più o meno oscure, si contraddicono con metodo, si
azzannano con ferocia. E così i guardiani della legalità, le lame scintillanti
della legge si graffiano, si tirano i capelli e recuperano episodi sottovuoto,
dissigillando giudizi rancorosi. Uno spettacolo avvilente. Ed ancora a sfatare
il mito dei magistrati onnipotenti ci pensano loro stessi, ridimensionandosi a
semplici uomini, quali sono, tendenti all’errore, sempre impunito però. A ciò
serve la polemica tra le Procure che indagano su Mps. «In
certi uffici di procura "sembra che la regola della competenza territoriale sia
un optional. C'è stata una gara tra diversi uffici giudiziari, ma sembra che la
new entry abbia acquisito una posizione di primato irraggiungibile».
Nel suo intervento al congresso di Magistratura democratica del 2
febbraio 2013 il procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati ha alluso
criticamente, pur senza citarla direttamente, alla procura di Trani, l'ultima ad
aprire, tra
le tante inchieste aperte,
un'indagine su
Mps. «No al protagonismo di certi magistrati che si propongono come tutori del
Vero e del Giusto magari con qualche strappo alle regole processuali e alle
garanzie, si intende a fin di Bene». A censurare il fenomeno il procuratore di
Milano Edmondo Bruti Liberati nel suo intervento al congresso di Md. Il
procuratore di Milano ha puntato l'indice contro il "populismo" e la "demagogia"
di certi magistrati, che peraltro - ha osservato - "non sanno resistere al
fascino" dell'esposizione mediatica. Di tutto quanto lungamente ed
analiticamente detto bisogna tenerne conto nel momento in cui si deve dare un
giudizio su indagini, processi e condanne. Perché mai nulla è come appare ed i
magistrati non sono quegli infallibili personaggi venuti dallo spazio, ma solo
uomini che hanno vinto un concorso pubblico, come può essere quello italiano. E
tenendo conto di ciò, il legislatore ha previsto più gradi di giudizio per il
sindacato del sottoposto.
LA
REPUBBLICA DELLE MANETTE.
La
Repubblica delle manette (e degli orrori giudiziari).
Augusto Minzolini, già direttore del Tg1, è stato assolto ieri dall'accusa di
avere usato in modo improprio la carta di credito aziendale. Tutto bene? Per
niente, risponde scrive Alessandro Sallusti. Perché quell'accusa di avere
mangiato e viaggiato a sbafo (lo zelante Pm aveva chiesto due anni di carcere)
gli è costata il posto di direttore oltre che un anno e mezzo di linciaggio
mediatico da parte di colleghi che, pur essendo molto esperti di rimborsi spese
furbetti, avevano emesso una condanna definitiva dando per buono il teorema del
Pm (suggerito da Antonio Di Pietro, guarda caso). Minzolini avrà modo di rifarsi
in sede civile, ma non tutti i danni sono risarcibili in euro, quando si toccano
la dignità e la credibilità di un uomo. Fa rabbia che non il Pm, non la Rai, non
i colleghi infangatori e infamatori sentano il bisogno di chiedere scusa. È
disarmante che questo popolo di giustizialisti non debba pagare per i propri
errori. Che sono tanti e si annidano anche dentro l'ondata di manette fatte
scattare nelle ultime ore: il finanziere Proto, l'imprenditore Cellino, il
manager del Montepaschi Baldassarri. Storie diverse e tra i malcapitati c'è
anche Angelo Rizzoli, l'erede del fondatore del gruppo editoriale, anziano e
molto malato anche per avere subito un calvario giudiziario che gli ha bruciato
un terzo dell'esistenza: 27 anni per vedersi riconosciuta l'innocenza da accuse
su vicende finanziarie degli anni Ottanta. L'uso spregiudicato della giustizia
distrugge le persone, ma anche il Paese. Uno per tutti: il caso Finmeccanica,
che pare creato apposta per oscurare la vicenda Montepaschi, molto scomoda alla
sinistra. Solo la magistratura italiana si permette di trattare come se fosse
una tangente da furbetti del quartierino il corrispettivo di una mediazione per
un affare internazionale da centinaia di milioni di euro. Cosa dovrebbe fare la
più importante azienda di alta tecnologia italiana (70mila dipendenti iper
qualificati, i famosi cervelli) in concorrenza con colossi mondiali, grandi
quanto spregiudicati? E se fra due anni, come accaduto in piccolo a Minzolini,
si scopre che non c'è stato reato, chi ripagherà i miliardi in commesse persi a
favore di aziende francesi e tedesche? Non c'entra «l'elogio della tangente» che
ieri il solito Bersani ha messo in bocca a Berlusconi, che si è invece limitato
a dire come stanno le cose nel complicato mondo dei grandi affari
internazionali. Attenzione, che l'Italia delle manette non diventi l'Italia
degli errori e orrori.
Un tempo era
giustizialista. Ora invece ha cambiato idea. Magari si
avvicinano le elezioni e Beppe Grillo comincia ad avere paura
anche lui. Magari per i suoi. Le toghe quando agiscono non guardano in faccia
nessuno. E così anche Beppe se la prende con i magistrati: "La legge
protegge i delinquenti e manda in galera gli innocenti", afferma dal
palco di Ivrea. Un duro attacco alla magistratura da parte del comico genovese,
che afferma: "Questa magistratura fa paura. Io che sono un
comico ho più di ottanta processi e Berlusconi da presidente del Consiglio ne ha
22 in meno, e poi va in televisione a lamentarsi". Il leader del Movimento
Cinque Stelle solo qualche tempo fa chiedeva il carcere immediato per il crack
Parmalat e anche oggi per lo scandalo di Mps. Garantista part-time
- Beppe ora si scopre garantista. Eppure per lui la presunzione di
innocenza non è mai esistita. Dai suoi palchi ha sempre emesso condanne prima
che finissero le istruttorie. Ma sull'attacco alle toghe, Grillo non sembra così
lontano dal Cav. Anche se in passato, il leader Cinque Stelle non ha mai perso
l'occasione per criticare Berlusconi e le sue idee su una
riforma della magistratura. E sul record di processi Berlusconi, ospite di
Sky Tg24, ha precisato: "Grillo non è informato. Io ho un record assoluto
di 2700 udienze. I procedimenti contro di me più di cento, credo nessuno possa
battere un record del genere".
"La vera
mafia è lo Stato, alcuni magistrati che lo rappresentano si comportano da
mafiosi. Il magistrato che mi racconta che Andreotti ha baciato Riina io lo
voglio in galera". Così Vittorio Sgarbi il 6 maggio 2013 ad “Un Giorno Da
Pecora su Radio 2.
«Da noi
-
ha dichiarato Silvio Berlusconi ai cronisti di una televisione
greca il 23 febbraio 2013 - la magistratura è una mafia più pericolosa della
mafia siciliana, e lo dico sapendo di dire una cosa grossa». «In Italia
regna una "magistocrazia". Nella magistratura c'è una vera e propria
associazione a delinquere» Lo ha detto Silvio Berlusconi il 28 marzo 2013
durante la riunione del gruppo Pdl a Montecitorio. Ed ancora Silvio Berlusconi
all'attacco ai magistrati: «L'Anm è come la P2, non dice chi sono i loro
associati». Il riferimento dell'ex premier è alle associazioni interne ai
magistrati, come Magistratura Democratica. Il Cavaliere è a Udine il 18 aprile
2013 per un comizio.
Sui media
prezzolati e/o ideologicizzati si parla sempre dei privilegi, degli sprechi e
dei costi della casta dei rappresentanti politici dei cittadini nelle
istituzioni, siano essi Parlamentari o amministratori e consiglieri degli enti
locali. Molti di loro vorrebbero i barboni in Parlamento. Nessuno che pretenda
che i nostri Parlamentari siano all’altezza del mandato ricevuto, per
competenza, dedizione e moralità, al di là della fedina penale o delle prebende
a loro destinate. Dimenticandoci che ci sono altri boiardi di Stato: i militari,
i dirigenti pubblici e, soprattutto, i magistrati. Mai nessuno che si chieda:
che fine fanno i nostri soldi, estorti con balzelli di ogni tipo. Se è vero,
come è vero, che ci chiudono gli ospedali, ci chiudono i tribunali, non ci sono
vie di comunicazione (strade e ferrovie), la pensione non è garantita e il
lavoro manca. E poi sulla giustizia, argomento dove tutti tacciono, ma c’è tanto
da dire. “Delegittimano la Magistratura” senti accusare gli idolatri sinistroidi
in presenza di velate critiche contro le malefatte dei giudici, che in
democrazia dovrebbero essere ammesse. Pur non avendo bisogno di difesa d’ufficio
c’è sempre qualche manettaro che difende la Magistratura dalle critiche che essa
fomenta. Non è un Potere, ma la sinistra lo fa passare per tale, ma la
Magistratura, come ordine costituzionale detiene un potere smisurato. Potere
ingiustificato, tenuto conto che la sovranità è del popolo che la esercita nei
modi stabiliti dalle norme. Potere delegato da un concorso pubblico come può
essere quello italiano, che non garantisce meritocrazia. Criticare l’operato dei
magistrati nei processi, quando la critica è fondata, significa incutere dubbi
sul loro operato. E quando si sentenzia, da parte dei colleghi dei PM, adottando
le tesi infondate dell’accusa, si sentenzia nonostante il ragionevole dubbio.
Quindi si sentenzia in modo illegittimo che comunque è difficile vederlo
affermare da una corte, quella di Cassazione, che rappresenta l’apice del potere
giudiziario. Le storture del sistema dovrebbero essere sanate dallo stesso
sistema. Ma quando “Il Berlusconi” di turno si sente perseguitato dal maniaco
giudiziario, non vi sono rimedi. Non è prevista la ricusazione del Pubblico
Ministero che palesa il suo pregiudizio. Vi si permette la ricusazione del
giudice per inimicizia solo se questi ha denunciato l’imputato e non viceversa.
E’ consentita la ricusazione dei giudici solo per giudizi espliciti preventivi,
come se non vi potessero essere intendimenti impliciti di colleganza con il PM.
La rimessione per legittimo sospetto, poi, è un istituto mai applicato.
Lasciando perdere Berlusconi, è esemplare il caso ILVA a Taranto. Tutta la
magistratura locale fa quadrato: dal presidente della Corte d’Appello di Lecce,
Buffa, al suo Procuratore Generale, Vignola, fino a tutto il Tribunale di
Taranto. E questo ancora nella fase embrionale delle indagini Preliminari. Quei
magistrati contro tutti, compreso il governo centrale, regionale e locale,
sostenuti solo dagli ambientalisti di maniera. Per Stefano Livadiotti, autore di
un libro sui magistrati, arrivano all'apice della carriera in automatico e
guadagnano 7 volte più di un dipendente”, scrive Sergio Luciano su “Il
Giornale”.
Pubblichiamo ampi stralci dell'intervista di Affaritaliani.it a Stefano
Livadiotti realizzata da Sergio Luciano. Livadiotti, giornalista del settimanale
l'Espresso e autore di Magistrati L'ultracasta, sta aggiornando il suo
libro sulla base dei dati del rapporto 2012 del Cepej (Commissione europea per
l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa). Livadiotti è anche
l'autore di un libro sugli sprechi dei sindacati, dal titolo L'altra casta.
La giustizia
italiana non funziona, al netto delle polemiche politiche sui processi
Berlusconi. Il rapporto 2012 del Cepej (Commissione europea per l'efficienza
della giustizia del Consiglio d'Europa) inchioda il nostro sistema alla sua
clamorosa inefficienza: 492 giorni per un processo civile in primo grado, contro
i 289 della Spagna, i 279 della Francia e i 184 della Germania. Milioni di
procedimenti pendenti. E magistrati che fanno carriera senza alcuna selezione
meritocratica. E senza alcun effettivo rischio di punizione nel caso in cui
commettano errori o illeciti. «Nessun sistema può essere efficiente se non
riconosce alcun criterio di merito», spiega Stefano Livadiotti, giornalista del
settimanale l'Espresso e autore di Magistrati-L'ultracasta. «È evidente che
Silvio Berlusconi ha un enorme conflitto d'interessi in materia, che ne
delegittima le opinioni, ma ciò non toglie che la proposta di riforma avanzata
all'epoca da Alfano, con la separazione delle carriere, la ridefinizione della
disciplina e la responsabilità dei magistrati, fosse assolutamente giusta».
Dunque
niente meritocrazia, niente efficienza in tribunale?
«L'attuale
normativa prevede che dopo 27 anni dall'aver preso servizio, tutti i magistrati
raggiungano la massima qualifica di carriera possibile. Tanto che nel 2009 il
24,5% dei circa 9.000 magistrati ordinari in servizio era appunto all'apice
dell'inquadramento. E dello stipendio. E come se un quarto dei giornalisti
italiani fosse direttore del Corriere della Sera o di Repubblica».
E come si
spiega?
«Non si
spiega. Io stesso quando ho studiato i meccanismi sulle prime non ci credevo.
Eppure e così. Fanno carriera automaticamente, solo sulla base dell'anzianità di
servizio. E di esami che di fatto sono una barzelletta. I verbali del Consiglio
superiore della magistratura dimostrano che dal 1° luglio 2008 al 31 luglio 2012
sono state fatte, dopo l'ultima riforma delle procedure, che avrebbe dovuto
renderle più severe, 2.409 valutazioni, e ce ne sono state soltanto 3 negative,
una delle quali riferita a un giudice già in pensione!».
Tutto
questo indipendentemente dagli incarichi?
«Dagli
incarichi e dalle sedi. E questa carriera automatica si riflette, ovviamente,
sulla spesa per le retribuzioni. I magistrati italiani guadagnano più di tutti i
loro colleghi dell'Europa continentale, e al vertice della professione
percepiscono uno stipendio parti a 7,3 volte lo stipendio medio dei lavoratori
dipendenti italiani».
Quasi
sempre i magistrati addebitano ritardi e inefficienze al basso budget statale
per la giustizia.
«Macché, il
rapporto Cepej dimostra che la macchina giudiziaria costa agli italiani, per
tribunali, avvocati d'ufficio e pubblici ministeri, 73 euro per abitante
all'anno (dato 2010, ndr) contro una media europea di 57,4. Quindi molto di
più».
Ma almeno
rischiano sanzioni disciplinari?
«Assolutamente
no, di fatto. Il magistrato è soggetto solo alla disciplina domestica, ma
sarebbe meglio dire addomesticata, del Csm. E cane non mangia cane. Alcuni dati
nuovi ed esclusivi lo dimostrano».
Quali dati?
«Qualunque
esposto venga rivolto contro un magistrato, passa al filtro preventivo della
Procura generale presso la Corte di Cassazione, che stabilisce se c'è il
presupposto per avviare un procedimento. Ebbene, tra il 2009 e il 2011 - un dato
che fa impressione - sugli 8.909 magistrati ordinari in servizio, sono pervenute
a questa Procura 5.921 notizie di illecito: il PG ha archiviato 5.498 denunce,
cioè il 92,9%; quindi solo 7,1% è arrivato davanti alla sezione disciplinare del
Csm».
Ma poi ci
saranno state delle sanzioni, o no?
«Negli ultimi
5 anni, tra il 2007 e il 2011, questa sezione ha definito 680 procedimenti, in
seguito ai quali i magistrati destituiti sono stati... nessuno. In dieci anni,
tra il 2001 e il 2011, i magistrati ordinari destituiti dal Csm sono stati 4,
pari allo 0,28 di quelli finiti davanti alla sezione disciplinare e allo 0,044
di quelli in servizio».
Ma c'è
anche una legge sulla responsabilità civile, che permette a chi subisca un
errore giudiziario di essere risarcito!
«In teoria sì,
è la legge 117 dell'88, scritta dal ministro Vassalli per risponde al referendum
che aveva abrogato le norme che limitavano la responsabilità dei magistrati».
E com'è
andata, questa legge?
«Nell'arco 23
anni, sono state proposte in Italia 400 cause di richiesta di risarcimento danni
per responsabilità dei giudici. Di queste, 253 pari al 63% sono state dichiarate
inammissibili con provvedimento definitivo. Ben 49, cioè 12% sono in attesa di
pronuncia sull'ammissibilità, 70, pari al 17%, sono in fase di impugnazione di
decisione di inammissibilità, 34, ovvero l'8,5%, sono state dichiarate
ammissibili. Di queste ultime, 16 sono ancora pendenti e 18 sono state decise:
lo Stato ha perso solo 4 volte. In un quarto di secolo è alla fine è stato
insomma accolto appena l'1 per cento delle pochissime domande di risarcimento».
Cioè non si
sa quanto lavorano e guadagnano?
«Risulta che
da un magistrato ci si possono attendere 1.560 ore di lavoro all'anno, che
diviso per 365 vuol dire che lavora 4,2 ore al giorno. Sugli stipendi bisogna
vedere caso per caso, perché ci sono molte variabili. Quel che è certo, un
consigliere Csm, sommando stipendi base, gettoni, rimborsi e indennizzi, e
lavorando 3 settimane su 4 dal lunedì al giovedì, quindi 12 giorni al mese,
guadagna 2.700 euro per ogni giorno di lavoro effettivo».
TRALASCIANDO L’ABILITAZIONE UNTA DAI VIZI ITALICI, A FRONTE DI TUTTO QUESTO CI
RITROVIAMO CON 5 MILIONI DI ITALIANI VITTIME DI ERRORI GIUDIZIARI.
MAGISTRATI
CHE SONO MANTENUTI DAI CITTADINI E CHE SPUTANO NEL PIATTO IN CUI MANGIANO.
Chi frequenta
assiduamente le aule dei tribunali, da spettatore o da attore, sa benissimo che
sono luogo di spergiuro e di diffamazioni continue da parte dei magistrati e
degli avvocati. Certo è che sono atteggiamenti impuniti perché i protagonisti
non possono punire se stessi. Quante volte le requisitorie dei Pubblici
Ministeri e le arringhe degli avvocati di parte civile hanno fatto carne da
macello della dignità delle persone imputate, presunte innocenti in quella fase
processuale e, per lo più, divenuti tali nel proseguo. I manettari ed i
forcaioli saranno convinti che questa sia un regola aurea per affermare la
legalità. Poco comprensibile e giustificabile è invece la sorte destinata alle
vittime, spesso trattate peggio dei delinquenti sotto processo.
Tutti hanno
sentito le parole di Ilda Boccassini: "Ruby è furba di quella furbizia orientale
propria della sua origine". «E' una giovane di furbizia orientale che come molti
dei giovani delle ultime generazioni ha come obbiettivo entrare nel mondo
spettacolo e fare soldi, il guadagno facile, il sogno italiano di una parte
della gioventù che non ha come obiettivo il lavoro, la fatica, lo studio ma
accedere a meccanismi che consentano di andare nel mondo dello spettacolo, nel
cinema. Questo obiettivo - ha proseguito la Boccassini - ha accomunato la
minore "con le ragazze che sono qui sfilate e che frequentavano la residenza di
Berlusconi: extracomunitarie, prostitute, ragazze di buona famiglia anche con
lauree, persone che hanno un ruolo nelle istituzioni e che pure avevano un ruolo
nelle serate di Arcore come la europarlamentare Ronzulli e la europarlamentare
Rossi. In queste serate - afferma il pm - si colloca anche il sogno di Kharima.
Tutte, a qualsiasi prezzo, dovevano avvicinare il presidente del Consiglio con
la speranza o la certezza di ottenere favori, denaro, introduzione nel mondo
dello spettacolo».
Fino a prova contraria Ruby,
Karima El Mahroug, è parte offesa nel processo.
La ciliegina
sulla torta, alla requisitoria, è quella delle 14.10 circa del 31 maggio 2013,
quando Antonio Sangermano era sul punto d'incorrere su una clamorosa gaffe che
avrebbe fatto impallidire quella della Boccassini su Ruby: "Non si può
considerare la Tumini un cavallo di ....", ha detto di Melania Tumini,
la principale teste dell'accusa, correggendosi un attimo prima di pronunciare la
fatidica parola.
Ancora come
esempio riferito ad un caso mediatico è quello riconducibile alla morte di
Stefano Cucchi.
“Vi annuncio
che da oggi pomeriggio (8 aprile 2013) provvederò a inserire sulla mia pagina
ufficiale di Facebook quanto ci hanno riservato i pm ed avvocati e le
loro poco edificanti opinioni sul nostro conto. Buon ascolto”, ha scritto sulla
pagina del social network Ilaria Cucchi, sorella di Stefano. E il primo audio è
dedicato proprio a quei pm con i quali la famiglia Cucchi si è trovata
dall’inizio in disaccordo. «Lungi dall’essere una persona sana e sportiva,
Stefano Cucchi era un tossicodipendente da 20 anni,…….oltre che essere
maleducato, scorbutico, arrogante, cafone». Stavolta a parlare non è il senatore
del Pdl Carlo Giovanardi – anticipa Ilaria al Fatto –, ma il
pubblico ministero Francesca Loy, durante la requisitoria finale. Secondo
lei mio fratello aveva cominciato a drogarsi a 11 anni…”, commenta ancora
sarcastica la sorella del ragazzo morto. Requisitoria che, a suo dire, sembra in
contraddizione con quella dell’altro pm, Vincenzo Barba, il quale
“ammette – a differenza della collega – che Stefano potrebbe essere stato
pestato. Eppure neanche lui lascia fuori dalla porta l’ombra della droga e,
anzi, pare voglia lasciare intendere che i miei genitori ne avrebbero nascosto
la presenza ai carabinieri durante la perquisizione, la notte dell’arresto”.
A tal riguardo
è uscito un articolo su “L’Espresso”. A firma di Ermanno Forte. “Ora
processano Mastrogiovanni”. Requisitoria da anni '50 nel dibattimento
sull'omicidio del maestro: il pm difende gli imputati e se la prende con le
'bizzarrie' della vittima. Non c'è stato sequestro di persona perché la
contenzione è un atto medico e quindi chi ha lasciato un uomo legato mani e
piedi a un letto, per oltre 82 ore, ha semplicemente agito nell'esercizio di un
diritto medico. Al massimo ha ecceduto nella sua condotta, ma questo non basta a
considerare sussistente il reato di sequestro. E' questa la considerazione
centrale della requisitoria formulata da Renato Martuscelli al processo che vede
imputati medici e infermieri del reparto di psichiatria dell'ospedale San Luca
di Vallo della Lucania, per la morte di Francesco Mastrogiovanni. Il pm ha
dunque in gran parte sconfessato l'impianto accusatorio imbastito nella fase
delle indagini e di richiesta di rinvio a giudizio da Francesco Rotondo, il
magistrato che sin dall'inizio ha lavorato sul caso, disponendo l'immediato
sequestro del video registrato dalle telecamere di sorveglianza del reparto
psichiatrico, e che poi è stato trasferito. Nella prima parte della requisitoria
- durata un paio d'ore, davanti al presidente del tribunale Elisabetta Garzo
–Martuscelli si è soffermato a lungo sui verbali di carabinieri e vigili urbani
relativi alle ore precedenti al ricovero (quelli dove si descrivono le reazioni
di Mastrogiovanni alla cattura avvenuta sulla spiaggia di San Mauro Cilento e le
presunte infrazioni al codice della strada commesse dal maestro), oltre a
ripercorrere la storia sanitaria di Mastrogiovanni, già sottoposto in passato a
due Tso, nel 2002 e nel 2005. "Una buona metà dell'intervento del pm è stata
dedicata a spiegare al tribunale quanto fosse cattivo e strano Franco
Mastrogiovanni" commenta Michele Capano, rappresentante legale del Movimento per
la Giustizia Robin Hood, associazione che si è costituita parte civile al
processo "sembrava quasi che l'obiettivo di questa requisitoria fosse lo stesso
maestro cilentano, e non i medici di quel reparto".
Beati coloro che hanno fame e
sete di giustizia perché saranno giustiziati.
“Il carcere
uno stupro. Ora voglio la verità”, dice Massimo Cellino, presidente del
Cagliari calcio, ad Ivan Zazzaroni.
«Voglio
conoscere la vera ragione di tutto questo, i miei legali l’hanno definito “uno
stupro”. Cassazione e Tar hanno stabilito che non ci sono stati abusi, dandomi
ragione piena. -
Ricorda:
riordina. - La forestale s’è presentata a casa mia alle sette del mattino. Ho le
piante secche?, ho chiesto. E loro: deve venire con noi. Forza, tirate fuori le
telecamere, dove sono le telecamere? Siete di Scherzi a parte. L’inizio di un
incubo dal quale non esco. Sto male, non sono più lo stesso. A Buoncammino mi
hanno messo in una cella minuscola, giusto lo spazio per un letto, il vetro
della finestra era rotto, la notte faceva freddo. Un detenuto mi ha regalato una
giacca, un altro i pantaloni della tuta, alla fine ero coperto a strati con in
testa una papalina. Mi hanno salvato il carattere e gli altri detenuti. Un
ragazzo che sconta otto anni e mezzo perché non ha voluto fare il nome dello
spacciatore che gli aveva consegnato la roba. Otto anni e mezzo, capisci? “Se
parlo non posso più tornare a casa, ho paura per i miei genitori”, ripeteva. E
poi un indiano che mi assisteva in tutto, credo l’abbiano trasferito come altri
a Macomer. Mi sento in colpa per loro, solo per loro. Ringrazio
le guardie carcerarie, si sono dimostrate sensibili… Mi ha tradito la Sardegna
delle istituzioni. Ma adesso voglio il perché, la verità. Non si può finire in
carcere per arroganza». Una situazione di straordinario strazio per un uomo fin
troppo diretto ma di un’intelligenza e una prontezza rare quale è il presidente
del Cagliari. «Non odio nessuno (lo ripete più volte). Ma ho provato vergogna.
Non ho fatto un cazzo di niente. Dopo la revoca dei domiciliari per un paio di
giorni non ho avuto la forza di tornare a casa. Sono rimasto ad Assemini con gli
avvocati, Altieri e Cocco – Cocco per me è un fratello. E le
intercettazioni? Pubblicatele, nulla, non c’è nulla. Mi hanno accusato
di aver trattato con gente che non ho mai incontrato, né sentito; addirittura mi
è stato chiesto cosa fossero le emme-emme di cui parlavo durante una telefonata:
solo un sardo può sapere cosa significhi emme-emme, una pesante volgarità (sa
minchia su molente, il pene dell’asino). Da giorni mi raccontano di assessori
che si dimettono, di magistrati che chiedono il trasferimento. Mi domando cosa
sia diventata Cagliari, e dove sia finita l’informazione che non ha paura di
scrivere o dire come stanno realmente le cose.
Cosa penso oggi dei magistrati? Io sono dalla parte dei pm, lo sono sempre
stato!»
VEDETE, E’ TUTTO INUTILE.
NON C’E’ NIENTE DA FARE. SE QUANTO PROVATO SULLA PROPRIA PELLE E SE QUANTO DETTO
HA UN RISCONTRO E TUTTO CIO' NON BASTA A RIBELLARSI O ALMENO A RICREDERSI
SULL'OPERATO DELLA MAGISTRATURA, ALLORA MAI NULLA CAMBIERA' IN QUESTA ITALIA CON
QUESTI ITALIANI.
D'altronde di italiani si
tratta: dicono una cosa ed un’altra ne fanno. Per esempio, rimanendo in ambito
sportivo in tema di legalità, è da rimarcare come la
parola di un altoatesino vale di più di quella di un napoletano. Almeno secondo
Alex Schwazer, atleta nato in quel di Vipiteno il 26 dicembre 1984, trovato
positivo al test antidoping prima delle Olimpiadi di Londra 2012. Era il 28
giugno 2012. Due giorni dopo, un test a sorpresa della Wada, l'agenzia mondiale
antidoping, avrebbe rivelato la sua positività all'assunzione dell'Epo. «Posso
giurare che non ho fatto niente di proibito – scriveva Schwazer, il 28 giugno
2012, al medico della Fidal Pierluigi Fiorella – ti ho dato la mia parola e non
ti deluderò. Sono altoatesino, non sono napoletano». Due giorni dopo, il 30
giugno, l'atleta viene trovato positivo all'Epo. Ma l'insieme della
contraddizioni (a voler essere gentili) non finisce qui. Nella sua confessione
pubblica dell'8 agosto 2012, Schwazer ammise di aver assunto Epo a causa di un
cedimento psicologico. Era un brutto periodo, e qualcosa bisognava pur fare. Ma
le indagini dei Ros di Trento e dei Nas di Firenze contraddicono la versione
dell'assunzione momentanea. I carabinieri, addirittura, parlano di “profilo
ematologico personale”, un'assunzione continua e costante di sostanze dopanti
per la quale non è escluso che Schwazer facesse utilizzo di Epo anche durante i
giochi di Pechino 2008. Competizione, lo ricordiamo, dove l'atleta di Vipiteno,
vinse l'oro alla marcia di 50 chilometri. Infatti, questo si evince anche nel
decreto di perquisizione della Procura di Bolzano. “La polizia giudiziaria
giunge pertanto a ritenere che non possa escludersi che Schwazer Alex, già
durante la preparazione per i Giochi Olimpici di Pechino 2008 (e
forse ancor prima), sia stato sottoposto a trattamenti farmacologici
o a manipolazioni fisiologiche capaci di innalzare considerevolmente i suoi
valori ematici.” Insomma: Schwazer non solo
offende i napoletani e di riporto tutti i meridionali, incluso me, ma poi, come
un fesso, si fa cogliere pure con le mani nel sacco. E dire che, oltretutto, è
la parola di un carabiniere, qual è Alex Schwazer.
L'Italia è
un Paese fondato sulla fregatura: ecco tutti i modi in cui gli italiani
raggirano gli altri (e sé stessi).
In un libro, "Io
ti fotto" di Carlo Tecce e Marco Morello, la pratica dell'arte della
fregatura in Italia. Dai più alti livelli ai più infimi, dalle truffe moderne
realizzate in Rete a quelle più antiche e consolidate.
In Italia, fottere l'altro - una parola più tenue non renderebbe
l'idea - è un vizio che è quasi un vanto, "lo ti fotto" è una legge: di più, un
comandamento.
E fottuti siamo stati dagli albori della Repubblica.
L'armistizio di Cassabile in Sicilia o armistizio corto, siglato
segretamente il 3 settembre 1943, è l'atto con il quale il Regno d’Italia cessò
le ostilità contro le forze anglo-americane (alleati) nell'ambito della seconda
guerra mondiale. In realtà non si trattava affatto di un armistizio ma di una
vera e propria resa senza condizioni da parte dell'Italia. Poiché tale atto
stabiliva la sua entrata in vigore dal momento del suo annuncio pubblico, esso è
comunemente detto dell'" 8 settembre", data in cui, alle 18.30, fu pubblicamente
reso noto prima dai microfoni di Radio Algeri da parte del generale Dwight D.
Eisenhower e, poco più di un'ora dopo, alle 19.42, confermato dal proclama del
maresciallo Pietro Badoglio trasmesso dai microfoni dell' Eiar. In quei
frangenti vi fu grande confusione e i gerarchi erano in fuga. L’esercito allo
sbando. Metà Italia combatteva contro gli Alleati, l’altra metà a favore.
La grande
ipocrisia vien da lontano. “I Vinti non dimenticano” (Rizzoli 2010), è il
titolo del volume di Giampaolo Pansa. Ci si fa largo tra i
morti, ogni pagina è una fossa e ci sono perfino preti che negano la benedizione
ai condannati. E poi ci sono le donne, tante, tutte ridotte a carne su cui
sbattere il macabro pedaggio dell’odio. È un viaggio nella memoria negata,
quella della guerra civile, altrimenti celebrata nella retorica della
Resistenza.. Le storie inedite di sangue e violenza che completano e concludono
"Il sangue dei vinti", uscito nel 2003. Si tenga conto
che da queste realtà politiche uscite vincenti dalla guerra civile è nata
l'alleanza catto-comunista, che ha dato vita alla Costituzione Italiana e
quantunque essa sia l'architrave delle nostre leggi, ad oggi le norme più
importanti, che regolano la vita degli italiani (codice civile, codice penale,
istituzione e funzionamento degli Ordini professionali, ecc.), sono ancora
quelle fasciste: alla faccia dell'ipocrisia comunista, a cui quelle leggi non
dispiacciono.
Esecuzioni,
torture, stupri. Le crudeltà dei partigiani. La Resistenza mirava alla dittatura
comunista. Le atrocità in nome di Stalin non sono diverse dalle efferatezze
fasciste. Anche se qualcuno ancora lo nega scrive Giampaolo Pansa. (scrittore
notoriamente comunista osteggiato dai suoi compagni di partito per essere ai
loro occhi delatore di verità scomode). C’è da scommettere che il libro di
Giampaolo Pansa, "La guerra sporca dei partigiani e dei fascisti" (Rizzoli,
pagg. 446), farà infuriare le vestali della Resistenza. Mai in maniera così
netta come nell’introduzione al volume (di cui per gentile concessione “Il
Giornale” pubblica un estratto) i crimini partigiani sono equiparati a quelli
dei fascisti. Giampaolo Pansa imbastisce un romanzo che, sull’esempio delle sue
opere più note, racconta la guerra civile in chiave revisionista, sottolineando
le storie dei vinti e i soprusi dei presunti liberatori, i partigiani comunisti
in realtà desiderosi di sostituire una dittatura con un’altra, la loro.
Altra storica
menzogna è stata sbugiardata da
"Mai più
terroni. La fine della questione meridionale"
di Pino Aprile. Come abbattere i pregiudizi che rendono il meridione diverso?
Come mettere fine a una questione costruita ad arte sulla pelle di una parte
d'Italia? La risposta sta anche negli strumenti di comunicazione odierni, capaci
di abbattere i confini, veri o fittizi, rompere l'isolamento, superare le
carenze infrastrutturali. E se per non essere più "meridionali" bastasse un
clic? Con la sua solita vis polemica, Pino Aprile ci apre un mondo per mostrare
quanto questo sia vero, potente e dilagante. "Ops... stanno finendo i terroni.
Ma come, già? E così, da un momento all'altro?"
Terroni a
chi? Tre libri sul pregiudizio antimeridionale. Come è nata e come si è
sviluppata la diffidenza verso il Sud. Tre libri ne ricostruiscono le origini e
provano a ipotizzarne gli scenari.
"Negli ormai
centocinquant'anni di unità italiana il Mezzogiorno non ha mai mancato di creare
problemi". D'accordo, la frase è netta e controversa. Sulla questione
meridionale, nell'ultimo secolo e mezzo, si sono sprecati fiumi di inchiostro,
tonnellate di pagine, migliaia di convegni. In gran parte dedicati all'indagine
sociologica, al pregiudizio politico o alla rivendicazione identitaria. Ciò che
colpisce allora di "La palla al piede" di Antonino De Francesco
(Feltrinelli) è lo sguardo realistico e l'approccio empirico. De Francesco è
ordinario di Storia moderna all'Università degli studi di Milano, ma definire il
suo ultimo lavoro essenzialmente storico è quantomeno limitativo. In poco meno
di duecento pagine, l'autore traccia l'identikit di un pregiudizio, quello
antimeridionale appunto, nei suoi aspetti sociali, storici e politici. Lo fa
rincorrendo a una considerevole pubblicistica per niente autoreferenziale, che
non si ostina nel solito recinto storiografico. Il risultato si avvicina a una
controstoria dell'identità italiana e, al tempo stesso, a un'anamnesi dei vizi e
dei tic dell'Italia Unita. Ma per raccontare una storia ci si può ovviamente
mettere sulle tracce di una tradizione e cercare, attraverso le sue strette
maglie, di ricostruire una vicenda che ha il respiro più profondo di una
semplice schermaglia localistica. E' quello che accade nel "Libro napoletano
dei morti" di Francesco Palmieri (Mondadori). Racconta la Napoli eclettica e
umbratile che dall’Unità d'Italia arriva fino alla Prima guerra mondiale. Per
narrarla, si fa scudo della voce del poeta napoletano Ferdinando Russo
ricostruendo con una certa perizia filologica e una sottile verve
narrativa le luci e le smagliature di un'epopea in grado di condizionare la
realtà dei giorni nostri. Ha il respiro del pamphlet provocatorio e spiazzante
invece l'ultimo libro di Pino Aprile, "Mai più terroni" (Piemme), terzo
volume di una trilogia di successo (Terroni e Giù al Sud i titoli
degli altri due volumi). Aprile si domanda se oggi abbia ancora senso dividere
la realtà sulla base di un fantomatico pregiudizio etnico e geografico
che ha la pretesa di tagliare Nord e Sud. E si risponde che no, che in tempi di
iperconnessioni reali (e virtuali), quelli stereotipo è irrimediabilmente
finito. "Il Sud - scrive - è un luogo che non esiste da solo, ma soltanto se
riferito a un altro che lo sovrasta". Nelle nuove realtà virtuali, vecchie
direzioni e punti cardinali non esistono più, relegati come sono a un
armamentario che sa di vecchio e obsoleto.
D'altronde
siamo abituati alle stronzate dette da chi in mala fede parla e le dice a chi,
per ignoranza, non può contro ribattere. Cominciamo a dire: da quale pulpito
viene la predica. Vediamo in Inghilterra cosa succede. I sudditi inglesi
snobbano gli italiani. Ci chiamano mafiosi, ma perché a loro celano la verità.
Noi apprendiamo la notizia dal tg2 delle 13.00 del 2 gennaio 2012. Il loro
lavoro è dar la caccia ai criminali, ma alcuni ladri non sembrano temerle: le
forze di polizia del Regno sono state oggetto di furti per centinaia di migliaia
di sterline, addirittura con volanti, manette, cani ed uniformi tutte sparite
sotto il naso degli agenti. Dalla lista, emersa in seguito ad una richiesta
secondo la legge sulla libertà d'informazione, emerge che la forza di polizia
più colpita è stata quella di Manchester, dove il valore totale degli oggetti
rubati arriva a quasi 87.000 sterline. Qui i ladri sono riusciti a fuggire con
una volante da 10.000 sterline e con una vettura privata da 30.000.
E poi. Cosa
sarebbe oggi la Germania se avesse sempre onorato con puntualità il proprio
debito pubblico? Si chiede su “Il Giornale” Antonio Salvi, Preside della
Facoltà di Economia dell’Università Lum "Jean Monnet". Forse non a tutti è
noto, ma il Paese della cancelliera Merkel è stato protagonista di uno dei più
grandi, secondo alcuni il più grande, default del secolo scorso, nonostante non
passi mese senza che Berlino stigmatizzi il comportamento vizioso di alcuni
Stati in materia di conti pubblici. E invece, anche la Germania, la grande e
potente Germania, ha qualche peccatuccio che preferisce tenere nascosto.
Anche se
numerosi sono gli studi che ne danno conto, di seguito brevemente tratteggiati.
Riapriamo i libri di storia e cerchiamo di capire la successione dei fatti. La
Germania è stata protagonista «sfortunata» di due guerre mondiali nella prima
metà dello scorso secolo, entrambe perse in malo modo. Come spesso accade in
questi casi, i vincitori hanno presentato il conto alle nazioni sconfitte, in
primis alla Germania stessa. Un conto salato, soprattutto quello successivo alla
Prima guerra mondiale, talmente tanto salato che John Maynard Keynes, nel suo
Conseguenze economiche della pace, fu uno dei principali oppositori a tale
decisione, sostenendo che la sua applicazione avrebbe minato in via permanente
la capacità della Germania di avviare un percorso di rinascita post-bellica.
Così effettivamente accadde, poiché la Germania entrò in un periodo di profonda
depressione alla fine degli anni '20 (in un più ampio contesto di recessione
mondiale post '29), il cui esito minò la capacità del Paese di far fronte ai
propri impegni debitori internazionali. Secondo Scott Nelson, del William and
Mary College, la Germania negli anni '20 giunse a essere considerata come
«sinonimo di default». Arrivò così il 1932, anno del grande default tedesco.
L'ammontare del debito di guerra, secondo gli studiosi, equivalente nella sua
parte «realistica» al 100% del Pil tedesco del 1913 (!), una percentuale
ragguardevole. Poi arrivò al potere Hitler e l'esposizione debitoria non trovò
adeguata volontà di onorare puntualmente il debito (per usare un eufemismo). I
marchi risparmiati furono destinati ad avviare la rinascita economica e il
programma di riarmo. Si sa poi come è andata: scoppio della Seconda guerra
mondiale e seconda sconfitta dei tedeschi. A questo punto i debiti pre-esistenti
si cumularono ai nuovi e l'esposizione complessiva aumentò. Il 1953 rappresenta
il secondo default tedesco. In quell'anno, infatti, gli Stati Uniti e gli altri
creditori siglarono un accordo di ridefinizione complessiva del debito tedesco,
procedendo a «rinunce volontarie» di parte dei propri crediti, accordo che
consentì alla Germania di poter ripartire economicamente (avviando il proprio
miracolo economico, o «wirtschaftswunder»). Il lettore non sia indotto in
inganno: secondo le agenzie di rating, anche le rinegoziazioni volontaristiche
configurano una situazione di default, non solo il mancato rimborso del capitale
e degli interessi (la Grecia nel 2012 e l'Argentina nel 2001 insegnano in tal
senso). Il risultato ottenuto dai tedeschi dalla negoziazione fu davvero
notevole:
1)
l'esposizione debitoria fu ridotta considerevolmente: secondo alcuni calcoli, la
riduzione concessa alla Germania fu nell'ordine del 50% del debito complessivo!
2) la durata
del debito fu estesa sensibilmente (peraltro in notevole parte anche su debiti
che erano stati non onorati e dunque giunti a maturazione già da tempo). Il
rimborso del debito fu «spalmato» su un orizzonte temporale di 30 anni;
3) le somme
corrisposte annualmente ai creditori furono legate al fatto che la Germania
disponesse concretamente delle risorse economiche necessarie per effettuare tali
trasferimenti internazionali.
Sempre secondo
gli accordi del '53, il pagamento di una parte degli interessi arretrati fu
subordinata alla condizione che la Germania si riunificasse, cosa che, come
noto, avvenne nell'ottobre del 1990. Non solo: al verificarsi di tale condizione
l'accordo del 1953 si sarebbe dovuto rinegoziare, quantomeno in parte. Un terzo
default, di fatto. Secondo Albrecht Frischl, uno storico dell'economia tedesco,
in una intervista concessa a Spiegel, l'allora cancelliere Kohl si oppose alla
rinegoziazione dell'accordo. A eccezione delle compensazioni per il lavoro
forzato e il pagamento degli interessi arretrati, nessun'altra riparazione è
avvenuta da parte della Germania dopo il 1990. Una maggiore sobrietà da parte
dei tedeschi nel commentare i problemi altrui sarebbe quanto meno consigliabile.
Ancora Fritschl, precisa meglio il concetto: «Nel Ventesimo secolo, la Germania
ha dato avvio a due guerre mondiali, la seconda delle quali fu una guerra di
annientamento e sterminio, eppure i suoi nemici annullarono o ridussero
pesantemente le legittime pretese di danni di guerra. Nessuno in Grecia ha
dimenticato che la Germania deve la propria prosperità alla generosità delle
altre nazioni (tra cui la Grecia, ndr)». È forse il caso di ricordare inoltre
che fu proprio il legame debito-austerità-crisi che fornì linfa vitale ad Adolf
Hitler e alla sua ascesa al potere, non molto tempo dopo il primo default
tedesco. Tre default, secondo una contabilità allargata. Non male per un Paese
che con una discreta periodicità continua a emettere giudizi moralistici sul
comportamento degli altri governi. Il complesso da primo della classe ottunde la
memoria e induce a mettere in soffitta i propri periodi di difficoltà. «Si sa
che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio». Era un
tempo la «bocca di rosa» di De André, è oggi, fra gli altri, la bocca del
Commissario europeo Ottinger (e qualche tempo fa del ministro delle Finanze
tedesco Wolfgang Schauble). A suo avviso, Bruxelles «non si è ancora resa
abbastanza conto di quanto sia brutta la situazione» e l'Europa invece di
lottare contro la crisi economica e del debito, celebra «il buonismo» e si
comporta nei confronti del resto del mondo come una maestrina, quasi un
«istituto di rieducazione». Accidenti, da quale pulpito viene la predica.
Non solo. Un
altro luogo comune viene sfatato ed abbattuto. La Germania di Angela
Merkel è il paese che ha l'economia sommersa più grande d'Europa in
termini assoluti. L'economia in nero teutonica vale 350 miliardi di euro. Sono
circa otto milioni i cittadini tedeschi che vivono lavorando in nero. Secondo
gli esperti il dato è figlio dell'ostilità dei tedeschi ai metodi di pagamento
elettronici. I crucchi preferiscono i contanti. La grandezza dell'economia in
nero della Germania è stata stimata e calcolata dal colosso delle carte di
credito e dei circuiti di pagamento Visa in collaborazione con l'università di
Linz. In relazione al Pil tedesco il nero sarebbe al 13 per cento, pari a un
sesto della ricchezza nazionale. Quindi in termini relativi il peso del sommerso
è minore, ma per volume e in termini assoluti resta la più grande d'Europa. Chi
lavora in nero in Germania di solito opera nel commercio e soprattutto
nell'edilizia, poi c'è il commercio al dettaglio e infine la gastronomia. Il
livello del nero in Germania comunque si è stabilizzato. Il picco è arrivato
dieci anni fa. Nel 2003 la Germania ha attraversato la peggiore stagnazione
economica degli ultimi vent'anni e all'epoca il nero valeva 370 miliardi. Ora
con l'economia in ripresa che fa da locomotiva per l'Europa, il nero è fermo al
13 per cento del Pil.
Tornando alla
repubblica delle manette ci si chiede. Come può, chi indossa una toga, sentirsi
un padreterno, specie se, come è noto a tutti, quella toga non rispecchia alcun
meritocrazia? D’altronde di magistrati ve ne sono più di 10 mila a regime, cosi
come gli avvocati sono intorno ai 150 mila in servizio effettivo.
Eppure nella
mia vita non ho mai trovato sulla mia strada una toga degna di rispetto, mentre
invece, per loro il rispetto si pretende. A me basta ed avanza essere Antonio
Giangrande, senza eguali per quello che scrive e dice. Pavido nell’affrontare
una ciurma togata pronta a fargli la pelle, mal riuscendoci questi, però, a
tacitarlo sulle verità a loro scomode.
Si chiedeva
Sant’Agostino (354-430): «Eliminata la giustizia, che cosa sono i regni se non
bande di briganti? E cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni?».
Secondo il Vescovo di Ippona è la giustizia il principale, per non dire l’unico,
argine contro la voracità dei potenti.
Da quando è
nato l’uomo, la libertà e la giustizia sono gli unici due strumenti a
disposizione della gente comune per contrastare la condizione di sudditanza in
cui tendono a relegarla i detentori del potere. Anche un bambino comprende che
il potere assoluto equivale a corruzione assoluta.
Certo. Oggi
nessuno parlerebbe o straparlerebbe di assolutismo. I tempi del Re Sole sembrano
più lontani di Marte. Ma, a differenza della scienza e delle tecnologie, l’arte
del governo è l’unica disciplina in cui non si riscontrano progressi. Per dirla
con lo storico Tacito (55-117 d. C.), la sete di potere è la più scandalosa
delle passioni. E come si manifesta questa passione scandalosa? Con l’inflazione
di spazi, compiti e competenze delle classi dirigenti. Detto in termini
aggiornati: elevando il tasso di statalismo presente nella nostra società.
Friedrich
Engels (1820-1895) tutto era tranne che un liberale, ma, da primo marxista della
Storia, scrisse che quando la società viene assorbita dallo Stato, che a suo
giudizio è l’insieme della classe dirigente, il suo destino è segnato:
trasformarsi in «una macchina per tenere a freno la classe oppressa e
sfruttata». Engels ragionava in termini di classe, ma nelle sue parole
riecheggiava una palese insofferenza verso il protagonismo dello Stato, che lui
identificava con il ceto dirigente borghese, che massacrava la società. Una
società libera e giusta è meno corrotta di una società in cui lo Stato comanda
in ogni pertugio del suo territorio. Sembra quasi un’ovvietà, visto che la
scienza politica lo predica da tempo: lo Stato, per dirla con Sant’Agostino,
tende a prevaricare come una banda di briganti. Bisogna placarne gli appetiti.
E così i
giacobini e i giustizialisti indicano nel primato delle procure la vera terapia
contro il malaffare tra politica ed economia, mentre gli antigiustizialisti
accusano i magistrati di straripare con le loro indagini e i loro insabbiamenti
fino al punto di trasformarsi essi stessi in elementi corruttivi, dato che
spesso le toghe, secondo i critici, agirebbero per fini politici, se non,
addirittura, fini devianti, fini massonici e fini mafiosi.
Insomma. Uno
Stato efficiente e trasparente si fonda su buone istituzioni, non su buone
intenzioni. Se le Istituzioni non cambiano si potranno varare le riforme più
ambiziose, dalla giustizia al sistema elettorale; si potranno pure mandare in
carcere o a casa tangentisti e chiacchierati, ma il risultato (in termini di
maggiore onestà del sistema) sarà pari a zero. Altri corrotti si faranno avanti.
La controprova? Gli Stati meno inquinati non sono quelli in cui l’ordinamento
giudiziario è organizzato in un modo piuttosto che in un altro, ma quelli in cui
le leggi sono poche e chiare, e i cui governanti non entrano pesantemente nelle
decisioni e nelle attività che spettano a privati e società civile.
Oggi ci si
scontra con una dura realtà. La magistratura di Milano? Un potere separatista.
Procure e tribunali in Italia fanno quello che vogliono: basta una toga e
arrivederci, scrive Filippo Facci su “Libero Quotidiano”. L’equivoco prosegue da
una vita: un sacco di gente pensa che esista una sinergia collaudatissima tra i
comportamenti della politica e le decisioni della giustizia, come se da qualche
parte ci fosse una camera di compensazione in cui tutti i poteri (politici,
giudiziari, burocratici, finanziari) contrattassero l’uno con l’altro e
rendessero tutto interdipendente. Molti ragionano ancora come Giorgio
Straquadanio sul Fatto: «Questo clima pacifico porta a
Berlusconi una marea di benefici, l’aggressione giudiziaria è destinata a
finire... c’è da aspettarsi che le randellate travestite da sentenze, così come
gli avvisi di garanzie e le inchieste, cessino». Ora: a parte che solo una
nazione profondamente arretrata potrebbe funzionare così, questa è la stessa
mentalità che ha contribuito al crollo della Prima Repubblica, protesa com’era a
trovare il volante «politico» di inchieste che viceversa avevano smesso di
averne uno. In troppi, in Italia, non hanno ancora capito che non esiste più
niente del genere, se non, in misura fisiologica e moderata, a livello di
Quirinale-Consulta-Csm. Ma per il resto procure e tribunali fanno quello che
vogliono: basta un singolo magistrato e arrivederci. L’emblema ne resta Milano,
dove la separatezza tra giudici e procuratori non ci si preoccupa nemmeno di
fingerla: la magistratura, più che separato, è ormai un potere separatista.
Prodigio delle
toghe: per lo stesso reato salvano il Pd e non il Pdl. A Bergamo "non luogo a
procedere" per un democratico, a Milano invece continua il processo contro
Podestà, scrive Matteo Pandini su “Libero Quotidiano”.
Stesso fatto
(firme tarocche autenticate), stesso capo d’accusa (falso ideologico), stesso
appuntamento elettorale (le Regionali lombarde), stesso anno (il 2010). Eppure a
Bergamo un esponente di centrosinistra esce dal processo perché il giudice
stabilisce il «non luogo a procedere», mentre a Milano altri politici di
centrodestra - tra cui il presidente della Provincia Guido Podestà - restano
alla sbarra. Ma andiamo con ordine. Nel febbraio 2010 fervono i preparativi in
vista delle elezioni. È sfida tra Roberto Formigoni e Filippo Penati. Matteo
Rossi, consigliere provinciale di Bergamo del Pd, è un pubblico ufficiale e
quindi può vidimare le sottoscrizioni a sostegno delle varie liste. Ne autentica
una novantina in quel di Seriate a sostegno del Partito pensionati, all’epoca
alleato del centrosinistra. Peccato che tra gli autografi ne spuntino sette
irregolari, tra cui due persone decedute, una nel 2009 e l’altra nel 1992. È il
Comune a sollevare dubbi e il caso finisce in Procura. All’udienza preliminare
l’avvocato Roberto Bruni, ex sindaco del capoluogo orobico e poi consigliere
regionale della lista Ambrosoli, invoca la prescrizione. Lo fa appellandosi a
una riforma legislativa e il giudice gli dà ragione. È successo che Bruni, tra i
penalisti più stimati della città, ha scandagliato il testo unico delle leggi
sulle elezioni. Testo che in sostanza indica in tre anni il tempo massimo per
procedere ed emettere la sentenza. Parliamo di una faccenda da Azzeccagarbugli,
anche perché un recente pronunciamento della Cassazione conferma sì il limite di
tre anni per arrivarne a una, ma solo se la denuncia è partita dai cittadini.
Mentre nel caso di Rossi tutto è scattato per un intervento del Comune di
Seriate. Fatto sta che a Milano c’è un altro processo con lo stesso capo
d’imputazione e che riguarda la lista Formigoni. Nessuno, finora, ha sollevato
la questione della prescrizione ma in questi giorni la decisione del giudice
orobico ha incuriosito non poco gli avvocati Gaetano Pecorella e Maria
Battaglini, dello stesso studio dell’ex parlamentare del Pdl. Vogliono capire
com’è andata la faccenda di Rossi, così da decidere eventuali strategie a difesa
dei loro assistiti, tra cui spicca Podestà. Nel suo caso, le sottoscrizioni
fasulle sarebbero 770, raccolte in tutta la Lombardia: nell’udienza il
procuratore aggiunto Alfredo Robledo e il pm Antonio D’Alessio hanno indicato
come testimoni 642 persone che, sentite dai carabinieri nel corso
dell’inchiesta, avevano affermato che quelle firme a sostegno del listino di
Formigoni, apposte con il loro nome, erano false. Tra i testi ammessi figura
anche l’allora responsabile della raccolta firme del Pdl, Clotilde Strada, che
ha già patteggiato 18 mesi. A processo, oltre a Podestà, ci sono quattro ex
consiglieri provinciali del Popolo della Libertà milanese: Massimo Turci, Nicolò
Mardegan, Barbara Calzavara e Marco Martino. Tutti per falso ideologico, come
Rossi, e tutti per firme raccolte tra gennaio e febbraio del 2010. All’ombra
della Madonnina il processo era scattato per una segnalazione dei Radicali, in
qualità di semplici cittadini. Non è detto che il destino del democratico Rossi
coinciderà con quello degli imputati azzurri di Milano. Strano ma vero.
Certo c’è da
storcere il naso nel constatare che non di democrazia si parla (POTERE
DEL POPOLO) ma di magistocrazia (POTERE DEI MAGISTRATI).
Detto questo
parliamo del Legittimo Impedimento. Nel diritto processuale penale
italiano, il legittimo impedimento è l'istituto che permette all'imputato, in
alcuni casi, di giustificare la propria assenza in aula. In questo caso
l’udienza si rinvia nel rispetto del giusto processo e del diritto di difesa. In
caso di assenza ingiustificata bisogna distinguere se si tratta della prima
udienza o di una successiva. Nel caso di assenza in luogo della prima udienza il
giudice, effettuate le operazioni riguardanti gli accertamenti relativi alla
costituzione delle parti (di cui al 2° comma dell'art. 420), in caso di assenza
non volontaria dell'imputato se ne dichiara la condizione di contumacia e il
procedimento non subisce interruzioni. Se invece l'assenza riguarda una udienza
successiva alla prima ed in quella l'imputato non è stato dichiarato contumace,
questi è dichiarato semplicemente assente. E ancora, se nell'udienza successiva
alla prima alla quale l'imputato non ha partecipato (per causa maggiore, caso
fortuito o forza maggiore) questi può essere ora dichiarato contumace.
''L'indipendenza, l'imparzialità, l'equilibrio dell'amministrazione della
giustizia sono più che mai indispensabili in un contesto di persistenti tensioni
e difficili equilibri sia sul piano politico che istituzionale''. Lo afferma il
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
l’11 giugno 2013 al Quirinale ricevendo i neo giudici al Quirinale e, come se
sentisse puzza nell’aria, invita al rispetto della Consulta.
Tre ''tratti distintivi'' della magistratura, ha sottolineato il capo
dello Stato, ricevendo al Quirinale i 343 magistrati ordinari
in tirocinio, che rappresentano ''un costume da acquisire interiormente,
quasi al pari di una seconda natura''. Napolitano ha chiesto
poi rispetto verso la Consulta: serve "leale
collaborazione, oltre che di riconoscimento verso il giudice delle leggi,
ossia la Corte Costituzionale, chiamata ad arbitrare anche il conflitto tra
poteri dello Stato''. E dopo aver fatto osservare che sarebbe ''inammissibile e
scandaloso rimettere in discussione la revisione delle circoscrizioni
giudiziarie, per ciechi particolarismi anche politici'', Napolitano parlando del
Consiglio superiore della magistratura ha detto che ''non è un organo di mera
autodifesa, bensì un organo di autogoverno, che concorre alle riforme
obiettivamente necessarie'' della giustizia.
D’altronde il
Presidente della Repubblica in quanto capo dei giudici, non poteva dire
altrimenti cosa diversa.
Eppure la
corte Costituzionale non si è smentita.
Per quanto
riguarda il Legittimo Impedimento attribuibile a Silvio Berlusconi, nelle
funzioni di Presidente del Consiglio impegnato in una seduta dello stesso
Consiglio dei Ministri, puntuale, atteso, aspettato, è piovuto il 19 giugno 2013
il "no" al legittimo impedimento. La Corte Costituzionale, nel caso Mediaset, si
schiera contro Silvio Berlusconi. Per le toghe l'ex premier
doveva partecipare all'udienza e non al CDM. È stato corretto l'operato dei
giudici di Milano nel processo “Mediaset” quando, il primo marzo del 2010, non
hanno concesso il legittimo impedimento a comparire in udienza all'allora
premier e imputato di frode fiscale Silvio Berlusconi. A deciderlo, nel
conflitto di attribuzioni sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
in dissidio con i togati milanesi, è stata la Corte Costituzionale che ha
ritenuto che l'assenza dall'udienza non sia stata supportata da alcuna
giustificazione relativa alla convocazione di un Cdm fuori programma rispetto al
calendario concordato in precedenza.
"Incredibile" -
In una
nota congiunta i ministri PDL del governo Letta, Angelino Alfano,
Gaetano Quagliariello, Maurizio
Lupi, Nunzia De Girolamo e Beatrice
Lorenzin, commentano: "E' una decisione incredibile. Siamo allibiti,
amareggiati e profondamente preoccupati. La decisione - aggiungono - travolge
ogni principio di leale collaborazione e sancisce la subalternità della politica
all'ordine giudiziario". Uniti anche tutti i deputati azzurri, che al termine
della seduta della Camera, hanno fatto sapere in un comunicato, "si sono riuniti
e hanno telefonato al presidente Berlusconi per esprimere la loro
profonda indignazione e preoccupazione per la vergognosa
decisione della Consulta che mina gravemente la leale collaborazione tra gli
organi dello Stato e il corretto svolgimento dell’esercizio democratico". Al
Cavaliere, si legge, "i deputati hanno confermato che non sarà certo una
sentenza giudiziaria a decretare la sua espulsione dalla vita politica ed
istituzionale del nostro Paese, e gli hanno manifestato tutta la loro vicinanza
e il loro affetto". "Siamo infatti all’assurdo di una Corte costituzionale che
non ritiene legittimo impedimento la partecipazione di un presidente del
Consiglio al Consiglio dei ministri", prosegue il capogruppo del Pdl alla
Camera, Renato Brunetta, "Dinanzi all’assurdo, che documenta la resa pressoché
universale delle istituzioni davanti allo strapotere dell’ingiustizia in toga,
la tentazione sarebbe quella di chiedere al popolo sovrano di esprimersi e di
far giustizia con il voto". Occorre – dice – una riforma del sistema per
limitare gli abusi e una nuova regolazione dei poteri dell’ordine
giudiziario che non è un potere ma un ordine in quanto la magistratura non è
eletta dal popolo. ''A mente fredda e senza alcuna emozione il giudizio sulla
sentenza è più chiaro e netto che mai. Primo: la sentenza è un'offesa al buon
senso, tanto varrebbe dichiarare l'inesistenza del legittimo impedimento a
prescindere, qualora ci sia di mezzo Silvio Berlusconi. Secondo: la Consulta
sancisce che la magistratura può agire in quanto potere assoluto come princeps
legibus solutus. Terzo: la risposta di Berlusconi e del Pdl con lui è di netta
separazione tra le proteste contro l'ingiustizia e leale sostegno al governo
Letta. Quarto: non rinunceremo in nessun caso a far valere in ogni sede i
diritti politici del popolo di centrodestra e del suo leader, a cui vanno da
parte mia solidarietà e ammirazione. Quinto: credo che tutta la politica, di
destra, di sinistra e di centro, dovrebbe manifestare preoccupazione per una
sentenza che di fatto, contraddicendo la Costituzione, subordina la politica
all'arbitrio di qualsiasi Tribunale''. E' quanto afferma Renato Brunetta,
presidente dei deputati del Pdl. Gli fa eco il deputato Pdl Deborah Bergamini,
secondo cui "è difficile accettare il fatto che viviamo in un Paese in cui c’è
un cittadino, per puro caso leader di un grande partito moderato votato da
milioni di italiani, che è considerato da una parte della magistratura sempre e
per forza colpevole e in malafede. Purtroppo però è così".
Nessuna
preoccupazione a sinistra. "Per quanto riguarda il Pd le sentenze si applicano e
si rispettano quindi non ho motivo di ritenere che possa avere effetti su un
governo che è di servizio per i cittadini e il Paese in una fase molto
drammatica della vita nazionale e dei cittadini", ha detto Guglielmo Epifani, "È
una sentenza che era attesa da tempo. Dà ragione a una parte e torto all’altra,
non vedo un rapporto tra questa sentenza e il quadro politico".
Non si aveva
nessun dubbio chi fossero gli idolatri delle toghe.
LE SENTENZE
DEI GIUDICI SI APPLICANO, SI RISPETTANO, MA NON ESSENDO GIUDIZI DI DIO SI
POSSONO BEN CRITICARE SE VI SONO FONDATE RAGIONI.
Piero Longo e
Niccolò Ghedini, legali di Silvio Berlusconi, criticano duramente la decisione
della Consulta sull'ex premier. «I precedenti della Corte Costituzionale in tema
di legittimo impedimento sono inequivocabili e non avrebbero mai consentito
soluzione diversa dall'accoglimento del conflitto proposto dalla presidenza del
Consiglio dei Ministri», assicurano. Per poi aggiungere: «Evidentemente la
decisione assunta si è basata su logiche diverse che non possono che destare
grave preoccupazione»."La preminenza della giurisdizione rispetto alla
legittimazione di un governo a decidere tempi e modi della propria azione -
continuano i due legali di Silvio Berlusconi - appare davvero al di fuori di
ogni logica giuridica. Di contro la decisione, ampiamente annunciata da giorni
da certa stampa politicamente orientata, non sorprende visti i precedenti della
stessa Corte quando si è trattato del presidente Berlusconi e fa ben comprendere
come la composizione della stessa non sia più adeguata per offrire ciò che
sarebbe invece necessario per un organismo siffatto". Mentre per Franco Coppi,
nuovo legale al posto di Longo, si tratta di «una decisione molto discutibile
che crea un precedente pericoloso perché stabilisce che il giudice può decidere
quando un Consiglio dei ministri è, o meno, indifferibile. Le mie idee sul
legittimo impedimento non coincidono con quelle della Corte Costituzionale ma,
purtroppo, questa decisione la dobbiamo tenere così come è perché è
irrevocabile».
Ribatte
l'Associazione Nazionale Magistrati: «È inaccettabile attribuire alla Consulta
logiche politiche»; un'accusa che «va assolutamente rifiutata». A breve distanza
dalla notizia che la Consulta ha negato il legittimo impedimento a Silvio
Berlusconi nell'ambito del processo Mediaset, arriva anche la reazione di
Rodolfo Sabelli, presidente dell'associazione nazionale magistrati, che
ribadisce alle voci critiche che si sono sollevate dal Pdl la versione delle
toghe."Non si può accettare, a prescindere dalla decisione presa - dice Sabelli
- l’attribuzione alla Corte Costituzionale di posizioni o logiche di natura
politica". Ribadendo l'imparzialità della Corte Costituzionale "a prescindere
dal merito della sentenza", chiede "una posizione di rispetto" per la Consulta e
una discussione che - se si sviluppa - sia però fatta "in modo informato,
conoscendo le motivazioni della sentenza, e con rigore tecnico".
La Corte
costituzionale ha detto no. Respinto il ricorso di Silvio Berlusconi per il
legittimo impedimento (giudicato non assoluto, in questo caso) che non ha
consentito all’allora premier di partecipare all’udienza del 10 marzo 2010 del
processo Mediaset, per un concomitante consiglio dei ministri. Nel dare ragione
ai giudici di Milano che avevano detto no alla richiesta di legittimo
impedimento di Berlusconi, la Corte Costituzionale ha osservato che «dopo che
per più volte il Tribunale (di Milano), aveva rideterminato il calendario delle
udienze a seguito di richieste di rinvio per legittimo impedimento, la riunione
del Consiglio dei ministri, già prevista in una precedente data non coincidente
con un giorno di udienza dibattimentale, è stata fissata dall'imputato
Presidente del Consiglio in altra data coincidente con un giorno di udienza,
senza fornire alcuna indicazione (diversamente da quanto fatto nello stesso
processo in casi precedenti), nè circa la necessaria concomitanza e la non
rinviabilità» dell'impegno, né circa una data alternativa per definire un nuovo
calendario. "La riunione del Cdm - spiega la Consulta - non è un impedimento
assoluto". Si legge nella sentenza: "Spettava all'autorità giudiziaria stabilire
che non costituisce impedimento assoluto alla partecipazione all'udienza penale
del 1 marzo 2010 l'impegno dell'imputato Presidente del Consiglio dei ministri"
Silvio Berlusconi "di presiedere una riunione del Consiglio da lui stesso
convocata per tale giorno", che invece "egli aveva in precedenza indicato come
utile per la sua partecipazione all'udienza".
Ma è veramente
imparziale la Corte costituzionale?
Tutta la
verità sui giornali dopo la bocciatura del “Lodo Alfano”, sulla sospensione dei
procedimenti penali per le più alte cariche dello Stato, avvenuta da parte della
Corte Costituzionale il 7 ottobre 2009. La decisione della
Consulta è arrivata con nove voti a favore e sei contrari. Quanto al
Lodo Alfano, si sottolinea che il
mutamento di indirizzo della Corte "oltre che una scelta politica si
configura anche come violazione del principio di leale
collaborazione tra gli organi costituzionali che ha avuto la conseguenza
di sviare l'azione legislativa del Parlamento". Berlusconi dice: "C'è
un presidente della Repubblica di sinistra, Giorgio Napolitano, e c'è una Corte
costituzionale con undici giudici di sinistra, che non è certamente un
organo di garanzia, ma è un organo politico. Il presidente è stato eletto da una
maggioranza di sinistra, ed ha le radici totali della sua storia nella sinistra.
Credo che anche l'ultimo atto di nomina di un magistrato della Corte dimostri da
che parte sta". La Corte ha 15 membri, con mandato di durata 9 anni: 5 nominati
dal Presidente della Repubblica, Ciampi e Napolitano (di area centro-sinistra);
5 nominati dal Parlamento (maggioranza centro-sinistra); 5 nominati dagli alti
organi della magistratura (che tra le sue correnti, quella più influente è di
sinistra). Non solo. Dalla Lega Nord si scopre che 9 giudici su 15 sono campani.
«Ci sembra alquanto strano che ben 9 dei 15 giudici della Consulta siano
campani» osservano due consiglieri regionali veneti della Lega Nord, Emilio
Zamboni e Luca Baggio. «È quasi incredibile - affermano Zamboni e Baggio - che
un numero così elevato di giudici provenga da una sola regione, guarda caso la
Campania. Siamo convinti che questo dato numerico debba far riflettere non solo
l'opinione pubblica, ma anche i rappresentanti delle istituzioni». «Il Lodo
Alfano è stato bocciato perché ritenuto incostituzionale. Ma cosa c'è di
costituzionale - si chiedono Baggio e Zamboni - nel fatto che la maggior parte
dei giudici della Consulta, che ha bocciato la contestata legge provenga da
Napoli? Come mai c'è un solo rappresentante del Nord?».
Da “Il
Giornale” poi, l’inchiesta verità: “Scandali e giudizi politici: ecco la vera
Consulta”. Ermellini rossi, anche per l’imbarazzo. Fra i giudici della Corte
costituzionale che hanno bocciato il Lodo Alfano ve n’è uno che da sempre
strizza un occhio a sinistra, ma li abbassa tutti e due quando si tratta di
affrontare delicate questioni che riguardano lui o i suoi più stretti congiunti.
È Gaetano Silvestri, 65 anni, ex csm, ex rettore dell’ateneo di Messina, alla
Consulta per nomina parlamentare («alè, hanno eletto un altro comunista!» tuonò
il 22 giugno 2005 l’onorevole Carlo Taormina), cognato di quell’avvocato
Giuseppe «Pucci» Fortino arrestato a maggio 2007 nell’inchiesta Oro Grigio e
sotto processo a Messina per volontà del procuratore capo Luigi Croce. Che ha
definito quel legale intraprendente «il Ciancimino dello Stretto», con
riferimento all’ex sindaco mafioso di Palermo, tramite fra boss e istituzioni.
Per i pm l’«avvocato-cognato» era infatti in grado di intrattenere
indifferentemente rapporti con mafiosi, magistrati, politici e imprenditori. Di
Gaetano Silvestri s’è parlato a lungo anche per la vicenda della «parentopoli»
all’università di Messina. Quand’era rettore s’è scoperto che sua moglie,
Marcella Fortino (sorella di Giuseppe, il «Ciancimino di Messina») era diventata
docente ordinario di Scienze Giuridiche. E che costei era anche cognata dell’ex
pro-rettore Mario Centorrino, il cui figlio diventerà ordinario, pure lui, nel
medesimo ateneo. E sempre da Magnifico, Silvestri scrisse una lettera riservata
al provveditore agli studi Gustavo Ricevuto per perorare la causa del figlio
maturando, a suo dire punito ingiustamente all’esito del voto (si fermò a
97/100) poiché agli scritti - sempre secondo Silvestri - il ragazzo aveva osato
criticare un certo metodo d’insegnamento. La lettera doveva rimanere riservata,
il 5 agosto 2001 finì in edicola. E fu scandalo. «Come costituzionalista -
scrisse Silvestri - fremo all’idea che una scuola di una Repubblica democratica
possa operare siffatte censure, frutto peraltro di un non perfetto aggiornamento
da parte di chi autoritariamente le pone in atto. Ho fatto migliaia di esami in
vita mia, ma sentirei di aver tradito la mia missione se avessi tolto anche un
solo voto a causa delle opinioni da lui professate». Andando al luglio ’94,
governo Berlusconi in carica, Silvestri firma un appello per «mettere in guardia
contro i rischi di uno svuotamento della carta costituzionale attraverso
proposte di riforme e revisione, che non rispettino precise garanzie». Nel 2002
con una pletora di costituzionalisti spiega di «condividere le critiche delle
opposizioni al Ddl sul conflitto di interessi». L’anno appresso, a proposito del
Lodo sull’immunità, se ne esce così: «Siamo costretti a fare i conti con
questioni che dovrebbero essere scontate, che risalgono ai classici dello stato
di diritto (...). Se si va avanti così fra breve saremo capaci di metabolizzare
le cose più incredibili». Altro giudice contrarissimo al Lodo è Alessandro
Criscuolo. Ha preso la difesa e perorato la causa dell’ex pm di Catanzaro, Luigi
De Magistris, nel procedimento disciplinare al Csm: «Non ha mai arrestato
nessuno ingiustamente, De Magistris è stato molto attento alla gestione dei suoi
provvedimenti». Smentito. Quand’era presidente dell’Anm, alle accuse dei
radicali sulla (mala) gestione del caso Tortora, Criscuolo rispose prendendo le
parti dei magistrati, difese la sentenza di primo grado, ringraziò i pentiti per
il loro contributo (sic!). Nel ’97 entrò a gamba tesa in un altro processo,
quello per l’omicidio del commissario Calabresi, al grido di «meglio un
colpevole libero che un innocente dentro». E che dire del giudice Franco Gallo,
già ministro delle Finanze con Ciampi, nemico giurato del successore visto che
all’insediamento di Giulio Tremonti (scrive Il Fatto) rassegnò le dimissioni
dalla scuola centrale tributaria dopo esser uscito da un’inchiesta finita al
tribunale dei ministri, su presunti illeciti compiuti a favore del Coni per il
pagamento di canoni irrisori per alcuni immobili. Altro ministro-giudice di
Ciampi, rigorosamente no-Lodo, è il professor Sabino Cassese, gettonatissimo in
commissioni di studio e d’inchiesta, ai vertici di società importanti e di
banche. A proposito della sentenza del gip Clementina Forleo, che assolveva
cinque islamici accusati di terrorismo definendoli «guerriglieri», chiosò
dicendo che gli Stati Uniti avevano violato lo stato di diritto. Giuseppe
Tesauro, terza creatura di Ciampi alla Consulta, viene ricordato al vertice
dell’Antitrust per la sua battaglia contro la legge Gasparri («è una legge
contro la concorrenza», oppure, «il testo non è in odor di santità, la riforma
mescola coca-cola, whisky e acqua»). Di lui si parlò come candidato dell’Ulivo a
fine mandato 2005 e come «persecutore» di Gilberto Benetton e della sua Edizioni
Holding interessata ad acquistare la società Autogrill (l’inchiesta venne
archiviata). Considerato a sinistra da sempre anche Ugo De Siervo, almeno dal
’95 quando al convegno «Con la Costituzione non si scherza» parlò di
comportamenti «ispirati a dilettantismo e tatticismo, interpretazioni di stampo
plebiscitario, spregio della legalità costituzionale». A maggio 2001 è a fianco
dell’ex sottosegretario e senatore dei Ds Stefano Passigli, che annuncia un
esposto contro Berlusconi per la violazione dei limiti di spesa per la legge
elettorale.
Tanto
comandano loro: le toghe! Magistrati, raddoppiati gli incarichi extragiudiziari.
Le richieste per svolgere un secondo lavoro sono aumentate in 12 mesi del 100%.
Sono passate da 961 a 494. Un record. Consulenze e docenze le più appetibili,
scrive “Libero Quotidiano”. La doppia vita dei magistrati. Alle toghe di casa
nostra non bastano mai i soldi che incassano con il loro lavoro da magistrato.
Le toghe preferiscono la seconda attività. Negli ultimi sei mesi il totale degli
incarichi autorizzati dal Csm alle toghe ha toccato quota 961, quasi il doppio
dei 494 concessi nei sei mesi precedenti. Insomma il doppio lavoro e la doppia
busta paga servono per riempire le tasche. La doppia attività è
una tradizione dei nostri magistrati. E la tendenza è in
crescita. Si chiamano incarichi “extragiudiziari”, in
quanto relativi ad attività che non fanno riferimento alla professione
giudiziaria. Gli incarichi per le toghe arrivano dalle società, dagli enti di
consulenza e università private, come quella della Confindustria. I dati
sull'incremento degli incarichi extragiudiziari li fornisce il Csm. Tra novembre
2012 e maggio 2013 gli incarichi sono raddoppiati. A dare l'ok alla doppia
attività è proprio il Csm. Le toghe amano le cattedre e così vanno ad insegnare
alla Luiss, l’ateneo confindustriale diretto da Pier Luigi Celli. Poi ci sono le
consulenze legali per la Wolters Kluwer, multinazionale che si occupa di
editoria e formazione professionale. Ma non finisce qua. Qualche magistrato
lavora per la Altalex Consulting, altra società attiva nell’editoria e nella
formazione giuridica. Le paghe sono sostanziose. Ad esempio Giovanni Fanticini,
racconta Lanotiziagiornale.it, è giudice al tribunale di Reggio
Emilia. Ma ha 11 incarichi extragiudiziali. Tra docenze, seminari e lezioni
varie, è semplicemente impressionante: dalla Scuola superiore dell’economia e
delle finanze (controllata al ministero di via XX Settembre) ha avuto un
incarico di 7 ore con emolumento orario di 130 euro (totale 910 euro); dalla
società Altalex ha avuto sei collaborazioni: 15 ore per complessivi
2.500 euro, 7 ore per 1.300, 8 ore per 1.450, 15 ore per 2.500, 5 ore
per 750 e 5 ore per 700; dal Consorzio interuniversitario per l’aggiornamento
professionale in campo giuridico ha ottenuto due incarichi, complessivamente 8
ore da 100 euro l’una (totale 800 euro). Insomma un buon bottino. In
Confindustria poi c'è l'incarico assegnato a Domenico Carcano,
consigliere della Corte di cassazione, che per 45 ore di lezioni ed esami di
diritto penale ha ricevuto 6 mila euro. C’è Michela Petrini, magistrato
ordinario del tribunale di Roma, che ha incassato due docenze di diritto penale
dell’informatica per complessivi 4.390 euro. Ancora, Enrico Gallucci, magistrato
addetto all’Ufficio amministrazione della giustizia, ha ottenuto 5.500 euro per
36 ore di lezione di diritto penale. Il doppio incarico di certo non va molto
d'accordo con l'imparzialità della magistratura. Se le società dove lavorano
questi magistrati dovessero avere problemi giudiziari la magistratura e i
giudici quanto sarebbero equidistanti nell'amministrare giustizia? L'anomalia
degli incarichi extragiudiziari va eliminata.
“VADA A
BORDO, CAZZO!!”.
E’ celebre il
“vada a bordo, cazzo” del comandante De Falco. L’Italia paragonata al destino ed
agli eventi che hanno colpito la nave Concordia. Il naufragio della Costa
Concordia, è un sinistro marittimo "tipico" avvenuto venerdì 13 gennaio
2012 alle 21:42 alla nave da crociera al comando di Francesco Schettino e di
proprietà della compagnia di navigazione genovese Costa Crociere, parte del
gruppo anglo-americano Carnival Corporation & plc. All'1.46 di sabato mattina 14
gennaio il comandante della Concordia Francesco Schettino riceve l'ennesima
telefonata dalla Capitaneria di Porto. In linea c'è il comandante Gregorio Maria
De Falco. La chiamata è concitata e i toni si scaldano rapidamente.
De Falco:
«Sono De Falco da Livorno, parlo con il comandante?
Schettino:
«Sì, buonasera comandante De Falco»
De Falco: «Mi
dica il suo nome per favore»
Schettino:
«Sono il comandante Schettino, comandante»
De Falco:
«Schettino? Ascolti Schettino. Ci sono persone intrappolate a bordo. Adesso lei
va con la sua scialuppa sotto la prua della nave lato dritto. C'è una
biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo e
mi riporta quante persone ci sono. Le è chiaro? Io sto registrando questa
comunicazione comandante Schettino...».
Schettino:
«Comandante le dico una cosa...»
De Falco:
«Parli a voce alta. Metta la mano davanti al microfono e parli a voce più alta,
chiaro?».
Schettino: «In
questo momento la nave è inclinata...».
De Falco: «Ho
capito. Ascolti: c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei
quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante
persone e che cosa hanno a bordo. Chiaro? Mi dice se ci sono bambini, donne o
persone bisognose di assistenza. E mi dice il numero di ciascuna di queste
categorie. E' chiaro? Guardi Schettino che lei si è salvato forse dal mare ma io
la porto… veramente molto male… le faccio passare un’anima di guai. Vada a
bordo, cazzo!»
“TUTTI
DENTRO, CAZZO!!”
Parafrasando
la celebre frase di De Falco mi rivolgo a tutti gli italiani: ““TUTTI DENTRO
CAZZO!!”. Il tema è “chi giudica chi?”. Chi lo fa, ha veramente una padronanza
morale, culturale professionale per poterlo fare? Iniziamo con il parlare della
preparazione culturale e professionale di ognuno di noi, che ci permetterebbe,
in teoria, di superare ogni prova di maturità o di idoneità all’impiego
frapposta dagli esami scolastici o dagli esami statali di abilitazione o di un
concorso pubblico. In un paese in cui vigerebbe la meritocrazia tutto ciò ci
consentirebbe di occupare un posto di responsabilità. In Italia non è così. In
ogni ufficio di prestigio e di potere non vale la forza della legge, ma la legge
del più forte. Piccoli ducetti seduti in poltrona che gestiscono il loro piccolo
potere incuranti dei disservizi prodotti. La massa non è li ha pretendere
efficienza e dedizione al dovere, ma ad elemosinare il favore. Corruttori nati.
I politici non scardinano il sistema fondato da privilegi secolari. Essi
tacitano la massa con provvedimenti atti a quietarla.
Panem et
circenses,
letteralmente: "pane e giochi del circo", è una locuzione in lingua latina molto
conosciuta e spesso citata. Era usata nella Roma antica. Contrariamente a quanto
generalmente ritenuto, questa frase non è frutto della fantasia popolare, ma è
da attribuirsi al poeta latino Giovenale:
« ...duas tantum res anxius optat panem et circenses».
« ...[il
popolo] due sole cose ansiosamente desidera pane e i giochi circensi».
Questo poeta
fu un grande autore satirico: amava descrivere l'ambiente in cui viveva, in
un'epoca nella quale chi governava si assicurava il consenso popolare con
elargizioni economiche e con la concessione di svaghi a coloro che erano
governati (in questo caso le corse dei carri tirati da cavalli che si svolgevano
nei circhi come il Circo Massimo e il Circo di Massenzio).
Perché quel
“TUTTI DENTRO CAZZO!!”. Perché la legge dovrebbe valere per tutti. Non applicata
per i più ed interpretata per i pochi. E poi mai nessuno, in Italia, dovrebbe
permettersi di alzare il dito indice ed accusare qualcun altro della sua stessa
colpa. Prendiamo per esempio la cattiva abitudine di copiare per poter superare
una prova, in mancanza di una adeguata preparazione. Ognuno di noi almeno un
volta nella vita ha copiato. In principio era la vecchia “cartucciera” la fascia
di stoffa da stringere in vita con gli involtini a base di formule
trigonometriche, biografie del Manzoni e del Leopardi, storia della filosofia e
traduzioni di Cicerone. Poi il vocabolario farcito d'ogni foglio e foglietto,
giubbotti imbottiti di cultura bignami e addirittura scarpe con suola
manoscritta. Oggi i metodi per “aiutarsi” durante gli esami sono più
tecnologici: il telefonino, si sa, non si può portare, ma lo si porta lo stesso.
Al massimo, se c’è la verifica, lo metti sul tavolo della commissione. Quindi
non è malsana l'idea dell'iPhone sul banco, collegato a Wikipedia e pronto a
rispondere ad ogni quesito nozionistico. Comunque bisogna attrezzarsi, in
maniera assolutamente diversa. La rete e i negozi di cartolibreria vendono
qualsiasi accrocchio garantendo si tratti della migliore soluzione possibile per
copiare durante le prove scritte. C'è ad esempio la penna UV cioè a raggi
ultravioletti scrive con inchiostro bianco e si legge passandoci sopra un led
viola incluso nel corpo della penna. Inconveniente: difficile non far notare in
classe una luce da discoteca. Poi c'è la cosiddetta penna-foglietto: nel corpo
della stilo c'è un foglietto avvolto sul quale si è scritto precedentemente
formule, appunti eccetera. Foglietto che in men che non si dica si srotola e
arrotola. Anche in questo caso l'inconveniente è che se ti sorprendono sono
guai. E infine, c'è l'ormai celebre orologio-biglietto col display elettronico
e una porta Usb sulla quale caricare testi d'ogni tipo. Pure quello difficile
da gestire: solo gli artisti della copia copiarella possono.
Il consiglio è
quello di studiare e non affidarsi a trucchi e trucchetti. Si rischia grosso e
non tutti lo sanno. Anche perché il copiare lo si fa passare per peccato
veniale. Copiare ad esami e concorsi, invece, potrebbe far andare in galera. E'
quanto stabilito dalla legge n. 475/1925 e dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 32368/10. La legge recita all'art.1 :“Chiunque in esami o
concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il
conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico,
per l’abilitazione all’insegnamento ed all’esercizio di una professione, per il
rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi,
pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non
può essere inferiore a sei mesi qualora l’intento sia conseguito”. A conferma
della legge è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n.32368/10, che
ha condannato una candidata per aver copiato interamente una sentenza del TAR in
un elaborato a sua firma presentato durante un concorso pubblico. La sentenza
della sezione VI penale n. 32368/10 afferma: “Risulta pertanto ineccepibile la
valutazione dei giudici di merito secondo cui la (…) nel corso della prova
scritta effettuò, pur senza essere in quel frangente scoperta, una pedissequa
copiatura del testo della sentenza trasmessole (…). Consegue che il reato è
integrato anche qualora il candidato faccia riferimento a opere intellettuali,
tra cui la produzione giurisprudenziale, di cui citi la fonte, ove la
rappresentazione del suo contenuto sia non il prodotto di uno sforzo mnemonico e
di autonoma elaborazione logica ma il risultato di una materiale riproduzione
operata mediante l’utilizzazione di un qualsiasi supporto abusivamente impiegato
nel corso della prova”.
In particolare
per gli avvocati la Riforma Forense, legge 247/2012, al CAPO II (ESAME DI STATO
PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO) Art. 46. (Esame
di Stato) stabilisce che “….10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad
uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema
proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena
della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel
comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del
distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per
i provvedimenti di sua competenza.”
Ma, di fatto,
quello previsto come reato è quello che succede da quando esiste questo tipo di
esame e vale anche per i notai ed i magistrati. Eppure, come ogni altra cosa
italiana c’è sempre l’escamotage tutto italiano. Una sentenza del Consiglio
di Stato stabilisce che copiare non è reato: niente più punizione. Dichiarando
tuttavia “legale” copiare a scuola, si dichiara pure legale copiare nella vita.
Non viene sanzionato un comportamento che è senza dubbio scorretto. Secondo
il Consiglio di Stato, il superamento dell’esame costituisce di per sè
attestazione delle “competenze, conoscenze e capacità anche professionali
acquisite” dall'alunna e la norma che regola l'espulsione dei candidati dai
pubblici concorsi per condotta fraudolenta, non può prescindere "dal contesto
valutativo dell’intera personalità e del percorso scolastico dello studente,
secondo i principi che regolano il cosiddetto esame di maturità": le competenze
e le conoscenze acquisite….in relazione agli obiettivi generali e specifici
propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle
capacità critiche del candidato. A ciò il Cds ha anche aggiunto un'attenuante,
cioè "uno stato d’ansia probabilmente riconducibile anche a problemi di salute"
della studentessa stessa, che sarebbe stato alla base del gesto. Il 12 settembre
2012 una sentenza del Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar della
Campania che aveva escluso dagli esami di maturità una ragazza sorpresa a
copiare da un telefono palmare. Per il Consiglio di Stato la decisione del Tar
non avrebbe adeguatamente tenuto conto né del “brillante curriculum scolastico”
della ragazza in questione, né di un suo “stato di ansia”. Gli esami, nel
frattempo, la giovane li aveva sostenuti seppur con riserva. L’esclusione della
ragazza dagli esami sarà forse stata una sanzione eccessiva. Probabilmente la
giovane in questione, sulla base del suo curriculum poteva esser perdonata. Gli
insegnanti, conoscendola e comprendendo il suo stato d’ansia pre-esame,
avrebbero potuto chiudere un occhio. Tutto vero. Ma sono valutazioni che
spettavano agli insegnanti che la studente conoscono. Una sentenza del Consiglio
di Stato stabilisce invece, di fatto, un principio. E in questo caso il
principio è che copiare vale. Non è probabilmente elegante, ma comunque va bene.
Questo principio applicato alla scuola, luogo in cui le generazioni future si
forgiano ed educano, avrà ripercussioni sulla società del futuro. Se ci viene
insegnato che a non rispettar le regole, in fondo, non si rischia nulla più che
una lavata di capo, come ci porremo di fronte alle regole della società una
volta adulti? Ovviamente male. La scuola non è solo il luogo dove si insegnano
matematica e italiano, storia e geografia. Ma è anche il luogo dove dovrebbe
essere impartito insegnamento di civica educazione, dove si impara a vivere
insieme, dove si impara il rispetto reciproco e quello delle regole. Dove si
impara a “vivere”. Se dalla scuola, dalla base, insegniamo che la “furbizia” va
bene, non stupiamoci poi se chi ci amministra si compra il Suv con i soldi delle
nostre tasse. In fondo anche lui avrà avuto il suo “stato d’ansia”. Ma il punto
più importante non è tanto la vicenda della ragazza sorpresa a copiare e di come
sia andata la sua maturità. Il punto è la sanzionabilità o meno di un
comportamento che è senza dubbio scorretto. In un paese già devastato dalla
carenza di etica pubblica, dalla corruzione e dall’indulgenza programmatica di
molte vulgate pedagogiche ammantate di moderno approccio relazionale, ci mancava
anche la corrività del Consiglio di Stato verso chi imbroglia agli esami.
E, comunque,
vallo a dire ai Consiglieri di Stato, che dovrebbero già saperlo, che
nell’ordinamento giuridico nazionale esiste la gerarchia della legge.
Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione;
queste sono disposte secondo una scala gerarchica, per cui la norma di fonte
inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore (gerarchia
delle fonti). nel caso in cui avvenga un contrasto del genere si dichiara
l'invalidità della fonte inferiore dopo un accertamento giudiziario, finché non
vi è accertamento si può applicare la "fonte invalida". Al primo livello della
gerarchia delle fonti si pongono la Costituzione e le leggi costituzionali
(fonti superprimarie). La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in
vigore il 1º gennaio 1948, è composta da 139 articoli: essa detta i principi
fondamentali dell'ordinamento (artt. 1-12); individua i diritti e i doveri
fondamentali dei soggetti (artt. 13-54); detta la disciplina dell'organizzazione
della Repubblica (artt. 55-139). La Costituzione italiana viene anche definita
lunga e rigida, lunga perché non si limita "a disciplinare le regole generali
dell'esercizio del potere pubblico e delle produzioni delle leggi" riguardando
anche altre materie, rigida in quanto per modificare la Costituzione è richiesto
un iter cosiddetto aggravato (vedi art. 138 cost.). Esistono inoltre dei
limiti alla revisione costituzionale. Al di sotto delle leggi costituzionali si
pongono i trattati internazionali e gli atti normativi comunitari, che possono
presentarsi sotto forma di regolamenti o direttive. I primi hanno efficacia
immediata, le seconde devono essere attuate da ogni paese facente parte
dell'Unione europea in un determinato arco di tempo. A queste, si sono aggiunte
poi le sentenze della Corte di Giustizia Europea "dichiarative" del Diritto
Comunitario (Corte Cost. Sent. n. 170/1984). Seguono le fonti primarie, ovvero
le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti
legislativi), ma anche le leggi regionali e delle provincie autonome di Trento e
Bolzano. Le leggi ordinarie sono emanate dal Parlamento, secondo la procedura di
cui gli artt. 70 ss. Cost., le cui fasi essenziali sono così articolate:
l'iniziativa di legge; l'approvazione del testo di legge è affidata alle due
Camere del Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica); la
promulgazione del Presidente della Repubblica; la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. Al di sotto delle fonti primarie, si collocano i regolamenti
governativi, seguono i regolamenti ministeriali e di altri enti pubblici e
all'ultimo livello della scala gerarchica, si pone la consuetudine, prodotta
dalla ripetizione costante nel tempo di una determinata condotta. Sono ammesse
ovviamente solo consuetudini secundum legem e praeter legem non
dunque quelle contra legem.
Pare che
molte consuetudini sono contra legem e pervengono proprio da coloro che
dovrebbero dettare i giusti principi.
Tutti in
pensione da "presidente emerito". I giudici della Corte Costituzionale si danno
una mano tra loro per dare una spinta in più alla remunerazione pensionistica a
fine carriera. Gli ermellini in pratica a rotazione, anche breve, cambiano il
presidente della Corte per regalargli il titolo più prestigioso prima che giunga
il tramonto professionale. Nulla di strano se non fosse che il quinto comma
dell'articolo 135 della Costituzione recita: "La Corte elegge tra i suoi
componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in
carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di
scadenza dall’ufficio di giudice". Dunque secondo Costituzione il presidente
dovrebbe cambiare ogni 3 anni, o quanto meno rieletto anche per un secondo
mandato dopo 36 mesi. Le cose invece vanno in maniera completamente diversa. La
poltrona da presidente con relativa pensione fa gola a tanti e allora bisogna
accontentare tutti. Così dagli Anni Ottanta la norma è stata aggirata per un
tornaconto personale, scrive “Libero Quotidiano”. Per consentire al maggior
numero di membri di andare in pensione col titolo da presidente emerito, e fino
al 2011 con tanto di auto blu a vita, si è deciso che il prescelto debba essere
quello con il maggior numero di anni di servizio. Il principio di anzianità.
Questo passaggio di consegne oltre a garantire una pensione più sostanziosa
rispetto a quella di un semplice giudice costituzionale, offre anche
un’indennità aggiuntiva in busta paga: "I giudici della Corte costituzionale
hanno tutti ugualmente una retribuzione corrispondente al complessivo
trattamento economico che viene percepito dal magistrato della giurisdizione
ordinaria investito delle più alte funzioni. Al Presidente è inoltre attribuita
una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione", recita la
legge 87/1953. Successivamente, il legislatore è intervenuto con legge 27
dicembre 2002, n. 289, sostituendo il primo periodo dell'originario art. 12,
comma 1, della legge 87/1953 nei seguenti termini: "I giudici della Corte
costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al più
elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della
giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni, aumentato della
metà". Resta ferma l'attribuzione dell'indennità di rappresentanza per il
Presidente. Quella era intoccabile. Così ad esempio accade che Giovanni Maria
Flick è stato presidente per soli 3 mesi, dal 14 novembre 2008 al 18 febbraio
2009. Flick si difese dicendo che quella "era ormai una prassi consolidata".
Già, consolidata in barba alla Carta Costituzionale che loro per primi
dovrebbero rispettare. Gustavo Zagerblesky ad esempio è stato presidente per
soli 7 mesi. Poi è stato il turno di Valerio Onida, presidente per 4 mesi dal 22
settembre 2004 al 30 maggio 2005. Ugo De Servio invece ha tenuto la poltrona dal
10 dicembre 2010 al 29 aprile 2011, 4 mesi anche per lui. Recordman invece
Alfonso Quaranta che è stato in carica per un anno e sette mesi, dal 6 giugno
2011 al 27 gennaio 2012. Ora la corsa alla poltrona è per l'attuale presidente
Franco Gallo, in carica dal gennaio 2013. Durerà fin dopo l'estate?
Probabilmente no.
“TUTTI
DENTRO, CAZZO!!”
Per esempio
nei processi, anche i testimoni della difesa.
Tornando alla
parafrasi del “TUTTI DENTRO, CAZZO!!” si deve rimarcare una cosa. Gli italiani
sono: “Un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di
scienziati, di navigatori, di trasmigatori”. Così è scritto sul Palazzo della
Civiltà Italiana dell’EUR a Roma. Manca: “d’ingenui”. Ingenui al tempo di
Mussolini, gli italiani, ingenui ancora oggi. Ma no, un popolo d’ingenui non va
bene. Sul Palazzo della Civiltà aggiungerei: “Un popolo d’allocchi”, anzi “Un
popolo di Coglioni”. Perché siamo anche un popolo che quando non sa un “cazzo”
di quello che dice, parla. E parla sempre. Parla..…parla. Specialmente sulle
cose di Giustizia: siamo tutti legulei.
Chi frequenta
bene le aule dei Tribunali, non essendo né coglione, né in mala fede, sa molto
bene che le sentenze sono già scritte prima che inizi il dibattimento. Le
pronunce sono pedisseque alle richieste dell’accusa, se non di più. Anche perché
se il soggetto è intoccabile l’archiviazione delle accuse è già avvenuta nelle
fasi successive alla denuncia o alla querela: “non vi sono prove per sostenere
l’accusa” o “il responsabile è ignoto”. Queste le motivazioni in calce alla
richiesta accolta dal GIP, nonostante si conosca il responsabile o vi siano un
mare di prove, ovvero le indagini non siano mai state effettuate. La difesa: un
soprammobile ben pagato succube dei magistrati. Il meglio che possono fare è
usare la furbizia per incidere sulla prescrizione. Le prove a discarico: un
perditempo, spesso dannoso. Non è improbabile che i testimoni della difesa siano
tacciati di falso.
Nel formulare
la richiesta la Boccassini nel processo Ruby ha fatto una gaffe dicendo: "Lo
condanno", per poi correggersi: "Chiedo la condanna" riferita a Berlusconi.
Esemplare
anche è il caso di Napoli. Il gip copia o si limita a riassumere le tesi
accusatorie della Procura di Napoli e per questo il tribunale del riesame del
capoluogo campano annulla l'arresto di Gaetano Riina, fratello del boss di Cosa
nostra, Totò, avvenuto il 14 novembre 2011. L'accusa era di concorso esterno in
associazione camorristica. Il gip, scrive il Giornale
di Sicilia, si sarebbe limitato a riassumere la richiesta di
arresto della Procura di Napoli, incappando peraltro in una serie di errori e
non sostituendo nella sua ordinanza neanche le parole «questo pm» con «questo
gip».
Il paradosso, però, sono le profezie cinematografiche adattate ai
processi:
«... e lo
condanna ad anni sette di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici
uffici, e all'interdizione legale per la durata della pena». Non è una frase
registrata Lunedì 24 giugno 2013 al Tribunale di Milano, ma una battuta presa
dagli ultimi minuti del film «Il caimano» di Nanni Moretti. La condanna inflitta
al protagonista (interpretato dallo stesso regista) è incredibilmente identica a
quella decisa dai giudici milanesi per Silvio Berlusconi. Il Caimano Moretti,
dopo la sentenza, parla di «casta dei magistrati» che «vuole avere il potere di
decidere al posto degli elettori».
Sul degrado
morale dell’Italia berlusconiana (e in generale di tutti quelli che hanno votato
Berlusconi nonostante sia, per dirla con Gad Lerner, un “puttaniere”) è stato
detto di tutto, di più. Ma poco, anzi meno, è stato detto a mio parere sul
degrado moralista della sinistra anti-berlusconiana (e in generale di molti che
hanno votato “contro” il Cavaliere e che hanno brindato a champagne, festeggiato
a casa o in ufficio, tirato un sospiro di sollievo come al risveglio da un
incubo di vent’anni). Quella sinistra che, zerbino dei magistrati, ha messo il
potere del popolo nelle mani di un ordine professionale, il cui profilo
psico-fisico-attitudinale dei suoi membri non è mai valutato e la loro idoneità
professionale incute dei dubbi.
Condanna a
sette anni di carcere per concussione per costrizione (e non semplice induzione
indebita) e prostituzione minorile, con interdizione perpetua dai pubblici
uffici per Silvio Berlusconi: il processo Ruby
a Milano finisce come tutti, Cavaliere in testa, avevano pronosticato. Dopo una
camera di consiglio-fiume iniziata alle 10 di mattina e conclusa sette ore
abbondanti dopo, le tre giudici della quarta sezione penale Giulia Turri,
Orsola De Cristofaro e Carmen D'Elia hanno
accolto in pieno, e anzi aumentato, le richieste di 6 anni dell'accusa,
rappresentata dai pm Ilda Boccassini (in ferie e quindi non in
aula, sostituita dal procuratore capo di Milano Edmondo Bruti Liberati,
fatto mai avvenuto quello che il procuratore capo presenzi in dibattimento)
e Antonio Sangermano. I giudici hanno anche trasmesso alla
Procura, per le opportune valutazioni, gli atti relativi alla testimonianza, tra
gli altri, di Giorgia Iafrate, la poliziotta che affidò Ruby a
Nicole Minetti. Inoltre, sono stati trasmessi anche i verbali
relativi alle deposizioni di diverse olgettine, di Mariano
Apicella e di Valentino Valentini. Il tribunale di
Milano ha disposto anche la confisca dei beni sequestrati a Ruby,
Karima El Mahroug e al compagno Luca Risso, ai sensi dell'articolo 240
del codice penale, secondo cui il giudice "può ordinare la confisca delle cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono
il prodotto o il profitto".
I paradossi
irrisolti della sentenza sono che colpiscono anche la “vittima” Ruby e non solo
il “carnefice” Berlusconi. L’ex minorenne, Karima El Mahroug, «per un astratta
tutela della condizione di minorenne», viene dichiarata prima “prostituta” e poi
i suoi beni le vengono confiscati: «Come nel caso del concusso, la parte lesa
non si dichiara tale anzi si manifesta lesa per l’azione dei magistrati».
Ruby «è doppiamente lesa dai magistrati», spiega Sgarbi, «nella reputazione e
nel vedersi sottrarre, in via cautelativa, i denari che Berlusconi le ha dato».
«Non
chiamiamola sentenza. Non chiamiamolo processo. Soprattutto, non chiamiamola
giustizia». Comincia così, con queste amarissime parole, la nota di Marina
Berlusconi in difesa di suo padre. «Quello cui abbiamo dovuto assistere è uno
spettacolo assurdo che con la giustizia nulla ha a che vedere, uno spettacolo
che la giustizia non si merita. La condanna - scrive Marina - era scritta fin
dall'inizio, nel copione messo in scena dalla Procura di Milano. Mio padre non
poteva non essere condannato. Ma se possibile il Tribunale è andato ancora più
in là, superando le richieste dell'accusa e additando come spergiuri tutti i
testi in contrasto con il suo teorema». Nonostante la "paccata" di testimoni
portati in tribunale dalla difesa di Silvio Berlusconi, il presidente della
Corte Giulia Turri e i giudici Orsolina De Cristofano e Carmen D'Elia hanno
preferito inseguire il teorema costruito ad arte dal pm Ilda Boccassini e
tacciare di falsa testimonianza tutte le persone che, con le proprie parole,
hanno scagionato il Cavaliere. Insomma, se la "verità" non coincide con quella
professata dalla magistratura milanese, allora diventa automaticamente bugia.
Non importa che non ci sia alcuna prova a dimostrarlo.
L'accusa dei
giudici milanesi è sin troppo chiara, spiega Andrea Indini su "Il Giornale": le
trentadue persone che si sono alternate sul banco dei testimoni per rendere
dichiarazioni favorevoli a Berlusconi hanno detto il falso. Solo le motivazioni,
previste tra novanta giorni, potranno chiarire le ragioni per cui il collegio
abbia deciso di trasmettere alla procura i verbali di testimoni che vanno
dall’amico storico dell’ex premier Mariano Apicella all’ex massaggiatore del
Milan Giorgio Puricelli, dall’europarlamentare Licia Ronzulli alla deputata
Maria Rosaria Rossi. Da questo invio di atti potrebbe nascere, a breve, un maxi
procedimento per falsa testimonianza. A finir nei guai per essersi opposta al
teorema della Boccassini c'è anche il commissario Giorgia Iafrate che era in
servizio in Questura la notte del rilascio di Ruby. La funzionaria aveva,
infatti, assicurato di aver agito "nell’ambito dei miei poteri di pubblico
ufficiale". "Di fronte alla scelta se lasciare la ragazza in Questura in
condizioni non sicure o affidarla ad un consigliere regionale - aveva spiegato -
ho ritenuto di seguire quest’ultima possibilità". Proprio la Boccassini, però,
nella requisitoria aveva definito "avvilenti le dichiarazioni della Iafrate che
afferma che il pm minorile Fiorillo le aveva dato il suo consenso". Alla procura
finiscono poi i verbali di una ventina di ragazze. Si va da Barbara Faggioli a
Ioana Visan, da Lisa Barizonte alle gemelle De Vivo, fino a Roberta Bonasia.
Davanti ai giudici avevano descritto le serate di Arcore come "cene eleganti",
con qualche travestimento sexy al massimo, e avevano sostenuto che Ruby si era
presentata come una 24enne. "I giudici hanno dato per scontato che siamo sul
libro paga di Berlusconi - ha tuonato Giovanna Rigato, ex del Grande Fratello
- io tra l’altro al residence non ho mai abitato, sono una che ha sempre
lavorato, l’ho detto in mille modi che in quelle serata ad Arcore non ho mai
visto nulla di scabroso ma tanto...". Anche Marysthelle Polanco è scioccata
dalla sentenza: "Non mi hanno creduto, non ci hanno creduto, io ho detto la
verità e se mi chiamano di nuovo ripeterò quello che ho sempre raccontato".
Sebbene si siano lasciate scivolare addosso insulti ben più pesanti, le ragazze
che hanno partecipato alle feste di Arcore non sono disposte ad accettare l’idea
di passare per false e bugiarde. Da Puricelli a Rossella, fino al pianista
Mariani e ad Apicella, è stato tratteggiato in Aula un quadro di feste fatto di
chiacchiere, balli e nessun toccamento.
Nel tritacarne
giudiziario finisce anche la Ronzulli, "rea" di aver fornito una versione
diversa da quella resa da Ambra e Chiara nel processo "gemello" e di aver negato
di aver visto una simulazione di sesso orale con l’ormai famosa statuetta di
Priapo. Stesso destino anche per l’ex consigliere per le relazioni
internazionali Valentino Valentini che aveva svelato di esser stato lui a far
contattare la Questura di Milano per "capire cosa stesse accadendo". Ed era
stato sempre lui a parlare di una conversazione tra Berlusconi e l'ex raìs Hosni
Mubarak sulla parentela con Ruby. Anche il viceministro Bruno Archi, all’epoca
diplomatico, ai giudici aveva descritto quel pranzo istituzionale nel quale si
sarebbe parlato di Karima. E ancora: sono stati trasmessi ai pm anche i verbali
di Giuseppe Estorelli, il capo scorta di Berlusconi, e del cameriere di Arcore
Lorenzo Brunamonti, "reo" di aver regalato al Cavaliere, di ritorno da un
viaggio, la statuetta di Priapo. Tutti bugiardi, tutti nella tritarcarne del
tribunale milanese. La loro colpa? Aver detto la verità. Una verità che non
piace ai giudici che volevano far fuori a tutti i costi Berlusconi.
C'era un solo
modo per condannare Silvio Berlusconi nel processo cosiddetto Ruby, spiega
Alessandro Sallusti su "Il Giornale": fare valere il teorema della Boccassini
senza tenere conto delle risultanze processuali, in pratica cancellare le decine
e decine di testimonianze che hanno affermato, in due anni di udienze, una
verità assolutamente incompatibile con le accuse. E cioè che nelle notti di
Arcore non ci furono né vittime né carnefici, così come in Questura non ci
furono concussi. Questo trucco era l'unica possibilità e questo è accaduto.
Trenta testimoni e protagonisti della vicenda, tra i quali rispettabili
parlamentari, dirigenti di questura e amici di famiglia sono stati incolpati in
sentenza, cosa senza precedenti, di falsa testimonianza e dovranno risponderne
in nuovi processi. Spazzate via in questo modo le prove non solo a difesa di
Berlusconi ma soprattutto contrarie al teorema Boccassini, ecco spianata la
strada alla condanna esemplare per il capo: sette anni più l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici, esattamente la stessa pronunciata nella scena
finale del film Il Caimano di Nanni Moretti, in cui si immagina l'uscita di
scena di Berlusconi. Tra questa giustizia e la finzione non c'è confine. Siamo
oltre l'accanimento, la sentenza è macelleria giudiziaria, sia per il metodo sia
per l'entità. Ricorda molto, ma davvero molto, quelle che i tribunali stalinisti
e nazisti usavano per fare fuori gli oppositori: i testimoni che osavano alzare
un dito in difesa del disgraziato imputato di turno venivano spazzati via come
vermi, bollati come complici e mentitori, andavano puniti e rieducati. Come osi,
traditore - sostenevano i giudici gerarchi - mettere in dubbio la parola dello
Stato padrone? Occhio, che in galera sbatto pure te. Così, dopo Berlusconi,
tocca ai berlusconiani passare sotto il giogo di questi pazzi scatenati
travestiti da giudici. I quali vogliono che tutti pieghino la testa di fronte
alla loro arroganza e impunità. In trenta andranno a processo per aver
testimoniato la verità, raccontato ciò che hanno visto e sentito. Addio Stato di
diritto, addio a una nobile tradizione giuridica, la nostra, in base alla quale
il giudizio della corte si formava esclusivamente sulle verità processuali, che
se acquisite sotto giuramento e salvo prova contraria erano considerate sacre.
Omicidi,
tentati omicidi, sequestro di persona, occultamenti di cadavere.
Per la giustizia italiana questi reati non sono poi così diversi da quello di
concussione, scrive Nadia Francalacci su "Panorama". La condanna inflitta a
Silvio Berlusconi a 7 anni di carcere, uno in più rispetto alla pena chiesta dai
pubblici ministeri, e interdizione perpetua dai pubblici uffici per i reati di
prostituzione minorile e concussione, non differisce che di poche settimane da
quella inflitta a Michele Misseri il contadino di Avetrana che ha occultato il
cadavere della nipotina Sara Scazzi in un pozzo delle campagne pugliesi. Non
solo. La condanna all’ex premier è addirittura ancor più pesante rispetto
a quella inflitta a due studenti di Giurisprudenza, Scattone e Ferraro, che “ quasi
per gioco” hanno mirato alla testa di una studentessa, Marta Russo,
uccidendola nel cortile interno della facoltà. Quasi per gioco. Così in pochi
istanti hanno ucciso, tolto la vita, ad una ragazza che aveva tanti sogni da
realizzare. Marta Russo così come Sara Scazzi oppure un Gabriele Sandri, il
tifoso laziale ucciso nell’area di servizio dopo dei tafferugli con i tifosi
juventini. Il poliziotto che ha premuto il grilletto colpendolo alla nuca, è
stato condannato a 9 anni e 4 mesi. A soli 28
mesi in più di carcere rispetto a Silvio Berlusconi.
Analizzando
casi noti e quelli meno conosciuti dall’opinione pubblica, non è possibile non
notare una “sproporzione” di condanna tra il caso Ruby e una vicenda
quale il caso Scazzi o Russo. Ecco alcuni dei casi e delle sentenze di condanna.
Caso Sandri: 9
anni e 4 mesi. Per la Cassazione è omicidio volontario. Per l'agente della
Polstrada Luigi Spaccarotella, la sentenza è diventata definitiva con la
pronuncia della Cassazione. La condanna è di nove anni e quattro mesi di
reclusione per aver ucciso il tifoso della Lazio Gabriele Sandri dopo un
tafferuglio con tifosi juventini nell'area di servizio aretina di Badia al Pino
sulla A1. Sandri era sulla Renault che doveva portarlo a Milano, la mattina
dell'11 novembre 2007, per vedere Inter-Lazio insieme ad altri quattro amici.
Spaccarotella era stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione per
omicidio colposo, determinato da colpa cosciente. In secondo grado i fatti erano
stati qualificati come omicidio volontario per dolo eventuale e la pena era
stata elevata a nove anni e quattro mesi di reclusione.
Caso Scazzi:
per Michele Misseri, 8 anni. Ergastolo per Sabrina. Ergastolo per sua madre
Cosima Serrano. Otto anni per Michele Misseri, che ora rischia anche un
procedimento per autocalunnia. Questo è il verdetto di primo grado sulla
tragedia di Avetrana. il contadino è accusato di soppressione di cadavere
insieme al fratello e al nipote.
Caso Marta
Russo. L’omicidio quasi per gioco di Marta Russo è stato punito con la condanna
di Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, rispettivamente puniti con 5 anni e
quattro mesi il primo e 4 anni e due mesi il secondo; Marta Russo, 22 anni,
studentessa di giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma, fu uccisa
all'interno della Città universitaria il 9 maggio 1997, da un colpo di pistola
alla testa.
Caso Jucker.
Ruggero Jucker, reo di aver assassinato la propria fidanzata sotto l’effetto di
stupefacenti, è stato condannato, con un patteggiamento in appello a 16 anni di
reclusione salvo poi essere stato liberato dopo 10 anni.
Casi minori
e meno conosciuti dall’opinione pubblica.
Bari. 8 anni
di carcere ad un politico che uccise un rapinatore. 5 giugno 2013. La Corte
d’appello di Bari, ha chiesto la condanna a otto anni di reclusione per Enrico
Balducci, l’ex consigliere regionale pugliese, gestore del distributore di
carburante di Palo del Colle, accusato di omicidio volontario e lesioni
personali, per aver ucciso il 23enne Giacomo Buonamico e ferito il 25enne Donato
Cassano durante un tentativo di rapina subito il 5 giugno 2010. In primo grado,
Balducci era stato condannato con rito abbreviato alla pena di 10 anni di
reclusione. Dinanzi ai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Bari l’accusa
ha chiesto una riduzione di pena ritenendo sussistente l’attenuante della
provocazione, così come era stato chiesto anche dal pm in primo grado ma non era
stato riconosciuto dal gup. Chiesta una condanna a quattro anni di reclusione
per Cassano (condannato in primo grado a 5 anni) per i reati di rapina e
tentativo di rapina. Prima di recarsi in moto al distributore di carburante
gestito da Balducci, infatti, i due avrebbero compiuto un’altra rapina al vicino
supermercato. Balducci, questa la ricostruzione dell’accusa, vedendosi
minacciato, non sarebbe riuscito a controllare la sua ira, e consapevole di
poter uccidere, avrebbe fatto fuoco ferendo Cassano e uccidendo Buonamico.
Sequestro
Spinelli (ragioniere di Berlusconi): 8 anni e 8 mesi di carcere al capobanda
Leone. Condannati anche i tre complici albanesi. Ma le pene sono state
dimezzate rispetto alle richieste dell'accusa. Il pm Paolo Storari ha chiesto la
condanna a 16 anni di carcere per Francesco Leone, ritenuto il capo banda, e
pene tra gli 8 e i 10 anni per gli altri tre imputati. I quattro furono
arrestati nel novembre dell'anno scorso assieme ad altri due italiani, Pier
Luigi Tranquilli e Alessandro Maier, per i quali invece è stata chiesta
l'archiviazione. Il gup di Milano Chiara Valori ha condannato con il rito
abbreviato a 8 anni e 8 mesi Francesco Leone, riqualificando il reato in
sequestro semplice. Sono arrivate due condanne a 4 anni e 8 mesi, e una a 6 anni
e 8 mesi, per gli altri tre imputati. La vicenda è quella del sequestro lampo di
Giuseppe Spinelli e della moglie.
Pesaro.
Picchiò e gettò la ex dal cavalcavia: condannato a 10 anni di carcere. Il 22
giugno scorso, Saimo Luchetti è stato condannato ieri a 10 anni di reclusione
per sequestro di persona, stalking, violenza privata e tentato omicidio. Dovrà
versare anche una provvisionale immediata di 60mila euro per la ragazza, 40mila
per la madre e 15 per la sorella. Luchetti, 23 anni, calciatore dilettante, la
notte del 18 marzo 2012 aveva malmenato e rapito sotto casa l’ex fidanzata
Andrea Toccaceli di 18 anni, gettandola poi da un viadotto di Fossombrone alto
15 metri. Lui si gettò giù subito dopo. Sono sopravvissuti entrambi,
ristabilendosi completamente. Luchetti è in carcere ad Ancona e dove dovrà
rimanerci altri nove anni.
Caso Mancuso:
condannato per tentato omicidio a 5 anni di carcere. Il diciannovenne Luigi
Mancuso è stato condannato a 5 anni di reclusione per il tentato omicidio di Ion
Sorin Sheau, un cittadino romeno aggredito e abbandonato in strada a San
Gregorio d'Ippona. Assieme a Mancuso, figlio di Giuseppe Manuso, boss della
'ndrangheta, è stato condannato anche Danilo Pannace, 18 anni, che dovrà
scontare la pena di 4 anni e 8 mesi sempre per tentato omicidio. I due imputati,
giudicati col rito abbreviato, sono stati ritenuti responsabili del tentato
omicidio del romeno Ion Sorin Sheau, aggredito e lasciato in strada con il
cranio sfondato ed in un lago di sangue il 10 agosto del 2011 a San Gregorio
d’Ippona, in provincia di Vibo. Mancuso è stato ritenuto responsabile anche del
reato di atti persecutori nei confronti della comunità romena di San Gregorio.
All’estero. In
Argentina l’ex-presidente Carlos Menem è stato condannato a 8 anni di
carcere per traffico d'armi internazionale. Sono otto gli anni di carcere
che l’ex presidente, ora senatore al parlamento di Buenos Aires, dovrà scontare
insieme a Óscar Camilión, ministro della difesa durante il suo governo, con
l’accusa di contrabbando aggravato d’armi a Croazia ed Ecuador. Tra il 1991 e il
1995, l’Argentina esportò 6.500 tonnellate di armamenti destinati ufficialmente
a Panama e Venezuela. Questi raggiunsero però la Croazia nel pieno del conflitto
jugoslavo, e l’Ecuador che nel ‘95, combatteva con il Perú.
Parlare, però,
di Berlusconi è come sminuire il problema. I Pasdaran della forca a buon mercato
storcerebbero il naso: Bene, parliamo d’altro.
«In questo
processo chiunque ha detto cose in contrasto con la tesi accusatoria è stato
tacciato di falso, mentre ben altri testi non hanno detto la verità e sono
passati per super testimoni» ha detto Franco De Jaco difensore di Cosima
Serrano. E’ così è stato, perché sotto processo non c’è solo Sabrina Misseri,
Michele Misseri, Cosima Serrano Misseri, Carmine Misseri, Cosimo Cosma, Giuseppe
Nigro, Cosima Prudenzano Antonio Colazzo, Vito Junior Russo, ma c’è tutta
Avetrana e tutti coloro che non si conformano alla verità mediatica-giudiziaria.
Ed ancora Morrone fu arrestato mezz’ora dopo la mattanza, il 30 gennaio ’91. Sul
terreno c’erano i corpi di due giovani e le forze dell’ordine di Taranto
cercavano un colpevole a tutti i costi. La madre di una delle vittime indirizzò
i sospetti su di lui. Lo presero e lo condannarono. Le persone che lo
scagionavano furono anche loro condannate per falsa testimonianza. Così funziona
a Taranto. Vai contro la tesi accusatoria; tutti condannati per falsa
testimonianza. Nel ’96 alcuni pentiti svelarono la vera trama del massacro: i
due ragazzi erano stati eliminati perché avevano osato scippare la madre di un
boss. Morrone non c’entrava, ma ci sono voluti altri dieci anni per ottenere
giustizia. E ora arriva anche l’indennizzo per le sofferenze subite: «Avevo 26
anni quando mi ammanettarono - racconta lui - adesso è difficile ricominciare.
Ma sono soddisfatto perché lo Stato ha capito le mie sofferenze, le umiliazioni
subite, tutto quello che ho passato». Un procedimento controverso: due volte la
Cassazione annullò la sentenza di condanna della corte d’Assise d’Appello, ma
alla fine Morrone fu schiacciato da una pena definitiva a 21 anni. Non solo:
beffa nella beffa, fu anche processato e condannato a 1 anno e 8 mesi per
calunnia. La sua colpa? Se l’era presa con i magistrati che avevano trascurato i
verbali dei pentiti.
Taranto,
Milano, l’Italia.
“Egregi
signori, forse qualcuno di voi, componente delle più disparate commissioni di
esame di avvocato di tutta Italia, da Lecce a Bari, da Venezia a Torino, da
Palermo a Messina o Catania, pensa di intimorirmi con la forza di intimidazione
del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne
deriva per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
Sicuramente il più influente tra di voi, bocciandomi o (per costrizione e non
per induzione) facendomi bocciare annualmente senza scrupoli all’esame di
avvocato dal lontano 1998, (da quando ho promosso interrogazioni parlamentari e
inoltrato denunce penali, che hanno ottenuto dei risultati eclatanti, come
l’esclusione dei consiglieri dell’ordine degli avvocati dalle commissioni
d’esame e ciononostante uno di loro è diventato presidente nazionale), pensa che
possa rompermi le reni ed impedirmi di proseguire la mia lotta contro questo
concorso forense e tutti i concorsi pubblici che provo nei miei libri essere
truccati. E sempre su quei libri provo il vostro sistema giudiziario essere, per
gli effetti, fondato sull’ingiustizia. Mi conoscete tutti bene da vent’anni,
come mi conoscono bene, prima di giudicarmi, i magistrati che critico. Per chi
non fa parte del sistema e non MI conosce e non VI conosce bene, al di là
dell’immagine patinata che vi rendono i media genuflessi, pensa che in Italia
vige la meritocrazia e quindi chi esamina e giudica e chi supera gli esami,
vale. Non è così e non mi impedirete mai di gridarlo al mondo. Avete la forza
del potere, non la ragione della legge. Forse qualcuno di voi, sicuramente il
più influente, perseguendomi artatamente anche per diffamazione a mezzo stampa,
senza mai riuscire a condannarmi, pur con le sentenze già scritte prima del
dibattimento, pensa di tagliarmi la lingua affinchè non possa denunciare le
vostre malefatte. Non è così e non mi impedirete mai di gridarlo al mondo. E non
per me, ma per tutti coloro che, codardi, non hanno il coraggio di ribellarsi.
Anche perché se lo fate a me, lo fate anche agli altri. Fino a che ci saranno
centinaia di migliaia di giovani vittime che mi daranno ragione, voi sarete
sempre dalla parte del torto. Avete un potere immeritato, non la ragione. Un
ordine che dileggia il Potere del popolo sovrano. In Italia succede anche
questo. Potete farmi passare per mitomane o pazzo. E’ nell’ordine delle cose:
potrebbe andarmi peggio, come marcire in galera o peggio ancora. Potete, finché
morte non ci separi, impedirmi di diventare avvocato. Farò vita eremitica e
grama. Comunque, cari miei, vi piaccia o no, di magistrati ce ne sono più di
dieci mila, criticati e non sono certo apprezzati; di avvocati più di 250 mila e
questi, sì, disprezzati. Alla fine per tutti voi arriva comunque la Livella e
l’oblio. Di Antonio Giangrande c’è uno solo. Si ama o si odia, ma fatevene un
ragione: sarò per sempre una spina nel vostro fianco e sopravviverò a voi. Più
mi colpite, più mi rendete altrettanto forte. Eliminarmi ora? E’ troppo tardi.
Il virus della verità si diffonde. E ringraziate Dio che non ci sia io tra quei
945 parlamentari che vi vogliono molto, ma molto bene, che a parlar di voi si
cagano addosso. Solo in Italia chi subisce un’ingiustizia non ha nessuno a cui
rivolgersi, siano essi validi bocciati ai concorsi pubblici o innocenti in
galera, che si chiamino Berlusconi o Sallusti o Mulè o Riva (e tutti questi li
chiamano “persone influenti e potenti”). I nostri parlamentari non sanno nemmeno
di cosa tu stia parlando, quando ti prestano attenzione. Ed è raro che ciò
succeda. In fede Antonio Giangrande”.
Una denuncia
per calunnia, abuso d’ufficio e diffamazione contro la Commissione d’esame di
avvocato di Catania per tutelare l’immagine dei professionisti e di tutti i
cittadini leccesi, tarantini e brindisini è quanto propone il dr Antonio
Giangrande, presidente della “Associazione Contro Tutte le Mafie” (www.controtuttelemafie.it)
e profondo conoscitore del fenomeno degli esami e dei concorsi pubblici
truccati. Proposta presentata a tutti coloro che sono stati esclusi ed a tutti
gli altri, anche non candidati all’esame di avvocato, che si sentono vittime di
questo fenomeno di caccia alle streghe o che si sentano diffamati come
rappresentanti e come cittadini del territorio, ormai sputtanato in tutta
Italia. E proposta di presentazione del ricorso al Tar che sarebbe probabilmente
accolto, tenuto conto dei precedenti al Consiglio di Stato.
«A Lecce
sarebbero solo 440 su 1258 i compiti ritenuti validi. Questo il responso della
Commissione di Catania, presieduta dall’Avvocato Antonio Vitale, addetta alla
correzione degli elaborati. Più di cento scritti finiscono sul tavolo della
Procura della Repubblica con l’accusa di plagio, per poi, magari, scoprire che è
tutta una bufala. Copioni a parte, sarebbe, comunque, il 65% a non superare
l’esame: troppi per definirli asini, tenuto conto che, per esperienza personale,
so che alla fase di correzione non si dedicano oltre i 5 minuti, rispetto ai
15/20 minuti occorrenti. Troppo pochi per esprimere giudizi fondati. Da 20 anni
denuncio che in Italia agli esami tutti si copia ed adesso scoprono l’acqua
calda. E copiano tutti. Si ricordi il “Vergogna, Vergogna” all’esame per
magistrato o il “Buffoni, Buffoni” all’esame di notaio, o le intemperanze agli
esami per l’avvocatura di Stato o la prova annullata per l’esame di notaio nel
2010 o di magistrato nel 1992.
Le mie denunce
sono state sempre archiviate ed io fatto passare per pazzo o mitomane.
Quindi chi si
è abilitato barando, ha scoperto l’acqua calda. Questa caccia alle streghe,
perché? Vagito di legalità? Manco per idea. In tempo di magra per i
professionisti sul mercato, si fa passare per plagio, non solo la dettatura
uniforme dell’intero elaborato (ripeto, che c’è sempre stata), ma anche
l’indicazione della massima giurisprudenziale senza virgolette. Ergo: dov’è il
dolo? Per chi opera in ambito giuridico le massime della Cassazione sono
l’appiglio per tutte le tesi difensive di parte o accusatorie. Senza di queste
sarebbero solo opinioni personali senza valore. Altra cosa è riportare pari
pari, più che le massime, le motivazioni delle sentenze.
Prescindendo
dalla caccia mirata alle streghe, c’è forse di più?
Ed allora i
candidati esclusi alla prova scritta dell’esame di avvocato tenuta presso la
Corte d’Appello di Lecce si rivolgano a noi per coordinare tutte le azioni di
tutela: una denuncia per calunnia, abuso d’ufficio e per diffamazione contro
tutti coloro che si son resi responsabili di una campagna diffamatoria ed un
accanimento senza precedenti. Premo ricordare che l’esame è truccato insitamente
e non bisogna scaricare sulla dignità e l’onore dei candidati gli interessi di
una categoria corporativistica. Nessuno li difende i ragazzi, esclusi e
denunciati (cornuti e mazziati) ma, dato che io c’ero e ci sono dal 1998, posso
testimoniare che se plagio vi è stato, vi è sempre stato, e qualcuno ha omesso
il suo intervento facendola diventare una consuetudine e quindi una norma da
rispettare, e sono concorsi nel reato anche la commissione di Lecce ed il
Presidente della Corte d’Appello, Mario Buffa, in quanto hanno agevolato le
copiature. L’esame di avvocato in tutta Italia si apre alle 9 con la lettura
delle tracce, che così finiscono in rete sul web. A Lecce l’esame non inizia mai
prima delle undici. I ragazzi più furbi hanno tutto il tempo di copiare
legalmente, in quanto l’esame non è ancora iniziato e quindi, se hanno copiato,
non lo hanno fatto in quel frangente, perché non ci si può spostare dal banco.
Anche se, devo dire, si è sempre permessa la migrazione per occupare posti non
propri.
Su questi
punti chiamerei a testimoniare, a rischio di spergiuro, tutti gli avvocati
d’Italia.
Ai malfidati,
poi, spiegherei per filo e per segno come si trucca l’esame, verbalmente, in
testi ed in video.
Mi chiedo,
altresì, perché tanto accanimento su Lecce se sempre si è copiato ed in tutta
Italia? E perché non ci si impegna ha perseguire le commissioni che i compiti
non li correggono e li dichiarano tali?
Ma la
correzione era mirata al dare retti giudizi o si sono solo impegnati a fare
opera inquisitoria e persecutoria?
Inoltre ci
sono buone possibilità che il ricorso al Tar avverso all’esclusione possa essere
accolto in base ai precedenti del Consiglio di Stato».
Sarebbe il
colmo dei paradossi se tra quei 100 ci fosse il mio nome.
I commissari
dovrebbero dimostrare che, in quei pochi minuti, la loro attenzione era rivolta,
non a correggere ed a valutare i compiti, ma esclusivamente a cercare l’opera
primaria, fonte del plagio, presentata come propria dal candidato, per
verificarne l’esatta ed integrale corrispondenza.
Essi, al di là
della foga persecutoria, dovrebbero dimostrare che la Premessa, la Tesi e
l’Antitesi, le Conclusioni sono frutto di imitazione totale dell’altrui
pensiero. Dovrebbero, altresì, dimostrare che il richiamo essenziale alle
massime giurisprudenziali (spesso contrastanti tra loro) per suffragare la
propria tesi e renderla convincente, siano anch’esse plagio, pur essendo ammessi
i codici commentati dalla giurisprudenza, così come non lo sono per i magistrati
e per i prossimi esami di avvocato (tempi di applicazione della riforma
permettendo).
Dovrebbero, i
commissari, dimostrare che quei pochi minuti sono bastati a loro per correggere,
accusare e giudicare, rischiando si dichiarare il falso.
Sarebbe il
colmo dei paradossi se tra quei 100 ci fosse il mio nome.
Io che ho
denunciato e dimostrato che gli esami ed i concorsi pubblici sono truccati.
Forse per questo per le mie denunce sono stato fatto passare per mitomane o
pazzo ed ora anche per falsario.
Denigrare la
credibilità delle vittime e farle passare per carnefici. Vergogna, gentaglia.
VADEMECUM
DEL CONCORSO TRUCCATO.
INDIZIONE
DEL CONCORSO:
spesso si indice un concorso quando i tempi sono maturi per soddisfare da parte
dei prescelti i requisiti stabiliti (acquisizione di anzianità, titoli di
studio, ecc.). A volte chi indice il concorso lo fa a sua immagine e somiglianza
(perché vi partecipa personalmente come candidato). Spesso si indice il concorso
quando non vi sono candidati (per volontà o per induzione), salvo il prescelto.
Queste anomalie sono state riscontrate nei concorsi pubblici tenuti presso le
Università e gli enti pubblici locali. Spesso, come è successo per la polizia ed
i carabinieri, i vincitori rimangono casa.
COMMISSIONE
D’ESAME:
spesso a presiedere la commissione d’esame di avvocato sono personalità che
hanno una palese incompatibilità. Per esempio nella Commissione d’esame centrale
presso il Ministero della Giustizia del concorso di avvocato 2010 è stato
nominato presidente colui il quale non poteva, addirittura, presiedere la
commissione locale di Corte d’Appello di Lecce. Cacciato in virtù della riforma
(decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, coordinato con la legge di conversione 18
luglio 2003, n. 180). La legge prevede che i Consiglieri dell’Ordine degli
Avvocati non possono essere Commissari d’esame (e per conseguenza i nominati dal
Consiglio locale per il Consiglio Nazionale Forense, che tra i suoi membri
nomina il presidente di Commissione centrale). La riforma ha cacciato gli
avvocati e sbugiardato i magistrati e professori universitari (in qualità
anch’essi di commissari d’esame) perché i compiti vengono letti presso altre
sedi: tutto questo perché prima tutti hanno raccomandato a iosa ed abusato del
proprio potere dichiarando altresì il falso nei loro giudizi abilitativi od
osteggiativi. Spesso le commissioni d’esame di avvocato sono mancanti delle
componenti necessarie per la valutazione tecnica della materia d’esame.
Essenziale nelle commissioni a cinque è la figura del magistrato, dell’avvocato,
del professore universitario: se una manca, la commissione è nulla. Le
Commissioni d’esame hanno sempre e comunque interessi amicali, familistiche e
clientelari.
I CONCORSI
FARSA:
spesso i concorsi vengono indetti per sanare delle mansioni già in essere, come
il concorso truffa a 1.940 posti presso l’INPS, bandito per sistemare i
lavoratori socialmente utili già operanti presso l’Ente.
LE TRACCE:
le tracce sono composte da personalità ministeriali scollegate
alla realtà dei fatti. Ultimamente le tracce si riferiscono a massime
giurisprudenziali espresse nell’imminenza della stilazione della traccia,
quindi, in prossimità dell’esame. Quasi nessun testo recente, portato legalmente
dai candidati, è talmente aggiornato da riportare quella massima. Altre volte si
son riportate tracce con massime vecchissime e non corrispondenti con le riforme
legislative successive. Sessione d’esame d’avvocato 2002-2003. Presidente di
Commissione, Avv. Luigi Rella, Principe del Foro di Lecce. Ispettore
Ministeriale, Giorgino. Sono stato bocciato. Il Ministero, alla prova di scritto
di diritto penale, alla traccia n. 1, erroneamente chiede ai candidati cosa
succede al Sindaco, che prima nega e poi rilascia una concessione edilizia ad un
suo amico, sotto mentite spoglie di un’ordinanza. In tale sede i Commissari
penalisti impreparati suggerivano in modo sbagliato. Solo io rilevavo che la
traccia era errata, in quanto riferita a sentenze della Cassazione riconducibili
a violazioni di legge non più in vigore. Si palesava l’ignoranza dell’art.107,
D.Lgs. 267/00, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, in cui si
dispongono le funzioni dei dirigenti, e l’ignoranza del D.P.R. 380/01, Testo
Unico in materia edilizia. Da molti anni, con le varie Bassanini, sono entrate
in vigore norme, in cui si prevede che è competente il Dirigente dell’Ufficio
Tecnico del Comune a rilasciare o a negare le concessioni edilizie. Rilevavo che
il Sindaco era incompetente. Rilevavo altresì che il Ministero dava per scontato
il comportamento dei Pubblici Ufficiali omertosi, che lavorando con il Sindaco e
conoscendo i fatti penalmente rilevanti, non li denunciavano alla Magistratura.
Per non aver seguito i loro suggerimenti, i Commissari mi danno 15 (il minimo)
al compito esatto, 30 (il massimo) agli altri 2 compiti. I candidati che hanno
scritto i suggerimenti sbagliati, sono divenuti idonei.
LE PROVE
D’ESAME:
spesso sono conosciute in anticipo. A volte sono pubblicate su internet giorni
prima, come è successo per il concorso degli avvocati (con denuncia del
sottosegretario Alfredo Mantovano di Lecce), dei dirigenti scolastici, o per
l’accesso alle Università a numero chiuso (medicina), ovvero, come succede
all’esame con più sedi (per esempio all’esame forense o per l’Agenzia delle
Entrate, le tracce sono conosciute tramite cellulari o palmari in virtù del
tardivo inizio delle prove in una sede rispetto ad altre. Si parla di ore di
ritardo tra una sede ed un’altra). A volte le tracce sono già state elaborate in
precedenza in appositi corsi, così come è successo all’esame di notaio. A volte
le prove sono impossibili, come è successo al concorsone pubblico per insegnanti
all’estero: 40 quesiti a risposta multipla dopo averli cercati, uno ad uno, in
un volume di oltre 4mila che i partecipanti alla selezione hanno visto per la
prima volta, leggere quattro testi in lingua straniera e rispondere alle
relative domande. Il tutto nel tempo record di 45 minuti, comprese parti di
testo da tradurre. Quasi 1 minuto a quesito.
MATERIALE
CONSULTABILE:
c’è da dire che intorno al materiale d’esame c’è grande speculazione e un grande
salasso per le famiglie dei candidati, che sono rinnovati anno per anno in caso
di reiterazione dell’esame a causa di bocciatura. Centinaia di euro per codici e
materiale vario. Spesso, come al concorso di magistrato o di avvocato dello
Stato ed in tutti gli altri concorsi, ad alcuni è permessa la consultazione di
materiale vietato (codici commentati, fogliettini, fin anche compiti elaborati
dagli stessi commissari) fino a che non scoppia la bagarre. Si ricordi il
“Vergogna, Vergogna” all’esame per magistrato o il “Buffoni, Buffoni” all’esame
di notaio, o le intemperanze agli esami per l’avvocatura di Stato o la prova
annullata per l’esame di notaio nel 2010. Al concorso di avvocato, invece, è
permesso consultare codici commentati con la giurisprudenza. Spesso, come
succede al concorso di avvocato, sono proprio i commissari a dettare il parere
da scrivere sull’elaborato, tale da rendere le prove dei candidati uniformi e
nonostante ciò discriminati in sede di correzione. Il caso esemplare è lo
scandalo di Catanzaro: oltre duemila compiti-fotocopia. Su 2301 prove scritte
per l’accesso all’albo degli avvocati consegnate a metà dicembre del 1997 alla
commissione d’esame di Catanzaro, ben 2295 risultano identiche. Soltanto sei
elaborati, cioè lo 0,13 per cento del totale, appare non copiato. Compiti
identici, riga per riga, parola per parola. Le tre prove di diritto civile,
diritto penale e atti giudiziari non mettono in risalto differenze. Sono uguali
anche negli errori: tutti correggono l’avverbio «recisamente» in «precisamente».
Una concorrente rivela che un commissario avrebbe letteralmente dettato lo
svolgimento dei temi ai candidati. Racconta: «Entra un commissario e fa:
“scrivete”. E comincia a dettare il tema, piano piano, per dar modo a tutti di
non perdere il filo». «Che imbecilli quelli che hanno parlato, sono stati loro
a incasinare tutto. Se non avessero piantato un casino sarebbe andato tutto
liscio», dice una candidata, che poi diventerà avvocato e probabilmente
commissario d’esame, che rinnegherà il suo passato e che accuserà di plagio i
nuovi candidati. L’indagine è affidata ai pm Luigi de Magistris e Federica
Baccaglini, che ipotizzano il reato di falso specifico e inviano ben 2295 avvisi
di garanzia. Catanzaro non è l’unica mecca delle toghe: le fa concorrenza anche
Reggio Calabria che, tra l’altro, nel 2001 promuove il futuro ministro
dell’Istruzione per il Pdl Mariastella Gelmini in trasferta da Brescia. Ma
Catanzaro è da Guinness dei primati. I candidati arrivano da tutta Italia, e i
veri intoccabili soprattutto dalle sedi del Nord dove gli esami sono molto
selettivi per impedire l’accesso di nuovi avvocati nel mercato saturo. Gli
aspiranti avvocati milanesi o torinesi risultano residenti a Catanzaro per i sei
mesi necessari per il tirocinio, svolto in studi legali del luogo, i quali
certificano il praticantato dei futuri colleghi. Frotte di giovani si fanno
consigliare dove e come chiedere ospitalità. In città esistono numerose pensioni
e alloggi, oltre a cinque alberghi, che periodicamente accolgono con pacchetti
scontati i pellegrini forensi. Tutti sanno come funziona e nessuno se ne
lamenta. L’omertà è totale. I magistrati interrogano gruppi di candidati
dell’esame del dicembre 1997, che rispondono all’unisono: «Mi portai sovente in
bagno per bisogni fisiologici […]. Non so spiegare la coincidenza tra gli
elaborati da me compilati e quelli esibiti. Mi preme tuttavia evidenziare che
qualcuno potrebbe avermi copiato durante la mia assenza». Mentre il procedimento
giudiziario avanza a fatica per la difficoltà di gestire un numero così grande
di indagati, tutti gli aspiranti avvocati dell’esame del 1997 rifanno le prove
nel 1998 nel medesimo posto e sono promossi. Dopo otto anni di indagini e
rinvii, nell’estate 2005 il pm Federico Sergi, nuovo titolare dell’indagine,
chiede e ottiene per ciascuno il «non luogo a procedere per avvenuta
prescrizione». Tutto finito. Ultimamente le tracce si riferiscono a massime
giurisprudenziali espresse nell’imminenza della stilazione della traccia,
quindi, in prossimità dell’esame. Quasi nessun testo recente, portato legalmente
dai candidati, è talmente aggiornato da riportare quella massima. Ecco perché i
commissari d’esame, con coscienza e magnanimità, aiutano i candidati. Altrimenti
nessuno passerebbe l’esame. I commissari dovrebbero sapere quali sono le fonti
di consultazioni permesse e quali no. Per esempio all’esame di avvocato può
capitare che il magistrato commissario d’esame, avendo fatto il suo esame senza
codici commentati, non sappia che per gli avvocati ciò è permesso. I commissari
d’esame dovrebbero dimostrare che, in quei pochi minuti, la loro attenzione era
rivolta, non a correggere ed a valutare i compiti, ma esclusivamente a cercare
l’opera primaria, fonte del plagio, presentata come propria dal candidato, per
verificarne l’esatta ed integrale corrispondenza. Essi, al di là della foga
persecutoria, dovrebbero dimostrare che la Premessa, la Tesi e l’Antitesi, le
Conclusioni sono frutto di imitazione totale dell’altrui pensiero. Dovrebbero,
altresì, dimostrare che il richiamo essenziale alle massime giurisprudenziali
(spesso contrastanti tra loro) per suffragare la propria tesi e renderla
convincente, siano anch’esse plagio, pur essendo ammessi i codici commentati
dalla giurisprudenza, così come non lo sono per i magistrati e per i prossimi
esami di avvocato (tempi di applicazione della riforma permettendo). Dovrebbero,
i commissari, dimostrare che quei pochi minuti sono bastati a loro per
correggere, accusare e giudicare, rischiando si dichiarare il falso. Impuniti,
invece sono coloro che veramente copiano integralmente i compiti. In principio
era la vecchia “cartucciera” la fascia di stoffa da stringere in vita con gli
involtini. Poi il vocabolario farcito d'ogni foglio e foglietto, giubbotti
imbottiti di cultura bignami e addirittura scarpe con suola manoscritta. Oggi i
metodi per “aiutarsi” durante gli esami sono più tecnologici: il telefonino, si
sa, non si può portare, ma lo si porta lo stesso. Al massimo, se c’è la
verifica, lo metti sul tavolo della commissione. Quindi non è malsana l'idea
dell'iPhone sul banco, collegato a Wikipedia e pronto a rispondere ad ogni
quesito nozionistico. Comunque bisogna attrezzarsi, in maniera assolutamente
diversa. La rete e i negozi di cartolibreria vendono qualsiasi accrocchio
garantendo si tratti della migliore soluzione possibile per copiare durante le
prove scritte. C'è ad esempio la penna UV cioè a raggi ultravioletti scrive con
inchiostro bianco e si legge passandoci sopra un led viola incluso nel corpo
della penna. Inconveniente: difficile non far notare in classe una luce da
discoteca. Poi c'è la cosiddetta penna-foglietto: nel corpo della stilo c'è un
foglietto avvolto sul quale si è scritto precedentemente formule, appunti
eccetera. Foglietto che in men che non si dica si srotola e arrotola. E infine,
c'è l'ormai celebre orologio-biglietto col display elettronico e una porta Usb
sulla quale caricare testi d'ogni tipo.
IL
MATERIALE CONSEGNATO:
il compito dovrebbe essere inserito in una busta da sigillare contenente
un’altra busta chiusa con inserito il nome del candidato. Non ci dovrebbero
essere segni di riconoscimento. Non è così come insegna il concorso di notaio.
Oltre ai segni di riconoscimento posti all’interno (nastri), i commissari
firmano in modo diverso i lembi di chiusura della busta grande consegnata.
LA
CORREZIONE DEGLI ELABORATI.
Quanto già indicato sono i trucchi che i candidati possono vedere ed
eventualmente denunciare. Quanto avviene in sede di correzione è lì la madre di
tutte le manomissioni. Proprio perchè nessuno vede. La norma prevede che la
commissione d’esame (tutti i componenti) partecipi alle fasi di:
• apertura
della busta grande contenente gli elaborati;
• lettura del
tema da parte del relatore ed audizione degli altri membri;
• correzione
degli errori di ortografia, sintassi e grammatica;
• richiesta di
chiarimenti, valutazione dell’elaborato affinchè le prove d’esame del ricorrente
evidenzino un contesto caratterizzato dalla correttezza formale della forma
espressiva e dalla sicura padronanza del lessico giuridico, anche sotto il
profilo più strettamente tecnico-giuridico, e che anche la soluzione delle
problematiche giuridiche poste a base delle prove d’esame evidenzino un corretto
approccio a problematiche complesse;
•
consultazione collettiva, interpello e giudizio dei singoli commissari, giudizio
numerico complessivo, motivazione, sottoscrizione;
• apertura
della busta piccola contenete il nome del candidato da abbinare agli elaborati
corretti;
• redazione
del verbale.
Queste sono
solo fandonie normative. Di fatto si apre prima la busta piccola, si legge il
nome, se è un prescelto si dà agli elaborati un giudizio positivo, senza nemmeno
leggerli. Quando i prescelti sono pochi rispetto al numero limite di idonei
stabilito illegalmente, nonostante il numero aperto, si aggiungono altri idonei
diventati tali “a fortuna”.
La riforma del
2003 ha cacciato gli avvocati e sbugiardato i magistrati e professori
universitari (in qualità anch’essi di commissari d’esame) perché i compiti
vengono letti presso altre sedi: tutto questo perché prima tutti hanno
raccomandato a iosa ed abusato del proprio potere dichiarando altresì il falso
nei loro giudizi abilitativi od osteggiativi. Spesso le commissioni d’esame sono
mancanti delle componenti necessarie per la valutazione tecnica della materia
d’esame. Le Commissioni d’esame hanno sempre e comunque interessi amicali,
familistiche e clientelari. Seguendo una crescente letteratura negli ultimi anni
abbiamo messo in relazione l’età di iscrizione all’albo degli avvocati con un
indice di frequenza del cognome nello stesso albo. In particolare, per ogni
avvocato abbiamo calcolato la frequenza del cognome nell’albo, ovvero il
rapporto tra quante volte quel cognome vi appare sul totale degli iscritti, in
relazione alla frequenza dello stesso cognome nella popolazione. In media, il
cognome di un avvocato appare nell’albo 50 volte di più che nella popolazione.
Chi ha un cognome sovra-rappresentato nell’albo della sua provincia diventa
avvocato prima. Infine vi sono commissioni che, quando il concorso è a numero
aperto, hanno tutto l’interesse a limitare il numero di idonei per limitare la
concorrenza: a detta dell’economista Tito Boeri: «Nelle commissioni ci sono
persone che hanno tutto da perderci dall’entrata di professionisti più bravi e
più competenti».
Paola Severino
incoraggia gli studenti e racconta: “Anch’io la prima volta fui bocciata
all’esame per diventare avvocato”. Raccontare una propria disavventura per
infondere coraggio alle nuove generazioni. Questa è la tecnica adottata dal
Ministro della Giustizia Paola Severino con i ragazzi della «Summer School»
promossa dalla Fondazione Magna Charta di Gaetano Quagliariello e Maurizio
Gasparri. “Cari ragazzi, non dovete scoraggiarvi perché anch’io la prima volta
fui bocciata all’esame per diventare avvocato… Quella volta ero con il mio
futuro marito: lui fu promosso e io non ce la feci… Ma eccoci ancora qua. Siamo
sposati da tanti anni” ha raccontato di fronte ai futuri avvocati puntando tutto
sulla love story e omettendo che, nonostante quella bocciatura, sarà titolare
fino a novembre di uno degli studi legali più importanti d’Italia (con cifre che
si aggirano intorno ai 7 milioni di euro). Una piccola consolazione non solo per
i laureati in legge, ma anche per tutte le future matricole che sosterranno i
test di ammissione. In fondo anche Albert Einstein venne bocciato. E a quanto
pare anche la Severino. Bisognerebbe, però, chiedere al ministro: gli amorosi
l’aiuto se lo son dato vicendevolmente ed i compiti sicuramente erano simili,
quindi perché un diverso giudizio?
In quei mesi
di tormenti a cavallo tra il 2000 e il 2001 la Mariastella Gelmini si trova
dunque a scegliere, spiegherà essa stessa a Flavia Amabile de “La Stampa.it”:
«La mia famiglia non poteva permettersi di mantenermi troppo a lungo agli studi,
mio padre era un agricoltore. Dovevo iniziare a lavorare e quindi dovevo
superare l'esame per ottenere l'abilitazione alla professione». Quindi? «La
sensazione era che esistesse un tetto del 30% che comprendeva i figli di
avvocati e altri pochi fortunati che riuscivano ogni anno a superare l'esame.
Per gli altri, nulla. C'era una logica di casta». E così, «insieme con altri
30-40 amici molto demotivati da questa situazione, abbiamo deciso di andare a
fare l'esame a Reggio Calabria». I risultati della sessione del 2000, del resto,
erano incoraggianti. Nonostante lo scoppio dello scandalo, nel capoluogo
calabrese c'era stato il primato italiano di ammessi agli orali: 93,4%. Il
triplo che nella Brescia della Gelmini (31,7) o a Milano (28,1), il quadruplo
che ad Ancona. Idonei finali: 87% degli iscritti iniziali. Contro il 28% di
Brescia, il 23,1% di Milano, il 17% di Firenze. Totale: 806 idonei. Cinque volte
e mezzo quelli di Brescia: 144. Quanti Marche, Umbria, Basilicata, Trentino,
Abruzzo, Sardegna e Friuli Venezia Giulia messi insieme. Insomma, la tentazione
era forte. Spiega il ministro dell'Istruzione: «Molti ragazzi andavano lì e
abbiamo deciso di farlo anche noi». E l'esame? Com'è stato l'esame? Quasi 57% di
ammessi agli orali. Il doppio che a Roma o a Milano. Quasi il triplo che a
Brescia. Dietro soltanto la solita Catanzaro, Caltanissetta, Salerno.
Quello per
giudici e pm resta uno dei concorsi più duri. Dopo la laurea occorrono oltre due
anni di preparazione negli studi forensi. Oppure nelle scuole universitarie di
specializzazione per le professioni legali. Sui 3.193 candidati che nel novembre
2008 hanno consegnato i tre scritti di diritto amministrativo, penale e civile,
la commissione ha mandato agli orali soltanto 309 aspiranti magistrati. Per poi
promuoverne 253. Nonostante i quasi due anni di prove e correzioni e i soldi
spesi, il ministero non è nemmeno riuscito a selezionare i 500 magistrati
previsti dal concorso. E tanto attesi negli uffici giudiziari di tutta Italia.
Se questi sono i risultati dei corsi di formazione post-laurea, il fallimento
degli obiettivi è totale. Eppure almeno cinque tra i 28 commissari sono stati
scelti dal ministro Alfano proprio tra quanti hanno insegnato nelle scuole di
specializzazione per le professioni legali. "I componenti della commissione
rispondono che il livello degli elaborati non ammessi era basso", dice
l'avvocato Anna Sammassimo, dell'Unione giuristi cattolici: "Ma alla lettura
degli elaborati dichiarati idonei si resta perplessi e molto. Tanto più che i
curricula dei candidati esclusi destano ammirazione. Dal verbale da me
visionato, il 227, risulta che la correzione dei tre elaborati di ciascun
candidato ha impegnato la sottocommissione per circa 30 minuti: per leggere tre
temi di tre materie, discuterne e deciderne il voto o la non idoneità sembra
obiettivamente un po' poco". Riguardo la magistratura, l’avvocato astigiano
Pierpaolo Berardi, classe 1964, per anni ha battagliato per far annullare il
concorso per magistrati svolto nel maggio 1992. Secondo Berardi, infatti, in
base ai verbali dei commissari, più di metà dei compiti vennero corretti in 3
minuti di media (comprendendo “apertura della busta, verbalizzazione e richiesta
chiarimenti”) e quindi non “furono mai esaminati”. I giudici del tar gli hanno
dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il Csm, nel 2008, è stato costretto ad
ammettere: “Ci fu una vera e propria mancanza di valutazione da parte della
commissione”. Giudizio che vale anche per gli altri esaminati. In quell’esame
divenne uditore giudiziario, tra gli altri, proprio Luigi de Magistris, giovane
Pubblico Ministero che si occupò inutilmente del concorso farsa di abilitazione
forense a Catanzaro: tutti i compiti identici e tutti abilitati.
Al Tg1 Rai
delle 20.00 del 1 agosto 2010 il conduttore apre un servizio: esame di accesso
in Magistratura, dichiarati idonei temi pieni zeppi di errori di ortografia. La
denuncia è stata fatta da 60 candidati bocciati al concorso 2008, che hanno
spulciato i compiti degli idonei e hanno presentato ricorso al TAR per
manifesta parzialità dei commissari con abuso del pubblico ufficio.
Di scandali
per i compiti non corretti, ma ritenuti idonei, se ne è parlato.
Nel 2008 un
consigliere del Tar trombato al concorso per entrare nel Consiglio di Stato, si
è preso la briga di controllare gli atti del giorno in cui sono state corrette
le sue prove, scoprendo che i cinque commissari avevano analizzato la bellezza
di 690 pagine. "Senza considerare la pausa pranzo e quella della toilette,
significa che hanno letto in media tre pagine e mezzo in 60 secondi. Un record
da guinness, visto che la materia è complessa", ironizza Alessio Liberati. Che
ha impugnato anche i concorsi del 2006 e del 2007: a suo parere i vincitori
hanno proposto stranamente soluzioni completamente diverse per la stessa
identica sentenza. Il magistrato, inoltre, ha sostenuto che uno dei vincitori,
Roberto Giovagnoli, non aveva nemmeno i titoli per partecipare al concorso.
L'esposto viene palleggiato da mesi tra lo stesso Consiglio di Stato e la
presidenza del Consiglio dei ministri, ma i dubbi e "qualche perplessità"
serpeggiano anche tra alcuni consiglieri. "Il bando sembra introdurre
l'ulteriore requisito dell'anzianità quinquennale" ha messo a verbale uno di
loro durante una sessione dell'organo di presidenza: "Giovagnoli era stato
dirigente presso la Corte dei conti per circa 6 mesi (...) Il bando non sembra
rispettato su questo punto". Per legge, a decidere se i concorsi siano stati o
meno taroccati, saranno gli stessi membri del Consiglio. Vedremo.
In effetti,
con migliaia di ricorsi al TAR si è dimostrato che i giudizi resi sono
inaffidabili. La carenza, ovvero la contraddittorietà e la illogicità del
giudizio negativo reso in contrapposizione ad una evidente assenza o rilevanza
di segni grafici sugli elaborati, quali glosse, correzioni, note, commenti,
ecc., o comunque la infondatezza dei giudizi assunti, tale da suffragare e
giustificare la corrispondente motivazione indotta al voto numerico. Tutto ciò
denota l’assoluta discrasia tra giudizio e contenuto degli elaborati, specie se
la correzione degli elaborati è avvenuta in tempi insufficienti, tali da rendere
un giudizio composito. Tempi risibili, tanto da offendere l’umana intelligenza.
Dai Verbali si contano 1 o 2 minuti per effettuare tutte le fasi di correzione,
quando il Tar di Milano ha dichiarato che ci vogliono almeno 6 minuti solo per
leggere l’elaborato. La mancanza di correzione degli elaborati ha reso invalido
il concorso in magistratura. Per altri concorsi, anche nella stessa
magistratura, il ministero della Giustizia ha fatto lo gnorri e si è sanato
tutto, alla faccia degli esclusi. Già nel 2005 candidati notai ammessi agli
orali nonostante errori da somari, atti nulli che vengono premiati con buoni
voti, mancata verbalizzazione delle domande, elaborati di figli di
professionisti ed europarlamentari prima considerati “non idonei” e poi promossi
agli orali. Al Tg1 Rai delle 20.00 del 1 agosto 2010 il conduttore apre un
servizio: esame di accesso in Magistratura, dichiarati idonei temi pieni zeppi
di errori di ortografia. La denuncia è stata fatta da 60 candidati bocciati al
concorso 2008, che hanno spulciato i compiti degli idonei e hanno presentato
ricorso al TAR per manifesta parzialità dei commissari con abuso del pubblico
ufficio. Riguardo la magistratura, l’avvocato astigiano Pierpaolo Berardi,
classe 1964, per anni ha battagliato per far annullare il concorso per
magistrati svolto nel maggio 1992. Secondo Berardi, infatti, in base ai verbali
dei commissari, più di metà dei compiti vennero corretti in 3 minuti di media
(comprendendo “apertura della busta, verbalizzazione e richiesta chiarimenti”) e
quindi non “furono mai esaminati”. I giudici del tar gli hanno dato ragione nel
1996 e nel 2000 e il Csm, nel 2008, è stato costretto ad ammettere: “Ci fu una
vera e propria mancanza di valutazione da parte della commissione”. Giudizio che
vale anche per gli altri esaminati. In quell’esame divenne uditore giudiziario,
tra gli altri, proprio Luigi de Magistris, giovane Pubblico Ministero che si
occupò inutilmente del concorso farsa di abilitazione forense a Catanzaro: tutti
i compiti identici e tutti abilitati. O ancora l’esame di ammissione all’albo
dei giornalisti professionisti del 1991, audizione riscontrabile negli archivi
di radio radicale, quando la presenza di un folto gruppo di raccomandati venne
scoperta per caso da un computer lasciato acceso nella sala stampa del Senato
proprio sul file nel quale il caposervizio di un’agenzia, commissario
esaminatore, aveva preso nota delle prime righe dei temi di tutti quelli da
promuovere. E ancora lo scandalo denunciato da un’inchiesta del 14 maggio 2009
apparsa su “La Stampa”. A finire sotto la lente d’ingrandimento del quotidiano
torinese l’esito del concorso per allievi per il Corpo Forestale. Tra i 500
vincitori figli di comandanti, dirigenti, uomini di vertice. La casualità ha
voluto, inoltre, che molti dei vincitori siano stati assegnati nelle stazioni
dove comandano i loro genitori. Una singolare coincidenza che diventa ancor più
strana nel momento in cui si butta un occhio ad alcuni “promemoria”, sotto forma
di pizzini, ritrovati nei corridoi del Corpo forestale e in cui sono annotati
nomi, cognomi, date di nascita e discendenze di alcuni candidati. «Per Alfonso,
figlio di Rosetta», «Per Emidio, figlio di Cesarina di zio Antonio», «Per Maria,
figlia di Raffaele di zia Maria». Piccole annotazioni, certo. Il destino, però,
ha voluto che le tutte persone segnalate nei pizzini risultassero vincitrici al
concorso.
GLI
ESCLUSI, RIAMMESSI.
Candidati che sono stati esclusi dalla prova per irregolarità, come è successo
al concorso per Dirigenti scolastici, o giudicati non idonei, che poi si
presentano regolarmente agli orali. L’incipit della confidenza di Elio
Belcastro, parlamentare dell’Mpa di Raffaele Lombardo, pubblicata su “Il
Giornale”. Belcastro ci fa subito capire, scandendo bene le parole, che Tonino
non era nemmeno riuscito a prenderlo quel voto, minimo. «Tempo fa l’ex
procuratore capo di Roma, Felice Filocamo, che di quella commissione d’esami era
il segretario, mi ha raccontato che quando Carnevale si accorse che i vari
componenti avevano bocciato Di Pietro, lo chiamò e si arrabbiò molto. Filocamo
fu costretto a tornare in ufficio, a strappare il compito del futuro paladino di
Mani pulite e a far sì che, non saprei dire come, ottenesse il passaggio agli
orali, seppur con il minimo dei voti». Bocciato e ripescato? Magistrato per un
falso? Possibile? Non è l’unico caso. Era già stato giudicato non idoneo, ma in
una seconda fase sarebbero saltati fuori degli strani fogli aggiuntivi che prima
non c’erano. Ecco come sarebbe sorto il sospetto che qualcuno li avesse inseriti
per “salvare” il candidato già bocciato, in modo da giustificare una valutazione
diversa oppure da consentire un successivo ricorso al TAR. I maggiori quotidiani
nazionali e molti locali, ed anche tanti periodici, si sono occupati di tale
gravissimo fatto, e che è stato individuato con nome e cognome il magistrato
(una donna) in servizio a Napoli quale autore del broglio accertato. Per tale
episodio il CSM ha deciso di sospendere tale magistrato dalle funzioni e dallo
stipendio. In quella sessione a fronte di 350 candidati ammessi alle prove orali
pare che oltre 120 siano napoletani, i quali sembrano avere particolari
attitudini naturali verso le scienze giuridiche e che sembrano essere
particolarmente facilitati nel loro cammino anche dalla numerosa presenza nella
commissione di esami di magistrati e professori napoletani.
TUTELA
AMMINISTRATIVA: non è ammesso ricorso amministrativo gerarchico.
Sessione
d’esame d’avvocato 2002-2003. Presidente di Commissione, Avv. Luigi Rella,
Principe del Foro di Lecce. Ispettore Ministeriale, Giorgino. Sono stato
bocciato. Il Ministero, alla prova di scritto di diritto penale, alla traccia n.
1, erroneamente chiede ai candidati cosa succede al Sindaco, che prima nega e
poi rilascia una concessione edilizia ad un suo amico, sotto mentite spoglie di
un’ordinanza. In tale sede i Commissari penalisti impreparati suggerivano in
modo sbagliato. Solo io rilevavo che la traccia era errata, in quanto riferita a
sentenze della Cassazione riconducibili a violazioni di legge non più in vigore.
Si palesava l’ignoranza dell’art.107, D.Lgs. 267/00, Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in cui si dispongono le funzioni dei
dirigenti, e l’ignoranza del D.P.R. 380/01, Testo Unico in materia edilizia. Da
molti anni, con le varie Bassanini, sono entrate in vigore norme, in cui si
prevede che è competente il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune a
rilasciare o a negare le concessioni edilizie. Rilevavo che il Sindaco era
incompetente. Rilevavo altresì che il Ministero dava per scontato il
comportamento dei Pubblici Ufficiali omertosi, che lavorando con il Sindaco e
conoscendo i fatti penalmente rilevanti, non li denunciavano alla Magistratura.
Per non aver seguito i loro suggerimenti, i Commissari mi danno 15 (il minimo)
al compito esatto, 30 (il massimo) agli altri 2 compiti. I candidati che hanno
scritto i suggerimenti sbagliati, sono divenuti idonei. Il presidente di
Commissione d’esame di Lecce, ricevendo il ricorso amministrativo gerarchico
contro l’esito della valutazione della sottocommissione, non ha risposto entro i
trenta giorni (nemmeno per il diniego) impedendomi di presentare ricorso al Tar.
TUTELA
GIUDIZIARIA.
Un ricorso al TAR non si nega a nessuno: basta pagare la tangente delle spese di
giudizio. Per veder accolto il ricorso basta avere il principe del Foro
amministrativo del posto; per gli altri non c’è trippa per gatti. Cavallo di
battaglia: mancanza della motivazione ed illogicità dei giudizi. Nel primo caso,
dovendo accertare un’ecatombe dei giudizi, la Corte Costituzionale, con sentenza
175 del 2011, ha legittimato l’abuso delle commissioni: “buon andamento,
economicità ed efficacia dell’azione amministrativa rendono non esigibile una
dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni
sottese ad un giudizio di non idoneità, sia per i tempi entro i quali le
operazioni concorsuali o abilitative devono essere portate a compimento, sia per
il numero dei partecipanti alle prove”. Così la Corte Costituzionale ha sancito,
il 7 giugno 2011, la legittimità costituzionale del cd. “diritto vivente”,
secondo cui sarebbe sufficiente motivare il giudizio negativo, negli esami di
abilitazione, con il semplice voto numerico. La Corte Costituzionale per ragion
di Stato (tempi ristretti ed elevato numero) afferma piena fiducia nelle
commissioni di esame (nonostante la riforma e varie inchieste mediatiche e
giudiziarie ne minano la credibilità), stabilendo una sorta d’infallibilità del
loro operato e di insindacabilità dei giudizi resi, salvo che il sindacato non
promani in sede giurisdizionale. I candidati, quindi, devono sperare nel Foro
presso cui vi sia tutela della meritocrazia ed un certo orientamento
giurisprudenziale a favore dei diritti inviolabili del candidato, che nella
massa è ridimensionato ad un semplice numero, sia di elaborato, sia di giudizio.
Giudizi rapidi e sommari, che spesso non valorizzano le capacità tecniche e
umane che da un’attenta lettura dell’elaborato possono trasparire. Fatto
assodato ed incontestabile il voto numerico, quale giudizio e motivazione
sottesa. Esso deve, però, riferire ad elementi di fatto corrispondenti che
supportino quel voto. Elementi di fatto che spesso mancano o sono insussistenti.
All’improvvida sentenza della Corte Costituzionale viene in soccorso la Corte di
Cassazione. Il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice
amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di
esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento
amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo
tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica
amministrazione), è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione
esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in
relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio
sull’elaborato sottoposto a valutazione. In sostanza il TAR può scendere sul
terreno delle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici per l’accesso
a una professione o in un concorso pubblico, quando il giudizio è viziato da
evidente illogicità e da travisamento del fatto. Ad affermare l’importante
principio di diritto sono le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.
8412, depositata il 28 maggio 2012. Insomma, la Cassazione afferma che le
commissioni deviano il senso della norma concorsuale.
Sì, il Tar può
salvare tutti, meno che Antonio Giangrande. Da venti anni inascoltato Antonio
Giangrande denuncia il malaffare di avvocati e magistrati ed il loro malsano
accesso alla professione. Cosa ha ottenuto a denunciare i trucchi per superare
l’esame? Prima di tutto l’ostracismo all’abilitazione. Poi, insabbiamento delle
denunce contro i concorsi truccati ed attivazione di processi per diffamazione e
calunnia, chiusi, però, con assoluzione piena. Intanto ti intimoriscono. Ed
anche la giustizia amministrativa si adegua. A parlar delle loro malefatte i
giudici amministrativi te la fanno pagare. Presenta l’oneroso ricorso al Tar di
Lecce (ma poteva essere qualsiasi altro Tribunale Amministrativo Regionale) per
contestare l’esito negativo dei suoi compiti all’esame di avvocato:
COMMISSIONE NAZIONALE D'ESAME PRESIEDUTA DA CHI NON POTEVA RICOPRIRE L'INCARICO,
COMMISSARI (COMMISSIONE COMPOSTA DA MAGISTRATI, AVVOCATI E PROFESSORI
UNIVERSITARI) DENUNCIATI CHE GIUDICANO IL DENUNCIANTE E TEMI SCRITTI NON
CORRETTI, MA DA 15 ANNI SONO DICHIARATI TALI. Ricorso, n. 1240/2011
presentato al Tar di Lecce il 25 luglio 2011 contro il voto numerico
insufficiente (25,25,25) dato alle prove scritte di oltre 4 pagine cadaune della
sessione del 2010 adducente innumerevoli nullità, contenente, altresì, domanda
di fissazione dell’udienza di trattazione. Tale ricorso non ha prodotto alcun
giudizio nei tempi stabiliti, salvo se non il diniego immediato ad una istanza
cautelare di sospensione, tanto da farlo partecipare, nelle more ed in pendenza
dell’esito definitivo del ricorso, a ben altre due sessioni successive, i cui
risultati sono stati identici ai temi dei 15 anni precedenti (25,25,25): compiti
puliti e senza motivazione, voti identici e procedura di correzione nulla in più
punti. Per l’inerzia del Tar si è stati costretti a presentare istanza di
prelievo il 09/07/2012. Inspiegabilmente nei mesi successivi all’udienza fissata
e tenuta del 7 novembre 2012 non vi è stata alcuna notizia dell’esito
dell’istanza, nonostante altri ricorsi analoghi presentati un anno dopo hanno
avuto celere ed immediato esito positivo di accoglimento. Eccetto qualcuno che
non poteva essere accolto, tra i quali i ricorsi dell'avv. Carlo Panzuti e
dell'avv. Angelo Vantaggiato in cui si contestava il giudizio negativo reso ad
un elaborato striminzito di appena una pagina e mezza. Solo in data 7 febbraio
2013 si depositava sentenza per una decisione presa già in camera di consiglio
della stessa udienza del 7 novembre 2012. Una sentenza già scritta, però, ben
prima delle date indicate, in quanto in tale camera di consiglio (dopo aver
tenuto anche regolare udienza pubblica con decine di istanze) i magistrati
avrebbero letto e corretto (a loro dire) i 3 compiti allegati (più di 4 pagine
per tema), valutato e studiato le molteplici questioni giuridiche presentate a
supporto del ricorso. I magistrati amministrativi potranno dire che a loro
insindacabile giudizio il ricorso di Antonio Giangrande va rigettato, ma devono
spiegare a chi in loro pone fiducia, perché un ricorso presentato il 25 luglio
2011, deciso il 7 novembre 2012, viene notificato il 7 febbraio 2013?
Un'attenzione non indifferente e particolare e con un risultato certo e
prevedibile, se si tiene conto che proprio il presidente del Tar era da
considerare incompatibile perchè è stato denunciato dal Giangrande e perché le
sue azioni erano oggetto di inchiesta video e testuale da parte dello stesso
ricorrente? Le gesta del presidente del Tar sono state riportate da Antonio
Giangrande, con citazione della fonte, nella pagina d'inchiesta attinente la
città di Lecce. Come per dire: chi la fa, l'aspetti?
In Italia
tutti sanno che i concorsi pubblici sono truccati e nessuno fa niente, tantomeno
i magistrati. Gli effetti sono che non è la meritocrazia a condurre le sorti del
sistema Italia, ma l’incompetenza e l’imperizia. Non ci credete o vi pare
un’eresia? Basta dire che proprio il Consiglio Superiore della Magistratura,
dopo anni di giudizi amministrativi, è stato costretto ad annullare un concorso
già effettuato per l’accesso alla magistratura. Ed i candidati ritenuti idonei?
Sono lì a giudicare indefessi ed ad archiviare le denunce contro i concorsi
truccati. E badate, tra i beneficiari del sistema, vi sono nomi illustri.
Certo che a
qualcuno può venire in mente che comunque una certa tutela giuridica esiste. Sì,
ma dove? Ma se già il concorso al TAR è truccato. Nel 2008 un consigliere del
Tar trombato al concorso per entrare nel Consiglio di Stato, si è preso la briga
di controllare gli atti del giorno in cui sono state corrette le sue prove,
scoprendo che i cinque commissari avevano analizzato la bellezza di 690 pagine.
“Senza considerare la pausa pranzo e quella della toilette, significa che hanno
letto in media tre pagine e mezzo in 60 secondi. Un record da guinness, visto
che la materia è complessa”, ironizza Alessio Liberati. Che ha impugnato anche i
concorsi del 2006 e del 2007: a suo parere i vincitori hanno proposto
stranamente soluzioni completamente diverse per la stessa identica sentenza. Il
magistrato, inoltre, ha sostenuto che uno dei vincitori, Roberto Giovagnoli, non
aveva nemmeno i titoli per partecipare al concorso. Mentre il Governo rifiuta da
mesi di rispondere alle varie interrogazioni parlamentari sul concorso delle
mogli (il concorso per magistrati Tar vinto da Anna Corrado e Paola Palmarini,
mogli di due membri dell’organo di autogoverno che ne nominò la commissione) si
è svolto un altro – già discusso – concorso per l’accesso al Tar. Nonostante
l’organo di autogoverno dei magistrati amministrativi (Consiglio di Presidenza –
Cpga) si sia stretto in un imbarazzante riserbo, che davvero stride con il
principio di trasparenza che i magistrati del Tar e del Consiglio di Stato sono
preposti ad assicurare controllando l’operato delle altre amministrazioni, tra i
magistrati amministrativi si vocifera che gli elaborati scritti del concorso
sarebbero stati sequestrati per mesi dalla magistratura penale, dopo aver
sorpreso un candidato entrato in aula con i compiti già svolti, il quale avrebbe
già patteggiato la pena. Dopo il patteggiamento la commissione di concorso è
stata sostituita completamente ed è ricominciata la correzione dei compiti. Si è
già scritto della incredibile vicenda processuale del dott. Enrico Mattei,
fratello di Fabio Mattei (oggi membro dell’organo di autogoverno), rimesso “in
pista” nel precedente concorso c.d. delle mogli grazie ad una sentenza del
presidente del Tar Lombardia, assolutamente incompetente per territorio, che,
prima di andare in pensione coinvolto dallo scandalo della c.d. cricca, si era
autoassegnato il ricorso ed aveva ammesso a partecipare al concorso il Mattei,
redigendo addirittura una sentenza breve (utilizzabile solo in caso di manifesta
fondatezza), poco dopo stroncata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 6190/2008),
che ha rilevato perfino l’appiattimento lessicale della motivazione della
decisione rispetto alle memorie difensive presentate dal Mattei. Dopo il
concorso delle mogli e il caso Mattei, un altro concorso presieduto da Pasquale
De Lise è destinato a far parlare di sé. Si sono infatti concluse le prove
scritte del concorso per 4 posti a consigliere di Stato, presieduto da una
altisonante commissione di concorso: il presidente del Consiglio di Stato
(Pasquale De Lise), il presidente aggiunto del Consiglio di Stato (Giancarlo
Coraggio), il presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
regione Sicilia (Riccardo Virgilio), il preside della facoltà di giurisprudenza
(Carlo Angelici) ed un presidente di sezione della Corte di Cassazione (Luigi
Antonio Rovelli). Ma anche il concorso al Consiglio di Stato non è immune da
irregolarità. Tantissime le violazioni di legge già denunciate all’organo di
autogoverno: area toilettes non sigillata e accessibile anche da avvocati e
magistrati durante le prove di concorso, ingresso a prove iniziate di pacchi non
ispezionati e asseritamente contenenti cibi e bevande, ingresso di estranei
nella sala durante le prove di concorso, uscita dei candidati dalla sala prima
delle due ore prescritte dalla legge, mancanza di firma estesa dei commissari di
concorso sui fogli destinati alle prove, presenza di un solo commissario in
aula. Tutti vizi, questi, in grado di mettere a rischio la validità delle prove.
Qual è l’organo deputato a giudicare, in caso di ricorso, sulla regolarità del
concorso per consigliere di Stato? Il Consiglio di Stato… naturalmente! Ecco
perché urge una riforma dei concorsi pubblici. Riforma dove le lobbies e le
caste non ci devono mettere naso. E c’è anche il rimedio. Niente esame di
abilitazione. Esame di Stato contestuale con la laurea specialistica. Attività
professionale libera con giudizio del mercato e assunzione pubblica per nomina
del responsabile politico o amministrativo che ne risponde per lui (nomina
arbitraria così come di fatto è già oggi). E’ da vent’anni che Antonio
Giangrande studia il fenomeno dei concorsi truccati. Anche la fortuna fa parte
del trucco, in quanto non è tra i requisiti di idoneità. Qualcuno si
scandalizzerà. Purtroppo non sono generalizzazioni, ma un dato di fatto. E da
buon giurista, consapevole del fatto che le accuse vanno provate, pur in una
imperante omertà e censura, l’ha fatto. In video ed in testo. Se non basta ha
scritto un libro, tra i 50, da leggere gratuitamente su
www.controtuttelemafie.it
o su Google libri o in ebook su Amazon.it o cartaceo su Lulu.com. Invitando ad
informarsi tutti coloro che, ignoranti o in mala fede, contestano una verità
incontrovertibile, non rimane altro che attendere: prima o poi anche loro si
ricrederanno e ringrazieranno iddio che esiste qualcuno con le palle che non ha
paura di mettersi contro Magistrati ed avvocati. E sappiate, in tanti modi
questi cercano di tacitare Antonio Giangrande, con l’assistenza dei media
corrotti dalla politica e dall’economia e genuflessi al potere. Ha perso le
speranze. I praticanti professionali sono una categoria incorreggibile: “so
tutto mi”, e poi non sanno un cazzo, pensano che essere nel gota, ciò garantisca
rispetto e benessere. Che provino a prendere in giro chi non li conosce. La
quasi totalità è con le pezze al culo e genuflessi ai Magistrati. Come avvoltoi
a buttarsi sulle carogne dei cittadini nei guai e pronti a vendersi al miglior
offerente. Non è vero? Beh! Chi esercita veramente sa che nei Tribunali, per
esempio, vince chi ha più forza dirompente, non chi è preparato ed ha ragione.
Amicizie e corruttele sono la regola. Naturalmente per parlare di ciò, bisogna
farlo con chi lavora veramente, non chi attraverso l’abito, cerca di fare il
monaco.
Un esempio per
tutti di come si legifera in Parlamento, anche se i media lo hanno sottaciuto.
La riforma forense, approvata con Legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra gli ultimi
interventi legislativi consegnatici frettolosamente dal Parlamento prima di
cessare di fare danni. I nonni avvocati in Parlamento (compresi i comunisti)
hanno partorito, in previsione di un loro roseo futuro, una contro riforma fatta
a posta contro i giovani. Ai fascisti che hanno dato vita al primo
Ordinamento forense (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 - Ordinamento della
professione di avvocato e di procuratore convertito con la legge 22 gennaio 1934
n.36) questa contro riforma reazionaria gli fa un baffo. Trattasi di
una “riforma”, scritta come al solito negligentemente, che non viene in alcun
modo incontro ed anzi penalizza in modo significativo i giovani.
In tema di
persecuzione giudiziaria, vi si racconta una favola e per tale prendetela.
C‘era una
volta in un paese ridente e conosciuto ai più come il borgo dei sognatori, un
vecchietto che andava in bicicletta per la via centrale del paese. Il vecchietto
non era quello che in televisione indicano come colui che buttava le bambine nei
pozzi. In quel frangente di tempo una sua coetanea, avendo parcheggiato l’auto
in un tratto di strada ben visibile, era in procinto di scendere, avendo aperto
la portiera. Ella era sua abitudine, data la sua tarda età, non avere una sua
auto, ma usare l’auto della nipote o quella simile del fratello. Auto identiche
in colore e marca. Il vecchietto, assorto nei suoi pensieri, investe lo
sportello aperto dell’auto e cade. Per sua fortuna, a causa della bassa velocità
tenuta, la caduta è indolore. Assicurato alla signora che nulla era accaduto, il
vecchietto inforca la bicicletta e va con le sue gambe. Dopo poco tempo arriva
alla signora da parte del vecchietto una richiesta di risarcimento danni, su
mandato dato allo studio legale di sua figlia. L’assicurazione considera che sia
inverosimile la dinamica indicata ed il danno subito e ritiene di non pagare.
Dopo due anni
arriva una citazione da parte di un’altro avvocato donna. Una richiesta per
danni tanto da farsi ricchi. Ma non arriva alla vecchietta, ma a sua nipote.
Essa indica esattamente l’auto, la zona del sinistro e la conducente, accusando
la nipote di essere la responsabile esclusiva del sinistro.
E peccato,
però, che nessun testimone in giudizio ha riconosciuto la targa, pur posti a
pochi metri del fatto; che nessun testimone in giudizio ha riconosciuto l’auto
distinguendola da quella simile; che nessun testimone in giudizio ha
disconosciuto la vecchietta come protagonista; che nessun testimone in giudizio
ha ammesso che vi siano stati conseguenze per la caduta.
E peccato,
però, che l’auto non era in curva, come da essa indicato.
Peccato, però,
che la responsabile del sinistro non fosse quella chiamata in giudizio, ma la
vecchietta di cui sopra.
Una prima
volta sbaglia il giudice competente ed allora cambia l’importo, riproponendo la
domanda.
Tutti i
giudici di pace ed onorari (avvocati) fanno vincere la causa del sinistro
fantasma alla collega.
La tapina
chiamata in causa afferma la sua innocenza e presenta una denuncia contro
l’avvocato. La poveretta, che poteva essere querelata per lesioni gravissime, si
è cautelata. La sua denuncia è stata archiviata, mentre contestualmente, alla
stessa ora, i testimoni venivano sentiti alla caserma dei carabinieri.
La poveretta
non sapeva che l’avvocato denunciato era la donna del pubblico ministero, il cui
ufficio era competente sulla denuncia contro proprio l’avvocato.
Gli amorosi
cosa hanno pensato per tacitare chi ha osato ribellarsi? L’avvocato denuncia per
calunnia la poveretta, ingiustamente accusata del sinistro, la procura la
persegue e gli amici giudici la condannano.
L’appello
sacrosanto non viene presentato dagli avvocati, perché artatamente ed in
collusione con la contro parte sono fatti scadere i termini. L’avvocato amante
del magistrato altresì chiede ed ottiene una barca di soldi di danni morali.
La poveretta
ha due fratelli: uno cattivo, amico e succube di magistrati ed avvocati, che le
segue le sue cause e le perde tutte: uno buono che è conosciuto come il
difensore dei deboli contro i magistrati e gli avvocati. I magistrati le tentano
tutte per condannarlo: processi su processi. Ma non ci riescono, perché è
innocente e le accuse sono inventate. L’unica sua colpa è ribellarsi alle
ingiustizie su di sé o su altri. Guarda caso il fratello buono aveva denunciato
il magistrato amante dell’avvocato donna di cui si parla. Magistrato che ha
archiviato la denuncia contro se stesso.
La procura ed
i giudici accusano anche il fratello buono di aver presentato una denuncia
contro l’avvocato e di aver fatto conoscere la malsana storia a tutta l’Italia.
Per anni si cerca la denuncia: non si trova. Per anni si riconduce l’articolo a
lui: non è suo.
Il paradosso è
che si vuol condannare per un denuncia, che tra tante, è l’unica non sua.
Il paradosso è
che si vuol condannare per un articolo, che tra tanti (è uno scrittore), è
l’unico non suo e su spazio web, che tra tanti, non è suo.
Se non si può
condannare, come infangare la sua credibilità? Dopo tanti e tanti anni si fa
arrivare il conto con la prescrizione e far pagare ancora una volta la tangente
per danni morali all’avvocato donna, amante di magistrati.
Questa è il
finale triste di un favola, perché di favola si tratta, e la morale cercatevela
voi.
Ed in fatto di
mafia c’è qualcuno che la sa lunga. «Io non cercavo nessuno, erano loro che
cercavano me….Mi hanno fatto arrestare Provenzano e Ciancimino, non come dicono,
i carabinieri……Di questo papello non ne sono niente….Il pentito Giovanni Brusca
non ha fatto tutto da solo, c'è la mano dei servizi segreti. La stessa cosa vale
anche per l'agenda rossa. Ha visto cosa hanno fatto? Perchè non vanno da quello
che aveva in mano la borsa e si fanno consegnare l'agenda. In via D'Amelio
c'erano i servizi……. Io sono stato 25 anni latitante in campagna senza che
nessuno mi cercasse. Com'è possibile che sono responsabile di tutte queste cose?
La vera mafia sono i magistrati e i politici che si sono coperti tra di loro.
Loro scaricano ogni responsabilità sui mafiosi. La mafia quando inizia una cosa
la porta a termine. Io sto bene. Mi sento carico e riesco a vedere oltre queste
mura……Appuntato, lei mi vede che possa baciare Andreotti? Le posso dire che era
un galantuomo e che io sono stato dell'area andreottiana da sempre». Le
confidenze fatte da Toto Riina, il capo dei capi, sono state fatte in due
diverse occasioni, a due guardie penitenziarie del Gom del carcere Opera di
Milano. Il dialogo tra polizia penitenziaria e l'ex numero uno della mafia, è
avvenuto lo scorso 31 maggio 2013, durante la pausa di un'udienza alla quale il
boss partecipava in teleconferenza. Queste frasi sono contenute in una relazione
di servizio stilata dagli agenti del Gom, il gruppo speciale della polizia
penitenziaria che si occupa della gestione dei detenuti eccellenti. La relazione
è stata inviata ai magistrati della Procura di Palermo che si occupano della
trattativa Stato-mafia, Nino Di Matteo, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia.
La legge forse
è uguale per tutti, le toghe certamente no. Ci sono quelle buone e quelle
cattive. Ci sono i giudici e i pm da una parte e gli avvocati dall'altra. Il
Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri al convegno di Confindustria del
2 luglio 2013 risponde senza peli sulla lingua alla domanda del direttore del Tg
de La7 Enrico Mentana , su chi sia al lavoro per frenare le riforme: «gli
avvocati... le grandi lobby che impediscono che il Paese diventi normale». Così
come è altrettanto diretta quando Mentana le chiede se nel governo c’è una unità
di intenti sulla giustizia: «non c’è un sentimento comune, o meglio c’è solo a
parole», dice, spiegando che «quando affrontiamo il singolo caso, scattano i
campanilismi e le lobby». Magari ha ragione lei. Forse esiste davvero la lobby
degli azzeccagarbugli, scrive Salvatore Tramontano su “Il Giornale”. Ogni
categoria fa nel grande gioco del potere la sua partita. Non ci sono, però, solo
loro. Il Guardasigilli, ex Ministro dell’Interno ed ex alto burocrate come ex
Prefetto non si è accorto che in giro c'è una lobby molto più forte, un Palazzo,
un potere che da anni sogna di sconfinare e che fa dell'immobilismo la sua
legge, tanto da considerare qualsiasi riforma della giustizia un attentato alla
Costituzione. No, evidentemente no.
Oppure il
ministro fa la voce grossa con le toghe piccole, ma sta bene attenta a non
infastidire i mastini di taglia grossa. La lobby anti riforme più ostinata e
pericolosa è infatti quella dei dottor Balanzone, quella con personaggi grassi e
potenti. È la Lobby ed anche Casta dei magistrati. Quella che se la tocchi
passi guai, e guai seri. Quella che non fa sconti. Quella che ti dice: subisci e
taci. Quella che non si sottopone alla verifica pisco-fisica-attitudinale.
Quella vendicativa. Quella che appena la sfiori ti inquisisce per lesa maestà. È
una lobby così minacciosa che perfino il ministro della Giustizia non se la
sente neppure di nominarla. Come se al solo pronunciarla si evocassero anatemi e
disgrazie. È un'ombra che mette paura, tanto che la sua influenza agisce perfino
nell'inconscio. Neanche in un fuori onda la Cancellieri si lascia scappare il
nome della gran casta. È una censura preventiva per vivere tranquilli. Maledetti
avvocati, loro portano la scusa. Ma chi soprattutto non vuole riformare la
giustizia in Italia ha un nome e un cognome: magistratura democratica. Quella
delle toghe rosse. Dei comunisti che dovrebbero tutelare i deboli contro i
potenti.
Ma si sa in
Italia tutti dicono: “tengo famiglia e nudda sacciu, nudda vidi, nudda sentu”.
I magistrati,
diceva Calamandrei, sono come i maiali. Se ne tocchi uno gridano tutti. Non puoi
metterti contro la magistratura, è sempre stato così, è una corporazione.
In tema di
Giustizia l'Italia è maglia nera in Europa. In un anno si sono impiegati 564
giorni per il primo grado in sede civile, contro una media di 240 giorni
nei Paesi Ocse. Il tempo medio per la conclusione di un procedimento civile nei
tre gradi di giudizio si attesta sui 788 giorni. Non se la passa meglio
la giustizia penale: la sua lentezza è la causa principale di sfiducia nella
giustizia (insieme alla percezione della mancata indipendenza dei magistrati e
della loro impunità, World Economic Forum). La durata media di un processo
penale, infatti, tocca gli otto anni e tre mesi, con punte di oltre 15
anni nel 17% dei casi. Ora, tale premessa ci sbatte in faccia una cruda realtà. Per
Silvio Berlusconi la giustizia italiana ha tempi record, corsie preferenziali e
premure impareggiabili. Si prenda ad esempio il processo per i diritti
televisivi: tre gradi di giudizio in nove mesi, una cosa del genere non si è mai
vista in Italia. Il 26 ottobre 2012 i giudici del Tribunale di Milano
hanno condannato Silvio Berlusconi a quattro anni di reclusione, una pena più
dura di quella chiesta dalla pubblica accusa (il 18 giugno 2012 i PM Fabio De
Pasquale e Sergio Spadaro chiedono al giudice una condanna di 3 anni e 8 mesi
per frode fiscale di 7,3 milioni di euro). Il 9 novembre 2012 Silvio Berlusconi,
tramite i suoi legali, ha depositato il ricorso in appello. L'8 maggio 2013
la Corte d'Appello di Milano conferma la condanna di 4 anni di reclusione, 5
anni di interdizione dai pubblici uffici e 3 anni dagli uffici direttivi. Il 9
luglio 2013 la Corte di Cassazione ha fissato al 30 luglio 2013 l'udienza
del processo per frode fiscale sui diritti Mediaset. Processo pervenuto
in Cassazione da Milano il 9 luglio con i ricorsi difensivi depositati il 19
giugno. Per chi se ne fosse scordato - è facile perdere il conto tra i 113
procedimenti (quasi 2700 udienze) abbattutisi sull'ex premier dalla sua
discesa in campo, marzo 1994 - Berlusconi è stato condannato in primo grado e in
appello a quattro anni di reclusione e alla pena accessoria di cinque anni di
interdizione dai pubblici uffici. Secondo i giudici, l'ex premier sarebbe
intervenuto per far risparmiare a Mediaset tre milioni di imposte nel 2002-2003.
Anni in cui, per quanto vale, il gruppo versò all'erario 567 milioni di tasse.
I legali di Berlusconi avranno adesso appena venti giorni di tempo per
articolare la difesa. «Sono esterrefatto, sorpreso, amareggiato» dichiara Franco
Coppi. Considerato il migliore avvocato cassazionista d'Italia, esprime la sua
considerazione con la sua autorevolezza e il suo profilo non politicizzato: «Non
si è mai vista un'udienza fissata con questa velocità», che «cade tra capo e
collo» e «comprime i diritti della difesa». Spiega: «Noi difensori dovremo fare
in 20 giorni quello che pensavamo di fare con maggior respiro». Tutto perché?
«Evidentemente - ragiona Coppi -, la Cassazione ha voluto rispondere a chi
paventava i rischi della prescrizione intermedia. Ma di casi come questo se ne
vedono molti altri e la Suprema Corte si limita a rideterminare la pena, senza
andare ad altro giudice. Al di là degli aspetti formali, sul piano sostanziale,
dover preparare una causa così rinunciando a redigere motivi nuovi, perché i
tempi non ci sono, significa un'effettiva diminuzione delle possibilità di
difesa». Il professore risponde così anche all'Anm che definisce «infondate» le
polemiche e nega che ci sia accanimento contro il Cavaliere.
113
procedimenti.
Tutto iniziò
nel 1994 con un avviso di garanzia (poi dimostratosi infondato) consegnato a
mezzo stampa dal Corriere della Sera durante il G8 che si teneva a Napoli. Alla
faccia del segreto istruttorio. E’ evidentemente che non una delle centinaia di
accuse rivoltegli contro era fondata. Nessun criminale può farla sempre franca
se beccato in castagna. E non c’è bisogno di essere berlusconiano per affermare
questo.
E su come ci
sia commistione criminale tra giornali e Procure è lo stesso Alessandro
Sallusti che si confessa. In un'intervista al Foglio di
Giuliano Ferrara, il direttore de Il Giornale racconta
i suoi anni al Corriere della Sera, e il suo rapporto con Paolo
Mieli: «Quando pubblicammo l'avviso di garanzia che poi avrebbe fatto
cadere il primo governo di Silvio Berlusconi, ero felicissimo. Era uno
scoop pazzesco. E lo rifarei. Ma si tratta di capire perché certe
notizie te le passano. Sin dai tempi di Mani pulite il Corriere aveva
due direttori, Mieli e Francesco Saverio Borrelli, il
procuratore capo di Milano. I magistrati ci passavano le notizie, con una
tempistica che serviva a favorire le loro manovre. Mi ricordo bene la notte in
cui pubblicammo l'avviso di garanzia a Berlusconi.
Fu una giornata bestiale, Mieli a un certo punto, nel pomeriggio, sparì. Poi
piombò all'improvviso nella mia stanza, fece chiamare Goffredo Buccini e
Gianluca Di Feo, che firmavano il pezzo, e ci disse, pur con una certa dose di
insicurezza, di scrivere tutto, che lo avremmo pubblicato. Parlava con un tono
grave, teso. Quella notte, poi, ci portò in pizzeria, ci disse che aveva già
scritto la lettera di dimissioni, se quello che avevamo non era vero sarebbero
stati guai seri. Diceva di aver parlato con Agnelli e poi anche con il
presidente Scalfaro. Ma poi ho ricostruito che non era così, non li aveva
nemmeno cercati, secondo me lui pendeva direttamente dalla procura di Milano».
Si potrebbe
sorridere al fatto che i processi a Silvio Berlusconi, nonostante cotanto di
principi del foro al seguito, innalzino sensibilmente la media nazionale dello
sfascio della nostra giustizia. Ma invece la domanda, che fa capolino e che
sorge spontanea, è sempre la stessa: come possiamo fidarci di "questa"
giustizia, che se si permette di oltraggiare se stessa con l’uomo più potente
d’Italia, cosa potrà fare ai poveri cristi? La memoria corre a quel film di Dino
Risi, "In nome del popolo italiano", 1971. C'è il buono, il magistrato
impersonato da Tognazzi. E poi c'è il cialtrone, o presunto tale, che è uno
strepitoso Gassman. Alla fine il buono fa arrestare il cialtrone, ma per una
cosa che non ha fatto, per un reato che non ha commesso. Il cialtrone è
innocente, ma finalmente è dentro.
Ciononostante
viviamo in un’Italia fatta così, con italiani fatti così, bisogna subire e
tacere. Questo ti impone il “potere”. Ebbene, si faccia attenzione alle parole
usate per prendersela con le ingiustizie, i soprusi e le sopraffazioni, le
incapacità dei governati e l’oppressione della burocrazia,i disservizi, i
vincoli, le tasse, le code e la scarsezza di opportunità del Belpaese. Perché
sfogarsi con il classico "Italia paese di merda", per quanto
liberatorio, non può essere tollerato dai boiardi di Stato. E' reato, in
quanto vilipendio alla nazione. Lo ha certificato la Corte di cassazione -
Sezione I penale - Sentenza 4 luglio 2013 n. 28730. Accadde che un vigile, a
Montagnano, provincia di Campobasso, nel lontano 2 novembre 2005
fermò un uomo di 70 anni: la sua auto viaggiava con un solo faro acceso. Ne
seguì una vivace discussione tra il prossimo multato e l'agente. Quando
contravvenzione fu, il guidatore si lasciò andare al seguente sfogo: "Invece di
andare ad arrestare i tossici a Campobasso, pensate a fare queste stronzate e
poi si vedono i risultati. In questo schifo di Italia di merda...". Il vigile
zelante prese nota di quella frase e lo denunciò. Mille euro di multa -
In appello, il 26 aprile del 2012, per il viaggiatore senza faro che
protestò aspramente contro la contravvenzione
arrivò la condanna, pena interamente coperta da
indulto. L'uomo decise così di rivolgersi alla Cassazione. La sentenza poi
confermata dai giudici della prima sezione penale del Palazzaccio. Il verdetto:
colpevole di "vilipendio alla nazione". Alla multa di ormai
otto anni fa per il faro spento, si aggiunge quella - salata - di mille
euro per l'offesa al tricolore. L'uomo si era difeso sostenendo che non
fosse sua intenzione offendere lo Stato e appellandosi al "diritto alla libera
manifestazione di pensiero". «Il diritto di manifestare il proprio pensiero in
qualsiasi modo - si legge nella sentenza depositata - non può trascendere in
offese grossolane e brutali prive di alcuna correlazione con una critica
obiettiva»: per integrare il reato, previsto dall'articolo 291 del codice
penale, «è sufficiente una manifestazione generica di vilipendio alla nazione,
da intendersi come comunità avente la stessa origine territoriale, storia,
lingua e cultura, effettuata pubblicamente». Il reato in esame, spiega la
Suprema Corte, «non consiste in atti di ostilità o di violenza o in
manifestazioni di odio: basta l'offesa alla nazione, cioè un'espressione di
ingiuria o di disprezzo che leda il prestigio o l'onore della collettività
nazionale, a prescindere dai vari sentimenti nutriti dall'autore». Il
comportamento dell'imputato, dunque, che «in luogo pubblico, ha inveito contro
la nazione», gridando la frase “incriminata”, «sia pure nel contesto di
un'accesa contestazione elevatagli dai carabinieri per aver condotto
un'autovettura con un solo faro funzionante, integra - osservano gli “ermellini”
- il delitto di vilipendio previsto dall'articolo 291 cp, sia nel profilo
materiale, per la grossolana brutalità delle parole pronunciate pubblicamente,
tali da ledere oggettivamente il prestigio o l'onore della collettività
nazionale, sia nel profilo psicologico, integrato dal dolo generico, ossia dalla
coscienza e volontà di proferire, al cospetto dei verbalizzanti e dei numerosi
cittadini presenti sulla pubblica via nel medesimo frangente, le menzionate
espressioni di disprezzo, a prescindere dai veri sentimenti nutriti dall'autore
e dal movente, nella specie di irata contrarietà per la contravvenzione subita,
che abbia spinto l'agente a compiere l'atto di vilipendio».
A questo punto
ognuno di noi ammetta e confessi che, almeno per un volta nella sua vita, ha
proferito la fatidica frase “che schifo questa Italia di merda” oppure “che
schifo questi italiani di merda”.
Bene, allora
cari italiani: TUTTI DENTRO, CAZZO!!
Non sarà la
mafia a uccidermi ma alcuni miei colleghi magistrati (Borsellino). La verità
sulle stragi non la possiamo dire noi Magistrati ma la deve dire la politica se
non proprio la storia (Ingroia). Non possiamo dire la verità sulle stragi
altrimenti la classe politica potrebbe non reggere (Gozzo). Non sono stato io a
cercare loro ma loro a cercare me (Riina). In Italia mai nulla è come appare.
Ipocriti e voltagabbana. Le stragi come eccidi di Stato a cui non è estranea la
Magistratura e e gran parte della classe politica del tempo tranne quei pochi
che ne erano i veri destinatari (Craxi e Forlani) e quei pochissimi che si
rifiutarono di partecipare al piano stragista (Andreotti Lima e Mannino) e che
per questo motivo furono assassinati o lungamente processati. La Sinistra non di
governo sapeva. La Sinistra Democristiana ha partecipato al piano stragista fino
all'elezione di Scalfaro poi ha cambiato rotta. I traditori di Craxi e la destra
neofascista sono gli artefici delle stragi. Quelli che pensavamo essere i peggio
erano i meglio. E quelli che pensavamo essere i meglio erano i peggio. In questo
contesto non si può cercare dai carabinieri Mario Mori e Mario Obinu che
comunque dipendevano dal Ministero degli Interni e quindi dal Potere Politico,
un comportamento lineare e cristallino.
Ed a proposito
del “TUTTI DENTRO”, alle toghe milanesi Ruby non basta mai. Un gigantesco terzo
processo per il caso Ruby, dove sul banco degli imputati siedano tutti quelli
che, secondo loro, hanno cercato di aiutare Berlusconi a farla franca:
poliziotti, agenti dei servizi segreti, manager, musicisti, insomma quasi tutti
i testimoni a difesa sfilati davanti ai giudici. Anche Ruby, colpevole di avere
negato di avere fatto sesso con il Cavaliere. Ma anche i suoi difensori storici,
Niccolò Ghedini e Piero Longo. E poi lui medesimo, Berlusconi. Che della opera
di depistaggio sarebbe stato il regista e il finanziatore. I giudici con questa
decisione mandano a dire (e lo renderanno esplicito nelle motivazioni) che
secondo loro in aula non si è assistito semplicemente ad una lunga serie di
false testimonianze, rese per convenienza o sudditanza, ma all'ultima puntata di
un piano criminale architettato ben prima che lo scandalo esplodesse, per
mettere Berlusconi al riparo dalle sue conseguenze. Corruzione in atti
giudiziari e favoreggiamento, questi sono i reati che i giudici intravedono
dietro quanto è accaduto. Per l'operazione di inquinamento e depistaggio la
sentenza indica una data di inizio precisa: il 6 ottobre 2010, quando Ruby viene
a Milano insieme al fidanzato Luca Risso e incontra l'avvocato Luca Giuliante,
ex tesoriere del Pdl, al quale riferisce il contenuto degli interrogatori che ha
già iniziato a rendere ai pm milanesi. I giudici del processo a Berlusconi
avevano trasmesso gli atti su quell'incontro all'Ordine degli avvocati,
ritenendo di trovarsi davanti a una semplice violazione deontologica. Invece la
sentenza afferma che fu commesso un reato, e che insieme a Giuliante ne devono
rispondere anche Ghedini e Longo. E l'operazione sarebbe proseguita a gennaio,
quando all'indomani delle perquisizioni e degli avvisi di garanzia, si tenne una
riunione ad Arcore tra Berlusconi e alcune delle «Olgettine» che erano state
perquisite. Berlusconi come entra in questa ricostruzione? Essendo imputato nel
processo, il Cavaliere non può essere accusato né di falsa testimonianza né di
favoreggiamento. La sua presenza nell'elenco vuol dire che per i giudici le
grandi manovre compiute tra ottobre e gennaio si perfezionarono quando
Berlusconi iniziò a stipendiare regolarmente le fanciulle coinvolte
nell'inchiesta. Corruzione di testimoni, dunque. Ghedini e Longo ieri reagiscono
con durezza, definendo surreale la mossa dei giudici e spiegando che gli
incontri con le ragazze erano indagini difensive consentite dalla legge. Ma la
nuova battaglia tra Berlusconi e la Procura di Milano è solo agli inizi. D’altra
parte anche Bari vuol dire la sua sulle voglie sessuali di Berlusconi. Silvio
Berlusconi avrebbe pagato l'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini tramite il
faccendiere Walter Lavitola, perchè nascondesse dinanzi ai magistrati la verità
sulle escort portate alle feste dell’ex premier. Ne è convinta la procura di
Bari che ha notificato avvisi di conclusioni delle indagini sulle presunte
pressioni che Berlusconi avrebbe esercitato su Tarantini perchè lo coprisse
nella vicenda escort. Nell’inchiesta Berlusconi e Lavitola sono indagati per
induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria. Secondo
quanto scrivono alcuni quotidiani, l’ex premier avrebbe indotto Tarantini a
tacere parte delle informazioni di cui era a conoscenza e a mentire nel corso
degli interrogatori cui è stato sottoposto dai magistrati baresi (tra luglio e
novembre 2009) che stavano indagando sulla vicenda escort. In cambio avrebbe
ottenuto complessivamente mezzo milione di euro, la promessa di un lavoro e la
copertura delle spese legali per i processi. Secondo l’accusa, Tarantini avrebbe
mentito, tra l'altro, negando che Berlusconi fosse a conoscenza che le donne che
Gianpy reclutava per le sue feste erano escort. Sono indagati Berlusconi e
Lavitola, per induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria.
Comunque
torniamo alle condanne milanesi. Dopo il processo Ruby 1, concluso con la
condanna in primo grado di Silvio Berlusconi a 7 anni, ecco il
processo Ruby 2, con altri 7 anni di carcere per Emilio Fede e
Lele Mora e 5 per Nicole Minetti. Ma
attenzione, perché si parlerà anche del processo Ruby 3, perché
come accaduto con la Corte che ha giudicato il Cav anche quella che ha
condannato Fede, Mora e Minetti per induzione e favoreggiamento della
prostituzione ha stabilito la trasmissione degli atti al pm per valutare
eventuali ipotesi di reato in relazione alle indagini difensive. Nel mirino ci
sono, naturalmente, Silvio Berlusconi, i suoi legali Niccolò Ghedini
e Piero Longo e la stessa Karima el Mahroug,
in arte Ruby. Come accaduto per il Ruby 1 anche per il Ruby 2 il profilo penale
potrebbe essere quello della falsa testimonianza. La procura,
rappresentata dal pm Antonio Sangermano e dall’aggiunto Piero Forno, per gli
imputati aveva chiesto sette anni di carcere per induzione e favoreggiamento
della prostituzione anche minorile. Il processo principale si era concluso con
la condanna a sette anni di reclusione per Silvio Berlusconi, accusato di
concussione e prostituzione minorile. Durante la requisitoria l’accusa aveva
definito le serate di Arcore “orge bacchiche”. Secondo gli inquirenti sono in
tutto 34 le ragazze che sono state indotte a prostituirsi durante le serate ad
Arcore per soddisfare, come è stato chiarito in requisitoria, il “piacere
sessuale” del Cavaliere. Serate che erano “articolate” in tre fasi: la prima
“prevedeva una cena”, mentre la seconda “definita ‘bunga bunga’” si svolgeva
“all’interno di un locale adibito a discoteca, dove le partecipanti si esibivano
in mascheramenti, spogliarelli e balletti erotici, toccandosi reciprocamente
ovvero toccando e facendosi toccare nelle parti intime da Silvio Berlusconi”. La
terza fase riguardava infine la conclusione della serata e il suo proseguimento
fino alla mattina dopo: consisteva, scrivono i pm, “nella scelta, da parte di
Silvio Berlusconi, di una o più ragazze con cui intrattenersi per la notte in
rapporti intimi, persone alle quali venivano erogate somme di denaro ed altre
utilità ulteriori rispetto a quelle consegnate alle altre partecipanti”. A
queste feste, per 13 volte (il 14, il 20, il 21, il 27 e il 28 febbraio, il 9
marzo, il 4, il 5, il 24, il 25 e il 26 aprile, e l’1 e il 2 maggio del 2010)
c’era anche Karima El Mahroug, in arte Ruby Rubacuori, non ancora 18enne. La
ragazza marocchina, in base all’ipotesi accusatoria, sarebbe stata scelta da
Fede nel settembre del 2009 dopo un concorso di bellezza in Sicilia, a Taormina,
dove lei era tra le partecipanti e l’ex direttore del Tg4 uno dei componenti
della giuria. Secondo le indagini, andò ad Arcore la prima volta accompagnata da
Fede con una macchina messa a disposizione da Mora. Per i pm, però, ciascuno dei
tre imputati, in quello che è stato chiamato “sistema prostitutivo”, aveva un
ruolo ben preciso. Lele Mora “individuava e selezionava”, anche insieme a Emilio
Fede, “giovani donne disposte a prostituirsi” nella residenza dell’ex capo del
Governo scegliendole in alcuni casi “tra le ragazze legate per motivi
professionali all’agenzia operante nel mondo dello spettacolo” gestita dall’ex
agente dei vip. Inoltre Mora, come Fede, “organizzava” in alcune occasioni
“l’accompagnamento da Milano ad Arcore” di alcune delle invitate alla serate
“mettendo a disposizione le proprie autovetture”, con tanto di autista. I pm in
requisitoria hanno paragonato Mora e Fede ad “assaggiatori di vini pregiati”,
perché valutavano la gradevolezza estetica delle ragazze e le sottoponevano a
“un minimo esame di presentabilità socio-relazionale”, prima di immetterle nel
“circuito” delle cene. Nicole Minetti, invece, avrebbe fatto da intermediaria
per i compensi alle ragazze – in genere girati dal ragionier Giuseppe Spinelli,
allora fiduciario e “ufficiale pagatore” per conto del leader del Pdl – che
consistevano “nella concessione in comodato d’uso” degli appartamenti nel
residence di via Olgettina e “in contributi economici” per il loro mantenimento
o addirittura per il pagamento delle utenze di casa o delle spese mediche fino
agli interventi di chirurgia estetica.
Il rischio di
una sentenza che smentisse quella inflitta a Berlusconi è stato dunque
scongiurato: e di fatto la sentenza del 19 luglio 2013 e quella che del 24
giugno 2013 rifilò sette anni di carcere anche al Cavaliere si sorreggono a
vicenda. Chiamati a valutare sostanzialmente il medesimo quadro di prove, di
testimonianze, di intercettazioni, due tribunali composti da giudici diversi
approdano alle stesse conclusioni. Vengono credute le ragazze che hanno parlato
di festini hard. E non vengono credute le altre, Ruby in testa, che proprio
nell’aula di questo processo venne a negare di avere mai subito avances sessuali
da parte di Berlusconi. La testimonianza di Ruby viene trasmessa insieme a
quella di altri testimoni alla procura perché proceda per falso, insieme a
quella di molti altri testimoni. I giudici, come già successo nel processo
principale, hanno trasmesso gli atti alla Procura perché valutino le
dichiarazioni di 33 testimoni della difesa compresa la stessa Ruby; disposta la
trasmissione degli atti anche per lo stesso Silvio Berlusconi e dei suoi
avvocati: Niccolò Ghedini e Piero Longo per violazione delle indagini difensive.
Il 6-7 ottobre 2010 (prima che scoppiasse lo scandalo) e il 15 gennaio 2011 (il
giorno dopo l’avviso di garanzia al Cavaliere) alcune ragazze furono convocate
ad Arcore, senza dimenticare l’interrogatorio fantasma fatto a Karima. Durante
le perquisizioni in casa di alcune Olgettine erano stati trovati verbali
difensivi già compilati. Vengono trasmessi gli atti alla procura anche perché
proceda nei confronti di Silvio Berlusconi e dei suoi difensori Niccolò Ghedini
e Piero Longo, verificando se attraverso l'avvocato Luca Giuliante abbiano
tentato di addomesticare la testimonianza di Ruby. In particolare la Procura
dovrà valutare la posizione, al termine del processo di primo grado «Ruby bis»
non solo per Silvio Berlusconi, i suoi legali e Ruby, ma anche per altre
ventinove persone. Tra queste, ci sono numerose ragazze ospiti ad Arcore che
hanno testimoniato, tra le quali: Iris Berardi e Barbara Guerra (che all'ultimo
momento avevano ritirato la costituzione di parte civile) e Alessandra
Sorcinelli. Il tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura
della Repubblica anche per il primo avvocato di Ruby, Luca Giuliante. «Inviare
gli atti a fini di indagini anche per il presidente Berlusconi e i suoi
difensori è davvero surreale». Lo affermano i legali di Berlusconi, Niccolò
Ghedini e Piero Longo, in merito alla decisione dei giudici di Milano di
trasmettere gli atti alla procura in relazione alla violazione delle indagini
difensive. «Quando si cerca di esplicare il proprio mandato defensionale in modo
completo, e opponendosi ad eventuali prevaricazioni, a Milano possono
verificarsi le situazioni più straordinarie» proseguono i due avvocati. E
ancora: «La decisione del Tribunale di Milano nel processo cosiddetto Ruby bis
di inviare gli atti per tutti i testimoni che contrastavano la tesi accusatoria
già fa ben comprendere l'atteggiamento del giudicante. Ma inviare gli atti ai
fini di indagini anche per il presidente Berlusconi e per i suoi difensori è
davvero surreale. Come è noto nè il presidente Berlusconi nè i suoi difensori
hanno reso testimonianza in quel processo. Evidentemente si è ipotizzato che vi
sarebbe stata attività penalmente rilevante in ordine alle esperite indagini
difensive. Ciò è davvero assurdo».
La sentenza è
stata pronunciata dal giudice Annamaria Gatto. Ad assistere all'udienza anche
per il Ruby 2, in giacca e cravatta questa volta e non in toga, anche il
procuratore Edmondo Bruti Liberati, che anche in questo caso,
come nel processo a Berlusconi, ha voluto rivendicare in questo modo all'intera
Procura la paternità dell'inchiesta Ruby. Il collegio presieduto da Anna Maria
Gatto e composto da Paola Pendino e Manuela Cannavale è formato da sole donne. Giudici
donne come quelle del collegio del processo principale formato dai giudici
Orsola De Cristofaro, Carmela D'Elia e dal presidente Giulia Turri. Anche la
Turri, come la Gatto, ha deciso anche di rinviare al pm le carte per valutare
l'eventuale falsa testimonianza per le dichiarazioni rese in aula da 33 testi:
una lunga serie di testimoni che hanno sfilato davanti alla corte.
TOGHE ROSA
Dici donna
e dici danno, anzi, "condanno".
È il sistema
automatico che porta il nome di una donna, Giada (Gestione informatica
assegnazioni dibattimentali) che ha affidato il caso della minorenne Karima el
Mahroug, detta Ruby Rubacuori, proprio a quelle tre toghe. Che un processo possa
finire a un collegio tutto femminile non è una stranezza, come gridano i falchi
del Pdl che dopo troppi fantomatici complotti rossi ora accusano la trama rosa:
è solo il segno dell'evoluzione storica di una professione che fino a 50 anni fa
era solo maschile. Tra i giudici del tribunale di Milano oggi si contano 144
donne e 78 uomini: quasi il doppio.
Donna è
anche Ilda Boccassini,
che rappresentava l’accusa contro Berlusconi. Tutti hanno sentito le parole di
Ilda Boccassini: "Ruby è furba di quella furbizia orientale propria della sua
origine". «E' una giovane di furbizia orientale che come molti dei giovani delle
ultime generazioni ha come obbiettivo entrare nel mondo spettacolo e fare soldi,
il guadagno facile, il sogno italiano di una parte della gioventù che non ha
come obiettivo il lavoro, la fatica, lo studio ma accedere a meccanismi che
consentano di andare nel mondo dello spettacolo, nel cinema. Questo obiettivo -
ha proseguito la Boccassini - ha accomunato la minore "con le ragazze che sono
qui sfilate e che frequentavano la residenza di Berlusconi: extracomunitarie,
prostitute, ragazze di buona famiglia anche con lauree, persone che hanno un
ruolo nelle istituzioni e che pure avevano un ruolo nelle serate di Arcore come
la europarlamentare Ronzulli e la europarlamentare Rossi. In queste serate -
afferma il pm - si colloca anche il sogno di Kharima. Tutte, a qualsiasi prezzo,
dovevano avvicinare il presidente del Consiglio con la speranza o la certezza di
ottenere favori, denaro, introduzione nel mondo dello spettacolo».
Dovesse mai
essere fermata un'altra Ruby, se ne occuperebbe lei. Il quadro in rosa a tinta
forte si completa con il gip Cristina Di Censo, a cui il computer
giudiziario ha affidato l'incarico di rinviare a "giudizio immediato"
Berlusconi, dopo averle fatto convalidare l'arresto di Massimo Tartaglia, il
folle che nel 2010 lo ferì al volto con una statuetta del Duomo. Per capirne la
filosofia forse basta la risposta di una importante giudice di Milano a una
domanda sulla personalità di queste colleghe: «La persona del magistrato non ha
alcuna importanza: contano solo le sentenze. È per questo che indossiamo la
toga».
Donna di
carattere anche Annamaria Fiorillo, il magistrato dei minori che,
convocata dal tribunale, ha giurato di non aver mai autorizzato l'affidamento
della minorenne Ruby alla consigliera regionale del Pdl Nicole Minetti e
tantomeno alla prostituta brasiliana Michelle Conceicao. Per aver smentito
l'opposta versione accreditata dall'allora ministro Roberto Maroni, la pm si è
vista censurare dal Csm per "violazione del riserbo".
Ruby 2, chi
sono le tre giudicesse che hanno condannato Mora, Fede e la Minetti, e trasmesso
gli atti per far condannare Berlusconi, i suoi avvocati e tutti i suoi
testimoni? Anna Maria Gatto, Paola Pendino e Manuela Cannavale. Si assomigliano
molto anche nel look alle loro colleghe del Ruby 1.
Anna Maria Gatto si ricorda
per una battuta.
La
testimone Lisa Barizonte, sentita in aula, rievoca le confidenze tra
lei e Karima El Mahrough, alias Ruby. In particolare il giudice
le chiede di un incidente con l’olio bollente. La teste conferma: “Mi
disse che lo zio le fece cadere addosso una pentola di olio bollente”.
“Chi era lo zio? Mubarak?”, chiede Anna Maria Gatto strappando
un sorriso ai presenti in aula. Ironia che punta dritta al
centro dello scandalo. La teste, sottovoce, risponde: “No, non l’ha detto”.
Annamaria Gatto, presidente della quinta sezione penale, è il giudice che, tra
le altre cose, condannò in primo grado a 2 anni l'ex ministro Aldo Brancher per
ricettazione e appropriazione indebita, nell'ambito di uno stralcio
dell'inchiesta sulla tentata scalata ad Antonveneta da parte di Bpi.
Manuela
Cannavale,
invece, ha fatto parte del collegio che nel 2008 ha condannato in primo grado a
tre anni di reclusione l'ex ministro della Sanità Girolamo Sirchia.
Paola
Pendino
è stata invece in passato membro della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione di
Milano, e si è occupata anche di Mohammed Daki, il marocchino che era stato
assolto dall'accusa di terrorismo internazionale dal giudice Clementina Forleo.
Ruby 1, chi
sono le tre giudichesse che hanno condannato Berlusconi?
Giulia Turri, Carmen D’Elia
e Orsola De Cristofaro:
sono i nomi dei tre giudici che hanno firmato la sentenza di condanna di
Berlusconi a sette anni. La loro foto sta facendo il
giro del web e tra numerosi commenti di stima e complimenti, spunta anche
qualche offesa (perfino dal carattere piuttosto personale).
L’aggettivo più ricorrente, inteso chiaramente in senso dispregiativo, è quello
di “comuniste”. Federica De Pasquale le ha definite “il peggior
esempio di femminismo” arrivando ad ipotizzare per loro il reato di
stalking. Ma su twitter qualche elettore del Pdl non ha esitato a definirle come
“represse” soppesandone il valore professionale con l’aspetto fisico e
definendole “quasi più brutte della Bindi”. Ma cosa conta se il giudice
è uomo/donna, bello/brutto?
Condanna a
Berlusconi: giudici uomini sarebbero stati più clementi? Ma per qualcuno il
problema non è tanto che si trattasse di “toghe rosse” quanto piuttosto
di “giudici rosa”. Libero intitola l’articolo sulla sentenza di
condanna alle “giudichesse”, sottolineando con un femminile
forzato di questo sostantivo la natura di genere della condanna e quasi a
suggerire che se i giudici fossero stati uomini la sentenza sarebbe stata
diversa da quella che il giornale definisce “castrazione” e “ergastolo politico”
del Cav. La natura rosa del collegio quindi avrebbe influenzato
l’esito del giudizio a causa di un “dente avvelenato in un caso così
discusso e pruriginoso. Un dente avvelenato che ha puntualmente azzannato
Berlusconi”. Eppure è lo stesso curriculum dei giudici
interessati, sintetizzato sempre da Libero, a confermare la preparazione e la
competenza delle tre toghe a giudicare con lucidità in casi di grande impatto
mediatico.
Giulia Turri
è nota come il giudice che nel marzo del 2007 firmò l’ordinanza di arresto per
Fabrizio Corona ma è anche la stessa che ha giudicato in qualità di gup due
degli assassini del finanziere Gian Mario Roveraro e che, nel 2010, ha disposto
l’arresto di cinque persone nell’ambito dell’inchiesta su un giro di tangenti e
droga che ha coinvolto la movida milanese, e in particolare le note discoteche
Hollywood e The Club.
Orsola De Cristofaro
è stata giudice a latere nel processo che si è concluso con la condanna a
quindici anni e mezzo di carcere per Pier Paolo Brega Massone, l’ex primario di
chirurgia toracica, nell’ambito dell’inchiesta sulla clinica Santa Rita.
Carmen D’Elia
si è già trovata faccia a faccia con Berlusconi in tribunale: ha fatto infatti
parte del collegio di giudici del processo Sme in cui era imputato.
A condannare
Berlusconi sono state tre donne: la Turri, la De Cristofaro e la D'Elia che già
lo aveva processato per la Sme. La presentazione è fatta da “Libero Quotidiano”
con un articolo del 24 giugno 2013. A condannare Silvio Berlusconi
a 7 anni di reclusione e all'interdizione a vita dai pubblici uffici nel primo
grado del processo Ruby sono state tre toghe rosa. Tre giudichesse che hanno
propeso per una sentenza pesantissima, ancor peggiore delle richieste di
Ilda Boccassini. Una sentenza con cui si cerca la "castrazione" e
l'"ergastolo politico" del Cav. Il collegio giudicante della quarta sezione
penale del Tribunale di Milano che è entrato a gamba tesa contro il governo
Letta e contro la vita democratica italiana era interamente composto da donne,
tanto che alcuni avevano storto il naso pensando che la matrice "rosa" del
collegio avrebbe potuto avere il dente avvelenato in un caso così discusso e
pruriginoso. Un dente avvelenato che ha puntualmente azzannato Berlusconi.
A presiedere
il collegio è stata Giulia Turri, arrivata in Tribunale
dall'ufficio gip qualche mese prima del 6 aprile 2011, giorno dell'apertura del
dibattimento. Come gup ha giudicato due degli assassini del finanziere
Gian Mario Roveraro, sequestrato e ucciso nel 2006, pronunciando due
condanne, una all'ergastolo e una a 30 anni. Nel marzo del 2007 firmò
l'ordinanza di arresto per il "fotografo dei vip" Fabrizio Corona,
e nel novembre del 2008 ha rinviato a giudizio l'ex consulente Fininvest e
deputato del Pdl Massimo Maria Berruti. Uno degli ultimi suoi
provvedimenti come gip, e che è salito alla ribalta della cronaca, risale al
luglio 2010: l'arresto di cinque persone coinvolte nell'inchiesta su un presunto
giro di tangenti e droga nel mondo della movida milanese, e in particolare nelle
discoteche Hollywood e The Club, gli stessi locali frequentati
da alcune delle ragazze ospiti delle serate ad Arcore e che sono sfilate in
aula.
La seconda
giudichessa è stata Orsola De Cristofaro, con un passato da pm
e gip, che è stata giudice a latere nel processo che ha portato alla condanna a
quindici anni e mezzo di carcere per Pier Paolo Brega Massone,
l'ex primario di chirurgia toracica, imputato con altri medici per il caso della
clinica Santa Rita e che proprio sabato scorso si è visto in pratica confermare
la condanna sebbene con una lieve diminuzione per via della prescrizioni di
alcuni casi di lesioni su pazienti.
Carmen D'Elia
invece è un volto noto nei procedimenti contro il Cavaliere: nel 2002, ha fatto
parte parte del collegio di giudici del processo Sme che vedeva come imputato,
tra gli altri, proprio Silvio Berlusconi. Dopo che la posizione del premier
venne stralciata - per lui ci fu un procedimento autonomo - insieme a
Guido Brambilla e a Luisa Ponti, il 22 novembre 2003
pronunciò la sentenza di condanna in primo grado a 5 anni per Cesare
Previti e per gli altri imputati, tra cui Renato Squillante
e Attilio Pacifico. Inoltre è stata giudice nel processo sulla
truffa dei derivati al Comune di Milano.
Donna è
anche Patrizia Todisco del caso Taranto.
Ed è lo stesso “Libero Quotidiano” che la presenta con un articolo del 13 agosto
2012. Patrizia Todisco, gip: la zitella rossa che licenzia 11mila operai Ilva.
Patrizia Todisco,
il
giudice per le indagini preliminari che sabato 11 agosto ha corretto il tiro
rispetto alla decisione del Tribunale di Riesame decidendo di fermare la
produzione dell'area a caldo dell'Ilva si Taranto lasciando quindi a casa 11mila
operai, è molto conosciuta a Palazzo di giustizia per la sua durezza. Una
rigorosa, i suoi nemici dicono "rigida", una a cui gli avvocati che la conoscono
bene non osano avvicinarsi neanche per annunciare la presentazione di
un'istanza. Il gip è nata a Taranto, ha 49 anni, i capelli rossi, gli occhiali
da intellettuale, non è sposata, non ha figli e ha una fama di "durissima". Come
scrive il Corriere della Sera, è una donna che non si fermerà davanti
alle reazioni alla sua decisione che non si aspetta né la difesa della procura
tarantina né di quella generale che sulle ultime ordinanze non ha aperto bocca.
Patrizia Todisco è entrata in magistratura 19 anni fa, e non si è mai spostata
dal Palazzo di giustizia di Taranto, non si è mai occupata dell'Ilva dove sua
sorella ha lavorato come segretaria della direzione fino al 2009. Non si è mai
occupata del disastro ambientale dell'Ilva ma, vivendo da sempre a Taranto, ha
osservato da lontano il profilo delle ciminiere che hanno dato lavoro e morte ai
cittadini. La sua carriera è cominciata al Tribunale per i minorenni, poi si si
è occupata di violenze sessuali, criminalità organizzata e corruzione.
Rigorosissima nell'applicazione del diritto, intollerante verso gli avvocati che
arrivano in ritardo, mai tenera con nessuno. Sempre il Corriere ricorda quella
volta che, davanti a un ragazzino che aveva rubato un pezzo di formaggio dal
frigorifero di una comunità. Fu assolto, come come dice un avvocato "lo fece
così nero da farlo sentire il peggiore dei criminali".
Ma anche
Giusi Fasano per "Il Corriere della Sera" ne dà una definizione.
Patrizia va alla guerra. Sola. Gli articoli del codice penale sono i suoi
soldati e il rumore dell'esercito «avversario» finora non l'ha minimamente
spaventata. «Io faccio il giudice, mi occupo di reati...» è la sua filosofia. Il
presidente della Repubblica, il Papa, il ministro dell'Ambiente, il presidente
della Regione, i sindacati, il Pd, il Pdl... L'Ilva è argomento di tutti. Da
ieri anche del ministro Severino, che ha chiesto l'acquisizione degli atti, e
del premier Mario Monti che vuole i ministri di Giustizia, Ambiente e Sviluppo a
Taranto il 17 agosto, per incontrare il procuratore della Repubblica. Anna
Patrizia Todisco «ha le spalle grosse per sopportare anche questa» giura chi la
conosce. Ha deciso che l'Ilva non deve produrre e che Ferrante va rimosso? Andrà
fino in fondo. Non è donna da farsi scoraggiare da niente e da nessuno: così
dicono di lei. E nemmeno si aspetta la difesa a spada tratta della procura
tarantina o di quella generale che sulle ultime ordinanze, comunque, non hanno
aperto bocca. Ieri sera alle otto il procuratore generale Giuseppe Vignola, in
Grecia in vacanza, ha preferito non commentare gli interventi del ministro
Severino e del premier Monti «perché non ho alcuna notizia di prima mano e non
me la sento di prendere posizione». È stato un prudente «no comment» anche per
il procuratore capo di Taranto Franco Sebastio. Nessuna affermazione. Che vuol
dire allo stesso tempo nessuna presa di posizione contro o a favore della
collega Todisco. Quasi un modo per studiare se prenderne o no le distanze. Lei,
classe 1963, né sposata né figli, lavora e segue tutto in silenzio. La rossa
Todisco (e parliamo del colore dei capelli) è cresciuta a pane e codici da
quando diciannove anni fa entrò nella magistratura scegliendo e rimanendo sempre
nel Palazzo di giustizia di Taranto. Dei tanti procedimenti aperti sull'Ilva
finora non ne aveva seguito nessuno. Il mostro d'acciaio dove sua sorella ha
lavorato fino al 2009 come segretaria della direzione, lo ha sempre osservato da
lontano. Non troppo lontano, visto che è nata e vive a pochi chilometri dal
profilo delle ciminiere che dev'esserle quantomeno familiare. Il giudice Todisco
non è una persona riservata. Di più. E ovviamente è allergica ai giornalisti.
«Non si dispiaccia, proprio non ho niente da dire» è stata la sola cosa uscita
dalle sue labbra all'incrocio delle scale che collegano il suo piano terra con
il terzo, dov'è la procura. Lei non parla, ma i suoi provvedimenti dicono di
lei. Di quel «rigore giuridico perfetto» descritto con ammirazione dai colleghi
magistrati, o dell'interpretazione meno benevola di tanti avvocati: «Una dura
oltremisura, rigida che più non si può». Soltanto un legale che non la conosce
bene potrebbe avvicinarla al bar del tribunale per dirle cose tipo «volevo
parlarle di quell'istanza che vorrei presentare...». Nemmeno il tempo di finire
la frase. «Non c'è da parlare, avvocato. Lei la presenti e poi la valuterò». E
che dire dei ritardi in aula? La sua pazienza dura qualche minuto, poi si
comincia, e poco importa se l'avvocatone sta per arrivare, come spiega
inutilmente il tirocinante. Istanza motivata o niente da fare: si parte senza il
principe del foro. La carriera di Patrizia Todisco è cominciata nel più delicato
dei settori: i minorenni, poi fra i giudici del tribunale e infine all'ufficio
gip dove si è occupata di violenze sessuali, criminalità organizzata,
corruzione. Qualcuno ricorda che la giovane dottoressa Todisco una volta fece
marcia indietro su un suo provvedimento, un bimbetto di cinque anni che aveva
tolto alla famiglia per presunti maltrattamenti. Una perizia medica dimostrò che
i maltrattamenti non c'entravano e lei si rimangiò l'ordinanza. Mai tenera con
nessuno. Nemmeno con il ragazzino che aveva rubato un pezzo di formaggio dal
frigorifero di una comunità: «alla fine fu assolto» racconta l'avvocato «ma lo
fece così nero da farlo sentire il peggiore dei criminali».
Donne sono
anche le giudici del caso Scazzi.
Quelle del tutti dentro anche i testimoni della difesa e del fuori onda.
«Bisogna un po' vedere, no, come imposteranno...potrebbe essere mors tua vita
mea». È lo scambio di opinioni tra il presidente della Corte d'assise di
Taranto, Rina Trunfio, e il giudice a latere Fulvia Misserini. La
conversazione risale al 19 marzo ed è stata registrata dai microfoni delle
telecamere «autorizzate a filmare l'udienza». Il presidente della corte, tra
l'altro, afferma: «Certo vorrei sapere se le due posizioni sono collegate.
Quindi bisogna vedere se si sono coordinati tra loro e se si daranno l'uno
addosso all'altro»; il giudice a latere risponde: «Ah, sicuramente». Infine il
presidente conclude: «(Non è che) negheranno in radice».
Donne sono
anche le giudici coinvolte nel caso Vendola.
Susanna De Felice, il magistrato fu al centro delle polemiche dopo che i
due magistrati che rappresentavano l'accusa nel processo a Vendola,
Desirée Digeronimo
(trasferita alla procura di Roma) e Francesco Bretone, dopo l'assoluzione
del politico (per il quale avevano chiesto la condanna a 20 mesi di reclusione)
inviarono un esposto al procuratore generale di Bari e al capo del loro ufficio
segnalando l'amicizia che legava il giudice De Felice alla sorella del
governatore, Patrizia.
Donna è
anche il giudice che ha condannato Raffaele Fitto.
Condannarono Fitto: giudici sotto inchiesta. Sentenza in tempi ristretti e
durante le elezioni: Lecce apre un fascicolo. L'ira di Savino: procedura
irrituale, non ci sono ancora le motivazioni del verdetto, scrive Giuliano
Foschini su “La Repubblica”. La procura di Lecce ha aperto un'inchiesta sul
collegio di giudici che, nel dicembre scorso, ha condannato l'ex ministro del
Pdl, Raffaele Fitto a quattro anno di reclusione per corruzione e abuso di
ufficio. Nelle scorse settimane il procuratore Cataldo Motta ha chiesto al
presidente del Tribunale di Bari, Vito Savino, alcune carte che documentano lo
svolgimento del processo. Una richiesta che ha colto di sorpresa il presidente
che ha inviato tutti gli atti alla procura. Ma contestualmente ha segnalato la
vicenda al presidente della Corte d'Appello, Vito Marino Caferra, indicandone
l'originalità non fosse altro perché si sta indagando su una sentenza della
quella non si conoscono ancora le motivazioni. L'indagine della procura di Lecce
nasce dopo le durissime accuse di Fitto, 24 ore dopo la sentenza nei confronti
della corte che lo aveva condannato. Secondo l'ex ministro il presidente di
sezione Luigi Forleo, e gli altri due giudici Clara Goffredo e Marco Galesi
avrebbero imposto un ritmo serrato al suo processo in modo da condannarlo
proprio nel mezzo della campagna elettorale. "Si è aperta in maniera ufficiale
un'azione da parte della magistratura barese - aveva detto Fitto - che è entrata
a piedi uniti in questa campagna elettorale. Non c'era bisogno di fare questa
sentenza in questi tempi. Attendo di sapere dal presidente Forleo, dalla
consigliera Goffredo e dal presidente del tribunale Savino - aveva attaccato
Fitto - perché vengono utilizzi due pesi e due misure in modo così clamoroso. Ci
sono dei processi - aveva spiegato per i quali gli stessi componenti del
collegio che mi ha condannato hanno fatto valutazioni differenti con tre udienze
all'anno, salvo dichiarare la prescrizione di quei procedimenti a differenza del
caso mio nel quale ho avuto il privilegio di avere tre udienze a settimana". Il
riferimento era al processo sulla missione Arcobaleno che era appunto seguito
dagli stessi giudici e che invece aveva avuto tempi molto più lunghi. "Questa è
la volontà precisa di un collegio che ha compiuto una scelta politica precisa,
che è quella di dare un'indicazione a questa campagna elettorale". Alle domande
di Fitto vuole rispondere evidentemente ora la procura di Lecce che ha aperto
prontamente l'indagine e altrettanto prontamente si è mossa con il tribunale.
Tra gli atti che verranno analizzati ci sono appunti i calendari delle udienze:
l'obiettivo è capire se sono stati commessi degli abusi, come dice Fitto, o se
tutto è stato svolto secondo le regole.
Donna è
anche Rita Romano, giudice di Taranto
che è stata denunciata da Antonio Giangrande, lo scrittore autore di decine di
libri/inchieste, e da questa denunciato perchè lo scrittore ha chiesto la
ricusazione del giudice criticato per quei processi in cui questa giudice doveva
giudicarlo. La Romano ha condannato la sorella del Giangrande che si proclamava
estranea ad un sinistro di cui era accusata di essere responsabile esclusiva,
così come nei fatti è emerso, e per questo la sorella del Giangrande aveva
denunciato l'avvocato, che aveva promosso i giudizi di risarcimento danni.
Avvocato, molto amica di un pubblico ministero del Foro. La Romano ha condannato
chi si professava innocente e rinviato gli atti per falsa testimonianza per la
sua testimone.
E poi giudice
donna è per il processo………
E dire che la
Nicole Minetti ebbe a dire «Ovvio che avrei preferito evitarlo, ma visto che ci
sarà sono certa che riuscirò a chiarire la mia posizione e a dimostrare la mia
innocenza. Da donna mi auguro che a giudicarmi sia un collegio di donne o per lo
meno a maggioranza femminile». Perché, non si fida degli uomini? «Le
donne riuscirebbero a capire di più la mia estraneità ai fatti. Le donne hanno
una sensibilità diversa».
Quello che
appare accomunare tutte queste donne giudice è, senza fini diffamatori, che non
sono donne normali, ma sono donne in carriera. Il lavoro, innanzi tutto, la
famiglia è un bisogno eventuale. E senza famiglia esse sono. Solo la carriera
per esse vale e le condanne sono una funzione ausiliare e necessaria, altrimenti
che ci stanno a fare: per assolvere?!?
Ma quanti
sono le giudici donna?
A questa domanda risponde Gabriella Luccioli dal sito Donne Magistrato. La
presenza delle donne nella Magistratura Italiana.
L'ammissione
delle donne all'esercizio delle funzioni giurisdizionali in Italia ha segnato il
traguardo di un cammino lungo e pieno di ostacoli. Come è noto, l'art. 7 della
legge 17 luglio 1919 n. 1176 ammetteva le donne all'esercizio delle professioni
ed agli impieghi pubblici, ma le escludeva espressamente dall'esercizio della
giurisdizione. L'art. 8 dell'ordinamento giudiziario del 1941 poneva quali
requisiti per accedere alle funzioni giudiziarie “essere cittadino italiano, di
razza ariana, di sesso maschile ed iscritto al P.N.F.". Pochi anni dopo, il
dibattito in seno all’Assemblea Costituente circa l’accesso delle donne alla
magistratura fu ampio e vivace ed in numerosi interventi chiaramente rivelatore
delle antiche paure che la figura della donna magistrato continuava a suscitare:
da voci autorevoli si sostenne che “nella donna prevale il sentimento sul
raziocinio, mentre nella funzione del giudice deve prevalere il raziocinio sul
sentimento” (on. Cappi); che “ soprattutto per i motivi addotti dalla scuola di
Charcot riguardanti il complesso anatomo-fisiologico la donna non può giudicare”
(on. Codacci); si ebbe inoltre cura di precisare che “non si intende affermare
una inferiorità nella donna; però da studi specifici sulla funzione
intellettuale in rapporto alle necessità fisiologiche dell’uomo e della donna
risultano certe diversità, specialmente in determinati periodi della vita
femminile” (on. Molè). Più articolate furono le dichiarazioni dell’onorevole
Leone, il quale affermò: “Si ritiene che la partecipazione illimitata delle
donne alla funzione giurisdizionale non sia per ora da ammettersi. Che la donna
possa partecipare con profitto là dove può far sentire le qualità che le
derivano dalla sua sensibilità e dalla sua femminilità, non può essere negato.
Ma negli alti gradi della magistratura, dove bisogna arrivare alla rarefazione
del tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possono mantenere
quell’equilibrio di preparazione che più corrisponde per tradizione a queste
funzioni”; e che pertanto alle donne poteva essere consentito giudicare soltanto
in quei procedimenti per i quali era maggiormente avvertita la necessità di una
presenza femminile, in quanto richiedevano un giudizio il più possibile conforme
alla coscienza popolare. Si scelse infine di mantenere il silenzio sulla
specifica questione della partecipazione delle donne alle funzioni
giurisdizionali, stabilendo all’art. 51 che “tutti i cittadini dell’uno e
dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. Si intendeva in tal
modo consentire al legislatore ordinario di prevedere il genere maschile tra i
requisiti per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali, in deroga al principio
dell’eguaglianza tra i sessi, e ciò ritardò fortemente l’ingresso delle donne in
magistratura. Solo con la legge 27 dicembre 1956 n. 1441 fu permesso alle donne
di far parte nei collegi di corte di assise, con la precisazione che almeno tre
giudici dovessero essere uomini. La legittimità costituzionale di tale
disposizione fu riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 56
del 1958, nella quale si affermò che ben poteva la legge “ tener conto,
nell’interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli
appartenenti a ciascun sesso, purchè non fosse infranto il canone fondamentale
dell’eguaglianza giuridica”. Fu necessario aspettare quindici anni dall’entrata
in vigore della Carta fondamentale perchè il Parlamento - peraltro direttamente
sollecitato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 33 del 1960, che aveva
dichiarato parzialmente illegittimo il richiamato art. 7 della legge n. 1176 del
1919, nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che
implicavano l’esercizio di diritti e di potestà politiche - approvasse una
normativa specifica, la legge n. 66 del 9 febbraio 1963, che consentì l' accesso
delle donne a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la
magistratura. Dall'entrata in vigore della Costituzione si erano svolti ben
sedici concorsi per uditore giudiziario, con un totale di 3127 vincitori, dai
quali le donne erano state indebitamente escluse. Con decreto ministeriale del 3
maggio 1963 fu bandito il primo concorso aperto alla partecipazione delle donne:
otto di loro risultarono vincitrici e con d.m. 5 aprile del 1965 entrarono nel
ruolo della magistratura. Da quel primo concorso l’accesso delle donne
nell’ordine giudiziario ha registrato nel primo periodo dimensioni modeste, pari
ad una media del 4% -5% per ogni concorso, per aumentare progressivamente
intorno al 10% -20%“ dopo gli anni ’70, al 30% - 40% negli anni ’80 e registrare
un’impennata negli anni successivi, sino a superare ormai da tempo ampiamente la
metà. Attualmente le donne presenti in magistratura sono 3788, per una
percentuale superiore al 40% del totale, e ben presto costituiranno
maggioranza, se continuerà il trend che vede le donne vincitrici di
concorso in numero di gran lunga superiore a quello degli uomini. Come è
evidente, tale fenomeno è reso possibile dal regime di assunzione per concorso
pubblico, tale da escludere qualsiasi forma di discriminazione di genere; esso è
inoltre alimentato dalla presenza sempre più marcata delle studentesse nelle
facoltà di giurisprudenza, superiore a quello degli uomini. Dal primo concorso
ad oggi il profilo professionale delle donne magistrato è certamente cambiato.
Alle prime generazioni fu inevitabile, almeno inizialmente, omologare totalmente
il proprio ideale di giudice all’unico modello professionale di riferimento ed
integrarsi in quel sistema declinato unicamente al maschile attraverso un
processo di completa imitazione ed introiezione di tale modello, quale passaggio
necessario per ottenere una piena legittimazione. Ma ben presto, una volta
pagato per intero il prezzo della loro ammissione, superando la prova che
si richiedeva loro di essere brave quanto gli uomini, efficienti quanto gli
uomini, simili il più possibile agli uomini, e spesso vivendo in modo
colpevolizzante i tempi della gravidanza e della maternità come tempi sottratti
all’attività professionale, si pose alle donne magistrato il dilemma se
continuare in una assunzione totale del modello dato, di per sé immune da rischi
e collaudata da anni di conquistate gratificazioni, o tentare il recupero di una
identità complessa, tracciando un approccio al lavoro, uno stile, un
linguaggio, delle regole comportamentali sulle quali costruire una figura
professionale di magistrato al femminile.
Certo che a
parlar male di loro si rischia grosso. Ma i giornalisti questo coraggio ce
l’hanno?
Certo che no!
Per fare vero giornalismo forse è meglio non essere giornalisti.
PARLIAMO
DEI BRAVI CHE NON POSSONO ESERCITARE, EPPURE ESERCITANO.
Questa è
“Mi-Jena Gabanelli” (secondo Dagospia), la Giovanna D’Arco di Rai3, che i
grillini volevano al Quirinale. Milena Gabanelli intervistata da
Gian Antonio Stella per "Sette - Corriere della Sera".
Sei impegnata da anni nella
denuncia delle storture degli ordini professionali: cosa pensi dell'idea di
Grillo di abolire solo quello dei giornalisti?
«Mi fa un po'
sorridere. Credo che impareranno che esistono altri ordini non meno assurdi.
Detto questo, fatico a vedere l'utilità dell'Ordine dei giornalisti. Credo
sarebbe più utile, come da altre parti, un'associazione seria e rigorosa nella
quale si entra per quello che fai e non tanto per aver dato un esame...».
Ti pesa ancora la
bocciatura?
«Vedi un po'
tu. L'ho fatto assieme ai miei allievi della scuola di giornalismo. Loro sono
passati, io no».
Bocciata agli orali per una
domanda su Pannunzio.
«Non solo.
Avrò risposto a tre domande su dieci. Un disastro. Mi chiesero cos'era il
Coreco. Scena muta».
Come certi parlamentari
beccati dalle Iene fuori da Montecitorio...
«Le Iene fanno
domande più serie. Tipo qual è la capitale della Libia. Il Coreco!».
Essere bocciata come Alberto
Moravia dovrebbe consolarti.
«C'era una
giovane praticante che faceva lo stage da noi. Le avevo corretto la tesina...
Lei passò, io no. Passarono tutti, io no».
Mai più rifatto?
«No. Mi
vergognavo. Per fare gli orali dovevi mandare a memoria l'Abruzzo e io lavorando
il tempo non l'avevo».
Nel senso del libro di
Franco Abruzzo, giusto?
«Non so se c'è
ancora quello. So che era un tomo che dovevi mandare a memoria per sapere tutto
di cose che quando ti servono le vai a vedere volta per volta. Non ha senso. Ho
pensato che si può sopravvivere lo stesso, anche senza essere professionista».
Tornando al
caso Ruby, logica vorrebbe che chi ha avuto la fortuna nella vita di fare tanti
soldi dovrebbe sistemare innanzi tutto i propri figli. Fatto ciò, dovrebbe
divertirsi e godersi la vita e se, altruista, fare beneficenza.
Bene.
L’assurdità di un modo di ragionare sinistroide ed invidioso, perverso e
squilibrato, pretenderebbe (e di fatto fa di tutto per attuarlo) che per i
ricchi dovrebbe valere la redistribuzione forzosa della loro ricchezza agli
altri (meglio se sinistri) e se a questo vi si accomuna un certo tipo di
divertimento, allora vi è meretricio. In questo caso non opera più la
beneficenza volontaria, ma scatta l’espropriazione proletaria.
Una cosa è
certa. In questa Italia di m….. le tasse aumentano, cosi come le sanguisughe. I
disservizi e le ingiustizie furoreggiano. Ma allora dove cazzo vanno a finire i
nostri soldi se è vero, come è vero, che sono ancora di più gli italiani che
oltre essere vilipesi, muoiono di fame? Aumenta in un anno l’incidenza della
povertà assoluta in Italia. Come certifica l’Istat, le persone in povertà
assoluta passano dal 5,7% della popolazione del 2011 all’8% del 2012, un record
dal 2005. È quanto rileva il report «La povertà in Italia», secondo cui nel
nostro Paese sono 9 milioni 563 mila le persone in povertà relativa, pari al
15,8% della popolazione. Di questi, 4 milioni e 814 mila (8%) sono i poveri
assoluti, cioè che non riescono ad acquistare beni e servizi essenziali per una
vita dignitosa. Una situazione accentuata soprattutto al Sud. Nel 2012 infatti
quasi la metà dei poveri assoluti (2 milioni 347 mila persone) risiede nel
Mezzogiorno. Erano 1 milione 828 mila nel 2011.
Ed è con
questo stato di cose che ci troviamo a confrontarci quotidianamente. Ed a tutto
questo certo non corrisponde un Stato efficace ed efficiente, così come
ampiamente dimostrato. Anzi nonostante il costo del suo mantenimento questo
Stato si dimostra incapace ed inadeguato.
Eppure ad
una mancanza di servizi corrisponde una Spesa pubblica raddoppiata.
E tasse locali che schizzano all'insù. Negli ultimi venti anni le imposte
riconducibili alle amministrazioni locali sono aumentate da 18 a 108 miliardi di
euro, «con un eccezionale incremento di oltre il 500% ». È quanto emerge da uno
studio della Confcommercio in collaborazione con il Cer (Centro Europa Ricerche)
che analizza le dinamiche legate al federalismo fiscale a partire dal 1992. È
uno studio del Corriere della Sera a riportare al centro del dibattito la
questione delle tasse locali e della pressione fiscale sugli italiani. Con una
interessante intervista a Luca Antonini, presidente della Commissione sul
federalismo fiscale e poi alla guida del Dipartimento delle Riforme di Palazzo
Chigi, si mettono in luce le contraddizioni e il peso di “un sistema
ingestibile”: “Cresce la spesa statale e cresce la spesa locale, crescono le
tasse nazionali (+95% in 20 anni secondo Confcommercio) e crescono quelle locali
(+500%). Così non può funzionare. Non c'è una regia, manca completamente il
ruolo di coordinamento dello Stato”. Sempre dal 1992 la spesa corrente delle
amministrazioni centrali (Stato e altri enti) è cresciuta del 53%. La spesa di
regioni, province e comuni del 126% e quella degli enti previdenziali del 127%:
il risultato è che la spesa pubblica complessiva è raddoppiata. «Per
fronteggiare questa dinamica - sottolinea il dossier - si è assistito ad una
esplosione del gettito derivante dalle imposte (dirette e indirette) a livello
locale con un aumento del 500% a cui si è associato il sostanziale raddoppio a
livello centrale. I cittadini si aspettavano uno Stato più efficiente, una
riduzione degli sprechi, maggior responsabilità politica dagli amministratori
locali. Non certo di veder aumentare le tasse pagate allo Stato e pure quelle
versate al Comune, alla Provincia e alla Regione. E invece è successo proprio
così: negli ultimi vent'anni le imposte nazionali sono raddoppiate, e i tributi
locali sono aumentati addirittura cinque volte. Letteralmente esplosi. Tanto che
negli ultimi dodici anni le addizionali Irpef regionali e comunali sono
cresciute del 573%, ed il loro peso sui redditi è triplicato, arrivando in
alcuni casi oltre il 17%.
Nonostante che
i Papponi di Stato, centrali e periferici, siano mantenuti dai tartassati ecco
che è clamorosa l'ennesima uscita dell'assessore Franco D'Alfonso, lo stesso che
voleva proibire i gelati dopo mezzanotte ricoprendo Milano di ridicolo e che si
è ripetuto in versione giacobina accusando Dolce e Gabbana di evasione fiscale a
iter giudiziario non ancora concluso. Provocando i tre giorni di serrata dei
nove negozi D&G di Milano. E a chi avesse solo immaginato la possibilità di
rinnegarlo, il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia fa subito capire che il suo
vero bersaglio non è D'Alfonso e il suo calpestare il più elementare stato di
diritto, ma gli stilisti offesi. «Che c'entra “Milano fai schifo”? Sono molte -
va all'attacco un durissimo Pisapia - le cose che fanno schifo, ma non ho mai
visto chiudere i loro negozi per le stragi, le guerre, le ingiustizie».
Ricordando che il fisco, le sue regole e le sanzioni contro le infrazioni, non
sono materia di competenza del Comune. Giusto. Perché in quella Babilonia che è
diventata il Comune tra registri per le coppie omosessuali, no-global che
occupano e rom a cui rimborsare le case costruite abusivamente, nulla succede
per caso. Intanto, però, i negozi, i ristoranti, i bar e l'edicola di Dolce e
Gabbana sono rimasti chiusi per giorni. In protesta contro le indagini della Gdf
e le sentenze di condanna in primo grado del Tribunale, dopo le dichiarazioni
dell'assessore al Commercio, Franco D'Alfonso, sul non «concedere spazi pubblici
a marchi condannati per evasione». «Spazi mai richiesti», secondo i due
stilisti, che con l'ennesimo tweet hanno rilanciato la campagna contro il
Comune.
Uomini trattati da animali
dai perbenisti di maniera. Politici inetti, incapaci ed ipocriti che si danno
alla zoologia.
Anatra
– Alla politica interessa solo se è zoppa. Una maggioranza senza maggioranza.
Asino
– Simbolo dei democrat Usa. In Italia ci provò Prodi con risultati scarsi.
Balena
– La b. bianca fu la Dc. La sua estremità posteriore è rimasta destinazione da
augurio.
Caimano
– Tra le definizioni correnti di Berlusconi. Dovuto a un profetico film di Nanni
Moretti.
Cignalum
– Sistema elettorale toscano da cui, per involuzione, nacque il porcellum
(v.).
Cimice
– Di provenienza statunitense, di recente pare abbia invaso l’Europa.
Colomba
– Le componenti più disponibili al dialogo con gli avversari. Volatili.
Coccodrillo
– Chi piange sul latte versato. Anche articolo di commemorazione redatto
pre-mortem.
Delfino
– Destinato alla successione. Spesso è un mistero: a oggi non si sa chi sia il
d. del caimano (v.).
Elefante
– Simbolo dei republican Usa. L’e. rosso fu il Pci. La politica si muove “Come
un e. in una cristalleria”.
Falco
– Le componenti meno disponibili al dialogo con gli avversari. Amano le
picchiate.
Gambero
– Il suo passo viene evocato quando si parla della nostra economia.
Gattopardo
– Da Tomasi di Lampedusa in poi segno dell’immutabilità della politica. Sempre
attuale.
Giaguaro
– Ci fu un tentativo di smacchiarlo. Con esiti assai deludenti.
Grillo
– Il primo fu quello di Pinocchio. L’attuale, però, dice molte più parolacce.
Gufo
– Uno che
spera che non vincano né i falchi né le colombe.
Orango
– L’inventore del Porcellum (vedi Roberto Calderoli Cecile Kyenge) ne
ha fatto un uso ributtante confermandosi uomo bestiale.
Piccione
– Di recente evocato per sé, come obiettivo di tiro libero, da chi disprezzò il tacchino
(v.).
Porcellum
– Una porcata di sistema elettorale che tutti vogliono abolire, ma è sempre lì.
Pitonessa
– Coniato specificatamente per Daniela Santanchè. Sinuosa e infida, direi.
Struzzo
- Chi non vuol
vedere e mette la testa nella sabbia. Un esercito.
Tacchino
– Immaginato su un tetto da Bersani, rischiò di eclissare il giaguaro.
Tartaruga
– La t. un tempo fu un animale che correva a testa in giù. Ora dà il passo alla
ripresa.
Ed a
proposito di ingiustizia e “canili umani”.
La presidente della Camera, Laura Boldrini, il 22 luglio 2013 durante la visita
ai detenuti del carcere di Regina Coeli, ha detto: «Il sovraffollamento delle
carceri non è più tollerabile, spero che Governo e Parlamento possano dare una
risposta di dignità ai detenuti e a chi lavora. Ritengo che sia importante
tenere alta l’attenzione sull’emergenza carceri e sono qui proprio per dare
attenzione a questo tema, la situazione delle carceri è la cartina di tornasole
del livello di civiltà di un Paese. La certezza del diritto è fondamentale: chi
ha sbagliato deve pagare, non chiediamo sconti, ma è giusto che chi entra in
carcere possa uscire migliore, è giusto che ci sia la rieducazione e in una
situazione di sovraffollamento è difficile rieducare perché non si fa altro che
tirare fuori il peggio dell’essere umano e non il meglio. Nel codice non c’è
scritto che un’ulteriore pena debba essere quella del sovraffollamento.
Costruire nuove strutture è complicato perché non ci sono risorse ma in alcuni
carceri ci sono padiglioni non utilizzati e con un po’ di fondi sarebbe
possibile renderli agibili. In più bisogna mettere in atto misure alternative e
considerare le misure di custodia cautelare perché il 40% dei detenuti non ha
una condanna definitiva. Bisogna ripensare, rivedere il sistema di custodia
cautelare. Perché se quelle persone sono innocenti, il danno è irreparabile».
«Dignità, dignità». Applaudono e urlano, i detenuti della terza sezione del
carcere di Regina Coeli quando vedono arrivare il presidente della Camera Laura
Boldrini, in visita ufficiale al carcere romano che ha una capienza di 725 unità
e ospita, invece, più di mille persone. Urlano i detenuti per invocare
«giustizia e libertà» che il sovraffollamento preclude non solo a loro, ma anche
agli agenti di polizia penitenziaria costretti a turni insostenibili (a volte
«c'è un solo agente per tre piani, per circa 250 detenuti» confessa un
dipendente). “Vogliamo giustizia, libertà e dignità”, sono queste invece le
parole che hanno intonato i detenuti durante la visita della Boldrini. I
detenuti nell'incontro con il presidente della Camera hanno voluto sottolineare
che cosa significa in concreto sovraffollamento: "Secondo la Corte europea di
Giustizia ", ha detto uno di loro "ogni detenuto ha diritto a otto metri quadri
di spazio, esclusi bagno e cucina. Noi abbiamo 17 metri quadri per tre detenuti,
in letti a castello con materassi di gomma piuma che si sbriciolano e portano
l'orma di migliaia di detenuti. Anche le strutture ricreative sono state ridotte
a luoghi di detenzione. Questo non è un carcere ma un magazzino di carne umana".
E' stata la seconda visita a un istituto carcerario italiano per Laura Boldrini
da quando è diventata presidente della Camera dei deputati. A Regina Coeli, dove
la capienza sarebbe di 725 detenuti, ve ne sono attualmente circa 1.050; le
guardie carcerarie sono 460 ma ne sarebbero previste 614. «Ho voluto fortemente
questo incontro, non avrebbe avuto senso la mia visita, sarebbe stata una farsa.
Ora mi sono resa conto di persona della situazione nelle celle e condivido la
vostra indignazione» ha replicato la Boldrini ai detenuti. Dici Roma, dici
Italia.
Già!! La
giustizia e le nostre vite in mano a chi?
«Antonio Di
Pietro è il primo a lasciare l'ufficio di Borrelli. È irriconoscibile. Cammina
come un ubriaco, quasi appoggiandosi ai muri». Così scrive Goffredo Buccini sul
Corriere della Sera del 24 luglio 1993, il giorno dopo il suicidio di Raul
Gardini.
«Per me fu una
sconfitta terribile - racconta oggi Antonio Di Pietro ad Aldo Cazzullo su “Il
Corriere della Sera” -. La morte di Gardini è il vero, grande rammarico che
conservo della stagione di Mani pulite. Per due ragioni. La prima: quel 23
luglio Gardini avrebbe dovuto raccontarmi tutto: a chi aveva consegnato il
miliardo di lire che aveva portato a Botteghe Oscure, sede del Pci; chi erano i
giornalisti economici corrotti, oltre a quelli già rivelati da Sama; e chi erano
i beneficiari del grosso della tangente Enimont, messo al sicuro nello Ior. La
seconda ragione: io Gardini lo potevo salvare. La sera del 22, poco prima di
mezzanotte, i carabinieri mi chiamarono a casa a Curno, per avvertirmi che
Gardini era arrivato nella sua casa di piazza Belgioioso a Milano e mi dissero:
"Dottore che facciamo, lo prendiamo?". Ma io avevo dato la mia parola agli
avvocati che lui sarebbe arrivato in Procura con le sue gambe, il mattino dopo.
E dissi di lasciar perdere. Se l'avessi fatto arrestare subito, sarebbe ancora
qui con noi».
Ma proprio
questo è il punto. Il «Moro di Venezia», il condottiero dell'Italia anni 80, il
padrone della chimica non avrebbe retto l'umiliazione del carcere. E molte cose
lasciano credere che non se la sarebbe cavata con un interrogatorio. Lei, Di
Pietro, Gardini l'avrebbe mandato a San Vittore?
«Le rispondo
con il cuore in mano: non lo so. Tutto sarebbe dipeso dalle sue parole: se mi
raccontava frottole, o se diceva la verità. Altre volte mi era successo di
arrestare un imprenditore e liberarlo in giornata, ad esempio Fabrizio
Garampelli: mi sentii male mentre lo interrogavo - un attacco di angina -, e fu
lui a portarmi in ospedale con il suo autista... Io comunque il 23 luglio 1993
ero preparato. Avevo predisposto tutto e allertato la mia squadretta, a Milano e
a Roma. Lavoravo sia con i carabinieri, sia con i poliziotti, sia con la Guardia
di Finanza, pronti a verificare quel che diceva l'interrogato. Se faceva il nome
di qualcuno, prima che il suo avvocato potesse avvertirlo io gli mandavo le
forze dell'ordine a casa. Sarebbe stata una giornata decisiva per Mani pulite.
Purtroppo non è mai cominciata».
Partiamo
dall'inizio. Il 20 luglio di vent'anni fa si suicida in carcere, con la testa in
un sacchetto di plastica, Gabriele Cagliari, presidente dell'Eni.
«L'Eni aveva
costituito con la Montedison di Gardini l'Enimont. Ma Gardini voleva comandare -
è la ricostruzione di Di Pietro -. Quando diceva "la chimica sono io", ne era
davvero convinto. E quando vide che i partiti non intendevano rinunciare alla
mangiatoia della petrolchimica pubblica, mamma del sistema tangentizio, lui si
impuntò: "Io vendo, ma il prezzo lo stabilisco io". Così Gardini chiese tremila
miliardi, e ne mise sul piatto 150 per la maxitangente. Cagliari però non era in
carcere per la nostra inchiesta, ma per l'inchiesta di De Pasquale su Eni-Sai.
Non si possono paragonare i due suicidi, perché non si possono paragonare i due
personaggi. Cagliari era un uomo che sputava nel piatto in cui aveva mangiato.
Gardini era un uomo che disprezzava e comprava, e disprezzava quel che comprava.
Il miliardo a Botteghe Oscure lo portò lui. Il suo autista Leo Porcari mi aveva
raccontato di averlo lasciato all'ingresso del quartier generale comunista, ma
non aveva saputo dirmi in quale ufficio era salito, se al secondo o al quarto
piano: me lo sarei fatto dire da Gardini. Ma era ancora più importante stabilire
chi avesse imboscato la maxitangente, probabilmente portando i soldi al sicuro
nello Ior. Avevamo ricostruito la destinazione di circa metà del bottino;
restavano da rintracciare 75 miliardi».
Chi li
aveva presi?
«Qualcuno
l'abbiamo trovato. Ad esempio Arnaldo Forlani: non era certo Severino Citaristi
a gestire simili cifre. Non è vero che il segretario dc fu condannato perché non
poteva non sapere, e lo stesso vale per Bettino Craxi, che fu condannato per i
conti in Svizzera. Ma il grosso era finito allo Ior. Allora c'era il Caf».
Craxi.
Forlani. E Giulio Andreotti.
«Il vero capo
la fa girare, ma non la tocca. Noi eravamo arrivati a Vito Ciancimino, che era
in carcere, e a Salvo Lima, che era morto. A Palermo c'era già Giancarlo
Caselli, tra le due Procure nacque una stretta collaborazione, ci vedevamo
regolarmente e per non farci beccare l'appuntamento era a casa di Borrelli.
Ingroia l'ho conosciuto là».
Torniamo a
Gardini. E al 23 luglio 1993.
«Con Francesco
Greco avevamo ottenuto l'arresto. Un gran lavoro di squadra. Io ero
l'investigatore. Piercamillo Davigo era il tecnico che dava una veste giuridica
alle malefatte che avevo scoperto: arrivavo nel suo ufficio, posavo i fascicoli
sulla scrivania, e gli dicevo in dipietrese: "Ho trovato quindici reati di
porcata. Ora tocca a te trovargli un nome". Gherardo Colombo, con la Guardia di
Finanza, si occupava dei riscontri al mio lavoro di sfondamento, rintracciava i
conti correnti, trovava il capello (sic) nell'uovo. Gli avvocati Giovanni Maria
Flick e Marco De Luca vennero a trattare il rientro di Gardini, che non era
ancora stato dichiarato latitante. Fissammo l'appuntamento per il 23, il mattino
presto». «Avevamo stabilito presidi a Ravenna, Roma, a Milano e allertato le
frontiere. E proprio da Milano, da piazza Belgioioso dove Gardini aveva casa, mi
arriva la telefonata: ci siamo, lui è lì. In teoria avrei dovuto ordinare ai
carabinieri di eseguire l'arresto. Gli avrei salvato la vita. Ma non volevo
venir meno alla parola data. Così rispondo di limitarsi a sorvegliare con
discrezione la casa. Il mattino del 23 prima delle 7 sono già a Palazzo di
Giustizia. Alle 8 e un quarto mi telefona uno degli avvocati, credo De Luca, per
avvertirmi che Gardini sta venendo da me, si sono appena sentiti. Ma poco dopo
arriva la chiamata del 113: "Gardini si è sparato in testa". Credo di essere
stato tra i primi a saperlo, prima anche dei suoi avvocati». «Mi precipito in
piazza Belgioioso, in cinque minuti sono già lì. Entro di corsa. Io ho fatto il
poliziotto, ne ho visti di cadaveri, ma quel mattino ero davvero sconvolto.
Gardini era sul letto, l'accappatoio insanguinato, il buco nella tempia».
E la
pistola?
«Sul comodino.
Ma solo perché l'aveva raccolta il maggiordomo, dopo che era caduta per terra.
Capii subito che sarebbe partito il giallo dell'omicidio, già se ne sentiva
mormorare nei conciliaboli tra giornalisti e pure tra forze dell'ordine, e lo
dissi fin dall'inizio: nessun film, è tutto fin troppo chiaro. Ovviamente in
quella casa mi guardai attorno, cercai una lettera, un dettaglio rivelatore,
qualcosa: nulla».
Scusi Di
Pietro, ma spettava a lei indagare sulla morte di Gardini?
«Per carità,
Borrelli affidò correttamente l'inchiesta al sostituto di turno, non ricordo
neppure chi fosse, ma insomma un'idea me la sono fatta...».
Quale?
«Fu un
suicidio d'istinto. Un moto d'impeto, non preordinato. Coerente con il
personaggio, che era lucido, razionale, coraggioso. Con il pelo sullo stomaco;
ma uomo vero. Si serviva di Tangentopoli, che in fondo però gli faceva schifo.
La sua morte per me fu un colpo duro e anche un coitus interruptus».
Di Pietro,
c'è di mezzo la vita di un uomo.
«Capisco, non
volevo essere inopportuno. È che l'interrogatorio di Gardini sarebbe stato una
svolta, per l'inchiesta e per la storia d'Italia. Tutte le altre volte che nei
mesi successivi sono arrivato vicino alla verità, è sempre successo qualcosa,
sono sempre riusciti a fermarmi. L'anno dopo, era il 4 ottobre, aspettavo le
carte decisive dalla Svizzera, dal giudice Crochet di Ginevra: non sono mai
arrivate. Poi mi bloccarono con i dossier, quando ero arrivato sulla soglia
dell'istituto pontificio...».
Ancora i
dossier?
«Vada a
leggersi la relazione del Copasir relativa al 1995: contro di me lavoravano in
tanti, dal capo della polizia Parisi a Craxi».
Lei in
morte di Gardini disse: «Nessuno potrà più aprire bocca, non si potrà più dire
che gli imputati si ammazzano perché li teniamo in carcere sperando che
parlino».
«Può darsi che
abbia detto davvero così. Erano giornate calde. Ma il punto lo riconfermo: non è
vero, come si diceva già allora, che arrestavamo gli inquisiti per farli
parlare. Quando arrestavamo qualcuno sapevamo già tutto, avevamo già trovato i
soldi. E avevamo la fila di imprenditori disposti a parlare».
Altri
capitani d'industria hanno avuto un trattamento diverso.
«Carlo De
Benedetti e Cesare Romiti si assunsero le loro responsabilità. Di loro si
occuparono la Procura di Roma e quella di Torino. Non ci furono favoritismi né
persecuzioni. Purtroppo, nella vicenda di Gardini non ci furono neanche
vincitori; quel giorno abbiamo perso tutti».
Dopo 20 anni
Di Pietro è senza: pudore: «Avrei potuto salvarlo». Mani Pulite riscritta per
autoassolversi. L'ex pm: "Avrei dovuto arrestarlo e lui avrebbe parlato delle
mazzette al Pci". La ferita brucia ancora. Vent'anni fa Antonio Di Pietro,
allora l'invincibile Napoleone di Mani pulite, si fermò sulla porta di Botteghe
Oscure e il filo delle tangenti rosse si spezzò con i suoi misteri, scrive
Stefano Zurlo su “Il Giornale”.
Per questo, forse per trovare una spiegazione che in realtà spiega solo in
parte, l'ex pm racconta che il suicidio di Raul Gardini, avvenuto il 23 luglio
'93 a Milano, fu un colpo mortale per quell'indagine. «La sua morte - racconta
Di Pietro ad Aldo Cazzullo in un colloquio pubblicato ieri dal Corriere della
Sera - fu per me un coitus interruptus». Il dipietrese s'imbarbarisce ancora di
più al cospetto di chi non c'è più, ma non è questo il punto. È che l'ormai ex
leader dell'Italia dei Valori si autoassolve a buon mercato e non analizza con
la dovuta brutalità il fallimento di un'inchiesta che andò a sbattere contro
tanti ostacoli. Compresa l'emarginazione del pm Tiziana Parenti, titolare di
quel filone. E non s'infranse solo sulla tragedia di piazza Belgioioso. Di
Pietro, come è nel suo stile, semplifica e fornisce un quadro in cui lui e il
Pool non hanno alcuna responsabilità, diretta o indiretta, per quel fiasco.
Tutto finì invece con quei colpi di pistola: «Quel 23 luglio Gardini avrebbe
dovuto raccontarmi tutto: a chi aveva consegnato il miliardo di lire che aveva
portato a Botteghe Oscure, sede del Pci; chi erano i giornalisti economici
corrotti, oltre a quelli già rivelati da Sama; e chi erano i beneficiari del
grosso della tangente Enimont, messo al sicuro nello Ior». E ancora, a proposito
di quel miliardo su cui tanto si è polemizzato in questi anni, specifica: «Il
suo autista Leo Porcari mi aveva raccontato di averlo lasciato all'ingresso del
quartier generale comunista, ma non aveva saputo dirmi in quale ufficio era
salito, se al secondo o al quarto piano: me lo sarei fatto dire da Gardini». Il
messaggio che arriva è chiaro: lui ha fatto tutto quel che poteva per scoprire i
destinatari di quel contributo illegale, sulla cui esistenza non c'è il minimo
dubbio, ma quel 23 luglio cambiò la storia di Mani pulite e in qualche modo
quella d'Italia e diventa una data spartiacque, come il 25 luglio 43. Vengono i
brividi, ma questa ricostruzione non può essere accettata acriticamente e
dovrebbero essere rivisti gli errori, e le incertezze dell'altrove insuperabile
Pool sulla strada del vecchio Pci. Non si può scaricare su chi non c'è più la
responsabilità di non aver scoperchiato quella Tangentopoli. Di Pietro invece se
la cava così, rammaricandosi solo di non aver fatto ammanettare il signore della
chimica italiana la sera prima, quando i carabinieri lo avvisarono che Gardini
era a casa, in piazza Belgioioso. «M avevo dato la mia parola agli avvocati che
lui sarebbe arrivato in procura con le sue gambe, il mattino dopo». Quello
fatale. «E dissi di lasciar perdere. Se l'avessi fatto arrestare subito sarebbe
ancora qui con noi. Io Gardini lo potevo salvare». La storia non si fa con i se.
E quella delle tangenti rosse è finita prima ancora di cominciare.
Pomicino:
il pm Di Pietro tentò di farmi incastrare Napolitano.
L'ex ministro Cirino Pomicino: "Inventando una confessione, cercò di spingermi a
denunciare una tangente all'attuale capo dello Stato, poi spiegò il trucco",
scrive
Paolo Bracalini su “Il Giornale”.
E mentre la truccatrice gli passa la spazzola sulla giacca, prima di entrare
nello studio tv di Agorà, 'o ministro ti sgancia la bomba: «Di Pietro mi chiese:
"È vero che Giorgio Napolitano ha ricevuto soldi da lei?". Io risposi che non
era vero, ma lui insisteva. "Guardi che c'è un testimone, un suo amico, che lo
ha confessato". "Se l'ha detto, ha detto una sciocchezza, perché non è vero"
risposi io. E infatti la confessione era finta, me lo rivelò lo stesso Di Pietro
poco dopo, un tranello per farmi dire che Napolitano aveva preso una tangente.
Ma si può gestire la giustizia con questi metodi? E badi bene che lì aveva
trovato uno come me, ma normalmente la gente ci metteva due minuti a dire quel
che volevano fargli dire". "In quegli anni le persone venivano arrestate,
dicevano delle sciocchezze, ammettevano qualsiasi cosa e il pm li faceva subito
uscire e procedeva col patteggiamento. Quando poi queste persone venivano
chiamate a testimoniare nel processo, contro il politico che avevano accusato,
potevano avvalersi della facoltà di non rispondere. E quindi restavano agli atti
le confessioni false fatte a tu per tu col pubblico ministero», aveva già
raccontato Pomicino in una lunga intervista video pubblicata sul suo blog
paolocirinopomicino.it. La stessa tesi falsa, cioè che Napolitano, allora
presidente della Camera, esponente Pds dell'ex area migliorista Pci, avesse
ricevuto dei fondi, per sé e per la sua corrente, col tramite dell'ex ministro
democristiano, Pomicino se la ritrovò davanti in un altro interrogatorio,
stavolta a Napoli. «Il pm era il dottor Quatrano (nel 2001 partecipò ad un
corteo no global e l'allora Guardasigilli Roberto Castelli promosse un'azione
disciplinare). Mi fece incontrare una persona amica, agli arresti, anche lì per
farmi dire che avevo dato a Napolitano e alla sua corrente delle risorse
finanziaria». La ragione di quel passaggio di soldi a Napolitano, mai
verificatosi ma da confermare a tutti i costi anche col tranello della finta
confessione di un amico (uno dei trucchi dell'ex poliziotto Di Pietro, "altre
volte dicevano che se parlavamo avremmo avuto un trattamento più mite"), per
Cirino Pomicino è tutta politica: «Obiettivo del disegno complessivo era far
fuori, dopo la Dc e il Psi, anche la componente amendoliana del Pci, quella più
filo-occidentale, più aperta al centrosinistra. Tenga presente che a Milano fu
arrestato Cervetti, anch'egli della componente migliorista di Giorgio
Napolitano, e fu accusata anche Barbara Pollastrini. Entrambi poi scagionati da
ogni accusa». I ricordi sono riemersi di colpo, richiamati dalle «corbellerie»
dette da Di Pietro al Corriere a proposito del suicidio di Raul Gardini,
vent'anni esatti fa (23 luglio 1993). «Sono allibito che il Corriere della Sera
dia spazio alle ricostruzioni false raccontate da Di Pietro. Ho anche mandato un
sms a De Bortoli, ma quel che gli ho scritto sono cose private. Di Pietro dice
che Gardini si uccise con un moto d'impeto, e che lui avrebbe potuto salvarlo
arrestandolo il giorno prima. Io credo che Gardini si sia ucciso per il motivo
opposto», forse perché era chiaro che di lì a poche ore sarebbe stato arrestato.
Anche Luigi Bisignani, l'«Uomo che sussurra ai potenti» (bestseller
Chiarelettere con Paolo Madron), braccio destro di Gardini alla Ferruzzi,
conferma questa lettura: «Raul Gardini si suicidò perché la procura aveva
promesso che la sua confessione serviva per non andare in carcere, ma invece
scoprì che l'avrebbero arrestato». Processo Enimont, la «madre di tutte le
tangenti», l'epicentro del terremoto Tangentopoli. «La storia di quella
cosiddetta maxitangente, che poi invece, come diceva Craxi, era una maxiballa, è
ancora tutta da scrivere. - Pomicino lo spiega meglio - Alla politica andarono
15 o 20 miliardi, ma c'erano 500 miliardi in fondi neri. Dove sono finiti? A chi
sono andati? E chi ha coperto queste persone in questi anni? In parte l'ho
ricostruito, con documenti che ho, sui fondi Eni finiti a personaggi all'interno
dell'Eni. Ma di questo non si parla mai, e invece si pubblicano false
ricostruzioni della morte tragica di Gardini».
Ieri come
oggi la farsa continua.
Dopo 5 anni
arriva la sentenza di primo grado: l'ex-governatore dell'Abruzzo
Ottaviano del Turco è stato condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione
dal Tribunale collegiale di Pescara nell'inchiesta riguardo le presunti tangenti
nella sanità abruzzese. L’ex ministro delle finanze ed ex segretario generale
aggiunto della Cgil all’epoca di Luciano Lama è accusato di
associazione per delinquere, corruzione, abuso, concussione, falso. Il pm aveva
chiesto 12 anni. Secondo la Procura di Pescara l’allora governatore avrebbe
intascato 5 milioni di euro da Vincenzo Maria Angelini, noto
imprenditore della sanità privata, all’epoca titolare della casa di cura Villa
Pini.
«E' un
processo che è nato da una vicenda costruita dopo gli arresti, cioè
senza prove - attacca l'ex governatore dell'Abruzzo intervistato
al Giornale Radio Rai -. Hanno cercato disperatamente le prove
per 4 anni e non le hanno trovate e hanno dovuto ricorrere a una specie di
teorema e con il teorema hanno comminato condanne che non si usano più nemmeno
per gli assassini, in questo periodo. Io sono stato condannato esattamente a 20
anni di carcere come Enzo Tortora». E a Repubblica ha
poi affidato un messaggio-shock: «Ho un tumore, ma
voglio vivere per dimostrare la mia innocenza».
Lunedì 22
luglio 2013, giorno della sentenza, non si era fatto attendere il commento del
legale di Del Turco, Giandomenico Caiazza, che ha
dichiarato: «Lasciamo perdere se me lo aspettassi o no perchè questo
richiederebbe ragionamenti un pò troppo impegnativi. Diciamo che è una sentenza
che condanna un protagonista morale della vita politica istituzionale sindacale
del nostro paese accusato di aver incassato sei milioni e 250 mila euro a titolo
di corruzione dei quali non si è visto un solo euro. Quindi penso che sia un
precedente assoluto nella storia giudiziaria perchè si possono non trovare i
soldi ma si trovano le tracce dei soldi».
Nello
specifico, Del Turco è accusato insieme all’ex capogruppo del Pd alla Regione
Camillo Cesarone e a Lamberto Quarta,
ex segretario generale dell’ufficio di presidenza della Regione, di aver
intascato mazzette per 5 milioni e 800mila euro. Per questa vicenda fu arrestato
il 14 luglio 2008 insieme ad altre nove persone, tra le quali assessori e
consiglieri regionali. L’ex presidente finì in carcere a Sulmona (L'Aquila) per
28 giorni e trascorse altri due mesi agli arresti domiciliari. A seguito
dell’arresto, Del Turco il 17 luglio 2008 si dimise dalla carica di presidente
della Regione e con una lettera indirizzata all’allora segretario nazionale
Walter Veltroni si autosospese dal Pd, di cui era uno dei 45
saggi fondatori nonchè membro della Direzione nazionale. Le dimissioni
comportarono lo scioglimento del consiglio regionale e il ritorno anticipato
alle urne per i cittadini abruzzesi.
Del Turco
condannato senza prove. All'ex presidente dell'Abruzzo 9 anni e sei mesi per
presunte tangenti nella sanità. Ma le accuse non hanno riscontri: nessuna
traccia delle mazzette né dei passaggi di denaro, scrive Gian Marco Chiocci
su “Il Giornale”. In dubio pro reo. Nel dubbio - dicevano i latini - decidi a
favore dell'imputato. Duole dirlo, e non ce ne voglia il collegio giudicante del
tribunale di Pescara, ma la locuzione dei padri del diritto sembra sfilacciarsi
nel processo all'ex presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco.
Processo che in assenza di prove certe s'è concluso come gli antichi si
sarebbero ben guardati dal concluderlo: con la condanna del principale imputato
e dei suoi presunti sodali. Qui non interessa riaprire il dibattito sulle
sentenze da rispettare o sull'assenza o meno di un giudice a Berlino. Si tratta
più semplicemente di capire se una persona - che su meri indizi è finita prima
in cella e poi con la vita politica e personale distrutta - di fronte a un
processo per certi versi surreale, contraddistintosi per la mancanza di
riscontri documentali, possa beccarsi, o no, una condanna pesantissima a nove
anni e sei mesi (non nove mesi, come ha detto erroneamente in aula il giudice).
Noi crediamo di no. E vi spieghiamo perché. In cinque anni nessuno ha avuto il
piacere di toccare con mano le «prove schiaccianti» a carico dell'ex governatore
Pd di cui parlò, a poche ore dalle manette, l'allora procuratore capo Trifuoggi.
Un solo euro fuori posto non è saltato fuori dai conti correnti dell'indagato
eccellente, dei suoi familiari o degli amici più stretti, nemmeno dopo centinaia
di rogatorie internazionali e proroghe d'indagini. E se non si sono trovati i
soldi, nemmeno s'è trovata una traccia piccola piccola di quei soldi. Quanto
alle famose case che Del Turco avrebbe acquistate coi denari delle tangenti (sei
milioni di euro) si è dimostrato al centesimo esser state in realtà acquistate
con mutui, oppure prima dei fatti contestati o ancora coi soldi delle
liquidazioni o le vendite di pezzi di famiglia. Non c'è un'intercettazione
sospetta. Non un accertamento schiacciante. Non è emerso niente di clamoroso al
processo. Ma ciò non vuol dire che per i pm non ci sia «niente» posto che nella
requisitoria finale i rappresentanti dell'accusa hanno spiegato come l'ex
segretario della Cgil in passato avesse ricoperto i ruoli di presidente della
commissione parlamentare Antimafia e di ministro dell'Economia, e dunque fosse a
conoscenza dei «sistemi» criminali utilizzati per occultare i quattrini oltre
confine. Come dire: ecco perché i soldi non si trovano (sic !). Per arrivare a
un verdetto del genere i giudici, e in origine i magistrati di Pescara (ieri
assolutamente sereni prima della sentenza, rinfrancati dalla presenza a sorpresa
in aula del loro ex procuratore capo) hanno creduto alle parole del re delle
cliniche abruzzesi, Vincenzo Maria Angelini, colpito dalla scure della giunta di
centrosinistra che tagliava fondi alla sanità privata, per il quale i
carabinieri sollecitarono (invano) l'arresto per tutta una serie di ragioni che
sono poi emerse, e deflagrate, in un procedimento parallelo: quello aperto non a
Pescara bensì a Chieti dove tal signore è sotto processo per bancarotta per aver
distratto oltre 180 milioni di euro con operazioni spericolate, transazioni
sospette, spese compulsive per milioni e milioni in opere d'arte e beni di
lusso. Distrazioni, queste sì, riscontrate nel dettaglio dagli inquirenti
teatini. Da qui il sospetto, rimasto tale, che il super teste possa avere
utilizzato per sé (vedi Chieti) ciò che ha giurato (a Pescara) di avere passato
ai politici. Nel «caso Del Turco» alla mancanza di riscontri si è supplito con
le sole dichiarazioni dell'imprenditore, rivelatesi raramente precise e puntuali
come dal dichiarante di turno pretendeva un certo Giovanni Falcone. Angelini
sostiene che prelevava contanti solo per pagare i politici corrotti? Non è vero,
prelevava di continuo ingenti somme anche prima, e pure dopo le manette (vedi
inchiesta di Chieti). Angelini giura che andava a trovare Del Turco nella sua
casa di Collelongo, uscendo al casello autostradale di Aiello Celano? Non è
vero, come dimostrano i telepass, le testimonianze e le relazioni degli autisti,
a quel casello l'auto della sua azienda usciva prima e dopo evidentemente anche
per altri motivi. Angelini dice che ha incontrato Del Turco a casa il giorno x?
Impossibile, quel giorno si festeggiava il santo patrono e in casa i numerosi
vertici istituzionali non hanno memoria della gola profonda. Angelini porta la
prova della tangente mostrando una fotografia sfocata dove non si riconosce la
persona ritratta? In dibattimento la difesa ha fornito la prova che quella foto
risalirebbe ad almeno un anno prima, e così cresce il giallo del taroccamento.
Angelini corre a giustificarsi consegnando ai giudici il giaccone che indossava
quando passò la mazzetta nel 2007, e di lì a poco la casa produttrice della
giubba certifica che quel modello nel 2007 non esisteva proprio essendo stato
prodotto a far data 2011. Questo per sintetizzare, e per dire che le prove
portate da Angelini, che la difesa ribattezza «calunnie per vendetta», sono
tutt'altro che granitiche come una sana certezza del diritto imporrebbe. Se per
fatti di mafia si è arrivati a condannare senza prove ricorrendo alla
convergenza del molteplice (il fatto diventa provato se lo dicono più pentiti)
qui siamo decisamente oltre: basta uno, uno soltanto, e sei fregato. «Basta la
parola», recitava lo spot di un celebre lassativo. Nel dubbio, d'ora in poi, il
reo presunto è autorizzato a farsela sotto. Del Turco: "Ho un cancro, voglio
vivere per provare la mia innocenza". «Da tre mesi so di avere un tumore, da due
sono in chemioterapia. Domani andrò a Roma a chiedere al professor Mandelli di
darmi cinque anni di vita, cinque anni per dimostrare la mia innocenza e
riabilitare la giunta della Regione Abruzzo che ho guidato». A dichiararlo in
una intervista a Repubblica è Ottaviano Del Turco, condannato a nove anni e sei
mesi per presunte tangenti nella sanità privata abruzzese. «Mi hanno condannato
senza una prova applicando in maniera feroce il teorema Angelini, oggi in Italia
molti presidenti di corte sono ex pm che si portano dietro la cultura
accusatoria. Il risultato, spaventoso, sono nove anni e sei mesi basati sulle
parole di un bandito. Ho preso la stessa condanna di Tortora, e questo mi dà
sgomento». Il Pd? «Ha così paura dei giudici che non è neppure capace di
difendere un suo dirigente innocente», ha aggiunto Del Turco.
MA CHE
CAZZO DI GIUSTIZIA E’!?!?
Funziona alla
grande, la giustizia in Italia, scrive Marco Ventura su Panorama. Negli ultimi
tempi abbiamo assistito a punizioni esemplari, sentenze durissime nei confronti
di fior di criminali. Castighi detentivi inflitti da giudici inflessibili. Due
esempi per tutti. Il primo: Lele Mora e Emilio Fede condannati a 7 anni di
carcere e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici per aver “presentato”
Ruby a Silvio Berlusconi. Il secondo: Ottaviano Del Turco condannato a 9 anni e
6 mesi per le tangenti sulla sanità in Abruzzo, anche se i 6 milioni di mazzette
non sono mai stati trovati sui conti suoi o riconducibili a lui, e anche se il
suo grande accusatore ha dimostrato in diverse occasioni di non essere
attendibile nell’esibire “prove” contro l’ex governatore. In compenso, per
cinque imputati del processo sul naufragio della Costa Concordia (32 i morti,
più incalcolabili effetti economici, d’inquinamento ambientale e d’immagine
internazionale dell’Italia), sono state accettate le richieste di
patteggiamento. Risultato: a fronte di accuse come omicidio plurimo colposo e
lesioni colpose, ma anche procurato naufragio, i cinque ottengono condanne che
variano, a seconda delle responsabilità e dei reati contestati, da 1 anno e 8
mesi a 2 anni e 10 mesi. Tutto previsto dal codice. Tutto legale. Tutto
giuridicamente ineccepibile. Ma avverto un certo disagio se poi faccio
confronti. Se navigo nel web e scopro che mentre l’ex direttore del Tg4, Fede,
subisce la condanna a 7 anni di carcere per il caso Ruby, la stessa pena viene
inflitta a un tale che abusa della figlia di 8 anni e a un altro che, imbottito
di cocaina, travolge e uccide una diciottenne sulle strisce pedonali. E non
trovo altri colpevoli per crimini analoghi a quelli contestati a Fede a Milano,
né personaggi che abbiano pagato (o per i quali sia valsa la fatica di provare a
identificarli) per complicità nella pubblicazione di intercettazioni coperte da
segreto come qualcuno ben noto agli italiani, che di intercettazioni pubblicate
è vittima quasi ogni giorno. E temo pure che la percezione della pubblica
opinione sia molto distante dalla scala di gravità dei tribunali, almeno stando
a questi casi. Un anno e 8 mesi è un quarto della pena comminata a Fede. Ho
ancora nella mente, negli occhi, la scena della “Costa Concordia” coricata col
suo carico di morte per l’incosciente inchino al Giglio. E ricordo il massacro
dei media di tutto il mondo sull’Italietta di Schettino (l’unico per il quale
non ci sarà patteggiamento e che presumibilmente pagherà per intero le sue
colpe). Nei paesi anglosassoni con una tradizione marinara, colpe come quelle
emerse nella vicenda “Costa Concordia” sono trattate con la gravità che
meritano: la sicurezza è una priorità assoluta. Ciascuno di noi ha esperienza
diretta o indiretta di come funzioni la giustizia in Italia: della sua rapidità
o lentezza, della sua spietatezza o clemenza, dei suoi pesi e delle sue misure.
Une, doppie, trine. La lettera della legge e delle sentenze non combacia col
(buon) senso comune. Sarà un caso che la fiducia nelle toghe, in Italia, risulti
ai livelli più bassi delle classifiche mondiali?
Sul Foglio del
del 24 luglio 2013 Massimo Bordin spiega bene che nel processo Del Turco la
difesa ha dimostrato che in determinati giorni citati dai pm nel capo d'accusa,
l'ex governatore abruzzese sicuramente non aveva potuto commettere il reato che
gli era imputato. "E' vero" risponde l'accusa. Vorrà dire che cambieremo la
data" Capito? Le date non corrispondono così le cambieranno, elementare. Perché
Del Turco è, nella loro formazione barbarica, colpevole a prescindere. E quindi
quel corpo lo vogliono, anche senza prove. Tutto per loro. Dunque, ecco a voi
servita "l'indipendenza della magistratura". A me avevano insegnato che per
essere indipendenti, bisogna prima esseri liberi. E per essere liberi, bisogna
essere soprattutto Responsabili. A questi giudici gli si potrebbe sicuramente
attribuire una certa inclinazione alla libertà, ma intesa come legittimazione a
delinquere. E' vero, Del Turco non sarà Tortora. Ma il comportamento da canaglie
di alcuni magistrati italiani - salvaguardato da sessant'anni da giornali e
apparati - continua e continuerà ad avere, nel tempo, lo stesso tanfo di sempre.
E che dire del Processo Mediaset. Un processo "assurdo e risibile", per di più
costato ai contribuenti "una ventina di milioni di euro". I conti, e le
valutazioni politiche, sono del Pdl che mette nero su bianco i motivi per cui
"in qualunque altra sede giudiziaria, a fronte di decisioni consimili si sarebbe
doverosamente ed immediatamente pervenuti ad una sentenza più che assolutoria.
Ma non a Milano". "Il 'processo diritti Mediaset', così convenzionalmente
denominato, è basato su una ipotesi accusatoria così assurda e risibile che in
presenza di giudici non totalmente appiattiti sull'accusa e "super partes",
sarebbe finito ancor prima di iniziare, con grande risparmio di tempo per i
magistrati e di denaro per i contribuenti", si legge nel documento politico
elaborato dal Pdl a proposito del processo "diritti Mediaset", "dopo una
approfondita analisi delle carte processuali". "Basti pensare - scrive ancora il
Pdl - che una sola delle molte inutili consulenze contabili ordinate dalla
Procura è costata ai cittadini quasi tre milioni di euro. Non è azzardato
ipotizzare che tra consulenze, rogatorie ed atti processuali questa vicenda sia
già costata allo Stato una ventina di milioni di euro".
Del Turco
come Tortora.
Un punto di
vista (di sinistra) contro la condanna dell'ex governatore Del Turco. Il caso
Del Turco come il caso Tortora: Una condanna senza indizi né prove, scrive Piero
Sansonetti il 23 luglio 2013 su “Gli Altri. Il problema non è quello della
persecuzione politica o dell’accanimento. La persecuzione è lo spunto, ma il
problema è molto più grave: se la cosiddetta “Costituzione materiale” si
adatterà al metodo (chiamiamolo così) Del Turco-Minetti, la giustizia in Italia
cambierà tutte le sue caratteristiche, sostituendosi allo stato di diritto. E ci
rimetteranno decine di migliaia di persone. E saranno riempite le carceri di
persone innocenti. Non più per persecuzione ma per “burocrazia” ed eccesso di
potere. Il rischio è grandissimo perché, in qualche modo, prelude ad un salto di
civiltà. Con le sentenze contro Minetti e, neppure sette giorni dopo, contro Del
Turco, la magistratura ha maturato una svolta fondata su due pilastri: il primo
è la totale identificazione della magistratura giudicante con la magistratura
inquirente: tra le due magistrature si realizza una perfetta integrazione e
collaborazione (non solo non c’è separazione delle carriere ma viene stabilita
la unità e l’obbligo di lealtà e di collaborazione attiva); il secondo pilastro
è la cancellazione, anzi proprio lo sradicamento del principio di presunzione di
innocenza. Nel caso della Minetti (accusata di avere organizzato una festa e per
questo condannata a cinque anni di carcere) al processo mancavano, più che le
prove, il reato. E infatti i giudici, in assenza di delitti definibili
giuridicamente, sono ricorsi al “favoreggiamento”. L’hanno condannata per aver
“favorito” un festino. Nel caso di Del Turco il reato c’era, ma erano del tutto
assenti le prove, e anzi – cosa più grave – i pochi indizi racimolati si sono
rivelati falsi durante il processo. Non solo mancavano le prove, e persino gli
indizi, ma mancava il corpo del reato. In questi casi è difficile la condanna
anche in situazioni di dittatura. I giudici hanno deciso allora di usare questo
nuovo principio: è vero che non ci sono né prove né indizi a carico
dell’imputato, però la sua difesa ha mostrato solo indizi di innocenza e non una
prova regina. E hanno stabilito che non sono consentite “assoluzioni
indiziarie”, decidendo di conseguenza la condanna con una nuova formula:
insufficienza di prove a discolpa. Avete presenti quei processi americani nei
quali il giudice a un certo punto chiede ai giurati: “siete sicuri, oltre ogni
ragionevole dubbio, della colpevolezza dell’imputato?”. In America basta che un
solo giurato dica: “no, io un piccolo dubbio ce l’ho ancora…” e l’imputato è
assolto. Può essere condannato solo all’unanimità e senza il più piccolo dubbio.
Con Del Turco si è fatto al contrario: i giurati hanno stabilito che a qualcuno
(per esempio a Travaglio) poteva essere rimasto qualche ragionevole dubbio sulla
sua innocenza. E gli hanno rifilato 10 anni di carcere, come fecero una trentina
d’anni fa con Enzo Tortora. Con Tortora i Pm avevano lavorato sulla base di
indizi falsi o del tutto inventati. In appello Tortora fu assolto, il mondo
intero si indignò, ma i pubblici ministeri non ricevettero neppur una noticina
di censura e fecero delle grandi carrierone. Sarà così anche con Del Turco. Per
oggi dobbiamo però assistere allo spettacolo di uno dei protagonisti della
storia del movimento operaio e sindacale italiano condannato sulla base
esclusivamente dell’accusa di un imprenditore che probabilmente non aveva
ottenuto dalla Regione quello che voleva.
Toghe
impunite e fannullone: loro il problema della giustizia.
Le condanne
abnormi sono ormai quotidiane: da Tortora a Del Turco, è colpa dei magistrati.
Ma non si può dire. Su Libero di mercoledì 24 luglio il commento di
Filippo Facci: "Toghe impunite e fannullone. Così c'è un Del Turco al giorno".
Secondo Facci le condanne abnormi sono ormai quotidiane: dal caso Tortora a oggi
il problema giustizia, spiega, è colpa dei magistrati. Ma è vietato dirlo. I
casi Del Turco durano un giorno, ormai: scivolano subito in una noia mediatica
che è generazionale. La verità è che l’emergenza giustizia e l’emergenza
magistrati (ripetiamo: magistrati) non è mai stata così devastante: solo che a
forza di ripeterlo ci siamo sfibrati, e l’accecante faro del caso Berlusconi ha
finito per vanificare ogni battaglia. E’ inutile girarci attorno: in nessun
paese civile esiste una magistratura così, una casta così, una sacralità e
un’intangibilità così.
Accade, nelle
carceri italiani, che persone indagate per i reati più disparati vengano
sbattute in cella per obbligarle a vuotare il sacco. Accade anche che le chiavi
che danno la libertà vengano dimenticate in un cassetto per settimane, se non
mesi. In barba al principio di non colpevolezza fino al terzo grado di giudizio.
Tanto che il carcere preventivo diventa una vera e propria tortura ad uso
e consumo delle toghe politicizzate. Toghe che con tipi loschi come gli
stupratori si trasformano in specchiati esempi di garantismo. No alla
custodia cautelare in carcere per il reato di violenza sessuale di gruppo
qualora il caso concreto consenta di applicare misure alternative. Lo ha
stabilito la Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 275, comma 3, terzo periodo, del Codice di
procedura penale. I «gravi indizi di colpevolezza». si legge nella motivazione,
non rendono automatica la custodia in carcere. La decisione segue quanto già
stabilito in relazione ad altri reati, tra cui il traffico di stupefacenti,
l'omicidio, e delitti a sfondo sessuale e in materia di immigrazione. La norma
“bocciata” dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.232 depositata il 23
luglio 2013, relatore il giudice Giorgio Lattanzi, prevede che quando sussistono
gravi indizi di colpevolezza per il delitto di violenza sessuale di gruppo si
applica unicamente la custodia cautelare in carcere. Ora la Consulta ha
stabilito che, se in relazione al caso concreto, emerga che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, il giudice può
applicarle. Nella sentenza, peraltro, la Corte conferma la gravità del reato, da
considerare tra quelli più «odiosi e riprovevoli». Ma la «più intensa lesione
del bene della libertà sessuale», «non offre un fondamento giustificativo
costituzionalmente valido al regime cautelare speciale previsto dalla norma
censurata», scrive la Corte. Alla base del pronunciamento una questione di
legittimità sollevata dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno.
Richiamando anche precedenti decisioni la Consulta ricorda in sentenza come «la
disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del “minore
sacrificio necessario”: la compressione della libertà personale deve essere,
pertanto, contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le
esigenze cautelari del caso concreto. Ciò impegna il legislatore, da una parte,
a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della “pluralità
graduata”, predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da
differenti gradi di incidenza sulla libertà personale, e, dall’altra, a
prefigurare criteri per scelte “individualizzanti” del trattamento cautelare,
parametrate sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete».
Sul punto si era pronunciata analogamente la Corte di Cassazione nel 2012,
accogliendo il ricorso di due imputati per lo stupro subìto da una minorenne a
Cassino. Il Tribunale di Roma aveva confermato il carcere nell'agosto 2011, ma
la Cassazione motivò così la sua decisione: «L'unica interpretazione compatibile
con i principi fissati dalla sentenza 265 del 2010 della Corte Costituzionale è
quella che estende la possibilità per il giudice di applicare misure diverse
dalla custodia in carcere anche agli indagati sottoposti a misura cautelare per
il reato previsto all'art. 609 octies c.p.». In pratica recependo il dettato
della Consulta del 2010 e l'indicazione della Corte di Strasburgo.
Da questo si
evince che la Corte Costituzionale se ne infischia della violenza sessuale di
gruppo. Oggi le toghe hanno, infatti, deciso che gli stupratori non dovranno
scontare la custodia cautelare in carcere qualora il caso concreto consenta di
applicare misure alternative. Nessuna preoccupazione, da parte dei giudici
costituzionalisti, che le violenze possano essere reiterate. La beffa maggiore?
Nella sentenza, della Corte costituzionale le toghe si premurano di confermare
la gravità del reato invitando i giudici a considerarlo tra quelli più "odiosi e
riprovevoli". Non abbastanza - a quanto pare - per assicurarsi che lo stupratore
non commetta più la brutale violenza di cui si macchia. "La più intensa lesione
del bene della libertà sessuale - si legge nella sentenza shock redatta dalla
Corte - non offre un fondamento giustificativo costituzionalmente valido al
regime cautelare speciale previsto dalla norma censurata". Alla base del
pronunciamento della Consulta c'è una questione di legittimità sollevata dalla
sezione riesame del Tribunale di Salerno. Richiamando anche precedenti
decisioni, la Consulta ricorda come la disciplina delle misure cautelari
debba essere ispirata al criterio del "minore sacrificio necessario". Già nel
2010 la Corte aveva bocciato le norme in materia di misure cautelari nelle parti
in cui escludevano la facoltà del giudice di decidere se applicare la custodia
cautelare in carcere o un altro tipo di misura cautelare per chi ha abusato di
un minore. Insomma, adesso appare chiaro che il carcere preventivo sia una
misura "cautelare" pensata ad hoc per far fuori gli avversari politici.
Nemmeno per gli stupratori è più prevista.
Stupro,
dalla parte dei carnefici: niente carcere (per un po’) per il branco. Firmato:
Corte Costituzionale,
scrive Deborah Dirani su Vanity Fair. C’era una volta, 3 anni fa, a Cassino,
comune ciociaro di 33 mila anime (per la maggior parte buone), una ragazzina che
non aveva ancora compiuto 18 anni ed era molto graziosa. Sgambettava tra libri e
primi “ti amo” sussurrati all’orecchio del grande amore, e pensava che la vita
fosse bella. Pensava che il sole l’avrebbe sempre scaldata, che le avrebbe
illuminato la vita ogni giorno. Non pensava che il sole potesse scomparire, che
potesse tramontare e non tornare più a riscaldarle la pelle, a illuminarle la
vita. Ma un giorno, un giorno di 3 anni fa, il suo sole tramontò oscurato dal
buio di due ragazzi del suo paese, due che la volevano e, dato che con le buone
non erano riusciti a prenderla, quel giorno scuro decisero di ricordarle che la
donna è debole e l’uomo è forte. Così, quei due maschi del suo paese, la
stuprarono, assieme, dandosi il cambio, a turno. Lei non voleva, lei piangeva,
lottava, mordeva e graffiava con le sue unghie dipinte di smalto. Lei urlava, ci
provava, perché poi quelli erano in due e si ritrovava sempre con una mano sulla
bocca che la faceva tacere, che non la faceva respirare. Ma gli occhi quella
ragazzina li aveva aperti a cercare quelli di quei due, a chiedere pietà, a
scongiurarli di ritirarsi su i pantaloni, di uscire da lei, che le facevano
male, nel cuore, più ancora che tra le gambe. Raccontano che quella ragazzina
oggi non viva più nel suo paese, che quella notte sia scesa sulla sua vita e
ancora non l’abbia lasciata. Raccontano che non esca di casa, che soffra di
depressione e attacchi di panico. Raccontano che il suo buio sia denso come il
petrolio. Raccontano che sia come un cormorano con le ali zuppe di olio nero che
non può più volare. Raccontano anche che quando, a pochi mesi dal giorno
più brutto della sua vita, la Corte di Cassazione ha stabilito che i suoi due
stupratori non dovessero stare in custodia cautelare in carcere, ma potessero
(in attesa della sentenza definitiva) essere trattenuti ai domiciliari, lei
abbia pensato che Rino Gaetano non avesse mica ragione a cantare che il cielo è
sempre più blu. Secondo la Cassazione, la galera (prevista da una legge
approvata dal Parlamento nel 2009 che stabiliva che dovesse stare in carcere
chiunque avesse abusato di una minorenne) non era giusta per quei due bravi
figlioli perché quella stessa legge del 2009 violava gli articoli 3 (uguaglianza
davanti alla legge), 13 (libertà personale) e 27 (funzione rieducativa della
pena) della Costituzione. Secondo i giudici, insomma, ci sono misure alternative
al carcere (nella fattispecie gli arresti domiciliari) alle quali ricorrere in
casi come questo. Questo che, per la cronaca, è uno stupro di gruppo. I giorni
passano, la vita continua, le sentenze si susseguono e quella della Cassazione
apre un’autostrada a 4 corsie per chi, in compagnia di un paio di amici, prende
una donna le apre le gambe e la spacca a metà. Così la Corte Costituzionale, la
Suprema Corte, con una decisione barbara, incivile, retrograda, vigliacca,
pilatesca, giusto poche ore fa, ha dichiarato illegittimo l’articolo 275, comma
3, periodo terzo del Codice di Procedura Penale che prevede che gravi indizi di
colpevolezza rendano automatica la custodia cautelare in carcere per chi
commette il reato previsto all’articolo 609 octies del Codice Penale: lo stupro
di gruppo (niente carcere subito per chi violenta in gruppo, non importa, dice
la Corte Costituzionale). Fortuna che quella ragazzina, che lo stupro di gruppo
lo ha provato sulla sua luminosa pelle di adolescente, non può guardare in
faccia i giudici di quella che si chiama Suprema Corte che hanno sentenziato
che i suoi stupratori in galera non ci debbano andare (almeno fino al terzo
grado di giudizio), ma che possano beatamente starsene ai domiciliari. Che
possano evadere dai domiciliari (fossero i primi), possano prendere un’altra
ragazzina, un’altra donna, un’altra mamma, una vedova, una che comunque in mezzo
alle gambe ha un taglio e abusarne a turno, per ore, per giorni. Fino a quando
ne hanno voglia. E poi, ritirati su i pantaloni, possano tonarsene a casa, ai
domiciliari, che il carcere chissà se e quando lo vedranno. Bastardi, loro, e
chi non fa giustizia. Che una donna non è un pezzo di carne con un taglio tra le
gambe. Questa ragazzina non era quello che quei due maschi avevano visto in lei:
un pezzo di carne, giovane, con un taglio in cui entrare a forza. No, non era un
pezzo di carne, era un essere umano, e la Corte Costituzionale, la CORTE
COSTITUZIONALE, non un giudice qualunque oberato e distratto di carte e senza un
cancelliere solerte, ha certificato che il suo dolore non meritava nemmeno la
consolazione che si dovrebbe alle vittime, agli esseri umani umiliati e offesi.
Chi ha negato a questa giovane donna il diritto a credere nel sole della
giustizia non è in galera, oggi. Chi da oggi lo negherà a qualunque donna: a voi
che mi leggete, alle vostre figlie, mamme, nonne, sorelle, non andrà in galera.
Non ci andrà fino a quando l’ultimo grado di giudizio non avrà stabilito che sì,
in effetti, un po’ di maschi che tengono ferma una donna e che a turno le
entrano dentro al corpo e all’anima, sono responsabili del suo dolore, del buio
in cui l’hanno sepolta. E allora, voglio le parole della presidente della
Camera, del ministro per le Pari opportunità, voglio le parole di ogni donna: le
voglio sentire perché non serve essere femministe e professioniste delle
dichiarazioni per scendere in piazza, in tutte le piazze, e incazzarsi. Non ci
vuole sempre un capo del Governo antipatico e discutibile per fare scendere in
piazza noi donne. Perché: SE NON OGGI, QUANDO?
Bene, allora
cari italiani: TUTTI DENTRO, CAZZO!!
LA LEGGE
NON E’ UGUALE PER TUTTI.
Tutti dentro
se la legge fosse uguale per tutti. Ma la legge non è uguale per tutti. Così la
Cassazione si è tradita.
Sconcertante
linea delle Sezioni unite civili sul caso di un magistrato sanzionato. La
Suprema Corte: vale il principio della discrezionalità. E le toghe di Md si
salvano, scrive
Stefano Zurlo
su “Il Giornale”. La legge è uguale per tutti. Ma non al tribunale dei giudici.
Vincenzo Barbieri, toga disinvolta, viene inchiodato dalle intercettazioni
telefoniche, ma le stesse intercettazioni vengono cestinate nel caso di Paolo
Mancuso, nome storico di Magistratura democratica. Eduardo Scardaccione, altro
attivista di Md, la corrente di sinistra delle toghe italiane, se la cava anche
se ha avuto la faccia tosta di inviare un pizzino al collega, prima
dell'udienza, per sponsorizzare il titolare di una clinica. Assolto pure lui,
mentre Domenico Iannelli, avvocato generale della Suprema corte, si vede
condannare per aver semplicemente sollecitato una sentenza attesa da quasi sette
anni. Sarà un caso ma il tribunale disciplinare funziona così: spesso i giudici
al di fuori delle logiche correntizie vengono incastrati senza pietà. Quelli che
invece hanno un curriculum sfavillante, magari a sinistra, magari dentro Md,
trovano una via d'uscita. Non solo. Quel che viene stabilito dalla Sezione
disciplinare del Csm trova facilmente sponda nel grado superiore, alle Sezioni
unite civili della Cassazione, scioglilingua chilometrico, come i titoli dei
film di Lina Wertmüller, per indicare la più prestigiosa delle corti. E proprio
le Sezioni unite civili della Cassazione, nei mesi scorsi, hanno teorizzato il
principio che sancisce la discrezionalità assoluta per i procedimenti
disciplinari: se un magistrato viene punito e l'altro no, si salva anche se la
mancanza è la stessa, pazienza. Il primo se ne dovrà fare una ragione. Testuale.
Così scrive l'autorevolissimo collegio guidato da Roberto Preden, dei Verdi,
l'altra corrente di sinistra della magistratura italiana, e composto da eminenti
giuristi come Renato Rordorf e Luigi Antonio Rovelli, di Md, e Antonio Segreto
di Unicost, la corrente di maggioranza, teoricamente centrista ma spesso
orientata a sua volta a sinistra. A lamentarsi è Vincenzo Brancato, giudice di
Lecce, incolpato per gravi ritardi nella stesura delle sentenze e di altri
provvedimenti. La Cassazione l'ha condannato e le sezioni unite civili
confermano ribadendo un principio choc: la legge non è uguale per tutti. O
meglio, va bene per gli altri, ma non per i giudici. Un collega di Lecce, fa
notare Brancato, ha avuto gli stessi addebiti ma alla fine è uscito indenne dal
processo disciplinare. Come mai? È tutto in regola, replica il tribunale di
secondo grado. «La contraddittorietà di motivazione - si legge nel verdetto del
25 gennaio 2013 - va colta solo all'interno della stessa sentenza e non dal
raffronto fra vari provvedimenti, per quanto dello stesso giudice». Chiaro? Si
può contestare il diverso trattamento solo se i due pesi e le due misure
convivono dentro lo stesso verdetto. Altrimenti ci si deve rassegnare. E poiché
Brancato e il collega più fortunato, valutato con mano leggera, sono
protagonisti di due sentenze diverse, il caso è chiuso. Senza se e senza ma: «Va
ribadito il principio già espresso da queste sezioni unite secondo cui il
ricorso avverso le pronunce della sezione disciplinare del Csm non può essere
rivolto a conseguire un sindacato sui poteri discrezionali di detta sezione
mediante la denuncia del vizio di eccesso di potere, attesa la natura
giurisdizionale e non amministrativa di tali pronunce». Tante teste, tante
sentenze. «Pertanto non può censurarsi il diverso metro di giudizio adottato
dalla sezione disciplinare del Csm nel proprio procedimento rispetto ad altro,
apparentemente identico, a carico di magistrato del medesimo ufficio
giudiziario, assolto dalla stessa incolpazione». Tradotto: i magistrati, nelle
loro pronunce, possono far pendere la bilancia dalla parte che vogliono. Il
principio è srotolato insieme a tutte le sue conseguenze e porta il timbro di
giuristi autorevolissimi, fra i più titolati d'Italia. È evidente che si tratta
di una massima sconcertante che rischia di creare figli e figliastri. È, anche,
sulla base di questo ragionamento che magistrati appartenenti alle correnti di
sinistra, in particolare Md, così come le toghe legate alle corporazioni più
strutturate, sono stati assolti mentre i loro colleghi senza reti di rapporti o
di amicizie sono stati colpiti in modo inflessibile. Peccato che questo
meccanismo vada contro la Convenzione dei diritti dell'uomo: «L'articolo 14
vieta di trattare in modo differente, salvo giustificazione ragionevole e
obiettiva, persone che si trovino in situazioni analoghe». Per i giudici
italiani, a quanto pare, questo criterio non è valido. Non solo. La stessa
Cassazione, sezione Lavoro, afferma che la bilancia dev'essere perfettamente in
equilibrio. Il caso è quello di due dipendenti Telecom che avevano usato il
cellulare aziendale per conversazioni private. Il primo viene licenziato, il
secondo no. E dunque quello che è stato spedito a casa si sente discriminato e
fa causa. La Cassazione gli dà ragione: «In presenza del medesimo illecito
disciplinare commesso da più dipendenti, la discrezionalità del datore di lavoro
non può trasformarsi in arbitrio, con la conseguenza che è fatto obbligo al
datore di lavoro di indicare le ragioni che lo inducono a ritenere grave il
comportamento illecito di un dipendente, tanto da giustificare il licenziamento,
mentre per altri dipendenti è applicata una sanzione diversa». Il metro
dev'essere sempre lo stesso. Ma non per i magistrati, sudditi di un potere
discrezionale che non è tenuto a spiegare le proprie scelte. La regola funziona
per i dipendenti Telecom, insomma, per i privati. Non per i magistrati e il loro
apparato di potere. La legge è uguale per tutti ma non tutti i magistrati sono
uguali davanti alla legge. La Legge che non sia uguale per tutti è pacifico.
Invece è poco palese la sua conoscenza, specie se in Italia è tutto questione di
famiglia. Famiglia presso cui si devono lavare i panni sporchi.
Quando anche
per i comunisti è tutto questione di famiglia.
Luigi
Berlinguer (ex ministro PD) è il cugino di Bianca Berlinguer (direttrice del Tg3
e figlia di Enrico) che è sposata con Luigi Manconi (senatore PD, fondatore e
presidente dell’Associazione “A Buon Diritto”) che è cognato di Luca Telese
(giornalista La7 e Canale 5) che è marito di Laura Berlinguer (giornalista
MEDIASET) che è cugina di Sergio Berlinguer (consigliere di Stato), fratello di
Luigi e cugino di Enrico.
Bene, allora
cari italiani: TUTTI DENTRO, CAZZO??? QUASI TUTTI!!!!
ITALIA
PAESE DELL’IMMUNITA’ E DELLA CENSURA. PER L’EUROPA INADEMPIENTE SU OGNI NORMA.
La Commissione
europea, la Corte Europea dei diritti dell’uomo e “Le Iene”, sputtanano. Anzi,
“Le Iene” no!!
E la stampa
censura pure…..
Pensavo di
averle viste tutte.
La
Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione
contro l'Italia perchè non adegua la sua normativa sulla
responsabilità civile dei giudici al diritto comunitario.
Bruxelles si aspetta che il governo nostrano estenda la
casistica per i risarcimenti "cagionati nell’esercizio delle
funzioni giudiziarie". Casistica regolata da una legge del 1988
e assai stretta: il legislatore prevede che le toghe rispondano in prima persona
solo in caso di dolo o colpa grave nel compimento dell'errore
giudiziario. Qual è il problema per l'Ue? Si chiede “Libero Quotidiano”. Che i
giudici italiani sono chiamati a pagare per i propri errori in casi troppo
ristretti, godendo di una normativa che non solo li avvantaggia rispetto ad
altri lavoratori e professionisti italiani, ma
anche rispetto ai propri colleghi europei. La legge italiana
117/88 restringe la responsabilità dei giudici ai soli casi di
errore viziato da "dolo e colpa grave". E, come se non fosse abbastanza, il
legislatore assegna l'onere della prova (ovvero la dimostrazione del dolo e
della colpa del giudice) al querelante che chiede
risarcimento per il danno subito. Per l'Ue troppo
poco. La Commissione Ue chiede all'Italia di conformarsi al diritto comunitario.
Innanzitutto via l'onere della dimostrazione del dolo e della colpa. E poi
estensione della responsabilità del giudice di ultima istanza anche ai casi di
sbagliata interpretazione delle leggi e di errata valutazione
delle prove, anche senza il presupposto della malevolezza della toga
verso l'imputato. Anche per colpa semplice, insomma. E, comunque, non pagano i
giudici, paghiamo noi.
Inoltre su un
altro punto è intervenuta l’Europa. Condannare un giornalista alla prigione è
una violazione della libertà d’espressione, salvo casi eccezionali come
incitamento alla violenza o diffusione di discorsi razzisti. A stabilirlo,
ancora una volta. è la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza in cui
dà ragione a Maurizio Belpietro, direttore di Libero, condannato a quattro anni
dalla Corte d’Appello di Milano.
La
Convenzione e la Corte europea dei diritti dell’uomo ampliano il diritto di
cronaca (“dare e ricevere notizie”) e proteggono il segreto professionale
dei giornalisti. No alle perquisizioni in redazione! Il giudice nazionale deve
tener conto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo ai fini
della decisione, anche in corso di causa, con effetti immediati e assimilabili
al giudicato: è quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n.
19985 del 30/9/2011.
Cedu.
Decisione di Strasburgo. Il diritto di cronaca va sempre salvato. Per i giudici
l'interesse della collettività all'informazione prevale anche quando la fonte
siano carte segretate, scrive Marina Castellaneta per Il Sole 24 Ore il
17/4/2012. La Corte europea dei diritti dell'uomo pone un freno alle
perquisizioni nei giornali e al sequestro da parte delle autorità inquirenti dei
supporti informatici dei giornalisti. Con un preciso obiettivo. Salvaguardare il
valore essenziale della libertà di stampa anche quando sono pubblicate notizie
attinte da documenti coperti da segreto. Lo ha chiarito la Corte dei diritti
dell'uomo nella sentenza depositata il 12 aprile 2012 (Martin contro Francia)
che indica i criteri ai quali anche i giudici nazionali devono attenersi nella
tutela del segreto professionale dei giornalisti per non incorrere in una
violazione della Convenzione e in una condanna dello Stato. A Strasburgo si
erano rivolti quattro giornalisti di un quotidiano francese che avevano
pubblicato un resoconto di documenti della Corte dei conti che riportavano
anomalie nell'amministrazione di fondi pubblici compiute da un ex governatore
regionale. Quest'ultimo aveva agito contro i giornalisti sostenendo che era
stato leso il suo diritto alla presunzione d'innocenza anche perché erano stati
pubblicati brani di documenti secretati. Il giudice istruttore aveva ordinato
una perquisizione nel giornale con il sequestro di supporti informatici, agende
e documenti annotati. Per i giornalisti non vi era stato nulla da fare. Di qui
il ricorso a Strasburgo che invece ha dato ragione ai cronisti condannando la
Francia per violazione del diritto alla libertà di espressione (articolo 10
della Convenzione). Per la Corte la protezione delle fonti dei giornalisti è una
pietra angolare della libertà di stampa. Le perquisizioni nel domicilio e nei
giornali e il sequestro di supporti informatici con l'obiettivo di provare a
identificare la fonte che viola il segreto professionale trasmettendo un
documento ai giornalisti compromettono la libertà di stampa. Anche perché il
giornalista potrebbe essere dissuaso dal fornire notizie scottanti di interesse
della collettività per non incorrere in indagini. È vero - osserva la Corte -
che deve essere tutelata la presunzione d'innocenza, ma i giornalisti devono
informare la collettività. Poco contano - dice la Corte - i mezzi con i quali i
giornalisti si procurano le notizie perché questo rientra nella libertà di
indagine che è inerente allo svolgimento della professione. D'altra parte, i
giornalisti avevano rispettato le regole deontologiche precisando che i fatti
riportati erano ricavati da un rapporto non definitivo. Giusto, quindi, far
conoscere al pubblico le informazioni in proprio possesso sulla gestione di
fondi pubblici.
Ed ancora. La
Corte europea dei diritti dell’Uomo ha accolto il ricorso presentato dall’autore
di “Striscia la notizia”, Antonio Ricci, per violazione dell’art. 10 della
Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Il ricorso era stato presentato in
seguito alla sentenza con la quale, nel 2005, la Corte di cassazione – pur
dichiarando la prescrizione del reato – aveva ritenuto integrato il reato
previsto dall’art. 617 quater e 623 bis c.p., per avere “Striscia la notizia”
divulgato nell’ottobre del 1996 un fuori onda della trasmissione di Rai3
“L’altra edicola”, con protagonisti il filosofo Gianni Vattimo e lo scrittore
Aldo Busi che se ne dicevano di tutti i colori.
I fatti
risalgono al 1996 e c'erano voluti 10 anni perchè la Cassazione ritenesse Ricci
colpevole per la divulgazione del fuori onda di Rai Tre.
«Superando le
eccezioni procedurali interposte dal Governo Italiano, che - dicono i legali di
Ricci, Salvatore Pino e Ivan Frioni - ha provato a scongiurare una pronuncia che
entrasse nel merito della vicenda, ha ottenuto l’auspicato risarcimento morale,
sancito dalla Corte che – al termine di una densa motivazione – ha riconosciuto
la violazione dell’art. 10 della Convenzione, posto a tutela della libertà
d’espressione».
«La Corte – dopo aver
riconosciuto che “il rispetto della vita privata e il diritto alla libertà
d’espressione meritano a priori un uguale rispetto”
– diversamente da quanto sostenuto dai giudici italiani, “che -spiega l’avvocato
Salvatore Pino- avevano escluso la possibilità stessa di un bilanciamento – ha
ritenuto che la condanna di Antonio Ricci abbia costituito un’ingerenza nel suo
diritto alla libertà di espressione garantito dall’articolo 10 § 1 della
Convenzione ed ha altresì stigmatizzato la sproporzione della pena applicata
rispetto ai beni giuridici coinvolti e dei quali era stata lamentata la
lesione».
«Sono felice
per la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo - ha commentato
Antonio Ricci, creatore di Striscia la notizia.- La condanna aveva veramente
dell’incredibile, tra l’altro sia in primo che in secondo grado la Pubblica
Accusa aveva chiesto la mia assoluzione. E' una vittoria di Antonio Ricci
contro lo Stato italiano, per questo la sentenza di Strasburgo è molto
importante». E' soddisfatto il patron di Striscia la notizia per quella
che ritiene essere stata una vittoria di principio. «Il fatto che l'Europa si
sia pronunciata a mio favore - ha dichiarato Ricci - implica che esiste una
preoccupazione in merito alla libertà d'espressione nel nostro Paese». Una
vittoria importante nella battaglia per la libertà d'espressione che segna un
punto a favore di Ricci e che pone ancora una volta l'accento sui lacci e
lacciuoli con i quali bisogna fare i conti in Italia quando si cerca di fare
informazione, come spiega lo stesso Ricci nella video intervista. «Quante volte
sono andati in onda dei fuori onda - si è chiesto Ricci - E nessuno è mai stato
punito? Per questo sono voluto andare fino in fondo, la mia è stata una
battaglia di principio».
Trattativa
stato-mafia, Ingroia rientra nel processo come avvocato parte civile.
Rappresenta l'associazione vittime della strage di via Georgofili. Si presenta
con la sua vecchia toga, abbracciato dagli amici pm. Antonio Ingroia, nelle
vesti di avvocato di parte civile. Il leader di Azione civile rappresenta
l'associazione dei familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili,
presieduta da Giovanna Maggiani Chelli. Ingroia sarà il sostituto processuale
dell'avvocato Danilo Ammannato. Antonio Ingroia denunciato per
esercizio abusivo della professione? Il rischio c'è. Il segretario dell’Ordine
di Roma, dove Ingroia è iscritto, e il presidente del Consiglio di Palermo, dove
sarebbe avvenuto l’esercizio abusivo della professione, ritengono "che
prima di potere esercitare la professione l’avvocato debba giurare davanti al
Consiglio".
Ed Ancora.
Bruxelles avvia un'azione contro l'Italia per l'Ilva di Taranto. La Commissione
"ha accertato" che Roma non garantisce che l'Ilva rispetti le prescrizioni Ue
sulle emissioni industriali, con gravi conseguenze per salute e ambiente. Roma è
ritenuta "inadempiente" anche sulla norma per la responsabilità ambientale. La
Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione sull’Ilva per
violazione delle direttive sulla responsabilità ambientale e un’altra sul
mancato adeguamento della legislazione italiana alle direttive europee in
materia di emissioni industriali. Le prove di laboratorio «evidenziano un forte
inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde
acquifere, sia sul sito dell'Ilva, sia nelle zone abitate adiacenti della città
di Taranto. In particolare, l'inquinamento del quartiere cittadino di Tamburi è
riconducibile alle attività dell'acciaieria». Oltre a queste violazioni della
direttiva IPPC e al conseguente inquinamento, risulta che «le autorità italiane
non hanno garantito che l'operatore dello stabilimento dell'Ilva di Taranto
adottasse le misure correttive necessarie e sostenesse i costi di tali misure
per rimediare ai danni già causati».
Bene. Di tutto
questo la stampa si guarda bene di indicare tutti i responsabili, non fosse
altro che sono i loro referenti politici. Ma sì, tanto ci sono “Le Iene” di
Italia 1 che ci pensano a sputtanare il potere.
Cosa????
Invece “Le
Iene” ci ricascano. Tralasciamo il fatto che è da anni che cerco un loro
intervento a pubblicizzare l’ignominia dell’esame forense truccato, ma tant’è.
Ma parliamo di altro. La pubblicazione del video di Alessandro Carluccio
denuncia la censura de “Le Iene” su Francesco Amodeo, quando Francesco ha
parlato è stato censurato...non serve parlare !! il Mes, il gruppo Bilderberg,
Mario Monti, Enrico Letta, Giorgio Napolitano, il Signoraggio Bancario, la
Guerra Invisibile,...e tanta truffa ancora!!! Alessandro Carluccio, il bastardo
di professione .. "figlio di iene"….indaga,..spiegando che non è crisi.. è
truffa..se accarezzi la iena rischi di esser azzannato...in quanto la iena
approfitta delle prede facili...ma se poi dopo diventi il leone sono costrette a
scappare...un faccia a faccia con Matteo Viviani e Pablo Trincia in arte LE
IENE....con Francesco Amodeo.
Dopo questo,
ci si imbatte nel caso di Andrea Mavilla, vittima di violenza e di censura.
C’è il servizio shock delle Iene sui carabinieri, ma il video scompare
scatenando le ire del web. Una storia davvero incredibile che ha lasciato
tutto il pubblico de Le Iene Show senza parole. Peccato che le stesse Iene
abbiano censurato, o siano state costrette a farlo, il loro stesso lavoro. “Ma
il servizio di Viviani?”, “dove si può vedere il video riguardo Andrea Mavilla e
il vergognoso abuso di potere che ha subito?”, “TIRATE FUORI IL VIDEO!”. Sono
solo alcuni dei commenti che hanno inondato il 25 settembre 2013 la pagina
Facebook di Le Iene, noto programma di Italia Uno la
cui fama è legata ai provocatori, ma anche il più delle volte illuminanti,
servizi di inchiesta, scrive Francesca su “Che Donna”. Proprio oggi però
l’intrepido coraggio dei ragazzi in giacca e cravatta è stato messo in dubbio
proprio dai loro stessi fan. Tempo fa Andrea Mavilla,
blogger, filmò un’auto dei carabinieri mentre sostava contromano sulle
strisce pedonali: l’uomo dimostrò che i tre militari
rimasero diversi minuti nella pasticceria lì vicino, uscendo poi con un
pacchetto della stessa. I carabinieri dovettero poi ricorrere
alle vie legali, dimostrando con tanto di verbale che il
pasticcere li aveva chiamati e loro, seguendo il regolamento,
erano intervenuti parcheggiando la volante quanto più vicino
possibile al locale. Il pacchetto? Un semplice regalo del negoziante
riconoscente per la celerità dell’arma. Storia finita dunque? A quanto pare no.
Il blogger infatti sostiene di aver subito una ritorsione da parte
dell’arma: i carabinieri sarebbero entrati senza
mandato in casa sua svolgendo una perquisizione dunque non
autorizzata. Proprio qui sono intervenute Le Iene: Viviani,
inviato del programma, ha infatti realizzato sull’accaduto un servizio
andato in onda la sera del 24 settembre 2013, alla ripresa del programma dopo la
pausa estiva. Inutile dire che la cosa ha subito calamitato l’attenzione del
pubblico che così, la mattina dopo, si è catapultato sul web per rivedere il
servizio. Peccato che questo risulta ad oggi irreperibile e la cosa non è
proprio piaciuta al pubblico che ora alza la voce su Facebook per richiedere il
filmato in questione. Come mai manca proprio quel filmato? Che i temerari di
Italia Uno non siano poi così impavidi? Le provocazioni e le
domande fioccano sul social network e la storia sembra dunque non finire qui.
Quando la
tv criminalizza un territorio.
7 ottobre
2013. Dal sito di Striscia la Notizia si legge “Stasera a Striscia la notizia
Fabio e Mingo documentano la situazione di drammatico degrado in cui vivono
migliaia di persone nelle campagne di Foggia. Si tratta di lavoratori stranieri
che vengono in Italia per raccogliere i pomodori e lavorano dalle 5 del mattino
fino a notte per pochi euro. Il caso documentato da Striscia riguarda un gruppo
di lavoratori bulgari che per otto mesi l'anno vivono con le loro famiglie in
case improvvisate, senza acqua, gas e elettricità, in condizioni igieniche
insostenibili, tra fango e rifiuti di ogni genere, tra cui anche lastre di
amianto.”
In effetti il
filmato documenta una situazione insostenibile. Certo, però, ben lontana dalla
situazione descritta. Prima cosa è che non siamo in periodo di raccolta del
pomodoro, né dell’uva. Nel filmato si vede un accampamento di poche famiglie
bulgare, ben lontane dal numero delle migliaia di persone richiamate nel
servizio. Famiglie senza acqua, luce e servizi igienici. Un accampamento immerso
nell’immondizia e con auto di grossa cilindrata parcheggiate vicino alle
baracche. «Scusate ma a me sembra un "normale" accampamento di Zingari, come ci
sono ahimè in tutte le città italiane - scrive Antonio sul sito di Foggia Today
- Purtroppo oggi la televisione per fare audience, deve proporre continuamente
lo scoop, specialmente quando si tratta di televisione cosiddetta commerciale.
Ma anche la televisione pubblica a volte non è esente da criticare a riguardo.
Fare televisione oggi significa soprattutto speculare sulla notizia, e molte
volte non ci si fa scrupoli di speculare anche sulle tragedie, pur di
raggiungere gli agognati indici di ascolto. E tutto questo senza preoccuparsi
minimamente, di quanto viene proposto agli spettatori, a volte paganti (vedi il
canone Rai). Tanto a nessuno importa, perchè vige la regola: "Il popolo è
ignorante".» Giovanni scrive: «quello è un campo nomadi e non il campo dei
lavoratori agricoli stagionali».
Questo non per
negare la terribile situazione in cui versano i lavoratori stagionali, a nero e
spesso clandestini, che coinvolge tutta l’Italia e non solo il Foggiano, ma per
dare a Cesare quel che è di Cesare.
In effetti di
ghetto ne parla “Foggia Città Aperta”. Ma è un’altra cosa rispetto a quel campo
documentato da Striscia. Una fetta di Africa a dodici chilometri da Foggia.
Benvenuti nel cosiddetto Ghetto di Rignano, un villaggio di cartone sperduto fra
le campagne del Tavoliere Dauno che ogni estate ospita circa 700 migranti.
Tutti, o quasi, impegnati nella raccolta dei campi, in modo particolare dei
pomodori. Dodici ore di lavoro sotto al sole e al ritorno neanche la possibilità
di farsi la doccia. Attenzione si parla di Africani, non di Bulgari.
Sicuramente
qualcuno mi farà passare per razzista, ma degrado e sudiciume illustrato da
Striscia, però, sono causati da quelle persone che ivi abitano e non sono certo
da addebitarsi all’amministrazione pubblica Foggiana, che eventualmente, per
competenza, non ha ottemperato allo sgombero ed alla bonifica dei luoghi.
Ai buonisti di
maniera si prospettano due soluzioni:
L’Amministrazione pubblica assicura ai baraccati vitto, alloggio e lavoro,
distogliendo tale diritto ai cittadini italiani, ove esistesse;
L’Amministrazione pubblica assicura la prole ad un centro per minori,
togliendoli alle famiglie; libera con forza l’accampamento abusivo e persegue
penalmente i datori di lavori, ove vi sia sfruttamento della manodopera; chiede
ai baraccati ragione del loro tenore di vita in assenza di lavoro, per
verificare che non vi siano da parte loro atteggiamenti e comportamenti
criminogeni, in tal caso provvede al rimpatrio coatto.
Colui il quale
dalla lingua biforcuta sputerà anatemi per aver ristabilito una certa verità,
sicuramente non avrà letto il mio libro “UGUAGLIANZIOPOLI L’ITALIA DELLE
DISUGUAGLIANZE. L'ITALIA DELL'INDISPONENZA, DELL'INDIFFERENZA,
DELL'INSOFFERENZA”, tratto dalla collana editoriale “L’Italia del Trucco,
l’Italia che siamo”. Opere reperibili su Amazon.it.
Alla fine
della fiera, si può dire che stavolta Fabio e Mingo e tutta Striscia la Notizia
per fare sensazionalismo abbiano toppato?
Che anche le
toghe paghino per i loro errori: adesso lo
pretende la Ue, chiede “Libero Quotidiano”. La
Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione
contro l'Italia perchè non adegua la sua normativa sulla
responsabilità civile dei giudici al diritto
comunitario. Bruxelles si aspetta che il governo nostrano
estenda la casistica per i risarcimenti "cagionati
nell’esercizio delle funzioni giudiziarie". Casistica regolata da una legge del
1988 e assai stretta: il legislatore prevede che le toghe
rispondano in prima persona solo in caso di dolo o colpa grave
nel compimento dell'errore giudiziario. All'Ue non sta bene, e il procedimento
di infrazione non è un fulmine a ciel sereno. E' del novembre 2011 la
condanna all'Italia da parte della Corte di Giustizia Ue per
l'inadeguatezza della nostra normativa in materia di responsabilità civile dei
giudici, mentre già nel settembre 2012 la Commissione aveva
chiesto al governo aggiornamenti sull'applicazione del decreto di condanna. Ma
non è bastato. In due anni i governi di Mario Monti e
Enrico Letta non hanno adeguato la legge italiana a quella europea, e
ora l'Ue passa ai provvedimenti sanzionatori. L'Italia è responsabile della
violazione del diritto dell'Unione da parte di un suo organo (in questo caso
giudiziario), e per questo sarà chiamata a pagare. Qual è il problema per l'Ue?
Che i giudici italiani sono chiamati a pagare per i propri errori in casi troppo
ristretti, godendo di una normativa che non solo li avvantaggia rispetto ad
altri lavoratori e professionisti italiani, ma
anche rispetto ai propri colleghi europei. La legge
italiana 117/88 restringe la responsabilità dei giudici ai soli
casi di errore viziato da "dolo e colpa grave". E, come se non fosse abbastanza,
il legislatore assegna l'onere della prova (ovvero la dimostrazione del dolo e
della colpa del giudice) al querelante che chiede
risarcimento per il danno subito. Per l'Ue troppo
poco. La Commissione Ue chiede all'Italia di conformarsi al diritto comunitario.
Innanzitutto via l'onere della dimostrazione del dolo e della colpa. E poi
estensione della responsabilità del giudice di ultima istanza anche ai casi di
sbagliata interpretazione delle leggi e di errata valutazione
delle prove, anche senza il presupposto della malevolezza della toga
verso l'imputato. Anche per colpa semplice, insomma. Interpellate da Bruxelles
nel settembre 2012, le autorità italiane avevano risposto in maniera
rassicurante: cambieremo la legge. In dodici mesi non si è
mossa una foglia, e ora il Belpaese va incontro a un procedimento di infrazione,
cioè a una cospicua multa. Insomma, non pagano i giudici,
paghiamo noi.
La proposta di
aprire una nuova procedura d'infrazione è stata preparata dal servizio giuridico
della Commissione che fa capo direttamente al gabinetto del presidente Josè
Manuel Barroso, scrive “La Repubblica”. Bruxelles si è in pratica limitata a
constatare che a quasi due anni dalla prima condanna, l'Italia non ha fatto
quanto necessario per eliminare la violazione del diritto europeo verificata nel
2011. La prima sentenza emessa dai giudici europei ha decretato che la legge
italiana sulla responsabilità civile dei magistrati li protegge in modo
eccessivo dalle conseguenze del loro operato, ovvero rispetto agli eventuali
errori commessi nell'applicazione del diritto europeo (oggi circa l'80% delle
norme nazionali deriva da provvedimenti Ue). Due in particolare le ragioni che
hanno portato Commissione e Corte a censurare la normativa italiana giudicandola
incompatibile con il diritto comunitario. In primo luogo, osservano fonti
europee, la legge nazionale esclude in linea generale la responsabilità dei
magistrati per i loro errori di interpretazione e valutazione. Inoltre, la
responsabilità dello Stato scatta solo quando sia dimostrato il dolo o la colpa
grave. Un concetto, quest'ultimo, che secondo gli esperti Ue la Cassazione ha
interpretato in maniera troppo restrittiva, circoscrivendola a sbagli che
abbiano un carattere “manifestamente aberrante”.
Ciò che
l'Unione Europea contestava, e ancora contesta, è l'eccessiva protezione
garantita alla magistratura italiana, scrive “Il Giornale”. Per eventuali errori
commessi nell'applicare il diritto europeo, non è infatti
prevista responsabilità civile, che entra in gioco per dolo o colpa grave, ma
non per errori di valutazione o interpretazione. Una differenzia importante, se
si considera che circa l'80% delle norme italiana deriva ormai da provvedimenti
comunitari.
Pronta la
replica delle toghe: guai a toccare i magistrati.
Nessun
"obbligo per l'Italia di introdurre una responsabilità diretta e personale del
singolo giudice": l'Europa "conferma che nei confronti del cittadino l'unico
responsabile è lo Stato". Il vice presidente del Csm Michele Vietti commenta
così la notizia dell'avvio di una procedura da parte dell'Ue. "L'Europa ha
parlato di responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario;
non entra invece nella questione della responsabilità personale dei giudici
perché é un problema di diritto interno, regolato diversamente nei vari Stati
membri", ha puntualizzato il presidente dell'Associazione nazionale magistrati
Rodolfo Sabelli, che sin da ora avverte: "Denunceremo ogni tentativo di
condizionamento dei magistrati attraverso una disciplina della responsabilità
civile che violi i principi di autonomia e indipendenza".
Tutti uguali
davanti alla legge. Tutti uguali? Anche i magistrati? E invece no. I magistrati
sono al di sopra della legge, ci si tengono - al di sopra - con pervicacia, si
rifugiano sotto l’ombrello dell’autonomia, indipendenza dalla politica, in
realtà tenendosi stretto il privilegio più anacronistico che si possa
immaginare: l’irresponsabilità civile. O irresponsabilità incivile, scrive Marvo
Ventura su “Panorama”. La Commissione Europea ha deciso di avviare una procedura
d’infrazione nei confronti dell’Italia per l’eccessiva protezione offerta dalle
norme ai magistrati, per i limiti all’azione di risarcimento delle vittime di
palesi e magari volute ingiustizie. Per l’irresponsabilità del magistrato che
per dolo o colpa grave rovini la vita delle persone con sentenze chiaramente
errate, se non persecutorie. Succede che in capo direttamente al presidente
della Commissione UE, Barroso, è partita la proposta di agire contro l’Italia
per aver totalmente ignorato la condanna del 2011 della Corte di Giustizia che
fotografava l’inadeguatezza del sistema italiano agli standard del diritto
europeo rispetto alla responsabilità civile delle toghe. Dov’è finita allora
l’urgenza, la fretta, quel rimbocchiamoci le maniche e facciamo rispettare la
legge e le sentenze, che abbiamo visto negli ultimi giorni, settimane, mesi,
come una battaglia di principio che aveva e ha come bersaglio l’avversario
politico Silvio Berlusconi. Perché dal 1987, anno del referendum sulla
responsabilità civile dei magistrati, c’è stata solo una legge, la Vassalli
dell’anno successivo, che serviva purtroppo per introdurre una qualche
responsabilità ma non troppa, per non pestare i piedi alla magistratura, forte
già allora di uno strapotere discrezionale nella sua funzione inquirente e nella
sua vocazione sovente inquisitoria. Adesso che l’Europa ci bacchetta (e la
minaccia è anche quella di farci pagare per l’irresponsabilità dei nostri
magistrati, dico far pagare a noi contribuenti che sperimentiamo ogni giorno le
inefficienze e i ritardi della giustizia civile e penale), l’Europa non è più
quel mostro sacro che ha sempre ragione. Non è più neanche il depositario del
bene e del giusto. È invece la fonte di una raccomandazione che merita a stento
dichiarazioni di seconda fila. E l’Associazione nazionale magistrati stavolta
non tuona, non s’indigna, non incalza. Si limita a scaricare il barile al
governo, dice per bocca dei suoi vertici che la Commissione non ha infilzato i
singoli magistrati ma lo Stato italiano per la sua inadempienza al diritto UE,
comunitario. Come se i magistrati e la loro associazione corporativa non
avessero avuto alcuna voce in capitolo nel tornire una legislazione che non è in
linea con lo stato di diritto di un avanzato paese europeo. Come se in questo
caso le toghe potessero distinguere le loro (ir)responsabilità da quelle di una
parte della politica che ha fatto sponda alle correnti politiche giudiziarie e
alla loro campagna ventennale. Come se i magistrati più in vista, più esposti,
non avessero facilmente e disinvoltamente travalicato i confini e non si fossero
gettati in politica facendo tesoro della popolarità che avevano conquistato
appena il giorno prima con le loro inchieste di sapore “politico”. Ma quel che è
peggio è l’odissea di tanti cittadini vittime di ingiustizia che si sono dovuti
appellare all’Europa, avendo i soldi per farlo e il tempo di aspettare senza
morire (a differenza di tanti altri). A volte ho proprio l’impressione di non
trovarmi in Europa ma in altri paesi che non saprei citare senza peccare di
presunzione. L’Italia, di certo, non appartiene più al novero dei paesi nei
quali vi è certezza del diritto. Per quanto ancora?
Di altro
parere rispetto a quello espresso dalle toghe, invece è il Presidente della
Repubblica e capo del CSM. L’opposizione dei giudici alla riforma della
giustizia è eccessiva, spiega “Libero Quotidiano”. Se ne è accorto anche Giorgio
Napolitano che, il 20 settembre 2013 intervenendo alla Luiss per ricordare Loris
D'Ambrosio, riflette sul rapporto tra magistratura e politica: entrambi i poteri
sbagliano, ma la magistratura è troppo piegata sulle sue posizioni ed una
rinfrescata ai codici sarebbe cosa buona. Secondo Napolitano, le critiche che le
piovono addosso, vero, sono eccessive; ma ai punti a perdere sono i magistrati,
sempre più convinti di essere intoccabili. La politica e la giustizia devono
smettere di "concepirsi come mondi ostili, guidati dal sospetto reciproco", dice
Napolitano che sogna, invece, l’esaltazione di quella "comune responsabilità
istituzionale" propria dei due poteri. "Ci tocca operare in questo senso -
precisa Napolitano - senza arrenderci a resistenze ormai radicate e a nuove
recrudescenze del conflitto da spegnere nell'interesse del Paese". Per superare
quelle criticità emerse con foga negli ultimi vent’anni (prendendo Tangentopoli
come primo e vero momento di scontro tra politica e magistratura), secondo
Napolitano, la soluzione si può trovare "attraverso un ridistanziamento tra
politica e diritto" ma soprattutto non senza la cieca opposizione ad una riforma
completa della magistratura. Il presidente della Repubblica sembra non sapersi
spiegare perché proprio i magistrati siano sulle barricate per difendere il loro
status. Tra i giudici, dice Napolitano, dovrebbe "scaturire un'attitudine meno
difensiva e più propositiva rispetto al discorso sulle riforme di cui la
giustizia ha indubbio bisogno da tempo e che sono pienamente collocabili nel
quadro dei principi della Costituzione repubblicana". Sul Quirinale non sventola
mica la bandiera di Forza Italia, ma bastano le lampanti criticità ad illuminare
il discorso di Re Giorgio. "L'equilibrio, la sobrietà ed il riserbo, l'assoluta
imparzialità e il senso della misura e del limite, sono il miglior presidio
dell'autorità e dell'indipendenza del magistrato". Così Napolitano non si lascia
sfuggire l’occasione di parlare indirettamente a quei magistrati che fanno del
protagonismo la loro caratteristica principale. Pm, come Henry John Woodcock, o
giudicanti, come il cassazionista Antonio Esposito, che si sono lasciarti
sedurre da taccuini e telecamere quando, invece, avrebbero dovuto seguire quei
dettami di "sobrietà e riserbo". Il presidente, poi, ricorda che nessun lavoro è
delicato quanto quello del giudice perché sa che dalla magistratura dipende la
vita (o la non-vita) degli indagati.
Inoltre su un
altro punto è intervenuta l’Europa. Condannare un giornalista alla prigione è
una violazione della libertà d’espressione, salvo casi eccezionali come
incitamento alla violenza o diffusione di discorsi razzisti. A stabilirlo,
ancora una volta. è la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza in cui
dà ragione a Maurizio Belpietro, direttore di Libero, condannato a quattro anni
dalla Corte d’Appello di Milano. In sostanza, scrive Vittorio Feltri, i giudici
continentali si sono limitati a dire ai tribunali italiani che i giornalisti non
devono andare in galera per gli sbagli commessi nello svolgimento del loro
lavoro, a meno che inneggino alla violenza o incitino all'odio razziale. Tutti
gli altri eventuali reati commessi dai colleghi redattori vanno puniti, a
seconda della gravità dei medesimi, con sanzioni pecuniarie. Perché la libertà
di espressione non può essere compressa dal terrore dei giornalisti di finire
dietro le sbarre. La Corte, per essere ancora più chiara, ha detto che il
carcere collide con la Carta dei diritti dell'uomo. Inoltre, scrive “Panorama”,
ha condannato lo Stato italiano a risarcire Belpietro - per il torto patito -
con 10mila euro, più 5mila per le spese legali. La Corte europea dei diritti
dell'uomo ha condannato lo Stato italiano a pagare a Maurizio Belpietro 10
mila euro per danni morali e 5 mila per le spese processuali a causa della
condanna a 4 anni di carcere, inflittagli dai giudici d'appello di Milano, per
aver ospitato sul suo giornale un articolo del 2004 ritenuto gravemente
diffamatorio a firma Lino Jannuzzi, allora senatore PdL. Senza entrare nel
merito della questione giudiziaria, la Corte ha cioè ribadito un principio
assimilato da tutti i Paesi europei: il carcere per i giornalisti per il reato
di diffamazione - previsto dal nostro codice penale - è un abominio giuridico
incompatibile con i principi della libertà d'informazione. A questo tema, di cui
si è occupato anche Panorama , è dedicato il fondo di Vittorio Feltri su
Il Giornale intitolato E l'Europa ci bastona. Un orrore il carcere per
i giornalisti . “La vicenda dell'attuale direttore
di Libero è addirittura paradossale. Udite. Lino Jannuzzi scrive un articolo
scorticante sui misteri della mafia, citando qualche magistrato, e lo invia al
Giornale. La redazione lo mette in pagina. E il dì appresso partono le querele
delle suddette toghe. Si attende il processo di primo grado. Fra la sorpresa
generale, il tribunale dopo avere udito testimoni ed esaminato approfonditamente
le carte, assolve sia Jannuzzi sia Belpietro. Jannuzzi perché era senatore ed
era suo diritto manifestare le proprie opinioni, senza limitazioni. Belpietro
perché pubblicare il pezzo di un parlamentare non costituisce reato. Ovviamente,
i soccombenti, cioè i querelanti, ricorrono in appello. E qui si ribalta tutto.
Il direttore si becca quattro mesi di detenzione, per non parlare della sanzione
economica: 100mila e passa euro. Trascorrono mesi e anni, e si arriva in
Cassazione - suprema corte - che, lasciando tutti di stucco, conferma la
sentenza di secondo grado, a dimostrazione che la giustizia è un casino, dove la
certezza del diritto è un sogno degli ingenui o dei fessi. Belpietro, allora,
zitto zitto, inoltra ricorso alla Corte di Strasburgo che, essendo più civile
rispetto al nostro sistema marcio, riconosce al ricorrente di avere ragione.
Attenzione. Le toghe europee non se la prendono con i colleghi italiani che,
comunque , hanno esagerato con le pene, bensì con lo Stato e chi lo guida
(governo e Parlamento) che consentono ancora - non avendo mai modificato i
codici - di infliggere ai giornalisti la punizione del carcere, prediletta dalle
dittature più infami.”
Anche il fondo
di Belpietro è dedicato alla storica decisione della Corte di Strasburgo che ha
dato ragione a quanti, tra cui Panorama, sostengono che il carcere per i
giornalisti sia una stortura liberticida del nostro sistema penale che un
Parlamento degno di questo nome dovrebbe subito cancellare con una nuova legge
che preveda la pena pecuniaria, anziché il carcere. Così ricostruisce la vicenda
il direttore di Libero.
La
questione è che per aver dato conto delle opinioni di un senatore su un fatto di
rilevante interesse nazionale un giornalista è stato condannato al carcere. Ho
sbagliato a dar voce a Iannuzzi? Io non credo, perché anche le opinioni
sbagliate se corrette da un contraddittorio o da una rettifica contribuiscono a
far emergere la verità. Tuttavia, ammettiamo pure che io sia incorso in un
errore, pubblicando opinioni non corrette: ma un errore va punito con il
carcere? Allora cosa dovrebbe succedere ai magistrati che commettono errori
giudiziari e privano della libertà una persona? Li mettiamo in cella e buttiamo
via la chiave? Ovvio che no, ma nemmeno li sanzioniamo nella carriera o nel
portafoglio, a meno che non commettano intenzionalmente lo sbaglio. Naturalmente
non voglio mettere noi infimi cronisti sullo stesso piano di superiori uomini di
legge, ma è evidente che c’è qualcosa che non va. Non dico che i giornalisti
debbano avere licenza di scrivere, di diffamare e di insultare, ma nemmeno
devono essere puniti con la galera perché sbagliano. Altrimenti la libertà di
stampa e di informare va a quel paese, perché nel timore di incorrere nei rigori
della legge nessuno scrive più nulla. Tradotto in giuridichese, questo è quel
che i miei avvocati hanno scritto nel ricorso contro la condanna presentato alla
Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale proprio ieri ci ha dato ragione,
condannando l’Italia a risarcirmi per i danni morali subiti e sentenziando che
un omesso controllo in un caso di diffamazione non giustifica una sanzione tanto
severa quale il carcere. Qualcuno penserà a questo punto che io mi sia preso una
rivincita contro i giudici, ma non è così.
Siamo una
masnada di fighetti neppure capaci di essere una corporazione, anzi peggio,
siamo dei professionisti terminali e già «morti» come direbbe un qualsiasi
Grillo, scrive Filippo Facci. La Corte di Strasburgo ha sancito che il carcere
per un giornalista - Maurizio Belpietro, nel caso - costituisce una sproporzione
e una violazione della libertà di espressione. È una sentenza che farà
giurisprudenza più di cento altri casi, più della nostra Cassazione, più degli
estenuanti dibattiti parlamentari che da 25 anni non hanno mai partorito una
legge decente sulla diffamazione. Il sindacato dei giornalisti si è detto
soddisfatto e anche molti quotidiani cartacei (quasi tutti) hanno almeno dato la
notizia, che resta essenzialmente una notizia: ora spiegatelo ai censori del
Fatto Quotidiano (il giornale di Marco Travaglio), a questi faziosi impregnati
di malanimo che passano la vita a dare dei servi e chi non è affiliato al loro
clan. Non una riga. Niente.
Tutt’altro
trattamento, però, è riservato a Roberto Saviano. Ci dev'essere evidentemente un
delirio nella mente di Saviano dopo la condanna per plagio, scrive Vittorio
Sgarbi. Lo hanno chiamato per una occasione simbolico-folkloristica: guidare la
Citroen Mehari che fu di Giancarlo Siani, un'automobile che rappresenta il gusto
per la libertà di una generazione. All'occasione Saviano dedica un'intera pagina
della Repubblica. Possiamo essere certi che non l'ha copiata, perché senza paura
del ridicolo, di fronte alla tragedia della morte del giornalista, per il suo
coraggio e le sue idee, che si potrebbero semplicemente celebrare ripubblicando
i suoi articoli in un libro da distribuire nelle scuole (pensiero troppo facile)
scrive: «Riaccendere la Mehari, ripartire, è il più bel dono che Paolo Siani (il
fratello) possa fare non solo alla città di Napoli ma al Paese intero... la
Mehari che riparte è il contrario del rancore, è il contrario di un legittimo
sentimento di vendetta che Paolo Siani potrebbe provare». Eppure Roberto Saviano
e la Mondadori sono stati condannati per un presunto plagio ai danni del
quotidiano Cronache di Napoli, scrive “Il Corriere del Mezzogiorno”.
Editore e scrittore sono stati ritenuti responsabili di «illecita riproduzione»
nel bestseller Gomorra di tre articoli (pubblicati dai quotidiani locali
«Cronache di Napoli» e «Corriere di Caserta»). In particolare, Saviano e
Mondadori , suo editore prima del passaggio con Feltrinelli, sono stati
condannati in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, per 60mila
euro. Questa la decisione del secondo grado di giudizio. Spetterà adesso ai
giudici di Cassazione dire l'ultima parola su una querelle che si trascina da
almeno cinque anni, da quando cioè la società Libra, editrice dei due quotidiani
campani, imputò allo scrittore anticamorra di essersi appropriato di diversi
articoli senza citare la fonte per redigere alcune parti di Gomorra
(corrispondenti, sostiene Saviano, a due pagine).
Detto questo si presume che
le ritorsioni su chi testimonia una realtà agghiacciante abbiano uno stop ed
invece c’è il servizio shock delle Iene sui carabinieri, ma il video scompare
scatenando le ire del web.
“Ma il
servizio di Viviani?”, “dove si può vedere il video riguardo Andrea Mavilla e il
vergognoso abuso di potere che ha subito?”, “TIRATE FUORI IL VIDEO!”. Sono solo
alcuni dei commenti che hanno inondato il 25 settembre 2013 la pagina
Facebook di Le Iene, noto programma di Italia Uno
la cui fama è legata ai provocatori, ma anche il più delle volte illuminanti,
servizi di inchiesta, scrive “Che Donna”. Proprio oggi però l’intrepido coraggio
dei ragazzi in giacca e cravatta è stato messo in dubbio proprio dai loro stessi
fan. Ma andiamo con ordine.
Tempo fa
Andrea Mavilla, blogger, filmò un’auto dei carabinieri
mentre sostava contromano sulle strisce pedonali: l’uomo dimostrò che i
tre militari rimasero diversi minuti nella pasticceria lì
vicino, uscendo poi con un pacchetto della stessa. I carabinieri
dovettero poi ricorrere alle vie legali, dimostrando con tanto di
verbale che il pasticcere li aveva chiamati e
loro, seguendo il regolamento, erano intervenuti parcheggiando la
volante quanto più vicino possibile al locale. Il pacchetto? Un
semplice regalo del negoziante riconoscente per la celerità dell’arma. Storia
finita dunque? A quanto pare no. Il blogger infatti sostiene di aver subito una
ritorsione da parte dell’arma: i carabinieri
sarebbero entrati senza mandato in casa sua svolgendo una perquisizione
dunque non autorizzata. Proprio qui sono intervenute Le Iene:
Viviani, inviato del programma, ha infatti realizzato sull’accaduto un
servizio andato in onda la sera del 25 settembre 2013, alla
ripresa del programma dopo la pausa estiva. Inutile dire che la cosa ha subito
calamitato l’attenzione del pubblico che così, la mattina dopo, si è catapultato
sul web per rivedere il servizio. Peccato che questo risulta ad oggi
irreperibile e la cosa non è proprio piaciuta al pubblico che ora alza la voce
su Facebook per richiedere il filmato in questione. Come mai manca proprio quel
filmato? Che i temerari di Italia Uno non siano poi così
impavidi? Le provocazioni e le domande fioccano da questa mattina sul social
network e la storia sembra dunque non finire qui.
Andrea Mavilla,
blogger dallo spiccato senso civico, ha pubblicato su YouTube
un filmato in cui pizzicava un’auto dei carabinieri in divieto di sosta, sulle
strisce pedonali, in prossimità di un semaforo e controsenso, scrive “Blitz
Quotidiano”. Oltre trecentomila contatti in poche ore e poco dopo un plotone di
30 carabinieri si precipita a casa sua, a Cavenago di Brianza,
comune alle porte di Milano. Il video è stato girato domenica mattina, nel
filmato intitolato “operazione pasticcini” il blogger insinua
che i militari stessero comprando pasticcini all’interno della pasticceria
accanto. Per svariati minuti il videoamatore resta in attesa dei carabinieri:
ferma i passanti “signora guardi sono sulle strisce, in prossimità di un
semaforo, saranno entrati a prendere i pasticcini in servizio”, commenta ironico
“è scioccante”, “normale parcheggiare sulle strisce vero?”. Quando infine i
carabinieri escono dalla pasticceria, con in mano un pacchetto, notano l’uomo
con la telecamera in mano. Il blogger li bracca e chiede loro spiegazioni e i
militari lo fermano per identificarlo. Il legale dei tre carabinieri, Luigi
Peronetti, spiega che: “La realtà è un’altra. E lo dicono i
documenti, non solo i miei assistiti. Il caso è agghiacciante e mostra come
immagini neutre con un commentatore che insinua a e fa deduzioni malevole
possano distorcere la realtà”. Sulla carta, in effetti, risulta che i
carabinieri erano in quella pasticceria perché il proprietario aveva chiesto il
loro intervento, hanno lasciato l’auto nel posto più vicino, come prevedono le
disposizioni interne all’Arma in materia di sicurezza, hanno verificato
richieste e problemi del pasticcere, hanno redatto un verbale, poi sono usciti.
In mano avevano un pacchetto, è vero: “Ma certo. Solo che non
l’avevano acquistato – continua l’avvocato Peronetti – in realtà i negozianti,
per ringraziare i militari della gentilezza e della professionalità, hanno
regalato loro alcune brioches avanzate a fine mattinata, da portare anche ai
colleghi in caserma. I militari hanno rifiutato, e solo dopo alcune insistenze,
hanno accettato il pacchetto. Al blogger bastava chiedere, informarsi prima di
screditare così i miei assistiti!. Ora il blogger rischia guai grossi,
perché i militari stanno valutando se procedere contro di lui legalmente per
aver screditato la loro professionalità. Ma Andrea Mavilla non si arrende e
controbatte: “Ho le prove che dimostrano i soprusi di cui sono stato
vittima – annuncia – ho solo cercato di documentare un fatto che ho
visto e ho ripreso per il mio blog, la mia passione. Ho visto quella che secondo
me è una violazione al codice della strada, che in realtà è concessa ai
carabinieri solo in caso di pericolo o emergenze. Poi hanno effettuato una
perquisizione, ma i carabinieri non dovevano entrare in casa mia
e la vicenda è in mano agli avvocati. Per questo motivo sono sotto choc,
sconvolto e mi sento sotto attacco”.
Nel servizio
de Le Iene, in onda martedì 25 settembre 2013, Andrea
Mavilla è protagonista di un sequestro di beni non dovuto, a
seguito di un video che documentava una macchina dei carabinieri
parcheggiata sulle strisce pedonali e in controsenso, davanti ad una
pasticceria. Mavilla, già ospite a Pomeriggio 5 per via di
un’altra vicenda, è stato poi convocato in questura dove, racconta a
Matteo Viviani de Le Iene, sarebbe stato costretto a denudarsi mentre
veniva insultato: dichiarazioni che tuttavia non sono supportate da
registrazioni audio o video, e che quindi non possono essere provate. Un esperto
di informatica, però, ha fatto notare che, in seguito al sequestro
dei computer di Mavilla, i carabinieri avrebbero cancellato ogni
cosa presente sul pc dell’autore del filmato incriminato.
Uno dei
servizi più interessanti (e, a tratti, agghiaccianti) andati in onda nella prima
puntata de Le Iene Show, è stato quello curato da
Matteo Viviani che ha documentato un presunto caso di abuso di
potere perpetrato dai Carabinieri nei confronti di Andrea
Mavilla. L’uomo è molto famoso su internet e, ultimamente, è apparso
anche in televisione ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque.
Ecco cos’è accaduto nel servizio de Le Iene.
Andrea
accoglie la Iena Matteo Viviani in lacrime: ha la casa a
soqquadro, come se fosse stata appena svaligiata dai ladri. Ma la verità è ben
diversa. Purtroppo. L’incubo comincia quando Andrea Mavilla filma,
con il proprio cellulare, una volante dei Carabinieri parcheggiata sulle strisce
pedonali e davanti ad uno scivolo per disabili. L’auto rimane parcheggiata sulle
strisce per circa venti minuti mentre i Carabinieri, presumibilmente,
sono in pasticceria. Non appena gli agenti si accorgono di
essere filmati, intimano ad Andrea di spegnere il cellulare e
di mostrare loro i documenti. Poi inizia l’incubo. Il Comandante dei
Carabinieri si sarebbe recato a casa di Andrea per intimargli di
consegnargli tutto il materiale video e fotografico in suo possesso. Al rifiuto
del ragazzo, gli agenti avrebbero iniziato a perquisire
la sua casa alla ricerca di materiale compromettente. Matteo Viviani,
nel suo servizio, ha riportato l’audio della la conversazione tra Andrea ed i
carabinieri registrato tramite Skype da una collaboratrice di
Andrea. Nel servizio andato in onda a Le Iene Show, poi,
Andrea racconta quel che è accaduto dopo la presunta perquisizione: secondo
Mavilla i Carabinieri lo avrebbero condotto in Caserma ed insultato
pesantemente. Il giovane si sarebbe sentito poi male tanto da rendere necessario
il suo ricovero in Ospedale. Una storia davvero incredibile che ha lasciato
tutto il pubblico de Le Iene Show senza parole. Peccato che le stesse Iene
abbiano censurato, o siano state costrette a farlo, il loro stesso lavoro.
MALAGIUSTIZIA. PUGLIA: BOOM DI CASI.
C’è l’elettricista incensurato scambiato per un pericoloso narcotrafficante per
un errore nella trascrizione delle intercettazioni; e ci sono i due poliziotti
accusati di rapina ai danni di un imprenditore, sottoposti nel 2005 a misura
cautelare per 13 mesi, spogliati della divisa e poi assolti con formula piena.
Ma nel frattempo hanno perso il lavoro, scrive Vincenzo Damiani su “Il Corriere
del Mezzogiorno”. Sino alla drammatica storia di Filippo Pappalardi, ammanettato
e rinchiuso in una cella con l’accusa - rivelatasi poi completamente sbagliata -
di aver ucciso i suoi due figli, Francesco e Salvatore. E’ lungo l’elenco delle
persone incastrate nelle maglie della malagiustizia, che hanno - loro malgrado -
vissuto per mesi o per anni un incubo chiamato carcere. A Bari, secondo i dati
ufficiali raccolti dal sito errori giudiziari.com, le richieste di risarcimento
presentate per ingiusta detenzione, nell’ultimo anno, si sono più che
raddoppiate: nel 2012 i giudici della Corte di appello hanno riconosciuto 29
errori da parte dei loro colleghi, condannando lo Stato a pagare
complessivamente 911mila euro. A metà dell’ultimo anno i casi sono già passati a
64, valore totale degli indennizzi oltre 1,7 milioni. In aumento gli errori
anche a Taranto, dove si è passati dai due risarcimenti riconosciuti nel 2012 ai
sette del 2013. In controtendenza, invece, l’andamento nel distretto di Lecce:
nel 2012 gli errori riconosciuti sono stati ben 97, quest’anno la statistica è
ferma a 37. Spesso i mesi o addirittura gli anni trascorsi da innocente dietro
le sbarre vengono "liquidati" con poche migliaia di euro, al danno così si
unisce la beffa. Secondo quanto disposto dagli articoli 314 e 315 del codice
penale e dalla Convenzione dei diritti dell’uomo, la persona diventata suo
malgrado imputato ha diritto ad un’equa riparazione. La legge "Carotti" ha
aumentato il limite massimo di risarcimento per aver patito un'ingiusta
permanenza in carcere, passando da cento milioni di lire a 516mila euro, ma
raramente viene riconosciuto il massimo. Per non parlare dei tempi per ottenere
la riparazione: le cause durano anni, basti pensare che Filippo Pappalardi,
giusto per fare un esempio, è ancora in attesa che venga discussa la sua
richiesta. Ma il papà dei due fratellini di Gravina, i ragazzini morti dopo
essere caduti accidentalmente in una cisterna, non è l’unico arrestato
ingiustamente. Attenzione ingiusta detenzione da non confondere il risarcimento
del danno per l’errore giudiziario causato da colpa grave o dolo. Eventi,
questi, quasi mai rilevati dai colleghi magistrati contro i loro colleghi
magistrati. Gianfranco Callisti conduceva una vita normale e portava avanti
serenamente la sua attività di elettricista. Sino al giorno in cui, nel 2002,
viene prelevato dai carabinieri e trasferito in carcere all’improvviso. La
Procura e il Tribunale di Bari erano convinti che fosse coinvolto in un vasto
traffico di droga, la storia poi stabilirà che si trattò di un tragico errore
provocato da uno sbaglio nella trascrizione delle intercettazioni. Callisti da
innocente fu coinvolto nella maxi inchiesta denominata "Operazione Fiume", come
ci finì? Il suo soprannome, "Callo", fu confuso con il nome "Carlo", che era
quello di una persona effettivamente indagato. Il telefono dell’elettricista non
era sotto controllo, ma quello di un suo conoscente si, una casualità sfortunata
che lo fece entrare nell’ordinanza di custodia cautelare. Si fece sei mesi in
carcere, tre mesi ai domiciliari e tre mesi di libertà vigilata, prima che i
giudici riconobbero il clamoroso abbaglio. Dopo 10 anni lo Stato gli ha
riconosciuto un indennizzo di 50mila euro, nulla in confronto all’inferno
vissuto.
Correva l'anno 1985 e Indro Montanelli, che a quel tempo direttore del
Giornale, era ospite di Giovanni Minoli a Mixer, scrive Francesco
Maria Del Vigo su “Il Giornale”. In un'intervista del 1985 il giornalista
attacca le toghe. Dopo ventotto anni è ancora attuale: "C'è pieno di giudici
malati di protagonismo. Chiedo ed esigo che la magistratura risponda dei suoi
gesti e dei suoi errori spesso catastrofici"Un pezzo di modernariato, direte
voi. Invece è una perfetta, precisa, lucida ma soprattutto attuale, fotografia
della giustizia italiana. Sono passati ventotto anni. Si vede dai colori delle
riprese, dagli abiti e anche dal format stesso della trasmissione. Ma solo da
questo. In tutto il resto, il breve spezzone che vi riproponiamo, sembra una
registrazione di poche ore fa. Attuale. Più che mai. Una prova della
lungimiranza di Montanelli, ma anche la testimonianza dell'immobilità di un
Paese che sembra correre su un tapis roulant: sempre in movimento, ma sempre
nello stesso posto, allo stesso punto di partenza. Montanelli parla di giustizia
e ci va giù pesante. Minoli lo interpella sul un articolo in cui aveva
attaccato i giudici che avevano condannato Vincenzo Muccioli, fondatore ed
allora patron di San Patrignano. Una presa di posizione che gli costò una
querela. "Quello di Muccioli è uno dei più clamorosi casi in cui la giustizia si
è messa contro la coscienza popolare", spiega Montanelli. Poi torna sulla sua
querela: "Ne avrò delle altre. Non sono affatto disposto a tollerare una
magistratura come quella che abbiamo in Italia". Montanelli continua attaccando
il protagonismo delle toghe, puntando il dito in particolare contro il
magistrato Carlo Palermo, e denunciando le degenerazioni di una stampa sempre
più sensazionalistica e di una magistratura sempre più arrogante. Ma non solo.
Il giornalista mette alla berlina i giudici che cavalcano le indagini per farsi
vedere e poi, dopo aver rovinato uomini e aziende, non pagano per i loro errori.
Parole profetiche. Sembra storia di oggi, invece è storia e basta. Insomma, una
lezione attualissima. Una pagina sempreverde dell'infinita cronaca del Paese
Italia. Purtroppo.
Libri. "Discorsi potenti. Tecniche di persuasione per lasciare il segno" di
Trupia Flavia. Giusto per dire: con le parole fotti il popolo…che i fatti
possono aspettare. Alcuni discorsi colpiscono; altri, invece, generano solo un
tiepido applauso di cortesia. Dov'è la differenza? Cosa rende un discorso
potente? Certamente l'argomento, l'oratore, il luogo e il momento storico sono
fattori rilevanti. Ma non basta, occorre altro per dare forza a un discorso.
Occorre la retorica. L'arte del dire non può essere liquidata come artificio
ampolloso e manieristico. È, invece, una tecnica che permette di dare gambe e
respiro a un'idea. È la persuasione la sfida affascinante della retorica.
Quell'istante magico in cui le parole diventano condivisione, emozione, voglia
di agire, senso di appartenenza, comune sentire dell'uditorio. Non è magia nera,
ma bianca, perché la parola è lo strumento della democrazia. La retorica non è
morta, non appartiene al passato. Fa parte della nostra vita quotidiana molto
più di quanto immaginiamo. Siamo tutti retori, consapevoli o inconsapevoli.
Tuttavia, per essere buoni retori è necessaria la conoscenza dell'arte oratoria.
Ciò non vale solo per i politici ma per tutti coloro che si trovano nella
condizione di pronunciare discorsi, presentare relazioni, convincere o motivare
i propri interlocutori, argomentare sulla validità di una tesi o di un pensiero.
Ecco allora un manuale che analizza le tecniche linguistiche utilizzate dai
grandi oratori dei nostri giorni e ne svela i meccanismi di persuasione. Perché
anche noi possiamo imparare a "lasciare il segno".
«Grillo è l'invidia», B. è l'inganno', dice Trupia a Rossana Campisi su
“L’Espresso”.
Quali sono gli strumenti retorici dei politici? Un'esperta di
comunicazione li ha studiati. E sostiene che il fondatore del M5S punta sulla
rabbia verso chi sta in alto, mentre il capo del Pdl 'vende' sempre un sogno che
non si realizzerà mai.
Che la nostra felicità dipendesse da un pugnetto di anafore, non ce lo avevano
ancora detto. O forse si. «Gorgia da Lentini si godeva la Magna Grecia. Un bel
giorno, smise di pensare e disse: la parola è farmacon. Medicina ma anche
veleno». Flavia Trupia, ghostwriter ed esperta di comunicazione, ce lo ricorda.
La storia dell'umanità, del resto, è lunga di esempi che lei ha ripreso in
Discorsi potenti. Tecniche di persuasione per lasciare il segno (FrancoAngeli) e
nel suo blog.
«Spesso dimentichiamo il potere dell'arte della parola. La retorica insomma. Poi
arrivano certi anniversari e tutti lì a prendere appunti».
Sono i 50 anni di I Have a Dream. Martin Luther King Jr., davanti
al Lincoln Memorial di Washington, tiene il discorso conclusivo della marcia su
Washington. Partiamo da qui?
«Sì, è uno di quelli che i linguisti non hanno mai smesso di studiare. Si tratta
di un vero atto linguistico: le parole diventano azione. King aveva 34 anni,
sarebbe morto dopo cinque anni. Quel 28 agosto del 1963 ha cambiato il mondo».
Con le sue parole?
«Chiamale parole. Lì dentro c'è tutto il mondo in cui credono ancora oggi gli
americani: i riferimenti alla Bibbia, ne trovi una in ogni hotel e in ogni casa,
quelli alle costituzioni e alle dichiarazioni nazionali, quelli ai motel, luogo
tipico della cultura americana dove ti puoi riposare in viaggio. E poi ripeteva
sempre "today": l'efficienza americana è da sempre impaziente».
Strategia dei contenuti.
«Magari fossero solo quelli. C'è il ritmo che è fondamentale. E poi cosa dire di
quella meravigliosa anafora diventata quasi il ritornello di una canzone? "I
Have a Dream" è ripetuto ben otto volte».
Il potere ha proprio l'oro in bocca.
«King ha cambiato il mondo rendendo gli uomini più uomini e meno bestie. Anche
Goebbles faceva discorsi molto applauditi. Ma ha reso gli uomini peggio delle
bestie».
Anche gli italiani hanno avuto bisogno di
"discorsi" veri, no?
«Certo. Beppe Grillo è stato un grande trascinatore, ha emozionato le piazze, le
ha fatte ridere e piangere. Il suo stile però è quello delle Filippiche. Inveire
sempre. Scatenare l'invidia e l'odio per chi ha il posto fisso, per chi sta in
Parlamento. Muove le folle ma costruisce poco».
Abbiamo perso anche questa occasione.
«King diceva di non bere alla coppa del rancore e dell'odio. Questa è una grande
differenza tra i due. Il suo era in fondo un invito in fondo all'unità nazionale
e la gente, bianca e nera, lo ha sentito».
Ma era anche un invito a sognare.
«Anche Berlusconi ha fatto sognare gli italiani. Indimenticabile il suo discorso
d'esordio: "L'Italia è il paese che io amo". La gente aveva iniziato a pensare
che finalmente si poteva fare politica in modo diverso e che si poteva parlare
di ricchezza senza imbarazzi. Quello che propone però è un sogno infinito».
In che senso?
«Lo scorso febbraio ha fatto ancora promesse: non far pagare l'Imu. Lo ha fatto
anche lui in termini biblici sancendo una sorta di alleanza tra gli italiani e
lo Stato. Ma non è questo quello di cui abbiamo bisogno».
E di cosa?
«L'Imu da non pagare non basta. Aneliamo tutti a una visione diversa del paese
dove viviamo, della nostra storia comune e personale».
Ci faccia un esempio.
«Alcide De Gasperi. Era appena finita la seconda guerra mondiale, lo aspettava
la Conferenza di pace a Parigi. Partì per andare a negoziare le sanzioni per
l'Italia che ne era uscita perdente. Questo piccolo uomo va ad affrontare
letteralmente il mondo. Arriva e non gli stringono neanche la mano».
Cosa otterrà?
«Inizia il suo discorso così: "Avverto che in quest'aula tutto è contro di
me...". Ha usato parole semplici ed educate. E' riuscito a far capire che
l'Italia era ancora affidabile. Ha ottenuto il massimo del rispetto. Tutti
cambiarono idea, capirono che il paese aveva chiuso col fascismo».
Sono passati un bel po' di anni.
«Solo dopo dieci quel discorso l'Italia divenne tra le potenze industriali più
potenti del mondo».
La domanda «Perché oggi non ci riusciamo?» potrebbe diventare un'ennesima figura
retorica: excusatio non petita accusatio manifesta.... Tanto vale.
STATO DI
DIRITTO?
Berlusconi, il
discorso integrale. Ecco l’intervento video del Cavaliere: «Care amiche, cari
amici, voglio parlarvi con la sincerità con cui ognuno di noi parla alle persone
alle quali vuole bene quando bisogna prendere una decisione importante che
riguarda la nostra famiglia. Che si fa in questi casi? Ci si guarda negli occhi,
ci si dice la verità e si cerca insieme la strada migliore. Siete certamente
consapevoli che siamo precipitati in una crisi economica senza precedenti, in
una depressione che uccide le aziende, che toglie lavoro ai giovani, che
angoscia i genitori, che minaccia il nostro benessere e il nostro futuro. Il
peso dello Stato, delle tasse, della spesa pubblica è eccessivo: occorre
imboccare la strada maestra del liberalismo che, quando è stata percorsa, ha
sempre prodotto risultati positivi in tutti i Paesi dell’Occidente: qual è
questa strada? Meno Stato, meno spesa pubblica, meno tasse. Con la sinistra al
potere, il programma sarebbe invece, come sempre, altre tasse, un’imposta
patrimoniale sui nostri risparmi, un costo più elevato dello Stato e di tutti i
servizi pubblici. I nostri ministri hanno già messo a punto le nostre proposte
per un vero rilancio dell’economia, proposte che saranno principalmente volte a
fermare il bombardamento fiscale che sta mettendo in ginocchio le nostre
famiglie e le nostre imprese. Ma devo ricordare che gli elettori purtroppo non
ci hanno mai consegnato una maggioranza vera, abbiamo sempre dovuto fare i conti
con i piccoli partiti della nostra coalizione che, per i loro interessi
particolari, ci hanno sempre impedito di realizzare le riforme indispensabili
per modernizzare il Paese, prima tra tutte quella della giustizia. E proprio per
la giustizia, diciamoci la verità, siamo diventati un Paese in cui non vi è più
la certezza del diritto, siamo diventati una democrazia dimezzata alla mercé di
una magistratura politicizzata, una magistratura che, unica tra le magistrature
dei Paesi civili, gode di una totale irresponsabilità, di una totale impunità.
Questa magistratura, per la prevalenza acquisita da un suo settore, Magistratura
Democratica, si è trasformata da “Ordine” dello Stato, costituito da impiegati
pubblici non eletti, in un “Potere” dello Stato, anzi in un “Contropotere” in
grado di condizionare il Potere legislativo e il Potere esecutivo e si è data
come missione, quella - è una loro dichiarazione - di realizzare “la via
giudiziaria” al socialismo. Questa magistratura, dopo aver eliminato nel ’92 -
’93 i cinque partiti democratici che ci avevano governati per cinquant’anni,
credeva di aver spianato definitivamente la strada del potere alla
sinistra. Successe invece quel che sapete: un estraneo alla politica, un certo
Silvio Berlusconi, scese in campo, sconfisse la gioiosa macchina da guerra della
sinistra, e in due mesi portò i moderati al governo. Ero io. Subito, anzi
immediatamente, i P.M. e i giudici legati alla sinistra e in particolare quelli
di Magistratura Democratica si scatenarono contro di me e mi inviarono un avviso
di garanzia accusandomi di un reato da cui sarei stato assolto, con formula
piena, sette anni dopo. Cadde così il governo, ma da quel momento fino ad oggi
mi sono stati rovesciati addosso, incredibilmente, senza alcun fondamento nella
realtà, 50 processi che hanno infangato la mia immagine e mi hanno tolto tempo,
tanto tempo, serenità e ingenti risorse economiche. Hanno frugato ignobilmente e
morbosamente nel mio privato, hanno messo a rischio le mie aziende senza alcun
riguardo per le migliaia di persone serie ed oneste che vi lavorano, hanno
aggredito il mio patrimonio con una sentenza completamente infondata, che ha
riconosciuto a un noto, molto noto, sostenitore della sinistra una somma quattro
volte superiore al valore delle mie quote, con dei pretesti hanno attaccato me,
la mia famiglia, i miei collaboratori, i miei amici e perfino i miei ospiti. Ed
ora, dopo 41 processi che si sono conclusi, loro malgrado, senza alcuna
condanna, si illudono di essere riusciti ad estromettermi dalla vita politica,
con una sentenza che è politica, che è mostruosa, ma che potrebbe non essere
definitiva come invece vuol far credere la sinistra, perché nei tempi giusti,
nei tempi opportuni, mi batterò per ottenerne la revisione in Italia e in
Europa. Per arrivare a condannarmi si sono assicurati la maggioranza nei collegi
che mi hanno giudicato, si sono impadroniti di questi collegi, si sono inventati
un nuovo reato, quello di “ideatore di un sistema di frode fiscale”, senza
nessuna prova, calpestando ogni mio diritto alla difesa, rifiutandosi di
ascoltare 171 testimoni a mio favore, sottraendomi da ultimo, con un ben
costruito espediente, al mio giudice naturale, cioè a una delle Sezioni
ordinarie della Cassazione, che mi avevano già assolto, la seconda e la terza,
due volte, su fatti analoghi negando - cito tra virgolette - “l’esistenza in
capo a Silvio Berlusconi di reali poteri gestori della società
Mediaset”. Sfidando la verità, sfidando il ridicolo, sono riusciti a condannarmi
a quattro anni di carcere e soprattutto all’interdizione dai pubblici uffici,
per una presunta ma inesistente evasione dello zero virgola, rispetto agli oltre
10 miliardi, ripeto 10 miliardi di euro, quasi ventimila miliardi di vecchie
lire, versati allo Stato, dal ’94 ad oggi, dal gruppo che ho fondato. Sono
dunque passati vent’anni da quando decisi di scendere in campo. Allora dissi che
lo facevo per un Paese che amavo. Lo amo ancora, questo Paese, nonostante
l’amarezza di questi anni, una grande amarezza, e nonostante l’indignazione per
quest’ultima sentenza paradossale, perché, voglio ripeterlo ancora, con
forza, “io non ho commesso alcun reato, io non sono colpevole di alcunché, io
sono innocente, io sono assolutamente innocente”. Ho dedicato l’intera seconda
parte della mia vita, quella che dovrebbe servire a raccogliere i frutti del
proprio lavoro, al bene comune. E sono davvero convinto di aver fatto del bene
all’Italia, da imprenditore, da uomo di sport, da uomo di Stato. Per il mio
impegno ho pagato e sto pagando un prezzo altissimo, ma ho l’orgoglio di aver
impedito la conquista definitiva del potere alla sinistra, a questa sinistra che
non ha mai rinnegato la sua ideologia, che non è mai riuscita a diventare
socialdemocratica, che è rimasta sempre la stessa: la sinistra dell’invidia, del
risentimento e dell’odio. Devo confessare che sono orgoglioso, molto orgoglioso,
di questo mio risultato. Proprio per questo, adesso, insistono nel togliermi di
mezzo con un’aggressione scientifica, pianificata, violenta del loro braccio
giudiziario, visto che non sono stati capaci di farlo con gli strumenti della
democrazia. Per questo, adesso, sono qui per chiedere a voi, a ciascuno di voi,
di aprire gli occhi, di reagire e di scendere in campo per combattere questa
sinistra e per combattere l’uso della giustizia a fini di lotta politica, questo
male che ha già cambiato e vuole ancora cambiare la storia della nostra
Repubblica. Non vogliamo e non possiamo permettere che l’Italia resti rinchiusa
nella gabbia di una giustizia malata, che lascia tutti i giorni i suoi segni
sulla carne viva dei milioni di italiani che sono coinvolti in un processo
civile o penale. È come per una brutta malattia: uno dice “a me non capiterà”,
ma poi, se ti arriva addosso, entri in un girone infernale da cui è difficile
uscire. Per questo dico a tutti voi, agli italiani onesti, per bene, di buon
senso: reagite, protestate, fatevi sentire. Avete il dovere di fare qualcosa di
forte e di grande per uscire dalla situazione in cui ci hanno precipitati. So
bene, quanto sia forte e motivata la vostra sfiducia, la vostra nausea verso la
politica, verso “questa” politica fatta di scandali, di liti in tv, di una
inconcludenza e di un qualunquismo senza contenuti: una politica che sembra un
mondo a parte, di profittatori e di mestieranti drammaticamente lontani dalla
vita reale. Ma nonostante questo, ed anzi proprio per questo, occorre che noi
tutti ci occupiamo della politica. È sporca? Ma se la lasci a chi la sta
sporcando, sarà sempre più sporca… Non te ne vuoi occupare? Ma è la politica
stessa che si occuperà comunque di te, della tua vita, della tua famiglia, del
tuo lavoro, del tuo futuro. È arrivato quindi davvero il momento di svegliarci,
di preoccuparci, di ribellarci, di indignarci, di reagire, di farci sentire. È
arrivato il momento in cui tutti gli italiani responsabili, gli italiani che
amano l’Italia e che amano la libertà, devono sentire il dovere di impegnarsi
personalmente. Per questo credo che la cosa migliore da fare sia quella di
riprendere in mano la bandiera di Forza Italia. Perché Forza Italia non è un
partito, non è una parte, ma è un’idea, un progetto nazionale che unisce tutti.
Perché Forza Italia è l’Italia delle donne e degli uomini che amano la libertà
e che vogliono restare liberi. Perché Forza Italia è la vittoria dell’amore
sull’invidia e sull’odio. Perché Forza Italia difende i valori della nostra
tradizione cristiana, il valore della vita, della famiglia, della solidarietà,
della tolleranza verso tutti a cominciare dagli avversari. Perché Forza Italia
sa bene che lo Stato deve essere al servizio dei cittadini e non invece i
cittadini al servizio dello Stato. Perché Forza Italia è l’ultima chiamata prima
della catastrofe. È l’ultima chiamata per gli italiani che sentono che il
nostro benessere, la nostra democrazia, la nostra libertà sono in pericolo e
rendono indispensabile un nuovo, più forte e più vasto impegno. Forza Italia
sarà un vero grande movimento degli elettori, dei cittadini, di chi vorrà
diventarne protagonista. Una forza che può e che deve conquistare la
maggioranza dei consensi perché, vi ricordo, che solo con una vera e autonoma
maggioranza in Parlamento si può davvero fare del bene all’Italia, per tornare
ad essere una vera democrazia e per liberarci dall’oppressione giudiziaria, per
liberarci dall’oppressione fiscale, per liberarci dall’oppressione burocratica.
Per questo vi dico: scendete in campo anche voi. Per questo ti dico: scendi in
campo anche tu, con Forza Italia. Diventa anche tu un missionario di libertà,
diffondi i nostri valori e i nostri programmi, partecipa ai nostri convegni e
alle nostre manifestazioni, impegnati nelle prossime campagne elettorali e
magari anche nelle sezioni elettorali per evitare che ci vengano sottratti
troppi voti, come purtroppo è sempre accaduto. Voglio ripeterlo ancora: in
questo momento, nella drammatica situazione in cui siamo, ogni persona
consapevole e responsabile che vuol continuare a vivere in Italia ha il dovere
di occuparsi direttamente del nostro comune destino. Io sarò sempre con voi, al
vostro fianco, decaduto o no. Si può far politica anche senza essere in
Parlamento. Non è il seggio che fa un leader, ma è il consenso popolare, il
vostro consenso. Quel consenso che non mi è mai mancato e che, ne sono sicuro,
non mi mancherà neppure in futuro. Anche se, dovete esserne certi, continueranno
a tentare di eliminare dalla scena politica, privandolo dei suoi diritti
politici e addirittura della sua libertà personale, il leader dei moderati,
quegli italiani liberi che, voglio sottolinearlo, sono da sempre la maggioranza
del Paese e lo saranno ancora se sapranno finalmente restare uniti. Sono
convinto che mi state dando ragione, sono convinto che condividete questo mio
allarme, sono convinto che saprete rispondere a questo mio appello, che è prima
di tutto una testimonianza di amore per la nostra Italia. E dunque: Forza
Italia! Forza Italia! Forza Italia! Viva l’Italia, viva la libertà: la libertà è
l’essenza dell’uomo e Dio creando l’uomo, l’ha voluto libero.»
Lettera
aperta al dr Silvio Berlusconi.
«Sig.
Presidente, sono Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Diverso,
perché, nell’informare la gente dell’imperante ingiustizia, i magistrati se ne
lamentano. E coloro che io critico, poi, sono quelli che mi giudicano e mi
condannano. Ma io, così come altri colleghi perseguitati che fanno vera
informazione, non vado in televisione a piangere la mia malasorte.
Pur essendo
noi, per i forcaioli di destra e di sinistra, “delinquenti” come lei.
Sono un
liberale, non come lei, ed, appunto, una cosa a Lei la voglio dire.
Quello che le
è capitato, in fondo, se lo merita. 20 anni son passati. Aveva il potere
economico. Aveva il potere mediatico. Aveva il potere politico. Aveva il potere
istituzionale. E non è stato capace nemmeno di difendere se stesso dallo
strapotere dei magistrati. Li ha lasciati fare ed ha tutelato gli interessi
degli avvocati e di tutte le lobbies e le caste, fregandosene dei poveri cristi.
Perché se quello di cui si lamenta, capita a lei, figuriamoci cosa capita alla
povera gente. E i suoi giornalisti sempre lì a denunciare abusi ed ingiustizie a
carico del loro padrone. Anzi, lei, oltretutto, imbarca nei suoi canali
mediatici gente comunista genuflessa ai magistrati. Non una parola sul fatto che
l’ingiustizia contro uno, siffatto potente, è l’elevazione a sistema di un
cancro della democrazia. Quanti poveri cristi devono piangere la loro sorte di
innocenti in carcere per convincere qualcuno ad intervenire? Se è vero, come è
vero, che se funzionari di Stato appartenenti ad un Ordine si son elevati a
Potere, è sacrosanto sostenere che un leader politico che incarna il Potere del
popolo non sta lì a tergiversare con i suoi funzionari, ma toglie loro la linfa
che alimenta lo strapotere di cui loro abusano. Ma tanto, chi se ne fotte della
povera gente innocente rinchiusa in canili umani.
“Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei
libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio
i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso! Ha mai pensato, per un momento, che c’è qualcuno che da anni lavora
indefessamente per farle sapere quello che non sa? E questo al di là della sua
convinzione di sapere già tutto dalle sue fonti? Provi a leggere un e-book o un
book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede veramente in Italia. Cose che
nessuno a lei vicino le dirà mai. Non troverà le cose ovvie. Cose che servono
solo a bacare la mente. Troverà quello che tutti sanno, o che provano sulla loro
pelle, ma che nessuno ha il coraggio di raccontare.
Può anche non
leggere questi libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza imperante che
impedisce l’evoluzione non potrà dire che la colpa è degli altri e che gli altri
son tutti uguali.
Ad oggi, per
esempio, sappiamo che lo studio di due ricercatori svela: i magistrati di
sinistra indagano di più gli avversari politici; i magistrati di destra
insabbiano di più le accuse contro i loro amici e colleghi. E poi. Parla l’ex
capo dei Casalesi. La camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno
politici, magistrati e forze dell’ordine mafiosi. Inutile lamentarci dei
"Caccamo" alla Cassazione. Carmine Schiavone ha detto: Roma nostra! "Ondata
di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici,
Napoli capitale dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto»
un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori". O la
statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso
di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi
agli orali vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che
rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della
popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza:
erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della
commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli
esaminatori. Lo strumento per addentrarsi nei gangli del potere sono gli esami
di Stato ed i concorsi pubblici truccati.
Bene, dr
Berlusconi, Lei, avendone il potere per 20 anni, oltre che lamentarsi, cosa ha
fatto per tutelare, non tanto se stesso, i cui risultati sono evidenti, ma i
cittadini vittime dell’ingiustizia (contro il singolo) e della malagiustizia
(contro la collettività)?
Quello che i
politici oggi hanno perso è la credibilità: chi a torto attacca i magistrati;
chi a torto li difende a spada tratta; chi a torto cerca l’intervento
referendario inutile in tema di giustizia, fa sì che quel 50 % di astensione
elettorale aumenti. Proprio perché, la gente, è stufa di farsi prendere in giro.
Oltremodo adesso che siete tutti al Governo delle larghe intese per fottere il
popolo. Quel popolo che mai si chiede: ma che cazzo di fine fanno i nostri
soldi, che non bastano mai? E questo modo di fare informazione e spettacolo
della stampa e della tv, certamente, alimenta il ribrezzo contro l'odierno
sistema di potere.
Per fare un
sillogismo. Se l’Italia è la Costa Concordia, e come tale è affondata, la colpa
non è dello Schettino di turno, ma dell’equipaggio approssimativo di cui si è
circondato. E se la Costa Crociere ha la sua Flotta e l’Italia ha la sua
amministrazione centrale e periferica, quanti Schettino e relativi equipaggi ci
sono in giro a navigare? E quante vittime i loro naufragi provocano? Si dice che
l’Italia, come la Costa Concordia, è riemersa dall’affondamento? Sì, ma come?
Tutta ammaccata e da rottamare!!! E gli italioti lì a belare……»
Antonio
Giangrande, orgoglioso di essere diverso.
“Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. È uno Stato di diritto che funziona quello che
è costretto a sborsare ogni anno decine di milioni per rimborsare cittadini che
hanno dovuto trascorrere giorni, mesi, anni in carcere da innocenti? È uno Stato
di diritto quello in cui dove dovrebbero stare 100 detenuti ce ne stanno 142? È
uno Stato di diritto quello in cui ogni quattro procedimenti già fissati per il
dibattimento tre vengono rinviati per motivi vari?
Domande che
con Andrea Cuomo su “Il Giornale” giriamo al premier Enrico Letta del Partito
Democratico (ex PCI), che - in funzione chiaramente anti-Cav - ha giurato: «In
Italia lo Stato di diritto funziona». Postilla: «Non ci sono persecuzioni».
Chissà che cosa pensano in particolare di questa ultima affermazione categorica
le tantissime vittime di errori giudiziari a cui il quotidiano romano Il Tempo
ha dedicato un'inchiesta di cinque giorni che ha contrassegnato l'insediamento
alla direzione del nostro ex inviato Gian Marco Chiocci, che di giornalismo
giudiziario ne mastica eccome.
Tanti i dati
sciorinati e le storie raccontate dal quotidiano di piazza Colonna. Secondo cui
per il Censis, nel dopoguerra, sono stati 5 milioni gli italiani coinvolti in
inchieste giudiziarie e poi risultati innocenti. Di essi circa 25mila sono
riusciti a ottenere il rimborso per ingiusta detenzione a partire dal 1989, per
un esborso totale di 550 milioni di euro in tutto: del resto per ogni giorno
passato in carcere lo Stato riconosce all'innocente 235,83 euro, e la metà
(117,91) in caso di arresti domiciliari. Il tetto massimo di rimborso sarebbe di
516.456,90 euro. Ma Giuseppe Gulotta, che con il marchio di duplice assassino
impresso sulla pelle da una confessione estorta a forza di botte (metodo usato
per tutti) ha trascorso in cella 22 anni per essere scagionato nel 2012,
pretende 69 milioni. Tanto, se si pensa al tetto di cui sopra. Nulla se questo è
il prezzo di una vita squartata, merce che un prezzo non ce l'ha. Per il caso
Sebai, poi, è calata una coltre di omertà. I condannanti per i delitti di 13
vecchiette, anche loro menati per rendere una confessione estorta, sono ancora
dentro, meno uno che si è suicidato. Questi non risultano come vittime di errori
giudiziari, nonostante il vero assassino, poi suicidatosi, ha confessato, con
prove a sostegno, la sua responsabilità. Lo stesso fa Michele Misseri, non
creduto, mentre moglie e figlia marciscono in carcere. Siamo a Taranto, il Foro
dell’ingiustizia.
E siccome i
cattivi giudici non guardano in faccia nessuno, spesso anche i vip sono caduti
nella trappola dell'errore giudiziario. Il più famoso è Enzo Tortora. Ma ci sono
anche Serena Grandi, Gigi Sabani, Lelio Luttazzi, Gioia Scola, Calogero Mannino
e Antonio Gava nel Who's Who della carcerazione ingiusta. Carcerazione che è a
suo modo ingiusta anche per chi colpevole lo è davvero quando è trascorsa nelle
206 carceri italiane. La cui capienza ufficiale sarebbe di 45.588 persone ma ne
ospitano 66.632. Lo dice il rapporto «Senza Dignità 2012» dell'associazione
Antigone, vero museo degli orrori delle prigioni d'Italia. Il Paese secondo il
cui premier «lo Stato di diritto è garantito». Pensate se non lo fosse.
Non solo ci è
impedito dire “Italia di Merda” in base alla famosa sentenza della Corte di
Cassazione. In questo Stato, addirittura, è vietato dire “Fisco di Merda”. Per
gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana,
con le motivazioni della sentenza del tribunale di Milano che il 19 luglio 2013
li ha condannati a un anno e otto mesi di reclusione per il reato di omessa
dichiarazione dei redditi, è arrivata, dopo il danno, anche la beffa. La
sentenza li obbliga a risarcire con 500mila euro il «danno morale»
arrecato al Fisco italiano. Di cosa sono colpevoli? Da molti anni i «simboli»
della moda italiana denunciano l’eccessiva pressione fiscale. All’indomani della
sentenza avevano chiuso per protesta i negozi di Milano. E una critica, pare,
può costare cara. La sentenza sembra quasi contenere una excusatio non petita:
il danno, scrivono i magistrati, è dovuto «non tanto, ovviamente, per
l’esposizione a legittime critiche in merito agli accertamenti, quanto per il
pregiudizio che condotte particolarmente maliziose cagionano alla funzionalità
del sistema di accertamento ed alla tempestiva percezione del tributo».
Ora venite a
ripeterci che le sentenze non si discutono, scrive Filippo Facci. Gli stilisti
Dolce & Gabbana sono già stati condannati a un anno e otto mesi per evasione
fiscale, e pace, lo sapevamo. Ma, per il resto, chiudere i propri negozi per
protesta è un reato oppure non lo è. E non lo è. Il semplice denunciare
l’eccesso di pressione fiscale è un reato oppure non lo è. E non lo è. Comprare
una pagina di giornale per lamentarsi contro Equitalia è un reato oppure non lo
è. E non lo è. Rilasciare interviste contro il fisco rapace è un reato oppure
non lo è. E non lo è. E se non lo è - se queste condotte non sono reati - la
magistratura non può prendere questi non-reati e stabilire che nell’insieme
abbiano inferto un «danno morale» al fisco italiano, come si legge nelle
motivazioni della sentenza appena rese note. I giudici non possono stabilire
che degli atti leciti «cagionano pregiudizio alla funzionalità del sistema di
accertamento e alla tempestiva percezione del tributo». Ergo, i giudici non
possono affibbiare a Dolce & Gabbana altri 500mila euro di risarcimento per
«danno morale», come hanno fatto: perché significa che il diritto di critica è
andato definitivamente a ramengo e che la sola cosa da fare è pagare e stare
zitti, perché sennò la gente, sai, poi pensa male di Equitalia. Ecco perché
occorre proteggerla da quella moltitudine di crudeli cittadini pronti a
infliggerle terrificanti danni morali con le loro lagnanze. Siamo alla follia.
Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali.
Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio
i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Ha mai
pensato, per un momento, che c’è qualcuno che da anni lavora indefessamente per
farle sapere quello che non sa? E questo al di là della sua convinzione di
sapere già tutto dalle sue fonti?
Provi a
leggere un e-book o un book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede
veramente nella sua regione o in riferimento alla sua professione. Cose che
nessuno le dirà mai.
Non troverà le
cose ovvie contro la Mafia o Berlusconi o i complotti della domenica. Cose che
servono solo a bacare la mente. Troverà quello che tutti sanno, o che provano
sulla loro pelle, ma che nessuno ha il coraggio di raccontare.
Può anche non
leggere questi libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza imperante che
impedisce l’evoluzione non potrà dire che la colpa è degli altri e che gli altri
son tutti uguali.
CHI E’ IL
POLITICO?
Ora lo dice
anche la scienza: la politica manda fuori di testa. Incapace di accettare idee
diverse e pronto a manipolare i dati a proprio comodo. Il cervello della casta
secondo Yale, scrive “Libero Quotidiano”. Oramai c'è anche il sigillo della
scienza: la politica rende intellettualmente disonesti.
Lo dimostra uno studio condotto da Dan Kahan della Yale
University: la passione politica compromette il funzionamento della
mente e induce a distorcere logica e capacità di calcolo. Perché? Perché il
cervello del politico, come risulta dallo studio, prova a ogni costo
a modificare i dati reali per farli aderire alla propria visione del mondo.
L'esperimento, la prima
parte
- Tra i vari esperimenti che hanno composto lo studio (pubblicato col titolo “Motivated
numeracy and Enlightened self-government”), ce n'è uno che illustra meglio
di tutti il meccanismo di deformazione intellettuale dei politici. E' stato
chiesto alle "cavie" di interpretare delle tavole numeriche relativa alla
capacità di provocare prurito di alcune creme dermatologiche.
Non avendo l'argomento implicazioni sociali, i politici sono
stati in grado di eseguire correttamente i calcoli aritmetici.
L'esperimento, la seconda
parte -
In seconda battuta, allo stesso campione umano è stato chiesto di leggere tavole
che per tema, però, avevano il rapporto tra licenze dei porti d'armi e
variazione del tasso di criminalità. E i nodi sono venuti al pettine. Avendo
l'argomento ovvia rilevanza politica, le cavie sono andate in
tilt. Quando si trovavano a dover rispondere a quesiti aritmetici in
contraddizione con le proprie convinzioni, sbagliavano
in maniera inconscia anche calcoli semplici per non dover arrivare a una
soluzione sgradita. Insomma: meglio andare fuori strada che
imboccare una strada spiacevole.
Le conclusioni -
Il prof
della Yale non ha dubbi: la passione politica è una fatto congenito che però
condiziona il cervello. Una volta che il politico fa sua una
certa visione del mondo, non c'è dato o riscontro oggettivo che possa fargli cambiare
idea.
CHI E’
L’AVVOCATO?
Chi è
l’avvocato: fenomenologia di una categoria, spiega un anonimo sul portale “La
Legge per tutti”.
O li si ama o
li si odia: non esistono vie di mezzo per gli avvocati, una delle categorie
professionali più contraddittorie e discusse dai tempi degli antichi greci.
“E il
Signore disse: Facciamo Satana, così la gente non mi incolperà di tutto. E
facciamo gli avvocati, così la gente non incolperà di tutto Satana”.
La battuta del
comico statunitense, George Burns, è il modo migliore per aprire l’argomento su
una delle professioni da sempre più discusse. Perché, diciamoci la verità,
appena si parla di “avvocati” la prima idea che corre è quella di una
“categoria“: non tanto nel senso di lobby, quanto di un mondo sociale a parte,
con i suoi strani modi di essere e di pensare. Insomma, proprio come quando si
pensa ad una razza animale.
Difensori dei
diritti o azzeccagarbugli abili solo a far assolvere i colpevoli? Professionisti
della logica o dotati retori? La linea di confine è così labile che
l’immaginario collettivo li ha sempre collocati a cavallo tra la menzogna e il
rigore.
Di tutto
questo, però, una cosa è certa: gli avvocati formano un mondo a sé.
La parola
“avvocato” deriva dal latino “vocatus“‘ ossia “chiamato”. Non nel senso, come
verrebbe spontaneo pensare, che all’indirizzo di questa figura vengono rivolti
irripetibili epiteti offensivi, ma nel significato che a lui ci si rivolge
quando si ha bisogno di aiuto.
L’odio da
sempre legato al legale va a braccetto con la parola “parcella“: un peso che ha
trascinato questa categoria nel più profondo girone dantesco. Perché – la gente
si chiede – bisogna pagare (anche profumatamente) per far valere i propri
diritti? In realtà, la risposta è la stessa per cui bisogna remunerare un medico
per godere di buona salute o aprire un mutuo per avere un tetto sotto cui
dormire. Tuttavia, i fondamenti della difesa legale risalgono a quando, già
dagli antichi greci, i soliti individui omaggiati di improvvisa ricchezza erano
anche quelli inabissati di profonda ignoranza: costoro trovarono più conveniente
affidare ai più istruiti la difesa dei propri interessi. E ciò fu anche la
consegna delle chiavi di un’intera scienza. Perché, da allora, il popolo non si
è più riappropriato di ciò che era nato per lui: la legge.
I primi
avvocati erano anche filosofi, e questo perché non esistevano corpi legislativi
definiti e certi. Erano, insomma, la classe che non zappava, ma guardava le
stelle. Un’anima teorica che, a quanto sembra, è rimasta sino ad oggi.
Ciò che, però,
si ignora è che, ai tempi dei romani, il compenso dell’avvocato era la fama,
acquisita la quale si poteva pensare d’intraprendere la carriera politica. In
quel periodo sussisteva il divieto di ricevere denaro in cambio delle proprie
prestazioni professionali e la violazione di tale precetto era sanzionata con
una pena pecuniaria. Il divieto, sin da allora e secondo buona prassi italica,
veniva sistematicamente raggirato poiché era consentito – proprio come avviene
oggi nei migliori ambienti della pubblica amministrazione – accettare doni e
regalie da parte dei clienti riconoscenti. Da qui venne il detto: “ianua
advocati pulsanda pede” (“alla porta dell’avvocato si bussa col piede”, visto
che le mani sono occupate a reggere i doni).
“La
giurisprudenza estende la mente e allarga le vedute”: una considerazione che,
seppur vera, si scontra con la prassi. Il carattere di un avvocato, infatti, è
permaloso e presuntuoso. Provate a fargli cambiare idea: se ci riuscirete sarà
solo perché lui vi ha fatto credere così. In realtà, ogni avvocato resta sempre
della propria idea. Giusta o sbagliata che sia. Ed anche dopo la sentenza che
gli dà torto. A sbagliare è sempre il giudice o la legge.
L’avvocato è
una persona abituata a fare domande e, nello stesso tempo, ad essere evasivo a
quelle che gli vengono rivolte. È solito prendere decisioni e a prenderle in
fretta (calcolate la differenza di tempi con un ingegnere e vedrete!). È dotato
di problem solving e il suo obiettivo è trovare l’escamotage per uscire fuori
dal problema, in qualsiasi modo possibile.
Inoltre,
l’avvocato, nell’esercizio della propria professione, è un irriducibile
individualista: se ne sta nel suo studio, a coltivare le sue pratiche, e l’idea
dell’associativismo gli fa venire l’orticaria.
Egli considera
ogni minuto sottratto al proprio lavoro una perdita di tempo. Il tempo appunto:
ogni legale nasce con l’orologio al polso, e questo perché la vita professionale
è costellata di scadenze. Tra termini iniziali, finali, dilatori, ordinatori,
perentori, ogni avvocato considera la propria agenda più della propria compagna
di letto.
Così come la
caratteristica di ogni buon medico è quella di scrivere le ricette con una
grafia incomprensibile, dote di ogni avvocato è parlare con un linguaggio mai
chiaro per il cittadino. Tra latinismi, istituti, tecnicismi, concettualismi,
astrazioni, teorie e interpretazioni, commi, articoli, leggi, leggine e
sentenze, il vocabolario del legale è precluso ad ogni persona che non sia,
appunto, un altro legale. E questo – a quanto sembra – gratifica infinitamente
ogni avvocato che si rispetti.
Su tutto,
però, l’avvocato è un relativista nell’accezione più pirandelliana del termine.
La realtà non esiste (e chi se ne frega!): esiste solo ciò che appare dalle
carte. Tutto il resto è mutevole, contraddittorio, variabile, volubile,
capriccioso, instabile. Tanto vale non pensarci e accontentarsi di ciò che
racconta il cliente.
Si dice che il
problema dell’avvocatura sia il numero. Su 9.000 giudici, in Italia ci sono
circa 220.000 avvocati. In realtà, il problema sarebbe di gran lunga più grave
se di avvocati ve ne fossero pochi, circostanza che aprirebbe le porte alla
scarsità e, quindi, a tariffe ancora più alte e a una certa difficoltà a poter
difendere tutti.
La ragione di
tale eccesso di offerta risiede nel fatto che la facilità con cui si accede,
oggi, all’avvocatura ha fatto si che tale professione venisse considerata una
sorta di area di transito in cui potersi parcheggiare in attesa di un lavoro più
soddisfacente (e, di questi tempi, remunerativo). Poi, però, le cose non vanno
mai come programmato e ciò che doveva essere un impegno momentaneo diventa
quello di una vita (salvo tentare il classico concorso pubblico e inseguire la
chimera del posto fisso a reddito certo).
Ci piace
terminare con le parole di Giulio Imbarcati, pseudonimo di un collega che ha
saputo prendere in giro la categoria, disegnandola anche finemente in un suo
libro di successo.
“Il
problema è che oggi nel campo dell’avvocatura (più che in altre professioni) non
è il mercato a operare la selezione.
Se così
fosse tutti saremmo più tranquilli e fiduciosi, perché questo vorrebbe dire
qualità del servizio. E, come dovrebbe essere in qualsiasi sistema sociale che
voglia definirsi giusto, dopo l’uguale allineamento ai nastri di partenza, i più
dotati procedono veloci, i mediocri arrancano, gli inadatti si fermano.
Ma, nel
mondo all’incontrario che abbiamo costruito con lungimirante impegno, le cose
funzionano diversamente.
Capita che
siano proprio i più dotati a soccombere e non solo davanti ai mediocri, ma anche
rispetti agli inadatti.
Perché? Ma
perché proprio i mediocri e gli inadatti sono quelli più disposti al compromesso
e all’ipocrisia.
Proprio
loro, cioè, per raggiungere gli obiettivi, e consapevoli della modesta dote
professionale, hanno meno difficoltà a discostarsi da quelle coordinate di
riferimento che i dotati continuano a considerare sacre e inviolabili.
L’effetto,
nel settore dell’avvocatura, è dirompente e a pagarne gli effetti non sarà solo
il fruitore immediato (ossia il cittadino), ma l’intero sistema giustizia.“
DELINQUENTE
A CHI?
“Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Parla l’ex
capo dei Casalesi. La camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno
politici, magistrati e forze dell’ordine mafiosi.
CARMINE
SCHIAVONE. MAGISTRATI: ROMA NOSTRA!
"Ondata
di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici,
Napoli capitale dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto»
un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori".
O la
statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso
di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi
agli orali vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che
rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della
popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza:
erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della
commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli
esaminatori.
CHI E’ IL
MAGISTRATO?
"Giustizia
usata per scopi politici". Se lo dice anche la Boccassini...
Una sparata senza precedenti contro le toghe politicizzate,
contro quella branca della magistratura che ha usato le aule di tribunale per
spiccare il volo in parlamento. A Ilda la Rossa, che la politica l'ha sempre
fatta direttamente nei corridoi del Palazzo di Giustizia di Milano, proprio non
vanno giù i vari Antonio Di Pietro, Luigi De Magistris e Antonio Ingroia che,
negli ultimi anni, hanno amaramente tentato di accaparrarsi una poltrona.
"Non è una patologia della magistratura - ha
spiegato la pm di Milano - ma ci sono dei pubblici ministeri che hanno usato il
loro lavoro per altro".
«Ognuno deve
fare la sua parte, anche i politici, anche i giornalisti, ma in questi vent'anni
lo sbaglio di noi magistrati è di non aver mai fatto un'autocritica o una
riflessione. Perché si è verificato ed è inaccettabile che alcune indagini sono
servite ad altro (per gli stessi magistrati, per carriere, per entrare in
politica)». Alcuni suoi colleghi si sono sentiti portatori di verità assolute
per le loro indagini grazie al "consenso sociale", cosa sbagliatissima, una
"patologia", sia per lei, sia per Giuseppe Pignatone, procuratore capo di Roma,
seduto al suo fianco. Una sparata senza precedenti contro le toghe
politicizzate, contro quella branca della magistratura che ha usato le
aule di tribunale per spiccare il volo in parlamento. A Ilda la Rossa, che la
politica l'ha sempre fatta direttamente nei corridoi del Palazzo di Giustizia di
Milano, proprio non vanno giù i vari Antonio Di Pietro, Luigi De Magistris e
Antonio Ingroia che, negli ultimi anni, hanno amaramente tentato di accaparrarsi
una poltrona. "Non è una patologia della
magistratura - ha spiegato la pm di Milano - ma ci sono dei pubblici ministeri
che hanno usato il loro lavoro per altro".
«Io - racconta
Boccassini, che dopo trent'anni ha cambiato colore e taglio di capelli, è
diventata bionda - durante Tangentopoli, stavo in Sicilia. Noi vivevano in hotel
"bunkerizzati", con i sacchi di sabbia, intorno era guerra. E quando arrivavo a
Milano, per salutare i colleghi, vedevo le manifestazioni a loro favore, "Forza
mani pulite""». E non le piaceva, anzi "ho provato una cosa terribile" quando la
folla scandiva i nomi dei magistrati, perché a muoverli "non dev'essere
l'approvazione". «Non è il consenso popolare che ci deve dare la forza di andare
avanti, ma il fatto di far bene il nostro mestiere. Ho sempre vissuto molto male
gli atteggiamenti osannanti delle folle oceaniche degli anni di Mani pulite e
delle stragi di mafia"». Intervenuta alla presentazione del libro di Lionello
Mancini, "L'onere della toga", il 14 settembre 2013 il pm milanese Ilda
Boccassini ha sottolineato gli atteggiamenti e le dinamiche che si sono
sviluppate nella magistratura negli ultimi vent'anni. «Un'anomalia dalla quale
dovremo uscire per forza di cose. Quello che rimprovero alla mia categoria è di
non aver mai fatto una seria autocritica in tutti questi anni», ha concluso.
Come ha
sottolineato Giuseppe Pignatone, una riflessione dovrebbe nascere in seguito al
processo Borsellino: ci sono stati dei condannati sino alla cassazione, ma poi
le confessioni di un collaboratore di giustizia hanno raccontato che la verità
era un'altra: "Chi ha sbagliato in buona fede deve dirlo", perché i magistrati
dell'accusa devono muoversi sempre sulle prove certe, invece, a volte, ripete
Pignatone, "quando le prove non ci sono, alcune notizie vengono fatte uscire sui
giornali, per una carica moralistica che non deve appartenere alla
magistratura". Anzi, è il contrario. La parola che Pignatone usa di più è
"equilibrio", sia per fermarsi, per evitare che persone finiscano nei guai senza
prove, sia "per partire e andare sino in fondo quando le prove ci sono". Tutti e
due hanno collaborato a lungo nelle inchieste che hanno decimato alcune tra le
cosche più potenti della 'ndrangheta.

Sono entrambi
- e lo dicono - in prima pagina dieci volte di più dei colleghi citati nel libro
di Mancini, ma conoscono la "nausea" comune a chiunque debba fare un mestiere
difficile, che ha a che fare con la vita, la morte, il dolore. E per questo, "se
un giornalista ha una notizia che mette in pericolo la vita di una persona, non
la deve dare", dice Boccassini, Pignatone concorda, De Bortoli e Mancini alzano
gli occhi al cielo.
L’idolatria è
il male endemico di una società debole. Ha come effetti il ridimensionamento
della condizione civile del singolo, il suo declassamento da cittadino a cliente
oppure a percettore di una identità e/o idealità passive, chiuse nel recinto di
una tifoseria. Io sono con te, sempre e comunque. Non amo altro Dio all’infuori
di te. Fa dunque bene Ilda Boccassini a denunciare la
trasformazione sociale dell’identità del magistrato, sia esso giudice o
pubblico ministero, che nella storia recente della Repubblica è spesso assurto a
stella del firmamento sociale, si è fatto, malgrado ogni sua buona e
condivisibile intenzione, parte di una battaglia; ha goduto di un
riconoscimento che magari esuberava dalle sue funzioni, dalla qualità
di rappresentante della legge (“uguale per tutti”) che gli avrebbe dovuto far
osservare l’obbligo di assoluta e rigorosa discrezione.
LA SCIENZA LO
DICE: I MAGISTRATI FANNO POLITICA. I ROSSI ATTACCANO. GLI AZZURRI INSABBIANO.
Ecco la prova:
i giudici fanno politica. Lo studio di due ricercatori svela: i magistrati di
sinistra indagano di più la destra. Ecco la prova: i giudici fanno politica. La
persecuzione degli avversari rilevata in un saggio scientifico, scrive Luca
Fazzo su “Il Giornale”. Alla fine, la questione può essere riassunta così, un
po' cinicamente: ma d'altronde il convegno si tiene nella terra del Machiavelli.
«Chiunque di noi fa preferenze. Se può scegliere se indagare su un nemico o su
un amico, indaga sul nemico. È l'istinto umano. E vale anche in politologia».
Parola di Andrea Ceron, ricercatore alla facoltà di Scienze politiche di Milano.
Che insieme al collega Marco Mainenti si è messo di buzzo buono a cercare
risposte scientifiche a una domanda che si trascina da decenni: ma è vero che in
Italia i giudici indagano in base alle loro preferenze politiche? La risposta
Ceron e Mainenti la daranno oggi a Firenze, presentando il loro paper -
anticipato ieri dal Foglio - in occasione del convengo annuale della Società
italiana di Scienza politica. È una risposta basata su tabelle un po' difficili
da capire, modelli matematici, eccetera. Ma la risposta è chiara: sì, è vero. La
magistratura italiana è una magistratura politicizzata, le cui scelte sono
condizionate dalle convinzioni politiche dei magistrati. I pm di sinistra
preferiscono indagare sui politici di destra. I pm di destra chiudono un occhio
quando di mezzo ci sono i loro referenti politici. Una tragedia o la conferma
scientifica dell'esistenza dell'acqua calda? Forse tutte e due le cose insieme.
Ventidue pagine, rigorosamente scritte in inglese, intitolate «Toga Party: the
political basis of judicial investigations against MPs in Italy, 1983-2013».
Dove MPs è l'acronimo internazionale per «membri del Parlamento». I politici, la
casta, quelli che da un capo all'altro della terra devono fare i conti con le
attenzioni della magistratura. Racconta Ceron: «Nei paesi dove i magistrati sono
eletti dalla popolazione, come l'America o l'Australia, che si facciano
condizionare dalla appartenenza politica è noto e quasi scontato. Ma cosa
succede nei paesi, come l'Italia, dove in magistratura si entra per concorso e
dove non c'è un controllo politico? Questa è la domanda da cui abbiamo preso le
mosse». Ricerca articolata su due hypothesis, come si fa tra scienziati
empirici: 1) più l'orientamento politico di un giudice è lontano da quello di un
partito, più il giudice è disposto a procedere contro quel partito; 2) i giudici
sono più disponibili a indagare su un partito, quanto più i partiti rivali
aumentano i loro seggi. Come si fa a dare una risposta che non sia una
chiacchiera da bar? Andando a prendere una per una le richiesta di
autorizzazione a procedere inviate dalle procure di tutta Italia al Parlamento
nel corso di trent'anni, prima, durante e dopo Mani Pulite; catalogando il
partito di appartenenza dei destinatari. E andando a incrociare questo dato con
l'andamento, negli stessi anni e negli stessi tribunali, delle elezioni per gli
organi dirigenti dell'Associazione nazionale magistrati, l'organizzazione
sindacale delle toghe, catalogandoli in base al successo delle correnti di
sinistra (Magistratura democratica e Movimento per la giustizia), di centro
(Unicost) e di destra (Magistratura indipendente); e dividendo un po'
bruscamente in «tribunali rossi» e in «tribunali blu». «Il responso è stato
inequivocabile», dice Ceron. Ovvero, come si legge nel paper: «I risultati
forniscono una forte prova dell'impatto delle preferenze dei giudici sulle
indagini. I tribunali dove un numero più alto di giudici di sinistra
appartengono a Md e all'Mg, tendono a indagare maggiormente sui partiti di
destra. La politicizzazione funziona in entrambe le direzioni: un aumento di
voti per le fazioni di destra fa scendere le richieste contro i partiti di
destra». I numeri sono quelli di una gigantesca retata: 1.256 richieste di
autorizzazione a procedere nei confronti di 1.399 parlamentari. Di queste, i due
ricercatori hanno focalizzato quelle relative ai reati di corruzione e
finanziamento illecito: 526, per 589 parlamentari. Fino al 1993, come è noto,
l'autorizzazione serviva anche per aprire le indagini, oggi è necessaria solo
per arrestare o intercettare. Ma, secondo la richiesta di Ceron e Mainardi, non
è cambiato nulla: almeno nella componente ideologica dell'accusa, che i due
considerano scientificamente e platealmente dimostrata. Dietro due grandi alibi,
che sono la mancanza di risorse e la presunta obbligatorietà dell'azione penale,
di fatto vige la più ampia discrezionalità. È un pm quasi sempre ideologicamente
schierato a scegliere su quale politico indagare. E quasi sempre dimentica di
dimenticarsi le sue opinioni. «L'analisi dei dati - spiega Ceron - dice che i
comportamenti sono lievemente diversi tra giudici di sinistra e di destra:
quelli di sinistra sono più attivi nell'indagare gli avversari, quelli di destra
preferiscono risparmiare accuse ai politici del loro schieramento». Ma in ogni
caso, di giustizia piegata all'ideologia e all'appartenenza politica si tratta.
Unita ad un'altra costante, di cui pure qualche traccia si coglie a occhio nudo:
fino a quando un partito è saldamente al potere, i pm sono cauti. Ma quando il
suo potere traballa e si logora, allora si scatenano.
Parla l’ex
capo dei Casalesi. La camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno
politici, magistrati e forze dell’ordine mafiosi.
CARMINE
SCHIAVONE. MAGISTRATI: ROMA NOSTRA!
"Ondata di
ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici,
Napoli capitale dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto»
un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori". O la
statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso
di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi
agli orali vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che
rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della
popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza:
erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della
commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli
esaminatori.
TRAMONTO
ROSSO. I COMUNISTI E LA GIUSTIZIA.
Questo libro
va usato come uno strumento per capire chi sono i Rossi, la classe politica di
centrosinistra chiamata a rinnovare il paese. Scritto come un viaggio in Italia,
da nord a sud, regione per regione, città per città. I protagonisti, gli affari,
gli scandali, le inchieste. Uomini chiave come l’ex capo della segreteria
politica Pd Filippo Penati, accusato di aver imposto tangenti, o il tesoriere
della fu Margherita Luigi Lusi, che ha fatto sparire 22 milioni di euro di fondi
elettorali. Roccaforti rosse come l’Emilia investite da casi di malaffare e
penetrazioni mafiose mai visti. Nel Comune di Serramazzoni (Modena) indagini su
abusi edilizi e gare pubbliche. I 3 milioni di cittadini accorsi alle primarie
per la scelta del leader sono un’iniezione di fiducia. Ma nella contesa manca un
programma chiaro di riforme in termini di diritti, lavoro, crescita. La difesa
del finanziamento pubblico ai partiti spetta al tesoriere dei Ds Ugo Sposetti da
Viterbo. Sposetti blinda in una serie di fondazioni il “patrimonio comunista”
prima della fusione con la Margherita. Il Pd continua a occuparsi di banche dopo
la scalata illegale di Unipol a Bnl (caso Monte dei Paschi). Il sistema
sanitario nelle regioni rosse è piegato agli interessi corporativi. Tutta una
classe politica che per anni ha vissuto di inciuci con Berlusconi, ora si
dichiara ripulita e finalmente pronta a governare. Ma i nomi sono gli stessi di
sempre. Ma anche il sistema Ds prima e Pd poi in tutte le regioni d’Italia dove
il governo si è protratto per anni e che tra sanità, cemento e appalti e
municipalizzata , i conflitti di interesse dal Lazio alla Puglia all’Emilia si
moltiplicano.
Così gli ex
Pci condizionano le procure. Inchieste insabbiate, politici protetti, giudici
trasferiti: le anomalie da Nord a Sud nel libro "Tramonto rosso", scrive
Patricia Tagliaferri su “Il Giornale”. Il Pd e i suoi scandali, dal nord al sud
d'Italia, dentro e fuori le Procure. Abusi, tangenti, speculazioni edilizie,
scalate bancarie, interessi corporativi nel sistema sanitario, magistrati
scomodi isolati, intimiditi, trasferiti. Potenti di turno miracolosamente
soltanto sfiorati da certe indagini. È un libro che farà discutere quello
scritto da Ferruccio Pinotti, giornalista d'inchiesta autore di numerosi libri
di indagine su temi scomodi, e Stefano Santachiara, blogger del Fatto. Atteso e
temuto Tramonto rosso, edito da Chiarelettere, sarà in libreria a fine ottobre
2013, nonostante le voci di un blocco, smentito dagli autori, e dopo un piccolo
slittamento (inizialmente l'uscita era prevista a giugno 2013) dovuto, pare, ad
un capitolo particolarmente spinoso su una forte influenza «rossa» che agirebbe
all'interno di uno dei tribunali più importanti d'Italia, quello di Milano, dove
indagini che imboccano direzioni non previste non sarebbero le benvenute mentre
altre troverebbero la strada spianata. Il libro presenta un ritratto della
classe politica di centrosinistra, quella che si dichiara pulita e pronta a
prendere in mano le redini del Paese, ma che è sempre la stessa. Stessi nomi,
stesse beghe, stessi affanni. Un partito, il Pd, per niente diverso dagli altri
nonostante si proclami tale. Gli uomini chiave della sinistra troveranno molte
pagine dedicate a loro. Ce n'è per tutti. Per il tesoriere dei Ds Ugo Sposetti,
che ha blindato in una serie di fondazioni il «patrimonio comunista» prima della
fusione con la Margherita, per l'ex componente della segreteria di Bersani,
Filippo Penati, accusato di corruzione e di finanziamento illecito, per l'ex
tesoriere della Margherita Luigi Lusi, che avrebbe fatto sparire 22 milioni di
euro di fondi elettorali. Gli autori passano dagli abusi edilizi e dalle
infiltrazioni mafiose nell'Emilia rossa al pericoloso rapporto della sinistra
con gli istituiti bancari, da Unipol a Monte dei Paschi. Molto è stato scritto
sulla scalata Unipol-Bnl, sulla partecipazione ai vertici Ds e sul sequestro di
94 milioni di euro di azioni di Antonveneta disposto nel 2005 dal gip Clementina
Forleo. Poco si sa, invece, su cosa è accaduto dopo al giudice che si è trovato
tra le mani un fascicolo con i nomi di pezzi molto grossi del Pd. «Tramonto
rosso» riordina alcuni fatti e segnala circostanze, talvolta inquietanti, che
certamente fanno riflettere. Come le gravi intimidazioni subite dalla Forleo, le
minacce, gli attacchi politici, le azioni disciplinari, l'isolamento. Fino al
trasferimento per incompatibilità ambientale, nel 2008, poi clamorosamente
bocciato da Tar e Consiglio di Stato. Il tutto nel silenzio dei colleghi per i
quali i guai del gip erano legati al suo brutto carattere e non certo ai suoi
provvedimenti sulle scalate bancarie. «Questa pervicacia contra personam è
l'emblema dell'intromissione politica nella magistratura», si legge nel testo.
Gli autori approfondiscono poi il noto salvataggio operato dalla Procura di
Milano nei confronti di Massimo D'Alema e Nicola Latorre, descritti dalla Forleo
nell'ordinanza del luglio 2007, finalizzata a chiedere il placet parlamentare
all'uso delle telefonate nei procedimenti sulle scalate, come concorrenti del
reato di aggiotaggio informativo del presidente di Unipol Gianni Consorte. Con
la Forleo, sempre più nel mirino, oggetto di riunioni pomeridiane in cui alcuni
colleghi milanesi avrebbero discusso la strategia contro di lei, come rivelato
dal gip Guido Salvini. Per trovare un altro esempio di come riescono ad essere
minimizzate le inchieste che coinvolgono il Pd basta scendere a Bari. Qui a fare
le spese di un'indagine scomoda su alcuni illeciti nel sistema sanitario
regionale è stato il pm Desirèe Digeronimo, duramente osteggiata dai colleghi
fino al trasferimento.
DUE PAROLE
SULLA MAFIA. QUELLO CHE LA STAMPA DI REGIME NON DICE.
«Berlusconi
aveva assunto lo stalliere Vittorio Mangano per far entrare Cosa Nostra dentro
la sua villa. Il patto sancito in una cena a Milano alla quale avevano
partecipato lo stesso Cavaliere e diversi esponenti della criminalità
organizzata siciliana». Le motivazioni (pesantissime) della condanna d'appello
per Dell'Utri. «E' stato definitivamente accertato che Dell'Utri, Berlusconi,
Cinà, Bontade e Teresi (tre mafiosi) avevano siglato un patto in base al quale
l'imprenditore milanese avrebbe effettuato il pagamento di somme di denaro a
Cosa nostra per ricevere in cambio protezione (...)». E poi: «Vittorio Mangano
non era stato assunto per la sua competenza in materia di cavalli, ma per
proteggere Berlusconi e i suoi familiari e come presidio mafioso all'interno
della villa dell'imprenditore». Sono parole pesantissime quelle che i giudici
della terza sezione penale della Corte di appello di Palermo nelle motivazioni
della sentenza con cui Marcello Dell'Utri è stato condannato il 25 marzo 2013 a
sette anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Parole
pesanti verso lo stesso Dell'Utri, che «tra il 1974 e il 1992 non si è mai
sottratto al ruolo di intermediario tra gli interessi dei protagonisti», e «ha
mantenuto sempre vivi i rapporti con i mafiosi di riferimento», ma anche verso
l'ex premier dato che Dell'Utri viene definito «mediatore contrattuale» del
patto tra Cosa Nostra e lo stesso Berlusconi. Secondo i giudici, «è stato
acclarato definitivamente che Dell'Utri ha partecipato a un incontro organizzato
da lui stesso e Cinà (mafioso siciliano) a Milano, presso il suo ufficio. Tale
incontro, al quale erano presenti Dell'Utri, Gaetano Cinà, Stefano Bontade,
Mimmo Teresi, Francesco Di Carlo e Silvio Berlusconi, aveva preceduto
l'assunzione di Vittorio Mangano presso Villa Casati ad Arcore, così come
riferito da Francesco Di Carlo e de relato da Antonino Galliano, e aveva siglato
il patto di protezione con Berlusconi». «In tutto il periodo di tempo in oggetto
(1974-1992) Dell'Utri ha, con pervicacia, ritenuto di agire in sinergia con
l'associazione e di rivolgersi a coloro che incarnavano l'anti Stato, al fine di
mediare tra le esigenze dell'imprenditore milanese (Silvio Berlusconi) e gli
interessi del sodalizio mafioso, con ciò consapevolmente rafforzando il potere
criminale dell'associazione», è scritto poi nelle motivazioni. Dell'Utri quindi
è «ritenuto penalmente responsabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, della
condotta di concorso esterno in associazione mafiosa dal 1974 al 1992» e la sua
personalità «appare connotata da una naturale propensione ad entrare attivamente
in contatto con soggetti mafiosi, da cui non ha mai mostrato di volersi
allontanare neppure in momenti in cui le proprie vicende personali e lavorative
gli aveva dato una possibilità di farlo» .
Per i
magistrati è più utile considerare Berlusconi un mafioso, anziché considerarlo
una vittima dell’inefficienza dello Stato che non sa difendere i suoi cittadini.
Una vittima che è disposta ai compromessi per tutelare la sicurezza dei suoi
affari e della sua famiglia.
Chi paga il
pizzo per lo Stato è un mafioso. E se non ti adegui ti succede quello che
succede a tutti. Una storia esemplare. Valeria Grasso: “Ho denunciato la mafia,
ora denuncio lo Stato”. “Una vergogna, una vergogna senza fine”. Con queste
poche parole si può descrivere la situazione dei Testimoni di Giustizia in
Italia. Dove lo Stato non riesce a fare il proprio dovere. Fino in fondo. Sono
troppe le storie drammatiche, che restano nel silenzio. Troppi gli ostacoli, le
difficoltà, i pericoli, i drammi. I testimoni di giustizia, fondamentali per la
lotta alla criminalità organizzata, devono essere protetti e sostenuti. Nel
Paese delle mafie lo Stato abbandona i suoi testimoni. Lo ha fatto in passato e
sta continuando a farlo. Non stiamo parlando dei "pentiti", dei collaboratori di
giustizia. Di chi ha commesso dei reati e ha deciso, per qualsiasi ragione, di
"collaborare" con lo Stato. Anche i "pentiti" (quelli credibili) servono, sono
necessari per combattere le organizzazioni criminali. Ma i testimoni sono
un’altra cosa. Sono semplici cittadini, che non hanno commesso reati. Hanno
visto, hanno subito e hanno deciso di "testimoniare". Per dovere civico, perché
è giusto comportarsi in un certo modo. Nel BelPaese il dovere civico è poco
apprezzato. I testimoni di giustizia, in Italia, denunciano le stesse
problematiche. Ma nessuno ascolta, risponde. Si sentono abbandonati. Prima
utilizzati e poi lasciati in un "limbo" profondo. Senza luce e senza futuro.
“La mafia,
come ci è inculcata dalla stampa di regime, è un’entità astratta, impossibile da
debellare, proprio perché non esiste.”
Lo scrittore
Antonio Giangrande sul fenomeno “Mafia” ha scritto un libro: “MAFIOPOLI.
L’ITALIA DELLE MAFIE. QUELLO CHE NON SI OSA DIRE”. Book ed E-Book pubblicato su
Amazon.it e che racconta una verità diversa da quella profusa dai media
genuflessi alla sinistra ed ai magistrati.
«L'Italia
tenuta al guinzaglio da un sistema di potere composto da caste, lobbies, mafie e
massonerie: un'Italia che deve subire e deve tacere. La “Politica” deve essere
legislazione o amministrazione nell’eterogenea rappresentanza d’interessi,
invece è meretricio o mendicio, mentre le “Istituzioni” devono meritarlo il
rispetto, non pretenderlo. Il rapporto tra cittadini e il rapporto tra cittadini
e Stato è regolato dalla forza della legge. Quando non vi è cogenza di legge,
vige la legge del più forte e il debole soccombe. Allora uno “Stato di Diritto”
degrada in anarchia. In questo caso è palese la responsabilità politica ed
istituzionale per incapacità o per collusione. Così come è palese la
responsabilità dei media per omertà e dei cittadini per codardia o emulazione.»
Continua
Antonio Giangrande.
«La mafia
cos'è? La risposta in un aneddoto di Paolo Borsellino: "Sapete che cos'è la
Mafia... faccia conto che ci sia un posto libero in tribunale..... e che si
presentino 3 magistrati... il primo è bravissimo, il migliore, il più
preparato.. un altro ha appoggi formidabili dalla politica... e il terzo è un
fesso... sapete chi vincerà??? Il fesso. Ecco, mi disse il boss, questa è la
MAFIA!"
“La vera
mafia è lo Stato, alcuni magistrati che lo rappresentano si comportano da
mafiosi. Il magistrato che mi racconta che Andreotti ha baciato Riina io lo
voglio in galera”.
Così Vittorio Sgarbi il 6 maggio 2013 ad “Un Giorno Da Pecora su Radio 2.
“Da noi -
ha dichiarato Silvio Berlusconi ai cronisti di una televisione
greca il 23 febbraio 2013 - la magistratura è una mafia più pericolosa della
mafia siciliana, e lo dico sapendo di dire una cosa grossa”. “In Italia regna
una "magistocrazia". Nella magistratura c'è una vera e propria associazione a
delinquere”. Lo ha detto Silvio Berlusconi il 28 marzo 2013 durante la
riunione del gruppo Pdl a Montecitorio. Ed ancora Silvio Berlusconi all'attacco
ai magistrati: «L'Anm è come la P2, non dice chi sono i loro associati».
Il riferimento dell'ex premier è alle associazioni interne ai magistrati, come
Magistratura Democratica. Il Cavaliere è a Udine il 18 aprile 2013 per un
comizio.
Questi sono
solo pochi esempi di dichiarazioni ufficiali.
Abbiamo una
Costituzione catto-comunista predisposta e votata dagli apparati politici che
rappresentavano la metà degli italiani, ossia coloro che furono i vincitori
della guerra civile e che votarono per la Repubblica. Una Costituzione fondata
sul lavoro (che oggi non c’è e per questo ci rende schiavi) e non sulla libertà
(che ci dovrebbe sempre essere, ma oggi non c’è e per questo siamo schiavi). Un
diritto all’uguaglianza inapplicato in virtù del fatto che il potere, anziché
essere nelle mani del popolo che dovrebbe nominare i suoi rappresentanti
politici, amministrativi e giudiziari, è in mano a mafie, caste, lobbies e
massonerie.
Siamo un
popolo corrotto: nella memoria, nell’analisi e nel processo mentale di
discernimento. Ogni dato virulento che il potere mediatico ci ha propinato,
succube al potere politico, economico e giudiziario, ha falsato il senso etico
della ragione e logica del popolo. Come il personal computer, giovani e vecchi,
devono essere formattati. Ossia, azzerare ogni cognizione e ripartire da zero
all’acquisizione di conoscenze scevre da influenze ideologiche, religiose ed
etniche. Dobbiamo essere consci del fatto che esistono diverse verità.
Ogni fatto è
rappresentato da una verità storica; da una verità mediatica e da una verità
giudiziaria.
La verità
storica è conosciuta solo dai responsabili del fatto. La verità mediatica è
quella rappresentata dai media approssimativi che sono ignoranti in
giurisprudenza e poco esperti di frequentazioni di aule del tribunale, ma
genuflessi e stanziali negli uffici dei pm e periti delle convinzioni
dell’accusa, mai dando spazio alla difesa. La verità giudiziaria è quella che
esce fuori da una corte, spesso impreparata culturalmente, tecnicamente e
psicologicamente (in virtù dei concorsi pubblici truccati). Nelle aule spesso si
lede il diritto di difesa, finanche negando le più elementari fonti di prova, o
addirittura, in caso di imputati poveri, il diritto alla difesa. Il gratuita
patrocinio è solo una balla. Gli avvocati capaci non vi consentono, quindi ti
ritrovi con un avvocato d’ufficio che spesso si rimette alla volontà della
corte, senza conoscere i carteggi. La sentenza è sempre frutto della libera
convinzione di una persona (il giudice). Mi si chiede cosa fare. Bisogna, da
privato, ripassare tutte le fasi dell’indagine e carpire eventuali errori dei
magistrati trascurati dalla difesa (e sempre ve ne sono). Eventualmente svolgere
un’indagine parallela. Intanto aspettare che qualche pentito, delatore, o
intercettazione, produca una nuova prova che ribalti l’esito del processo.
Quando poi questa emerge bisogna sperare nella fortuna di trovare un magistrato
coscienzioso (spesso non accade per non rilevare l’errore dei colleghi), che
possa aprire un processo di revisione.
Non sarà la
mafia a uccidermi ma alcuni miei colleghi magistrati (Borsellino). La verità
sulle stragi non la possiamo dire noi Magistrati ma la deve dire la politica se
non proprio la storia (Ingroia). Non possiamo dire la verità sulle stragi
altrimenti la classe politica potrebbe non reggere (Gozzo). Non sono stato io a
cercare loro ma loro a cercare me (Riina). In Italia mai nulla è come appare.
Ipocriti e voltagabbana. Le stragi come eccidi di Stato a cui non è estranea la
Magistratura e gran parte della classe politica del tempo.
Chi frequenta
bene le aule dei Tribunali, non essendo né coglione, né in mala fede, sa molto
bene che le sentenze sono già scritte prima che inizi il dibattimento. Le
pronunce sono pedisseque alle richieste dell’accusa, se non di più. Anche perché
se il soggetto è intoccabile l’archiviazione delle accuse è già avvenuta nelle
fasi successive alla denuncia o alla querela: “non vi sono prove per sostenere
l’accusa” o “il responsabile è ignoto”. Queste le motivazioni in calce alla
richiesta accolta dal GIP, nonostante si conosca il responsabile o vi siano un
mare di prove, ovvero le indagini non siano mai state effettuate. La difesa: un
soprammobile ben pagato succube dei magistrati. Il meglio che possono fare è
usare la furbizia per incidere sulla prescrizione. Le prove a discarico: un
perditempo, spesso dannoso. Non è improbabile che i testimoni della difesa siano
tacciati di falso.
Nel formulare
la richiesta la Boccassini nel processo Ruby ha fatto una gaffe dicendo: "Lo
condanno", per poi correggersi: "Chiedo la condanna" riferita a Berlusconi.
Esemplare
anche è il caso di Napoli. Il gip copia o si limita a riassumere le tesi
accusatorie della Procura di Napoli e per questo il tribunale del riesame del
capoluogo campano annulla l'arresto di Gaetano Riina, fratello del boss di Cosa
nostra, Totò, avvenuto il 14 novembre 2011. L'accusa era di concorso esterno in
associazione camorristica. Il gip, scrive il Giornale
di Sicilia, si sarebbe limitato a riassumere la richiesta di
arresto della Procura di Napoli, incappando peraltro in una serie di errori e
non sostituendo nella sua ordinanza neanche le parole «questo pm» con «questo
gip».
Il paradosso, però, sono le profezie cinematografiche adattate ai
processi:
«... e lo
condanna ad anni sette di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici
uffici, e all'interdizione legale per la durata della pena». Non è una frase
registrata Lunedì 24 giugno 2013 al Tribunale di Milano, ma una battuta presa
dagli ultimi minuti del film «Il caimano» di Nanni Moretti. La condanna inflitta
al protagonista (interpretato dallo stesso regista) è incredibilmente identica a
quella decisa dai giudici milanesi per Silvio Berlusconi. Il Caimano Moretti,
dopo la sentenza, parla di «casta dei magistrati» che «vuole avere il potere di
decidere al posto degli elettori».
Tutti dentro
se la legge fosse uguale per tutti. Ma la legge non è uguale per tutti. Così la
Cassazione si è tradita. Sconcertante linea delle
Sezioni unite civili sul caso di un magistrato sanzionato. La Suprema Corte:
vale il principio della discrezionalità.
Ed in fatto di
mafia c’è qualcuno che la sa lunga. «Io non cercavo nessuno, erano loro che
cercavano me….Mi hanno fatto arrestare Provenzano e Ciancimino, non come dicono,
i carabinieri……Di questo papello non ne sono niente….Il pentito Giovanni Brusca
non ha fatto tutto da solo, c'è la mano dei servizi segreti. La stessa cosa vale
anche per l'agenda rossa. Ha visto cosa hanno fatto? Perchè non vanno da quello
che aveva in mano la borsa e si fanno consegnare l'agenda. In via D'Amelio
c'erano i servizi……. Io sono stato 25 anni latitante in campagna senza che
nessuno mi cercasse. Com'è possibile che sono responsabile di tutte queste cose?
La vera mafia sono i magistrati e i politici che si sono coperti tra di loro.
Loro scaricano ogni responsabilità sui mafiosi. La mafia quando inizia una cosa
la porta a termine. Io sto bene. Mi sento carico e riesco a vedere oltre queste
mura……Appuntato, lei mi vede che possa baciare Andreotti? Le posso dire che era
un galantuomo e che io sono stato dell'area andreottiana da sempre». Le
confidenze fatte da Toto Riina, il capo dei capi, sono state fatte in due
diverse occasioni, a due guardie penitenziarie del Gom del carcere Opera di
Milano.
Così come in
fatto di mafia c’è qualcun altro che la sa lunga. Parla l’ex capo dei Casalesi.
La camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno politici, magistrati e
forze dell’ordine mafiosi.
CARMINE
SCHIAVONE. MAGISTRATI: ROMA NOSTRA!
"Ondata
di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici,
Napoli capitale dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto»
un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori".
O la
statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso
di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi
agli orali vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che
rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della
popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza:
erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della
commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli
esaminatori.
Lo strumento
per addentrarsi nei gangli del potere sono gli esami di Stato ed i concorsi
pubblici truccati.
I criteri di
valutazione dell’elaborato dell’esame di magistrato, di avvocato, di notaio,
ecc.
Secondo la
normativa vigente, la valutazione di un testo dell’esame di Stato o di un
Concorso pubblico è ancorata ad alcuni parametri. Può risultare utile, quindi,
che ogni candidato conosca le regole che i commissari di esame devono seguire
nella valutazione dei compiti.
a)
chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
b)
dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi
giuridici;
c)
dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici
trattati;
d)
dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di
interdisciplinarietà;
e)
relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle
tecniche di persuasione.
Ciò
significa che la
comprensibilità dell’elaborato — sotto il profilo della grafia, della grammatica
e della sintassi — costituisce il primo criterio di valutazione dei commissari.
Ne consegue che il primo accorgimento del candidato deve essere quello di
cercare di scrivere in forma chiara e scorrevole e con grafia facilmente
leggibile: l’esigenza di interrompere continuamente la lettura, per soffermarsi
su parole indecifrabili o su espressioni contorte, infastidisce (e, talvolta,
irrita) i commissari ed impedisce loro di seguire il filo del ragionamento
svolto nel compito. Le varie parti dell’elaborato devono essere espresse con un
periodare semplice (senza troppi incisi o subordinate); la trattazione dei
singoli argomenti giuridici deve essere il più possibile incisiva; le
ripetizioni vanno evitate; la sequenza dei periodi deve essere rispettosa della
logica (grammaticale e giuridica). Non va mai dimenticato che ogni commissione
esaminatrice è composta da esperti (avvocati, magistrati e docenti
universitari), che sono tenuti a leggere centinaia di compiti in tempi
relativamente ristretti: il miglior modo di presentarsi è quello di esporre —
con una grafia chiara o, quanto meno, comprensibile (che alleggerisca la fatica
del leggere) — uno sviluppo ragionato, logico e consequenziale degli argomenti.
Questa è la
regola, ma la prassi, si sa, fotte la regola. Ed allora chi vince i concorsi
pubblici e chi supera gli esami di Stato e perché si pretende da altri ciò che
da sé non si è capaci di fare, né di concepire?
PARLIAMO DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, MADRE DI TUTTE LE CORTI. UN CASO PER TUTTI.
La sentenza
contro il Cavaliere è zeppa di errori (di grammatica).
Frasi senza
soggetto, punteggiatura sbagliata... Il giudizio della Cassazione è un obbrobrio
anche per la lingua italiana. Dopodiché ecco l’impatto della realtà nella
autentica dettatura delle motivazioni a pag.183: «Deve essere infine rimarcato
che Berlusconi, pur non risultando che abbia trattenuto rapporti diretti coi
materiali esecutori, la difesa che il riferimento alle decisioni aziendali
consentito nella pronuncia della Cassazione che ha riguardato l’impugnazione
della difesa Agrama della dichiarazione a non doversi procedere per
prescrizione in merito ad alcune annualità precedenti, starebbe proprio ad
indicare che occorre aver riguardo alle scelte aziendali senza possibilità.
quindi, di pervernire...». Ecco. Di prim’acchito uno si domanda: oddio, che fine
ha fatto la punteggiatura? Ma dov’è il soggetto? Qual è la coordinata, quante
subordinate transitano sul foglio. «...ad una affermazione di responsabilità di
Berlusconi che presumibilmente del tutto ignari delle attività prodromiche al
delitto, ma conoscendo perfettamente il meccanismo, ha lasciato che tutto
proseguisse inalterato, mantenendo nelle posizioni strategiche i soggetti da lui
scelti...». Eppoi, affiorano, «le prove sono state analiticamente analizzate». O
straordinarie accumulazioni semantiche come «il criterio dell’individuazione del
destinatario principale dei benfici derivanti dall’illecito fornisce un
risultato convergente da quello che s’è visto essere l’esito dell’apprezzamento
delle prove compito dai due gradi di merito..» E poi, nello scorrere delle 208
pagine della motivazione, ci trovi i «siffatto contesto normativo», gli
«allorquando», gli «in buona sostanza», che accidentano la lettura. Ed ancora la
frase «ha posto in essere una frazione importante dell’attività delittuosa che
si è integrata con quella dei correi fornendo un contributo causale...».
Linguaggio giuridico? Bene anch’io ho fatto Giurisprudenza, ed anch’io mi sono
scontrato con magistrati ed avvocati ignoranti in grammatica, sintassi e perfino
in diritto. Ma questo, cari miei non è linguaggio giuridico, ma sono gli effetti
di un certo modo di fare proselitismo.
LE DINASTIE
DEI MAGISTRATI.
LA FAMIGLIA
ESPOSITO
Qualcuno
potrebbe definirla una famiglia “particolare” scrive “Libero
Quotidiano”. Al centro c'è Antonio Esposito, giudice della
Corte di Cassazione che in una telefonata-intervista al Mattino anticipò le
motivazioni della condanna inflitta a Silvio Berlusconi per frode fiscale nel
processo Mediaset. E che in più occasioni è stato “pizzicato” da testimoni a
pronunciare frasi non proprio di ammirazione nei confronti del Cavaliere. Poi
c'è la nipote Andreana, che sta alla Corte europea dei diritti
dell'uomo di Strasburgo, cui i legali di Berlusconi vorrebbero far ricorso
contro la sentenza emessa dalla Cassazione. Paradosso: a passare al vaglio la
sentenza pronunciata da Esposito potrebbe essere la nipote. Non bastassero loro,
c'è il papà di Andreana, che come scrive, mercoledì 28 agosto, su
Libero Peppe Rinaldi, è stato fotografato mentre
prende il sole e fa il bagno presso il Lido Oasi di Agropoli, nel Cilento. Il
problema è che il lido è abusivo ed è stato soggetto a indagini, interpellanze,
ordinanze di abbattimento. In zona tutti sanno. Curioso che Vitaliano
Esposito, ex procuratore generale della Cassazione, non sappia di
mettersi a mollo in uno stabilimento balneare fuorilegge (abusivo a sua
insaputa). Infine, della famiglia fa parte anche Ferdinando Esposito,
Pubblico Ministero a Milano, che tempo fa finì sotto indagine del Csm
(che poi archiviò) per le cene a lume di candela del giudice (ma va, anche lui?)
in Porsche con Nicole Minetti, allora già imputata per istigazione alla
prostituzione insieme a Lele Mora ed Emilio Fede.
Una famiglia,
gli Esposito, una delle tante dinastie giudiziarie, che non fosse altro dimostra
come la magistratura sia una vera, autentica, casta.
Ciononostante
viviamo in un’Italia fatta così, con italiani fatti così, bisogna subire e
tacere. Questo ti impone il “potere”. Ebbene, si faccia attenzione alle parole
usate per prendersela con le ingiustizie, i soprusi e le sopraffazioni, le
incapacità dei governati e l’oppressione della burocrazia, i disservizi, i
vincoli, le tasse, le code e la scarsezza di opportunità del Belpaese. Perché
sfogarsi con il classico "Italia paese di merda", per quanto liberatorio, non
può essere tollerato dai boiardi di Stato. E' reato, in quanto vilipendio alla
nazione. Lo ha certificato la Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza
4 luglio 2013 n. 28730!!!
Ma non di solo
della dinastia Esposito è piena la Magistratura.
LA FAMIGLIA DE
MAGISTRIS.
La famiglia e
le origini, secondo “Panorama”. I de Magistris sono giudici da quattro
generazioni. Ma Luigi, l’ultimo erede, della famiglia è stato il primo a essere
trasferito per gli errori commessi nell’esercizio delle funzioni. Il bisnonno
era magistrato del Regno già nel 1860, il nonno ha subito due attentati, il
padre, Giuseppe, giudice d’appello affilato e taciturno, condannò a 9 anni l’ex
ministro Francesco De Lorenzo e si occupò del processo Cirillo. Luigi assomiglia
alla madre Marzia, donna dal carattere estroverso. Residenti nell’elegante
quartiere napoletano del Vomero, sono ricordati da tutti come una famiglia
perbene. In via Mascagni 92 vivevano al terzo piano, al primo l’amico di
famiglia, il noto ginecologo Gennaro Pietroluongo. Ancora oggi la signora Marzia
è la sua segretaria, in una clinica privata del Vomero. Un rapporto che forse ha
scatenato la passione del giovane de Magistris per le magagne della sanità.
Luigi Pisa, da quarant’anni edicolante della via, ricorda così il futuro pm: "Un
ragazzino studioso. Scendeva poco in strada a giocare a pallone e già alle medie
comprava Il Manifesto". Il padre, invece, leggeva Il Mattino e La
Repubblica. Il figlio ha studiato al Pansini, liceo classico
dell’intellighenzia progressista vomerese. Qui il giovane ha conosciuto la
politica: le sue biografie narrano che partecipò diciassettenne ai funerali di
Enrico Berlinguer. All’esame di maturità, il 12 luglio 1985, ha meritato 51/60.
A 22 anni si è laureato in giurisprudenza con 110 e lode. L’avvocato Pierpaolo
Berardi, astigiano, classe 1964, da decenni sta battagliando per far annullare
il concorso per entrare in magistratura svolto nel maggio 1992. Secondo Berardi,
infatti, in base ai verbali dei commissari più di metà dei compiti vennero
corretti in 3 minuti di media (comprendendo "apertura della busta,
verbalizzazione e richiesta chiarimenti") e quindi non "furono mai esaminati". I
giudici del tar gli hanno dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il Csm, nel 2008, è
stato costretto ad ammettere: "Ci fu una vera e propria mancanza di valutazione
da parte della commissione". Giudizio che vale anche per gli altri esaminati.
Uno dei commissari, successivamente, ha raccontato su una rivista giuridica
l’esame contestato, narrando alcuni episodi, fra cui quello di un professore di
diritto che, avendo appreso prima dell’apertura delle buste della bocciatura
della figlia, convocò il vicepresidente della commissione. Non basta. Scrive
l’esaminatore: "Durante tutti i lavori di correzione, però, non ho mai avuto la
semplice impressione che s’intendesse favorire un certo candidato dopo che i
temi di questo erano stati riconosciuti". Dunque i lavori erano anonimi solo
sulle buste. "Episodi come questi prevedono, per come riconosciuto dallo stesso
Csm, l’annullamento delle prove in questione" conclude con Panorama
Berardi. In quell’esame divenne uditore giudiziario, tra gli altri, Luigi de
Magistris.
LA FAMIGLIA
BORRELLI.
Biografia di
Francesco Saverio Borrelli. Napoli 12 aprile 1930. Ex magistrato (1955-2002).
Dal 1992 al 1998 capo della Procura di Milano, divenne noto durante l’inchiesta
del pool Mani pulite. Dal 1999 alla pensione procuratore generale della Corte
d’appello milanese, in seguito è stato capo dell’ufficio indagini della
Federcalcio (maggio 2006-giugno 2007) e presidente del Conservatorio “Giuseppe
Verdi” di Milano (marzo 2007-aprile 2010). Due fratelli maggiori e una sorella
minore, Borrelli nacque dal secondo matrimonio del magistrato Manlio (figlio e
nipote di magistrati) con Amalia Jappelli detta Miette. «Fino a sette anni non
sapevo che i miei fratelli avessero avuto un’altra madre, morta quando erano
piccolissimi. Nessuno mi aveva mai detto nulla. Me lo rivelò un uomo stupido
ridacchiando: “Ma che fratelli, i tuoi sono fratellastri”. Fu uno shock
tremendo. Corsi a casa disperato. Volevo sapere, capire. I miei avevano voluto
salvaguardare l’uguaglianza tra fratelli: non dovevo sentirmi un privilegiato
perché io avevo entrambi i genitori. Mi chetai, ma mi restò a lungo una fantasia
di abbandono, il timore, che più tardi ho saputo comune a molti bambini, di
essere un trovatello. Tremavo nel mio lettino e pregavo che non fosse così».
Dopo due anni a Lecce, nel 1936 la famiglia traslocò a Firenze: maturità al
liceo classico Michelangelo, laurea in giurisprudenza con Piero Calamandrei
(titolo della tesi Sentenza e sentimento) prese il diploma di pianoforte
al conservatorio Cherubini. Dal 1953 a Milano, dove il padre era stato nominato
presidente di Corte d’appello, nel 1955 vinse il concorso per entrare in
magistratura. Dal 1957 sposato con Maria Laura Pini Prato, insegnante di inglese
conosciuta all’università che gli diede i figli Andrea e Federica, passò
vent’anni al Civile, prima in Pretura, poi in Tribunale occupandosi di
fallimenti e diritto industriale, infine in Corte d’Appello. Passato al Penale,
dal ’75 all’82 fu in corte d’Assise, nel 1983 arrivò alla Procura della
Repubblica, nel 1992, l’anno dell’inizio dell’indagine Mani pulite, ne divenne
il capo. Quando, nell’aprile del 2002, Borrelli andò in pensione, a Palazzo
Chigi c’era nuovamente Silvio Berlusconi. Il 3 gennaio di quell’anno, aprendo il
suo ultimo anno giudiziario, l’ex procuratore capo di Milano aveva lanciato lo
slogan «Resistere, resistere, resistere». Nel maggio 2006, in piena Calciopoli,
Guido Rossi lo chiamò a guidare l’ufficio indagini della Federcalcio: «Rifiutare
mi sembrava una vigliaccata». Nel marzo 2007 divenne presidente del
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano (la più prestigiosa università musicale
d’Italia): «È una nuova sfida, l’ennesima che affronto con gioia e un certo
tremore». In contemporanea annunciò l’addio alla Figc: «Per ora mantengo il
posto in Federcalcio, non c’è incompatibilità. Se sono uscito dall’ombra lo devo
solo a Guido Rossi. Dopo la nomina del calcio mi riconoscono tutti, i taxisti e
anche i più giovani. Ma a luglio, con il nuovo statuto da me suggerito,
l’ufficio indagini confluirà nella Procura federale. Non voglio fare il
Procuratore federale: c’è Stefano Palazzi, è molto più giovane di me».
Nell’aprile 2010 il ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, cui spetta la
nomina della carica di presidente degli istituti musicali, gli negò il secondo
mandato triennale alla presidenza del Verdi: «Ragioni evidentemente politiche.
Appartengo a una corporazione che è in odio alle alte sfere della politica.
Evidentemente non devo essere gradito agli esponenti del governo. Ma la mia
amarezza è soprattutto quella di aver saputo della mia mancata conferma in modo
indiretto, senza comunicazione ufficiale. Sono sempre stato abbastanza umile da
accettare le critiche, ma ciò che mi offende è il metodo. Ho lavorato con
passione in questi anni». (Giorgio Dell’Arti Catalogo
dei viventi 2015.
ALTRA
DINASTIA: LA FAMIGLIA BOCCASSINI.
Boccassini,
una delle famiglie di magistrati più corrotte della storia d’Italia, scrive
“Imola Oggi”. Il paragone fra certi p.m. di Magistratura Democratica e gli
estremisti della Brigate Rosse è sicuramente improprio ma il fanatismo e la
propensione agli affari degli uni e degli altri è sicuramente simile. Ilda
Boccassini appartiene, secondo la stampa, a una delle famiglie di magistrati più
corrotte della storia d’Italia. Suo zio Magistrato Nicola Boccassini fu
arrestato e condannato per associazione a delinquere, concussione corruzione,
favoreggiamento e abuso di ufficio perchè spillò con altri sodali e con ricatti
vari 186 milioni di vecchie lire a un imprenditore. (vendeva processi per un
poker repubblica). Anche suo padre Magistrato e suo cugino acquisito Attilio
Roscia furono inquisiti. Suo marito Alberto Nobili fu denunciato alla procura di
Brescia da Pierluigi Vigna, Magistrato integerrimo e universalmente stimato per
presunte collusioni con gli affiliati di Cosa Nostra che gestivano l’Autoparco
Milanese di via Salamone a Milano. (attacco ai giudici di Milano Repubblica)
(Brescia torna inchiesta autoparco). Non se ne fece niente perchè la denuncia
finì nelle mani del giudice Fabio Salomone, fratello di Filippo Salomone,
imprenditore siciliano condannato a sei anni di reclusione per associazione a
delinquere di stampo mafioso. L’Autoparco milanese di via Salomone era un
crocevia di armi e di droga ha funzionato per 9 anni di seguito (dal 1984 al
1993), fu smantellato dai magistrati fiorentini e non da quelli milanesi e
muoveva 700 milioni di vecchie lire al giorno. A Milano tutti sapevano che cosa
si faceva lì dentro. Visto ciò che è emerso a carico del marito per l’Autoparco
e visto ciò che sta emergendo a carico del giudice Francesco Di Maggio (anche
lui della Procura di Milano) relativamente alla strage di Capaci anche il suo
trasferimento a Caltanisetta nel 1992 appare sospetto. In realtà a quel tempo
sei magistrati massoni della Procura di Milano appoggiavano il progetto di Riina
e Gardini, i quali erano soci, di acquisire Eni e poi di fondare Enimont e
quindi da un lato favorivano l’acquisizione di denaro da parte di Cosa Nostra
tutelando l’Autoparco (700.000.000 di vecchie lire al giorno di movimento di
denaro) tutelando i traffici con il c.d. metodo Ros (502.000.000 di euro di
ammanchi) e simulando con altre inchieste minori (Duomo Connenction, Epaminonda)
un contrasto alla mafia che in realtà non c’era, dall’altro con Di Maggio
intervennero pesantemente in Sicilia già nel 1989 per contrastare un attacco
della FBI americana contro i corleonesi attraverso il pentito Totuccio Contorno
e facendo ricadere la responsabilità delle lettere del corvo su Falcone, poi
attentato simulatamente dalla stessa Polizia. Poi nel 1992 sempre con uomini di
Di Maggio contribuirono alla strage di Capaci ove morì Giovanni Falcone il quale
si opponeva acchè il progetto Enimont, a quel tempo gestito da Andreotti e da
Craxi, tornasse nelle mani di Gardini e di Riina. Ora è noto ormai che anche le
Brigate Rosse eseguirono il sequestro Moro per affarismo e rifiutarono dieci
miliardi di vecchie lire da parte del Papa Paolo VI per liberare Aldo Moro
perchè qualcun altro le remunerò di più. Napolitano ha ben fatto appello più
volte a questi Magistrati di moderarsi. Palamara non c’entra niente con questo
discorso perchè è un buon Magistrato ed è affiliato a Unicost, una corrente di
magistrati seri e responsabili e non a M.D. Il tutto sembrerebbe discutibile se
il parente che si è messo in condizione di essere criticato fosse solo uno. Ma
qui i parenti chiacchierati sono tre. Fra l’altro osservo che
Alberto Nobili, dopo che si è separato dalla Boccassini, è tornato a
essere un magistrato stimato, per cui viene il dubbio che nei casini ce lo abbia
messo lei.
CARMINE
SCHIAVONE. LA VERA MAFIA SONO I POLITICI, I MAGISTRATI E LE FORZE DELL’ORDINE.
Parla l’ex
capo dei Casalesi. La camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno
politici, magistrati e forze dell’ordine mafiosi.
CARMINE
SCHIAVONE. MAGISTRATI: ROMA NOSTRA!
"Ondata
di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici,
Napoli capitale dei promossi . L'area coperta dalla Corte d'appello ha
«prodotto» un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori".
O la statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra
nell'attuale concorso di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli
aspiranti giudici ammessi agli orali vengono infatti dall'area della Corte
d'Appello di Napoli, che rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e
un dodicesimo della popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una
curiosa coincidenza: erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri
togati della commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo
degli esaminatori.
E quindi in
tema di giustizia ed informazione. Lettera aperta a “Quarto Grado”.
Egregio
Direttore di “Quarto Grado”, dr Gianluigi Nuzzi, ed illustre Comitato di
Redazione e stimati autori.
Sono il Dr
Antonio Giangrande, scrittore e cultore di sociologia storica. In tema di
Giustizia per conoscere gli effetti della sua disfunzione ho scritto dei saggi
pubblicati su Amazon.it: “Giustiziopoli. Ingiustizia contro i singoli”;
“Malagiustiziopoli”. Malagiustizia contro la Comunità”. Per conoscere bene
coloro che la disfunzione la provocano ho scritto “Impunitopoli. Magistrati ed
Avvocati, quello che non si osa dire”. Per giunta per conoscere come questi
rivestono la loro funzione ho scritto “Concorsopoli. Magistrati ed avvocati col
trucco”. Naturalmente per ogni città ho rendicontato le conseguenze di tutti gli
errori giudiziari. Errore giudiziario non è quello conclamato, ritenuto che si
considera scleroticamente solo quello provocato da dolo o colpa grave. E questo
con l’addebito di infrazione da parte dell’Europa. Né può essere considerato
errore quello scaturito solo da ingiusta detenzione. E’ errore giudiziario ogni
qualvolta vi è una novazione di giudizio in sede di reclamo, a prescindere se vi
è stata detenzione o meno, o conclamato l’errore da parte dei colleghi
magistrati. Quindi vi è errore quasi sempre.
Inoltre, cari
emeriti signori, sono di Avetrana. In tal senso ho scritto un libro: “Tutto su
Taranto, quello che non si osa dire” giusto per far sapere come si lavora presso
gli uffici giudiziari locali. Taranto definito il Foro dell’Ingiustizia. Cosa
più importante, però, è che ho scritto: “Sarah Scazzi. Il delitto di Avetrana.
Il resoconto di un avetranese. Quello che non si osa dire”. Tutti hanno
scribacchiato qualcosa su Sarah, magari in palese conflitto d’interesse, o come
megafono dei magistrati tarantini, ma solo io conosco i protagonisti, il
territorio e tutto quello che è successo sin dal primo giorno. Molto prima di
coloro che come orde di barbari sono scesi in paese pensando di trovare in loco
gente con l’anello al naso e così li hanno da sempre dipinti. Certo che
magistrati e giornalisti cercano di tacitarmi in tutti i modi, specialmente a
Taranto, dove certa stampa e certa tv è lo zerbino della magistratura. Come in
tutta Italia, d’altronde. E per questo non sono conosciuto alla grande massa, ma
sul web sono io a spopolare.
Detto questo,
dal mio punto di vista di luminare dell’argomento Giustizia, generale e
particolare, degli appunti ve li voglio sollevare sia dal punto giuridico (della
legge) sia da punto della Prassi. Questo vale per voi, ma vale anche per tutti
quei programmi salottieri che di giustizia ne sparlano e non ne parlano,
influenzando i telespettatori o da questi sono condizionati per colpa degli
ascolti. La domanda quindi è: manettari e forcaioli si è o si diventa guardando
certi programmi approssimativi? Perché nessuno sdegno noto nella gente quando si
parla di gente rinchiusa per anni in canili umani da innocente. E se capitasse
agli ignavi?
Certo,
direttore Nuzzi, lei si vanta degli ascolti alti. Non è la quantità che fa un
buon programma, ma la qualità degli utenti. Fare un programma di buon livello
professionale, si pagherà sullo share, ma si guadagna in spessore culturale e di
levatura giuridica. Al contrario è come se si parlasse di calcio con i tifosi al
bar: tutti allenatori.
Il suo
programma, come tutti del resto, lo trovo: sbilanciatissimo sull’accusa,
approssimativo, superficiale, giustizialista ed ora anche confessionale.
Idolatria di Geova da parte di Concetta e pubblicità gratuita per i suoi
avvocati. Visibilità garantita anche come avvocati di Parolisi. Nulla di nuovo,
insomma, rispetto alla conduzione di Salvo Sottile.
Nella puntata
del 27 settembre 2013, in studio non è stato detto nulla di nuovo, né di utile,
se non quello di rimarcare la colpevolezza delle donne di Michele Misseri. La
confessione di Michele: sottigliezze. Fino al punto che Carmelo Abbate si è
spinto a dire: «chi delle due donne mente?». Dando per scontato la loro
colpevolezza. Dal punto di vista scandalistico e gossipparo, va bene, ma solo
dalla bocca di un autentico esperto è uscita una cosa sensata, senza essere per
forza un garantista.
Alessandro
Meluzzi: «non si conosce ora, luogo, dinamica, arma, movente ed autori
dell’omicidio!!!».
Ergo: da dove
nasce la certezza di colpevolezza, anche se avallata da una sentenza, il cui
giudizio era già stato prematuramente espresso dai giudici nel corso del
dibattimento, sicuri di una mancata applicazione della loro ricusazione e della
rimessione del processo?
E quello del
dubbio scriminante, ma sottaciuto, vale per tutti i casi trattati in tv,
appiattiti invece sull’idolatria dei magistrati. Anzi di più, anche di Geova.
Una cosa è
certa, però. Non sarà la coerenza di questi nostri politicanti a cambiare le
sorti delle nostre famiglie.
2 OTTOBRE
2013. LE GIRAVOLTE DI BERLUSCONI. L’APOTEOSI DELLA VERGOGNA ITALICA.
«Perché ho
scelto di porre un termine al governo Letta».
Silvio Berlusconi, lettera a Tempi del 1 ottobre 2013. «Gentile direttore, non
mi sfuggono, e non mi sono mai sfuggiti, i problemi che affrontano l’Italia che
amo ed i miei concittadini. La situazione internazionale continua a essere
incerta. I dati economici nazionali non sono indirizzati alla ripresa. E,
nonostante le puntuali resistenze del centrodestra, un esorbitante carico
fiscale continua a deprimere la nostra industria, i commerci, i bilanci delle
famiglie». Inizia così la lunga lettera che Silvio Berlusconi ha scritto a
Tempi. Berlusconi si chiede quanti danni abbia provocato all’Italia «un
ventennio di assalto alla politica, alla società, all’economia, da parte dei
cosiddetti “magistrati democratici” e dei loro alleati nel mondo dell’editoria,
dei salotti, delle lobby? Quanto male ha fatto agli italiani, tra i quali mi
onoro di essere uno dei tanti, una giustizia al servizio di certi obiettivi
politici?». Berlusconi cita il caso dell’Ilva di Taranto, la cui chiusura è
avvenuta «grazie anche a quella che, grottescamente, hanno ancora oggi il
coraggio di chiamare “supplenza dei giudici alla politica”», e torna a chiedere:
«Di quanti casi Ilva è lastricata la strada che ci ha condotto nell’inferno di
una Costituzione manomessa e sostituita con le carte di un potere giudiziario
che ha preso il posto di parlamento e governo? (…) Hanno “rovesciato come un
calzino l’Italia”, come da programma esplicitamente rivendicato da uno dei pm
del pool di Mani Pulite dei primi anni Novanta, ed ecco il bel risultato: né
pulizia né giustizia. Ma il deserto». «Non è il caso Berlusconi che conta –
prosegue -. Conta tutto ciò che, attraverso il caso Silvio Berlusconi, è
rivelatore dell’intera vicenda italiana dal 1993 ad oggi. Il caso cioè di una
persecuzione giudiziaria violenta e sistematica di chiunque non si piegasse agli
interessi e al potere di quella parte che noi genericamente enunciamo come
“sinistra”. Ma che in realtà è rappresentata da quei poteri e forze radicate
nello Stato, nelle amministrazioni pubbliche, nei giornali, che sono
responsabili della rapina sistemica e del debito pubblico imposti agli
italiani. Berlusconi non è uno di quegli imprenditori fasulli che ha chiuso
fabbriche o ha fatto a spezzatini di aziende per darsi alla speculazione
finanziaria. Berlusconi non è uno di quelli che hanno spolpato Telecom o hanno
fatto impresa con gli aiuti di Stato. (…) Berlusconi è uno dei tanti grandi e
piccoli imprenditori che al loro paese hanno dato lavoro e ricchezza. Per
questo, l’esempio e l’eccellenza di questa Italia che lavora dovevano essere
invidiati, perseguitati e annientati (questo era l’obbiettivo di sentenze come
quella che ci ha estorto 500 milioni di euro e, pensavano loro, ci avrebbe
ridotto sul lastrico) dalle forze della conservazione». Il leader del
centrodestra ripercorre poi le vicende politiche degli ultimi anni, ricordando
il suo sostegno al governo Monti e, oggi, al governo Letta. Scrive Berlusconi:
«Abbiamo contribuito, contro gli interessi elettorali del centrodestra, a
sostenere governi guidati da personalità estranee – talvolta ostili – al nostro
schieramento. Abbiamo dato così il nostro contributo perché la nazione tornasse
a respirare, si riuscisse a riformare lo Stato, a costruire le basi per una
nostra più salda sovranità, a rilanciare l’economia. Con il governo Monti le
condizioni stringenti della politica ci hanno fatto accettare provvedimenti
fiscali e sul lavoro sbagliati. Con il governo Letta abbiamo ottenuto più
chiarezza sulle politiche fiscali, conquistando provvedimenti di allentamento
delle tasse e l’impostazione di una riforma dello Stato nel senso della
modernizzazione e della libertà». «Alla fine, però, i settori politicizzati
della magistratura sono pervenuti a un’incredibile, ingiusta perché infondata,
condanna di ultima istanza nei miei confronti. Ed altre manovre persecutrici
procedono in ogni parte d’Italia». «Enrico Letta e Giorgio Napolitano – scrive
l’ex presidente del Consiglio - avrebbero dovuto rendersi conto che, non ponendo
la questione della tutela dei diritti politici del leader del centrodestra
nazionale, distruggevano un elemento essenziale della loro credibilità e
minavano le basi della democrazia parlamentare. Come può essere affidabile chi
non riesce a garantire l’agibilità politica neanche al proprio fondamentale
partner di governo e lascia che si proceda al suo assassinio politico per via
giudiziaria?». «Il Pd (compreso Matteo Renzi) ha tenuto un atteggiamento
irresponsabile soffiando sul fuoco senza dare alcuna prospettiva politica.
Resistere per me è stato un imperativo morale che nasce dalla consapevolezza che
senza il mio argine – che come è evidente mi ha portato ben più sofferenze che
ricompense – si imporrebbe un regime di oppressione insieme giustizialista e
fiscale. Per tutto questo, pur comprendendo tutti i rischi che mi assumo, ho
scelto di porre un termine al governo Letta». Infine la conclusione: «Ho scelto
la via del ritorno al giudizio del popolo non per i “miei guai giudiziari” ma
perché si è nettamente evidenziata la realtà di un governo radicalmente ostile
al suo stesso compagno di cosiddette “larghe intese”. Un governo che non vuole
una forza organizzata di centrodestra in grado di riequilibrarne la sua linea
ondivaga e subalterna ai soliti poteri interni e internazionali». Berlusconi
dice di voler recuperare «quanto di positivo è stato fatto ed elaborato (per
esempio in tema di riforme istituzionali) da questo governo che, ripeto, io per
primo ho voluto per il bene dell’Italia e che io per primo non avrei abbandonato
se soltanto ci fosse stato modo di proseguire su una linea di fattiva, di
giusta, di leale collaborazione». Ma spiega anche di non averlo più voluto
sostenere «quando Letta ha usato l’aumento dell’Iva come arma di ricatto nei
confronti del mio schieramento ho capito che non c’era più margine di
trattativa». «Non solo – aggiunge -. Quando capisci che l’Italia è un Paese dove
la libera iniziativa e la libera impresa del cittadino diventano oggetto di
aggressione da ogni parte, dal fisco ai magistrati; quando addirittura grandi
imprenditori vengono ideologicamente e pubblicamente linciati per l’espressione
di un libero pensiero, quando persone che dovrebbero incarnare con neutralità e
prudenza il ruolo di rappresentanti delle istituzioni pretendono di insegnarci
come si debba essere uomini e come si debba essere donne, come si debbano
educare i figli e quale tipo di famiglia devono avere gli italiani, insomma,
quando lo Stato si fa padrone illiberale e arrogante mentre il governo tace e
non ha né la forza né la volontà di difendere la libertà e le tasche dei suoi
cittadini, allora è bene che la parola ritorni al nostro unico padrone: il
popolo italiano».
Sceneggiata
in fondo a destra,
scrive Stefania Carini su “Europa Quotidiano”. Nessuna sceneggiatura al mondo
può batterci, perché noi teniamo la sceneggiata. Non ci scalfisce manco Sorkin
con West Wing e The Newsroom (uno degli attori di quest’ultima
serie era pure presente al Roma Fiction Fest per annunciarne la messa in onda su
Raitre). Tze, nessun giornalista o politico sul piccolo schermo può batterci in
queste ore. Bastava vedere oggi le prime pagine di due giornali dall’opposto
populismo: per Il Giornale è tradimento, per Il Fatto è inciucio.
Ah, la crisi secondo il proprio target di spettatori! E ‘O Malamente che dice?
Ma come in tutti i melodrammi, i gesti sono più importanti. Vedere per capire.
In senato prima arriva Alfano e si siede accanto a Letta, vorrà dire qualcosa?
Poi arriva Berlusconi, e allora colpa di scena! Marcia indietro? Sardoni (sempre
la più brava) racconta di un Bondi che si scrolla dalla pacca sulla spalla di
Lupi. Non toccarmi, impuro! Biancofiore e Giovanardi litigano a Agorà, ma
ieri sera già aleggiava una forza di schizofrenia sui nostri schermi. Sallusti e
Cicchitto erano seduti a Ballarò dalla stessa parte, secondo solita
partitura visiva del talk. Solo che invece di scannarsi con i
dirimpettai, con quelli della sinistra, si scannavano fra di loro. Una grande
sequenza comico-drammatica, riproposta pure da Mentana durante la sua consueta
lunga maratona in mattinata.
A Matrix
pure Feltri faceva il grande pezzo d’attore, andandosene perché: «Non ne posso
più di Berlusconi, di Letta e di queste discussioni interminabili, come non ne
possono più gli italiani». Oh, sì, gli italiani non ne possono più, ma davanti a
un tale spettacolo come resistere? Siamo lì, al Colosseo pieno di leoni, e noi
con i popcorn. Alla fine ‘O Malamente vota il contrario di quanto detto in
mattinata, e il gesto plateale si scioglie in un risata farsesca per non
piangere. Tze, Sorkin, beccati questo. Noi teniamo Losito. Solo che nella realtà
non abbiamo nessuno bello come Garko.
COSA HA
RIPORTATO LA STAMPA.
IL CORRIERE
DELLA SERA - In apertura: “Resa di Berlusconi, ora il governo è più forte”.
LA REPUBBLICA
- In apertura: “La sconfitta di Berlusconi”.
LA STAMPA - In
apertura: “Fiducia a Letta e il Pdl si spacca”.
IL GIORNALE -
In apertura: “Caccia ai berlusconiani”.
IL SOLE 24 ORE
- In apertura: “Resa di Berlusconi, fiducia larga a Letta”.
IL TEMPO - In
apertura: “Berlusconi cede ad Alfano e vota la fiducia al governo. Pdl sempre
più nel caos”.
IL FATTO
QUOTIDIANO – In apertura: “La buffonata”.
Il
Financial Times titola a caratteri cubitali sulla "vittoria" del
premier Letta al senato e sottolinea che l'Italia si è allontanata dal baratro
dopo "l'inversione a U" di Berlusconi.
Sulla homepage
di BBC News campeggia la foto di Berlusconi in lacrime con sotto il
titolo "Vittoria di Letta dopo l'inversione a U di Berlusconi".
Apertura
italiana anche per il quotidiano The Guardian, che evidenzia un piccolo
giallo e chiede la partecipazione dei lettori. "Cosa ha detto Enrico Letta
subito dopo l'annuncio di Berlusconi di votare per la fiducia al Governo"?.
Passando alle testate spagnole, il progressista El Paìs pubblica in
homepage una photogallery dal titolo "Le facce di Berlusconi" (tutte
particolarmente adombrate) e titola il pezzo portante sulla crisi italiana
dicendo che l'ex premier, "avendo avuto certezza di non poter vincere, ha
deciso di non perdere".
Il
conservatore El Mundo, invece, dedica l'apertura oltre che alla cronaca
della giornata al Senato alla figura di Angelino Alfano, con un editoriale
intitolato: "Il delfino che ha detto basta", nel quale si evidenzia la
spaccatura profonda che ha minato l'integrità finora incrollabile del partito di
Silvio Berlusconi.
E poi ci sono
i quotidiani tedeschi. Lo Spiegel International titola a tutta pagina "Fallito
il colpo di Stato in Parlamento. L'imbarazzo di Berlusconi". Lo Spiegel
in lingua madre, invece, pone l'accento sulla "ribellione contro il
Cavaliere, che sancisce la fine di un'epoca".
Foto con
cravatta in bocca per Enrico Letta sul Frankfurter Allgemeine. Il
quotidiano, da sempre molto critico nei confronti di Berlusconi, titola in
apertura: "Enrico Letta vince il voto di fiducia" e poi si compiace che
sia "stata scongiurata in Italia una nuova elezione" dopo una svolta a
180 gradi di Berlusconi.
Il New York
Times dedica uno spazio in prima pagina a "Berlusconi che fa marcia
indietro sulla minaccia di far cadere il governo".
Tra i giornali
russi, il primo ad aprire sull'Italia è il moderato Kommersant, che
dedica al voto di fiducia un articolo di cronaca con foto triste di Berlusconi,
sottolineando che "L'Italia ha evitato nuove elezioni". Stessa cosa vale
anche per il sito in lingua inglese di Al Jazeera, l'emittente del Qatar,
che apre la sua edizione online con una foto di Enrico Letta che sorride
sollevato "dopo la vittoria".
Telegrafico Le
Monde, che titola: "Il governo Letta ottiene la fiducia. Dopo la
defezione di 25 senatori del PdL, Silvio Berlusconi ha deciso di votare la
fiducia all'esecutivo".
"Berlusconi
cambia casacca" è invece il titolo scelto dal quotidiano di sinistra
Liberation.
Infine Le
Figaro, quotidiano sarkozysta, titola: "Il voltafaccia di Silvio
Berlusconi risparmia all'Italia una crisi".
FARSA
ITALIA. UNA GIORNATA DI ORDINARIA FOLLIA.
Tra le 12,
quando Sandro Bondi scandisce in Aula “fallirete”, e le 13,30, quando Silvio
Berlusconi si arrende e, con un sorriso tirato, annuncia il sì al governo, è
racchiuso tutto il senso di una giornata che, senza enfasi, il premier Enrico
Letta definirà storica. Per la prima volta, infatti, il Cavaliere è costretto a
ripiegare e a cedere sovranità alla decisione imposta da Angelino Alfano, il
delfino considerato come un figlio che ha ucciso il padre. Che per il Pdl sia
stata una giornata convulsa è ormai chiaro a tutti. E lo dimostra anche questa
dichiarazione di Renato Brunetta, il quale, uscendo dalla riunione dei
parlamentari del partito a Palazzo Madama, annuncia convinto che il Pdl toglierà
la fiducia al Governo Letta. Poco dopo, in aula, la retromarcia di Berlusconi.
Mercoledì 2 ottobre intorno alle 13.32 Silvio Berlusconi ha preso la parola al
Senato e ha detto a sorpresa che il PdL avrebbe confermato la fiducia al governo
Letta. Poco prima, il capogruppo del PdL alla Camera Renato Brunetta aveva detto
perentoriamente ad alcuni giornalisti che «dopo lunga e approfondita
discussione» nel gruppo dei parlamentari PdL, «l’opzione di votare la sfiducia
al governo è stata assunta all’u-na-ni-mi-tà dei presenti».
La cronaca
della giornata comincia, infatti, molto presto.
2,30
del mattino, Angelino Alfano ha lasciato palazzo Grazioli dopo un lunghissimo
faccia a faccia con il Cavaliere, concluso con una rottura dolorosa, ed una
sfida, quella lanciata dal leader del centrodestra: "Provate a votare la fiducia
a Letta e vedremo in quanti vi seguiranno".
9.30,
“L’Italia corre un rischio fatale, cogliere o non cogliere l’attimo, con un sì o
un no, dipende da noi”, ha esordito Letta, aggiungendo che "gli italiani ci
urlano che non ne possono più di ‘sangue e arena’, di politici che si scannano e
poi non cambia niente”, ma al tempo stesso ribadendo che “i piani della vicenda
giudiziaria che investe Silvio Berlusconi e del governo, non potevano, né
possono essere sovrapposti” e che ”il governo, questo governo in particolare,
può continuare a vivere solo se è convincente. Per questo serve un nuovo patto
focalizzato sui problemi delle famiglie e dei cittadini”.
Quando il
presidente del Consiglio Letta ha cominciato a parlare in Senato, Giovanardi,
Roberto Formigoni e Paolo Naccarato, i più decisi fra gli scissionisti, facevano
circolare una lista di 23 nomi, aggiungendo però che al momento della conta il
risultato finale sarebbe stato ancoro più corposo. "Siamo già in 25 -
dice Roberto Formigoni parlando con i cronisti in Transatlantico della
scissione dal gruppo Pdl - E' possibile che altri si aggiungano. Nel
pomeriggio daremo vita a un gruppo autonomo chiamato 'I Popolari'. Restiamo
alternativi al centrosinistra, collocati nel centrodestra". Questi i cognomi
dei primi firmatari: Naccarato, Bianconi, Compagna, Bilardi, D'Ascola, Aielo,
Augello, Caridi, Chiavaroli, Colucci, Formigoni, Gentile, Giovanardi, Gualdani,
Mancuso, Marinello, Pagano, Sacconi, Scoma, Torrisi, Viceconte, L.Rossi,
Quagliariello. Con questi numeri, come già aveva pensato anche il ministro
Gaetano Quagliariello, il premier Letta aveva già raggiunto il quorum teorico al
Senato. Infatti il presidente del Consiglio parte da una base di 137 voti
(escluso quello del presidente del Senato che per tradizione non vota), ai quali
si aggiungono i 5 dei senatori a vita ed i 4 annunciati dai fuoriusciti M5s. In
questo modo il governo supera abbondantemente la fatidica ‘quota 161′ necessaria
a Palazzo Madama assestandosi intorno a quota 170.
Berlusconi,
che a seduta ancora in corso ha riunito i suoi per decidere il da farsi, ha
detto che ''sarà il gruppo in maniera compatta a decidere cosa fare.
Prendiamo una decisione comune per non deludere il nostro popolo''. Alla
riunione non hanno partecipato i senatori considerati i ormai con le valigie in
mano e una prima votazione si è chiusa con una pattuglia di 27 falchi
schieratissimi sulla sfiducia al governo, mentre 23 erano per lasciare l'aula al
momento del voto (al Senato l'astensione è equiparata al voto contrario) mentre
solo due si sono comunque espressi per il voto di fiducia. Nonostante i no
assoluti a Letta fossero quindi una netta minoranza rispetto al plenum del
gruppo Pdl, Berlusconi ha tagliato corto "voteremo contro la fiducia", come il
capo ufficio stampa del partito si è premurato di far sapere a tutti i
giornalisti presenti nella sala antistante l'aula. Il Cavaliere dichiara: “voteremo
no e resteremo in aula Se uscissimo fuori sarebbe un gesto ambiguo e gli
elettori non lo capirebbero''. In aula al Senato è Sandro Bondi a schierarsi
contro Enrico Letta con queste parole: “avete spaccato
il Pdl ma fallirete.
11.30. Contrariamente
a quanto si vociferava, non è Silvio Berlusconi ad intervenire in aula al Senato
ma Sandro Bondi. Bondi ricorda a Letta di essere a Palazzo Chigi grazie anche al
PdL; rimarca il passaggio di Letta circa il concetto di pacificazione e sostiene
che per Letta, la pacificazione sta nell’eliminare politicamente Silvio
Berlusconi. Bondi ricorda a Letta che il problema giudiziario di Berlusconi
nasce anche da Tangentopoli quando la tempesta giudiziaria travolse anche la
Democrazia Cristiana, partito d’origine del Premier. Intanto, il PdL ha deciso:
voterà la sfiducia all’unanimità. Questo è il quanto alle 12.00.
Poco dopo le
12.10 Enrico Letta riprende la parola nell’aula del Senato. Parla di
giornata storica ma dai risvolti drammatici e ricorda che il travaglio di molti
senatori va rispettato. Esprime gratitudine e solidarietà alla Senatrice Paola
De Pin, per l’intervento in aula e per aver rischiato un attacco fisico da parte
dei suoi ormai ex colleghi del M5S e sottolinea, rivolgendosi ai Senatori
grillini che il rispetto della persona è alla base della democrazia. Durante
l’intervento di Letta, vibranti proteste contro Letta da parte del Senatore
Scilipoti che viene zittito dal Presidente Grasso. Letta aggiunge che i numeri
che sostengono il governo sono cambiati ma comunque è fiducioso circa il
raggiungimento degli obiettivi di governo verso i quali si pone con le parole
“chiari” e “netti”. Il presidente del Consiglio ringrazia chi ha votato prima
per l’attuale maggioranza come chi, oggi ha deciso diversamente. Letta rimarca
il ruolo importante dell’Italia nel contesto europeo per il quale auspica
centralità ed il coinvolgimento del Parlamento per il semestre UE. Si conclude
qui, la replica del presidente del Consiglio e si aprono le dichiarazioni di
voto. Questo è il quanto alle 12,30.
13.32.
Berlusconi, e non il capogruppo Renato Schifani, interviene per la
dichiarazione di voto del Pdl. E in meno di tre minuti, con volto terreo, e
senza fare nessun riferimento alle convulsioni dei giorni precedenti, ha
rinnovato la fiducia a Letta "non senza travaglio". Il suo intervento al Senato
è arrivato alle 13.32. Sottolinea che ad aprile ritenne di mettere insieme un
governo di centrosinistra col centrodestra per il bene del Paese. Accettando
tutte le volontà del presidente incaricato Enrico Letta, accettando di avere
solo 5 ministri. “Lo abbiamo fatto con la speranza che potesse cambiare il
clima del nostro Paese - ha sostenuto - andando verso una pacificazione.
Una speranza che non abbiamo deposto. Abbiamo ascoltato le parole del premier
sugli impegni del suo Governo e sulla giustizia. Abbiamo deciso di
esprimere un voto di fiducia a questo governo”. Pone fine al proprio
intervento, torna a sedersi e scoppia a piangere.
La fiducia al
Governo Letta è passata con 235 voti a favore e 70 voti contrari.
Alle 16.00
il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha aperto il suo intervento alla
Camera. Sostanzialmente è un rimarcare quanto già espresso stamattina in Senato.
Intanto, nelle ore precedenti, si delinea la formazione del nuovo gruppo
politico costituito da transfughi del PdL e capitanati da Fabrizio Cicchitto;
sono ufficialmente 12 ma si conta di arrivare complessivamente a 26
Parlamentari. A margine della conferenza dei capigruppo alla Camera, la
Presidenza ha dato il disco verde per la costituzione del nuovo gruppo che
interverrà sin da oggi pomeriggio nel dibattito parlamentare che seguirà
l’intervento di Letta.
Poco prima
delle 21,30, la Camera ha espresso il proprio voto nei confronti del
governo Letta. 435 favorevoli e 162 contrari. Termina qui, questa lunga giornata
politica dalla quale il Paese esce con un governo confermato ma sostenuto da una
nuova maggioranza.
Vittorio Feltri fa
trapelare il suo malessere su Twitter: "Chi incendia la propria casa e poi
spegne le fiamme è un incendiario, un pompiere o un pirla?".
ITALIA DA
VERGOGNA.
Che Italia di
merda. Anzi no, perché non si può dire. Un’Italia da vergogna, però sì. Se
volete possiamo continuare ad enucleare le virtù dell’italica vergogna.
È proprio una
storiaccia, scrive Nicola Porro. Beccare l’esattore che per quattro danari fa lo
sconto sulle tasse da pagare, sembra un roba dell’altro secolo. Secondo la
Procura di Roma è quanto facevano alcuni funzionari (ed ex colleghi) di
Equitalia. Vedremo presto, si spera, se e quanto fosse diffuso il sistema. Una
tangente per alleggerire il proprio carico fiscale fa ribollire il sangue.
Equitalia è stata negli ultimi anni il braccio inflessibile della legge
(assurda) tributaria. Inflessibile nei suoi atteggiamenti oltre che nelle sue
regole. La prima reazione è di sdegno. Come per uno stupro, non si riesce a
ragionare, a essere lucidi. Ad aspettare un processo. In galera i presunti
delinquenti. Gli aguzzini che hanno rovinato la vita a migliaia di contribuenti
in sofferenza. Nei confronti dei quali (i contribuenti, si intende) non hanno
mai avuto pietà. Bene. Ora calmiamoci un po’. E ragioniamo. Il dito è l’indagine
di ieri. La luna è il caso di oggi e di domani. Ci stiamo forse prendendo in
giro? Qualcuno pensa veramente che il catasto sia un luogo di verginelle?
Qualcuno ritiene sul serio che le amministrazioni comunali che forniscono
licenze siano immacolate? Qualcuno si immagina davvero che le Asl e i relativi
controlli che fanno alle imprese siano tutti puliti? La lista potrebbe diventare
infinita. Ed è una lista che sarebbe comunque compilata per difetto. Non c’è
giorno che la cronaca non ci regali uno scandaletto locale su funzionari o
dipendenti pubblici che non svolgono con onestà il proprio lavoro e che si
mettono in tasca un stipendio alternativo a quello fornito dalla mamma Stato. Il
nostro non è un punto di vista rassegnato. E tanto meno un giudizio complessivo
sull’amministrazione pubblica. Il nostro è un puro ragionamento economico, senza
alcun intento moralistico. Questo lo lasciamo a chi legge. La cosa è semplice e
ha a che fare con la burocrazia statale. Essa ha un potere immenso, a ogni suo
livello. Che le deriva dalla legge e dalla possibilità di farla applicare grazie
al monopolio della violenza (legale e giudiziaria) di cui lo Stato dispone. Il
caso Equitalia è particolarmente odioso per il momento in cui ci troviamo. Ma la
stecca sulle tasse era ben più consistente e diffusa prima della riforma
tributaria. Il punto è dunque quello di guardare al principio e non al
dettaglio. Troppo Stato e la troppa burocrazia che ne consegue vuol dire una
cosa sola: incentivo alla corruzione. La nostra bulimia legislativa, normativa e
amministrativa nasce dalla presunzione pubblicistica, per la quale i privati
sono più o meno potenzialmente tutti dei mascalzoni e devono dunque essere
preventivamente controllati. Ecco le norme, le regole, i controlli, le agenzie,
i funzionari, le procedure, le carte. Quanto più sono numerose, quanto maggiore
è la possibilità che un passaggio sia economicamente agevolato da una
commissione di sveltimento/tangente. Niente moralismi: calcolo delle
probabilità. Nell’assurda costruzione pubblicistica che ci ha ormai
irrimediabilmente contagiati si è commesso un enorme refuso logico. E cioè: i
privati sono dei furfanti e come tali debbono essere regolati. Il mercato è in
fallimento e dunque deve essere sostituito dallo Stato. E mai si pensa (ecco il
refuso) che altrettanti furfanti e fallimenti ci possono statisticamente essere
in coloro che dovrebbero legiferare o controllare. La prima vera, grande
rivoluzione di questo Paese è ridurre il peso dello Stato, non solo perché costa
troppo, ma perché si presume, sbagliando, che sia migliore e più giusto del
privato.
ITALIA
BARONALE.
I concorsi
truccati di un Paese ancora feudale.
Un sistema
consolidato di scambio di favori che ha attraversato tutta la Penisola, da Nord
a Sud, coinvolgendo otto atenei: Bari, Sassari, Trento, Milano Bicocca, Lum,
Valle d'Aosta, Roma Tre, Europea di Roma. È quanto emerge da un'inchiesta
condotta dalla procura di Bari, che ha indagato su possibili manipolazioni di 15
concorsi pubblici per incarichi di docenti ordinari e associati nelle
università.
L’inchiesta
di Bari coinvolge 38 docenti, tra cui i 5 "saggi" chiamati dal governo, ma svela
ciò che tutti sanno: le università sono una lobby, scrive
Vittorio
Macioce su “Il Giornale”. Non servono i saggi per rispondere a questa domanda.
Come si diventa professori universitari? Lo sanno tutti. Non basta fare il
concorso. Quello è l'atto finale, la fatica è arrivarci con qualche possibilità
di vincerlo. È una corsa con regole antiche, dove la bravura è solo una delle
tante componenti in gioco. L'università è un mondo feudale. I baroni non si
chiamano così per caso. Ognuno di loro ha vassalli da piazzare. Entri se sei
fedele, se sei pure bravo tanto meglio. È la logica della cooptazione. Ti scelgo
dall'alto, per affinità, per affidabilità, per simpatia, perché apparteniamo
allo stesso partito, alla stessa lobby, allo stesso giro. I baroni si
riproducono tagliando fuori i devianti, le schegge impazzite, i cani sciolti.
Molti sono convinti che in fondo questo sia un buon modo per selezionare una
classe dirigente. Magari hanno ragione, magari no e il prezzo che si paga è la
«mummificazione». Fatto sta che sotto il concorso pubblico ufficiale ci sono
trattative, accordi, arrivi pilotati, rapporti di forza, «questa volta tocca al
mio», «tu vai qui e l'altro lo mandiamo lì». La stragrande maggioranza dei
futuri accademici vive e accetta questa logica. È l'università. È sempre stato
così. Perché cambiare? L'importante è mandare avanti la finzione dei concorsi. È
la consuetudine e pazienza se è «contra legem». I concorsi in genere funzionano
così e il bello è che non è un segreto. Poi ogni tanto il meccanismo si inceppa.
Qualcuno per fortuna ha il coraggio di denunciare o i baroni la fanno davvero
sporca. È quello che è successo con un'inchiesta che parte da Bari e tocca una
costellazione di atenei: Trento, Sassari, Bicocca, Lum, Valle d'Aosta,
Benevento, Roma Tre e l'Europea. Sotto accusa finiscono 38 docenti, ma la
notizia è che tra questi ci sono cinque «saggi». Cinque costituzionalisti cari
al Colle. Augusto Barbera, Lorenza Violini, Beniamino Caravita, Giuseppe De
Vergottini, Carmela Salazar. Che fanno i saggi? Solo pochi illuminati lo hanno
davvero capito. Forse qualcuno ancora se li ricorda. Sono quel gruppo di
professori nominati da Enrico Letta su consiglio di Napolitano per immaginare la
terza Repubblica. Sulla carta dovevano gettare le basi per cambiare la
Costituzione. In principio erano venti, poi per accontentare le larghe intese
sono diventati trentacinque, alla fine si sono aggiunti anche sette estensori,
con il compito di mettere in italiano corrente i pensieri degli altri.
Risultato: quarantadue. Il lavoro lo hanno finito. Quando servirà ancora non si
sa. I cinque saggi fino a prova contraria sono innocenti. Non è il caso di
metterli alla gogna. Il sistema feudale però esiste. Basta chiederlo in privato
a qualsiasi barone. Ed è qui che nasce il problema politico. Questo è un Paese
feudale dove chi deve cambiare le regole è un feudatario. Non è solo
l'università. L'accademia è solo uno dei simboli più visibili. È la nostra
visione del mondo che resta aggrappata a un eterno feudalesimo. Sono feudali le
burocrazie che comandano nei ministeri, paladini di ogni controriforma. È
feudale il sistema politico. Sono feudali i tecnici che di tanto in tanto si
improvvisano salvatori della patria. È feudale il mondo della sanità, della
magistratura, del giornalismo. È feudale la cultura degli eurocrati di
Bruxelles. È feudale il verbo del Quirinale. È stato sempre così. Solo che il
sistema negli anni è diventato ancora più rigido. Lo spazio per gli outsider sta
scomparendo. L'ingresso delle consorterie è zeppo di cavalli di frisia e filo
spinato. La crisi ha fatto il resto. Se prima era tollerata un quota di non
cooptazione dall'alto, ora la fame di posti liberi ha tagliato fuori i non
allineati. E sono loro che generano cambiamento. Il finale di questa storia
allora è tutto qui. Quando qualcuno sceglie 42 saggi per pilotare il cambiamento
non vi fidate. Nella migliore delle ipotesi sta perdendo tempo, nella peggiore
il concorso è truccato. Il prossimo candidato vincente è già stato scelto. Si
chiama Dc.
È una storia
antica quanto i baroni. Ma i nomi e i numeri, stavolta, fanno più rumore. Hanno
trafficato in cattedre universitarie, sostengono la Procura e la Finanza di
Bari. In almeno sette facoltà di diritto, pilotando concorsi per associati e
ordinari. Le indagini, spiega Repubblica, iniziano nel 2008 presso l’università
telematica “Giustino Fortunato”, di Benevento, che grazie al rettore Aldo
Loiodice divenne una succursale dell’università di Bari: “Tirando il filo che
parte dalla “Giustino Fortunato”, l’indagine si concentra infatti sui concorsi
di tre discipline — diritto costituzionale, ecclesiastico, pubblico comparato —
accertando che i professori ordinari “eletti nell’albo speciale” e dunque
commissari in pectore della Commissione unica nazionale sono spesso in realtà
legati da un vincolo di “reciproca lealtà” che, di fatto, li rende garanti di
vincitori già altrimenti designati dei concorsi che sono chiamati a giudicare.
Non ha insomma alcuna importanza chi viene “sorteggiato” nella Commissione”. La
prova, per la Finanza, sarebbero le conversazioni dei prof insospettiti, che
citano Shakespeare e parlano in latino: “È il caso dell’atto terzo, scena quarta
del Macbeth. «Ciao, sono l’ombra di Banco», ammonisce un professore,
rivolgendosi ad un collega. Già, Banco: la metafora della cattiva coscienza”. Da
una minuscola università telematica al Gotha del mondo accademico italiano,
scrive Giovanni Longo su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Una intercettazione
dietro l’altra: così la Procura di Bari ha individuato una rete di docenti che
potrebbe avere pilotato alcuni concorsi universitari di diritto ecclesiastico,
costituzionale e pubblico comparato. I finanzieri del nucleo di polizia
tributaria del comando provinciale di Bari avevano iniziato a indagare sulla
«Giustino Fortunato» di Benevento. Gli accertamenti si sono poi estesi: basti
pensare che i pm baresi Renato Nitti e Francesca Pirrelli stanno valutando le
posizioni di un ex ministro, dell'ex garante per la privacy, di cinque dei 35
saggi nominati dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. L’ipotesi è
che qualcuno possa avere influenzato i concorsi. Tra i 38 docenti coinvolti
nell'inchiesta che da Bari potrebbe fare tremare il mondo accademico italiano ci
sono infatti Augusto Barbera (Università di Bologna), Beniamino Caravita di
Toritto (Università La Sapienza Roma), Giuseppe De Vergottini (Università di
Bologna), Carmela Salazar (Università di Reggio Calabria) e Lorenza Violini
(Università di Milano), nominati da Napolitano per affiancare l’esecutivo sul
terreno delle riforme costituzionali. La loro posizione, al pari di quella
dell'ex ministro per le Politiche Comunitarie Anna Maria Bernini e di Francesco
Maria Pizzetti, ex Garante della Privacy, è al vaglio della Procura di Bari che
dovrà verificare se ci sono elementi per esercitare l’azione penale. Gli
accertamenti non sono legati agli incarichi istituzionali dei docenti, ma
riguardano la loro attività di commissari in concorsi da ricercatore e da
professore associato e ordinario, banditi nel secondo semestre del 2008. Quella
tessuta pazientemente nel tempo dalle fiamme gialle, coordinate dalla Procura di
Bari, sarebbe stata una vera e propria «rete» che per anni avrebbe agito su
tutto il territorio nazionale e che a Bari avrebbe avuto una sponda
significativa. Quattro i professori baresi sui quali sono da tempo in corso
accertamenti: Aldo Loiodice, all’epoca ordinario di diritto costituzionale
nell’Università di Bari, Gaetano Dammacco, ordinario di diritto canonico ed
ecclesiastico alla facoltà di scienze politiche; Maria Luisa Lo Giacco e Roberta
Santoro, ricercatrici di diritto ecclesiastico. Le ipotesi di reato a vario
titolo sono associazione per delinquere, corruzione, abuso d'ufficio, falso e
truffa. E’ una élite di studiosi di diritto che si conoscono da sempre, che si
incontrano a seminari e convegni di studio e che, anche in quel contesto,
pianificano i concorsi universitari in tutta Italia. Questa è l’ipotesi. Il
quadro emerso dalle centinaia di intercettazioni e dalle decine di perquisizioni
eseguite negli anni scorsi in abitazioni, studi professionali, istituzioni
universitarie, da Milano a Roma, da Teramo a Bari è da tempo al vaglio della
Procura. Nove gli Atenei coinvolti. Almeno una decina i concorsi universitari
espletati tra il 2006 e il 2010 finiti sotto la lente d’ingrandimento delle
Fiamme Gialle. A quanto pare non sarebbe emersa una vera e propria cabina di
regia, quanto piuttosto una sorta di «circolo privato» in grado di decidere il
destino di concorsi per professori di prima e seconda fascia in tre discipline
afferenti al diritto pubblico. Gli investigatori ritengono che questi concorsi
nascondano un sistema di favori incrociati. Dopo il sorteggio delle commissioni
giudicatrici previsto dalla riforma Gelmini, sarebbe insomma scattato un patto
della serie: «tu fai vincere il mio “protetto” nella tua commissione ed io
faccio vincere il tuo nella mia». «Accordi», «scambi di favore», «sodalizi e
patti di fedeltà» per «manipolare» l’esito di molteplici procedure concorsuali
pubbliche, bandite su tutto il territorio nazionale in quel quadriennio.
Dall’accusa iniziale, evidenziata in uno dei decreti di perquisizione, in oltre
due anni, si sarebbero aggiunti molti altri riscontri trovati dagli
investigatori. E pensare che l’inchiesta era partita dagli accertamenti
sull'università telematica «Giustino Fortunato », considerata dalla Finanza una
sorta di «titolificio» dove si poteva diventare professori in men che non si
dica. Dietro quella pagliuzza sarebbe spuntata una trave molto più grande.
Università,
i baroni si salvano con la prescrizione. Grazie alla riforma voluta da
Berlusconi, che garantisce l'impunità ai colletti bianchi, tre docenti
dell'ateneo di Bari sono stati assolti dall'accusa di spartizione delle
cattedre. Ma le intercettazioni hanno mostrato l'esistenza di una vera e propria
cupola in tutta Italia, scrive
Gianluca Di
Feo su “L’Espresso”. È stata l'inchiesta più clamorosa sulla spartizione delle
cattedre, quella che aveva fatto parlare di una mafia che decideva le nomine a
professore negli atenei di tutta Italia. E lo faceva nel settore più delicato:
la cardiologia. Ma nove anni dopo la retata che ha scosso le fondamenta del
mondo universitario, il tribunale di Bari ha assolto tre imputati chiave
dall'accusa di associazione a delinquere. Erano innocenti? Il reato è stato
dichiarato prescritto perché è passato troppo tempo: i fatti contestati
risalgono al 2002. Una beffa, l'ennesima conferma sull'effetto delle riforme
berlusconiane che hanno dilatato la durata dei processi e di fatto garantiscono
l'impunità ai colletti bianchi. Il colpo di spugna arriva proprio mentre da Roma
a Messina si torna a gridare allo scandalo per i concorsi pilotati negli atenei.
L'istruttoria di Bari era andata oltre, radiografando quanto fosse diventato
profondo il malcostume nel corpo accademico. Grazie alle intercettazioni
finirono sotto indagine decine di professori di tutte le regioni. Nel suo atto
di accusa il giudice Giuseppe De Benectis scrisse: «I concorsi universitari
erano dunque celebrati, discussi e decisi molto prima di quanto la loro
effettuazione facesse pensare, a cura di commissari che sembravano simili a
pochi “associati” a una “cosca” di sapore mafioso». Stando agli investigatori,
al vertice della rete che smistava cattedre e borse da di studio da Brescia a
Palermo c'era Paolo Rizzon, trevigiano diventato primario nel capoluogo
pugliese. Le intercettazioni lo hanno descritto come un personaggio da commedia
all'italiana. È stato registrato mentre manovrava la composizione di una
commissione d'esame che approvasse la nomina del figlio. Poi scopre che l'erede
non riesce neppure a mettere insieme la documentazione indicata per l'esame da
raccomandato («Ho guardato su Internet, non c'è niente») e si dà da fare per
trovargli un testo già scritto. Nei nastri finisce una storia dai risvolti
boccacceschi con scambi di amanti e persino l'irruzione della vera mafia. Quando
un candidato non si piega alle trame della “Cupola dei baroni” e presenta un
ricorso per vedere riconosciuti i suoi diritti, gli fanno arrivare questo
avvertimento: «Il professore ha fatto avere il tuo indirizzo a due mafiosi per
farti dare una sonora bastonata». Secondo gli inquirenti, non si trattava di
millanterie. I rapporti con esponenti di spicco della criminalità locale sono
stati documentati, persino nel «commercio di reperti archeologici». A uno di
loro – che al telefono definisce «il boss dei boss» - il primario chiede di
recuperare l'auto rubata nel cortile della facoltà. Salvo poi scoprire che la
vettura non era stata trafugata: si era semplicemente dimenticato dove l'aveva
parcheggiata. I magistrati sono convinti che tra la metà degli anni Novanta e il
2002 il professore avesse creato una macchina perfetta per decidere le nomine di
cardiologia in tutta Italia: «Una vera organizzazione che vedeva Rizzon tra i
capi e organizzatori, con una ripartizione di ruoli, regole interne e sanzioni
per la loro eventuale inosservanza che consentiva ai baroni, attraverso il
controllo dei diversi organismi associativi, di acquisire in ambito accademico
il controllo esecutivo e di predeterminare la composizione delle commissioni
giudicatrici e prestabilire quindi anche l´esito della procedura». Oggi la
sentenza ha prosciolto per prescrizione dall'associazione per delinquere tre
docenti di spicco che avevano scelto il rito abbreviato. Assoluzione nel merito
invece per gli altri reati contestati. Nonostante le accuse, i tre prof sono
tutti rimasti al loro posto e hanno proseguito le carriere accademiche. Uno si è
persino candidato alla carica di magnifico rettore. Una tutela garantista nei
loro confronti, ma anche un pessimo esempio per chiunque sogni di fare strada
con i propri mezzi nel mondo dell'università senza essere costretto a emigrare.
I codici etici negli atenei sono stati introdotti solo dopo gli ultimi scandali,
ma in tutta la pubblica amministrazione non si ricordano interventi esemplari
delle commissioni disciplinari interne: si aspetta la magistratura e la sentenza
definitiva, che non arriva praticamente mai. Anche nel caso del professore
Rizzon e di altri tre luminari per i quali è in corso il processo ordinario
sembra impossibile che si arrivi a un verdetto. Dopo nove anni siamo ancora al
primo grado di giudizio e pure per loro la prescrizione è ormai imminente. Una
lezione magistrale per chi crede nel merito.
CASA
ITALIA.
Case
popolari solo a stranieri?
Magari non è proprio così ma basta farsi un giro in certe zone per rendersi
conto che la realtà sembra sempre di più penalizzare gli italiani. Il record
delle case popolari. Una su due va agli stranieri. Ecco le graduatorie per
avere accesso agli alloggi di edilizia residenziale. Più del 50% delle domande
vengono da immigrati. E i milanesi aspettano, scrive Chiara Campo su “Il
Giornale”. Ci sono Aba Hassan, Abad, Abadir. Ventisette cognomi su ventisette
solo nella prima pagina (e almeno 17 idonei). Ma scorrendo il malloppo delle
1.094 pagine che in ordine alfabetico formano le graduatorie per accedere alle
case popolari del Comune, almeno il 50% dei partecipanti è di provenienza
straniera. Basta leggere i primi dieci fogli per avere l'impressione che, tra
gli Abderrahman e gli Abebe, gli italiani siano dei «panda» in estinzione. Le
graduatorie pubblicate da Palazzo Marino si riferiscono al bando aperto fino a
fine giugno 2013 a chi ha bisogno di appartamenti di edilizia residenziale. Chi
entra nell'elenco non ha automaticamente la casa perché la lista d'attesa è
lunga, ma tra i criteri per avanzare in classifica ci sono ovviamente reddito
(basso) e numero di figli (alto). Le proteste dei leghisti sono note: «Gli
immigrati lavorano in nero e fanno tanti figli». Nel 2012 (sono dati del Sicet)
su 1190 assegnazioni nel capoluogo lombardo 495, quasi la metà 455, sono state a
favore di immigrati. A vedere gli elenchi l'impressione è che la percentuale
possa alzarsi ancora, a scapito di tante famiglie milanesi che probabilmente
versano tasse da più tempo e nella crisi avrebbero altrettanto bisogno di una
casa a basso costo. «Sono per l'integrazione - commenta Silvia Sardone,
consigliera Pdl della Zona 2 - ma questa non si può realizzare con una
potenziale discriminazione per gli italiani. Probabilmente il sistema di
costruzione delle graduatorie ha bisogno di essere reso più equo». Ci tiene a
sottolineare: «Non sono razzista, non lo sono mai stata e non lo sarò. Non sono
nemmeno perbenista né figlia di un buonismo di sinistra cieco della realtà. Ho
molto amici italiani con cognomi stranieri, hanno un lavoro ed un mutuo sulla
casa». Ma «nella prime pagine degli elenchi in ordine alfabetico si fa fatica a
trovare un cognome italiano e complessivamente sono tantissimi i cognomi
stranieri. Indipendentemente da chi ha studiato i criteri di partecipazione e
assegnazione e di quando siano stati creati penso che oggi, nel 2013, debbano
essere rivisti. Perché sono stanca di pagare delle tasse per servizi che spesso
godono gli altri». Anche il capogruppo milanese della Lega torna a chiedere agli
enti (Regione per prima) di rivedere i criteri di accesso, alzando ad esempio i
5 anni d residenza minima: «Serve una norma che difenda la nostra gente da chi,
si dice, porta ricchezza, ma invece rappresenta un costo».
Laddove
l’alloggio non viene assegnato, si occupa (si ruba) con il beneplacito delle
Istituzioni.
Quando si
parla di case occupate abusivamente o illegalmente, in genere la mente è portata
a collegare tale fenomeno a quello dei centri sociali, scrive “Mole 24”. Un tema
che di per sé sarebbe da approfondire, perché esistono centri sociali occupati
da autonomi, altri da anarchici, altri ancora dai cosiddetti “squatter”, termine
che deriva dall’inglese “to squat”, che non è solo un esercizio per rassodare i
glutei ma significa anche per l’appunto “occupare abusivamente”. Ma
l’occupazione abusiva delle case è in realtà un fenomeno assai nascosto e
taciuto, praticamente sommerso. Un’anomalia che pochi conoscono, ancor meno
denunciano o rivelano, essenzialmente perché non si sa come risolvere. Le leggi
ci sono, o forse no, e se anche esistono pare proprio che le sentenze più
attuali siano maggiormente orientate a tutelare gli interessi dell’occupante
abusivo piuttosto che quelli del proprietario che reclama i suoi diritti da
“esautorato”, sia che si parli del Comune in senso lato sia che si parli di un
qualsiasi fruitore di case popolari che si ritrova il suo alloggio occupato da
“ospiti” che hanno deciso di prenderne il possesso. Il fenomeno si riduce spesso
ad essere una guerra tra poveri. Parliamo, per fare un esempio non così lontano
dalla realtà, di un anziano pensionato costretto ad essere ricoverato in
ospedale per giorni, settimane o anche mesi: ebbene, questo anziano signore,
qualora fosse residente in un alloggio popolare, una volta dimesso potrebbe
rischiare di tornare a casa e non riuscire più ad aprire la porta d’ingresso.
Serratura cambiata, e l’amara sorpresa che nel frattempo alcuni sconosciuti
hanno preso possesso dell’abitazione. Un problema risolvibile? Non così tanto.
Anzi, potrebbe essere l’inizio di un lungo iter giudiziario, e se il nuovo o i
nuovi occupanti, siano essi studenti cacciati di casa, extracomunitari,
disoccupati o famiglie indigenti, dimostrano di essere alle prese con una
situazione economica insostenibile o di non aver mai potuto accedere a bandi di
assegnazione alle case popolari per vari motivi (ad esempio: non ne sono stati
fatti per lunghi periodi), l’anziano in questione potrebbe rischiare di sudare
le proverbiali sette camicie. Trattandosi di case popolari, la proprietà non è
di nessuno ma del Comune. Questo vuol dire che quando qualcuno non è presente,
fra gli altri bisognosi scatta una vera e propria corsa a chi arraffa la casa.
Ci sarebbero sì le graduatorie per assegnare gli immobili, ma non mai vengono
rispettate. Nel sud, affidarsi alla criminalità organizzata, pagando il dovuto,
è il metodo più sicuro per assicurarsi una casa popolare. Chi pensa che questo
sia un fenomeno di nicchia, si sbaglia di grosso. Le cifre infatti sono
clamorose, anche se difficilmente reperibili. L’indagine più recente e
affidabile da questo punto di vista è stata realizzata da Dexia Crediop per
Federcasa sul Social Housing 2008. E parla di ben 40.000 case popolari occupate
abusivamente in tutto lo Stivale, che se venissero assegnate a chi ne ha diritto
permetterebbero a circa 100.000 persone di uscire da uno stato di emergenza.
L’onestà non
paga. Ti serve una casa? Sfonda la porta e occupa, scrive Arnaldo Capezzuto su
“Il Fatto Quotidiano”. L’appartamento di edilizia residenziale è abitato da una
famiglia legittima assegnataria del diritto alla casa ottenuto attraverso un
regolare quanto raro bando pubblico con relativo posto in graduatoria? Chi se ne
fotte. Li cacci a calci in culo. E se non vogliono andare via, aspetti che
escano e ti impossessi dell’abitazione. Con calma poi metti i loro mobili,
vestiti e effetti personali in strada. Se malauguratamente qualcuno di loro ha
la pazza idea di contattare le forze dell’ordine per sporgere denuncia, niente
problema: li fai minacciare da qualche “cumpariello” inducendoli a dichiarare
che quelle persone sono amici-parenti. Onde evitare però sospetti, con calma fai
presentare un certificato di stato di famiglia dove i “signori occupanti”
risultano dei conviventi. Il trucco è palese. Non regge l’escamotage
dell’appartamento ceduto volontariamente. Certo. Gli investigatori non dormono.
Questo è chiaro. Il solerte poliziotto esegue l’accertamento. I nodi alla fine
vengo al pettine. La denuncia scatta immediata. La giustizia è lenta ma
implacabile. Lo Stato vince. Gli occupanti abusivi in generale ammettono subito
che sono abusivi. Quindi? Nei fatti c’è un organismo dello Stato – i verbali
delle forze dell’ordine, le lettere di diffida degli enti pubblici gestori degli
appartamenti – che certifica che a decorrere dal giorno x , dal mese x,
dall’anno x, l’abitazione che era assegnata a tizio, caio e sempronio ora con la
violenza e il sopruso è stato occupata da pinco pallino qualsiasi. La
malapolitica trasversalmente e consociativamente per puri e bassi calcoli
elettoralistici e non solo mascherati da esigenze sociali, di povertà, di
coesione sociale e stronzate varie compulsando e piegando le istituzioni si
attivano e varano con il classico blitz leggi, norme, regolamenti che vanno a
sanare gli abusivi. Chi ha infranto la legge, chi ha prevaricato sul più debole,
chi ha strizzato l’occhio al camorrista e al politiconzolo di turno, chi non mai
ha presentato una regolare domanda di assegnazione, chi neppure ha i requisiti
minimi per ottenere alla luce del sole un’abitazione si ritrova per "legge" un
alloggio di proprietà pubblica a canone agevolatissimo. Accade in Campania e
dove sennò in Africa?
Martedì 7
maggio 2013 è stato pubblicato sul Burc la nuova sanatoria per chi ha assaltato
le case degli enti pubblici. La Regione Campania guidata dal governatore Stefano
Caldoro ha varato all’interno della finanziaria regionale un provvedimento che
regolarizza e stabilisce che può richiedere l’alloggio chi lo ha occupato prima
del 31 dicembre 2010. Si badi bene che lo scorso anno era stato deciso con una
legge simile che poteva ottenere la casa chi l’aveva assaltata entro il 2009.
L’interrogativo sorge spontaneo: se puntualmente ogni anno varate una sanatoria
per gli abusivi ma perché allora pubblicate i bandi di assegnazione con
graduatoria se poi le persone oneste sono destinate ad avere sempre la peggio?
Misteri regionali. C’è da precisare però che la nuova sanatoria contiene delle
norme “innovative” e “rivoluzionarie” a tutela della legalità (non è una
battuta!) per evitare che tra gli assegnatari in sanatoria ci siano pregiudicati
e che le occupazione siano guidate dalla camorra. A questo punto c’è davvero da
ridere. Le norme per entrare in vigore – però – hanno bisogno del “si” degli
enti locali. Ecco il Comune di Napoli – ad esempio – ha detto “no”. Non è
pragmatismo ma è guardare negli occhi il mostro. A Napoli non è solo malavita ci
sono casi davvero di estrema povertà. Ma è facile adoperare, manipolare e
nascondersi dietro questi ultimi per far proliferare camorra e fauna
circostante. A Napoli i clan hanno sempre gestito le case di edilizia pubblica.
Ad esempio a Scampia chi vive nei lotti di edilizia popolare sa bene che la
continuità abitativa dipende dalle sorti del clan di riferimento. Chi perde la
guerra, infatti, deve lasciare gli appartamenti ai nuovi padroni. Un altro
esempio è il rione De Gasperi a Ponticelli. Qui il boss Ciro Sarno – ora
fortunatamente dietro le sbarre a scontare diversi ergastoli – decideva le
famiglie che potevano abitare negli appartamenti del Comune di Napoli. Una
tarantella durata per decenni tanto che il padrino Ciro Sarno era soprannominato
in senso dispregiativo ‘o Sindaco proprio per questa sua capacità di disporre di
alloggi pubblici. Stesso discorso per le case del rione Traiano a Soccavo, le
palazzine di Pianura, i parchi di Casavatore, Melito e Caivano.
Di cosa
parliamo? Alle conferenze stampa ci si riempie la bocca con parole come
legalità, anticamorra, lotta ai clan. Poi alla prima occasione utile invece di
mostrare discontinuità, polso duro, mano ferma si deliberano norme che hanno
effetti nefasti: alimentano il mercato della case pubbliche gestite dai soliti
professionisti dell’occupazione abusiva borderline con i clan. Circola in Italia
una strana idea di legalità, scrive Antonio Polito su “Il Corriere della Sera”.
I suoi cultori chiedono alle Procure di esercitare il ruolo improprio di
«controllori» ma non appena possono premiano l'illegalità, per demagogia o per
calcolo elettorale. È il caso di Napoli, città-faro del movimento giustizialista
visto che ha eletto sindaco un pm, dove è stata appena approvata, praticamente
all'unanimità, la sanatoria degli occupanti abusivi delle case comunali. Nel
capoluogo partenopeo si tratta di un fenomeno vastissimo: sono circa 4.500 le
domande di condono giunte al Comune per altrettanti alloggi. Per ogni famiglia
che vedrà legalizzato un abuso, una famiglia che avrebbe invece diritto
all'abitazione secondo le regole e le graduatorie perderà la casa. Non c'è modo
migliore di sancire la legge del più forte, del più illegale; e di invitare
altri futuri abusivi a spaccare serrature e scippare alloggi destinati ai
bisognosi. Ma nelle particolari condizioni di Napoli la sanatoria non è solo
iniqua; è anche un premio alla camorra organizzata. È stato infatti provato da
inchieste giornalistiche e giudiziarie che «l'occupazione abusiva di case è per
i clan la modalità privilegiata di occupazione del territorio», come ha detto un
pubblico ministero. In rioni diventati tristemente famosi, a Secondigliano,
Ponticelli, San Giovanni, cacciare con il fuoco e le pistole i legittimi
assegnatari per mettere al loro posto gli affiliati o i clientes della famiglia
camorristica è il modo per impadronirsi di intere fette della città; sfruttando
le strutture architettoniche dell'edilizia popolare per creare veri e propri
«fortini», canyon chiusi da cancelli, garitte, telecamere, posti di blocco,
praticamente inaccessibili dall'esterno e perfetto nascondiglio per latitanti,
armi e droga. Non che tutto questo non lo sappia il sindaco de Magistris, che a
Napoli ha fatto il procuratore. E infatti ha evitato di assumersi in prima
persona la responsabilità di questa scelta. L'ha però lasciata fare al consiglio
comunale, Pd e Pdl in testa, difendendola poi con il solito eufemismo politico:
«Non è una sanatoria. Io la chiamerei delibera sul diritto alla casa». E in
effetti è una delibera che riconosce il diritto alla casa a chi già ce l'ha,
avendola occupata con la forza o l'astuzia.
E gli
alloggi di proprietà?
Le Iene, 1
ottobre 2013: case occupate abusivamente.
23.40.
L’associazione Action organizza occupazioni di case: prima erano per lo più
extracomunitari, ora sempre più spesso esponenti del ceto medio che non riesce
più a pagare il mutuo e viene sfrattata. Occupano così case vuote o sfitte. O,
peggio, entrano in case abitate, cambiano la serratura e addio (un incubo per
molti). Una signora, però, ha rioccupato la casa da cui è stata sfrattata.
23.48. Si
racconta la storia di una ragazza non ancora trentenne, fiorista, che ha
occupato una casa comprata da una famiglia, che ha acceso un mutuo e che ora si
trova con un immobile svalutato e un ambiente ben diverso da quello residenziale
che avevano scelto per far crescere i propri figli. “Si è scatenata una guerra
tra poveri” dice una signora che vive qui ‘legalmente’, che va a lavorare tutti
i giorni per pagare un mutuo per una casa che non rivenderà mai allo stesso
prezzo. E’ truffata anche lei.
L’occupazione abusiva degli immobili altrui e la tutela delle vittime.
In sede
civile, scrive Alessio Anceschi, chi si veda abusivamente privato del proprio
immobile può certamente adire l’autorità giudiziaria al fine di rientrare nella
disponibilità di esso da coloro che lo hanno illegittimamente occupato. In tal
senso, potrà proporre l’azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), oppure, entro
i termini previsti dalla legge, l’azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.). Il
legittimo proprietario o possessore dell’immobile potrà anche agire al fine di
ottenere il risarcimento dei danni sofferti, i quali si prestano ad essere molto
ingenti, sia sotto il profilo patrimoniale, che esistenziale. In tutti i casi,
tuttavia, in considerazione della lunghezza del procedimento civile e
soprattutto del procedimento di esecuzione, il legittimo proprietario o
possessore dell’immobile si trova concretamente privato della propria abitazione
(e di tutti i beni che in essa sono contenuti) e quindi costretto a vivere
altrove, da parenti o amici, quando và bene, in ricoveri o per la strada quando
và male.
Sotto il
profilo penale sono ravvisabili molti reati. Prima di tutti, il reato di
invasione di terreni od edifici (art. 633 c.p.), ma anche altri reati contro il
patrimonio funzionalmente collegati all’occupazione abusiva, quali il
danneggiamento (art. 635 c.p.) ed il furto (artt. 624 e 625 c.p.). Il secondo
luogo, colui che occupa abusivamente un immobile altrui commette il reato di
violazione di domicilio (art. 614 c.p.). Anche in questo caso, tuttavia, la
tutela postuma che consegue alla sentenza non si presta a tutelare adeguatamente
la vittima. Infatti, il reato di cui all’art. 633 c.p., unica tra le ipotesi
citate ad integrare un reato permanente, non consente l’applicazione né di
misure precautelari, né di misure cautelari. Lo stesso vale per gli altri reati
sopra indicati, soprattutto quando non vi sia stata flagranza di reato. La
vittima dovrà quindi attendere l’interminabile protrarsi del procedimento penale
ed anche in caso di condanna, non avrà garanzie sulla reintegrazione del proprio
bene immobile, posto che l’esiguità delle pene previste per i reati indicati e
le mille vie d’uscita che offre il sistema penale, si presta a beffare
nuovamente la povera vittima, anche laddove si sia costituita parte civile.
Laddove poi l’abusivo trascini nell’immobile occupato la propria famiglia, con
prole minorenne, le possibilità di vedersi restituire la propria abitazione
scendono drasticamente, in virtù dei vari meccanismi presenti tanto sotto il
profilo civilistico, quanto di quello penalistico.
La mancanza di
tutela per la vittima è evidente in tutta la sua ingiustizia. Essa diventa
ancora più oltraggiosa quando le vittime sono i soggetti deboli, soprattutto,
come accade spesso, gli anziani. Che fare ? Nell’attesa che ciò si compia, ove
si ritenga che il nostro “Sistema Giudiziario” sembri tutelare solo i criminali,
può osservarsi che esso può tutelare anche le vittime, laddove siano costrette a
convertirsi, per “necessità” di sopravvivenza e per autotutela. In effetti,
occorre osservare che, il nostro ordinamento penale, che di recente ha anche
ampliato la portata applicativa della scriminante della legittima difesa nelle
ipotesi di violazione di domicilio (art. 52 c.p., come mod. l. 13.2.2006 n. 59),
non consente che una persona ultrasettantenne possa subire una misura custodiale
in carcere (artt. 275 co. 4° c.p.p. e 47 ter, l. 354/1975). Conseguentemente,
solamente laddove l’anziano ultrasettantenne, spinto dall’amarezza, trovasse il
coraggio di commettere omicidio nei confronti di tutti coloro che, senza
scrupoli, lo abbiano indebitamente spogliato della propria abitazione, potrebbe
rientrare immediatamente nel possesso della propria abitazione, con la sicurezza
che, il nostro sistema giudiziario, gli garantirebbe una doverosa permanenza in
essa attraverso gli arresti o la detenzione domiciliare. Contraddizioni di
questa nostra Italia !!!
"Esci di casa
e te la occupano… e alla Cassazione va bene così" ha titolato un quotidiano
commentando una sentenza della Cassazione che avrebbe di fatto legittimato
l'occupazione abusiva degli alloggi. L'articolo riportava le affermazioni di un
sedicente funzionario dell'ex Istituto autonomo case popolari (Iacp) che
consigliava all'assegnatario di un alloggio di mettere una porta blindata perché
"Se sua mamma e suo papa vanno in ferie un paio di settimane, poi arrivano degli
abusivi, quelli sfondano, mettono fuori i mobili, ci mettono i loro, e nessuno
ha il potere di sgomberarli… Non ci si crede, ma è così". Ed infatti non bisogna
credergli… Non è così, scrive “Sicurezza Pubblica”. Gli ipotetici abusivi di cui
sopra commettono il reato di violazione di domicilio, e la polizia giudiziaria
deve intervenire d'iniziativa per "impedire che venga portato a conseguenze
ulteriori" (art. 55 cpp) allontanando (anche con la forza) i colpevoli dai
locali occupati contro la legge. Il secondo comma dell'art. 614 cp commina (cioè
minaccia) la pena della reclusione fino a tre anni a chiunque si trattenga
nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora, o nelle
appartenenze di essi, contro la volontà espressa di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. La pena è da
uno a cinque anni (arresto facoltativo, dunque) e si procede d'ufficio se il
fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, o se il colpevole è
palesemente armato. Il reato è permanente. Perciò possiamo andare
tranquillamente in ferie perché se qualcuno viola il nostro domicilio forzando
la porta o una finestra, la polizia giudiziaria è obbligata a liberare
l'alloggio ed il colpevole può essere arrestato. Quali potrebbero essere le
responsabilità della polizia giudiziaria, che eventualmente omettesse o
ritardasse l'intervento? Secondo l'art. 55 c.p.p. la p.g. deve (obbligo
giuridico) impedire che i reati vengano portati a ulteriori conseguenze, mentre
secondo l'art, 40 comma 2 del c.p.: "Non impedire un evento che si ha l'obbligo
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". Perciò le ulteriori conseguenze
dell'occupazione potrebbero essere addebitate ai responsabili del ritardo o
dell'omissione.
Cosa ha
veramente la Cassazione?
L'equivoco è
nato dalla errata lettura della sentenza 27 giugno - 26 settembre2007, n. 35580,
in cui la suprema Corte ha trattato il caso di una persona che, denunciata per
aver occupato abusivamente un alloggio ex Iacp vuoto, aveva invocato l'esimente
dello stato di necessità previsto dall'art. 54 cp, ma era stata condannata. La
Corte non ha affatto legittimato il reato, ma si è limitata ad annullare la
sentenza d'appello con rinvio ad altro giudice, ritenendo che fosse stata omessa
la dovuta indagine per verificare se l'esimente stessa sussistesse o meno. Nulla
di rivoluzionario dunque, ma applicazione di un principio: quando il giudice
ravvisa l'art. 54 cp, il reato sussiste, ma "non è punibile chi ha commesso il
fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla persona". In quest'ottica, giova
rammentare la sentenza 9265 del 9 marzo 2012, che ha definitivamente
fatto chiarezza (qualora ce ne fosse stato bisogno). La Cassazione ha respinto
il ricorso di una 43enne contro la sentenza del giudice di merito che aveva
ritenuto la donna colpevole del reato di cui agli articoli 633 e 639 bis Cp per
avere abusivamente occupato un immobile di proprietà dello Iacp di Palermo. La
seconda sezione penale, confermando la condanna, ha escluso lo stato di
necessità precisando che in base all’articolo 54 Cp per configurare questa
esimente (la cui prova spetta all’imputato che la invoca), occorre che «nel
momento in cui l’agente agisce contra ius - al fine di evitare un danno grave
alla persona - il pericolo deve essere imminente e, quindi, individuato e
circoscritto nel tempo e nello spazio. L’attualità del pericolo esclude quindi
tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti caratterizzate da una sorta
di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo». Nell' ipotesi
dell’occupazione di beni altrui, lo stato di necessità può essere invocato
soltanto per un pericolo attuale e transitorio non certo per sopperire alla
necessità di risolvere la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi
Iacp sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti,
attraverso procedure pubbliche e regolamentate. In sintesi: una precaria e
ipotetica condizione di salute non può legittimare, ai sensi dell’articolo 54
Cp, un’occupazione permanente di un immobile per risolvere, in realtà, in modo
surrettizio, un’esigenza abitativa.
Sequestro
preventivo dell'immobile occupato abusivamente.
La sussistenza
di eventuali cause di giustificazione non esclude l'applicabilità della misura
cautelare reale del sequestro preventivo. D'altronde la libera disponibilità
dell'immobile comporterebbe un aggravamento o una protrazione delle conseguenze
del reato, che il sequestro preventivo mira invece a congelare. (Corte di
Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 7722/12; depositata il 28 febbraio). Il
caso. Due indagati del reato di invasione e occupazione di un edificio di
proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari ricorrevano per cassazione
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce, che confermava il
sequestro preventivo dell'immobile disposto dal GIP. A sostegno della loro tesi
difensiva, gli indagati introducevano un elemento afferente il merito della
responsabilità penale, sostenendo come fosse documentato lo stato di assoluta
indigenza in cui versavano, tale da averli costretti ad occupare l'immobile per
la necessità di evitare un danno maggiore alla loro esistenza e salute. In
sostanza, invocavano lo stato di necessità che, secondo la tesi difensiva,
avrebbe non solo giustificato l'occupazione, ma che avrebbe potuto determinare
una revoca del provvedimento cautelare disposto…non opera per le misure
cautelari reali. La Suprema Corte esamina la censura, ma la rigetta perché, nel
silenzio della legge, non può applicarsi la regola - prevista dall'art. 273
comma 2 c.p.p. per le sole misure cautelari personali - che stabilisce che
nessuna misura (personale) può essere disposta quando il fatto è compiuto in
presenza di una causa di giustificazione, quale appunto l'invocato stato di
necessità. L'ordinanza impugnata ha chiarito che i due indagati hanno
abusivamente occupato un alloggio già assegnato ad altra persona, poi deceduta,
e ha correttamente rilevato che è del tutto irrilevante la circostanza che nel
lontano 1983 il B. sia stato assegnatario di un altro alloggio del cui possesso
sarebbe stato spogliato. Se queste sono le circostanze di fatto non è
ravvisabile alcuna violazione di legge, ma solo una diversa valutazione dei
fatti stessi non consentita in questa sede di legittimità, per di più con
riferimento a misure cautelari reali (art. 325, comma 1, c.p.p.). Per quanto
concerne la sussistenza della dedotta causa di giustificazione, se è vero che,
in tema di misure cautelari personali, ai sensi dall'art. 273, comma 2, cod.
proc. pen., nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato
compiuto in presenza di una causa di giustificazione, l'applicabilità di una
analoga normativa con riferimento alle misure cautelari reali, in assenza di
espressa previsione di legge, deve tenere conto dei limiti imposti al Tribunale
in sede di riesame, nel senso che la verifica delle condizioni di legittimità
della misura cautelare reale da parte del tribunale del riesame non può tradursi
in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità
della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di
investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la
fattispecie concreta e quella legale (per tutte: Sez. U, n. 7 del 23/02/2000,
Bocedi, Rv. 215840). È evidente, pertanto, che una causa di giustificazione può
rilevare nell'ambito del procedimento relativo a misure cautelari reali solo se
la sua sussistenza possa affermarsi con un ragionevole grado di certezza. Anche
sulla sussistenza del periculum in mora l'ordinanza impugnata, espressamente
pronunciandosi sul punto, afferma che la libera disponibilità da parte degli
indagati dell'immobile in questione comporterebbe un aggravamento o una
protrazione delle conseguenze del reato commesso. Al rigetto del ricorso
consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condotta e
dolo specifico.
L'articolo 633
cp stabilisce che "Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui,
pubblici o privati, al fine di occuparli o trame altrimenti profitto è punito a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa.
Si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una
almeno palesemente armata, o da più di dieci persone anche senz'armi". Si
procede altresì d'ufficio (art. 638 bis c.p.) se si tratta di acque, terreni,
fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico. Perché sussista il reato,
occorre che l'agente penetri dall'esterno nell'immobile (anche senza violenza) e
ne violi l'esclusività della proprietà o del possesso per una apprezzabile
durata, contro la volontà del titolare del diritto o senza che la legge
autorizzi tale condotta. Questo reato non consiste nel semplice fatto di
invadere edifici o terreni altrui, ma richiede il dolo specifico, cioè la
coscienza e volontà di invaderli al fine di occuparli o trame altrimenti
profitto. Non occorre neppure l'intenzione dell'occupazione definitiva, anche se
essa deve avere una durata apprezzabile. In caso di immobile già invaso, è
possibile il concorso successivo di persone diverse dai primi autori
dell'invasione (Cass. pen., Sez. Il, sent. 22 maggio 1975, n. 5459). Quanto al
reato di violazione di domicilio, previsto dall'art. 614 del C.P., esso è
ravvisabile anche "nella condotta di abusiva introduzione (o abusiva permanenza)
nei locali di una guardia medica fuori dell'orario ordinario di apertura al
pubblico per l'assistenza sanitaria. Infatti, se nell'orario ordinario di
servizio la guardia medica è aperta al pubblico, nell'orario notturno l'acceso è
limitato a quelli che hanno necessità di assistenza medica e che quindi sono
ammessi all'interno dei locali della stessa. Pertanto in questo particolare
contesto l'ambiente della guardia medica costituisce un'area riservata che può
assimilarsi a quella di un temporaneo privato domicilio del medico chiamato a
permanere lì durante la notte per potersi attivare, ove necessario, per
apprestare l'assistenza sanitaria dovuta" (Cass. pen. Sez. III, sent. 6 giugno -
30 agosto 2012, n. 33518, in Guida al diritto n. 39 del 2012, pag. 88).
Flagranza e
procedibilità d'ufficio.
Il reato
d'invasione di terreno o edifici ha natura permanente e cessa soltanto con
l'allontanamento del soggetto dall'edificio, o con la sentenza di condanna, dato
che l'offesa al patrimonio pubblico perdura sino a che continua l'invasione
arbitraria dell'immobile. Dopo la pronuncia della sentenza, la protrazione del
comportamento illecito da luogo a una nuova ipotesi di reato, che non necessita
del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione
dell'occupazione (Cass. pen., Sez. Il, sent. 22 dicembre 2003, n. 49169). Nella
distinzione tra uso pubblico e uso privato, una recente pronuncia ha affermato
che "l'alloggio realizzato dall'Istituto autonomo delle case popolari (lacp),
conserva la sua destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la
consegna all'assegnatario, cui non abbia ancora fatto seguito il definitivo
trasferimento della proprietà. Ne deriva che, in tale situazione, l'eventuale
invasione ad opera di terzi dell'alloggio medesimo è perseguibile d'ufficio, ai
sensi dell'art. 639 bis cp" (Cass. pen., Sez. Il, 12 novembre 2007, n. 41538).
In caso di invasione arbitraria di edifici costruiti da un appaltatore per conto
dell'ex lacp e non ancora consegnati all'Istituto, la persona offesa, titolare
del diritto di querela è l'appaltatore. Ai fini della procedibilità d'ufficio
del reato di cui all'art. 633 c.p., l'uso della disgiuntiva nell'art. 633-bis
(edifici pubblici o destinati a uso pubblico) pone il carattere pubblico come di
per sè sufficiente a configurare la procedibilità d'ufficio, nel senso che è
sufficiente che l'edificio sia di proprietà di un ente pubblico. A tal fine, si
devono considerare pubblici, secondo la nozione che il legislatore penale ha
mutuato dagli articoli 822 e seguenti del Cc, i beni appartenenti a qualsiasi
titolo allo stato o a un ente pubblico, quindi non solo i beni demaniali, ma
anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti
predetti. Mentre, sempre per la procedibilità d'ufficio, sono da considerare
"destinati a uso pubblico" quegli altri beni che, pur in ipo0tesi appartenenti a
privati, detta destinazione abbiano concretamente ricevuto
(Corte Appello di Palermo, sent. 20-22 giugno 2011,n. 2351 in
Guida al diritto n. 46 del 19 novembre 2011).
L'art. 634
c.p. - Turbativa violenta del possesso di cose immobili.
Chiunque,
fuori dei casi indicati nell'articolo 633 c.p., turba, con violenza alla persona
o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309. Il fatto si
considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci
persone. La maggior parte della dottrina ritiene che l'unica distinzione
possibile sia quella che fa perno sull'elemento soggettivo: mentre nell'art. 633
è previsto il dolo specifico, per l'art. 634 è sufficiente il dolo generico. Di
conseguenza si dovrà applicare l'art. 634 qualora vi sia un'invasione non
qualificata dal fine di occupare i terreno e gli edifici o di trarne altrimenti
profitto. Viceversa sussisterà la fattispecie di cui all'art. 633 anche nel caso
di invasione violenta finalizzata all'occupazione o al profitto. La turbativa di
cui all'art. 634 postula un comportamento minimo più grave della semplice
introduzione (art. 637) e meno grave dell'invasione (art. 633). La nozione di
turbativa deve intendersi come una non pregnante compromissione dei poteri del
possessore. La semplice violenza sulle cose, che non sia usata per coartare
l'altrui volontà, non basta ad integrare il reato. Peraltro il comma 2 dell'art.
634, parifica alla violenza alla persona e alla minaccia, la presenza di un
numero di persone (che commettono il fatto) superiore a dieci. Si discute se si
tratti di un delitto istantaneo o permanente. Prevale l'opinione che ritiene
trattarsi di reato istantaneo, potendo assumere connotazione permanente allorchè
la perturbazione richieda l'esperimento di una condotta prolungata nel tempo,
sostenuta da costante volontà del soggetto agente (Manzini).
Come agire?
Il delitto di
violazione di domicilio è permanente ed ammette l'arresto facoltativo in
flagranza (art. 381, lett. f-bis c.p.p.) Anche il delitto di invasione al fine
di occupazione (art. 633 c.p.) è permanente: la condotta criminosa perdura per
tutto il tempo dell'occupazione e deve essere interrotta dalla polizia
giudiziaria, che anche di propria iniziativa deve impedire che i reati vengano
portati a ulteriore conseguenze (art. 55 cpp). Non appena i titolari del diritto
sull'alloggio danno notizia dell'avvenuta invasione agli organi di pg questi
ultimi, se dispongono delle forze necessarie, debbono procedere allo sgombero,
senza necessità di attendere il provvedimento dell'Autorità. In ambedue i casi
spetta al giudice valutare poi l'esistenza di eventuali esimenti.
Inerente
l'occupazione abusiva di un immobile, pare opportuno inserire una breve
digressione sulle azioni a tutela dei diritti di godimento e del possesso. Il
panorama si presenta alquanto vario; troviamo, infatti, le azioni concesse al
solo proprietario, quelle esperibili dal titolare di un diritto di godimento su
cosa altrui o dal possessore in quanto tale. Tali azioni vengono qualificate
come reali, in quanto offrono tutela per il solo fatto della violazione del
diritto.
L'azione di
rivendicazione, rientrante fra le azioni petitorie, tende ad ottenere il
riconoscimento del diritto del proprietario sul bene e presuppone la mancanza
del possesso da parte dello stesso; è imprescrittibile e richiede la
dimostrazione del proprio diritto risalendo ad un acquisto a titolo originario.
L'azione
negatoria è concessa al proprietario al fine di veder dichiarata l'inesistenza
di diritti altrui sulla cosa o la cessazione di turbative o molestie; in questo
caso al proprietario si richiede soltanto la prova, anche in via presuntiva,
dell'esistenza di un titolo dal quale risulti il suo acquisto.
L'azione di
regolamento di confini mira all'accertamento del proprio diritto nel caso in cui
siano incerti i confini dello stesso rispetto a quello confinante; in tale
ipotesi la prova del confine può essere data in qualsiasi modo. Nell'azione di
apposizione di termini, al contrario, ciò che si richiede al Giudice è
l'individuazione, tramite indicazioni distintive, dei segni di confine tra due
fondi confinanti.
L'azione
confessoria è volta a far dichiarare l'esistenza del proprio diritto contro chi
ne contesti l'esercizio, e a far cessare gli atti impeditivi al suo svolgimento.
A difesa del
possesso incontriamo le categorie delle azioni possessorie e di enunciazione: le
prime si distinguono nell'azione di reintegrazione, che mira a far recuperare il
bene a chi sia stato violentemente o clandestinamente spogliato del possesso, da
proporsi entro un anno dallo spoglio, e l'azione di manutenzione, proposta al
fine di far cessare le molestie e le turbative all'esercizio del diritto.
L'azione di
manutenzione, al contrario di quella di reintegrazione, ha una funzione
conservativa, poiché mira alla cessazione della molestia per conservare integro
il possesso, e una funzione preventiva, poiché può essere esperita anche verso
il solo pericolo di una molestia. Diversamente dalle azioni a difesa della
proprietà, che impongono la prova del diritto, il possessore ha soltanto l'onere
di dimostrare il possesso (in quanto questo prescinde dall'effettiva titolarità
del diritto). Le azioni di enunciazione, con le quali si tende alla eliminazione
di un pericolo proveniente dal fondo vicino, si distinguono nella denunzia di
nuova opera e di danno temuto; esse, infatti, vengono qualificate come azioni
inibitorie, cautelari, che possono dar luogo a provvedimenti provvisori.
ITALIA.
SOLIDARIETA’ TRUCCATA E DI SINISTRA.
Ma come
sono cari (e di sinistra) i professionisti dell'accoglienza.
L'emergenza sbarchi comporta un giro vorticoso di denaro pubblico. Che si ripete
senza soluzione, scrive Stefano Filippi su “Il Giornale”. Dietro l'orrore, la
pietà, lo scandalo, il buonismo, le tragedie del mare nascondono il business che
non t'aspetti. Il giro d'affari del primo soccorso e dell'accoglienza. Da una
parte i milioni di euro stanziati dall'Europa e dall'Italia, dall'altra la
pletora di personaggi in attesa di incassare. Onlus, patronati, cooperative,
professionisti dell'emergenza, noleggiatori di aerei e traghetti, perfino i
poveri operatori turistici di Lampedusa: abbandonati dai vacanzieri si
rassegnano a riempire camere d'albergo, appartamenti e ristoranti con agenti,
volontari, giornalisti, personale delle organizzazioni non governative, della
Protezione civile, della Croce rossa. L'emergenza sbarchi comporta un giro
vorticoso di denaro pubblico. Nel 2011, l'anno più drammatico, gli sbarchi
provocati dalle sanguinose rivolte nordafricane sono costati all'Italia un
miliardo di euro. Ogni giorno le carrette del mare da Libia e Tunisia hanno
scaricato in media 1.500 persone. Il governo dovette aumentare le accise sui
carburanti per coprire parte di queste spese. E a qualcuno che sborsa
corrisponde sempre qualcun altro che incassa. Bisogna gestire la prima
accoglienza: acqua, cibo, vestiti, coperte, farmaci. Vanno organizzati i
trasferimenti sul continente ed eventualmente i rimpatri; si aggiungono spese
legali, l'ordine pubblico, l'assistenza (medici, psicologi, interpreti,
mediatori culturali). Ma questo è soltanto l'inizio, perché moltissimi rifugiati
chiedono asilo all'Italia. E l'Italia se ne fa carico, a differenza della Spagna
che ordina di cannoneggiare i barconi e di Malta che semplicemente abbandona i
disperati al loro destino. Nel triennio 2011/13 le casse pubbliche (ministero
dell'Interno ed enti locali) hanno stanziato quasi 50 milioni di euro per
integrare 3000 persone attraverso il Sistema di protezione per i richiedenti
asilo e rifugiati. A testa fanno più di 5.000 euro l'anno. L'Europa soccorre
soltanto in parte. Il finanziamento più cospicuo arriva dal Fondo europeo per le
frontiere esterne destinato alle forze di sicurezza di confine (capitanerie di
porto, marina militare, guardia di finanza): 30 milioni annui. Altri 14,7
milioni arrivano dal Fondo per l'integrazione, non riservato all'emergenza. Dal
Fondo per i rimpatri piovono 7 milioni di euro. Poi c'è il Fondo per i
rifugiati, che nel 2012 ha stanziato 7 milioni in via ordinaria più altri 5 per
misure di emergenza. Tutti questi denari vanno considerati come
co-finanziamento: si aggiungono cioè ai soldi che l'Italia deve erogare. Il
fondo più interessante è quello per i rifugiati, che è tale soltanto di nome
perché i veri destinatari dei 12 milioni di euro (sono stati 10 milioni nel
2008, 4,5 nel 2009, 7,2 nel 2010 e addirittura 20 nel fatidico 2011) sono Onlus,
Ong, cooperative, patronati sindacali e le varie associazioni umanitarie che si
muovono nel settore dell'immigrazione. Dal 2008, infatti, l'Europa ha stabilito
che quel fiume di contributi vada «non più all'attività istituzionale per
l'accoglienza, ma ad azioni complementari, integrative e rafforzative di essa».
Anche queste, naturalmente, co-finanziate dal governo italiano. Le
organizzazioni operano alla luce del sole, sono autorizzate dal ministero
dell'Interno che deve approvare progetti selezionati attraverso concorsi
pubblici. I soldi finiscono in fondi spese destinati non ai disperati ma a vitto
e alloggio delle truppe di volontari e professionisti. Per la felicità degli
albergatori lampedusani. Gli operatori sociali spiegano ai nuovi arrivati i loro
diritti. Li mettono in contatto con interpreti, avvocati, mediatori da essi
retribuiti. Organizzano la permanenza, li aiutano a restare in Italia o a capire
come proseguire il loro viaggio della speranza. Fanno compilare agli sbarcati,
che per la legge sono clandestini, un pacco di moduli per avere assistenza
legale d'ufficio. Pochissime organizzazioni, e tra queste Terre des hommes e
Medici senza frontiere, si fanno bastare i denari privati. A tutte le altre i
soldi italo-europei servono anche a sostenere i rispettivi apparati, come gli
uffici stampa, gli avvocati e gli attivisti per i diritti umani, per i quali
martellare i governi finanziatori è una vera professione. E magari usano
l'emergenza immigrazione come trampolino verso la politica.
Destra,
sinistra e solidarietà.
Come ci segnala un articolo de Il Redattore Sociale, la presenza del Terzo
Settore nelle liste dei candidati alle prossime elezioni è piuttosto
significativa: presidenti e direttori di molte importanti organizzazioni si
presentano nelle liste di PD, SEL, Ingroia e Monti. Questo scrive Gianni Rufini
su “La Repubblica”. Gianni Rufini, esperto di aiuto umanitario, ha lavorato
in missioni di assistenza in quattro continenti e insegna in numerose università
italiane e straniere. Se saranno eletti, buona parte dell’associazionismo e
del movimento cooperativo dovrà rinnovare i propri vertici. Molto meno forte, la
presenza del mondo della solidarietà internazionale. Ci sono personalità di
rilievo, come gli ottimi Laura Boldrini e Giulio Marcon, ma non abbastanza –
temo – da far nascere all’interno del parlamento un nucleo significativo di
deputati e senatori che possano promuovere un rinnovamento della politica
italiana in questo senso. Ma speriamo bene. Tutte queste persone si candidano
con partiti di sinistra o di centro, mentre la destra è completamente assente.
Se è vero che la sinistra è sempre stata più attenta a questi temi, sono
profondamente convinto che questioni come la cooperazione, l’aiuto umanitario o
i diritti umani siano assolutamente trasversali. Possono esserci visioni diverse
sulle politiche in questi campi, ma dovrebbe esserci un’intesa di fondo per
questioni che riguardano tutti i cittadini, di qualunque orientamento, in ogni
regime politico. Purtroppo non è così. In altri paesi, esiste un
“conservatorismo compassionevole” che ritiene moralmente doveroso impegnarsi in
questi ambiti; si trovano politiche estere di destra che vedono comunque nella
cooperazione uno strumento fondamentale; ci sono politiche sociali conservatrici
che promuovono il volontarismo per ridurre il peso dello Stato; ci sono visioni
del capitalismo che ritengono centrali, per il suo sviluppo, i diritti umani.
Nella destra italiana sembra invece prevalere una visione che definirei
“cattivista”. Sembra che da noi, per essere di destra bisogna necessariamente
coltivare cattivi sentimenti: l’irrisione per i poveri, l’avidità, lo sprezzo
del senso civico, il calpestamento dei diritti altrui. Cosa particolarmente
strana, in un paese che ha una forte cultura cattolica e una storia importante
di solidarietà unitaria, per esempio nei grandi disastri. E’ difficile
comprendere la mutazione che ha portato la destra italiana a questa deriva
antropologica. Forse è un altro dei residuati tossici dell’ultimo ventennio.
Questo è un problema per l’Italia, per due ragioni: la prima è che quando si
parla di diritti, di umanità, di relazioni con il mondo, si parla dell’identità
profonda di un paese, e questa dovrebbe essere in massima parte condivisa dalle
forze politiche. E poi, perché le strategie in questo campo esigono tempi
lunghi, per produrre risultati, tempi di decenni. E non possono scomparire e
ricomparire ad ogni cambio di governo. Credo che il lavoro più importante che
dovranno fare quei colleghi che hanno deciso di impegnarsi in politica sia
promuovere un cambiamento culturale dentro la politica, dentro il
parlamento. Perché certi principi e certi valori diventino un patrimonio
condiviso, al di là delle differenze ideologiche.
LA GUERRA
TRA ASSOCIAZIONI ANTIRACKET.
“L’efficienza
delle associazioni antimafia non si misura in fase ai finanziamenti ricevuti,
alle denunce presentate, alla parte politica che li sostiene, alla visibilità
data dai media ed alla santificazione di toghe e divise” risponde così il dr
Antonio Giangrande alle dichiarazioni di Maria Antonietta Gualtieri presidente
dell’Associazione Antiracket Salento (…a Brindisi totale assenza di denunce
nonostante tante associazioni antimafia…) ed alla piccata risposta del
presidente Salvatore Incalza dell’associazione antiracket di Francavilla Fontana
associata FAI (..cerca visibilità perché cessa il foraggiamento di Stato…). Il
Dr Antonio Giangrande, presidente nazionale della “Associazione Contro Tutte le
Mafie” da Taranto interviene nella polemica su stampa e tv sorta tra le
associazioni antiracket ed antiusura brindisine e leccesi. Una polemica che
serpeggia, però, in tutta Italia, laddove vi sono costituiti sodalizi antimafia
di contrapposti schieramenti. «L’attività delle associazioni antiracket ed
antiusura non si misura in base alla visibilità mediatica che certe tv locali
politicamente schierate danno ad alcune di loro, finanziate da progetti di
passati Ministri dell’Interno o da sottosegretari a loro vicini e comunque di
finanziamenti ricevuti perché facenti parte del FAI o di Libera; né tantomeno in
base alle denunce presentate da questi sodalizi o dalla loro costituzione in
giudizio per interesse di qualcuno. Il tutto per fare numero e molte volte
contro poveri cristi a vantaggio di truffatori. Sempre bene attenti a non
toccare i poteri forti: tra cui le banche. La loro efficienza non si misura
neanche in base al sostegno finanziario da loro ricevuto dallo Stato o da una
parte politica regionale. Comunque c’è da dire che il grado di valore che si dà
alle associazioni antimafia non è paragonato al fatto di quanto queste siano lo
zerbino o passacarte di toghe e divise. La capacità delle associazioni è legata
alla loro competenza ed al grado di assistenza e consulenza che loro sanno
offrire: senza fare politica. Questo è il loro compito: informare ed assistere
nella stesura degli atti. Le denunce le presentano le presunte vittime e
l’applicazione della giustizia spetta alle toghe ed i contributi li elargisce lo
Stato. Qualcuno non si deve allargare!». Va giù duro il presidente Antonio
Giangrande. « Io penso che la vittima di qualsivoglia sopraffazione e violenza
non ha bisogno di visibilità, per questo noi usiamo il web oltre che la sede
fissa. In questo modo le vittime non hanno bisogno di farsi vedere, quindi si
informano e le denunce le scaricano direttamente dal sito e le presentano alle
forze dell’ordine. Non mancano, però, le lamentele di abbandono da parte dello
Stato. E questo non bisogna tacerlo. Inoltre non siamo affiliati a nessuno e
quindi non riceviamo nulla da alcuno, né ritorno di immagine, né copertura delle
spese. D’altronde che volontariato è se poi si è sovvenzionati e quindi diventa
un lavoro. Alla stampa dico di seguire ed aiutare tutte quelle associazioni che
lavorano sul campo a rischio delle vite dei loro componenti, senza ricevere
nulla. E se proprio vogliono riportare le polemiche, i giornalisti chiedessero a
tutte queste associazioni, che vanno per la maggiore, chi li paga e chi votano e
come mai aprono sportelli antiracket in città in cui non sono iscritte presso le
locali prefetture, così come vuole la legge, tutto a svantaggio di chi è
legalmente iscritto in loco: se ne scoprirebbero delle belle!» Continua Antonio
Giangrande. «Additare i difetti altrui è cosa che tutti sanno fare, più
improbabile è indicare e correggere i propri. Non abbiamo bisogno di eroi, né,
tantomeno, di mistificatori con la tonaca (toga e divisa). L’abito non fa il
monaco. La legalità non va promossa solo nella forma, ma va coltivata anche
nella sostanza. E’ sbagliato ergersi senza meriti dalla parte dei giusti. Se
scrivi e dici la verità con il coraggio che gli altri non hanno, il risultato
non sarà il loro rinsavimento ma l’essere tu additato come pazzo. Ti scontri
sempre con la permalosità di magistrati e giornalisti e la sornionità degli
avvocati avvezzi solo ai loro interessi. Categorie di saccenti che non ammettono
critiche. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Questa è
sociologia storica, di cui sono massimo cultore. Conosciuto nel mondo come
autore ed editore della collana editoriale “L’Italia del Trucco, l’Italia che
siamo” pubblicata su www.controtuttelemafie.it ed altri canali web, su Amazon in
E-Book e su Lulu in cartaceo, oltre che su Google libri. 50 saggi pertinenti
questioni che nessuno osa affrontare. Ho dei canali youtube e sono anche editore
di Tele Web Italia: la web tv di promozione del territorio italiano. Bastone e
carota. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!»
Il livore
del PD, SEL, CGIL e di tutta la loro costellazione di sigle nel Lazio nei
confronti dell’Associazione Caponnetto.
Perché? Preferiscono forse un’antimafia del bon ton diversa dalla nostra di
indagine e denuncia? O avrebbero voluto che ci etichettassimo politicamente
assoggettandoci ai loro interessi e facendo un’antimafia soft, più retorica e
commemorativa, di parata insomma? Questo di chiede l’Associazione antimafia
“Antonino Caponnetto”. Non che ci dispiaccia. Anzi, è tutto il contrario perché
più stiamo lontani da queste nomenclature politiche screditate e più guadagniamo
in credibilità. Pur tuttavia certe cose vanno annotate per far comprendere ai
più sprovveduti e disinformati fino a che punto arrivano la bassezza, la
vuotaggine, l’insulsaggine, l’insignificanza e l’irresponsabilità della classe
dirigente del PD e del suo accoliti nella provincia di Latina e nel Lazio. Sono
oltre 10 anni che il PD del Lazio e della provincia di Latina fa la guerra
all’Associazione Caponnetto mostrando, peraltro, in maniera sfacciata di voler
privilegiare Libera e solo Libera ed il suo modo di fare antimafia. Non abbiamo
mai capito le ragioni di tanta ostilità. Forse perché abbiamo sempre dichiarato
la nostra assoluta indipendenza da tutto e da tutti mentre il PD voleva che noi
ci fossimo etichettati politicamente ed assoggettati ai suoi interessi? O perché
il PD preferisce un modello di antimafia tutto bon ton, all’acqua di rose,
culturale e basta, commemorativo e parolaio e niente affatto di indagine e
denuncia, nomi e cognomi, come facciamo noi dell’Associazione Caponnetto? Non lo
sappiamo e, a questo punto, nemmeno ci interessa saperlo più perché abbiamo
preso atto di un dato di fatto incontrovertibile e consolidato: il PD ed i suoi
accoliti combattono l’Associazione Caponnetto e riconoscono come propria
referente ed amica solo LIBERA. Bene così per il PD, per tutti i suoi accoliti e
per Libera. Se questa è l’antimafia che vuole il PD vadano avanti così ma non
osino più parlare di lotta alle mafie perché li talloneremo e gli rinfacceremo
di volta in volta che la lotta alle mafie non si fa come fanno lor signori che
si limitano solo a parlarne senza affrontare e risolvere i problemi veri della
lotta alla criminalità mafiosa. Brutto segnale quello che viene da questo
partito che dimostra palesemente di non volere l’antimafia reale, quella
effettiva, la vera antimafia, ma solo quella di parata, delle commemorazioni,
del racconto del passato e via di questo passo. La guerra all’Associazione
Caponnetto viene da lontano, dai tempi della Giunta Marrazzo alla Regione Lazio
quando la Presidente della Commissione Criminalità -la PD ex DS Luisa Laurelli –
volle escludere dai vari organismi consultivi della Regione la nostra
Associazione facendo, al contempo, entrarvi sigle assolutamente inconsistenti ed
esistenti solo sulla carta ma etichettate PD, oltre ovviamente a Libera. Cosa
che si è ripetuta puntualmente all’Amministrazione Provinciale di Roma sotto la
gestione Zingaretti, altro campione dell’antimafia parolaia e non di quella
reale dell’indagine e della denuncia. Non che le nostre ripetute esclusioni ci
siano dispiaciute, vista l’assoluta inutilità ed inerzia di tali organismi che
si sono appalesate a posteriori come delle sole sparate propagandistiche senza
alcuna efficacia. Evitiamo, per non tediare coloro che ci seguono, di raccontare
i dettagli, i continui tentativi di isolarci (dal convegno organizzato sempre
dal PD con Piero Grasso durante l’ultima campagna elettorale, con la
partecipazione della Fondazione nostra omonima, a sostegno della candidatura
dell’ex Procuratore Nazionale antimafia, convegno che, pur avendo visto la
nostra esclusione - e ne siamo stati lieti perché era un convegno elettorale e
di partito -, i relatori si sono visti costretti ad esaltare proprio l’opera
dell’Associazione Caponnetto!!!; all’ultima proprio di stamane 21 giugno con il
convegno promosso a livello provinciale e sempre a Gaeta dal Sindacato
Pensionati Italiani della CGIL sui problemi della legalità, un convegno che ha
visto la partecipazione in massa di elementi di Libera e basta). Potremmo citare
altri esempi della faziosità – e, peraltro, anche dell’ottusità politica- della
classe dirigente del PD e dei suoi accoliti di SEL (vi risparmiamo di
raccontarvi il comportamento inqualificabile di Zaratti uomo di punta di SEL il
quale durante una seduta della Commissione criminalità della Regione Lazio della
quale era Presidente dopo la Laurelli non spese una sola parola in difesa
dell’Associazione Caponnetto aggredita violentemente dal suo vicepresidente, un
consigliere di destra di cui non ricordiamo il nome, quasi a mostrare un
malcelato piacere -, della CGIL e così via. Ma tutto ciò non ci duole affatto.
Anzi, il contrario. Perché tutto questo livore nei nostri confronti da parte del
PD, SEL e di tutta la loro costellazione di sigle e siglette nei nostri
confronti sta a provare che agiamo bene, che colpiamo bene, senza lacci e
lacciuoli e che sono sempre di più coloro che hanno paura di noi in quanto
probabilmente sanno di avere qualche scheletro nell’armadio. Questo ovviamente
ci ha fatto accendere una lampadina e ci induce a porci la domanda del “perché”
di tale comportamento… Quando il cane ringhia rabbioso a difesa di una tana vuol
dire che là dentro nasconde qualcosa di importante, la nidiata, un pezzo di
carne… Ci lavoreremo… per scoprirlo. Poi, però, non si dica che siamo… cattivi
o, peggio, faziosi anche noi.
“LIBERA”
di nome ma non di fatto.
E’ solo un problema politico, scrive l'associazione antimafia "Casa della
legalità e della cultura Onlus della sicurezza sociale". E' difficile che le
cose che non funzionano vengano indicate quando riguardano quelli che sono una
sorta di “santuari” della cosiddetta società civile. Eppure le distorsioni, i
problemi, anche seri, ci sono. Sono fatti che, messi uno accanto all'altro, ci
dicono che qualcosa non va. Rompiamo questo silenzio, ponendo alcune semplici
domande e dando a queste una risposta. Non è per polemica, ma per dovere di
cronaca, per elencare i fatti di una questione “politica”. Siamo convinti che
solo guardando in faccia la realtà sia possibile migliorare e correggere quegli
errori che troppo spesso impediscono di fare passi avanti nella lotta alle mafie
ed all'illegalità. Il confronto e non la chiusura è strumento essenziale nella
democrazia, e lo è ancora di più quando si parla di strutture importanti, come è
Libera...
Perché criticate “LIBERA”,
che universalmente è riconosciuta, da destra a sinistra, quale grande
organizzazione antimafia?
«Innanzitutto
bisogna premettere che la critica è costruttiva, finalizzata al confronto per
risolvere i problemi. Criticare non significa distruggere e questo è ancora più
indiscutibile quando, come nel nostro caso, la critica è un elencare di fatti
che non si possono tacere ma che impongono, dovrebbero imporre, una riflessione
e quindi una reazione. Quindi... Avete mai sentito pronunciare un nome e cognome
di quella “zona grigia”, della rete di professionisti e politici collusi e
contigui, dagli esponenti di Libera che tanto a slogan punta l'indice contro
questa “zona grigia”? Mai, né un nome di un mafioso (se non già condannato in
via definitiva), né un nome di una società di famiglie mafiose, né il nome dei
politici che nei vari territori sono compromessi, vuoi per contiguità (che non è
un reato) o peggio. Mai un nome delle grandi imprese e cooperative che nei
propri cantieri, quali fornitori, scelgono le “offerte vantaggiose” delle
società di note famiglie mafiose. Non c'è una denuncia che sia una, se non “il
giorno dopo” ad un dramma o allo scattare delle manette o dei sigilli a qualche
bene.»
Ma questo può essere solo un
modo diverso di combattere la stessa battaglia...
«Non
è un discussione la “diversità” di metodi, ma i fatti ci testimoniano che la
questione non è solo un diverso modo di agire nella lotta alla mafia...La Libera
che abbiamo visto da qualche anno a questa parte, diversa, radicalmente diversa,
da quella delle origini, ha scelto una strada che, pur qualificandosi come
“antimafia”, di antimafia concreta ha ben poco. Cerchiamo di spiegare... Libera,
con la struttura che si è data, vive grazie ai contributi pubblici e privati.
Tra i suoi sponsor troviamo, ad esempio, l'Unieco, colosso cooperativo emiliano,
che si vanta dei finanziamenti che da a Libera. Ma l'Unieco nei propri cantieri
fa lavorare società di famiglie notoriamente mafiose, per l'esattezza di
'ndranghetisti. I soldi risparmiati dalla Unieco in quei cantieri, con le famose
offerte “economicamente vantaggiose”, ad esempio, di società di famiglie
espressione delle cosche MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI e PIROMALLI con i
GULLACE-RASO-ALBANESE, restano nelle casse di Unieco che poi finanzia Libera per
la lotta alla mafia. E' chiaro il controsenso? La contraddizione è palese.
Libera dovrebbe rifiutare quei fondi ed esigere da Unieco, così come dalle
grandi cooperative della Lega Coop, che non abbia alcun tipo di contiguità e
connivenze con società indecenti! Non lo fa, prende i soldi e fa iniziative al
fianco di Unieco e compagnia nel nome dell'antimafia. Ma vi rendete conto di che
impatto fortissimo avrebbe invece una scelta da parte di Libera di rispedire al
mittente quei contributi con la motivazione: prima fate pulizia tra i vostri
fornitori e poi ci potrete finanziare? Sarebbe un segnale concreto
importantissimo! Non è questione di illeciti, ma di opportunità... di decenza.»
Può essere un caso, non si
può confondere il tutto con un caso.
«Prima
di tutto non è “un caso” ma un questione sistematica e non lo diciamo noi, ma
una serie di fatti. Per esempio, oltre alle grandi cooperative “rosse”, c'è il
caso di Unipol. Oggi sappiamo, grazie alle inchieste su Consorte e furbetti
delle “scalate”, di cosa è capace quel gruppo: azioni spregiudicate, sul crinale
tra lecito e illecito... così come sappiamo che, come le altre grandi banche, ha
una inclinazione nel non notare operazioni sospette che si consumano nelle
propri filiali. Ed anche qui Libera si presenta al fianco di Unipol nel nome
della Legalità, della lotta alla corruzione ed alle mafie. Anche qui: vi
immaginate se quando Unipol o la fondazione Unipolis mandano i contributi a
Libera, l'associazione di don Ciotti rimandasse indietro quei contributi con un
bel comunicato stampa in cui dice che finché le indecenze di Unipol non saranno
eliminare loro non vogliono un centesimo dei loro fondi? Sarebbe un segnale
chiaro, durissimo! E poi vi è il campo più prettamente “politico”. Andiamo anche
in questo caso con esempi concreti. A Casal di Principe il sindaco e l'assessore
con Libera distribuivano targhe anti-camorra, ma quell'amministrazione comunale
era legata alla Camorra, ai Casalesi. Cose che si sanno in quei territori. Il
sindaco e l'assessore sono stati poi arrestati perché collusi con i Casalesi...
Libera li portò sul palco della sua principale manifestazione, nel marzo 2009, a
Casal di Principe, per distribuire le targhe intitolate a don Peppe Diana. Ecco:
Antonio Corvino e Cipriano Cristiano avevano ottenuto il loro bel “paravento”.
Spostiamoci in Sicilia. Nel trapanese, la terra del latitante Matteo Messina
Denaro, è stato arrestato Ciro Caravà. L'accusa: associazione mafiosa. Si
presentava in tv e nelle piazze nel nome di Libera, ma era parte della rete
mafiosa che fa capo al latitante di Cosa Nostra. Libera ha dichiarato che non
era nemmeno tesserato... lo ha dichiarato dopo l'arresto. Prima, dell'arresto,
che costui andasse per mari e per monti a promuovere Libera e la sua azione
antimafia da Sindaco andava bene. Siamo già a due casi eclatanti, pesanti come
macigni, in cui Libera era un “paravento”. Non sono opinioni o interpretazioni,
sono fatti.»
Ma due casi su scala
nazionale sono un’eccezione, non la prassi..
«Drammaticamente
non sono solo due casi in tutta Italia. Questi erano due esempi. Vediamone
qualche altro...Polistena, giornata della Memoria e dell'Impegno di Libera. Sul
palco Libera fa salire, a scandire i nomi delle vittime di mafia, Maria Grazia
Laganà vedova Fortugno. In allora già indagata dalla DDA di Reggio Calabria, per
truffa aggravata allo Stato in merito alle forniture della ASL di Locri...
quella dove la signora era vice-direttore sanitario e responsabile del
personale, quella Asl in cui assunzioni, promozioni, incarichi e appalti erano
decisi dalle 'ndrine, a partire dal “casato” dei MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI...
cosca di cui alcuni esponenti erano in contatto telefonico sia con la Laganà,
sia con Fortugno... e non dimentichiamoci la grande amicizia tra gli stessi
Laganà e Fortugno con i MARCIANO', riconosciuti responsabili dell'omicidio del
Fortugno stesso. E' quella stessa Laganà che subito dopo l'omicidio del marito,
omicidio politico-mafioso, ha promosso una lista elettorale per le elezioni
provinciali con Domenico CREA, indicato da più parti come il grande beneficiario
dell'omicidio Fortugno, nella sua veste di “signore della Sanità” in comunella
con la 'ndrangheta. Poi si scoprì anche che il segretario della Laganà, dal
telefono della signora, comunicava al sindaco di Gioia Tauro, l'avanzamento in
tempo reale del lavoro della Commissione di Accesso che ha portato allo
scioglimento di quell'amministrazione perché piegata ai desiderata dei
PIROMALLI. La Laganà infatti era membro della Commissione Parlamentare Antimafia
e quindi con accesso a informazioni riservate, secretate. Che segnale è, in
Calabria, nella Piana di Gioia Tauro, far salire un soggetto del genere sul
palco della cosiddetta “antimafia”? Chiaramente devastante. Ma andiamo avanti. A
Bari chi è stato il grande protagonista della giornata della Memoria e
dell'Impegno di Libera? Massimo D'Alema. Quel D'Alema i cui rapporti indecenti
sono ormai noti, a partire da quelli, con gli uomini della sanità pugliese e
quella vecchia tangente, andata in prescrizione, da uno degli uomini della
sanità legati alla Sacra Corona Unita. A Napoli vi era Bassolino, che sappiamo
cosa abbia rappresentato in materia di gestione dei rifiuti a Napoli e Campania.
A Torino c'era Chiamparino che nuovamente è espressione di quella componente
spregiudicata nella ricerca e costruzione di consenso, e tra i principali
supporter della TAV, un'opera inutile, antieconomica, devastante per ambiente e
salute e manna per le cosche che vogliono, come già avvenuto per altre tratte di
quest'opera, entrarci con i subappalti. Quest'anno è toccato a Genova... Don
Ciotti qui si schiera al fianco di Burlando e della Vincenzi, ad esempio. Li
ringrazia. Li presenta come esempio di lotta alla mafia... peccato che con le
amministrazioni guidate da Burlando e dalla Vincenzi, le mafie abbiano fatto (e
continuano a fare, anche nonostante misure interdittive) ottimi affari a Genova
ed in Liguria, proprio a partire da quelli con le società pubbliche aventi soci
la Regione ed il Comune, o con le grandi cooperative “rosse”. E' più chiara ora
la questione? Più che di “giornata della memoria e dell'impegno”, quella a
Genova, dello scorso marzo, è stata l'ennesima giornata della memoria corta e
dell'ipocrisia! Non ci pare chiedere tanto quando si dice che gli ipocriti della
politica, delle Istituzioni, e gli “indecenti”, non vengano fatti salire su quei
palchi. Ci sembrerebbe una normalità, un atto di rispetto per le vittime.»
Ma Libera non è una
struttura indipendente?
«No!
Purtroppo no. Quello che abbiamo detto lo dimostra e se servono ulteriori esempi
che Libera si sia piegata a “paravento” di chi la sovvenziona e di chi
politicamente le è “caro”, li porto senza esitazione e senza pericolo di
smentita alcuna. Ed attenzione: è pienamente legittimo quanto fa Libera. Non
vorrei che si pensasse l'opposto. Assolutamente no! E' legittimo che Libera si
faccia “braccio” di un blocco di potere politico-economico, ma sarebbe
intellettualmente corretto ed onesto che lo dichiarasse, senza negarlo e senza
dichiararsi “indipendente”. Parliamo del Piemonte? A Torino Libera ha una forte
vicinanza a SEL e già questo basterebbe a chiarire lo strano concetto che Libera
ha di “indipendente”. Michele Cutro, persona degnissima, era dal 2007 il
referente dell'area europea di Libera; si candida a Torino alle Primarie di
centro sinistra e poi per il Consiglio Comunale con SEL, in appoggio a Fassino.
Viene eletto ed entra in Comune. SEL è nella maggioranza di centrosinistra,
quella stessa maggioranza determinatasi grazie anche ai consensi raccolti tra
gli 'ndranghetisti, come ha messo in evidenza l'inchiesta MINOTAURO. Come può
quindi Libera, un esponente di primo piano di Libera, avere una vicinanza
marcata con un partito quando questi è parte integrante di quella maggioranza in
cui vi sono metodi spregiudicati e indecenti di raccolta del consenso? E se poi
vogliamo vi è tutto il capitolo TAV, con la posizione di Libera che fa da
stampella al blocco di potere politico-economico che persegue questa opera!
Scendiamo nell'alessandrino? Qui vi sono pesantissimi interessi ed affari di una
delle più potenti cosche della 'ndrangheta, quella dei GULLACE-RASO-ALBANESE. Il
“locale” della 'ndrangheta guidato da Bruno Francesco PRONESTI' contava tra i
propri affiliati anche il Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di
Alessandria. A Novi Ligure è consigliere comunale un giovane della famiglia
SOFIO, coinvolta in più inchieste legate ai MAMONE, ed operativa proprio
nell'alessandrino. Lì vi è uno degli snodi dei traffici e conferimenti illeciti
di sostanze tossiche che coinvolge Piemonte, Liguria e Lombardia. Vi era un bene
confiscato a Cosa Nostra, a Bosco Marengo. Cosa ha proposto Libera come progetto
di riutilizzo a fini sociali per farselo assegnare? Un allevamento di quaglie!
Sì: allevamento di quaglie! Ma davvero non si poteva fare altro di più incisivo
per una bonifica più ampia di quei territori, in quel bene confiscato? Noi
crediamo di sì. Ma non basta. Dopo la presentazione in pompa magna
dell'assegnazione a Libera di questo bene che cosa è successo? Che non si è
proceduto a sistemare quel casolare e così oggi, dopo gli articoli su come sono
brave le Istituzioni e Libera di alcuni anni fa, quel casolare deve essere
demolito perché impossibile, economicamente impossibile, ristrutturarlo! Un
fallimento devastante! Ma non basta ancora. Libera prima delle ultime elezioni
amministrative, cosa fa ad Alessandria, nella sua visione “ecumenica”? Va dal
anche dal Sindaco in carica, quello che aveva, con la sua maggioranza, messo il
CARIDI, l'affiliato alla 'ndrangheta, alla Presidenza della Commissione
Urbanistica, da quel Sindaco che ha contribuito in modo determinante al dissesto
del Bilancio di Alessandria, e gli propone di firmare il documentino contro le
mafie! Ecco, anziché indicarlo come pessimo esempio di gestione della cosa
pubblica e di “sponsor” del CARIDI, loro gli porgono la mano per dichiararsi,
con una firmetta antimafioso! Parliamo dell'Emilia-Romagna? Avete mai sentito
Libera indicare gli affari sporchi di riciclaggio e speculazione edilizia, di
smaltimenti illeciti di rifiuti o altro che non siano quelli più “visibilmente
sporchi”, come droga e prostituzione? No. Anche qui mai un nome o cognome... mai
una denuncia sull'atteggiamento dei colossi cooperativi emiliani come la Cmc, la
Ccc, Coopsette o Unieco che più volte hanno accettato la convivenza con le
società delle cosche. Mai una parola sui grandi colossi privati, come la
PIZZAROTTI, la gestione dell'Aeroporto di Bologna, le grandi colate di cemento
lungo la via Emilia o gli appalti per le infrastrutture dove non mancano gli
incendi dolosi ai mezzi di cantiere che non rispondono alle cosche. Solo qualche
parola, ma non troppe sui Casalesi a Parma, dove governava il centrodestra.
Reggio Emilia è una piccola Beirut, per anni, come il resto dell'Emilia-Romagna,
presentata come indenne dalla presenza mafiosa, quando invece la
“colonizzazione” si è consumata dopo che politica e settori imprenditoriali
hanno aperto le porte alle mafie per riceverne i servizi a “basso costo” e per
avere strada spianata alle cooperative nella partita TAV in Campania o, ancor
prima, a Bagheria e nel grande ed oscuro patto con i Cavalieri dell'Apocalisse
di Catania. A Firenze, Libera era legatissima all'amministrazione di Leonardo
Domenici, quella finita nell'occhio del ciclone per gli episodi di corruzione
nelle operazioni speculative di Salvatore Ligresti... quella del voto di scambio
alle elezioni primarie con cui il Cioni cercava di assicurarsi il consenso. E
mentre a Milano Libera accusava l'amministrazione di centrodestra che era in un
perfetto connubio con Ligresti, a Firenze tace. Anzi, va oltre: la firma “Libera
contro le mafie” siglava un volantino a sostegno del progetto devastante di
tramvia dell'Impregilo nel centro fiorentino! Non un volantino contro lo scempio
devastante della tramvia, così come nemmeno mai una parola contro il tunnel che
dovrebbe sventrare Firenze per la TAV, così come nulla di nulla sulla
devastazione del Mugello. Ecco Libera che tanto sostegno ha ricevuto da
quell'amministrazione fiorentina, passo dopo passo, ha sempre ricambiato.
Bastano come esempi o bisogna andare avanti con questa lista della
non-indipendenza di Libera? Ripetiamo: basterebbe che dichiarassero di essere
“di parte”, cosa legittima... e non dichiararsi per ciò che non sono:
indipendenti...Ancora: in Calabria, per citare un caso e non annoiare, basta
ricordare che il referente di Libera è andato ad un'iniziativa di presentazione
della “Casa dello Stocco” promossa da Francesco D'AGOSTINO, già Consigliere
provinciale dei “Riformisti”... Nella Piana sanno chi è questo imprenditore,
Libera non lo sa? Impossibile. Lo si conosce anche in Liguria. Ad esempio il
marchio “Stocco & Stocco” era in uso al boss Fortunato BARILARO, esponente
apicale del “locale” della 'ndrangheta di Ventimiglia. Perché ci è andato? Non
era meglio disertare tale “evento”? A Genova, in occasione delle ultime elezioni
amministrative, buona parte di Libera locale si è visibilmente schierata,
apertamente, a sostegno di Marco Doria, il candidato del centrosinistra. Scelta
legittima, ma... Un giornalista free-lance ha posto una domanda a Marco Doria: “Può
nominare qualche famiglia dell’ndrangheta che ha interessi a Genova?” e Doria ha
risposto: “No, perché non ho studiato il problema. Se lo sapessi lo
direi.”. Ecco: come possono gli esponenti locali di Libera sostenere un
candidato che non ha studiato il problema, in una città dove da anni ed anni,
ormai, i nomi e cognomi, le imprese ed i fatti sono pubblici, ampiamente noti?
Se mi si dice che lo si sosteneva perché “politicamente” è della loro parte, va
bene, ma lo si dica! Se mi si dice che invece no, perché sono indipendenti, e lo
sostenevano perché con lui si può combattere le mafie, allora non ci siamo, non
c'è onestà intellettuale... e non solo per l'intervista. Raccontiamo due fatti,
abbastanza significativi, crediamo. Tra gli assessori scelti da Doria, per la
delega ai Lavori Pubblici, c'è Gianni Crivello. Questi era il presidente del
Municipio Valpolcevera, lo è stato per dieci anni. Quel territorio è quello
maggiormente e storicamente, più colonizzato dalle mafie, Cosa Nostra e
'Ndrangheta. Lì la presenza delle mafie è palpabile. Bene, Crivello per anni ha
cercato, ed ancora cerca, di “minimizzare” la questione. Eppure sappiamo che
negare e minimizzare sono due linee pericolosissime, devastanti negli effetti
che producono. L'altro fatto che vi racconto è questo: tra gli sponsor di Doria
vi è l'architetto Giontoni, responsabile dell'Abit-Coop Liguria, il colosso
locale, nel settore edile, della Lega Coop Liguria. A parte il fatto che per una
cessione alla Cooperativa “Primo Maggio” dell'Abit-Coop l'ex rimessa di
Boccadasse dell'azienda per il trasporto pubblico locale (finalizzata alla
realizzazione di appartamenti di lusso), l'ex sindaco Pericu ed altri sui uomini
sono stati condannati pesantemente dalla Corte dei Conti per i danni alle casse
pubbliche, l'Abit-Coop vede nel suo Consiglio di Amministrazione tal Raffa
Fortunato. Questi per conto di Abit-Coop è stato nominato nei Cda delle aziende
del gruppo Mario Valle... Raffa Fortunato è il cugino dei FOTIA, la famiglia
della 'ndrangheta, riferimento nel savonese della cosca dei
MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI. Non solo: in diversi cantieri dell'Abit-Coop sono
stati incaricati di operare i FOTIA con la loro SCAVOTER (ora interdetta e per
cui la DIA ha chiesto la confisca) ed i PELLEGRINO di Bordighera con la loro
omonima impresa (sotto sequestro di nuovo per iniziativa della DIA). Doria è
stato informato di questo. Risposte giunte? Nessuna!»
Ma da Genova non poteva
“scattare” l'occasione delle svolta, dove Libera riaffermava la sua
indipendenza...
«A
Genova c'è stato e c'è il suggello della dipendenza piena di Libera al blocco
politico-economico “rosso” ed asservita, in cambio di fondi e visibilità, agli
amministratori peggiori che si possano trovare in circolazione. Altro che
svolta... qui c'è stata e si conferma l'apoteosi dell'ipocrisia. Andiamo con
ordine con 5 esempi di fatti:
1) Libera è
nata in Liguria fondata da Legacoop, Unipol, Arci e qualche altro cespuglio.
Tutto il fronte anti-cemento, impegnato da anni contro le attività di
riciclaggio delle mafie nella grandi operazioni di speculazione edilizia, a
partire dai porticcioli, e contro i condizionamenti delle Pubbliche
Amministrazioni e degli appalti, è stato messo alla porta già ai tempi della
fondazione di Libera in Liguria. Noi ed altri. Abbiamo le carte, le abbiamo
pubblicate. In una di queste dicono che bisogna stare attenti a noi che abbiamo
un gruppo a Ceriale... e sì quel gruppo con cui siamo riusciti a far crollare
l'impero del costruttore Andrea NUCERA che dopo un'interdizione antimafia per
una sua impresa ed il sequestro che avevamo sollecitato del mega cantiere di
Ceriale, è finito in bancarotta ed è latitante. Bella colpa vero?
2) Libera
organizzò una fiaccolata antimafia a Sanremo. Chi invitò ad aderire? Quei
partiti che hanno tenuto bel saldamente al proprio interno (difendendoli) i vari
esponenti con pesanti contiguità e complicità con le cosche. C'era l'Udc di
Monteleone, il Pdl degli Scajola, Praticò, Minasso e Saso... il Pd dei Drocchi,
Burlando, Vincenzi, Bertaina... Rc degli Zunino... l'Idv della Damonte, Cosma e
compagnia, SEL dell'assessore al patrimonio di Genova che dava la casa popolare
al boss di Cosa Nostra... ma su questo torniamo dopo. In prima fila, a quella
fiaccolata, c'erano i sindaci “antimafia” di Ventimiglia, Gaetano SCULLINO, e
quello di Bordighera, Giovanni BOSIO. Quest'ultimo lo hanno anche fatto parlare
come testimonianza di impegno per la legalità. Il fatto che le Amministrazioni
di BOSIO e SCULLINO fossero piegate dai condizionamenti della 'ndrangheta era un
dettaglio che è sfuggito a Libera. Ah naturalmente non ci mandarono nemmeno
l'invito... forse sapevano che lo avremmo rimandato al mittente.
3) Libera a
Genova ha visto mettersi a disposizione della Giunta comunale della VINCENZI,
dopo l'arresto del suo braccio destro e portavoce Stefano FRANCESCA, nientemeno
che il Presidente Onorario di Libera, Nando Dalla Chiesa. Quello che a Milano
denuncia i silenzi, le contiguità e connivenze mafiose del centrodestra ma che a
Genova ha perso la vista e non vede quelle pesantissime delle amministrazioni di
centrosinistra... della VINCENZI, di BURLANDO come di REPETTO e di molteplici
Comuni della Provincia e delle riviere. Lui è consulente e si occupa di
organizzare dei bei convegni e delle rassegne antimafia, con manifesti colorati
e tanti bei volantini patinati, ma non si accorge del boss ospitato in albergo
dal Comune, degli incarichi con ribassi da brivido assegnati a soggetti
attenzionati o addirittura interdetti, delle somme urgenze, appalti vari e
agevolazioni date ai MAMONE nonostante l'interdizione atipica antimafia... non
parliamo delle varianti urbanistiche promosse dalla Vincenzi (come sul caso
Lido, che poi abbiamo contribuito a bloccare) o i rapporti con le imprese del
gruppo imprenditoriale dei FOGLIANI di Taurianova... ivi compresa la
concessione, poi annullata dal TAR per una clinica privata ad Albaro. Queste
cose a Genova Nando non le nota... pare che soffra di una grave patologia di
“strabismo”, così, da un lato, da il “patentino” antimafia alle amministrazioni,
come quella di cui è consulente (prima pagato e dopo la nostra denuncia
pubblica, gratuitamente, senza più le decine di migliaia di euro annui),
promuovendo tante belle iniziative e dall'altro tace e “copre” le indecenze.
4) Vi è poi la
pantomima con 6... dico SEI... inaugurazioni dei beni confiscati di Vico della
Mele. So che la questione è stata anche oggetto di discussione durante la visita
della Commissione Parlamentare Antimafia a Genova lo scorso anno. Ad ogni
occasione elettorale il Comune di Genova, lo stesso che ospitava in albergo il
boss a cui sono stati confiscati e che noi siamo riusciti, con una serie di
iniziative pubbliche, a far sì che si sgomberasse, con Dalla Chiesa, faceva una
bella inaugurazione... poi il bene tornava ad essere chiuso. Un segnale
devastante dopo l'altro, in un territorio dove il controllo del territorio, come
si è dimostrato con le nuove inchieste e procedimenti a carico dei CACI,
CANFAROTTA e ZAPPONE, era saldamente in mano alla mafia. Qui il Comune, sotto la
regia di Dalla Chiesa (lo ha scritto direttamente lui in una lettera di insulti
a noi ed agli abitanti della Maddalena che avevano collaborato con noi alle
indagini che hanno portato alla confisca di 5 milioni di beni ai CANFAROTTA), ha
elaborato un bando in cui il vincitore era già scritto. Se dici che il bene lo
dai a chi vende i prodotti di Libera Terra secondo voi chi può vincerlo? E poi
perché una bottega in un posto del genere dove invece occorre attività che si
dirami e bonifichi i vicoli tutti intorno? Un’attività di quel tipo non è
socialmente utile lì... Avevamo proposto, insieme ad altri, un progetto di rete,
in cui poteva starci anche Libera, ma senza “monopolio”, e che le attività
fossero scelte insieme agli abitanti perché solo così si può coinvolgere la
comunità e rendere evidente una risposta collettiva alle cosche, facendo
riprendere alla comunità stessa quei beni. Ed invece no... lo hanno dato alla
rete di Libera.»
Sì, ma promuovere i prodotti
delle terre confiscate non è importante?
«Premettiamo
una cosa: molti dei ragazzi che vi operano ci mettono l'anima, così come molti
di coloro che credono che Libera sia una struttura che fa antimafia. Ma la
realtà dei fatti è diversa. Il quadro che ci viene presentato è utile a Libera,
che ha di fatto il monopolio della gestione dei beni confiscati riassegnati, ed
alle Istituzioni che così si fanno belle sventolando questo dichiarato
“utilizzo” dei beni confiscati. Ma questo quadro è un falso! Prima di tutto
perché i beni confiscati che vengono riassegnati sono pochissimi. Sono briciole.
Abbiamo pubblicato anche uno studio su questo, sulla normativa e sulla realtà.
Uno studio mai smentito! Secondo perché ad un sistema clientelare, nelle regioni
meridionali, si promuove un nuovo clientelismo nel nome dell'antimafia. Mi
spiego: senza i contributi pubblici quelle cooperative che lavorano sui terreni
confiscati non durerebbero un anno! La gestione di quelle cooperative è poi
piegata dal clientelismo. Prendiamo le cooperative siciliane. Le principali sono
coordinate da Gianluca Faraone, mentre suo fratello fa politica nel PD. E' quel
Davide Faraone “scoperto” da Striscia la Notizia cercare di ottenere voti alle
primarie di Palermo promettendo posti di lavoro nelle cooperative come
contropartita. Questo avrebbe dovuto far sobbalzare sulla sedia chiunque… Invece
silenzio... Come silenzio sulla recente convocazione da parte di una Procura
siciliana di don Luigi Ciotti perché in una delle cooperative di Libera Terra è
stato individuato un soggetto legato a Cosa Nostra. La questione è quindi:
perché Libera deve avere il “monopolio” del riutilizzo dei beni confiscati? Dove
sta scritto? E poi non ci si rende conto che questa situazione non aiuta a
ridare credibilità e fiducia nelle istituzioni, nella concorrenza? Inoltre, è
evidente che se una struttura gestisce, da sola, una quantità immane di beni
confiscati, qualche falla poi si crea. Ed allora perché non perseguire il lavoro
di “rete”, con più soggetti, che concorrono nella gestione dei beni confiscati?
L'idea di azione di “rete” era proprio la base della prima ed originaria Libera.
Poi vi è un'altra questione. Molte realtà locali di pubbliche amministrazioni
usano le assegnazioni dei beni confiscati per farsi una nuova “facciata” e
conquistarsi “credibilità”. In questi casi bisognerebbe valutare prima di
accettare un bene assegnato. Bisognerebbe considerare se quell'amministrazione è
davvero lineare, limpida oppure se ha ombre. Nel primo caso si collabora, nel
secondo si declina. Noi l'abbiamo fatto a Terrasini. Ci si voleva usare come
“paravento”, abbiamo chiesto all'allora Sindaco: o di qua o di là. Lui ha scelto
l'amico che faceva da codazzo al boss Girolamo D'Anna e noi, quindi, abbiamo
rinunciato all'assegnazione del bene confiscato. Non ci pare difficile o
complesso.»
Ma anche qui si tratta di un
caso, o comunque di casi isolati... le cooperative funzionano o no?
«Quelli
che si sono citati sono alcuni esempi. I casi preoccupanti sono molteplici e,
purtroppo, in aumento. Parte del grano veniva (non so se avvenga ancora)
macinato in un mulino dei Riina? Ci è stato raccontato così da chi per anni ha
lavorato alla Commissione Parlamentare Antimafia e vive a Palermo. Non è mai
stato smentito. Oppure c'è la storia di un agriturismo dove, per il centro di
ippoterapia, i cavalli e gli stallieri erano presi dal maneggio della famiglia
mafiosa ben nota in quei territori? Li ha ripresi anche Telejato! Anche sul
fatto del funzionamento delle cooperative poi vi è molto da dire. Già ricordavo
che senza sovvenzioni pubbliche crollerebbero ed altro che riscatto per i
giovani di quelle terre. Sarebbe una mazzata... Ma si può vivere di
assistenzialismo eterno, promuovendo progetti che nel momento in cui dovessero
mancare i fondi pubblici, crollerebbero inesorabilmente? Noi crediamo di no! Lo
spirito della legge Rognoni-La Torre non era quello di sostituire al
clientelismo democristiano e mafioso una sorta di clientelismo dell'antimafia!
Ma entriamo più nello specifico delle cooperative. Pare che nessuno sappia, in
questo Paese, fare due conti. Oppure li sanno fare ma ne tacciono i risultati.
Prendete la pasta prodotta ed impacchettata nelle bustine della pasta biologica
“Libera Terra”. Fate il conto di quanto grano sia necessario per produrre tale
quantità di pasta, non più per i numeri originari di una cerchia ristretta di
vendita ma sulla grande distribuzione. Scoprirete che buona parte del grano
usato per produrre quella pasta non viene affatto dalla coltivazione dei terreni
confiscati in concessione a Libera Terra. In quei terreni possono sorgere minime
percentuali del grano necessario. E' un dato oggettivo, lampante... sotto gli
occhi di tutti. Di “Libera Terra” ci sono quindi, nella grande maggioranza dei
casi, in quei pacchi di pasta, solo le confezioni. Il grano viene comprato da
terzi, non nasce dalla terra confiscata! Ci è stato riferito che addirittura nei
primi anni 2000 giungevano comunicazioni alla Commissione Parlamentare
Antimafia, in cui si evidenziava che parte del grano usato per produrre quella
pasta veniva comprato in Ucraina! Sul vino o sui pomodori il discorso è lo
stesso... In quei pochi ettari di terra confiscata assegnati alle cooperative di
Libera Terra non si può materialmente produrre la quantità di prodotti necessari
per il mercato. Anche qui di Libera c'è solo la confezione. Tutto si regge su
un’illusione che pare nessuno voglia indicare e questo è grave! In ultimo, ma
fondamentale, vi è un elemento che nessuno pare voglia vedere ma che, di nuovo,
è preoccupante. E' il monopolio! Di fatto la gestione delle terre confiscate
avviene in un regime di monopolio da parte delle cooperative di Libera. Ogni
possibilità di concorrenza è cancellata. Questo, nuovamente, è nello spirito
della Legge Rognoni-La Torre? Non ci pare. Così come non era nello spirito di
quel milione di firme che la “prima” Libera ha raccolto per fa sì che quella
norma per l'utilizzo sociale dei beni confiscati fosse approvata. Ed attenzione
questo stato di monopolio impedisce, o quanto meno impedirebbe, che, ad esempio,
in bandi pubblici si possa indicare come criterio l'utilizzo dei prodotti nati
dalle terre confiscate. Ci sono pronunce di sentenze che annullano bandi per
questa ragione. Perché non si vuole cambiare strada? Perché anziché
“monopolizzare” non si promuove una libera concorrenza che sarebbe a vantaggio
non solo della “forma” ma anche della sostanza, nel senso che si spingerebbe a
costruire realtà che vivono davvero sulle proprie gambe, e non quindi nicchie
clientelari.»
Ma perché tanta acredine
verso Libera? Degli errori si possono fare. Avete provato a parlare con don
Ciotti?
«Non
c'è acredine, come abbiamo già detto se si indicano i problemi, i fatti che
testimoniano i problemi, è perché si vuole contribuire a risolverli! Premettiamo
che siamo convinti che chi è in buona fede, ed in Libera in tanti sono in buona
fede, colga che il nostro non è un “attacco” o una “guerra”, come alcuni cercano
di far passare per eludere i problemi che poniamo. Chi è in buona fede sa che
non diciamo falsità e non compiamo forzature, ma ci limitiamo ad indicare
questioni, fatti, che è interesse di tutti, ed in primis di Libera, affrontare e
risolvere. Nella vita sociale, di una comunità, così come nella vita privata di
ciascuno, se si vive sulle illusioni, nei sogni, vedendo l'irreale come reale
perché ci fa stare meglio, facciamo danni. Aggiungiamo danni a quelli che già ci
sono. E' come il medico pietoso o che “sbaglia” diagnosi perché è “ottimista” e
perché non vuole guardare al peggio e tantomeno vuol dirlo al paziente. Darà una
terapia sbagliata o comunque inefficace ed il paziente si aggrava e muore. Non è
acredine. E' essere onesti e dire le cose come stanno. A noi farebbe molto
meglio accodarci a Libera, entrare nella sua “rete” che tutto può avere, ma per
farlo dovremmo rinunciare all'indipendenza ed al rigore di guardare sempre e
comunque a 360 gradi, senza mai tacere le cose che devono essere dette e
denunciate. E' indiscutibile poi che gli errori li si può commettere tutti. Ci
mancherebbe... ma qui non sono errori se li si nega, se si esula
dall'affrontarli e risolverli. Qui si è davanti ad una scelta precisa che
conduce agli errori e che vive di “errori”... e don Luigi Ciotti non è solo
consapevole di tutto questo, ma è il principale fulcro di questo sistema che
rappresenta la degenerazione della Libera originaria. Anche perché, se lui
volesse, queste questioni le si sarebbe già risolte! Gli errori si ammettono e
si correggono. Quando si nega, quando si decide di querelare chi indica le cose
che non funzionano, quando si prosegue lungo la strada sbagliata, che è evidente
ad un bambino, quando è conclamato dai fatti che si è persa la direzione
corretta, significa che siamo davanti ad una scelta consapevole, voluta e
perseguita. Questo è l'aspetto che genera rabbia e che impone di non tacere! Noi
abbiamo posto alcuni problemi, abbiamo indicato alcuni fatti, reali, tangibili,
riscontrabili da chiunque li voglia vedere. Per risposta abbiamo avuto due
comunicati ufficiali di Libera, uno della Presidenza ed uno di Nando Dalla
Chiesa, in cui non si rispondeva ad una virgola di quanto da noi sollevato, ma
si dichiarava che ci avrebbero querelati! Siamo noi o loro che hanno acredine,
odio e che rifiutano il confronto sui fatti? Noi viviamo una sorta di “guerra
fredda” mossaci da Libera. Noi, come gli altri che non hanno accettato di
accodarsi al loro monopolio dell'antimafia. Serve una svolta per ritrovare
l'unità del movimento antimafia, ammesso che questa ci sia mai stata
effettivamente, al di là della facciata.»
Il vertice di Libera quindi
le sa queste cose? Ad esempio quelle sulla Liguria...
«Sì,
le sanno. Le sanno da sempre e fanno finta di nulla. Anzi più le sanno, perché i
fatti emergono inequivocabili, più isolano noi, ad esempio, che abbiamo
contribuito a farli emergere, dando avvio alle azioni giudiziarie, e più fanno
da “paravento”. E per coprire quanto accaduto, mistificano la realtà, arrivano a
mentire. Dalla Chiesa, ad esempio, disse che assolutamente non stava operando
sui beni confiscati di Vico Mele, per poi smentirsi da solo! Incontrò noi e gli
abitanti della Maddalena dove gli dicemmo, ad esempio, dell'albergo a CACI...
poi un anno dopo fece quello che cadeva dal pero. Davide Mattiello, altro
esempio. Lo incontrai a Torino, in un bar davanti alla stazione di Porta Susa.
Gli dissi tutto su quelli che volevano fondare Libera in Liguria, gli “amici”
del fronte del cemento. Gli mostrai le carte dell'inchiesta della Guardia di
Finanza dove emergevano i rapporti illeciti e quelli inopportuni ed indecenti
tra Gino MAMONE e gli esponenti politici del centrosinistra genovese, dalla
Vincenzi a Burlando, a partire dalla partita viziata da corruzione per la
variante urbanistica dell'area dell'ex Oleificio Gaslini. Mi disse che avrebbe
provveduto... Sapete chi è stato il “garante” della costruzione di Libera in
Liguria, per allestire il grande “paravento”? Proprio Davide Mattiello... Quando
in diversi gli chiesero se avesse letto il libro-inchiesta “Il Partito del
Cemento” dove vi erano nomi, cognomi e connessioni di quelli che stavano
promuovendo Libera in Liguria, la sua risposta è sempre stata: no, non l'ho
letto e non intendo leggerlo! Non è questione di “noi” e “loro”. Se Libera non
funziona è un problema per tutti! Noi per anni, quando Libera non era ancora
questo, abbiamo chiesto e spinto perché si fondasse Libera in Liguria. Era
salito due volte a Genova per le riunioni da noi richieste anche Alfio Foti, che
in allora per il nazionale di Libera si occupava di queste cose. Inizialmente
l'Arci sosteneva che non vi era “necessità” di costruire Libera in Liguria. Poi,
con la seconda riunione, fecero naufragare tutto. Noi eravamo affiliati a
Libera. In Liguria eravamo solo noi ed il CSI, il Centro Sportivo Italiano. Per
anni è stato così... Ma l'Arci continuava a gestire il “marchio” Libera, con la
Carovana, escludendo sia noi sia il CSI. A noi rimproveravano di aver indicato i
rapporti tra i MAMONE con Burlando e l'amministrazione Pericu del Comune di
Genova. Ma erano fatti quelli che noi indicavamo che oggi sono confermati da
risultanze molteplici di inchieste, da un’interdizione atipica per i MAMONE e da
una condanna proprio di Gino MAMONE e di un ex consigliere comunale della
Margherita, STRIANO, per corruzione in merito ad una variante urbanistica di
un’area dei MAMONE.»
Ma perché secondo voi è così
pericolosa la strada imboccata da Libera?
«La
questione è semplice e parte dalla solita questione italica: illusione o
concretezza. Il sogno non come speranza che si cerca di perseguire con atti
quotidiani concreti, ma il sogno in cui ci si racchiude per stare meglio con se
stessi. L'illusione è la cosa che i preti sanno vendere meglio, lo fanno da
millenni, ed in mezzo a infinite contraddizioni o misteri riescono sempre a
conquistarsi “anime” per atti di fede. Don Ciotti è un prete e questo fa. Ora ad
esempio parla di “scomunica” ai mafiosi... bene, ma perché, realtà per realtà,
né lui, né gli altri responsabili di Libera, non osano mai pronunciare un nome e
cognome! Se si vuole scomunicare qualcuno questo qualcuno è in carne ed ossa, ha
un volto, ha un nome... La mafia non è un ectoplasma. Poi sappiamo tutti che la
lotta alla mafia è fatta anche di segnali. Se i segnali sono equivoci è un
problema. Facciamo un altro esempio concreto. “Avviso Pubblico” è una struttura
nata da Libera che raccoglie gli Enti Locali e le Regioni. Una struttura in cui
i Comuni, le Province e le Regioni possono aderire, previo versamento di una
quota annuale. Ma non c'è verifica, non ci sono discriminanti per l'adesione.
Prendiamo la Regione Liguria che recentemente ha aderito ad Avviso Pubblico. Qui
si ha un presidente della Regione, Burlando, che era amico dei MAMONE, che
frequentava e da cui ha preso sovvenzioni attraverso l'associazione Maestrale,
che aveva tra i propri supporter alle ultime elezioni liste che avevano uomini
legati alla 'ndrangheta tra le proprie fila. Abbiamo un presidente del Consiglio
Regionale che nel 2005 incassò i voti della 'ndrangheta, poi un pacchetto di
tessere sempre da questi per vincere il congresso, poi li ricercò ancora per le
elezioni del 2010, proponendo al capo locale di Genova, GANGEMI, una bella
spaghettata, e che, in ultimo, ha festeggiato la rielezione nel ristorante del
boss di Cosa Nostra Gianni CALVO. Abbiamo poi un consigliere regionale, Alessio
Saso, indagato per il patto politico-elettorale con la 'ndrangheta alle elezioni
del 2010. Davanti a questo panorama Avviso Pubblico, crediamo, avrebbe dovuto
dire: Cara Regione Liguria, prima ripulisci il tuo palazzo da questi soggetti e
poi la tua domanda di adesione sarà accolta. Invece no, accolta subito, con
questo bel quadretto. E così Libera che, per la manifestazione del marzo scorso,
incassa dalla Regione quarantamila euro di contributo e poi si presenta con don
Ciotti al fianco di Burlando e lo ringrazia per quello che fa nella lotta alla
mafia.»
In che senso “grande
illusione”?
«Antonino
Caponnetto ha indicato la strada maestra della lotta alle mafie: rifiutare la
logica del favore, indicare i mafiosi perché questi temono più l'attenzione
dell'ergastolo! Paolo Borsellino ha spiegato, credo meglio di ogni altro, che la
lotta alla mafia è una questione civile e culturale, perché la sola azione
giudiziaria non è sufficiente per sconfiggere le mafie. E ci diceva che bisogna
mettere in un angolo i politici compromessi, anche per sole semplici
frequentazioni indegne, e pur se non esistono rilievi penali. Ci diceva che
occorre negare il consenso alle cosche perché gli si fa venir meno la capacità
di condizionamento. Giovanni Falcone invece ha reso evidente già allora che la
mafia non è coppola, lupara e omicidi, ma è affari. Ci ha spiegato che tutte le
attività più cruente e prettamente “criminali” (droga, estorsione,
prostituzione...) servono alle organizzazioni mafiose per avere quei capitali
illeciti da riciclare facendosi impresa, finanza, politica. Ci spiegava che è
lì, seguendo i soldi, che si può colpire l'interesse mafioso. Ed allora perché
Libera questo non lo fa? E perché cerca, in un reciproco scambio di favore con
la politica, di monopolizzare la lotta alla mafia a livello sociale come se ci
fossero solo loro? Libera ha il vantaggio di rafforzarsi e incassare, la
politica ha un ritorno perché usa Libera come paravento per coprire le proprie
indecenze. Ci si può dire: ma sono solo modi diversi di perseguire lo stesso
obiettivo, cioè sconfiggere le mafie. Non ci pare così... Le iniziative
“mediatiche”, il merchandising che diventa la principale attività, le illusioni
di combattere le mafie con spaghettate, cene o pranzi, il parlare di una mafia
ectoplasma e non della concreta e palpabile rete mafiosa, di contiguità,
connivenze e complicità, fatta di soggetti ben precisi, con nomi e cognomi, non
è lotta alla mafia... al massimo possiamo considerarla una “buona azione”, come
il fare l'elemosina davanti alla chiesa al povero cristo di turno... Non risolve
il problema, ci convive! Libera parla sempre dei morti... ci dice che bisogna
ricordare i morti, vittime della mafia. Giusto e come si fa a non condividere il
dovere della Memoria? Ma dei vivi? Dei vivi non si parla mai... le vittime vive
delle mafie sono ben più numerose delle già tante, troppo, vittime morte
ammazzate. Di queste Libera si dimentica... Non è un caso se fu proprio don
Luigi Ciotti a chiedere che venisse previsto anche per i mafiosi l'istituto
della “dissociazione”, cioè ti penti, ti dichiari dissociato ma non confessi
nulla, non racconti nulla di ciò che conosci dell'organizzazione. E' chiaro che
se mai fosse stata accolta questa proposta, di collaboratori di giustizia non ne
avremmo più. Se per avere gli stessi benefici basta dissociarsi, senza rompere
l'omertà e denunciare i sodali e i segreti dell'organizzazione, quale mafioso
rischierebbe la propria vita e quella dei suoi familiari per collaborare?
Nessuno e lo strumento essenziale dei Collaboratori svanirebbe.»
Ma l'azione di Libera arriva
a molte persone, alla massa. Le vostre iniziative se pur incisive nell'azione di
contrasto civile e, nel vostro caso, anche giudiziario, alle organizzazioni
mafiose, le conoscono in pochi.
«Questo
è un problema che non dipende da noi. Dipende da ciò che dicevamo prima: Libera
è utile alla politica ed alle imprese perché gli fa da “paravento”, nascondendo
le loro pratiche indecenti. E' ovvio che Libera in cambio ha qualcosa da questo:
visibilità mediatica, grandi riconoscimenti, finanziamenti e strumenti per
promuoversi. Noi diamo l'orticaria a 360 gradi con la nostra indipendenza. E
quindi la risposta è evidente: l'isolamento! E qui Libera gioca di nuovo un
ruolo servile verso il Potere, verso quel potere compromesso, si presenta come
unica realtà “credibile” ed oscura chi non è gradito e non accetta di piegarsi
alla loro stessa logica. Le operazioni mediatiche non servono a colpire le
mafie. Pensate alla grande campagna mediatica dell'ex Ministro Maroni. Ogni
giorno sfruttava gli arresti di mafiosi fatti da magistrati e forze dell'ordine
per dire che stavano sconfiggendo la mafia. Hanno costruito una campagna
mediatica per cui “l'arresto” sconfigge la mafia. Una falsità assoluta... tanto
è vero che le mafie sono ancora ben forti e radicate sul territorio, con sempre
maggiore capacità di condizionare il voto, e quindi le Amministrazioni
Pubbliche, anche al Nord. Ed allora: è servita questa campagna mediatica sulla
vulnerabilità dei mafiosi per scalfire il loro potere? No. Facciamo alcuni
esempi...Trovate un amministratore pubblico in Italia che abbia speso quanto ha
investito Totò Cuffaro in manifesti di ogni dimensione, tappezzando un'intera
regione, la Sicilia, con lo slogan “la mafia fa schifo”. Non esiste. Cuffaro ha
speso più di ogni altro politico italiano in un’azione mediatica su larga scala.
Noi però sappiamo chi era quel Cuffaro. Un fiancheggiatore degli interessi
mafiosi. Cosa ci dice questo? Semplice: le azioni mediatiche la mafia non le
teme, anzi le vanno pure bene, perché le permettono una più efficace azione di
mimetizzazione. Altro esempio. Francesco Campanella, uomo che agevolò la
latitanza di Provenzano. Questi ebbe un'idea e la propose a Provenzano che
l'accolse con grande entusiasmo. L'idea era semplice: promuovere direttamente
manifestazioni antimafia. Chiaro? Ed ancora: dove facevano le riunioni gli
'ndranghetisti di Lombardia per eleggere il loro “capo”? Nel “Centro Falcone e
Borsellino”! Si vuole o no capire che i mafiosi sono i primi che hanno
l'interesse di “mascherarsi” e presentarsi pubblicamente come attori
dell'antimafia? Devono farlo i sindaci e gli eletti che hanno stretto un patto
con la mafia, così come devono farlo gli affiliati che hanno un ruolo pubblico o
comunque una visibilità pubblica. Gli serve per insabbiarsi! La linea
“ecumenica” di Libera lascia troppe porte aperte a queste “maschere”... E'
pericoloso! E' un insulto alla buona fede dei tanti che in Libera lavorano
seriamente e che da questo vedono, in determinati territori, il proprio lavoro
screditato. Quelle porte devono essere sbarrate! Se una persona vive su un
territorio sa chi sono i mafiosi. E se alla manifestazione antimafia tu vedi che
tra i promotori ci sono i mafiosi, il segnale è devastante! Per semplificare: se
tu sai che il responsabile degli edili di un grande sindacato va a braccetto con
il capobastone che organizza, con la sua rete, il caporalato o le infiltrazioni
nei cantieri edili con le ditte di ponteggi e le forniture, e poi vedi questo
sindacalista che promuove le manifestazioni antimafia, magari con Libera...
magari dicendoti “venite da me a denunciare”, è evidente che nessuno mai si
rivolgerà a lui, al sindacato. Quale lavoratore in nero andrà mai a denunciare
da lui? Nessuno. Ecco fatto che senza intimidazione, senza alcun gesto eclatante
si sono garantiti la pax.»
Ma allora Libera...
«Libera
dovrebbe tornare ad essere Libera “di fatto” oltre che di nome. Oggi non lo è. E
questo è un danno per tutti. E' un problema per tutti. Noi vogliamo che Libera
torni quello che era all'origine. Anche qui un esempio molto tangibile. Il
presidente della Casa della Legalità è una persona a rischio, per le denunce che
abbiamo fatto e l'azione di informazione mirata a colpire la mafia che si è
fatta impresa, la rete di professionisti asserviti, la mafia nella politica. E',
come si dice in gergo, un “obiettivo sensibile”... e lo è perché in questi anni
soprattutto in Liguria, ma anche in altre realtà, come Casa della Legalità siamo
stati soli ad indicare nome per nome, i mafiosi, i professionisti e le imprese
della cosiddetta “zona grigia”, la rete di complicità e contiguità con la
politica, le forze dell'ordine e persino nella magistratura. Abbiamo ottenuto
risultati con lo scioglimento delle Amministrazioni nel Ponente Ligure, così
come con le verifiche in corso su altri Comuni. Abbiamo squarciato l'omertà e
spinto ad adottare provvedimenti quali interdizioni a “colossi” delle imprese
mafiose. Si è contributo a far emergere i patrimoni illeciti che sono stati
aggrediti con sequestri e confische... Con un lavoro difficile, senza soldi, a
volte neppure per un bicchiere d'acqua. Si è piano piano conquistata la fiducia
di persone che poteva parlare e li si è messi in contatto con i reparti
investigativi. In alcuni casi hanno verbalizzato, in altri non vi è stato
nemmeno bisogno che si esponessero in questo. Ecco questo le mafie non ce lo
perdonano, così come non ce lo perdonano i politici che nel rapporto con le
cosche avevano costruito un pezzo determinante del loro consenso elettorale. Se
non fossimo stati soli, ma Libera avesse fatto qualcosa, oggi non sarei
probabilmente identificato dalle cosche come “il problema” da eliminare. Ed
invece no, sapendo la realtà ligure, perché la si conosce e la conoscono anche
quelli di Libera, hanno scelto di lasciarci soli e di fare da paravento alla
politica ed a quelle imprese che la porta alle mafie, in questo territorio, la
spalancarono ed ancora la tengono ben aperta. Non vorremmo che si pensasse che
queste cose siano questioni “astratte” o ancor peggio “personali”. Ed allora è
meglio che, oltre a quanto ho già raccontato, vi faccia un altro esempio
concreto. Alcune mesi fa è finalmente emerso quanto dicevamo da anni: Burlando
sapeva che nella sua rete di consensi nel ponente ligure vi erano soggetti
legati alla 'ndrangheta, della 'ndrangheta. Denunciamo questo con tutti i
dettagli del caso. Quello che è emerso è che il “collettore” era l'ex sindaco di
Camporosso, Marco Bertaina. Questi con la sua lista civica alle provinciali di
Imperia ha candidato due 'ndranghetisti: MOIO e CASTELLANA. Burlando appoggiò
quella lista civica che a sua volta appoggiava Burlando quale candidato alla
Presidenza della Regione Liguria. E chi è BERTAINA? E' l'attuale vice-sindaco di
Camporosso, dopo due anni di mandato come sindaco e diversi come assessore negli
anni Novanta... ed è soprattutto quello che ha promosso un progetto di
“educazione alla legalità” proprio con Libera. Dopo le rivelazioni su questo
asse BERTAINA-MOIO-CASTELLANA-BURLANDO cosa fa Libera? Organizza un convegno con
il Comune di Camporosso dove porta direttamente Gian Carlo Caselli! E' chiaro
che il segnale, su quel territorio, a quella comunità, è devastante? Noi
crediamo di sì e Libera ne ha tutte le responsabilità!»
Non siete stati alla
manifestazione della “Giornata della Memoria e dell'Impegno” che vi è stata a
Genova, quindi...
«No,
come Casa della Legalità non ci siamo andati. Ci è dispiaciuto di non poter
“abbracciare” i parenti delle vittime che hanno sfilato. Ci è dispiaciuto per
quelli che in buona fede ci credono... Ma noi non ci prestiamo a fare da
“paravento” in cambio di fondi, soldi o visibilità. La lotta alla mafia è una
cosa seria e le vittime dovrebbero essere rispettate e non usate. No, non ci
siamo andati alla “Giornata della Memoria corta e dell'ipocrisia”... Ma abbiamo
una speranza: che le persone che in buona fede credono in Libera la facciano
tornare Libera nei fatti. Se queste persone riusciranno a laicizzare e
decolonizzare Libera sarebbe importante per tutti. Non credo ci possano
riuscire... perché, come dicevo: un'illusione fa vivere meglio... la realtà è
più problematica ed in questa ci si deve assumere delle responsabilità concrete,
non a parole! Ma la speranza c'è, altrimenti queste cose non le direi, se fossi
convinto al 100% che nulla possa cambiare. Dico di più. Per noi della Casa della
Legalità, che convenienza c'è ad uno “scontro” con Libera? Nessuno. Loro sono,
si potrebbe dire, un “potere forte”, per la rete che hanno e che abbiamo cercato
di rendere evidente con i fatti enunciati. E se diciamo queste cose, se
indichiamo, ripeto, fatti e non opinioni, è perché vorremmo che chi è in buona
fede e crede in Libera, la faccia rinascere, eliminando quelle storture, tutte
quelle situazioni problematiche. Le critiche che poniamo sono reali, chiediamo
di riflettere su queste. Sappiamo già che qualcuno, quelli non in buona fede,
per intenderci, cercheranno di rispondere ignorando tutto quanto si è detto,
oppure scatenando una guerra aperta, non più sottotraccia alla Casa della
Legalità. Punteranno, in estrema sintesi, ad unire il proprio fronte contro il
“nemico” esterno... un'altra delle pratiche italiche che tanti danni hanno
fatto. Sappiamo di questo rischio, ma dobbiamo rischiare se vogliamo che quel
briciolo di speranza che dicevamo, possa avere una possibilità di concretizzarsi
in un cambiamento reale. Non siamo dei pazzi suicidi. Diciamo le cose come
stanno, guardando ai fatti, perché si rifletta e si affronti la realtà per
quello che è e quindi perché si possa agire per “correggerla”.»
Ma siete gli unici a dire
queste cose?
«Assolutamente
no. Forse siamo gli unici che riescono in qualche modo a bucare la cappa di
omertà che vi è su questa vicenda di Libera. Come dicevamo prima siamo davanti
ad un “santuario”. Si parla tanto di “poteri forti”, ma questi non sono solo
mica quelli della “politica”, ci sono anche nel “sociale”, nella cosiddetta
società civile. E' difficile trovare chi è disposto a subire una reazione
spietata per il solo fatto di aver indicato dei fatti che sono ritenuti
“indicibili” anche se veri. Chi ha rotto con l'associazione di don Luigi Ciotti
perché non ha avuto timore di vedere la realtà e di dirla, sono in molti.
Partiamo da un giornalista scrittore calabrese, costretto, nell'isolamento, ad
una sorta di perenne esilio dalla sua terra, Francesco Saverio Alessio. Potete
poi chiedere a Umberto Santino, del Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe
Impastato, anche lui le cose le dice senza reticenze...Il problema è che nessuno
domanda a chi risponde senza ipocrisie, perché se si da voce a chi guarda e
parla della realtà, dei fatti, allora l'illusione in cui ci vorrebbero far
vivere ed operare, svanisce.»
Ma proprio nulla va in
Libera, pare impossibile...
«Sarebbe
ingiusto dire che tutto non va. Diciamo che l'impostazione assunta da alcuni
anni a questa parte è altamente preoccupante, come abbiamo visto dai fatti. Poi
non bisogna mai generalizzare. Ci sono realtà locali che operano bene, che fanno
cose importanti e lavorano seriamente. Ci sono attività di formazione che
vengono promosse da Libera che rappresentano un contributo importante nella
sensibilizzazione. Alcune di queste in particolare, altre invece sono una sorta
di promozione di una “educazione alla legalità” slegata dal territorio, dalla
concretezza, diciamo ecumeniche e non laiche. Dire che da una parta c'è il bene
e dall'altra il male, senza dare esempio tangibile, riconoscibile sui territori
dove si promuove quell'attività, rischia di non incidere. Ecco qui vi è una
diversa visione... loro promuovono questa attività in modo meno “laico”, noi
cerchiamo invece di far vedere la realtà dei fatti, partendo da dove vivono quei
ragazzi che si incontrano e far scattare in loro quella capacità critica che gli
permette di arrivare loro a concludere ciò che è giusto e ciò che invece è
sbagliato, quale sia il bene e quale invece il male.»
Ma perché, visto che vi sta
a cuore Libera, non vi confrontate con Libera?
«Anche
qui la domanda è da rivolgere a loro. Noi non abbiamo mai avuto e non abbiamo
problema alcuno a confrontarci su questo e su altre cose con Libera e con
chiunque altro. E' proprio Libera che sfugge al confronto... che ci ignora
totalmente e cerca di isolarci, di “cancellarci”. Ma anche qui ci sono degli
esempi concreti. Andiamo con ordine...A Bologna un’associazione che fa parte di
Libera aveva organizzato un incontro di presentazione del libro “Tra la via
Emilia e il Clan”, invitando gli autori, Abbondanza ed Amorosi, ed il
Procuratore Capo di Bologna. Poi dal Nazionale di Libera arriva il veto: non ci
può essere Abbondanza! Viene comunicato che l'iniziativa è quindi rinviata! A
Genova, nessun invito formale, nemmeno semplicemente per partecipare come
pubblico, ci è stato mai mandato per le iniziative organizzate in preparazione
della manifestazione del marzo scorso...Ma vi è di più. Quando il Consiglio dei
Ministri approva lo scioglimento della Giunta e Consiglio Comunale di
Ventimiglia (a seguito dell'istruttoria seguita alla nostra denuncia), ed il
Presidente della Repubblica firma il Decreto di Scioglimento, il referente
regionale di Libera, Lupi (che è di Imperia) cosa dichiara? Che è “rammaricato”
per l'esito dello scioglimento! Non una parola sulle minacce ed intimidazioni
che ci sono giunte e per la situazione di pericolo che ha portato la Prefettura
di Genova ad adottare a tutela del presidente della Casa della Legalità le
misure di protezione. Silenzio ed isolamento, come se non esistessi, come se non
esistessimo...Per il 23 maggio l'Istituto degli Emiliani a Genova ci ha invitato
per ricordare Falcone e per far capire che la mafia c'è ancora, che è concreta,
che è qui al Nord... Lo scorso anno c'era anche Libera, quest'anno non si è
presentata. Hanno pubblicato due rapporti, redatti da loro, uno sulla Liguria ed
uno sull'Emilia-Romagna, in nessuno dei due casi appare neppure mezza delle
risultanze di indagini che abbiamo contribuito a raggiungere. Non una citazione…
fatti ed atti cancellati. Sull'Emilia-Romagna abbiamo anche pubblicato un
“atlante”, il libro “Tra la via Emilia e il Clan”, dove si è messo in evidenza,
atto dopo atto, che quella regione, quell'economia, non è affatto esente dalla
presenza e dalle attività delle mafie. Un libro che non ha avuto neanche mezza
contestazione, nessuna smentita e nessuna querela (un anomalo miracolo, si
potrebbe dire). Bene, per Libera non esiste...Se non sei dei loro non esisti e
non devi esistere! Poi questa ultima storia di Sarzana, evidenzia un nuovo
eclatante esempio. Tempo fa ci contatta l'ANPI di Sarzana per sapere a chi
potevano assegnare l'onorificenza civica "XXI luglio 1921". Ci dicono che,
essendo il ventennale delle stragi del 1992, volevano assegnarla ad un soggetto
che abbia operato ed operi nella lotta alle mafie. Non abbiamo dubbi e
proponiamo la DIA di Genova. La proposta viene poi accolta. Il Sindaco di
Sarzana contatta il presidente della Casa della Legalità, e gli comunica
ufficialmente l'accoglimento della proposta, gli chiede se poteva essere
presente per un intervento nella tavola rotonda del 20 luglio in cui verrà
consegnata l'onorificenza. Gli risponde di sì. Il giorno seguente Abbondanza
viene contattato dalla segreteria del Sindaco per avere conferma del suo
intervento, dovendo procedere per la stampa degli inviti. Gli viene data
conferma. L'altro ieri ci è arrivato l'invito. Non ci siamo più, l'intervento di
Abbondanza è svanito. C'è Libera. Ora, premesso che la cosa importante,
significativa, è il riconoscimento alla DIA che compie un lavoro straordinario
ma viene “tagliata” continuamente nelle risorse a propria disposizione, spesso
resta inascoltata anche da magistrati e istituzioni ciechi. Come abbiamo detto
anche al Sindaco che si è scusato ed ha fatto inoltrare anche una nota di scuse
ufficiali (tra l'altro nel comunicato stampa questo passaggio è svanito, chissà
perché?!), è che spunta Libera, espressione e “paravento” di quel blocco
politico-economico che corrisponde a quello dell'amministrazione del Comune di
Sarzana, e noi spariamo dagli interventi. Il Sindaco dice che Libera è attiva
nello spezzino. A parte il fatto che anche noi lo siamo da tempo, ci piacerebbe
sapere dove è Libera nella lotta contro le speculazioni edilizie che hanno
devastato quel territorio, contro il progetto della grande colata di cemento
alla Marinella, nato tra l'avvocato Giorgio Giorgi, uomo di Burlando, Monte dei
Paschi di Siena e cooperative rosse? Dove erano nel contrasto alla cricca del
“faraone” delle Cinque Terre, che era “pappa e ciccia” con Legambiente, altro
grande “paravento” del PD, legatissima a Libera? Il Sindaco risponde ad
Abbondanza: hanno proposto la Consulta per la Legalità e l'abbiamo approvata,
una struttura indipendente, con Libera, i sindacati ecc. ecc... Ma come,
Sindaco, se ci sono Libera ed i Sindacati, dove è “indipendente” questa
consulta? Se i Sindacati, a partire da quelli edili, iniziassero a fare il loro
lavoro e denunciassero le infiltrazioni nei cantieri, il caporalato, la lotta
all'illegalità ed alle mafie farebbe passi da gigante, ed invece tacciono,
coprono. La stessa cosa che avviene con le aziende agricole... ricordiamo la
Rosarno, dove tutti sapevano, i sindacati in primis, chi sfruttava come schiavi
quegli immigrati, e non osavano denunciarne nemmeno mezzo, mai un nome, ma solo
parate, fiaccolate, convegni. Noi ad un confronto siamo sempre disponibili, ma
come lo possiamo avere se sfuggono come anguille ad ogni possibilità di
confronto e se quando vi sarebbero occasioni di intervenire, entrambi, se non
saltano le iniziative, come nel caso di Bologna, fanno saltare la nostra
presenza o non si presentano loro?»
Cosa vi aspettate dopo
questa pubblicazione?
«Vorremmo
dire un confronto. Questo è quello che auspichiamo. Pensiamo che invece avremo
da un lato un “muro di gomma”, ovvero il tentativo di tenere tutto questo nel
silenzio, come se non esistesse, dall'altro lato invece subiremo un attacco
feroce, spietato. Crediamo che valga la pena, proprio per quel briciolo di
speranza riposto nelle tante persone in buona fede... Tacere ancora tutto questo
significherebbe perdere quella speranza di cambiamento necessario, perché
ripetiamo: Libera è una struttura importante e se torna alle origini ne abbiamo
tutti un vantaggio! Non vogliamo una “guerra” con Libera, vogliamo dare un
contributo, anche se attraverso una critica senza veli sui fatti, perché si
possa migliorare. Noi non vogliamo la fine di Libera, vogliamo la sua
rinascita.... e chi è in buona fede lo capisce, non può non capirlo.»
ITALIA:
PAESE ZOPPO.
Roberto
Gervaso: terapie per un Paese zoppo. Il nuovo libro racconta l’ultimo secolo
dell’Italia. Senza sconti a Grillo, Berlusconi, Renzi, Napolitano...La lezione è
quella, come lo stesso Roberto Gervaso racconta a Stefania Vitulli di
“Panorama”, appresa da Montanelli, Prezzolini, Buzzati, Longanesi. E quanto
questa lezione sia ancora inedita e scomoda nell’Italia contemporanea lo
dimostra il suo nuovo libro, Lo stivale zoppo. Una storia d’Italia
irriverente dal fascismo a oggi. Nella lista dei nomi che ritroviamo alla
fine del volume non manca nessuno: Abu Abbas, Agnelli e Alberto da Giussano
aprono un elenco alfabetico che si conclude con Zaccagnini, Zeman e Zingaretti.
Nel mezzo, l’ultimo secolo di storia di un Paese a cui Gervaso non risparmia
ricostruzioni accurate dei fatti e verità dure da accettare.
Che cosa c’è
di nuovo in questo libro?
«Le
cose che ho sempre detto. Solo che ora le dico con furia. Perché, se non si fa
una diagnosi spietata, l’Italia non avrà mai né terapia né prognosi.»
Filo
conduttore?
«La
storia di un Paese senza carattere, che sta ancora in piedi perché non sa da
che parte cadere.»
Si parte dalla
Conferenza di Versailles...
«Sì,
perché l’Ottocento finisce nel 1919, e quell’anno getta il seme dei fascismi.
Suggellò la Prima guerra mondiale, caddero quattro imperi, nacquero le grandi
dittature e l’America soppiantò l’Europa nella leadership mondiale.»
E l’Italia?
«Ha
vinto una guerra nelle trincee e sulla carta ma l’ha perduta in diplomazia,
società, economia. Era divisa fra le squadracce nere all’olio di ricino e quelle
rosse che volevano imporre i soviet. Partiti dilanianti e latitanti, i poteri
forti scelsero i fasci nell’illusione di addomesticare Benito Mussolini.»
Che si
affacciò al balcone...
«Tutto
era a pezzi, tutto in vendita. Oggi la situazione non è certo migliore del
1922.»
Partiti
dilanianti e latitanti?
«Non
hanno mai litigato tanto. La sinistra è un’insalata russa senza maionese, la
destra una macedonia di frutta con troppo maraschino giudiziario. Il Paese è a
un bivio: il balcone o la colonia.»
Sarebbe a
dire?
«O
qualcuno si leva dalla folla interpretando l’incazzatura della gente, si
affaccia al balcone e dichiara: «Il carnevale è finito», oppure diventiamo una
colonia delle grandi potenze europee o di quelle emergenti, come la Cina. La
moda italiana, tranne pochi del nostro Paese, si divide tra François Pinault e
Bernard Arnault; l’alimentare è in mano ai francesi, la meccanica è dei
tedeschi, gli alberghi diventano spagnoli...»
E gli italiani
non se ne accorgono?
«Abbiamo
un’ancestrale vocazione al servaggio. Gli italiani se ne infischiano della
libertà, le hanno sempre anteposto il benessere. L’uguaglianza non esiste: è
l’utopia dell’invidia.»
Ma che cosa ci
deve capitare di ancora più grave?
«L’Italia
ha sempre dato il meglio di sé in ginocchio, con le spalle al muro, l’acqua alla
gola e gli occhi pieni di lacrime. Nell’emergenza risorgeremo.»
Come si chiama
questa malattia?
«Mancanza
di senso dello stato. Al massimo abbiamo il senso del campanile. L’italiano non
crede in Dio ma in San Gennaro, Sant’Antonio, San Cirillo. A condizione che il
miracolo non lo faccia agli altri ma a se stesso.»
La cura?
«Utopistica:
che ognuno faccia il proprio dovere e magari sacrifici. Che devono
cominciare dall’alto.»
E parliamo di
chi sta in alto. Mario Monti?
«Un
economista teorico, un apprendista politico che ha fatto un passo falso e
fatale. Si fosse dimesso alla scadenza del mandato, sarebbe al Quirinale. Deve
cambiare mestiere: la politica non è affar suo e temo che non lo sia nemmeno
l’economia.»
Beppe Grillo?
«Un
Masaniello senza competenza politica, collettore dei voti di protesta. Se si
instaurasse una seria democrazia, sparirebbero i grillini, che vogliono la
riforma della Costituzione senza averla letta.»
Enrico Letta?
«Un
giovane vecchio democristiano, serio e competente, ma senza quel quid che fa
di un politico un leader o uno statista, cosa che, fra l’altro, non ha mai
preteso. Un buon governante.»
Matteo Renzi?
«Un
pallone gonfiato sottovuoto spinto. Un puffo al Plasmon che recita una parte
che vorrebbe incarnare ma non è la sua. Se lo si guarda bene quando parla e si
muove, si vede che non c’è niente di spontaneo. Ha una virtù: il coraggio. Più
teorico che pragmatico, però, perché oggi va a braccetto con Walter
Veltroni. Non è un rottamatore, è un illusionista.»
Veltroni?
«Un
perdente di successo, ormai attempato e fuori dai tempi. Che ha cercato di
conciliare Kennedy e Che Guevara.»
Pier Luigi
Bersani?
«Un
paesano. Un contadino abbonato a Frate Indovino, che parla per proverbi.»
Massimo
D’Alema?
«Un
uomo di grandi intuizioni. Tutte sbagliate.»
Silvio
Berlusconi?
«Un
grande leader d’opposizione. Che sa vincere le elezioni e ama il potere. Ma
non la politica.»
Giorgio
Napolitano?
«Ottimo
presidente della Repubblica. Che conserva una foto dei carri armati che
invasero l’Ungheria nel ’56. La tiene in cassaforte e la mostra solo ai
compagni.»
Cultura a
sinistra, Paese a destra Una «strana» Italia divisa in due.
Il vizio d'origine? Un'agenda politica, dettata da un antifascismo non sempre
democratico, che trova riscontro solo nelle élite, scrive Roberto Chiarini su
“Il Giornale”. Pubblichiamo qui uno stralcio della Premessa del nuovo saggio
dello storico Roberto Chiarini Alle origini di una strana Repubblica. Perché la
cultura politica è di sinistra e il Paese è di destra. Un libro che spiega i
mali che affliggono l'Italia, risalendo alla formazione della democrazia a
partire dalla caduta del fascismo. I tratti originari della nostra Repubblica
hanno reso operante la democrazia ma, alla distanza, l'hanno anche anchilosata.
L'antifascismo ha comportato l'operatività di una precisa sanzione costrittiva
del gioco democratico, sanzione controbilanciata presto sul fronte opposto da
una opposta e simmetrica, l'anticomunismo. Destra e sinistra si sono trovate in
tal modo, invece che protagoniste - come altrove è «normale» - della dialettica
democratica, solo comprimarie, stabilmente impedite da una pesante
delegittimazione ad avanzare una candidatura in proprio per la guida del paese.
Da ultimo, la configurazione di un «paese legale» connotato da una pregiudiziale
antifascista e di un «paese reale» animato da un prevalente orientamento
anticomunista ha comportato una palese, stridente assimetria tra una società
politica orientata a sinistra in termini sia di specifico peso elettorale che di
obiettivi proposti e un'opinione pubblica molto larga - una maggioranza
silenziosa? - per nulla disposta a permettere svolte politiche di segno
progressista. L'emersione nel 1994, grazie al passaggio a un sistema
tendenzialmente bipolare, della «destra occulta» rimasta per un cinquantennio
senza rappresentanza politica diretta ha risolto solo a metà il problema. È
rimasta l'impossibilità per una forza politica mantenuta - e tenutasi - nel
ghetto per mezzo secolo di esprimere di colpo una cultura, un disegno
strategico, una classe dirigente all'altezza del ruolo di comprimaria della
sinistra. Al deficit di maturità democratica ha aggiunto, peraltro,
un'inclinazione a secondare posizioni vuoi etno-regionaliste (se non
dichiaratamente separatiste) inconciliabili con l'ambizione di costruire una
forza politica di respiro nazionale, vuoi populistico-plebiscitarie in aperta
dissonanza con la destra liberale europea. Tutto ciò ha offerto il destro - e
l'alibi - alla sinistra per persistere in una battaglia di demonizzazione
dell'avversario, contribuendo in tal modo a rinviare una piena rigenerazione di
questa «strana democrazia», normale a parole ma ancora in larga parte
prigioniera di comportamenti ispirati alla delegittimazione del nemico. A
pagarne le conseguenze continuano a essere non solo destra e sinistra, ma anche
le istituzioni democratiche, ingessate come sono in un confronto polarizzato che
ha finito con il comprometterne la capacità operativa, soprattutto sul fronte
delle importanti riforme di cui il Paese ha un disperato bisogno. Il risultato è
stato di erodere pesantemente la credibilità e persino la rappresentatività
delle stesse forze politiche. Lo scontento e la disaffezione insorti per
reazione non potevano non ridare nuova linfa a una disposizione stabilmente
coltivata dall'opinione pubblica italiana, conformata a un radicato pregiudizio
sfavorevole alla politica. Una disposizione che ha accompagnato come un fiume
carsico l'intera vicenda politica repubblicana sin dal suo avvio, tanto da
rendere «il qualunquismo (...) maggioritario nell'Italia repubblicana, sia
presso il ceto intellettuale che presso l'opinione pubblica» (Sergio Luzzatto).
Una sorta di controcanto, spesso soffocato, al predominio incontrastato dei
partiti. S'è detto che la funzione dei partiti è cambiata nel tempo divenendo da
maieutica a invalidante della democrazia, da leva per una politicizzazione della
società a strumento di occupazione dello Stato e, per questa via, a stimolo
dell'antipolitica così come la loro rappresentatività da amplissima si è
progressivamente inaridita. Parallelamente anche le forme, i contenuti, gli
stessi soggetti interpreti dell'antipolitica si sono trasformati nel corso di un
sessantennio. Da Giannini a Grillo, la critica alla partitocrazia ha avuto
molteplici voci (da Guareschi a Montanelli fino a Pannella) e solleticato
svariati imprenditori politici a valorizzarne le potenzialità elettorali (dal
Msi alla Lega, alla stessa Forza Italia, passando per le incursioni sulla scena
politica di movimenti poi rivelatisi effimeri, come la Maggioranza Silenziosa
dei primissimi anni settanta o i «girotondini» di pochi anni fa). Costante è
stata la loro pretesa/ambizione di offrire una rappresentanza politica
all'opinione pubblica inespressa e/o calpestata dai partiti, facendo leva sulla
polarità ora di uomo qualunque vs upp (uomini politici professionali) ora di
maggioranza silenziosa vs minoranza rumorosa, ora di Milano «capitale morale» vs
Roma «capitale politica», ora di cittadini vs casta. Altro punto fermo è stato
la denuncia dello strapotere e dell'invadenza dei partiti accompagnata spesso
dall'irrisione demolitoria della figura del politico strutturato nei partiti,
poggiante sull'assunto che la politica possa - anzi, debba - essere appannaggio
di cittadini comuni. Un significativo elemento di discontinuità s'è registrato
solo negli ultimi tempi. L'antipartitismo prima attingeva a un'opinione pubblica
- e esprimeva istanze - marcatamente di destra, per quanto l'etichetta fosse
sgradita. A partire dagli anni Novanta, viceversa, l'antipolitica mostra di
attecchire anche presso il popolo di sinistra. Un'antipolitica debitamente
qualificata come «positiva» e inserita in un «orizzonte virtuoso», comunque non
meno accesamente ostile nei confronti della «nomenk1atura spartitoria», della
«degenerazione della politica in partitocrazia», dell'«occupazione dello Stato e
della cosa pubblica», dell'«arroccamento corporativo della professione
politica». È l'antipolitica che ha trovato la sua consacrazione nel M5S,
rendendo l'attacco al «sistema dei partiti» molto più temibile e imponendo
all'agenda politica del paese l'ordine del giorno del superamento insieme
dell'asimmetria storica esistente tra paese legale e paese reale e del ruolo
protagonista dei partiti nella vita delle istituzioni.
QUANDO I
BUONI TRADISCONO.
Lunedì 12
luglio 2010. Il tribunale di Milano condanna in primo grado il generale
Giampaolo Ganzer a 14 anni di prigione, 65mila euro di multa e interdizione
perpetua dai pubblici uffici per traffico internazionale di droga, scrive Mario
Di Vito su “Eilmensile”. Il processo andava avanti da cinque anni e nella sua
storia poteva contare sul numero record di oltre 200 udienze. La sentenza
racconta di un Ganzer disposto a tutto pur di fare carriera, in una clamorosa
lotta senza quartiere al narcotraffico. Una lotta che – sostiene il tribunale –
passava anche per l’importazione, la raffinazione e la vendita di quintali di
droga. Il fine giustifica i mezzi, si dirà. Ma, intanto, l’accusa chiese 27 anni
di prigione per il “grande servitore dello Stato”, che “dirigeva e organizzava i
traffici”. L’indagine su Ganzer nacque per merito del pm Armando Spataro che,
nel 1994, ricevette dal generalissimo l’insolita richiesta di ritardare il
sequestro di 200 chili di cocaina. Il Ros sosteneva di essere in grado di
seguire il percorso dello stupefacente fino ai compratori finali. Spataro firmò
l’autorizzazione, ma i i carabinieri procedettero comunque, per poi non dare più
notizia dell’operazione per diversi mesi, cioè fino a quando, di nuovo Ganzer se
ne uscì con la proposta di vendere il carico di cocaina sequestrata a uno
spacciatore di Bari. Spataro – verosimilmente con gli occhi fuori dalle orbite –
ordinò la distruzione immediata di tutta la droga. Quasi vent’anni dopo, la
procura di Milano avrebbe sostenuto che i carabinieri agli ordini di Ganzer
fossero al centro di un traffico enorme e “le brillanti operazioni non erano
altro che delle retate di pesci piccoli messe in atto per gettare fumo negli
occhi dell’opinione pubblica”. La prima vera, grande, pietra miliare
dell’inchiesta è datata 1997, cioè, quando il giudice bresciano Fabio Salamone
raccolse la testimonianza di un pentito, Biagio Rotondo, detto “il rosso”, che
gli raccontò di come alcuni agenti del Ros lo avvicinarono nel 1991 per
proporgli di diventare una gola profonda dall’interno del mercato della droga.
Rotondo si sarebbe poi suicidato in carcere a Lucca, nel 2007. Secondo
l’accusa, i “confidenti del Ros” – reclutati a decine per tutti gli anni ’90 –
erano degli spacciatori utilizzati come tramite con le varie organizzazioni
malavitose. L’indagine – che negli anni è stata rimpallata tra Brescia, Milano,
Torino, Bologna e poi di nuovo Milano, con centinaia di testimonianze e migliaia
di prove repertate– sfociò nella condanna del generalissimo e di altri membri
del Reparto, che, comunque, sono riusciti tutti ad evitare le dimissioni – e il
carcere – poiché si trattava “solo” di una sentenza di primo grado. Il nome di
Ganzer viene messo in relazione anche con uno strano suicidio, quello del 24enne
brigadiere Salvatore Incorvaia che, pochi giorni prima di morire, aveva detto al
padre Giuseppe, anche lui ex militare, di essere venuto a conoscenza di una
brutta storia in cui erano coinvolti “i pezzi grossi”, addirittura “un
maresciallo”. Incorvaia sarebbe stato ritrovato cadavere il 16 giugno 1994, sul
ciglio di una strada, con un proiettile nella tempia che veniva dalla sua
pistola di ordinanza. Nessuno ebbe alcun dubbio: suicidio. Anche se il vetro
della macchina di Incorvaia era stato frantumato, e non dal suo proiettile –
dicono le perizie – che correva nella direzione opposta. Altra brutta storia che
vede protagonista Ganzer – questa volta salvato dalla prescrizione – riguarda un
carico di armi arrivato dal Libano nel 1993: 4 bazooka, 119 kalashnikov e 2
lanciamissili che, secondo l’accusa, i Ros avrebbero dovuto vendere alla
‘ndrangheta. Zone d’ombra, misteri, fatti sepolti e mai riesumati. Tutte cose
che ora non riguarderanno più il generale Giampaolo Ganzer, già proiettato verso
una vecchiaia da amante dell’arte. Fuori da tutte quelle vicende assurde, ma
“nei secoli fedele”.
«Traditore
per smisurata ambizione».
Questa una delle motivazioni per le quali i giudici dell’ottava sezione penale
di Milano hanno condannato a 14 anni di carcere il generale del Ros Giampaolo
Ganzer, all’interdizione dai pubblici uffici e alla sanzione di 65 mila
euro, scrive “Il Malcostume”. Erano i giorni di Natale del 2010 quando arrivò
questa incredibile sentenza di primo grado. Secondo il Tribunale, il comandante
del Reparto operativo speciale dell’arma, fiore all’occhiello dei Carabinieri,
tra il 1991 e il 1997 «non si è fatto scrupolo di accordarsi con
pericolosissimi trafficanti ai quali ha dato la possibilità di vendere in Italia
decine di chili di droga garantendo loro l’assoluta impunità», dunque «Ganzer
ha tradito per interesse lo Stato e tutti i suoi doveri tra cui quello di
rispettare e fare rispettare la legge». Tutto questo possibile perché «all’interno
del raggruppamento dei Ros c’era un insieme di ufficiali e sottufficiali che, in
combutta con alcuni malavitosi, aveva costituito un’associazione finalizzata al
traffico di droga, al peculato, al falso, al fine di fare una rapida carriera».
La pm Maria Luisa Zanetti aveva chieso 27 anni per il generale Ganzer, ma
il tribunale aveva ridotto la condanna a 14 anni, in quanto la Corte presieduta
da Luigi Capazzo non ha riconosciuto il reato di associazione a
delinquere. Ma non ha concesso nemmeno le attenuanti generiche all’alto
ufficiale, in quanto «pur di tentare di sfuggire alle gravissime
responsabilità della sua condotta, Ganzer ha preferito vestire i panni di un
distratto burocrate che firmava gli atti che gli venivano sottoposti, dando agli
stessi solo una scorsa superficiale». Secondo i giudici, inoltre «Ganzer
non ha minimamente esitato a fare ricorso a operazioni basate su un metodo
assolutamente contrario alla legge ripromettendosi dalle stesse risultati di
immagine straordinari per sé stesso e per il suo reparto». 17 i
condannati nel processo, tra cui il narcotrafficante libanese Jean Bou
Chaaya (tuttora latitante) e molti carabinieri: il colonnello Mario Obinu
(ai servizi segreti) con 7 anni e 10 mesi, 13 anni e mezzo a Gilberto Lovato,
10 anni a Gianfranco Benigni e Rodolfo Arpa, 5 anni e 4 mesi a
Vincenzo Rinaldi, 5 anni e 2 mesi a Michele Scalisi, 6 anni e 2 mesi
ad Alberto Lazzeri Zanoni, un anno e mezzo a Carlo Fischione e
Laureano Palmisano. La clamorosa condanna del generale Ganzer fu accolta tra
il silenzio dell’allora ministro della Difesa Ignazio La Russa, la
solidarietà dell’allora ministro dell’Interno Roberto Maroni e la difesa
dell’ex procuratore antimafia Pierluigi Vigna, benché questa brutta
vicenda che “scuote l’arma” avrebbe dovuto portare alla sospensione della
carica e quindi del servizio di Ganzer, in ottemperanza all’articolo 922 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, la cosiddetta “norma di rinvio” che
dice: “Al personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di
sospensione dall’impiego previste dall’art 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97”
che attiene alle “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche” e che all’articolo 4 dice espressamente: “In
caso di condanna, anche non definitiva, per alcuno dei delitti indicati
all’articolo 3 comma 1, i dipendenti sono sospesi dal servizio”. Tra i
delitti considerati c’è pure il peculato, reato contemplato nella sentenza a
carico di Ganzer. Eppure, da allora, il generale Ganzer è rimasto in carica
nonostante “I Carabinieri valutano il trasferimento“, malgrado i numerosi
appelli alla responsabilità e all’opportunità delle dimissioni giunti da più
parti. Ganzer non ha mai mollato la poltrona e nessun ministro (La Russa
allora, Di Paola poi) gli ha fatto rispettare la legge, a parte
un’interrogazione parlamentare del deputato radicale Maurizio Turco.
Ganzer ha continuato a dirigere il Ros, ad occuparsi di inchieste della portata
di Finmeccanica, degli attentatori dell’ad di Ansaldo Roberto Adinolfi, senza
contare le presenze ai dibattiti sulla legalità al fianco dell’ex
sottosegretario del Pdl Alfredo Mantovano, suo grande difensore. Proprio
in questi giorni l’accusa in un processo parallelo, ha chiesto 8 anni di
condanna per Mario Conte, ex pm a Bergamo che firmava i decreti di
ritardato sequestro delle partite di droga per consentire alla cricca di
militari guidati da Ganzer di poterla rivendere ad alcune famiglie di
malavitosi. La posizione di Conte era stata stralciata per le sue precarie
condizioni di salute. Ebbene, in attesa della sentenza e senza un solo
provvedimento di rimozione dall’incarico anche a protezione del buon nome del
Ros, ora Ganzer lascia il comando del Reparto. Non per l’infamante
condanna. Ma “per raggiunti limiti d’età” . Ganzer lascerà il posto al
generale Mario Parente per andare in pensione. Da «Traditore per smisurata
ambizione» a fruitore di (smisurata?) pensione. Protetto dagli uomini delle
istituzioni e alla faccia di chi la legge la rispetta.
E poi ancora.
Sono stati arrestati dai loro stessi colleghi, per il più odioso dei reati,
quello di violenza sessuale, ancora più odioso perché compiuto su donne sotto la
loro custodia, una delle quali appena maggiorenne. A finire nei guai tre agenti
di polizia in servizio a Roma raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa dalla Procura della capitale ed eseguita dagli agenti della
Questura.
Ed ancora.
Erano un corpo nel corpo. Sedici agenti della Polizia Stradale di Lecce sono
stati arrestati con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al falso
ideologico e alla concussione ambientale. I poliziotti erano 20 anni che, stando
alle accuse, omettevano i controlli ai mezzi di trasporto di circa 100 ditte del
Salento in cambio di denaro e merce varia. Dalle intercettazioni telefoniche è
emerso che ogni agente racimolasse da questa attività extra qualcosa come 40.000
euro ogni 3 anni . Il “leader” dell’ organizzazione sarebbe l’ ispettore capo
Francesco Reggio, 57 anni, leccese. Nel corso di una telefonata intercettata
Reggio si sarebbe complimentato con un suo collega che, grazie alle somme
intascate, sarebbe andato anticipatamente in pensione. L’ indagine è partita
solo quando sulla scrivania del procuratore capo di Lecce, Cataldo Motta, è
arrivata una denuncia anonima contenente i nomi degli agenti e delle ditte
coinvolte. Un’ altra lettera, questa volta non anonima, arrivata successivamente
in Procura è partita invece proprio dall’interno della sezione di Polizia
Stradale di Lecce.
Ed Ancora. Tre
agenti di polizia e cinque immigrati sono stati arrestati dalla Squadra Mobile
della Questura di
Venezia nell'ambito di un'inchiesta che ha accertato il rilascio di permessi di
soggiorno in mancanza di requisiti di legge, sulla base di documentazione
falsificata.
Ed Ancora.
Arrestati due carabinieri nel Barese, chiedevano soldi per chiudere un occhio.
Facevano coppia, sono stati bloccati dai loro colleghi del comando provinciale
di Bari e della squadra mobile del capoluogo. A due ragazzi fermati durante un
controllo anti-prostituzione avevano chiesto denaro prospettando una denuncia
per sfruttamento.
Ecc. Ecc. Ecc.
G8 Genova.
Cassazione: "A Bolzaneto accantonato lo Stato di Diritto".
La Suprema corte rende note le motivazioni della sentenza dello scorso 14 giugno
2013. "Contro i manifestanti portati in caserma violenze messe in atto per dare
sfogo all'impulso criminale". "Inaccoglibile", secondo la Quinta sezione penale,
"la linea difensiva basata sulla pretesa inconsapevolezza di quanto si
perpetrava all’interno delle celle", scrive "Il Fatto Quotidiano". Un “clima di
completo accantonamento dei principi-cardine dello Stato di
diritto”. La Cassazione mette nero su bianco quello che accadde nella
caserma di Bolzaneto dove furono portati i manifestanti no
global arrestati e percossi durante il G8 di Genova nel
luglio del 2001: “Violenze senza soluzione di continuità” in condizioni di
“assoluta percettibilità visiva e auditiva da parte di chiunque
non fosse sordo e cieco”. Nelle 110 pagine depositate oggi
dalla Suprema corte si spiega perché, lo scorso 14 giugno 2013, sono state rese
definitive sette condanne e accordate quattro
assoluzioni per gli abusi alla caserma contro i
manifestanti fermati. La Cassazione ha così chiuso l’ultimo dei grandi
processi sui fatti del luglio 2001. Nel precedente
verdetto d’appello, i giudici avevano dichiarato prescritti i
reati contestati a 37 dei 45 imputati originari tra poliziotti,
carabinieri, agenti penitenziari e medici – riconoscendoli comunque responsabili
sul fronte dei risarcimenti. Risarcimenti che però la sentenza
definitiva ha ridotto. I giudici puntano il dito contro chi era preposto al
comando: “Non è da dubitarsi che ciascuno dei comandanti dei
sottogruppi, avendo preso conoscenza di quanto accadeva, fosse soggetto
all’obbligo di impedire l’ulteriore protrarsi delle
consumazioni dei reati”. Oltretutto, scrive la Cassazione “non risulta dalla
motivazione della sentenza che vi fossero singole celle da riguardare come oasi
felici nelle quali non si imponesse ai reclusi di mantenere la posizione
vessatoria, non volassero calci, pugni o schiaffi al
minimo tentativo di cambiare posizione, non si adottassero le modalità
di accompagnamento nel corridoio (verso il bagno o gli uffici) con le
modalità vessatorie e violente riferite” dai testimoni
ascoltati nel processo. I giudici di piazza Cavour denunciano come il
“compimento dei gravi abusi in danno dei detenuti si fosse reso
evidente per tutto il tempo, data l’imponenza delle risonanze vocali, sonore,
olfattive e delle tracce visibili sul corpo e sul vestiario delle vittime”. Ecco
perché, osserva la Quinta sezione penale, è “inaccoglibile la linea
difensiva basata sulla pretesa inconsapevolezza di
quanto si perpetrava all’interno delle celle, e anche nel corridoio durante gli
spostamenti, ai danni di quei detenuti sui quali i sottogruppi avrebbero dovuto
esercitare la vigilanza, anche in termini di protezione della loro incolumità”.
La Cassazione
descrive inoltre i comportamenti inaccettabili di chi aveva il
comando e non ha mosso un dito per fermare le violenze sui no global: “E’ fin
troppo evidente che la condotta richiesta dei comandanti dei sottogruppi
consisteva nel vietare al personale dipendente il compimento di atti la cui
illiceità era manifesta: ciò non significa attribuire agli imputati una
responsabilità oggettiva, ma soltanto dare applicazione” alla norma che regola “la
posizione di garanzia da essi rivestita in virtù della
supremazia gerarchica sugli agenti al loro comando”. Erano poi “ingiustificate”
le vessazioni ai danni dei fermati “non necessitate dai comportamenti di costoro
e riferibili piuttosto alle condizioni e alle caratteristiche delle persone
arrestate, tutte appartenenti all’area dei no global”, si legge nelle
motivazioni. Insomma, conclude la Suprema corte, le violenze commesse alla
caserma di Bolzaneto sono state un “mero pretesto, un’occasione per dare
sfogo all’impulso criminale“.
Scaroni,
l'ultras reso invalido dalla polizia:
"Dopo anni aspetto giustizia". Il giovane tifoso del Brescia il 24 settembre del
2005 è stato ridotto in fin di vita alla stazione di Verona dagli agenti. Nella
sentenza di primo grado i giudici hanno stabilito la responsabilità delle forze
dell'ordine ("hanno picchiato con il manganello al contrario"), ma nessuna
possibilità di individuare le responsabilità personali. Per questo gli imputati
sono stati tutti assolti, scrive David Marceddu su "Il Fatto Quotidiano". ”Sai
cosa? Secondo me quel giorno alla stazione di Verona
cercavano il morto”. Paolo Scaroni a otto anni esatti da quel pomeriggio di fine
estate in cui la sua vita è totalmente cambiata, alcune idee le ha chiare. Sa
che lui, che ne è uscito miracolosamente vivo, è uno dei pochi che può, e deve,
raccontare. ”Patrizia Moretti, la madre di Federico Aldrovandi,
me lo dice sempre: io posso essere quella voce che altri non hanno più”, spiega
a ilfattoquotidiano.it. Per il giovane tifoso del Brescia, ridotto in fin di
vita a colpi di manganello da agenti di polizia il 24 settembre 2005, per
tragica coincidenza proprio la sera prima dell’omicidio di “Aldro” a Ferrara, la
battaglia nelle aule di giustizia continua: il pubblico ministero della procura
scaligera, Beatrice Zanotti ha presentato a fine aprile il ricorso in appello
contro l’assoluzione di sette poliziotti del Reparto mobile di Bologna. Per la
sentenza di primo grado a pestare l’ultras dopo la partita tra Hellas e Brescia
furono sicuramente dei poliziotti, ma non c’è la prova che
siano stati proprio Massimo Coppola, Michele Granieri, Luca Iodice, Bartolomeo
Nemolato, Ivano Pangione, Antonio Tota e Giuseppe Valente, e non invece altri
appartenenti alla Celere (l’ottavo imputato, un autista, è stato scagionato per
non aver commesso il fatto). Erano 300 in stazione quel pomeriggio tutti in
divisa, tutti col casco, irriconoscibili. Paolo Scaroni, 36 anni, fino al
”maledetto giorno” era un fiero allevatore di tori. Ora, invalido al 100%, dalla
sua casa di Castenedolo dove abita con la moglie, lotta giorno per giorno per
ritrovare una vita un po’ normale. Adesso potrà forse avere un
risarcimento: ora che un giudice ha detto che quello fu un ”pestaggio
gratuito”, ”immotivato rispetto alle esigenze di uso legittimo della forza, di
un giovane, con danni gravissimi allo stesso”, avere qualcosa indietro dallo
Stato potrebbe essere più facile. Il giudice infatti dice che non ci sono prove
sull’identità dei poliziotti colpevoli, ma sulla responsabilità della Polizia
non ci sono dubbi. ”E finora, anche se proprio in questi giorni lo Stato ha
avviato con me una sorta di trattativa, non ho avuto neanche un euro”. Per tutti
questi anni Scaroni è stato omaggiato da migliaia di tifosi in tutta Italia, che
ne hanno fatto un simbolo delle ingiustizie subite dal mondo ultras. Lui, che
ormai raramente va allo stadio, si gode questa vicinanza, ma lamenta la
lontananza delle autorità: ”Solo il questore di Brescia mi ha fatto sentire la
sua solidarietà. Avevo scritto a Roberto Maroni quando era ministro
dell’Interno, persino al Papa. Niente”. Paolo porta sul suo corpo i segni di
quel giorno. La diagnosi dei medici non lasciava molte speranze: ”Trauma
cranio cerebrale. Frattura affondamento temporale destra. Voluminoso
ematoma extradurale temporo parietale destro”. Una persona spacciata: ”Il medico
legale si spaventò perché nonostante fossi in fin di vita non avevo un livido
nel corpo. Avevano picchiato solo in testa”. E avevano picchiato,
certifica il giudice Marzio Bruno Guidorizzi, ”con una certa
impugnatura” del manganello ”al contrario”.
Diritti
umani, governo Usa attacca l'Italia:
“Polizia violenta, carceri invivibili, Cie, femminicidio…”. Un dossier
governativo analizza la situazione di 190 Paesi. Nel nostro, sotto accusa forze
dell'ordine, carceri, Cie, diritti dei rom, violenza sulle donne..., scrive
“FanPage”. Secondo il Governo americano i “principali problemi
risiedono nelle condizioni dei detenuti, con le carceri sovraffollate,
la creazione dei Cie per i migranti, i pregiudizi e l'esclusione sociale di
alcune comunità”. Senza dimenticare “l'uso eccessivo della forza da
parte della polizia, un sistema giudiziario inefficiente, violenza e
molestie sulle donne, lo sfruttamento sessuale dei minori, le aggressioni agli
omosessuali, bisessuali e trans e la discriminazione sui luoghi di lavoro sulla
base dell'orientamento sessuale”. Al sud, denunciati anche i casi di
sfruttamento di lavoratori irregolari. Il prende in esame il caso di
Federico Aldrovandi e quello di Marcello Valentino Gomez Cortes, entrambi uccisi
a seguito di normali controlli di polizia. Ma si critica anche l'assenza del
reato di tortura nel nostro ordinamento giuridico e le violenze che subiscono
autori di piccoli reati da parte di alcuni agenti. Sotto accusa anche i
rimpatri forzati degli immigrati irregolari, oppure la loro detenzione nei
centri di identificazione ed espulsione: “Il 24 maggio decine di detenuti in un
centro di Roma sono stati coinvolti in una rivolta contro quattro guardie, che
hanno utilizzato gas lacrimogeni per impedirne la fuga. L'episodio ha seguito le
proteste della settimana precedente nei Cie di Modena e Bologna. Un rapporto del
Comitato dei Diritti Umani del Senato ha denunciato la promiscuità tra adulti e
minori, il sovraffollamento, i lunghi periodi di detenzione e l'inadeguato
accesso di avvocati e mediatori culturali”. Sotto accusa anche le frequenti
discriminazioni ai danni dei cittadini romanì: “Le violenze nei
confronti di rom, sinti e camminanti rimangono un problema. Durante il
2012 le popolazioni rom sono state sottoposte a discriminazioni da parte di
autorità comunali, soprattutto attraverso sgomberi forzati non autorizzati”.
Naturalmente il report governativo non tralascia le violenze sulle donne, il
femminicidio, l'antisemitismo e il lavoro nero.
Polizia
violenta, la garanzia dell'anonimato.
In Europa gli
agenti portano un codice personale sulla divisa. In Italia no. E, in caso di
abusi, non sono identificabili, scrive di Alessandro Sarcinelli su “Lettera
43. Sarebbero bastati tre numeri e tre lettere sulla divisa e sul casco dei
poliziotti in tenuta anti-sommossa. Sarebbe bastato un semplice codice
alfanumerico e Lorenzo Guadagnucci, giornalista del Quotidiano Nazionale,
avrebbe potuto denunciare chi a manganellate gli spaccò entrambe le braccia, la
notte del 21 luglio 2001 alla scuola Diaz durante il G8. Invece non ha mai
saputo chi stava dietro la furia incontrollata dei manganelli. Dopo 12 anni in
Italia nulla è cambiato e i poliziotti del reparto mobile non sono ancora
identificabili. Per questo in caso di abusi, la magistratura non ha la
possibilità di individuarne i responsabili. In tutto questo tempo ci sono state
numerose petizioni e raccolte firme. Lo scorso febbraio durante l’ultima
campagna elettorale, 117 candidati poi divenuti parlamentari hanno sottoscritto
la campagna Ricordati che devi rispondere proposta da Amnesty
International: il primo punto riguardava proprio la trasparenza delle forze di
polizia. Tuttavia non si è mai arrivati neanche a una proposta di legge in
parlamento. «Nel nostro Paese c’è una bassa consapevolezza su quali siano i
limiti all’uso della forza dei pubblici funzionari. Viviamo nelle tenebre», ha
attaccato Guadagnucci. L’articolo 30 del nuovo ordinamento di pubblica sicurezza
del 1981 recita: «Il ministro dell’Interno con proprio decreto determina le
caratteristiche delle divise degli appartenenti alla polizia di Stato nonché i
criteri generali concernenti l’obbligo e le modalità d’uso». Se in fondo a
questa legge si aggiungesse la formula «compresi i codici alfanumerici» la
questione sarebbe risolta. In oltre 30 anni nessun ministro dell’Interno ha mai
preso in considerazione questa modifica. Non è andata così invece nei principali
paesi europei: i codici alfanumerici sulle divise delle forze dell’ordine sono
infatti attualmente in uso in Inghilterra, Germania, Svezia, Spagna, Grecia,
Turchia e Slovacchia. In Francia non esistono ancora ma qualche mese fa, Manuel
Valls, attuale ministro dell’Interno, ne ha annunciato l'introduzione a breve.
Inoltre, nel dicembre 2012 una risoluzione del parlamento Europeo ha chiesto
esplicitamente ai paesi che non hanno ancora adottato i codici di avviare una
riforma. Ciononostante, la politica italiana non ha mostrato particolare
interesse sull’argomento: dei tre principali partiti solo il M5s si è detto
completamente favorevole all’introduzione dei codici. Mentre Pd e Pdl non hanno
trovato il tempo per esprimere la loro opinione. A causa di questo disinteresse
è calato il silenzio sul tema. Ma ogni volta che la cronaca riaccende il
dibattito l’opinione pubblica si divide tra chi è a favore della polizia e chi è
a favore dei manifestanti. Posizioni intermedie non sembrano esistere. Secondo
Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, l’arroccamento su
queste posizioni è frutto di un malinteso: «In Italia introdurre norme
riguardanti i diritti umani delle forze di polizia equivarrebbe a stigmatizzarne
il comportamento. In realtà l’introduzione dei codici servirebbe a individuare
solo i comportamenti penalmente rilevanti». In qualche modo quindi sarebbe uno
strumento per tutelare il corpo di polizia nel suo insieme dalle azioni illegali
dei singoli. Non la pensa così Nicola Tanzi, segretario generale Sap (Sindacato
autonomo di polizia): «Il manifestante violento tramite il codice sulla divisa
può risalire all’identità del poliziotto mettendo in pericolo l’incolumità sua e
dei suoi familiari». È bene precisare, tuttavia, che per abbinare a un codice
l’identità di un agente bisognerebbe avere un infiltrato all’interno della
polizia che fornisse queste informazioni. Secondo molte realtà della società
civile, l’uso (e l’abuso) della forza da parte della polizia non va affrontato
solo da un punto di vista legislativo ma anche culturale. Guadagnucci è convinto
che uno dei problemi principali sia la poca trasparenza: «All’interno della
polizia si risente ancora di cultura militare e corporativa e non si è
sviluppato un forte senso democratico», un’atmosfera da «non vedo, non sento,
non parlo». I vertici del Sap, però, non ci stanno, dicendosi convinti che «non
ci sia nel modo più assoluto un problema di trasparenza». Il primo in Italia a
proporre i codici identificativi per le forze dell’ordine fu Giuseppe Micalizio,
braccio destro dell’allora capo della polizia Gianni De Gennaro. Era il 22
luglio 2001 e Micalizio era stato inviato a Genova per fare una relazione
dettagliata sull’irruzione alla scuola Diaz, ma i suoi consigli rimasero rimasti
inascoltati da tutti, politica compresa. All’orizzonte non si intravede nessun
cambiamento e, secondo Amnesty International, per questo si è interrotto il
rapporto di fiducia tra cittadinanza e forze dell’ordine, fondamentale in uno
stato democratico. Ma per Noury c’è qualcosa di ancora più grave: «Tutto ciò
che ha consentito che la “macelleria messicana” della Diaz accadesse c’è ancora.
Quindi potrebbe succedere ancora». A Genova o in qualsiasi altra città italiana.
Antonio
Giangrande, orgoglioso di essere diverso.
“Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio
i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Ha mai
pensato, per un momento, che c’è qualcuno che da anni lavora indefessamente per
farle sapere quello che non sa? E questo al di là della sua convinzione di
sapere già tutto dalle sue fonti?
Provi a
leggere un e-book o un book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede
veramente nella sua regione o in riferimento alla sua professione. Cose che
nessuno le dirà mai.
Non troverà le
cose ovvie contro la Mafia o Berlusconi o i complotti della domenica. Cose che
servono solo a bacare la mente. Troverà quello che tutti sanno, o che provano
sulla loro pelle, ma che nessuno ha il coraggio di raccontare.
Può anche non
leggere questi libri, frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza imperante che
impedisce l’evoluzione non potrà dire che la colpa è degli altri e che gli altri
son tutti uguali.
“Pensino ora i
miei venticinque lettori che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto,
quello che s'è raccontato”. Citazione di Alessandro Manzoni.
DUE COSE SU
AMNISTIA, INDULTO ED IPOCRISIA.
“Gli
italiani, giustizialisti? No! Disinformati ed ignoranti. Se l'amnistia e
l'indulto serve a ristabilire una sorta di giustizia riparatrice per redimere
anche i peccati istituzionali: ben vengano.”
E’ chiaro e
netto il pensiero di Antonio Giangrande, scrittore e cultore di sociologia
storica ed autore della Collana editoriale "L'Italia del Trucco, l'Italia che
Siamo" edita su Amazon.it con decine di titoli.
Gli italiani
non vogliono né l'indulto né l'amnistia. A mostrarlo e dimostrarlo il sondaggio
Ispo per il Corriere: il 71 per cento degli intervistati ha detto no a ogni
provvedimento di clemenza. Un vero e proprio plebiscito contro che unisce,
trasversalmente, l'elettorato da sinistra a destra. Sempre secondo Ispo tra chi
vota Pd è la maggioranza (il 67%) a essere contraria. Così come nell'elettorato
del Pdl dove, nonostante ci sia di mezzo il futuro politico e non solo di
Berlusconi, qualunque idea di "salvacondotto " non piace per nulla. Il 63 (%
contro 35) dice no. Allineanti sulla linea intransigente anche gli elettori M5s:
contrari 3 e su 4. Questi sondaggi impongono ai politicanti l'adozione di atti
che nel loro interesse elettorale devono essere utili, più che giusti.
Da cosa nasce
questo marcato giustizialismo italico?
Dall’ignoranza, dalla disinformazione o dall’indole cattiva e vendicativa dei
falsi buonisti italici?
Prendiamo in
esame tre fattori, con l’ausilio di Wikipedia, affinchè tutti possano trovare
riscontro:
1. Parliamo
dei giornalisti e della loro viltà a parlare addirittura delle loro disgrazie.
Carcere per aver espresso la loro libertà di stampa scomoda per i potenti. Dice
Filippo Facci: «Siamo una masnada di fighetti neppure capaci di essere una
corporazione, anzi peggio, siamo dei professionisti terminali e già «morti» come
direbbe un qualsiasi Grillo. La Corte di Strasburgo ha sancito che il carcere
per un giornalista - Maurizio Belpietro, nel caso - costituisce una sproporzione
e una violazione della libertà di espressione. È una sentenza che farà
giurisprudenza più di cento altri casi, più della nostra Cassazione, più degli
estenuanti dibattiti parlamentari che da 25 anni non hanno mai partorito una
legge decente sulla diffamazione. Il sindacato dei giornalisti si è detto
soddisfatto e anche molti quotidiani cartacei (quasi tutti) hanno almeno dato la
notizia, che resta essenzialmente una notizia: ora spiegatelo ai censori del
Fatto Quotidiano, a questi faziosi impregnati di malanimo che passano la vita a
dare dei servi e chi non è affiliato al loro clan. Non una riga. Niente». Bene.
I giornalisti, censori delle loro disgrazie, possono mai spiegare bene cosa
succede prima, durante e dopo i processi? Cosa succede nelle quattro mura delle
carceri, laddove per paura e per viltà tutto quello che succede dentro, rimane
dentro?
2. Parliamo
dei politici e della loro ipocrisia.
Sovraffollamento e mancanza di dignità.
«È inaccettabile, non più tollerabile, il sovraffollamento delle carceri
italiane». La presidente della Camera Laura Boldrini visita Regina Coeli, nel
quartiere di Trastevere, a Roma, dove lei vive. «Dignità, dignità», urlano i
detenuti della terza sezione, le cui celle ospitarono durante il fascismo
Pertini e Saragat, al passaggio della presidente della Camera denunciando le
condizioni «insostenibili» di sovraffollamento in cui sono costretti a vivere.
«Il tema carceri è una cruciale cartina di tornasole del livello di civiltà di
un Paese», dice Boldrini, che si ferma ad ascoltare storie e istanze. «Chi ha
sbagliato è giusto che paghi, non chiediamo sconti - aggiunge - ma che ci sia la
rieducazione del detenuto: che chi entra in carcere possa uscirne migliore. E
invece con il sovraffollamento, che è come una pena aggiuntiva, si crea
tensione, abbrutimento, promiscuità e si tira fuori il peggio delle persone.
Questo, come ha detto il presidente della Repubblica, è inaccettabile in un
Paese come l'Italia». Boldrini invoca «quanto prima» una «risposta di dignità»
per superare «una condizione disumana che non fa onore al Paese di Beccaria».
Innocenti
in carcere.
Ma soprattutto, secondo la presidente della Camera, bisogna «ripensare il
sistema della custodia cautelare, perché non è ammissibile che più del 40% dei
detenuti sia in attesa di condanna definitiva, con il rischio di danni
irreparabili se innocenti. E bisogna pensare a misure alternative alle pene
detentive».
3. Parliamo
della sudditanza alla funzione giudiziaria e della convinzione della sua
infallibilità.
Il
giustizialismo. Nel linguaggio politico e giornalistico italiano indica una
supposta ideologia che vede la funzione giudiziaria al pari di un potere e come
tale il più importante e lo sostiene, o anche la presunta volontà di alcuni
giudici di influenzare la politica o abusare del proprio potere. Esso si
contrappone al garantismo, che invece è un principio fondamentale del sistema
giuridico: le garanzie processuali e la presunzione di non colpevolezza hanno un
valore prevalente su qualsiasi altra esigenza di esercizio e pubblicità
dell'azione penale anche nella sua fase pre-giudiziale; tale principio è sancito
anche dalla Costituzione: « La responsabilità penale è personale. L'imputato non
è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.»
La
negazione dell’errore giudiziario e la idolatria dei magistrati.
E’ certo che
gli umani siano portati all’errore. E’ certo anche che gli italiani hanno il dna
di chi è propenso a sbagliare, soprattutto per dolo o colpa grave. E' palese
l'esistenza di 5 milioni di errori giudiziari dal dopo guerra ad oggi. E'
innegabile che il risarcimento per l'ingiusta detenzione dei detenuti innocenti
è un grosso colpo all'economia disastrata dell'Italia. Nonostante l'idolatria è
risaputo che i magistrati italiani non vengono da Marte.
Sin dal Corpus
iuris il reato di denegata giustizia era oggetto di previsione normativa. La
novella 17 colpiva quei magistrati che obbligavano i sudditi ad andare ad
implorare giustizia dall'imperatore, perché gli era stata negata dai magistrati
locali. La novella 134 puniva con la multa di 3 libbre d'oro il giudice di
quella provincia, che, malgrado avesse ricevuto lettere rogatorie, trascurasse
l'arresto di un malfattore che si fosse rifugiato nella detta provincia; la
medesima pena era comminata agli ufficiali del giudice. In tempi più recenti,
nonostante il plebiscitario esito della consultazione referendaria tenutasi sul
tema nel 1987, la legge n. 117 del 1989 di fatto snaturò e vanificò il diritto
al conseguimento del risarcimento del danno per una condotta dolosa o colposa
del giudice. Essa stravolse il risultato del referendum e il principio stesso
della responsabilità personale del magistrato, per affermare quello, opposto,
della responsabilità dello Stato: vi si prevede che il cittadino che abbia
subìto un danno ingiusto a causa di un atto doloso o gravemente colposo da parte
di un magistrato non possa fargli causa, ma debba invece chiamare in giudizio lo
Stato e chiedere ad esso il risarcimento del danno. Se poi il giudizio sarà
positivo per il cittadino, allora sarà lo Stato a chiamare a sua volta in
giudizio il magistrato, che, a quel punto, potrà rispondere in prima persona, ma
solo entro il limite di un terzo di annualità di stipendio, (di fatto è un
quinto, oltretutto coperto da una polizza assicurativa che equivale intorno ai
cento euro annui). Quella legge ha così raggiunto il risultato di confermare un
regime di irresponsabilità per i magistrati. L'inadeguatezza della legge n. 117
del 1989 è dimostrata dal fatto che, a decenni dalla sua entrata in vigore, non
si registra una sola sentenza di condanna dello Stato italiano per
responsabilità colposa del giudice, nonostante le numerosissime sentenze con cui
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha acclarato inadempimenti dello Stato
italiano. L'esigenza di rivedere la legge n. 117 del 1989 viene ora avvertita
anche al fine di dare piena attuazione alla novella costituzionale approvata sul
tema del giusto processo, nonché al fine di dare concreta esecuzione del
principio consacrato dall'articolo 28 della Costituzione: tali norme subiscono
ingiustificabili limitazioni in riferimento alla responsabilità dei giudici.
Il sistema
della responsabilità civile dei magistrati in Italia deroga quindi alla "grande
regola" della responsabilità aquiliana, secondo quanto è riconducibile agli
altri pubblici funzionari (ai sensi dell'articolo 28 Cost. e con la possibilità
di agire in regresso verso lo Stato). La peculiarità giustificata ai magistrati
è quella della delimitazione al dolo ed alla colpa grave (articolo 3), e la
garanzia di insindacabilità (articolo 2) che fu riconosciuta nella citata
sentenza n. 18 del 1989, per la quale "l'autonomia di valutazione dei fatti e
delle prove e l'imparziale interpretazione delle norme di diritto (…) non può
dar luogo a responsabilità del giudice". Il rapporto tra questa peculiarità e la
denegata giustizia è però assai problematico. La responsabilità civile del
giudice sussiste in un giudizio procedurale, non del merito, ad esempio per la
violazione di termini perentori per l'uso delle intercettazioni, custodia
cautelare, notifica di atti o precetti, prescrizione dei reati. Stante questo
vincolo, con la normativa attuale restano necessari comunque due procedimenti
separati (coi relativi tre gradi di giudizio), uno per l'ammissibilità, perché
la richiesta non deve sindacare l'autonomia del giudice, e uno vero e proprio
per la richiesta di risarcimento.
Detto questo,
cosa ne sa la massa di come si abilita alla funzione giudiziaria e quali siano
le capacità, anche psicologiche di chi giudica? Cosa ne sa la massa di cosa
significa errore giudiziario e questo riguarda prima o poi una persona (anche se
stessi, non solo gli altri) e la sua dignità nella società ed in carcere, dove
torture e violenze sono relegate all’oblio o al segreto del terrore? Cosa ne sa
la massa se chi (i giornalisti), dovendo loro dare corretta e completa
informazione, non sa tutelare nemmeno se stesso?
Ed ecco
allora che l'ultimo sport dei giustizialisti è attaccare Balotelli.
Il commissario
della Nazionale Prandelli ha deciso di portarlo ugualmente a Napoli, nonostante
Balotelli fosse infortunato, per la sfida contro l'Armenia. Qualcuno ha scritto
che ci sarebbe andato anche come testimonial anti-camorra perché prima del match
l'Italia avrebbe giocato su un campo sequestrato ai clan. Senza dire questo
qualcuno, però, come il campo sia stato assegnato ed a chi. Questo qualcuno si è
arrogato il diritto di dare una funzione a Balotelli, senza che questo sia
consultato. Lui ha letto e ha spiegato su Twitter: «Questo lo dite voi. Io vengo
perché il calcio è bello e tutti devono giocarlo dove vogliono e poi c'è la
partita». Questo è bastato a scatenare la reazione indignata di politici,
parroci, pseudointellettuali. Tutti moralisti, perbenisti e giustizialisti.
Perché, secondo loro, questa affermazione sarebbe scorretta, volgare non nella
forma ma nella sostanza, perché ci si legge un sottotesto che strizza l'occhio
ai clan.
Poi,
naturalmente c’è chi va sopra le righe, per dovere di visibilità. Perche?
Bisogna chiederlo a Rosaria Capacchione, senatrice Pd e giornalista che è stata
la prima ad attaccarlo: «È un imbecille». Subito dopo al parroco don Aniello
Manganiello: «Mi chiedo se Balotelli abbia ancora diritto a essere convocato
nella Nazionale». Aggiungetevi una serie di insulti sui social network, le
dichiarazioni dei politici locali e avrete il quadro della situazione. Napoli.
In terra di Camorra spesso è difficile diversificare il camorrista da chi non lo
è. C'è chi sparla e c'è chi tace; c'è chi spara e c'è chi copre. A voi sembra
che meriti tutto questo (il bresciano Balotelli)? Si chiede Giuseppe De Bellis
su “Il Giornale”. È tornato quello stanco ritornello dei personaggi popolari che
devono essere da esempio. Dovere, lo chiamano. È un insulto all'intelligenza di
chi queste frasi le dice.
C'è il
legittimo sospetto che Balotelli sia soltanto uno straordinario capro
espiatorio. Un bersaglio facile: lo attacchi e non sbagli, perché tanto qualche
sciocchezza la fa di sicuro. Siamo alla degenerazione della critica: sparo su
Balotelli perché così ho i miei trenta secondi di popolarità. È questo ciò che è
accaduto. Lui sbaglia, eccome se sbaglia. In campo e fuori è già successo un
sacco di volte. Questa sarà solo un'altra, devono aver pensato i professionisti
dell'anticamorra: buttiamoci, perché noi siamo i giusti e lui è quello
sbagliato. Coni, Federazione, Nazionale non hanno avuto nulla di meglio da dire
che «Balotelli se le cerca», oppure, «poteva risparmiarsela». Avrebbero dovuto
dire solo una cosa: non usate lo sport e gli sportivi per le vostre battaglie
partigiane. Ci vuole coraggio per stare al proprio posto. A ciascuno il suo e
l'anticamorra non spetta al centravanti della Nazionale. Lui vuole solo giocare
a pallone. Lui deve solo giocare a pallone. Il resto è ipocrisia. Balotelli l'ha
solo svelata una volta di più.
Cosa ne sanno
gli italiani della mafia dell’antimafia, o degli innocenti in carcere. Gli
italiani bevono l’acqua che gli danno ed è tutta acqua inquinata e con quella
sputano giudizi sommari che sanno di sentenze.
E la colpa è
solo e sempre di una informazione corrotta ed incompleta da parte di una
categoria al cui interno vi sono rare mosche bianche.
Quindi, ecco
perché "Gli italiani, giustizialisti? No! Disinformati
ed ignoranti. Se l'amnistia e l'indulto serve a ristabilire una sorta di
giustizia riparatrice per redimere anche i peccati istituzionali: ben vengano".
Tanti sono gli
esempi lampanti su come disfunziona la Giustizia in Italia.
Che dire, per
esempio, dei 12 mesi di carcere di Scaglia, l'innocente. L'ex fondatore di
Fastweb assolto per non aver commesso il fatto. Storia di ordinaria ingiustizia,
scrive Annalisa Chirico su “Panorama”. Alla fine sono stati assolti. Il
pm aveva chiesto sette anni per Silvio Scaglia e per Stefano Mazzitelli,
rispettivamente fondatore e presidente di Fastweb e amministratore delegato di
Telecom Italia Sparkle. Entrambi accusati di una frode fiscale da circa 365
milioni di euro. Entrambi passati sotto il torchio delle manette preventive.
Insieme a loro sono stati assolti gli ex funzionari di Tis Antonio Catanzariti e
Massimo Comito, gli ex dirigenti di Fastweb Stefano Parisi, Mario Rossetti e
Roberto Contin. Tutti innocenti per “non aver commesso il fatto” o perché
“il fatto non costituisce reato”. Secondo i giudici della prima sezione
penale del tribunale di Roma, i manager non sapevano quello che stava
succedendo, mentre ad aver ideato e manovrato il sistema di megariciclaggio da
due miliardi di euro era Gennaro Mokbel, faccendiere napoletano con un passato
di attivismo nell’estrema destra. Su di lui adesso pende una condanna di primo
grado a 15 anni di reclusione. “Il mondo è un posto imperfetto. Quando
succedono cose di questo tipo ti senti una vittima. Poi però ti guardi attorno e
scopri che non sei solo: in Italia ci sono decine di migliaia di innocenti che
stanno dietro le sbarre”, è il commento a caldo di Scaglia, pochi minuti
dopo la lettura del dispositivo della sentenza. La sua vicenda è solo la
miniatura di una piaga ben più imponente: circa il 40 percento dei detenuti
nelle galere italiane sono persone in attesa di un giudizio definitivo. Sono,
letteralmente, imputati da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva, lo
statuisce l’articolo 27 della nostra veneranda Costituzione. Oltre 12mila
persone attendono un giudizio di primo grado. Tra questi c’era Scaglia, c’era
Mazzitelli, la cui innocenza è stata adesso certificata da una sentenza
giudiziaria. L’operazione Broker scatta il 23 febbraio 2010. Cinquantasei
persone vengono arrestate nell’ambito di una inchiesta su una maxi operazione di
riciclaggio e frode fiscale internazionale che coinvolgerebbe i vertici di
Fastweb e Telekom Sparkle. Tra le misure cautelari disposte dai magistrati
romani, spicca il mandato di cattura per Scaglia, che trovandosi all’estero
noleggia un aereo privato e dalle Antille atterra all’aeroporto romano di
Fiumicino. I beni di Scaglia vengono posti sotto sequestro preventivo e i
carabinieri traducono l’imprenditore nel carcere di Rebibbia, dove viene
rinchiuso in una cella di otto metri quadrati al secondo piano, sezione G11. In
regime di isolamento giudiziario non può avere contatti con nessuno, neppure col
suo avvocato. Attende tre giorni per l’interrogatorio di garanzia e oltre
quaranta per rispondere alle domande dei suoi accusatori, secondo i quali lui
sarebbe membro di una associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale
e a dichiarazione infedele mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti.
Ora sono stati smentiti dai giudici. Ma dietro le sbarre Scaglia trascorre tre
mesi prima di ottenere gli arresti domiciliari il 19 maggio 2010. In totale,
collezionerà 363 giorni di detenzione da innocente. Ancora oggi viene da
chiedersi quali fossero le esigenze cautelari nei confronti di un indagato, che
non ricopriva più alcun incarico societario in Fastweb e che era montato su un
aereo per farsi oltre diecimila chilometri e consegnarsi all’autorità
giudiziaria italiana. Nei suoi confronti i giudici hanno rigettato il teorema
dipietresco del “non poteva non sapere”. Ecco, sì, all’epoca dei fatti Scaglia
era Presidente di Fastweb, ma poteva non sapere. Nel dibattimento dati, prove e
testimonianze hanno dimostrato che Scaglia non sapeva, e neppure Mazzitelli
sapeva. Si poteva evitare tutto questo? Che giustizia è quella che tratta i
cittadini come presunti colpevoli? Arresti infondati, vite dilaniate e i
riverberi economici di una vicenda che ha colpito, tra gli altri, il guru
italiano della New Economy, l’uomo che il “Time” nel 2003 aveva annoverato nella
lista dei quindici manager tech survivors, profeti dell’innovazione usciti
indenni dalla bolla della New Economy. Ecco, della New Economy ma non della
giustizia made in Italy.
Nel 2010,
quando il gip di Roma ordina l’arresto di Silvio Scaglia, Stefano Parisi è
amministratore delegato di Fastweb, continua Annalisa Chirico su “Panorama”. A
ventiquattro ore dalla notizia dell’ordinanza di custodia cautelare, mentre
Scaglia organizza il suo rientro dalle Antille con un volo privato, Parisi
decide di convocare una conferenza stampa per spiegare urbi et orbi che Fastweb
non ha commesso alcun reato e che gli ipotetici fondi neri non esistono. “A
distanza di tre anni e mezzo posso dire che i giudici mi hanno dato ragione”.
Parisi è stato solo lambito dall’inchiesta Fastweb – Telecom Italia Sparkle.
Destinatario di un avviso di garanzia, la sua posizione è stata archiviata la
scorsa primavera. “Avrebbero potuto archiviare nel giro di quindici giorni,
invece ci sono voluti tre anni”. Ora che il Tribunale di Roma ha assolto
l’ex presidente di Fastweb Scaglia e altri dirigenti della società di
telecomunicazioni, Parisi prova un misto di soddisfazione e rabbia. “Mi
chiedo perché accadano vicende come questa in un Paese civile. Le vite di alcuni
di noi sono state letteralmente stravolte. La giustizia dovrebbe innanzitutto
proteggere cittadini e imprese, non rendersi responsabile di errori simili”.
Perché di errori si tratta. Quando nel 2007 su Repubblica compare il primo
articolo da cui cui filtrano informazioni riservate sulle indagini condotte
dalla procura di Roma su una presunta frode fiscale internazionale che
coinvolgerebbe Fastweb, l’azienda avvia immediatamente un audit interno per fare
chiarezza. “A distanza di sei anni una sentenza conferma quanto noi abbiamo
sostenuto e provato sin dall’inizio. Da quella analisi interna vennero fuori nel
giro di un mese dati e informazioni che noi trasmettemmo subito alla procura
perché sin dall’inizio ci fu chiaro che la truffa veniva ordita, con la
complicità di due dirigenti infedeli (ora condannati in primo grado per
corruzione, ndr), ai danni di Fastweb. Insomma noi eravamo la vittima di un
raggiro che, come hanno certificato i giudici, ha sottratto circa 50 milioni di
euro alla nostra società e 300 milioni a Tis”. Certo, dalle parole di Parisi
trapela l’amarezza per quello che si poteva evitare e invece non si è evitato.
“Purtroppo la stessa sentenza ha fatto chiarezza su un punto: c’erano dei
delinquenti, che sono stati condannati, e degli innocenti perseguitati dalla
giustizia”.
Scaglia
dopo l'assoluzione: "Il carcere peggio di come lo raccontano".
L'imprenditore assolto con formula piena dall'accusa di riciclaggio parla con
Toberto Rho su “La Repubblica” dell'anno trascorso in stato di detenzione, prima
a Rebibbia poi nella sua casa di Antagnod. "In cella meno spazio che per i
maiali. Quel pm non voleva cercare la verità, ma ora so che in Italia la
giustizia funziona". Silvio Scaglia, trecentosessantatré giorni, tre ore,
trentacinque minuti, quaranta secondi. Ovvero, "la battaglia più dura che ho
combattuto nella mia vita, ma sono contento di averla fatta e di non averla
evitata, come avrei facilmente potuto". Il counter del sito che amici e
sostenitori hanno aperto durante il periodo della sua detenzione per denunciarne
pubblicamente l'assurdità, è ancora fermo su quelle cifre, che misurano il
periodo che Silvio Scaglia, uno dei manager che hanno costruito il successo di
Omnitel, l'imprenditore che è diventato miliardario (in euro) durante il periodo
della New economy grazie all'intuizione di eBiscom-Fastweb, ha passato agli
arresti. Prima a Rebibbia, tre mesi, poi altri nove rinchiuso nella sua casa di
Antagnod, in cima alla Val d'Ayas, finestre affacciate sul gruppo del Monte
Rosa. Le sue montagne, che però non poteva guardare: "Nei primi tempi degli
arresti domiciliari non mi potevo affacciare, tantomeno uscire sul balcone, per
disposizione dei giudici". Oggi che è stato assolto con formula piena
dall'accusa di associazione a delinquere finalizzata a quella che la Procura
definì "la più grande frode mai attuata in Italia", Scaglia ripercorre l'anno
più difficile della sua esistenza. A cominciare da quella notte in cui, alle
Antille per affari, rispose alla telefonata della figlia, ventenne, che chiamava
dalla loro casa di Londra. "Era stata svegliata dagli agenti inglesi, avevano in
mano un mandato di cattura. Per noi era un mistero, non capivamo cosa stesse
accadendo. Ho compreso la gravità delle accuse solo quando ho letto l'ordine di
arresto con i miei avvocati".
Ha deciso
di rientrare in Italia, subito.
«Sapevo
esattamente quel che mi aspettava appena scesa la scaletta dell'aereo, ma
immaginavo un'esperienza breve. Poche settimane, il tempo di spiegare che di
quella vicenda avevo già parlato in un interrogatorio di tre anni prima, che da
anni ero uscito da Fastweb, e che l'azienda e i suoi manager non erano gli
artefici, ma le vittime di quella frode».
Come fu
quella notte in volo tra i Caraibi e l'Italia, ingegner Scaglia?
«Presi
una pastiglia per dormire, per non pensare. L'incubo cominciò a Ciampino, era
notte fonda. Si rilegga i giornali di quei giorni, per capire quale era il peso
che mi sono trovato addosso, all'improvviso, quale era la tensione, la pressione
su di me e sulle aziende coinvolte».
Subito in
carcere?
«Prima
una lunghissima procedura di identificazione e notifica dell'arresto. Poi
Rebibbia, in isolamento. Una cella lunga tre metri e larga uno e mezzo, il cesso
in vista, intendo in vista anche dall'esterno. Ero nel braccio dei delinquenti
comuni. Il carcere è un posto orribile, sporco, affollato all'inverosimile. C'è
meno spazio di quello che le leggi prevedono per gli allevamenti dei maiali».
Quale è la
privazione più dura?
«Più
ancora della libertà, delle umiliazioni, dello spazio che manca, è il senso di
impotenza, l'impossibilità di difendersi, di spiegare. Dopo cinque giorni di
isolamento, venne il giudice per l'interrogatorio cosiddetto di garanzia. Fu una
farsa. Poi, per due mesi, più nulla. Finalmente l'interrogatorio con il Pm: mi
sembrava di aver spiegato, di aver dimostrato con il mio ritorno dai Caraibi di
non aver alcun progetto di fuga, anzi il contrario. Quanto al possibile
inquinamento delle prove, si trattava di fatti avvenuti anni prima, in
un'azienda da cui ero uscito da anni. Invece, tornai in carcere. Quel Pm,
evidentemente, non aveva interesse a capire».
Poi gli
arresti domiciliari, un po' di respiro.
«Al
contrario. Fu il periodo più duro. Ero chiuso nella mia casa di Antagnod,
l'unica mia abitazione italiana, perché con la mia famiglia vivo da tempo a
Londra. Ero completamente solo, non potevo neppure uscire sul balcone, vedevo
solo la signora che mi procurava il cibo e la mia famiglia nel fine settimana.
Nove mesi così, senza potermi difendere».
Cosa le
resta addosso, di quell'anno?
«Certo
non la voglia di dimenticare. È stata un'esperienza troppo forte per me e per le
persone che mi vogliono bene. Semmai avverto l'urgenza di dire forte che queste
cose non dovrebbero più succedere».
Cosa pensa
della giustizia, oggi?
«Il
mio caso dimostra che la giustizia, in Italia, funziona. Io ho avuto giustizia.
Ma ci sono voluti troppo tempo e troppe sofferenze: il problema è la mancanza di
garanzie per chi è in attesa di giudizio. Vede, in carcere ho parlato con
tantissimi detenuti: la metà di loro erano in attesa di un processo. La metà
della metà risulteranno innocenti, come me».
Mai
rimpianto quel viaggio di ritorno dalle Antille a Roma, pendente un ordine di
arresto, neppure nei giorni più duri?
«Mai,
neppure per un secondo. Lo rifarei domattina. Era l'unico modo per reclamare la
mia innocenza e cancellare ogni possibile ombra. Fu proprio quella scelta a
rendere superflua ogni spiegazione alle persone che mi vogliono bene. La mia
famiglia, le mie figlie si sono fidate del loro padre, della sua parola, dei
suoi gesti. Non c'è stato bisogno d'altro».
Che ne è
del Silvio Scaglia "mister miliardo", l'imprenditore lungimirante e
spregiudicato, uno dei dieci uomini più ricchi e potenti d'Italia?
«Sono
sempre qui. Faccio ancora quel che so fare, cioè l'imprenditore, pochi mesi fa
ho acquistato un'azienda (La Perla, ndr). Certo, la mia reputazione ha subito
danni pesanti. Ancora oggi non posso andare negli Stati Uniti, se compilo il
modulo Esta mi negano il visto. Ma ad altri è andata peggio: vivendo a Londra,
per la mia famiglia è stato relativamente più facile mantenere il distacco
dall'onda di riprovazione che si accompagna ad accuse così gravi come quelle che
ho subito. E poi, ai miei coimputati è stato sequestrato tutto, hanno vissuto
per anni della generosità di amici e conoscenti».
Come vive
le eterne polemiche italiane sulla giustizia?
«Con
fastidio. Mi sembrano agitate strumentalmente per ottenere un vantaggio
politico, non per risolvere i problemi reali delle migliaia di persone che
vivono sulla loro pelle quel che ho vissuto io».
Ma il caso
Fastweb (a proposito così è stato conosciuto da tutti come se Telecom non ci
fosse, ingiustamente, anche lei) ha dimostrato in modo lampante come si debba
ragionare seriamente sul funzionamento della giustizia, scrive Nicola Porro su
“Il Giornale”. Le tesi dell'accusa (come ha denunciato un'altra vittima
dell'accanimento giudiziario, il generale Mario Mori) diventa immediatamente la
tesi della verità. I media non pensano, non riflettono, non investigano, copiano
gli atti dell'accusa. Gli indagati diventano subito colpevoli. Chiunque
conoscesse le carte della difesa, sarebbe stato in grado in un secondo di
verificare l'enormità dell'accusa. Ma andiamo oltre. Anche i pm hanno un obbligo
legale di ricercare la verità. Come hanno potuto aver avuto così poco buon senso
(sì sì certo, non c'è un articolo del codice che lo prevede) nell'applicare
misure cautelari così dure? Gli imputati sono stati tosti. Hanno resistito al
carcere e non hanno accettato sconti, patteggiamenti, ammissioni. Non sono
passati per la strada più facile. Hanno pagato un prezzo altissimo dal punto di
vista personale. Una piccola lezione, l'ennesima, ma forse la più clamorosa: una
persona, un'azienda, un processo non si giudica solo dalla carte dell'accusa. Ma
continuando a fare il nostro mestiere. Il processo Fastweb per il momento è
finito. Un terzo della nostra popolazione carceraria è dietro alle sbarre senza
una sentenza definitiva come Scaglia e soci. Forse prima dell'amnistia ci si
potrebbe occupare di questa mostruosità giuridica.
FACILE DIRE
EVASORE FISCALE A TUTTI I TARTASSATI. GIUSTO PER MANTENERE I PARASSITI. LA LOREN
E MARADONA.
Per tutti
coloro che del giustizialismo fanno la loro missione di vita si deve rammentare
la storia di Sofia Loren che non doveva finire in carcere. La Cassazione dà
ragione alla Loren dopo 31 anni: "Non doveva finire in carcere". Dopo un iter
giudiziario di 31 anni, la Suprema Corte dà ragione all'attrice finita in
carcere nel 1982: l'attrice utilizzò correttamente il condono fiscale. Ha
vinto Sofia Loren. Giunge al capolinea, dopo quasi 40 anni,
una delle cause fiscali ancora aperte tra l’attrice due volte premio Oscar Sofia
Loren - nata Scicolone (sorella della madre di Alessandra Mussolini, nipote di
Benito), e rimasta tale all’anagrafe dei contribuenti - e l’ Agenzia delle
Entrate. Dopo una così lunga attesa, per una vicenda legata alla presentazione a
reddito zero del modello 740 della dichiarazione dei redditi del 1974, la
Cassazione ha dato ragione alla Loren concedendole, a norma di quanto previsto
dal condono del 1982, di pagare le tasse solo sul 60% dell’imponibile non
dichiarato e non sul 70% di quei 920 milioni di vecchie lire sottratti alla
tassazione e, invece, accertati dal fisco. Ma non è l'aspetto fiscale da tenere
in considerazione, ma come sia facile finire dentro, anche per i big non
protetti dal Potere. Sophia Loren aveva ragione e non doveva essere arrestata
per evasione fiscale nel 1982. Ha perso la giustizia, ancora una volta. Lo ha
riconosciuto, definitivamente, la Cassazione. A riconoscerlo, in maniera
definitiva, dopo un iter giudiziario durato 31 anni, è stata la Corte di
Cassazione. La sezione tributaria della Suprema Corte, con una sentenza
depositata il 23 ottobre 2013, ha infatti accolto il ricorso dell’attrice contro
una decisione della Commissione tributaria centrale di Roma risalente al 2006.
L'attrice di Pozzuoli vince la causa contro il fisco per una dichiarazione dei
redditi del 1974, poi sottoposta al condono 8 anni dopo. Il caso suscitò grande
scalpore quando la stella del cinema si consegnò alla polizia a Fiumicino per
essere arrestata. Lei finì in carcere 31 anni fa per 17 giorni con l'accusa di
evasione fiscale. Il caso suscitò grande scalpore dopo che l'attrice decise di
consegnarsi alla polizia all'aeroporto di Fiumicino di ritorno dalla Svizzera
dove risiedeva con la famiglia. Le responsabilità della frode vennero poi
attribuite al suo commercialista. Al centro del procedimento, la dichiarazione
dei redditi per il 1974 che la Loren presentò, congiuntamente al marito Carlo
Ponti, in cui si escludeva, per quell’anno, «l’esistenza di proventi e spese»,
poiché «per i film ai quali stava lavorando erano sì previsti compensi ma da
erogarsi negli anni successivi». Sofia Loren, nella dichiarazione dei redditi
del 1974 presentata congiuntamente al marito, aveva escluso - ricorda il
verdetto della Cassazione - «l’esistenza di proventi e spese per il detto anno e
chiariva che per i film ai quali stava lavorando erano sì previsti compensi ma
da erogarsi negli anni successivi al 1974, in quanto per gli stessi era stata
concordata una retribuzione pari al 50% dei ricavi provenienti dalla
distribuzione dei film». Il fisco non ci ha creduto ed è andato a scovare quel
quasi miliardo non dichiarato, tassato per poco più della metà del suo valore.
Meno propensa all’applicazione delle ganasce soft era stata la Procura della
Suprema Corte, rappresentata da Tommaso Basile, che aveva chiesto il rigetto del
ricorso della Loren. Nel 1980 all’attrice venne notificato un avviso di
accertamento, per un reddito complessivo netto assoggettabile all’Irpef per il
1974 pari a 922 milioni di vecchie lire (l’equivalente, valutando il potere
d’acquisto che avevano allora quei soldi, di oltre 5.345.000 di euro di oggi).
La Loren, dunque, usufruendo del condono fiscale previsto dalla legge 516/1982,
aveva presentato una dichiarazione integrativa facendo riferimento a un
imponibile di 552 milioni di vecchie lire, pari al 60% del reddito accertato, ma
il Fisco aveva iscritto a ruolo un imponibile maggiore, pari a 644 milioni,
sostenendo che la percentuale da applicarsi fosse quella del 70%, poiché la
dichiarazione sul 1974 presentata dall’attrice, doveva considerarsi omessa,
perché «priva degli elementi attivi e passivi necessari alla determinazione
dell’imponibile». Le Commissioni di primo e secondo grado avevano dato ragione
alla Loren, mentre la Commissione tributaria centrale di Roma aveva dichiarato
legittima la liquidazione del condono con l’imponibile al 70%. Nonostante gli
ermellini abbiano sconfessato la pretesa dei giudici fiscali di secondo grado di
Roma di sottoporre a tassazione il 70% dei 920 milioni di lire non dichiarati
nel 1974 (ossia di calcolare come imponibile 644 milioni anziché 552 milioni,
come sostenuto dai legali della Loren che si sono battuti per un imponibile pari
al 60% della cifra evasa), nulla dovrà essere ridato all’attrice perché il fisco
- in questi tanti anni - le ha usato la cortesia di non chiederle quel 10% di
differenza in attesa della decisione della Cassazione. Oltre alla
certificazione, ora garantita dalla Suprema Corte, di aver presentato un condono
fatto bene, alla Loren rimane anche la soddisfazione di vedere addossate
all’Agenzia delle Entrate le spese legali dei suoi avvocati pari a settemila
euro. La Loren si è detta "felice" per il verdetto della Cassazione: "Finalmente
si chiude una storia che è durata quaranta anni". E Sophia commenta: «Il
miracolo della giustizia: quando non ci credi più trova un modo di ridarti
speranza. È una vicenda vecchia di 30 anni fa in cui ho avuto finalmente
ragione». Interviene anche l‘avvocato Giovanni Desideri che ha difeso Sophia
Loren nel ricorso in Cassazione: «È una vicenda kafkiana durata quaranta anni
quella vissuta dalla signora Loren, per di più per delle tasse correttamente
pagate: adesso la Cassazione ha reso, finalmente, il fisco giusto. Ma
l’amministrazione tributaria, senza arrivare a disturbare la Cassazione, avrebbe
potuto autocorreggersi da sola prendendo atto delle dichiarazioni in autotutela
presentate dalla contribuente Loren anni orsono!».
Forse si
sarebbero lasciati andare a qualche parola di più se non fossero ancora calde le
polemiche sul gesto dell’ombrello rivolto da Maradona al fisco: chi conosce la
Loren - madrina e testimonial di tanti eventi, dalle sfilate di moda al varo di
navi da crociera - sa che non ci tiene a finire in compagnia dell’ex pibe de oro
nel novero di chi si ritiene «vittima» delle tasse. Si sa in Italia: sono le
stesse vittime di ingiustizie che si rendono diverse dai loro disgraziati
colleghi e se ne distanziano. Questo perchè in Italia ognuno guarda ai cazzi
suoi. Non si pensa che si sia tutti vittime della stessa sorte e per gli effetti
fare fronte comune per combatterla. Intanto è polemica sulle dichiarazioni di
Diego Armando Maradona a Che tempo che fa. L'ex "pibe de oro" ha parlato
dei propri problemi fiscali e ha dichiarato: "Io non sono mai stato un evasore.
Io non ho mai firmato contratto, lo hanno fatto Coppola e Ferlaino che ora
possono andare tranquillamente in giro mentre a me hanno sequestrato l’orologio
e l’orecchino, tanti volevano transare per me con fisco per farsi pubblicità, ma
io ho detto no, io non sono un evasore, voglio andare in fondo. Equitalia si fa
pubblicità venendo da me, perché il loro lavoro non è Maradona. Io non mi
nascondo". Poi il gesto dell'ombrello rivolto a Equitalia. E ripartiamo dunque
da Maradona che ha fatto il gesto dell'ombrello a Equitalia «che mi vuole
togliere tutto: tié». Nessun commento da parte del conduttore Fabio Fazio. Il
gesto invece non è piaciuto al viceministro dell'Economia, Stefano Fassina: "È
un gesto da miserabile e credo che vada perseguito con grande determinazione,
funzionari di Equitalia hanno notificato nei giorni scorsi a Diego Armando
Maradona un avviso di mora da oltre 39 milioni di euro, stiamo parlando di quasi
40 milioni di euro, farebbe bene a imparare a rispettare le leggi", ha tuonato
l'esponente del Pd a Mix 24 su Radio 24.
Diego Armando Maradona
e il gesto dell’ombrello contro Equitalia. Ma perché il Pibe de oro ha
reagito in modo così plateale e non educato durante la trasmissione di Fabio
Fazio? Una possibile motivazione la dà il quotidiano di Napoli, il Mattino.
Maradona sarebbe stato indispettito da quanto accaduto al suo arrivo in
Italia: appena sceso dall’aereo sarebbe stato “ispezionato” da un
funzionario di Equitalia per verificare se addosso avesse oggetti pignorabili
come orecchini, anelli o affini. Memore di quanto accaduto nel 2010, quando gli
fu sequestrato l’orecchino, Maradona si è presentato senza beni pignorabili. Ma
spiega il Mattino, la visita degli ispettori, avvenuta davanti alla figlia
Dalma e alla compagna Rocio, lo ha indispettito. E quindi, al sentir nominare
Equitalia, Diego ha risposto con l’ombrello. Diego Armando Maradona non ci sta.
Finito nel mirino di Equitalia, che lo accusa di aver evaso il
fisco per la cifra di 39 milioni di euro, l'ex calciatore argentino ha deciso di
reagire. E la controffensiva non si è limitata al gesto dell'ombrello verso
l'agenzia di riscossione italiana durante la trasmissione di Fabio Fazio, che
già di per se aveva smosso un marasma di polemiche. Il Pibe de Oro ha infatti
annunciato un'azione legale nei confronti dell'ente tributario.
La ragione? Gli agenti del fisco lo avrebbero perquisito al suo arrivo a
Ciampino "davanti al suo legale Angelo Pisano, alla figlia Dalma e alla compagna
Rocio", mettendogli le mani addosso per cercare presunti oggetti di valore da
poter sequestrare. La denuncia è per "ingiusta attività esecutiva degli organi
tributari". Un'offesa, un'umiliazione che il campione non ha
sopportato. Soprattutto dopo che Equitalia continua a pretendere soldi che in
realtà non sono giustificati sul piano sostanziale. Infatti, la contestazione -
notificata al calciatore argentino solo 11 anni dopo i fatti - riguarda un
eventuale mancato versamento al fisco dal 1985 al 1990 di 13 miliardi di lire,
pari a 6,7 milioni di euro. Quella cifra nel 2013 ammonterebbe a 11,4 milioni di
euro. I 28 milioni di euro in più che vengono pretesi da Equitalia sono la somma
di mora, interessi di mora e sanzioni.
Dopo il "tiè"
al Fisco. Maradona ha ragione: non è un evasore scrive Franco Bechis su
“Libero Quotidiano”. Diego non fece ricorso nel '94 contro la presunta
frode perché era all'estero: lo avrebbero scagionato. Il Fisco lo sa, ma non
rinuncia a sequestri e show. Diego Armando Maradona non ha evaso al fisco
italiano i 39 milioni di euro che continuano a chiedergli. Questo è certo,
perché nemmeno il fisco italiano lo sostiene: la contestazione - notificata al
calciatore argentino solo 11 anni dopo i fatti - riguarda un eventuale mancato
versamento al fisco dal 1985 al 1990 di 13 miliardi di lire, pari a 6,7 milioni
di euro. Quella cifra nel 2013 ammonterebbe a 11,4 milioni di euro. I 28 milioni
di euro in più che vengono pretesi da Equitalia sono la somma di mora, interessi
di mora e sanzioni. E questo sarebbe un primo problema di equità per qualsiasi
contribuente, anche per Maradona. Ma anche sui 13 miliardi di lire dell’epoca il
fisco ha torto sul piano sostanziale e lo sa benissimo: per pretenderli ne fa
esclusivamente una questione di forma. Il gruppo di finanzieri e di «messi» di
Equitalia che notifica cartelle, avvisi di mora, e sequestra orecchini e orologi
a Maradona ogni volta che questo entra in Italia, sa benissimo di avere torto
sul piano sostanziale, anche se la forma consente questo show. Maradona è
innocente, ma non si è difeso nei tempi e nei modi consentiti: quando lo ha
fatto era troppo tardi, e la giustizia tributaria italiana non gli ha consentito
di fare valere le sue ragioni (conosciute e indirettamente riconosciute da altre
sentenze) perché era prescritta la possibilità di ricorrere e contestare le
richieste del fisco. Quello di Maradona così è uno dei rarissimi casi in cui la
prescrizione va a tutto danno dell’imputato. Il calciatore più famoso del mondo
è finito nel mirino del fisco insieme alla società calcistica per cui aveva
lavorato in Italia (il Napoli di Corrado Ferlaino), e a due giocatori
dell’epoca: Alemao e Careca. Il fisco ha emesso le sue cartelle esattoriali, e
la giustizia tributaria ha iniziato il suo processo quando Maradona era già
tornato in Argentina, dove avrebbe ancora giocato quattro anni. Conseguenza
naturale: le notifiche del fisco sono arrivate a chi era in Italia (Napoli
calcio, Alemao e Careca), e naturalmente non a chi era in Argentina, perché né
il fisco italiano né altri lo hanno comunicato laggiù. Il fisco si è lavato la
coscienza appendendo le sue cartelle all’albo pretorio di Napoli. Oggi
quell’albo è on line e in teoria uno che fosse curioso potrebbe anche guardarlo
dall’Argentina (ma perché mai dovrebbe farlo?). Allora no: per conoscere quelle
cartelle bisognava andare in comune a Napoli. Non sapendo nulla di quelle
cartelle (fra cui per altro c’erano anche alcune multe prese per violazione al
codice della strada), Maradona non ha potuto fare ricorso. Né conoscere il tipo
di contestazione che veniva fatta. Riassunto in breve. I calciatori allora come
oggi erano lavoratori dipendenti delle società per cui giocavano. Maradona,
Careca e Alemao erano dipendenti del Napoli. Che pagava loro lo stipendio e
fungeva da sostituto di imposta: tratteneva cioè l’Irpef dovuta per quei redditi
e la versava al fisco. Tutti e tre i giocatori (e molti altri in Italia) oltre
al contratto da dipendenti avevano anche una sorta di contratto ulteriore, con
cui cedevano alla società calcistica i propri diritti di immagine anche per
eventuali sponsorizzazioni e pubblicità. In tutti e tre i casi, come avveniva
all’epoca con i calciatori di tutto il mondo e in tutto il mondo, non erano i
calciatori ad incassare dal Napoli il corrispettivo di quei diritti, ma delle
società estere di intermediazione (tre diverse nel caso di Maradona), che poi
avrebbero dovuto dare ai giocatori gli utili di intermediazione. Secondo il
fisco italiano quei diritti in realtà erano stipendio extra per Alemao, Maradona
e Careca. Il Napoli quindi avrebbe dovuto versare al fisco trattenute simili a
quelle operate sugli stipendi base. Non avendolo fatto il Napoli, avrebbero
dovuto versare l’Irpef i singoli giocatori. Squadra di calcio, Alemao e Careca
fanno ricorso (Maradona no, perché non ne sa nulla): in primo grado hanno torto.
In secondo grado vedono riconosciute pienamente le loro ragioni, con una
sentenza che per Careca e Alemao verrà confermata dalla Cassazione. Il Napoli
calcio incassa la sentenza favorevole, ma quando la ottiene sta fallendo.
Preferisce non allungare i tempi: aderisce a un condono fiscale e sana tutto il
passato, pagando in misura ridotta anche l’Irpef che secondo le contestazioni
non era stata versata a nome di Alemao, Careca e Maradona. In teoria il caso
Maradona avrebbe dovuto considerarsi concluso con quel condono operato dal
sostituto di imposta. Ma il fisco va avanti. Si deve fermare davanti a Careca e
Alemao perché la sentenza tributaria di appello che verrà poi confermata prende
a schiaffoni quelli che sarebbero diventati Agenzia delle Entrate ed Equitalia.
La sentenza tributaria ricorda che in parallelo si era già svolto un processo
penale sulla stessa materia, e che il pm aveva proposto e il Gip accolto
l’archiviazione per Maradona, Alemao e Careca, escludendo «per tutti e tre i
calciatori che i corrispettivi versati agli sponsor fossero in realtà ulteriori
retribuzioni destinate ai calciatori». I giudici tributari poi accusano il fisco
italiano di avere preso un abbaglio: avevano accusato tutti sulla base di norme
che per altro sono entrate nel codice italiano con una legge di fine 1989:
quindi al massimo si poteva contestare qualcosa solo per il 1990, non potendo
essere retroattive le regole tributarie. Ma anche per il 1990 la contestazione
non era motivata: nessuna prova che quei diritti fossero cosa diversa e si
fossero trasformati in stipendi. Assolti e liberati dal fisco italiano dunque
sia Alemao che Careca. Maradona no, perché non aveva fatto ricorso. Quando ha
provato a farlo dopo la prima notifica del 2001, è stato respinto perché
tradivo. Quindi Maradona ha ragione, ma non può avere ragione perché la sua
ragione ormai è prescritta. Cose da azzeccagarbugli. Che però giustificano assai
poco lo show che il fisco mette in onda ogni volta che Maradona atterra in
Italia.
Maradona,
l'avvocato su "La Gazzetta dello Sport": "Stufo dell'Italia: lo trattino come
qualsiasi cittadino...". L'appello di Pisani, legale di Diego: "È un campione
anche di pignoramenti. E il bello è che alle multinazionali del gioco con debiti
di 2 miliardi e mezzo fanno lo sconto, a lui tolgono l'orologio. L'ombrello?
Totò faceva la pernacchia..." L'ultima puntata del Maradona-show è un appello
accorato di Angelo Pisani via etere. "Faccio un appello ai politici affinchè
trattino Maradona come un qualsiasi cittadino", ha detto l'avvocato di Diego a
"Radio Crc". La visita in Gazzetta, Roma-Napoli all'Olimpico e l'intervista di
Fazio che ha scatenato le polemiche: Diego è andato via, l'onda lunga delle sue
parole è rimasta. "In Italia chi è innocente viene perseguitato e chi invece è
palesemente colpevole viene agevolato dalle leggi - spiega Pisani - Secondo
Equitalia, che all'epoca dei fatti non esisteva, e quindi non secondo i giudici
che hanno assolto il mio assistito, Maradona è responsabile di un'evasione di 6
milioni di euro e non 39 milioni, come appare sui giornali Quella cifra è la
somma di interessi che non rappresentano evasione fiscale. Il paradosso è che le
multinazionali del gioco e delle slot machine, del gioco d'azzardo, che hanno
accumulato un debito enorme, pari a 2miliardi e 500milioni di euro relativi a
tasse, concessioni e tributi non pagati, godranno di uno sconto. Pare che il
Governo abbia inserito, nella legge sull'IMU, un provvedimento relativo allo
sconto del 75% su questa somma enorme accumulata dalle multinazionali. È
responsabile per un cavillo, viene perseguitato ed è l'unica persona al mondo
alla quale viene sequestrato l'orologio e gli orecchini. Maradona è un campione
anche nei pignoramenti ed è quasi stufo dell'Italia". Sul gesto dell'ombrello,
definito "miserabile" da Fassina e mal valutato anche da Letta, Pisani ribatte:
"Si lamentano del gesto di Maradona, di satira, quasi di soddisfazione per non
essere vittima di un pignoramento ingiusto, per essere scampato da un agguato.
Maradona non voleva offendere nessuno. Totò addirittura faceva la pernacchia che
è un gesto goliardico, un gesto che fa parte dell'arte. Tra l'altro, se
guardiamo le immagini, il gesto di Maradona era rivolto a se stesso".
ANCHE GESU'
E' STATO CARCERATO.
Come non dare
ragione al Papa. Il Papa prega per i detenuti: "Facile punire i più deboli, i
pesci grossi nuotano". Il 23 ottobre 2013 prima dell'udienza generale il
Pontefice ha incontrato 150 cappellani delle carceri italiane. "Anche Gesù è
stato un carcerato". Poi rivela: "Chiamo spesso i reclusi di Buenos Aires". Il
Papa ha voluto "far arrivare un saluto a tutti i detenuti" nelle carceri
italiane, ricevendo i cappellani, prima dell'udienza generale che ha raccolto
anche oggi circa 100mila persone. Gremite, oltre a piazza San Pietro, anche
piazza Pio XII e le vie limitrofe, compreso il primo tratto di via
Conciliazione. Il Pontefice ha parlato a braccio toccando diversi argomenti. "È
facile punire i più deboli, mentre i pesci grossi nuotano" ha detto Bergoglio ai
cappellani. "Ai detenuti - ha aggiunto - potete dire che il Signore è dentro con
loro. Nessuna cella è così isolata da escludere il Signore". Anche il Signore è
stato "carcerato dai nostri egoismi, dai nostri sistemi, dalle tante
ingiustizie. È facile punire i più deboli, mentre i pesci grossi nuotano".
Parlando a braccio durante l'udienza, il Pontefice ha detto: "Recentemente avete
parlato di una giustizia di riconciliazione, ma anche una giustizia di speranza,
di porte aperte, di orizzonti, questa non è una utopia, si può fare, non è
facile perché le nostre debolezze sono dappertutto, il diavolo è dappertutto, ma
si deve tentare". Il Papa ha raccontato che spesso, soprattutto la domenica,
telefona ad alcuni carcerati a Buenos Aires e che la domanda che gli viene in
mente è: "Perché lui è lì e non io?". "Mi domando: perché lui è caduto e non io?
Le debolezze che abbiamo sono le stesse... È un mistero che ci avvicina a loro".
Poi ha detto ai cappellani di portare un messaggio da parte sua: "Ai detenuti, a
nome del Papa, potete dire questo: il Signore è dentro con loro. Nessuna cella è
così isolata da escludere il Signore, il suo amore paterno e materno arriva
dappertutto". Il fondamento evangelico. Gesù stesso si riconosce nel carcerato:
"ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da
bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi
avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi" (Mt.25,35-36). Gesù non
giudica e non condanna come fanno i tribunali delle nostre società civili. Egli
muore tra due ladri, non tra due innocenti condannati ingiustamente, e a uno dei
due dice: "Oggi sarai con me nel paradiso" (Lc 23,43). Gesù insegna a non
giudicare e a non condannare: "Non giudicate, per non essere
giudicati…"(Mt.7,1).
ANCHE GLI
STUDENTI SONO UNA CASTA.
E poi ancora,
neanche gli studenti si salvano da questo marasma. Imparare ad essere Casta sin
dalle elementari. Pretendere presunti diritti e ignorare i sacrosanti doveri.
Altro che proteste, gli studenti sono una Casta iniziatica a future
corporazioni: magistrati, avvocati, notai, ecc. Costano molto più di quel che
pagano, si laureano dopo i 27 anni, non si muovono da casa. E non azzeccano una
battaglia, scrive Filippo facci su “Libero Quotidiano. Non è un Paese per
studenti, questo: a meno che siano svogliati, viziati, rammolliti dalla bambagia
familiare, cioè bamboccioni, iper-protetti dal familismo e da un welfare
schizofrenico. Allora sì, ecco che questo diventa un Paese per studenti: purché
siano quelli che sfilavano nel corteo romano, sabato, col fegato di sostenere
che «gli stanno rubando il futuro», quelli che il governatore di Bankitalia
Ignazio Visco ha sconsigliato dal laurearsi perché avrebbero meno probabilità di
trovare lavoro, quelli che hanno scambiato la condizione studentesca per un
parcheggio post-puberale, quelli, insomma, ai quali potete anche dirlo: che sono
una casta. Loro rimarranno di sale, li farete imbestialire, ma lo sono e lo
restano. Lo sono perché lo Stato gli chiede soltanto mille o duemila euro l’anno
di tasse universitarie, mentre ne costano - allo stesso Stato - una media di
settemila: soldi a carico nostro, della fiscalità generale, soldi pagati anche
da chi magari i figli all’università non ce li può mandare, magari perché non
può, perché non ce la fa. Una casta è proprio questo: il privilegio di una
minoranza a spese di una maggioranza. Ma voi provate a dirglielo. Provate a
spiegarglielo. Provate a spiegare a tanti coccolatissimi giovani, che per
definizione hanno sempre ragione, che da una quarantina d’anni non hanno
azzeccato una battaglia che sia una, spesso rincoglioniti dalla cultura bipolare
e catastrofista dei loro cattivissimi maestri sessantottini: dediti,
quest’ultimi, a condire il loro progressivo accomiatarsi con profezie di
sciagura che hanno trasformato ogni futuro in un funerale sociale, ambientale,
economico e tecnologico. Provate a dirglielo senza che vi saltino addosso: loro,
i loro genitori e ovviamente la stampa conformista. Provate a dirgli che l’ex
ministro Elsa Fornero, quando diceva che i giovani non devono essere schizzinosi
all’ingresso nel mondo del lavoro, aveva ragione e basta. Provate a dirgli che
Annamaria Cancellieri, quando parlò degli italiani «mammoni», aveva ragione pure
lei, o, peggio, che ce l’aveva anche l’ex viceministro Michel Martone quando
disse che un 28enne non ancora laureato è spesso uno sfigato. Oh certo, un
laureato italiano resta sfigato a qualsiasi età, molte volte: perché manca il
lavoro, perché la scuola non forma, e poi certo, perché un sacco di giovani si
chiudono nelle università anche per prolungare una sorta di anticamera della
vita reale, sfuggendo ogni minimo approccio col mondo del lavoro. Sta di fatto
che gli studenti lavoratori in Italia restano una minoranza: c’è poco da
sproloquiare. Da noi ci si laurea in media dopo i 27 anni quando in Europa non
si arriva ai 24, con un mercato che ormai è senza confini e rende i giovani
italiani dei potenziali ritardatari agli appuntamenti che contano. A sostenerlo
ci sono tutti i dati del mondo, e il governatore di Bankitalia l’ha detto
chiaro: il livello di istruzione dei nostri giovani è ancora ben distante da
quello degli altri Paesi avanzati, c’è dispersione scolastica, un laureato
italiano ha meno possibilità di trovare lavoro di un diplomato, c’è una
percentuale spaventosa di analfabetismo funzionale e cioè un’incapacità diffusa,
in sostanza, di usare efficacemente la lettura e la scrittura e il calcolo nelle
situazioni quotidiane. Ma dire questo, politicamente, non serve: ci sono animi
da non frustrare - ti spiegano. Teniamoci dunque la patetica casta degli
studenti, questi poveracci che siamo riusciti a rovinare con la scusa di
proteggerli. Non diciamogli che sono gli studenti con meno mobilità al mondo
(l’80 per cento è iscritto nella regione di residenza) e che spesso la facoltà
viene scelta secondo la distanza da casa, anche perché cinque giovani su dieci,
dai 25 ai 34 anni, vivono ancora coi genitori. Non diciamogli che quello
sciagurato e falso egualitarismo chiamato «valore legale del titolo di studio»
ha prodotto milioni di false illusioni perché un pezzo di carta non insegna un
lavoro né ti aiuta davvero a trovarlo, se nel frattempo non l’hai imparato e non
hai capito che una professione e un’emancipazione non sono regali, non sono
diritti, non sono pezzi di carta: sono una durissima conquista.
QUANTO SONO
ATTENDIBILI LE COMMISSIONI D’ESAME?
Ogni anno a
dicembre c’è un evento che stravolge la vita di molte persone. Il Natale? No!
L’esame di avvocato che si svolge presso ogni Corte di Appello ed affrontato da
decine di migliaia di candidati illusi.
La domanda
sorge spontanea: c’è da fidarsi delle commissioni dei concorsi pubblici o degli
esami di Stato?
«Dai dati
emersi da uno studio effettuato: per nulla!». Così opina Antonio Giangrande, lo
scrittore, saggista e sociologo storico, che sul tema ha scritto un libro
“CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. L’Italia dei concorsi e degli esami pubblici
truccati” tratto dalla collana editoriale “L’ITALIA DEL TRUCCO, L’ITALIA CHE
SIAMO”.
E proprio
dalle tracce delle prove di esame che si inizia. Appunto. Sbagliano anche le
tracce della Maturità. “Le parole sono importanti”, urlava Nanni Moretti nel
film Palombella Rossa alla giornalista che, senza successo, provava a
intervistarlo. E’ proprio dalla commissione dell’esame di giornalismo partiamo e
dalle tracce da queste predisposte. Giusto per saggiare la sua preparazione. La
commissione è quella ad avere elaborato le tracce d’esame. In particolare due
magistrati (scelti dalla corte d’appello di Roma) e cinque giornalisti
professionisti. Ne dà conto il sito de l’Espresso, che pubblica sia i
documenti originali consegnati ai candidati, sia la versione degli stessi per
come appare sul sito dell’Ordine, cioè con le correzioni (a penna) degli errori.
Ossia: “Il pubblico ministero deciderà se convalidare o meno il fermo”. Uno
strafalcione: compito che spetta al giudice delle indagini preliminari. Seguono
altre inesattezze come il cognome del pm (che passa da Galese a Galesi) e una
citazione del regista Carlo Lizzani, in cui “stacco la chiave” diventa “stacco
la spina”.
Sarà per
questo che Indro Montanelli decise di non affrontare l’esame e Milena Gabanelli
di non riaffrontarlo? Sarà per questo che Paolo Mieli è stato bocciato? E che
dire di Aldo Busi il cui compito respinto era considerato un capolavoro e
ricercato a suon di moneta? È in buona compagnia la signora Gabanelli & Company.
Infatti si racconta che anche Alberto Moravia fu bocciato all’esame da
giornalista professionista. Poco male. Sono le eccezioni che confermano la
regola. Non sono gli esami giudicate da siffatte commissioni che possono
attribuire patenti di eccellenza. Se non è la meritocrazia ha fare leva in
Italia, sono i mediocri allora a giudicare. Ed a un lettore poco importa sapere
se chi scrive ha superato o meno l'esame di giornalismo. Peccato che per
esercitare una professione bisogna abilitarsi ed anche se eccelsi non è facile
che i mediocri intendano l'eccellenza. L’esperienza e il buon senso, come
sempre, sono le qualità fondamentali che nessuno (pochi) può trasmettere o sa
insegnare. Del resto, si dice che anche Giuseppe Verdi fu bocciato al
Conservatorio e che Benedetto Croce e Gabriele D’Annunzio non si erano mai
laureati.
Che dire delle
Commissioni di esame di avvocato. Parliamo della sessione 2012. Potremmo
parlarne per le sessioni passate, ma anche per quelle future: tanto in questa
Italia le cose nefaste sono destinate a durare in eterno.
A Lecce
sarebbero solo 440 su 1258 i compiti ritenuti validi. Questo il responso della
Commissione di Catania, presieduta dall’Avvocato Antonio Vitale, addetta alla
correzione degli elaborati. Più di cento scritti finiscono sul tavolo della
Procura della Repubblica con l’accusa di plagio, per poi, magari, scoprire che è
tutta una bufala. Copioni a parte, sarebbe, comunque, il 65% a non superare
l’esame: troppi per definirli asini, tenuto conto che, per esperienza personale,
so che alla fase di correzione non si dedicano oltre i 5 minuti, rispetto ai
15/20 minuti occorrenti. Troppo pochi per esprimere giudizi fondati. Oltretutto
l’arbitrio non si motiva nemmeno rilasciando i compiti corretti immacolati.
Prescindendo
dalla caccia mirata alle streghe, c’è forse di più?
Eppure c’è chi
queste commissioni li sputtana. TAR Lecce: esame forense, parti estratte da un
sito? Legittimo se presenti in un codice commentato. È illegittimo
l’annullamento dell’elaborato dell’esame di abilitazione forense per essere
alcune parti estratte da un sito, se tali parti sono presenti all’interno di un
codice commentato. (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce –
Sezione Prima, Ordinanza 19 settembre 2013, n. 465).
E’ lo stesso
Tar Catania che bacchetta la Commissione d’esame di Avvocato della stessa città
Esame di avvocato...Copiare non sempre fa rima con annullare - TAR CATANIA
ordinanza n. 1300/2010. Esame avvocato: Qualora in sede di correzione
dell'elaborato si accerta che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da
altro elaborato o da qualche manuale, per condurre all’annullamento della
prova, deve essere esatto e rigoroso. Tale principio di diritto è desumibile
dall’ordinanza in rassegna n. 1300/2010 del TAR Catania che ha accolto l’istanza
cautelare connessa al ricorso principale avanzata avverso la mancata ammissione
del ricorrente alla prova orale dell’esame di avvocato. In particolare, per il
Tar etneo “il ricorso appare fondato, in quanto la Commissione si è limitata
ad affermare apoditticamente che il compito di diritto penale della ricorrente
conteneva “ampi passi del tutto identici all’elaborato di penale contenuto” in
altra busta recante il n. 459 senza alcuna specificazione, anche sul compito,
che consenta di appurare che questa presunta “identità” vada oltre la semplice
preparazione sui medesimi testi, o la consultazione dei medesimi codici”.
Per il TAR siciliano, inoltre, “l’elaborato di penale del candidato
contraddistinto dal n. 459 era stato corretto da una diversa sottocommissione
durante la seduta del 19 marzo 2010, e tale elaborato non risulta essere stato
parimenti annullato”.
E a sua volta
è la stessa Commissione d’esame di Avvocato di Lecce ad essere sgamata. Esami di
avvocato. Il Tar di Salerno accoglie i ricorsi dei bocciati. I ricorsi accolti
sono già decine, più di trenta soltanto nella seduta di giovedì 24 ottobre 2013,
presentati da aspiranti avvocati bocciati alle ultime prove scritte da un
giudizio che il Tar ha ritenuto illegittimo in quanto non indica i criteri sui
cui si è fondato. Il Tribunale amministrativo sta quindi accogliendo le domande
cautelari, rinviando al maggio del 2014 il giudizio di merito ma indicando, per
sanare il vizio, una nuova procedura da affidare a una commissione diversa da
quella di Lecce che ha deciso le bocciature. Il numero dei bocciati, reso noto
lo scorso giugno 2013, fu altissimo. Soltanto 366 candidati, su un totale di
1.125, passarono le forche caudine dello scritto e furono ammessi alle prove
orali. Una percentuale del 32,53: quasi 17 punti in meno del 49,16 registrato
alla sessione dell’anno precedente. Numeri, questi ultimi, in linea con una
media che, poco più o poco meno, si è attestata negli ultimi anni
sull’ammissione della metà dei partecipanti. Nel 2012, invece, la ghigliottina è
caduta sul 64,09 per cento degli esaminandi. In numeri assoluti i bocciati
furono 721, a cui vanno aggiunti i 38 compiti (3,38 per cento) annullati per
irregolarità come il rinvenimento di svolgimenti uguali. Adesso una parte di
quelle persone ha visto accogliere dal Tar i propri ricorsi. I criteri usati dai
commissari per l’attribuzione del punteggio, hanno spiegato i giudici, «non si
rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle
ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della
Sottocommissione locale». La valutazione, quindi, «deve ritenersi
l'illegittima».
Che ne sarà di
tutti coloro che quel ricorso non lo hanno presentato. Riproveranno l’esame e,
forse, saranno più fortunati. Anche perché vatti a fidare dei Tar.
Ci si deve
chiedere: se il sistema permette da sempre questo stato di cose con il libero
arbitrio in tema di stroncature dei candidati, come mai solo il Tar di Salerno,
su decine di istituzioni simili, vi ha posto rimedio?
Esami di
Stato: forche caudine, giochi di prestigio o giochi di azzardo? Certo non
attestazione di merito.
Sicuramente
nell’affrontare l’esame di Stato di giornalismo sarei stato bocciato per aver,
questo articolo, superato le 45 righe da 60 caratteri, ciascuna per un totale di
2.700 battute, compresi gli spazi. Così come previsto dalle norme.
Certamente,
però, si leggerà qualcosa che proprio i giornalisti professionisti preferiscono
non dire: tutte le commissioni di esame sono inaffidabili, proprio perché sono i
mediocri a giudicare, in quanto in Italia sono i mediocri a vincere ed a fare
carriera!
LO STATO
CON LICENZA DI TORTURARE ED UCCIDERE.
"Licenza di tortura". Ilaria Cucchi. La famiglia di Federico Aldrovandi, Aldo
Bianzino, Riccardo Rasman. La nipote di Franco Mastrogiovanni. Parenti e amici
di persone picchiate o uccise da forze dell'ordine, guardie penitenziarie,
medici. La giovane fotografa Claudia Guido ha deciso di immortalare i loro
volti. Per mostrare che potrebbe succedere ad ognuno di noi, scrive Francesca
Sironi su “L’Espresso”. Rudra Bianzino indossa una giacca blu, ha le mani in
tasca, sullo sfondo le colline di Perugia. Suo padre, Aldo, è morto in carcere
cinque anni fa. Era entrato in ottima salute. È uscito due giorni dopo in una
bara. L'unica certezza che Rudra e i suoi fratelli hanno avuto dal processo,
finora, è che il padre si sarebbe potuto salvare, se qualcuno avesse ascoltato
le sue urla di dolore. Ma la guardia carceraria ch'era servizio non ha chiamato
i soccorsi. Per questo l'agente è stata condannato a un anno e mezzo di
reclusione: ma in carcere non ci andrà perché la pena è sospesa. Quella di Aldo
Bianzino e dei suoi figli è una delle undici storie raccontate attraverso i
ritratti dei parenti e dei “sopravvissuti” da Claudia Guido, giovane fotografa
padovana che li ha raccolti in una mostra itinerante intitolata “ Licenza di
tortura ”. Un progetto che, spiega l'autrice, è diventato anche una forma di
protesta: «Per due anni ho vissuto con queste famiglie. Ho conosciuto le loro
battaglie, lo sconforto, la difficoltà di arrivare non dico a una sentenza, alla
punizione dei colpevoli, ma anche semplicemente al processo: che costa tanto,
economicamente ed emotivamente. Con loro ho conosciuto anche la tortura
quotidiana dell'abbandono e delle parole di chi accusa, deride o rilegge le loro
storie senza pensare alla sofferenza che provano intere famiglie». Gli scatti
della Guido sono frontali, scarni, senza forzature: «Non ho aggiunto elementi
distintivi, non ho associato ai ritratti le immagini agghiaccianti delle vittime
che abbiamo visto sui giornali», spiega l'autrice: «Perché quello che vorrei
trasmettere è il sentimento che ho provato io stessa leggendo queste storie sui
quotidiani: l'idea che quelle violenze sarebbero potute capitare a me. Quando
mia madre ha visto la foto di Patrizia Moretti ha detto: “Potrei essere io”».
Lucia Uva - sorella di Giuseppe. La notte tra il 13 e il 14 luglio 2008 Giuseppe
Uva rimase per tre ore nella caserma dei carabinieri di Varese. Da lì fu
trasferito in ospedale, dove morì. Il giudice di primo grado, Orazio Muscato, ha
scritto che le cause del decesso andrebbero individuate "in una tempesta emotiva
legata al contenimento, ai traumi auto e/o etero prodotti, nonché all'agitazione
da intossicazione alcolica acuta". Se ha assolto i medici, il tribunale ha
stabilito però che "permangono ad oggi ignote le ragioni per le quali Giuseppe
Uva, nei cui confronti non risulta esser stato redatto un verbale di arresto o
di fermo, mentre sarebbe stata operata una semplice denuncia per disturbo della
quiete pubblica, è prelevato e portato in caserma, così come tutt'ora
sconosciuti rimangono gli accadimenti intervenuti all'interno della stazione dei
carabinieri di Varese (certamente concitati, se è vero che sul posto confluirono
alcune volanti di polizia) ed al cui esito Uva, che mai in precedenza aveva
manifestato problemi di natura psichiatrica, verrà ritenuto necessitare di un
intervento particolarmente invasivo quale il trattamento sanitario
obbligatorio". Patrizia Moretti, la madre di Federico Aldrovandi , ucciso di
botte da quattro poliziotti la notte del 25 settembre 2005, è stata uno dei
primi contatti della ventinovenne padovana. Poi sono arrivati il padre e il
fratello di Federico, insieme alle altre vittime che ora stanno girando per
tutta Italia : la mostra arriverà a breve anche a Roma e a Milano. «Dopo undici
casi mi son dovuta fermare: ero troppo coinvolta. Ma non escludo la possibilità
di continuare: l'argomento è purtroppo sempre attuale». Nel frattempo,
dall'aprile del 2011, la Guido ha portato davanti al suo obiettivo Ilaria
Cucchi, la sorella di Stefano , morto dopo esser stato arrestato, picchiato, e
lasciato senza cure il 22 ottobre del 2009; la famiglia di Riccardo Rasman, il
giovane con problemi psichici immobilizzato, colpito e asfissiato da tre agenti,
a casa sua, il 27 ottobre del 2006; un sopravvissuto come Paolo Scaroni , il
tifoso che nel 2005 finì in coma per le manganellate della polizia e dal suo
risveglio ha avviato una battaglia legale per individuare i colpevoli; o come
Stefano Gugliotta, menato da uomini in divisa il 5 maggio del 2010 e salvatosi
da una condanna per “resistenza a pubblico ufficiale” solo grazie ai video
girati col cellulare dagli abitanti della zona. Nella mostra ci sono poi Grazia
Serra, nipote di Franco Mastrogiovanni , il maestro morto il 4 agosto 2009 in un
reparto psichiatrico dell'ospedale di Vallo della Lucania, dopo esser rimasto
per ore legato a un letto senza cure né acqua. Si sono fatti ritrarre anche il
padre, la madre e la sorella di Carlo Giuliani , il ragazzo di 23 anni ucciso da
un proiettile della polizia il 20 luglio 2001 durante le contestazioni del G8 di
Genova ; la figlia di Michele Ferrulli , il 51enne morto d'infarto mentre veniva
arrestato il 30 giugno del 2011; Luciano Isidro Diaz , fermato la notte del 5
aprile del 2009 mentre guidava troppo forte e reso vittima di lesioni così gravi
da causargli la perforazione di un timpano e il distacco della retina; e infine
la sorella e il migliore amico di Giuseppe Uva , l'uomo morto in ospedale dopo
esser stato trattenuto per tre ore nella caserma dei carabinieri di Varese. Ci
sono i volti di tutti loro. Che interrogano, per primo, lo Stato. Perché non
lasci ripetere quelle violenze.
E LA CHIAMANO GIUSTIZIA. CHE CAZZO DI INDAGINI SONO?
Il perito non capisce il dialetto: tre anni in cella da
innocenti. A causa di intercettazioni mal interpretate
due fratelli pugliesi vengono scambiati per mafiosi e sbattuti in carcere. Ora
chiedono allo Stato un milione di risarcimento, scrive Peppe Rinaldi su
“Libero Quotidiano”. In Italia puoi essere sbattuto dentro e restarci
tre anni perché il consulente incaricato di analizzare le intercettazioni è di
Bologna e, non capendo il dialetto delle tue parti, interpreta fischi per
fiaschi. In Italia puoi esser agguantato d’improvviso insieme a tuo fratello
perché «promotori di un sodalizio mafioso» che ti costerà 36 e passa mesi di
cella. È possibile questo e pure altro, tanto non accadrà nulla a nessuno:
tranne che a te, alla tua famiglia e al tuo lavoro. Vecchia storia, solita
storia. La stessa capitata ai fratelli Antonio e Michele Ianno, di San Marco in
Lamis (Foggia) che un bel mattino si sono visti ammanettare dalla Dda di Bari.
Saranno detenuti «cautelarmente» tre anni uno e tre anni e mezzo l’altro, salvo
accorgersi poi che non c’entravano niente, che quel clan non l’avevano mai
costituito e che il duplice omicidio in concorso di cui erano accusati non lo
avevano compiuto. E neppure un altro tentato omicidio, il porto d’armi illegale,
niente di niente. Insomma, si trattava di un gigantesco abbaglio giudiziario.
Nel giugno del 2004 il gip del tribunale di Bari firma la richiesta di custodia
cautelare del pm della Dda per Antonio e Michele Ianno, poco meno che 40enni
all’epoca, di professione «mastri di cantiere», cioè piccoli imprenditori edili
formatisi a botte di secchi di calce sulle spalle. Sono considerati promotori di
una compagine malavitosa facente capo alle famiglie Martino-Di Claudio, operante
nel contesto della così detta mafia garganica. Associazione mafiosa (il “mitico”
art. 416 bis), concorso in tentato omicidio e in duplice omicidio, porto
illegale di armi, il tutto con l’aggravante di voler favorire i clan. Una
gragnuola di accuse da svenire solo a leggerne i capi d’imputazione, un fulmine
che incendia la vita dei due. E non solo. La difesa, rappresentata dal prof.
avv. Giuseppe Della Monica, prova a spiegare che stavano prendendo un granchio
ma quando le cose prendono una certa piega raddrizzarle è impresa titanica. Sarà
così tutto un crescendo di ricorsi e controricorsi, un supplizio di
“calamandreiana” memoria. In queste storie, in genere o c’è un «pentito» che si
ricorda di te oppure, intercettando a strascico in una certa area sensibile, si
rischia di scambiare lucciole per lanterne. Se di sbagliato poi c’è anche la
relazione di un consulente del pm che - chissà perché scovato a Bologna -
fraintende il dialetto pugliese ecco che la faccenda si complica, fino a farsi
kafkiana grazie a un’altra ordinanza che colpirà i fratelli, per giunta per gli
stessi reati più un’estorsione che prima non c’era: un modo come un altro per
mandare a farsi benedire il ne bis in idem. Negli atti si legge un po’ di tutto
oltre al sangue versato: appalti del comune di San Marco in Lamis di esclusivo
appannaggio degli Ianno mentre invece l’ente attesterà che non era vero esibendo
l’elenco delle opere pubbliche; oppure il pericolo di fuga a giustificazione
dell’arresto: per la Dda i due s’erano dati alla macchia per evitare lo Stub (il
guanto di paraffina) ma la difesa riuscirà a provare che non era così perché un
vigile urbano li aveva identificati su un cantiere per le proteste di un vicino
disturbato dai rumori proprio il giorno del reato contestato. Siamo nel 2006,
due anni sono già trascorsi intanto. La seconda ordinanza viene annullata
totalmente in udienza preliminare e il giudice ordina la scarcerazione «se non
detenuto per altro motivo». L’altro motivo, però, c’era ed era la prima
ordinanza, i cui effetti erano ancora in itinere dinanzi alla Corte d’Assise di
Foggia. Per farla breve, i giudici alla fine si accorgeranno dell’errore della
procura e scarcereranno prima Michele e poi Antonio, a distanza di sei mesi uno
dall’altro. Inutile dire delle conseguenze dirette ed indirette patite.
Risultato? Lo stato prepari un bell’assegno circolare da un milione di euro:
tanto hanno chiesto nel 2010 - quando tutto è passato in giudicato - cioè il
massimo previsto dalla legge (500mila euro cadauno) per tanta gratuita tragedia.
Ovviamente ancora aspettano.
Ed ancora. Correva l’anno 2006. Il 29 settembre, per l’esattezza, scrive
di Walter Vecellio su “Libero Quotidiano”. Il luogo: Ruvo del Monte,
comune, informano i manuali di geografia, in provincia di Potenza, «situato a
638 metri sul livello del mare, nella zona Nord Occidentale della Basilicata, ai
confini con l’Irpinia». A Ruvo del Monte vivono circa milleduecento persone; è
da credere si conoscano tutti. E più di tutti, i locali carabinieri, che con il
locale sacerdote, evidentemente sono a conoscenza di tutto quello che accade, si
fa, si dice. Dovrebbero, si suppone, anche conoscere due fratelli gemelli,
Domenico e Sebastiano. Dovrebbero conoscerli bene, perché in paese non deve
certo essere sfuggito il fatto che patiscono gravi ritardi mentali. Quando il 29
settembre del 2006 i carabinieri, frugando nella casa dei due fratelli trovano
una rivoltella, hanno evidentemente fatto il loro dovere, sequestrandola. Ed è
quello che prescrive la legge, quando viene redatto un rapporto che riassume
l’accusa in un paio di righe: «Detenzione illegale di arma». I carabinieri si
suppone conoscano le armi; se sostengono che si tratta di una pistola fabbricata
prima del 1890, si suppone sappiano quello che dicono. E cosa si fa, in casi del
genere? Si istruisce un processo; un processo per detenzione di arma illegale
che si conclude nel 2012. La sentenza: «Non luogo a procedere». E come mai, nel
2006 la detenzione illegale di arma sei anni dopo diventa «non luogo a
procedere»? Come mai, nei fatti e in concreto, il giudice di Melfi assolve
pienamente i due fratelli? Perché la pistola non è una pistola; perché non si
può detenere illegalmente un’arma che non è un’arma. Perché la pistola che si
diceva «fabbricata prima del 1890» in realtà è una pistola giocattolo. I due
fratelli l’avevano detto con tutto il fiato che avevano in gola: «Non è un’arma,
è un giocattolo». Niente da fare. «Detenzione di arma illegale». Bastava
guardarla, quell’«arma illegale»: «Si vedeva subito che era finta, con quella
foggia bizzarra che ricalca quelle strette alla cintura dei conquistadores
spagnoli del ‘500». Per i carabinieri era «un’arma illegale». I carabinieri come
mai erano entrati a casa dei due fratelli? Cercavano oggetti sacri rubati al
cimitero del paese. Qui si può immaginare la scena: chi può introdursi in un
cimitero per rubare? Degli spostati. E in paese, tutti lo sanno, i due fratelli
con la testa non ci sono del tutto. Allora andiamo da loro. Si bussa alla porta,
loro aprono. «Si può?». «Prego, accomodatevi». Ecco. E lì, in bella vista
«l’arma illegale». Subito in caserma, per l’interrogatorio di rito. Poi l’avviso
di garanzia. Passano i giorni, le settimane e i mesi, e arriva l’imputazione:
articolo 687 del codice di procedura penale, che punisce appunto la detenzione
illegale di armi: dai tre ai dodici mesi, 371 euro di ammenda. Si chiudono le
indagini preliminari, c’è il rinvio a giudizio. Finalmente qualcuno pensa di
rivolgersi a un perito. Naturalmente è l’avvocato dei due fratelli, non ci
pensano né i carabinieri né il Pubblico Ministero. Racconta l’avvocato:
«All’apertura della busta contenente la presunta arma idonea a offendere,
presenti io, il giudice e il perito tutto si è risolto in una risata. Non c’è
stato nemmeno bisogno di una analisi approfondita: una colata unica, un
simulacro da bancarella».
Ed Ancora. "Aspettavo questo momento da 36 anni". Giuseppe Gulotta, accusato
ingiustamente di essere l'autore del duplice omicidio dei carabinieri Carmine
Apuzzo e Salvatore Falcetta, avvenuto nella casermetta di Alcamo Marina il 27
gennaio 1976, lascia da uomo libero il tribunale di Reggio Calabria dove dopo
esattamente 36 anni dal giorno del suo arresto (21 gli anni trascorsi in cella)
è stato dichiarato innocente. Un nuovo macroscopico caso di malagiustizia,
scrive “Libero Quotidiano”. Alla lettura della sentenza, al termine del processo
di revisione che si è svolto a Reggio Calabria, Gulotta è scoppiato in lacrime,
insieme alla sua famiglia. Accanto a lui c'erano gli avvocati Baldassarre Lauria
e Pardo Cellini che lo hanno assistito durante l'iter giudiziario. "Spero - ha
dichiarato l'uomo parlando con i giornalisti - che anche per le famiglie dei due
carabinieri venga fatta giustizia. Non ce l’ho con i carabinieri - ha precisato
- solo alcuni di loro hanno sbagliato in quel momento". Giuseppe Gulotta,
nonostante la complessa vicenda giudiziaria che lo ha portato a subire nove
processi più il procedimento di revisione, non ha smesso di credere nella
giustizia. "Bisogna credere sempre alla giustizia. Oggi è stata fatta una
giustizia giusta", ha però aggiunto. Un ultimo pensiero va all’ex brigadiere
Renato Olino, che con le sue dichiarazioni ha permesso la riapertura del
processo: "Dovrei ringraziarlo perché mi ha permesso di dimostrare la mia
innocenza però non riesco a non pensare che anche lui ha fatto parte di quel
sistema". Il 26 gennaio 1976 furono trucidati i carabinieri Salvatore Falcetta e
Carmine Apuzzo. Ad accusare Gulotta della strage fu Giuseppe Vesco, considerato
il capo della banda, suicidatosi nelle carceri di San Giuliano a Trapani,
nell'ottobre del 1976 (era stato arrestato a febbraio). Gulotta, in carcere per
21 anni, dal 2007 godeva del regime di semilibertà nel carcere di San Gimignano
(Siena). Venne arrestato il 12 febbraio 1976 dai militari dell'Arma dopo la
presunta confessione di Vesco. Nel 2008 la procura di Trapani ha iscritto nel
registro degli indagati con l'accusa di sequestro di persona e lesioni aggravate
alcuni carabinieri, oggi in pensione, che nel 1976 presero parte agli
interrogatori degli accusati della strage di Alcamo Marina: il reato contestato
agli agenti è quello di tortura nei confronti degli interrogati.
Dall’altra parte ci troviamo al paradosso. Il killer ha confessato 30 delitti e
ha fatto luce su altri 50. Pentitosi di essere diventato un collaboratore di
giustizia ha ricominciato dedicandosi allo spaccio di droga. Per questo era
stato riammanettato e condannato a 20 anni di galera, scrive Peppe Rinaldi su
“Libero Quotidiano”. C’è un signore che ha confessato trenta omicidi e ha fatto
luce, con dichiarazioni ad hoc, su altri cinquanta. Era un «pentito» di camorra
che, pentitosi del pentimento, ricominciò alla grande sbarcando in Emilia
Romagna per dedicarsi alla spaccio internazionale di droga. Ovviamente, in
associazione (a delinquere) con altri. Lo stesso signore, riammanettato e
condannato a 20 anni nel secondo grado del nuovo giudizio, invece che starsene
in gattabuia circola liberamente per le strade di Afragola, popoloso centro
dell’hinterland napoletano celebre per essere anche la città d’origine di
Antonio Bassolino. Si chiama Mauro Marra, è tecnicamente un libero
cittadino perché i suoi giudici naturali non hanno trovato il tempo di rifargli
il processo come aveva loro intimato la Corte di Cassazione: sono scaduti i così
detti «termini di fase», non c’è più nulla da fare, se riuscite a fargli
nuovamente il processo che spetta a ogni cittadino italiano indipendentemente
dal reato commesso (si chiama civiltà giuridica) bene, altrimenti Marra deve
starsene a casa, come per ora già sta facendo. È una storia incredibile ma vera,
neanche tanto originale se si considera lo stato comatoso del servizio giustizia
nel Paese. Ne ha scritto ieri il più antico quotidiano italiano, il Roma.
Quando parli di Mauro Marra non ti appare il ragazzotto di Scampia, imbottito di
cocaina scadente e pronto a sparare anche per 200 euro. No, parli di uno che non
solo ha ucciso trenta avversari del clan nemico, non solo era nei programmi
strategici per fare altrettanto con ulteriori 50 persone (cosa che si verificò)
ma addirittura di uno dalla cieca fede in Raffaele Cutolo (l’ultimo,
vero, padrino) e braccio destro di Pasquale Scotti, latitante da 28 anni
che difficilmente qualcuno, ormai, prenderà. Sempre che sia vivo. Marra, poi, è
ancora molto altro: è il super killer della Nco (Nuova camorra organizzata) che
sbugiardò gli accusatori di Enzo Tortora aprendo uno squarcio su una
delle punte massime del disonore del sistema giudiziario. «Hanno accusato un
innocente» disse in aula il 25 settembre 1985, riferendosi alle «visioni» dei
vari Barra, Melluso, Auriemma, Catapano, Pandico e Dignitoso. Anche
grazie a quella presa di posizione per l’ex presentatore televisivo fu possibile
risalire la china ed ottenere -diciamo- giustizia. Scansata la matematica sfilza
di ergastoli grazie alla legge sul pentitismo, dopo una ventina d’anni riprese a
delinquere e finì incarcerato nel 2006 mentre era in una località protetta del
Nord. Il 26 marzo 2009 la I sezione penale lo condanna a 18 anni; in secondo
grado la IV Corte d’Appello di Napoli gli aumenta la pena a venti. Siamo nel
dicembre 2011. Il 21 novembre scorso la Cassazione ribalta tutto rinviando gli
atti a Napoli per una nuova sentenza: i tre anni entro cui i magistrati
avrebbero dovuto rendere definitiva la pena (i termini di fase) sono trascorsi
vanamente e, pertanto, Marra deve essere scarcerato. Ovviamente il lavoro
minuzioso di ricostruzione degli avvocati (Antonio Abet e Giuseppe Perfetto)
è stato determinante. Da una settimana il pluriomicida è libero. Aspetta che la
sentenza diventi definitiva. Non è scritto però da nessuna parte che i giudici
di II grado lo condannino, così come è altrettanto probabile che ricorra,
eventualmente, ancora in Cassazione. E il tempo passa. Ma sarà senz’altro colpa
dei cancellieri che mancano, degli stenografi che non si trovano o della carta
per fotocopie che scarseggia.
27 NOVEMBRE 2013. LA DECADENZA DI BERLUSCONI.
Storicamente, il populismo, ha rappresentato una delle più
sofisticate manifestazioni politiche di
disprezzo per il popolo. La premessa serve a
fare gli elogi al discorso tenuto in Senato dalla capogruppo del M5S, Paola
Taverna. Un discorso compatto, preciso, ricco di passione e ritmo, costruito
impeccabilmente. “In dieci minuti quello che
il Pd non ha detto per venti anni“, è stato
scritto sulla rete. Lo ripropongo nello stenografico di Palazzo Madama (i
puntini di sospensione segnalano le infinite, e stizzite, interruzioni da parte
di Forza Italia).
«Signor Presidente, onorevoli
colleghi, si chiude, oggi, impietosamente, una «storia italiana», segnata dal
fallimento politico, dall’imbarbarimento morale, etico e civile
della Nazione e da una pesantissima storia criminale. Storie che si intrecciano,
maledettamente, ai danni di un Paese sfinito e che riconducono ad un preciso
soggetto, con un preciso nome e cognome: Silvio Berlusconi. La
sua lunga e folgorante carriera l’abbiamo già ricordata in passato: un percorso
umano e politico costellato di contatti e rapporti mai veramente chiariti, che
passano per società occulte, P2, corruzione in atti giudiziari, corruzione
semplice, concussione, falsa testimonianza, finanziamento illecito, falso in
bilancio, frode fiscale, corruzione di senatori, induzione alla prostituzione,
sfruttamento della prostituzione e prostituzione minorile. Insomma un
delinquente abituale, recidivo e dedito al
crimine, anche organizzato, visti i suoi sodali. Ideatore,
organizzatore e utilizzatore finale dei reati da lui commessi. Senatore
Berlusconi, anzi signor Berlusconi, mi dispiace che lei non sia in Aula. Forse
alcuni hanno dimenticato che la sua discesa in campo ha avuto soprattutto, per
non dire esclusivamente, ragioni imprenditoriali: la situazione della Fininvest
nei primi anni Novanta, con più di 5.000 miliardi di lire di debiti, parlava fin
troppo chiaro; il rischio di bancarotta era dietro l’angolo.
Alcuni suoi dirigenti vedevano come unica via d’uscita il deposito dei libri
contabili in tribunale. La cura Forza Italia è stata fantastica per le sue
finanze, perché – ricordiamolo – non è entrato in politica per il bene di questo
Paese, come declamava da dietro una scrivania su tutte le sue televisioni. Le
elezioni politiche del 1994 hanno segnato l’inizio di una carriera parlamentare
illegittima, sulla base della violazione di una legge vigente sin dal 1957, la
n. 361, secondo la quale Silvio Berlusconi era ed è palesemente ineleggibile.
Quella legge non è mai stata applicata, benché fosse chiarissima, grazie alla
complicità del centrosinistra di dalemiana e violantiana memoria. Per non
parlare dell’eterna promessa, mai mantenuta, di risolvere il conflitto di
interessi. E tutto ciò è avvenuto non per ragioni giuridiche – come ora
qualcuno, mentendo, vorrebbe farci credere – ma per onorare patti scellerati,
firmati sottobanco per dividersi le spoglie di un Paese. Forse qualcuno si
indignerà, urlando che queste sono semplici illazioni. Lasciamo che sia
la storia a rispondere! Camera dei deputati, 28 febbraio 2002,
Resoconto stenografico della seduta n. 106 della XIV legislatura. Cito le
parole dell’onorevole Luciano Violante, al tempo capogruppo dei
Ds, oggi Pd, mentre si rivolge ad un collega dell’apparentemente opposto
schieramento: «(…) l’onorevole Berlusconi (…) sa per certo che gli è stata data
la garanzia piena – e non adesso, nel 1994, quando ci fu il cambio di Governo –
che non sarebbero state toccate le televisioni.. Lo sa lui e lo sa l’onorevole
Letta», zio. «Voi ci avete accusato di regime nonostante non avessimo fatto il
conflitto di interessi, avessimo dichiarato eleggibile Berlusconi nonostante le
concessioni (…). Durante i Governi di centrosinistra il fatturato di Mediaset è
aumentato di 25 volte». Questa è storia! Come storia è la discesa in campo del
senatore, fatta di promesse mai mantenute: dal taglio delle tasse al milione di
posti di lavoro. Ma non era l’imprenditore illuminato che avrebbe salvato
l’Italia, anzi l’azienda Italia? Quello che doveva pensare alla cosa pubblica?
Dal discorso del senatore Berlusconi del 1994 cito: «La vecchia classe politica
è stata travolta dai fatti e superata dai tempi. (…) L’autoaffondamento dei
vecchi governanti, schiacciati dal debito pubblico e dal finanziamento illegale
dei partiti, lascia il Paese impreparato e incerto nel momento difficile del
rinnovamento e del passaggio ad una nuova Repubblica». Incredibile, ma vero:
sono proprio sue parole. Potrà però sorgerci legittimamente il dubbio che si sia
preso gioco di noi per vent’anni, e ancora adesso? Due mesi fa abbiamo visto
diversi Ministri, in suo nome, presentare le dimissioni dando inizio al
siparietto della prima crisi di un Governo nato precario, per
non parlare della legge di stabilità che giaceva ormai da settimane nella 5a Commissione.
Ma lo vogliamo dire agli italiani che la legge, che dovrebbe assicurare i conti
ma soprattutto garantire la ripartenza economica del nostro Paese e la sua
stabilità, è stata svilita e degradata a semplice espediente dilatorio per farle
guadagnare qualche altro giorno in carica? Oppure vogliamo ricordare i due bei
regali che riceverà a spese di tutti noi contribuenti? Assegno di solidarietà
pari a circa 180.000 euro; assegno vitalizio di 8.000 euro mensili. C’è bisogno
poi di ricordare perché ancora oggi qualcuno, nonostante l’evidenza dei fatti,
nonostante una sentenza passata in giudicato, voglia un voto, uno stramaledetto
voto per applicare una legge? Ha senso ribadire lo sfacelo di venti anni di
indottrinamento fondato sull’apparire, sul dire e il non fare, sull’avere e non
sull’essere? Anche nell’ultimo atto della sua storia parlamentare comunque il
senatore riuscirà a segnare un record. L’illegittimità e l’indegnità
della sua carica senatoriale sono addirittura triple: incandidabilità
sopravvenuta, ineleggibilità e interdizione da pubblici uffici per indegnità
morale. In sostanza, un vero e proprio capolavoro! Questo Senato poi sentirà
un’enorme mancanza dell’operato parlamentare del signor Berlusconi. Ho sentito
oggi riprendere i senatori a vita. Dall’inizio della legislatura i dati
dimostrano la sua dedizione al lavoro in questa istituzione; dimostrano la
passione con cui ha interpretato il proprio mandato nell’interesse del Paese:
disegni di legge presentati zero; emendamenti presentati zero; ordini del giorno
zero; interrogazioni zero; interpellanze zero; mozioni zero; risoluzioni zero (Applausi
dal Gruppo M5S); interventi in Aula uno, per dare la fiducia a questo
Governo (eppure oggi è all’opposizione); presenze in Aula 0,01 per cento!
Quindi, di cosa stiamo discutendo? Della decadenza dalla carica di senatore di
un personaggio che il suo mandato non lo ha mai neppure lontanamente svolto, di
un signore che però ha puntualmente portato a Palazzo Grazioli e ad Arcore ben
16.000 euro al mese per non fare assolutamente nulla, se non
godere dell’immunità parlamentare. In questi venti anni il signor Berlusconi è
stato quattro volte Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente del
Consiglio dell’Unione europea, due volte Ministro dell’economia e delle finanze,
una volta Ministro dello sviluppo economico, Ministro degli affari esteri,
Ministro della salute ma, soprattutto, è stato il Presidente del Consiglio che
ha mantenuto per più tempo la carica di Governo e che ha disposto della più
ampia maggioranza parlamentare della storia. Un immenso potere svilito e
addomesticato esclusivamente ai propri fini, cioè architettare reati e
incrementare il suo personale patrimonio economico.… Quante cose avrebbe potuto
fare per questo nostro Paese, se solo avesse anteposto il bene comune ai suoi
interessi personali, le riforme strutturali alle leggi ad personam! E,
invece, dopo tutto questo tempo ci troviamo con la disoccupazione al 40 per
cento, pensionati a 400 euro mensili, nessun diritto alla salute, nessun diritto
all’istruzione… un territorio devastato dalle Alpi alla Sicilia, le nostre città
sommerse dalle piogge… e le nostre campagne avvelenate… Era il 1997 quando
Schiavone veniva a denunciare dove erano stati sversati quintali di rifiuti
tossici: lo stesso anno in cui questo Stato decise di segretare tali
informazioni. Tutto ciò con l’IVA al 22 per cento e un carico fiscale che si
conferma il più alto d’Europa, pari al 65,8 per cento dei profitti commerciali…
e gli imprenditori… che si suicidano per disperazione, spesso nemmeno per
debiti, ma per i crediti non pagati dalla pubblica amministrazione, cioè dallo
Stato stesso! Di tutto questo il senatore Berlusconi non sembra
preoccuparsi. La decadenza di un intero Paese sembra non interessargli
minimamente, conta solo la sua. Giusto…Ha il terrore di espiare la propria pena
ai servizi sociali, di svolgere mansioni che ritiene non alla sua altezza… Beh,
sappia che quelli sono lavori che centinaia di migliaia di italiani perbene
svolgono con dignità e onestà… Gli auguriamo che questa possa essere invece
un’occasione per uscire dal suo mondo dorato, così forse potrà rendersi conto
del disastro e del baratro in cui i cittadini normali si trovano a causa del
sistema da lui generato e alimentato…Questo però non deve essere un discorso di
rabbia. Questo vuole essere un discorso di speranza…Concludo,
Presidente. La nostra presenza in quest’Aula oggi rappresenta un solo e semplice
concetto: noi non vogliamo chiamarci politici, ma restituire il potere ai
cittadini… Questa non è una vendetta. Qui non c’è nessuna ingiustizia o
persecuzione. Qui ci sono solo cittadini italiani che vogliono
riprendersi il proprio presente, altrimenti non avranno più un
futuro.»
La decadenza di Berlusconi. Cronaca, frasi, retroscena di una giornata entrata
nella storia della politica, scrive Paola Sacchi su “Panorama”. Aldo
Cazzullo editorialista e commentatore del "Corriere della sera" inarca il
sopracciglio e un po' sorride quando, in uno dei corridoi di Palazzo Madama, il
verace senatore dalemiano Ugo Sposetti confessa: "La decadenza di Silvio
Berlusconi è come la caduta del muro di Berlino, ma i miei ora devono stare
attenti: quel muro in Italia venne addosso tutto a chi lo aveva preso a
picconate, la Dc e il Psi....". Il senatore Pd, Stefano Esposito, anche lui di
rito dalemiano a Panorama.it ammette chiaramente: "Sì, Berlusconi è decaduto, ma
è uscito solo dalla vita parlamentare, non dalla politica. L'uomo è ancora vivo
e vegeto e guai se il Pd lo dà per morto, commetterebbe lo stesso errore fatto
con la sottovalutazione di Beppe Grillo". Se queste sono le grida d'allarme che
vengono dalla sinistra (tendenza riformista), figuriamoci quelle che vengono da
Forza Italia. "Sarà per loro un boomerang", dice secco il senatore Fi Altero
Matteoli. E il vicepresidente del Senato (Fi) Maurizio Gasparri è caustico
sulla conduzione dei lavori in aula da parte del presidente Pietro Grasso: "Lui
è l'ultima rotella di un ingranaggio molto più vasto che voleva cacciare
Berlusconi dal Parlamento a tutti i costi". Gasparri ricorre al Manzoni: "E' il
piccolo untorello .... non sarà lui che spianta Milano". Quasi in contemporanea,
con l'annuncio della sua decadenza da senatore, Silvio Berlusconi in Via del
Plebiscito arringa la folla e annuncia dopo la "giornata di lutto per la
democrazia", già il "primo appuntamento elettorale: l'8 dicembre riunione dei
club di Fi di tutt'Italia", lo stesso giorno delle primarie del Pd. Rompe di
fatto la tregua con Angelino Alfano. La folla urla: "Traditori" E il Cav:
"Parole ruvide ma efficaci". Alfano in serata dirà: "Giornata nera per la
democrazia". Ma "noi andremo avanti con il governo, in un rapporto di
collaborazione-conflittualità", spiega a Panorama.it l'ex governatore lombardo e
ora pezzo da novanta di Ndc, Roberto Formigoni. Che annuncia una formula di
craxiana memoria e cioè "la collaborazione-competizione" del Psi con la Dc, in
questo caso nelle parti del Pd. Sono le 17,40 quando Grasso annuncia con tono
routinario, quasi fosse una pratica burocratica, la "non convalida
dell'elezione a senatore di Silvio Berlusconi in Molise". Grasso ad un certo
punto nel rush sembra ricorrere anche una celebre frase di Nanni Moretti. "E
continuiamo così, continuiamo cosi...". Moretti concludeva "a farci del male".
Ma quel "continuiamo così" non riguardava la mancata conoscenza della torta
sacher. Era "la violazione del regolamento del Senato". Denunciato da Forza
Italia con una valanga di ordini del giorno, ben nove, presentati da Fi
(Elisabetta Alberti Casellati, ne ha presentati la maggioranza e a seguire
Francesco Nitto Palma, Anna Maria Bernini e lo stato maggiore dei senatori
azzurri. Si è invano chiesto il rispetto del regolamento del Senato tornando al
voto segreto. Così come è previsto nelle votazioni che riguardano una singola
persona. Grasso ha risposto picche anche a Pier Ferdinando Casini e al
socialista Enrico Buemi, che hanno tentato di far passare la proposta di buon
senso di aspettare almeno la decisione della Cassazione sulla richiesta di
interdizione per Berlusconi da parte della Corte d'Appello di Milano. Niente da
fare. Alla fine è stato Sandro Bondi ad avvertire tutti "gli amici di Fi" e i
garantisti in generale a fermarsi: "Basta, inutile andare avanti, questa è una
decisione già scritta. Lasciateli fare, lasciateli di fronte alle loro
responsabilità". Poi stilettata ad Alfano: "E ora il Nuovo centrodestra che
governi insieme con questi signori". E' l'inizio di un'opposizione durissima. E
con numeri per la maggioranza meno robusti di quanto Enrico Letta abbia vantato.
Sulla stabiliità c'è stato uno scarto di 36 voti. 171 sono stati quelli della
maggioranza, 135 quelli dell'opposizione. Ma questo perché in realtà una decina
di forzisti non si sarebbero presentati. Roberto Calderoli, vicepresidente del
Senato, che di numeri si intende, a Panorama.it conferma: "Almeno sei non
c'erano e ho visto anche qualche senatore a vita, mai visto di giorno,
figuriamoci a quell'ora di notte". Era presente ieri per la prima volta Renzo
Piano, incorrendo negli strali di Gasparri. Il leader dei lealisti di Fi
Raffaele Fitto avverte: "E' incredibile che Letta faccia finta di nulla".
Decadenza Berlusconi. Le reazioni della stampa estera.
Dalla Spagna al Brasile, passando per Francia, Usa, Germania, Gran Bretagna,
Turchia e Qatar. Le prime pagine dei media mondiali aprono sul Cavaliere e in
molti credono che non sia finita qui, scrive Anna Mazzone su “Panorama”.
La decadenza di Silvio Berlusconi e la sua uscita dai palazzi ufficiali della
politica è un vero e proprio caso internazionale. Praticamente tutti i media del
pianeta pubblicano la notizia o corposi dossier sul Cavaliere sulle loro pagine
online. Mancano all'appello solo i russi e gli asiatici, ma solo per questione
di fuso orario. In Germania la Frankfurter Allgemeine titola
subito dopo la grande coalizione tedesca su "Berlusconi espulso dal Senato".
Sottolineando che con la decisione di un ramo del Parlamento italiano l'ex
premier perde la sua carica politica più importante. "Fino a poco tempo fa -
scrive la FAZ - Berlusconi e il suo partito avevano tentato di tutto per
scongiurare l'espulsione dal Senato. I sostenitori di Berlusconi hanno
dimostrato a Roma denunciando un golpe e la fine della democrazia". Lo stesso
Berlusconi ha nuovamente gridato la sua innocenza davanti ai suoi seguaci,
definendo quello di oggi "Un giorno amaro e un giorno di lutto per la
democrazia". Die Welt mette prima Berlusconi di Angela
Merkel nella priorità delle notizie e sottolinea che "L'ex premier italiano non
reagisce in modo morbido all'espulsione dal Senato e annuncia un'opposizione
serrata", e cita un duro attacco di Berlusconi alla sinistra italiana: "Oggi
sono contenti perché hanno messo i loro avversari davanti al plotone di
esecuzione. Sono euforici, perché aspettavano questo momento da 20 anni". Il
quotidiano tedesco conclude con la frase del Cavaliere sulla scia delle parole
dell'inno di Mameli: "Le parole ci Mameli le prendiamo come un dovere, siamo
pronti a morire ..". Per Die Welt l'espulsione di Berlusconi dal
Parlamento è un momento storico, che segna la fine della Seconda Repubblica
italiana. Lo Spiegel non regala a Berlusconi la sua
apertura online, ma mette la sua decadenza comunque in prima pagina. Nel
sottolineare che l'ex premier non ha alcuna intenzione di arrendersi, il
giornale tedesco pubblica un video che mostra i sostenitori di berlusconi
assiepati fuori palazzo Grazioli a poche ore dal voto del Senato, in cui molti
giovano dichiarano alle telecamere tedesche che "Loro devono decadere e non
Silvio". Lo Spiegel poi affianca Berlusconi a Beppe Grillo, che guida il M5S
pur stando fuori dal Parlamento, ma - comunque - scrive il quotidiano teutonico
"Per il Cavaliere, in politica dal 1994, restare sulla cresta dell'onda da
oggi in poi sarà molto difficile". E passiamo alla Gran Bretagna. Al momento
in cui scriviamo la rivista finanziaria The Economist - che già
aveva dedicato in passato copertine al vetriolo contro Berlusconi - non ha
ancora pubblicato il suo commento sull'avvenuta decadenza. L'ultimo articolo
dedicato alle cose della politica italiana risale al 21 novembre scorso a parla
di "Una opportunità d'oro" per la politica italiana, dopo la decisione di
un gruppo di ex fedelissimi di Berlusconi di passare dall'altra parte. "La
divisione del partito di Berlusconi potrebbe rilanciare la coalizione di
governo", scommette The Economist. Il Guardian apre la sua
edizione online con la decadenza del Cavaliere e pubblica un ricco dossier
sull'ex premier italiano, a cominciare da una dettagliata timeline dal titolo
Ups and downs of Berlusconi's career - Alti e bassi della carriera di
Berlusconi. Il quotidiano britannico, sempre molto duro nei confronti dell'ex
presidente del Consiglio, sottolinea che "Con il loro leader sbattuto fuori
dal Senato adesso i parlamentari di Forza Italia si cimenteranno in
un'opposizione serrata e metteranno in pericolo le riforme istituzionali che il
governo di Letta afferma di voler portare a termine". Immancabile la prima
pagina del Financial Times che pubblica una foto scattata
a Roma con un sostenitore di Berlusconi che agita un manifesto con il Cavlaiere
sotto il simbolo delle Brigate Rosse e la scritta: "Prigioniero politico".
Mentre il quotidiano conservatore di Londra, The Telegraph
scrive nella sua apertura online: "Silvio Berlusconi, l'uomo che ha dato un
nuovo significato alla parola 'faccia tosta', con aria di sfida ha promesso di
rimanere al centro della politica italiana di ieri, nonostante sia stato
ignominiosamente spogliato del suo seggio in parlamento a seguito di una
condanna per massiccia frode fiscale". La versione in inglese di Al
Jazeera , l'emittente del Qatar, mette Berlusconi nelle sue notizie di
apertura, sottolineando che "L'ex primo ministro italiano è stato cacciato dal
Senato in seguito alla sua condanna per frode fiscale". Ma - aggiunge Al Jazeera
- "In molti credono che il 77enne possa risorgere ancora". Andiamo ora
dall'altra parte dell'oceano. Berlusconi campeggia sulle homepage delle
principali testate statunitensi. Sul Wall Street Journal la
sua decadenza è la notizia di apertura. Il quotidiano della City americana
titola sul "Voto per espellere il politico miliardario condannato per frode
fiscale". La testata finanziaria sottolinea che la decadenza di Berlusconi "Ha
segnato il culmine di quasi quattro mesi di furore politico che ha avuto inizio
in agosto con la condanna per frode fiscale dell'uomo che ha dominato la vita
politica italiana per due decenni". In più il WSJ pubblica la storia di
Berlusconi e una sua gallery di foto. Il New York Times dà a
Berlusconi la sua prestigiosa colonna di sinistra in homepage. L'articolo è
firmato da Jim Yardley, che scrive che "L'ex primo ministro, un tempo molto
potente, è stato allontanato dal Senato". Yardley prosegue dicendo che "Dopo
aver speso mesi fabbricando ad arte ritardi procedurali o congiurando melodrammi
politici con il fine di salvarsi, Silvio Berlusconi oggi ha dovuto accettare
l'inevitabile: essere espulso dal Senato, un'espulsione tragica ed umiliante,
mentre altri potenziali problemi si profilano al suo orizzonte". Il
Washington Post preferisce invece aprire sulla politica interna
americana e poi passare solo in seconda battuta al caso della decadenza del
Cavaliere. E sulla "resistenza" di Berlusconi il giornale di Washington è
possibilista: "Anche se Berlusconi non avrà più un seggio in Parlamento -
scrive il giornalista - in molti si aspettano che resti comunque influente
nella politica italiana". Grancassa decadenza sul quotidiano spagnolo
El Pais, che dedica un'apertura a 8 colonne a Berlusconi e un corposo
dossier che ricorda - passo dopo passo - tutta la storia del Cavaliere, dalla
sua discesa in campo all'espulsione dal Senato. Corredano il dossier due gallery
di immagini. L'incipit dell'articolo principale del quotidiano progressista
spagnolo ha toni molto ironici: "Dicono che (Berlusconi) non dorma da molti
giorni, che alterna momenti di depressione profonda con altri di un'euforia
spropositata che lo porta a esclamare: "Giuro che tornerò a Palazzo Chigi [la
sede del Governo]. Il sempre teatrale Silvio Berlusconi sta perdendo la bussola.
E, a pensarci bene, questa non è una sorpresa". Meno ironico e più ottimista per
le sorti del Cavaliere il quotidiano El Mundo , di area
conservatrice. In un editoriale a firma di Miguel Cabanillas che commenta la
notizia sulla decadenza pubblicata in apertura dell'edizione online, si
definisce Berlusconi "Un'araba fenice con molti epitaffi politici sulle
spalle". Un politico sempre pronto a sorprendere e a rinascere. "Come
un'araba fenice che rinasce dalle sue cenerei quando tutti lo danno per
politicamente morto, il magnate italiano - scrive Cabanillas - non rinuncia al
pedigree della sua vita che, nelle ultime due decadi, lo ha trasformato in uno
dei leader più popolari nel mondo, idolatrato da una parte e odiato dall'altra".
Infine, El Pais riporta le parole dell'ex premier italiano che oggi ha
dichiarato: "La battaglia non è ancora finita". Fuoco di fila contro
Berlusconi sui quotidiani francesi. Le Monde titola in
apertura: "L'Italia senza Berlusconi" e pubblica un corposo dossier che include
"I suoi 20 anni di processi" e un articolo sui "Fedelissimi che lo hanno
abbandonato passando all'opposizione". Liberation pubblica la
notizia tra le prime ma non in apertura e sottolinea il j'accuse di
Berlusconi che si dice "vittima di una persecuzione" politica e giudiziaria.
Per Le Figaro (quotidiano conservatore) "Questo è l'ultimo atto
di una discesa agli Inferi cominciata a novembre de 2011", quando Silvio
Berlusconi fu "Attaccato dai mercati, umiliato al G20 di Cannes e congedato dal
presidente Giorgio Napolitano che lo ha rimpiazzato al governo con l'economista
Mario Monti. Apertura anche per O Globo , primo quotidiano
brasiliano, che senza mezzi termini titola: "Il Senato italiano fa fuori
Berlusconi" e poi pubblica un dossier che inizia con un articolo di commento
che recita: "Berlusconi, la fine è arrivata", con fotografie di
manifestanti anti-Cavaliere fuori dal Senato in attesa dell'esito della
votazione. O Globo cita anche un twit di Beppe Grillo, che festeggia
"cinguettando" la decadenza scrivendo: "Berlusconi è stato licenziato dal
Senato. Uno di loro è fuori. Ora dobbiamo mandare a casa anche tutti gli altri".
Infine, prima pagina per Berlusconi anche sui principali media turchi.
Hurriyet scrive che "La decisione del Senato potrebbe essere uno
spartiacque nella carriera del leader che ha dominato la politica italiana per
due decenni". Il quotidiano di Ankara così commenta: "Il voto, che arriva dopo
mesi di scontri politici, apre una fase incerta nella politica italiana, con il
77enne miliardario che si prepara a usare tutte le sue enormi risorse per
attaccare la coalizione di Governo guidata dal premier Enrico Letta".
Urss, Kissinger, massoneria Ecco i misteri di Napolitano.
Da dirigente Pci intrattenne rapporti riservati con Unione sovietica e Usa, dove
andò durante il sequestro Moro. E da allora la "fratellanza" mondiale lo tratta
con riguardo scrive Paolo Bracalini
su “Il Giornale”. «Il presidente Napolitano è stato sempre garante dei
poteri forti a livello nazionale e degli equilibri internazionali sull'asse
inclinato dal peso degli Stati Uniti» scrivono i giornalisti di inchiesta
Ferruccio Pinotti (del Corriere della sera) e Stefano Santachiara (Il Fatto) in
"I panni sporchi della sinistra" (ed. Il presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano Chiarelettere). Il primo ritratto, di 60 pagine, è dedicato proprio
al presidente della Repubblica («I segreti di Napolitano»), «l'ex ministro degli
esteri del Pci» come lo definì Bettino Craxi interrogato dal pm Di Pietro nel
processo Enimont. I rapporti con Mosca, quelli controversi con Berlusconi (il
mensile della corrente migliorista del Pci, Il Moderno, finanziato da Fininvest,
ma anche dai costruttori Ligresti e Gavio), e le relazioni oltreoceano, con
Washington. Una storia complessa, dalla diffidenza iniziale del Dipartimento di
Stato Usa e dell'intelligence americana («nel 1975 a Napolitano gli fu negato il
visto, come avveniva per tutti i dirigenti comunisti»), alle aperture
dell'ambasciata Usa a Roma, al «misterioso viaggio» di Napolitano negli Stati
uniti nel '78, nei giorni del sequestro Moro, l'altro viaggio insieme a Occhetto
nel 1989, fino «all'incontro festoso, molti anni dopo, nel 2001, a Cernobbio,
con Henry Kissinger, ex braccio destro di Nixon, che lo saluta calorosamente: My
favourite communist, il mio comunista preferito. Ma Napolitano lo corregge
ridendo: Il mio ex comunista preferito!». Il credito di Napolitano presso il
mondo anglosassone si dipana nel libro-inchiesta anche su un fronte diverso, che
Pinotti segue da anni, la massoneria, e che si intreccia con la storia più
recente, in particolare con le dimissioni forzate di Berlusconi nel 2011, a
colpi di spread e pressioni delle diplomazie internazionali. Su questo terreno
gli autori fanno parlare diverse fonti, tra cui una, di cui non rivela il nome
ma l'identikit: «Avvocato di altissimo livello, cassazionista, consulente delle
più alte cariche istituzionali, massone con solidissimi agganci internazionali
in Israele e negli Stati Uniti, figlio di un dirigente del Pci, massone, e lui
stesso molto vicino al Pd». Il quale racconta: «Già il padre di Giorgio
Napolitano è stato un importante massone, una delle figure più in vista della
massoneria partenopea» (proprio nei giorni successivi all'uscita del libro
sarebbe spuntata, dagli archivi di un'associazione massonica di primo piano, la
tessera numerata del padre di Napolitano). Tutta la storia familiare di
Napolitano è riconducibile all'esperienza massonica partenopea, che ha radici
antiche e si inquadra nell'alveo di quella francese...». Avvocato liberale,
poeta e saggista, Giovanni Napolitano avrebbe trasmesso al figlio Giorgio
(legatissimo al padre) non solo l'amore per i codici «ma anche quello per la
fratellanza» si legge. E poi: «Per quanto riguarda l'attuale presidente, negli
ambienti massonici si sussurra da tempo di simpatie della massoneria
internazionale nei confronti dell'unico dirigente comunista che a metà anni
Settanta, all'epoca della Guerra fredda, sia stato invitato negli Stati Uniti a
tenere un ciclo di lectures presso prestigiosi atenei. Napolitano sarebbe stato
iniziato, in tempi lontani, direttamente alla «fratellanza» anglosassone
(inglese o statunitense)». Da lì il passo ad accreditare la tesi, molto battuta
in ambienti complottisti, di un assist guidato a Mario Monti, è breve, e viene
illustrata da un'altra fonte, l'ex Gran maestro Giuliano Di Bernardo («criteri
massonici nella scelta di Mario Monti») e da uno 007 italiano. L'asse di
Berlusconi con Putin - specie sul dossier energia - poco gradito in certi
ambienti, entra in questo quadro (fantapolitica?). Con un giallo finale nelle
pagine del libro, raccontato dalla autorevole fonte (senza nome): Putin avrebbe
dato a Berlusconi delle carte su Napolitano. Se queste carte esistono,
riguardano più i rapporti americani di Napolitano che quelli con i russi».
Materiale per una avvincente spy story su Berlusconi, Napolitano, Monti, Putin,
la Cia, il Bilderberg...
Il Cav fu costretto da Napolitano a dimettersi perché voleva che
l'Italia uscisse dall'euro, scrive
Magdi Cristiano Allam su “Il Giornale”. Alla luce delle recenti
rivelazioni, si conferma che il 12 novembre 2011 Berlusconi fu costretto da
Napolitano a dimettersi da presidente del Consiglio, pur in assenza di un voto
di sfiducia del Parlamento, perché in seno ai vertici dell'Ue aveva ventilato la
possibilità che l'Italia esca dall'euro. Di fatto fu un colpo di Stato ordinato
dai poteri forti in seno all'Unione europea e alla Bce, innanzitutto la Germania
di Angela Merkel, manovrando l'impennata dello spread (il differenziale tra
Btp-Bund) che sfiorò i 600 punti alimentando un clima di terrorismo finanziario,
politico e mediatico, con la connivenza dei poteri finanziari speculativi che
determinarono il crollo delle azioni Mediaset in Borsa, realizzato con un
comportamento autocratico di Napolitano che in quattro giorni ottenne le
dimissioni di Berlusconi, nominò Mario Monti senatore a vita e lo impose a capo
di un governo tecnocratico a cui lo stesso Berlusconi fu costretto a dare
fiducia. Questo complotto contro il governo legittimo di uno Stato sovrano va
ben oltre l'ambito personale. Lorenzo Bini Smaghi, membro del Comitato esecutivo
della Bce dal giugno 2005 al 10 novembre 2011, a pagina 40 del suo recente libro
Morire d'austerità rivela: «Non è un caso che le dimissioni del primo ministro
greco Papandreou siano avvenute pochi giorni dopo il suo annuncio di tenere un
referendum sull'euro e che quelle di Berlusconi siano anch'esse avvenute dopo
che l'ipotesi di uscita dall'euro era stata ventilata in colloqui privati con i
governi degli altri Paesi dell'euro». Hans-Werner Sinn, presidente dell'Istat
tedesco, durante il convegno economico Fuehrungstreffen Wirtschaft 2013
organizzato a Berlino dal quotidiano Sueddeutsche Zeitung, ha rivelato negli
scorsi giorni: «Sappiamo che nell'autunno 2011 Berlusconi ha avviato trattative
per far uscire l'Italia dall'euro». Lo stesso Berlusconi, intervenendo sabato
scorso a un raduno della Giovane Italia, ha rivelato: «Oggi operiamo con una
moneta straniera, che è l'euro»; «Siamo nelle stesse condizioni dell'Argentina
che emetteva titoli in dollari»; «Il Giappone ha un debito pubblico del 243%
rispetto al Pil ma ha sovranità monetaria»; «Le mie posizioni nell'Ue hanno
infastidito la Germania»; «La Germania ordinò alle sue banche di vendere i
titoli italiani per far salire lo spread, provocando l'effetto gregge»; «Nel
giugno 2011 Monti e Passera preparavano già il programma del governo tecnico»;
«Nel 2011 ci fu una volontà precisa di far fuori il nostro governo»; «Al
Quirinale mi dissero che per il bene del Paese avrei dovuto cedere la guida del
governo ai tecnici». Nessuno si illude che la magistratura, ideologicamente
schierata a favore della sinistra, interverrà per sanzionare Napolitano (che è
il presidente del Csm) o per salvaguardare la sovranità nazionale dell'Italia
dalla dittatura dell'Eurocrazia e della finanza globalizzata. Dobbiamo prendere
atto che siamo in guerra. Abbiamo perso del tutto la sovranità monetaria,
all'80% la sovranità legislativa e ci stanno spogliando della sovranità
nazionale. Berlusconi, a 77 anni, limitato sul piano dell'agibilità politica,
può oggi dare un senso alto alla sua missione politica contribuendo con tutto il
suo carisma e le sue risorse al riscatto della nostra sovranità monetaria,
legislativa, giudiziaria e nazionale dalla schiavitù dell'euro, dalla sudditanza
di questa Ue alla Germania, ai banchieri e ai burocrati, dalla partitocrazia
consociativa che ha ucciso la democrazia sostanziale e lo Stato di diritto,
perpetuando uno Stato onerosissimo che impone il più alto livello di tassazione
al mondo che finisce per condannare a morte le imprese. Ma bisogna rompere ogni
indugio schierandosi con imprenditori, famiglie, sindaci e forze dell'ordine,
promuovendo subito la rete di tutti coloro che condividono la missione di
salvare gli italiani e far rinascere l'Italia libera, sovrana e federalista.
Zapatero rivela: il Cav obiettivo di un attacco dei leader europei.
In un libro l'ex premier spagnolo svela i retroscena del G20 di
Cannes nel 2011 e il pressing sull'Italia per accettare i diktat Fmi: "Si
parlava già di Monti", scrive
Riccardo Pelliccetti su “Il Giornale”. Vorremmo dire «clamoroso», ma non è così
perché sapevamo da tempo, e lo abbiamo più volte scritto, che non solo in Italia
ma anche dall'estero arrivavano pesanti pressioni per far fuori Silvio
Berlusconi. L'ultima prova, che conferma la volontà di rovesciare un governo
democraticamente eletto, la rivela l'ex premier spagnolo Luis Zapatero, che nel
libro El dilema (Il dilemma), presentato a Madrid, porta alla luce inediti
retroscena sulla crisi che minacciò di spaccare l'Eurozona. Il 3 e 4 novembre
2011 sono i giorni ad altissima tensione del vertice del G-20 a Cannes, sulla
Costa Azzurra. Tutti gli occhi sono puntati su Italia e Spagna che, dopo la
Grecia, sono diventate l'anello debole per la tenuta dell'euro. Il presidente
americano Barack Obama e la cancelliera tedesca Angela Merkel mettono alle corde
Berlusconi e Zapatero, cercando di imporre all'Italia e alla Spagna gli aiuti
del Fondo monetario internazionale. I due premier resistono, consapevoli che il
salvataggio da parte del Fmi avrebbe significato accettare condizioni capestro e
cedere di fatto la sovranità a Bruxelles, com'era già accaduto con Grecia,
Portogallo e Cipro. Ma la Germania con gli altri Paesi nordici, impauriti dagli
attacchi speculativi dei mercati, considerano il vertice di Cannes decisivo e
vogliono risultati a qualsiasi costo. Le pressioni sono altissime. Zapatero
descrive la cena del 3 novembre, con il tavolo «piccolo e rettangolare per
favorire la vicinanza e un clima di fiducia». Ma l'atmosfera è esplosiva. «Nei
corridoi si parlava di Mario Monti», rivela il premier spagnolo. Già, Monti. Che
solo una settimana dopo sarà nominato senatore a vita da Napolitano e che il 12
novembre diventerà premier al posto di Berlusconi. Il piano era già congegnato,
con il Quirinale pronto a soggiacere ai desiderata dei mercati e di Berlino. La
Merkel domanda a Zapatero se sia disponibile «a chiedere una linea di credito
preventiva di 50 miliardi di euro al Fondo monetario internazionale, mentre
altri 85 sarebbero andati all'Italia. La mia risposta fu diretta e chiara: no»,
scrive l'ex premier spagnolo. Allora i leader presenti concentrano le pressioni
sul governo italiano perché chieda il salvataggio, sperando di arginare così la
crisi dell'euro. «C'era un ambiente estremamente critico verso il governo
italiano», ricorda Zapatero, descrivendo la folle corsa dello spread e
l'impossibilità da parte del nostro Paese di finanziare il debito con tassi che
sfiorano il 6,5 per cento. Insomma, i leader del G-20 sono terrorizzati dai
mercati e temono che il contagio possa estendersi a Paesi europei come la
Francia se non prendono il toro per le corna. Il toro in questo caso è l'Italia.
«Momenti di tensione, seri rimproveri, invocazioni storiche, perfino invettive
sul ruolo degli alleati dopo la seconda guerra mondiale...», caratterizzano il
vertice. «Davanti a questo attacco - racconta l'ex leader socialista spagnolo -
ricordo la strenua difesa, un catenaccio in piena regola» di Berlusconi e del
ministro dell'Economia Giulio Tremonti. «Entrambi allontanano il pallone
dall'area, con gli argomenti più tecnici Tremonti o con le invocazioni più
domestiche di Berlusconi», che sottolinea la capacità di risparmio degli
italiani. «Mi è rimasta impressa una frase che Tremonti ripeteva: conosco modi
migliori di suicidio». Alla fine si raggiunge un compromesso, con Berlusconi che
accetta la supervisione del Fmi ma non il salvataggio. Ma tutto ciò costerà caro
al Cavaliere. «È un fatto - sostiene Zapatero - che da lì a poco ebbe effetti
importantissimi sull'esecutivo italiano, con le dimissioni di Berlusconi, dopo
l'approvazione della Finanziaria con le misure di austerità richieste
dall'Unione europea, e il successivo incarico al nuovo governo tecnico guidato
da Mario Monti».
Un governo, ora sappiamo con certezza, eletto da leader stranieri nei corridoi
di Cannes e non dalla volontà popolare degli italiani. Verrà un giorno in cui
l’Italia troverà il coraggio e l’onestà di rileggere (alcuni, se la coscienza li
soccorrerà, lo faranno non senza vergogna) la storia di questi giorni, prima
ancora di dedicarsi all’analisi del cosiddetto ventennio di Silvio Berlusconi.
Perché è da qui, dai giorni tristi e terribili dell’umiliazione del Diritto, che
bisognerà partire per spiegare come sia stato possibile arrivare al sabbah
giacobino contro il Cavaliere al Senato in barba a regole, buon senso e dignità,
scrive Giorgio Mulè, direttore di “Panorama”, nel suo editoriale. Era cominciato
tutto dopo la sentenza di condanna del 2 agosto emessa (prima anomalia) da una
sezione feriale della Cassazione, presieduta da un magistrato chiacchierone
(seconda anomalia) che non avrebbe dovuto giudicare l’ex premier. Una sentenza
in palese contraddizione con i verdetti di due sezioni «titolari» della Suprema
corte (terza anomalia) che avevano valutato le stesse identiche prove nella
vicenda della compravendita dei diritti televisivi giungendo alla conclusione
opposta, e cioè che l’ex premier era innocente. Ma innocente nel profondo, senza
ombra di dubbio e senza nemmeno una formula dubitativa che, come un sigaro, non
si nega mai a nessuno. Una classe politica prigioniera della sua mediocrità e
ossessionata dalla presenza di Berlusconi non poteva far altro che cogliere
l’occasione. A cominciare da Beppe Grillo e dai suoi accoliti, arrivati in
Parlamento con l’ambizioso programma fondato sull’eliminazione del Cav. Così,
dal 2 agosto, è iniziata una corsa orgiastica e forsennata per liberarsi
dell’odiato Caimano. In prima fila, a battere il tamburo per la caccia grossa,
ci sono stati sempre loro, gli avanguardisti della Repubblica con i cugini del
Fatto quotidiano, la falange editoriale che tiene al guinzaglio la mejo
sinistra e che ha sempre vissuto con il complesso di disfarsi del male assoluto
incarnato nell’uomo di Arcore. Il tutto portato avanti con la solita tecnica
becera delle inchieste da buco della serratura grazie all’ausilio di compiacenti
magistrati (quarta anomalia), della lettura distorta degli atti, del moralismo
ipocrita un tanto al chilo e a senso unico. Una sentina maleodorante spacciata
per giornalismo nobile dove si sorvola se a finire accusato di gravissimi reati
c’è Carlo De Benedetti. Chi poteva fermare questa ordalia non l’ha fatto.
Avrebbe potuto e dovuto farlo Giorgio Napolitano, in virtù dell’alto ed
esclusivo ruolo che gli assegna la Costituzione. Avrebbe dovuto usare la tanto
sbandierata moral suasion (quinta anomalia) per ricondurre alla ragione i
sanculotti del suo ex partito e provare nell’ardua impresa di riuscirci con gli
attuali maggiorenti; a cominciare da Matteo Renzi che scimmiotta Fonzie, si
indigna per una battuta in un cartone animato dei Simpson e non si rende conto
di essere la copia spiccicata (per la profondità delle riflessioni…) del
simpatico Kermit, il leader indiscusso dei pupazzi del Muppet show. E invece dal
Colle sono venute fuori interpretazioni pelose delle procedure e più o meno
pubblici risentimenti per le sacrosante lamentele espresse da un Berlusconi
profondamente deluso. Bisogna prendere atto chiaramente che Napolitano poteva
concedere la grazia al Cavaliere e non solo per la pena principale ma anche per
quella accessoria, cioè l’interdizione dai pubblici uffici, eventualità da lui
espressamente negata nella lunga nota del 13 agosto. Non è vero che per la
concessione del beneficio fosse necessario aver accettato la sentenza o aver
iniziato a espiare la pena (sesta anomalia). È una balla. Il 5 aprile di
quest’anno, il Quirinale comunicava: «Il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, ai sensi dell’articolo 87, comma 11, della Costituzione, ha oggi
concesso la grazia al colonnello Joseph L. Romano III, in relazione alla
condanna alla pena della reclusione (7 anni, ndr) e alle pene accessorie
(interdizione perpetua dai pubblici uffici, ndr) inflitta con sentenza della
Corte d’Appello di Milano del 15 dicembre 2010, divenuta irrevocabile il 19
settembre 2012. La decisione è stata assunta dopo aver acquisito la
documentazione relativa alla domanda avanzata dal difensore avvocato Cesare
Graziano Bulgheroni, le osservazioni contrarie del procuratore generale di
Milano e il parere non ostativo del ministro della Giustizia». Per la cronaca:
il colonnello era fra gli imputati del rapimento e delle successive torture
dell’imam Abu Omar, non si è presentato mai al processo, non ha
mai confessato alcunché, non si è mai pentito del gesto, non ha
chiesto scusa a nessuno, non ha mai scontato un giorno di carcere e
per la giustizia italiana era un latitante al pari del superboss
Matteo Messina Denaro. La grazia giunse dal Colle dopo appena 7 mesi
dalla pronuncia definitiva della Cassazione e con il parere contrario
dei magistrati. C’è ancora qualche anima bella o dannata disposta a
sostenere la tesi che il presidente della Repubblica non poteva
adottare lo stesso metodo nei confronti di Silvio Berlusconi? Chiamiamo
le cose con il loro nome: è mancato il coraggio per concedere la
grazia. Il provvedimento avrebbe aperto una fase nuova nella storia di
questo Paese, sarebbe stato l’atto di non ritorno verso la
pacificazione dopo vent’anni di guerra combattuta nel nome
dell’eliminazione per via giudiziaria del Cavaliere il quale, statene
certi, avrebbe abbandonato la politica attiva. Il capo dello Stato ha
avuto l’opportunità di consegnarsi alla storia e non l’ha fatto. E
solo quando giungerà quel famoso giorno in cui gli avvenimenti di
oggi potranno essere riletti senza veli e senza partigianerie capiremo
se al suo mancato gesto dovremo aggiungere i caratteri poco
commendevoli del cinismo, della pavidità o del calcolo politico. Nel
quadro tenebroso dell’oggi trova un posto nitido Enrico Letta, il
presidente del Consiglio che ha conferito a questo Paese una stabilità
degna di un cimitero, come ha giustamente notato il Wall Street
Journal. Incapace di avviare le riforme oramai improcrastinabili per
l’Italia, Letta non è stato neppure capace di imporre il più
impercettibile distinguo sulla giustizia (settima anomalia) ed è rimasto
avvinghiato al doroteismo stucchevole di una linea che voleva tenere
distinte la vicenda di Berlusconi e le sorti dell’esecutivo quando
anche un bambino ne coglieva l’intimo intreccio. Ma i bambini, si sa,
hanno la vista lunga. E ora tutti sanno, anche quelli dell’asilo, che
l’unico orizzonte di Letta non è quello di varare le riforme,
giustizia compresa, ma quello di mantenere il potere. E infatti eccoci
all’ottava anomalia, Angelino Alfano: ha mollato il Pdl per fondare il
Nuovo centrodestra, che al momento si distingue solo per la
fedeltà interessata al governo. Sarebbe toccato proprio ad Angelino
costringere Napolitano e Letta a guardare la realtà, a spalancare gli
occhi sullo scempio del diritto che si stava consumando, a denunciare
con argomenti solidi e di verità l’inganno di una procedura
interpretata in maniera torbida e manigolda. Come quella della
retroattività della legge Severino sulla decadenza (nona anomalia), che
una pletora di giuristi e politici di buon senso non affini ma
certamente lontani dal mondo berlusconiano voleva affidare al vaglio
della Corte costituzionale per un’interpretazione autentica. Anche per
questo motivo il luogotenente del Cav avrebbe dovuto elevare il caso
B a caso internazionale, avrebbe dovuto sfidare in campo aperto i
satrapi dell’informazione truccata. E invece ha preferito chinarsi sulla
propria poltroncina, talmente affascinato, e impaurito di perderla, da
consumare lo strappo di ogni linea politica e di ogni rapporto umano
con il proprio leader. Napolitano, Letta, Alfano: in questo triangolo
delle Bermude, che si autoalimenta nel nome dello status quo e di un
governo fatto solo di tasse e bugie, c’è finito Silvio Berlusconi. E
la conclusione della storia è stata ovvia: l’hanno inghiottito,
macinato ed espulso senza tanti complimenti. Neppure il colpo di reni
finale hanno sfruttato i tre del triangolo mortale, quello offerto
dalle nuove prove squadernate dall’ex premier per chiedere la revisione
del processo. Un percorso perfettamente legalitario, quello del Cav,
condotto all’interno del perimetro disegnato dal Codice di procedura
penale e che avrebbe dovuto fermare la mannaia dell’espulsione dal
Senato. Per mille motivi, ma soprattutto per una possibile e atroce
beffa: se la Corte d’appello darà ragione al Cavaliere e lo
proscioglierà, lui si troverà già fuori da Palazzo Madama. E nessuno
potrà dirgli: «Prego, ci scusi, si accomodi e riprenda il suo posto».
Con il corollario non secondario che, senza lo scudo da senatore, i
picadores in toga potranno infilzare il Cav e compiere l’ultimo
sfregio: l’arresto (decima anomalia). In questa cornice assai triste
tocca togliersi il cappello di fronte al coraggio di Francesco Boccia,
deputato del Pd di prima fila (almeno fino al 9 dicembre, quando
Matteo «Kermit» si presenterà sul palco della segreteria del partito)
che martedì 26 novembre, dopo aver visto gli elementi esposti da
Berlusconi, ha dichiarato: «Se fosse così mi aspetto una revisione del
processo come per qualsiasi altro cittadino». E ancora: «In un Paese
normale si sarebbe aspettata la delibera della Corte costituzionale
sull’interpretazione della legge Severino». Un Paese normale questo? È
una battutona, ditelo a Matteo «Kermit», che magari se la rivende.
Dovrà fare in fretta, però. Perché adesso inizia un’altra faida, che
lo metterà contro Letta e Napolitano. I tre non possono convivere: i
loro interessi non sono convergenti, i loro orizzonti non
corrispondono. Per questo, già prima dell’8 dicembre, ne vedremo delle
belle. Sarà il seguito della politica da avanspettacolo che ci hanno
rifilato negli ultimi mesi. Successe più o meno la stessa cosa ai
tempi di monsieur de Robespierre e dei giacobini. Fatto fuori il re,
si illusero di avere la Francia in pugno. Manco per niente.
Iniziarono a scannarsi l’un l’altro. Fin quando un giorno
accompagnarono Robespierre, l’Incorruttibile, al patibolo. Gli gridavano
dietro: «Morte al tiranno». Avete capito la storia?
Dopo gli Anni di piombo e le decine di magistrati uccisi dalle Brigate rosse e
dall'eversione di destra e di sinistra la corrente di Md più vicina al Partito
comunista scala le gerarchie della magistratura e impone il suo diktat, come
racconta al Giornale un ex giudice di Md: «Serve una giurisprudenza alternativa
per legittimare la lotta di classe e una nuova pace sociale». Ma serviva una
legittimazione incrociata. Non dallo Stato né dal popolo, ma da quel Pci
diventato Pds in crisi d'identità dopo il crollo del Muro di Berlino.
Tangentopoli nacque grazie a un matrimonio d'interessi e un nemico comune:
Bettino Craxi.
Quell'abbraccio tra Pci e Md che fece scattare Mani pulite.
Magistratura democratica pianificò l'alleanza col Pds sul giustizialismo per
ridare smalto alle toghe e offrire agli eredi del Pci il ruolo di moralizzatore
contro la corruzione in Italia,
scrive Sergio
d'Angelo su
“Il Giornale”. «La piattaforma politico-programmatica elaborata per la nuova
Magistratura democratica poteva convincere ed attirare buona parte dei giovani
magistrati, cresciuti politicamente e culturalmente nel crogiolo sessantottino.
Ma bisognava fornire a Md una base giuridica teorica che potesse essere
accettata dal mondo accademico e da una parte consistente della magistratura.
Ancora una volta fu la genialità di Luigi Ferrajoli a trovare una risposta: «La
giurisprudenza alternativa (...) è diretta ad aprire e legittimare (...) nuovi e
più ampi spazi alle lotte delle masse in vista di nuovi e alternativi assetti di
potere (...). Una formula che configura il giudice come mediatore dei conflitti
in funzione di una pace sociale sempre meglio adeguata alle necessità della
società capitalistica in trasformazione». In qualunque democrazia matura la
prospettiva tracciata da Ferrajoli non avrebbe suscitato altro che una normale
discussione accademica tra addetti ai lavori: ma la verità dirompente era tutta
italiana. Celato da slogan pseudorivoluzionari, il dibattito nel corpo
giudiziario ad opera di Md negli anni '70 e '80 presentava questo tema
fondamentale: a chi spetta assicurare ai cittadini nuovi fondamentali diritti
privati e sociali? Al potere politico (e di quale colore) attraverso
l'emanazione di norme (almeno all'apparenza) generali ed astratte, o all'ordine
giudiziario con la propria giurisprudenza «alternativa»? Un dubbio devastante
cominciò a infiltrarsi tra i magistrati di Md. Se la magistratura (o almeno la
sua parte «democratica») era una componente organica del movimento di classe e
delle lotte proletarie, allora da dove proveniva la legittimazione dei giudici a
«fare giustizia»? Dallo Stato (come era quasi sempre accaduto), che li aveva
assunti previo concorso e li pagava non certo perché sovvertissero l'ordine
sociale? Dal popolo sovrano? Da un partito? Quelli furono anni tragici per
l'Italia. Tutte le migliori energie della magistratura furono indirizzate a
combattere i movimenti eversivi che avevano scelto la lotta armata e la sfida
violenta allo Stato borghese: i giudici «democratici» pagarono un prezzo
elevato, l'ala sinistra della corrente di Md rimase isolata mentre l'ala
filo-Pci di Md mantenne un basso profilo. Dell'onore postumo legato al pesante
prezzo di sangue pagato dai giudici per mano brigatista beneficiarono
indistintamente tutte le correnti dell'ordine giudiziario, compresa Md e la
magistratura utilizzò questo vernissage per rifarsi un look socialmente
accettabile. Solo la frazione di estrema sinistra di Md ne fu tagliata fuori, e
questo determinò - alla lunga - la sua estinzione. Alcuni furono - per così dire
- «epurati»; a molti altri fu garantito un cursus honorum di tutto rispetto, che
fu pagato per molti anni a venire (Europarlamento, Parlamento nazionale, cariche
prestigiose per chi si dimetteva, carriere brillanti e fulminee per altri).
Quelli che non si rassegnarono furono di fatto costretti al silenzio e poi
«suicidati» come Michele Coiro, già procuratore della Repubblica di Roma,
colpito il 22 giugno 1997 da infarto mortale, dopo essere stato allontanato dal
suo ruolo (promoveatur ut amoveatur) dal Csm. L'ala filo Pci/Pds di Md,
vittoriosa all'interno della corrente, non era né poteva diventare un partito,
in quanto parte della burocrazia statale. Cercava comunque alleati per almeno
due ragioni: difendere e rivalutare un patrimonio di elaborazione teorica
passato quasi indenne attraverso il terrorismo di estrema sinistra e la lotta
armata e garantire all'intera «ultracasta» dei magistrati gli stessi privilegi
(economici e di status) acquisiti nel passato, pericolosamente messi in
discussione fin dai primi anni '90. Questo secondo aspetto avrebbe di sicuro
assicurato alla «nuova» Md l'egemonia (se non numerica certo culturale)
sull'intera magistratura associata: l'intesa andava dunque trovata sul terreno
politico, rivitalizzando le parole d'ordine dell'autonomia e indipendenza della
magistratura, rivendicando il controllo di legalità su una certa politica e
proclamando l'inscindibilità tra le funzioni di giudice e pubblico ministero.
Non ci volle molto ad individuare i partiti «nemici» e quelli potenzialmente
interessati ad un'alleanza di reciproca utilità. Alla fine degli anni '80 il Pci
sprofondò in una gravissima crisi di identità per gli eventi che avevano colpito
il regime comunista dell'Urss. Non sarebbe stato sufficiente un cambiamento di
look: era indispensabile un'alleanza di interessi fondata sul giustizialismo,
che esercitava grande fascino tra i cittadini, in quanto forniva loro
l'illusione di una sorta di Nemesi storica contro le classi dirigenti nazionali,
che avevano dato pessima prova di sé sotto tutti i punti di vista. La rivincita
dei buoni contro i cattivi, finalmente, per di più in forme perfettamente legali
e sotto l'egida dei «duri e puri» magistrati, che si limitavano a svolgere il
proprio lavoro «in nome del popolo». Pochi compresero che sotto l'adempimento di
un mero dovere professionale poteva nascondersi un nuovo Torquemada. Il Pci/Pds
uscì quasi indenne dagli attacchi «dimostrativi» (tali alla fine si rivelarono)
della magistratura che furono inseriti nell'enorme calderone noto come Mani
Pulite: d'altronde il «vero» nemico era già perfettamente inquadrato nel mirino:
Bettino Craxi. Chi scrive non è ovviamente in grado di dire come, quando e ad
opera di chi la trattativa si sviluppò: ma essa è nei fatti, ed è dimostrata dal
perfetto incastrarsi (perfino temporale) dei due interessi convergenti.
Naturalmente esistono alleanze che si costituiscono tacitamente, secondo il
principio che «il nemico del mio nemico è mio amico», e non c'è bisogno di
clausole sottoscritte per consacrarle. Quando il pool graziò il Pds e i
giudici diventarono casta. Mani pulite con la regia di Md sfiorò il partito
per dimostrare che avrebbe potuto colpire tutti Il Parlamento si arrese,
rinunciando all'immunità. E così consegnò il Paese ai magistrati - continua
Sergio d'Angelo su “Il
Giornale”. - Per rendersi credibile alla magistratura, il tacito accordo
tra Md e Pds avrebbe dovuto coinvolgere magistrati della più varia estrazione e
provenienza politica e culturale. Nel 1989 era entrato in vigore il nuovo codice
di procedura penale che apriva la strada ad un'attività dell'accusa priva di
qualunque freno, nonostante l'introduzione del Gip (giudice delle indagini
preliminari), in funzione di garanzia dei diritti della difesa. C'è un
significativo documento - intitolato I mestieri del giudice - redatto dalla
sezione milanese di Md a conclusione di un convegno tenutosi a Renate il 12
marzo 1988, in casa del pm Gherardo Colombo. In quel testo l'allora pm di Milano
Riccardo Targetti tracciò una netta distinzione tra «pm dinamico» e «pm
statico», schierandosi naturalmente a favore della prima tipologia, come il
nuovo codice gli consentiva di fare. Che cosa legava tra loro i componenti del
pool Mani pulite? Nulla. Che Gerardo D'Ambrosio (chiamato affettuosamente dai
colleghi zio Jerry) fosse «vicino» al Pci lo si sapeva (lui stesso non ne faceva
mistero), ma non si dichiarò mai militante attivo di Md. Gherardo Colombo era
noto per aver guidato la perquisizione della villa di Licio Gelli da cui saltò
fuori l'elenco degli iscritti alla P2: politicamente militava nella sinistra di
Md, anche se su posizioni moderate. Piercamillo Davigo era notoriamente un
esponente di Magistratura indipendente, la corrente più a destra. Francesco
Greco era legato ai gruppuscoli dell'estrema sinistra romana (lui stesso ne
narrava le vicende per così dire «domestiche»), ma nel pool tenne sempre una
posizione piuttosto defilata. Infine, Di Pietro, una meteora che cominciò ad
acquistare notorietà per il cosiddetto «processo patenti» (che fece piazza
pulita della corruzione nella Motorizzazione civile di Milano) e
l'informatizzazione accelerata dei suoi metodi di indagine, per la quale si
avvalse dell'aiuto di due carabinieri esperti di informatica. Il 28 febbraio
1993, a un anno dall'arresto di Mario Chiesa, cominciano a manifestarsi le prime
avvisaglie di un possibile coinvolgimento del Pds nell'inchiesta Mani pulite con
il conto svizzero di Primo Greganti alias «compagno G» militante del partito,
che sembra frutto di una grossa tangente. Il 6 marzo fu varato il decreto-legge
Conso che depenalizzava il finanziamento illecito ai partiti. Il procuratore
Francesco Saverio Borrelli va in tv a leggere un comunicato: la divisione dei
poteri nel nostro Paese non c'era più. Il presidente Oscar Luigi Scalfaro si
rifiuta di firmare il decreto, affossandolo. Alla fine di settembre il cerchio
sembra stringersi sempre di più intorno al Pds, per tangenti su Malpensa 2000 e
metropolitana milanese: tra smentite del procuratore di Milano Borrelli e timori
di avvisi di garanzia per Occhetto e D'Alema, la Quercia è nel panico. Il 5
ottobre Il Manifesto titola I giudici scagionano il Pds: l'incipit dell'articolo
- a firma Renata Fontanelli - è il seguente: «. La posizione di Marcello
Stefanini, segretario amministrativo della Quercia e parlamentare, verrà
stralciata e Primo Greganti (il «compagno G») verrà ritenuto un volgare
millantatore. Il gip Italo Ghitti (meglio noto tra gli avvocati come «il nano
malefico») impone alla Procura di Milano di indagare per altri quattro mesi poi
il 26 ottobre come titola il Manifesto a pagina 4 titola D'Ambrosio si ritira
dal pool per impedire speculazioni sui suoi rapporti «amicali» con il Pds. Quali
indicazioni si possono trarre da questa vicenda? Il pool dimostrò che la
magistratura sarebbe stata in grado di colpire tutti i partiti, Pds compreso; la
Quercia era ormai un partito senza ideologia e il suo elettorato si stava
fortemente assottigliando (era al 16%): c'era dunque la necessità di trovare un
pensiero politico di ricambio, che poteva venire solo dall'esterno; nessuna
forza politica avrebbe mai potuto modificare l'assetto istituzionale nonché
l'ordinamento giudiziario senza il consenso della magistratura; alla
magistratura fu fatto quindi comprendere che l'unico modo di conservare i propri
privilegi sarebbe stato quello di allearsi con un partito in cerca di ideologia.
Il Psi con Bettino Craxi, Claudio Martelli e Giuliano Amato avevano minacciato o
promesso un drastico ridimensionamento dei poteri e privilegi dell'ordine
giudiziario. Ma la reazione delle toghe fu tanto forte da indurre un Parlamento
letteralmente sotto assedio e atterrito a rinunciare ad uno dei cardini
fondamentali voluto dai costituenti a garanzia della divisione dei poteri:
l'immunità parlamentare. A questo punto il pallino passò al Pds, che non tardò a
giocarselo.
Senza una vera riforma il Paese resterà ostaggio del potere
giudiziario.
I giudici sono scesi in guerra per non rinunciare ai privilegi, guidati dalla
nuova "giustizia di classe" che Md è riuscita a imporre alle toghe. È arrivato
il momento di tirare le somme su quanto è accaduto tra magistratura e politica
negli ultimi venti anni. Magistratura democratica avrebbe dovuto rappresentare
una componente del «movimento di classe» antagonista allo sviluppo capitalistico
della società. L'ala filo-Pci della corrente fu decisamente contraria a questa
scelta così netta, e per molti anni praticò una sorta di «entrismo» (né aderire
né sabotare). La scelta di classe operata dalla sinistra di Md presentava rischi
pesantissimi di isolamento all'interno della magistratura e tra le forze
politiche egemoni nella sinistra, che la lotta armata delle brigate rosse
evidenziò immediatamente nel corso degli anni '80 («né con lo Stato né con le
Br? I brigatisti compagni che sbagliano?»). Alla fine degli Anni di piombo, in
pratica l'ala «rivoluzionaria» della magistratura non esisteva già più, e quella
filo-Pci ebbe campo libero. Il crollo dell'Urss gettò il partito egemone della
sinistra nello sconcerto: il Pci non aveva più un'ideologia, né il cambiamento
di sigla (Pds) poteva rivitalizzarlo. Al contrario, l'ala di Md filo Pci/Pds
aveva costruito una immagine ed una ideologia di sé stessa - pagata anche col
sangue di suoi aderenti di spicco - che poteva essere spesa su qualunque piazza,
ma le mancava un alleato sotto la forma partito. L'interesse di entrambi era
comunque troppo forte perché l'alleanza sfumasse, anche se non mancarono
resistenze e ricatti reciproci: così, il Pci/Pds fu duramente minacciato (ed
anche in piccola parte colpito) durante la stagione di Mani Pulite. Alla fine,
intorno al 1994, l'alleanza andò in porto, e un partito senza ideologia accolse
e fece propria (probabilmente senza salti di gioia) un'ideologia senza partito.
Due ostacoli, tuttavia, si frapponevano tra questa alleanza e la conquista del
potere: uno era il cosiddetto Caf (Craxi, Andreotti, Forlani); l'altro era
interno alla magistratura, formato da tutti quei giudici che da sponde opposte
si opponevano a questa operazione. Il primo ostacolo fu eliminato attraverso
Mani pulite, al secondo si applicarono vari metodi; dal promoveatur ut
amoveatur, ai procedimenti disciplinari, alla elevazione al soglio parlamentare
eccetera. Così la magistratura più restia fu lusingata con l'obiettivo di
mantenere i privilegi e la fetta di potere (anche economico) cui era stata
abituata, al punto di farle accettare impunemente l'accordo che era sotto gli
occhi di tutti. Il compito di questa Md era pressochè esaurito, in quanto il
nemico principale (il Caf ma soprattutto Bettino Craxi) era stato abbattuto.
Quando un nuovo nemico si presentò all'orizzonte, i cani da guardia dell'accordo
(ora la magistratura nel suo complesso) non ci misero molto a tirar fuori zanne
ed artigli, con l'appoggio del loro referente politico. Fantasie, opinioni
personali, dirà qualcuno. Può darsi, ma certo occorre riflettere su tre punti
cruciali dell'inchiesta Mani pulite, che sono - come tanti altri elementi -
caduti nel dimenticatoio della Storia. Come abbiamo detto in precedenza, tra i
membri del pool non c'era assolutamente nessuna identità culturale o «politica»,
e non può non destare perplessità la circostanza che essi furono messi insieme
per compiere un'operazione così complessa e delicata: fu davvero per garantire
il pluralismo e l'equidistanza fra i soggetti coinvolti o, come abbiamo
sostenuto, per raccogliere e compattare tutte le diverse anime della
magistratura? Quando esattamente fu costituito il pool? Al riguardo non abbiamo
nessuna certezza, ma di sicuro esso esisteva già il 17 febbraio 1992, data
dell'arresto di Mario Chiesa: chi, nei palazzi di giustizia milanesi e non solo,
aveva la sfera di cristallo? L'allora console statunitense a Milano Peter Semler
dichiarò di aver ricevuto da Antonio Di Pietro - nel novembre '91 -
indiscrezioni sulle indagini in corso, il quale gli avrebbe anticipato l'arresto
di Mario Chiesa (avvenuto nel febbraio '92) e l'attacco a Craxi e al Caf. In
realtà, la magistratura nell'arco di oltre vent'anni e fino ai giorni nostri ha
difeso sé stessa e il proprio status di supercasta: non già per motivi
ideologico-politici bensì per autotutela da un nemico che appariva
pericolosissimo. La casta, in altri termini, ha fatto e sempre farà quadrato a
propria difesa, a prescindere dall'essere «toghe rosse» o di qualunque altro
colore. L'accanimento contro Silvio Berlusconi riguarda - più che la sua persona
- il ruolo da lui svolto ed il pericolo che ha rappresentato e potrebbe ancora
rappresentare per la burocrazia giudiziaria e per gli eredi del Pci/Pds. Si può
senz'altro convenire che i giudici Nicoletta Gandus (processo Mills), Oscar Magi
(processo Unipol, per rivelazione di segreto istruttorio), Luigi de Ruggero
(condanna in sede civile al risarcimento del danno per il lodo Mondadori in
favore di De Benedetti) abbiano militato nella (ex) frazione di sinistra di Md,
come pure il procuratore Edmondo Bruti Liberati (noto come simpatizzante del
Pci/Pds): si può supporre che a quella corrente appartenga pure la presidente
Alessandra Galli (processo di appello Mediaset). Nel novero dei giudici di
sinistra si potrebbe anche ricomprendere la pm Boccassini: ma gli altri? Chi
potrebbe attribuire in quota Md il giudice Raimondo Mesiano (primo processo con
risarcimento del danno a favore di De Benedetti), il presidente Edoardo D'Avossa
(I° grado del processo Mediaset), la presidente Giulia Turri (processo Ruby), il
pm Fabio De Pasquale, il pm Antonio Sangermano, il presidente di cassazione
Antonio Esposito e tutti gli altri che si sono occupati e si stanno occupando
del «delinquente» Berlusconi? La verità è che la magistratura italiana da tempo
è esplosa in una miriade di monadi fuori da qualunque controllo gerarchico e
territoriale, essendo venuto meno (grazie anche al codice di procedura penale
del 1989) perfino l'ultimo baluardo che le impediva di tracimare; quello della
competenza territoriale, travolto dalla disposizione relativa alle cosiddette
«indagini collegate» (ogni pm può indagare su tutto in tutto il Paese, salvo poi
alla fine trasmettere gli atti alla Procura territorialmente competente).
Ciascun pm è padrone assoluto in casa propria, e nessuno - nemmeno un capo
dell'ufficio men che autorevole - può fermarlo. E la situazione non fa altro che
peggiorare, come è sotto gli occhi di tutti coloro che sono interessati a
vedere. La magistratura italiana - unica nel panorama dei Paesi occidentali
democratici - è preda di un numero indeterminato di «giovani» (e meno giovani,
ma anche meno sprovveduti) magistrati pronti a qualunque evenienza e
autoreferenziali. Focalizzare l'attenzione solo su Magistratura democratica
significa non cogliere appieno i pericoli che le istituzioni nazionali stanno
correndo e correranno negli anni a venire, con o senza la preda Berlusconi.
L'ala «ex»
comunista del Pd - dal canto suo - non può più abbandonare l'ideologia
giustizialista, che ormai resta l'unica via che potrebbe portare quella
forma-partito al potere. Una democrazia occidentale matura non può fare a meno
di riflettere su questi temi, cercando una via di uscita dall'impasse
politico-istituzionale in cui questo Paese si è infilato per la propria
drammatica incoscienza, immaturità ed incapacità di governo: con buona pace di
una ormai inesistente classe politica.» Sergio D'Angelo Ex
giudice di Magistratura democratica.
A riguardo
sentiamo il cronista che fa tremare i pm. "Sinistra ricattata dalle procure".
Dopo 35 anni a seguire i processi nelle aule dei tribunali Frank Cimini è andato
in pensione ma dal suo blog continua a svelare le verità scomode di Milano:
"Magistrati senza controllo", scrive Luca Fazzo su “Il Giornale”. «Antonio
Di Pietro è meno intelligente di me»: nel 1992, quando i cronisti di tutta
Italia scodinzolavano dietro il pm milanese, Frank Cimini fu l'unico cronista
giudiziario a uscire dal coro. Sono passati vent'anni, e Cimini sta per andare
in pensione. Confermi quel giudizio? «Confermo integralmente». Sul motivo
dell'ubriacatura collettiva dei mass media a favore del pm, Cimini ha idee
precise: «C'era un problema reale, la gente non ne poteva più dei politici che
rubavano, e la magistratura ha colto l'occasione per prendere il potere. Di
Pietro si è trovato lì, la sua corporazione lo ha usato. Mani pulite era un
fatto politico, lui era il classico arrampicatore sociale che voleva fare
carriera. Infatti appena potuto si è candidato: non in un partito qualunque, ma
nelle fila dell'unico partito miracolato dalle indagini». Uomo indubbiamente di
sinistra, e anche di ultrasinistra («ma faccio l'intervista al Giornale perché
sennò nessuno mi sta a sentire») Cimini (ex Manifesto, ex Mattino, ex Agcom, ex
Tmnews) resterà nel palazzo di giustizia milanese come redattore del suo blog,
giustiziami.it. E continuerà, dietro l'usbergo dell'enorme barba e
dell'indipendenza, a dire cose per cui chiunque altro verrebbe arrestato. Sulla
sudditanza degli editori verso il pool di Mani Pulite ha idee precise: «Gli
editori in Italia non sono editori puri ma imprenditori che hanno un'altra
attività, e come tali erano sotto scacco del pool: c'è stato un rapporto di do
ut des. Per questo i giornali di tutti gli imprenditori hanno appoggiato Mani
pulite in cambio di farla franca. Infatti poi l'unico su cui si è indagato in
modo approfondito, cioè Berlusconi, è stato indagato in quanto era sceso in
politica, sennò sarebbe stato miracolato anche lui. C'è stato un approfondimento
di indagine, uso un eufemismo, che non ha pari in alcun paese occidentale. Ma
lui dovrebbe fare mea culpa perché anche le sue tv hanno appoggiato la Procura».
Da allora, dice Cimini, nulla è cambiato: nessuno controlla i magistrati. «Il
problema è che la politica è ancora debole, così la magistratura fa quello che
vuole. Il centrosinistra mantiene lo status quo perché spera di usare i pm
contro i suoi avversari politici ma soprattutto perché gran parte del ceto
politico del centrosinistra è ricattato dalle procure. Basta vedere come escono
le cose, Vendola, la Lorenzetti, e come certe notizie spariscono
all'improvviso». Nello strapotere della magistratura quanto conta l'ideologia e
quanto la sete di potere? «L'ideologia non c'entra più niente, quella delle
toghe rosse è una cavolata che Berlusconi dice perché il suo elettorato così
capisce. Ma le toghe rosse non ci sono più, da quando è iniziata Mani pulite il
progetto politico che era di Borrelli e non certo di Di Pietro o del povero
Occhetto è stata la conquista del potere assoluto da parte della magistratura
che ha ottenuto lo stravolgimento dello Stato di diritto con la legge sui
pentiti. Un vulnus da cui la giustizia non si è più ripresa e che ha esteso i
suoi effetti dai processi di mafia a quelli politici. Oggi c'è in galera uno
come Guarischi che avrà le sue colpe, ma lo tengono dentro solo perché vogliono
che faccia il nome di Formigoni». Conoscitore profondo del palazzaccio milanese,
capace di battute irriferibili, Cimini riesce a farsi perdonare dai giudici
anche i suoi giudizi su Caselli («un professionista dell'emergenza») e
soprattutto la diagnosi impietosa di quanto avviene quotidianamente nelle aule:
«Hanno usato il codice come carta igienica, hanno fatto cose da pazzi e
continuano a farle». Chi passa le notizie ai giornali? «Nelle indagini
preliminari c'è uno strapotere della Procura che dà le notizie scientemente per
rafforzare politicamente l'accusa». E i cronisti si lasciano usare? «Se stessimo
a chiederci perché ci passano le notizie, i giornali uscirebbero in bianco».
"Beato chi cerca giustizia perché sarà giustiziato...".
Ex giornalista del "Manifesto" lancia un sito per tenere sotto tiro i
magistrati. "Fui il primo al mondo a venir querelato da Di Pietro e dal pool
Mani pulite", Stefano Lorenzetto su “Il Giornale”. Nonostante le generalità da
boss mafioso italoamericano, peraltro conformi al luogo di nascita (New Haven,
Connecticut), Frank Cimini è riuscito a vivere per 36 anni a piede libero
all'interno del Palazzo di giustizia di Milano, esercitandovi l'arte di cronista
giudiziario. Il prolungato contatto con i magistrati lo ha indotto a coniare una
massima su calco del Discorso della Montagna, il che è sorprendente, trattandosi
di un ateo: «Beato chi ha fiducia nella giustizia perché sarà giustiziato».
Forte di questo convincimento, ha fondato su Internet un seguitissimo blog dal
titolo coerente, Giustiziami.it, in cui la sigla automobilistica del capoluogo
lombardo trasforma il potere del diritto in un imperativo robespierriano.
Nell'avventura ha coinvolto Manuela D'Alessandro, che da otto anni batte il
tribunale per conto dell'agenzia Italia: «Bravissima. Insieme con Jari Pilati,
collega della Rai, la mia più degna erede. Eppure è ancora precaria, l'Agi non
si decide ad assumerla con regolare contratto». Giustiziami.it è cliccatissimo
da quando ha narrato la guerra fra il procuratore generale Edmondo Bruti
Liberati e il pm Alfredo Robledo, meritandosi una menzione speciale del premio
Guido Vergani. Lo scoop più sapido servito di recente riguarda il processo
iniziato il 19 giugno a carico di Selvaggia Lucarelli, la blogger transitata
dalle pagine di Libero a quelle del Fatto Quotidiano, ribattezzato Manette Daily
da Cimini. Una brutta storia che vede alla sbarra anche la giornalista Guia
Soncini e Gianluca Neri, alias Macchianera, curatore dell'omonimo blog, e che
sulla stampa sarebbe passata sotto silenzio se Giustiziami.it non avesse
pubblicato sul Web capi d'imputazione e retroscena. Secondo l'accusa, ci
sarebbero in ballo password violate e accessi abusivi alle caselle di posta
elettronica di Mara Venier, Sandra Bullock, Scarlett Johansson, Federica Fontana
e altre star, per conseguire «un profitto consistente nella vendita di
fotografie e di informazioni o conversazioni personali» o «comunque al fine di
arrecare danno a Elisabetta Canalis». Irrimediabilmente in preda alla sindrome
di Stoccolma, invece di godersi la pensione agguantata dopo un tormentato
percorso professionale, Cimini continua a frequentare il fascistissimo tempio
razionalista in corso di Porta Romana, eretto negli anni Trenta da Marcello
Piacentini, l'architetto prediletto dal Duce. Del primo giorno in cui vi mise
piede, ricorda la parola d'ordine (ancor oggi richiesta in sala stampa a tutti,
uomini e donne indistintamente) coniata da Annibale Carenzo, il decano dei
cronisti di giudiziaria, che ha lavorato una vita per l'Ansa e che a 82 anni
ancora bazzica il tribunale dal lunedì al venerdì: «Come ce l'hai?». La risposta
di rito fu purtroppo usurpata da Umberto Bossi in un comizio pronunciato nel
febbraio 1991 a Pieve Emanuele: «La Lega ce l'ha duro». Ciò consentì allo
sfrontato Cimini di chiedere allo stesso Bossi, reduce da un interrogatorio
sulle tangenti Enimont: «Ma fra lei e Antonio Di Pietro, chi ce l'ha più duro?».
La risposta del segretario leghista, madido di sudore, fu: «Ce l'abbiamo duro
uguale». Ecco, se c'è una benemerenza di cui Frank Cimini va orgoglioso è quella
di essere stato il primo giornalista al mondo a venir querelato dal pubblico
ministero molisano e dall'intero pool di Mani pulite, nelle persone di Francesco
Saverio Borrelli, Gerardo D'Ambrosio, Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo.
«Era il 28 aprile 1993. Avevo scritto che Cesare Romiti non era stato arrestato
perché i manager della Fiat si erano accordati con i magistrati per non finire
in galera. Il pool reagì con causa civile e richiesta di danni: 400 milioni di
lire. Vinse in primo grado. L'astuto Di Pietro preferì incassare un adeguato
indennizzo dal mio editore. I suoi colleghi persero in appello. Come sia finita
in Cassazione, non lo so».
Come finì dal Connecticut a Milano?
«Mio nonno Francesco andò negli Stati Uniti a estrarre carbone. Nel 1930 mio
padre Luigi emigrò a sua volta da Minori, costiera amalfitana, a New Haven, per
fare il parrucchiere. Nel 1952 tornò al paesello e conobbe Trofimena. Si
sposarono e partirono per gli Usa, dove l'anno dopo nacqui io. Rimanemmo là fino
al 1959, quando papà rientrò per sempre in patria. Nel 1975, con 70.000 lire in
tasca, salii a Milano perché avevo vinto un concorso nelle Ferrovie».
Qualifica?
«Manovale. Ma, più che per i treni, stravedevo per i giornali. Ero sempre nella
redazione del Manifesto, in via Valtellina. Alla fine il povero Walter Tobagi,
che era mio amico, mi suggerì di fare causa. Vinsi e fui liquidato con 400.000
lire al mese per due anni».
Stipendiato per non lavorare.
«Militando nella sinistra extraparlamentare, cominciai a occuparmi di carceri.
Entrai in Soccorso rosso. Dirigevo Controinformazione. Dopo l'arresto del
responsabile Emilio Vesce, prestai anche la firma ad Autonomia, la testata del
gruppo padovano di Toni Negri».
Ma nei giornali veri come ci arrivò?
«Con una sostituzione estiva di due mesi al Gazzettino di Venezia, diretto dal
democristiano Gianni Crovato. E poi con un contratto come corrispondente da
Milano per l'Aga, l'agenzia di stampa legata a Confindustria».
Bella serpe in seno, si sono allevati.
«Scopro la giudiziaria grazie a Marco Borsa, che mi assume nel neonato Italia
Oggi. Primo scoop: un paginone dedicato a ex militanti di Lotta continua che
aprivano locali sui Navigli, tipo Le Scimmie, pagando in nero i dipendenti.
Pasquale Nonno nel 1987 mi assume al Mattino di Napoli, dove rimango, con base a
Milano, fino al 2012».
Il suo barbone è anarchico o cheguevariano?
«Tutt'e due. Non lo taglio dal 1986».
Come manovale prestato al giornalismo che studi ha avuto?
«Ho abbandonato il liceo scientifico in quarta. Per iscrivermi all'albo ho
dovuto sostenere l'esame di cultura generale. E dire che Di Pietro è meno
intelligente di me. Stiamo parlando di un arrampicatore sociale che s'è trovato
al posto giusto nel momento giusto. Ambiva a far carriera ed è stato usato dalla
sua corporazione per accontentare le masse, vogliose di vedere in prigione i
politici ladri. La magistratura ne ha approfittato per prendersi il potere.
Dopodiché, Di Pietro si è candidato guardacaso nell'unico partito uscito indenne
dalle sue indagini. I magistrati non sono meglio dei politici. Anzi, la mia
personale opinione, dopo averli visti all'opera, è che siano molto peggio».
Se ho ben capito, secondo lei certa magistratura non sarebbe
faziosa per pregiudizio politico bensì per avidità di potere.
«Esatto. Non c'entrano né le toghe rosse né l'ideologia. I magistrati puntano
solo ad avere un potere superiore a quello dei parlamentari. Per conquistarlo,
hanno ottenuto lo stravolgimento dello stato di diritto con la legge sui
pentiti, una vergogna che ha esteso i suoi effetti perversi dai processi di
mafia a quelli politici. Persino Alfredo Rocco, guardasigilli del governo
Mussolini e autore del codice penale tuttora vigente, era contrario alle leggi
premiali perché sosteneva che non bisogna favorire la delazione nemmeno fra
scellerati. Che poi 'sti pentiti sono furbissimi. Leggono i giornali, guardano
la tv, capiscono al volo ciò di cui i magistrati hanno bisogno e gli scodellano
su un piatto d'argento che dietro le stragi c'erano Silvio Berlusconi e Marcello
Dell'Utri».
Ha seguito tutte le traversie giudiziarie del Cavaliere?
«Fin dai tempi della contesa con Carlo De Benedetti per la Mondadori. Avevo
chiesto che fosse affidato in prova ai servizi sociali presso il nostro sito.
Almeno in sala stampa ci saremmo divertiti a parlare di figa. Ma lui ha
preferito andare dai vecchietti».
Dovrebbe moderare il linguaggio.
«È lo stesso invito che mi rivolse Bruti Liberati, sorridendo, in giorno in cui
gli dissi che stava processando Berlusconi per un pelo di quella cosa lì».
Ha un buon rapporto con il procuratore capo di Milano?
«Lo conosco da quando simpatizzava per Il Manifesto. Però non mi ha invitato
alla festa di compleanno nel giardino di casa sua, dove c'era solo la metà dei
Pm, e senza coniugi, perché tutti non ci stavano. Si è bevuto benissimo, mi
dicono».
Giustiziami.it descrive il Palazzo di giustizia come un lupanare.
«Racconto ciò che ho visto. Come in tutti i luoghi di sofferenza, in tribunale
si tromba. Anche negli ospedali, sa?».
So, so.
«C'era un collega che tutti i pomeriggi fornicava nella cabina di regia della
postazione Rai in sala stampa. E quante chiavate in camera di consiglio, dove il
giudice presidente, il giudice a latere e i sei giurati popolari hanno a
disposizione le brande per quei processi in cui la sentenza va per le lunghe».
Non starà romanzando?
«Potrei farle i nomi di un presidente che copulò in camera di consiglio con la
sua giudice a latere, ma a che servirebbe? Mica li può pubblicare. È accaduto
anche fra due giudici, uomo e donna, in un processo di primo grado a Berlusconi.
Non lo dica all'interessato».
E lei?
«Ho sempre resistito alle tentazioni, a cominciare da quella per una Pm dai
capelli ramati che anni fa, in Sardegna, ebbi la fortuna di vedere in bikini.
Proprio una bella topa».
Qui finisce con una querela.
«Se usa l'imperfetto, scrivendo che “era” una bella topa, può giurarci».
Una pagina del sito s'intitola Camera di coniglio anziché di
consiglio.
«Ci piace lo sberleffo. Ma i contenuti sono seri. Siamo stati gli unici a
scrivere che la Procura ha applicato una moratoria sull'Expo, con tanti saluti
all'esercizio obbligatorio dell'azione penale. Eppure si tratta di un'inchiesta
ben più rilevante di Mafia capitale. È evidente che, a Expo in corso, i
magistrati hanno preferito astenersi per carità di patria in base a una
valutazione di tipo politico».
Che cosa glielo fa dire?
«Non lo dico io. Se lo dicono fra di loro. Di recente la Procura di Brescia ha
prosciolto Bruti Liberati per aver archiviato l'esposto di un esponente della
Lista Bonino-Pannella, scrivendo che “alcune remore del procuratore appaiono
caratterizzate da valutazioni di natura squisitamente politica”. Più chiaro di
così».
Esiste una categoria che abbia più potere dei magistrati?
«No, neppure l'alta finanza, perché loro sono gli unici che possono sbatterti in
galera e tenertici a vita. Usano i codici come se fossero carta igienica. Colpa
della sinistra, la quale da decenni pensa che il mondo debba cambiarlo la
magistratura. Ma quando mai il diritto ha modellato la società? Tocca alla
politica farlo. Invece la politica è assente. È un gravissimo deficit di
democrazia».
Mi sembra puerile ritenere che le toghe spadroneggino solo in
Italia.
«Infatti la giustizia ha i suoi problemi ovunque. Ma la politicizzazione che
esiste da noi non ha paragoni in Occidente. Con l'aggravante che viene negata.
Negli Stati Uniti i magistrati sono eletti, quindi rispondono al popolo. Ma qui
a chi rendono conto, visto che sono assunti per concorso?».
Rimedi?
«Abolire l'obbligatorietà dell'azione penale e separare le carriere di pubblici
ministeri e giudici. Campa cavallo».
L'avrà pure incontrato un magistrato simpatico, in tanti anni di
lavoro.
«Antonio Bevere. Adesso è in Cassazione. A Milano invitava i cronisti a casa sua
e ci cucinava pizza e pasta».
Che doti deve avere un cronista giudiziario?
«Deve pensare con la propria testa, essere autonomo dai magistrati. Oltre a
separare le carriere di giudici e pubblici ministeri, bisognerebbe separare
quelle di magistrati e giornalisti, che spesso procedono di pari passo. Tant'è
che i processi si celebrano prima sulla stampa che in tribunale».
Comoda la vita del cronista che può attingere ai faldoni della
Procura.
«Basterebbe una riformina semplice semplice: se da una Procura escono carte che
sono a disposizione della sola accusa, il magistrato titolare dell'indagine
subisce un procedimento disciplinare davanti al Csm. E poi si dovrebbe proibire
la pubblicazione dei nomi dei Pm sui giornali. Così cesserebbero le smanie di
protagonismo di certe toghe».
Che cosa consiglia a un giovane agli esordi in questa
professione?
«Di avercelo duro».
Per 62 magistrati di Milano il "caso Bruti" non esiste.
Un folto gruppo di pm smentisce le frizioni in Procura
denunciate da Robledo al Csm. "Il nostro ufficio dilaniato? Solo sui giornali,
basta con chi vuole delegittimarci", scrive Stefano Zurlo su “Il Giornale”.
Adesso la colpa è dei giornali. Pare di leggere la nota redatta da qualche
segreterie di partito e invece siamo dentro il palazzo di giustizia più
blasonato d'Italia. Anche i pm di Milano non trovano di meglio che buttare la
croce addosso alla stampa che da giorni racconta la violentissima contesa in
atto fra il capo dell'ufficio Edmondo Bruti Liberati e il suo aggiunto Alfredo
Robledo. Una guerra senza esclusione di colpi, con documenti, controdocumenti e
audizioni al Csm, in un carosello senza fine di reciproche smentite che lasciano
basiti. Non importa. Una sessantina di pm pensano bene di stilare un documento
che sarebbe andato bene ai tempi della vecchia Dc. Senza prendere posizione per
un partito o per l'altro, i magistrati mettono in fila due concetti: dicono no
ad ogni tentativo di delegittimazione, affermano poi che tutte queste divisioni
sono in realtà il frutto esasperato di una campagna di stampa che distorce la
realtà e strumentalizza anche i dettagli più minuti. Proprio così. «Respingiamo
ogni tentativo di delegittimazione complessiva dell'operato della nostra procura
- affermano i 62 pm che poi proseguono rimandando la palla alla stampa - e non
possiamo non intervenire in ordine alla rappresentazione mediatica non
corrispondente al vero che viene offerta alla pubblica opinione con l'immagine
di una procura dilaniata da contrapposizioni interne». Insomma, se i giornali
non si sono inventati tutta questa storia, poco ci manca. E non importa se lo
scontro abbia raggiunto punte inimmaginabili e si sia scoperto, nell'imbarazzo
generale, che i vertici della procura più titolata d'Italia in questi anni hanno
litigato furiosamente su tutto. Sull'iscrivere o meno Roberto Formigoni nel
registro degli indagati; sui reati da contestare per gli appalti dell'Expo, con
addirittura la surreale vicenda di un doppio pedinamento condotto o forse no,
non si capisce bene, dai due spezzoni antagonisti della procura; e ancora sulla
conduzione dell'indagine relativa a Ruby, ambita da Robledo ma poi assegnata
all'antimafia di Ilda Boccassini. Uno scenario di macerie che solo un anno fa
sarebbe stato liquidato come fantascienza. Ma questa mischia, che mette in crisi
anche i fragili equilibri fra la correnti al Csm, rischia di far pagare alla
magistratura un prezzo altissimo. E così qualcuno corre ai ripari. Ecco dunque
il documento partorito da una delle toghe più autorevoli, Armando Spataro,
magistrato dal curriculum chilometri che proprio ieri ha ricevuto la nomina a
procuratore della repubblica di Torino, al posto di Giancarlo Caselli, ornai in
pensione da alcuni mesi. Spataro ha ottenuto 16 voti, 8 sono andati all'altro
candidato, il procuratore di Novara Francesco Enrico Saluzzo, sostenuto dai
togati di Magistratura indipendente e dai laici del centrodestra. Insomma,
ancora una volta il Csm si è spaccato secondo una frattura in qualche modo
riconducibile alle logiche della politica. E oggi lo scontro Bruti-Robledo vive
al Csm un'altra puntata: la Settima commissione ascolterà il procuratore
aggiunto Alberto Nobili. Oggetto della sua convocazione: chiarire il presunto
«peccato originale», insomma le mosse dei diversi pm che si sono contesi il
fascicolo Ruby, dunque un'indagine esplosiva sul Cavaliere. Ancora una volta,
gli ingranaggi di quella macchina perfetta che era la procura di Milano mostrano
un'altra realtà: dietro il velo dell'obbligatorietà dell'azione penale e di
regole ferree esistevano ed esistono ampi margini di discrezionalità. Una terra
di nessuno in cui si scontrano vecchie ideologie e ambizioni personali.
Da «pool» a pollaio, il triste tramonto della Procura.
I pm di Mani pulite per la gente erano eroi. Oggi, con la guerra tra ilc apo e
il suo vice, il timore è che le toghe si arrestino tra loro, scrive
Vittorio Feltri su “Il Giornale”. I ricordi quando invecchiano si
affastellano e confondono. Ma non tutti. Molti di essi rimangono impressi nella
memoria, magari non con ogni dettaglio, ma nella sostanza sì. Ci fu un lungo
momento, 20 e rotti anni orsono, in cui la Procura di Milano era considerata
come una cattedrale, piena di santi e di madonne. La madonna era Antonio Di
Pietro. I santi erano Borrelli (il capo carismatico), Davigo, Colombo eccetera.
I magistrati, in particolare i rappresentanti della pubblica accusa, furono
protagonisti di una svolta assai apprezzata dal popolo, stanco della Balena
bianca, dei socialisti (ladri per definizione, allora) e di qualsiasi partito
che non fosse tinto di rosso vermiglio. Le toghe avevano buona fama. Chi le
indossava con orgoglio e supponenza era guardato con ammirazione, facendo parte
attivissima di una sorta di esercito di liberazione. I giudici (pensavano in
molti, tra cui io stesso) ci libereranno dai tangentari, dai gaglioffi, dai
mariuoli che hanno trasformato la democrazia italiana in una palestra di
disonesti, pronti ad arricchirsi alle nostre spalle senza badare all'interesse
dei cittadini, sfruttando e mortificando la povera gente oppressa dalle tasse.
Un Di Pietro che, infischiandosene della consueta prudenza attribuita agli
amministratori della giustizia, procedeva lancia in resta contro i magliari
della politica, veniva portato in trionfo. Il suo nome si leggeva sui cavalcavia
delle autostrade: «Tonino salvaci tu». Il contadino togato piaceva da matti. In
lui identificavamo il vendicatore, colui che avrebbe ripulito anche gli angoli
della stalla politica, ormai mefitica, infetta. Le sue prime mosse non erano
gradite ai colleghi della Procura, i quali si dichiaravano stupiti e infastiditi
dal fatto che costui, da anonimo magistrato, fosse diventato in poche settimane
molto popolare, un divo acclamato. Borrelli mi scrisse una lettera all'
Indipendente, che allora dirigevo con spirito garibaldino, un po' folle, nella
quale raccomandava di non esagerare col giustizialismo. Poi successe una cosa
strana ma non troppo. I Pm si resero conto che il dipietrismo era più forte
della tradizionale ponderazione cui erano avvezzi i magistrati e mutarono
registro. Cavalcarono quasi subito il dipietrismo che in precedenza avevano
criticato, consapevoli che esso era foriero di grandi successi e incontrava il
consenso delle masse. Se dapprincipio era il solo Di Pietro ad essere
applaudito, nel giro di poco tempo il cosiddetto pool di Mani pulite salì in
blocco sul palcoscenico, salutato con entusiasmo, e incoraggiato a castigare i
mariuoli. I giornali, inizialmente titubanti e restii ad appoggiare la Procura,
abbandonarono in fretta ogni timidezza e si prestarono a fare da cassa di
risonanza alle inchieste che avevano scoperchiato il malaffare e la corruzione
diffusa. Il pentapartito - maggioranza di governo - fu presto sgominato, ogni
sua componente ridotta al lumicino. In pratica restarono in piedi soltanto l'ex
Pci (cioè il Pds), il Movimento sociale di Gianfranco Fini e la Lega di Umberto
Bossi. Ma queste sono cose note, anche se gli italiani più giovani, o meno
anziani, le ignorano. Quello che è accaduto nel nostro Paese negli ultimi 20
anni ha dell'incredibile. Poiché la famosa discesa in campo di Silvio
Berlusconi, sorprendendo gli addetti ai lavori politici, coincise con la
vittoria di Forza Italia, frenando la corsa al potere della sinistra (sconfitta
alle elezioni del marzo 1994), l'attenzione del pool milanese si concentrò sul
ricco Cavaliere, sospettato di aver brigato - e commesso dei reati - allo scopo
di agguantare il potere. Per un paio di decenni la Procura si è così distinta
nella caccia grossa con questo obbiettivo: se incastriamo l'erede del
Cinghialone torniamo alla regolarità democratica. Come è andata a finire lo
sappiamo e non è il caso di ricostruire le fasi che hanno portato alla condanna
di Berlusconi, base di lancio di Matteo Renzi, succeduto alle meteore Mario
Monti e Enrico Letta. Ciò indispensabilmente premesso, dobbiamo ora registrare
che la parziale caduta del fondatore di Forza Italia ha provocato un altro
crollo: quello della Procura di Milano, che sta vivendo un periodo orrendo,
contrastante con gli anni d'oro inaugurati da Di Pietro e che permisero a
Borrelli di candidarsi - regnante Oscar Luigi Scalfaro - alla guida
dell'esecutivo (senza fortuna). Oggi il pool sembra un pollaio. Nel senso che le
liti interne alla casta dei signori magistrati prevalgono sull'attività dei
medesimi. I media non si occupano più delle mirabili (si fa per dire) indagini
condotte dai Vip togati, saliti alla ribalta negli anni Novanta e successivi,
bensì dei contrasti violenti tra Bruti Liberati - procuratore capo - e Robledo,
suo vice. I due da mesi sono in combattimento e non si è ancora capito perché
cerchino vicendevolmente di farsi fuori. Lo spettacolo che essi mostrano ai
cittadini è desolante. Non sappiamo chi abbia ragione e chi torto, probabilmente
sbagliano entrambi a scannarsi senza requie, suscitando nei cittadini un
sentimento negativo ai confini dello scandalo. Addirittura qualcuno, con perfida
ironia, ha commentato in questo modo la disputa fra gli alti magistrati: avanti
di questo passo, in Procura si arresteranno fra loro, in una gara a chi ne fa
secchi di più. È solo una battuta, ma esprime una preoccupazione non campata in
aria. Il settore giustizia è sotto attacco da alcuni lustri. Per un po' si è
pensato che le polemiche con al centro i giudici fossero strumentali, tese a
delegittimarli per motivi di bassa bottega politica. Poi però si è constatato
che anche negli ambienti tribunalizi (che dovrebbero essere austeri e riservati)
ci si mena come disperati per una poltrona, e allora la reputazione di
lorsignori ne ha sofferto. I sondaggi sulla credibilità dei magistrati sono
crollati rispetto ad altre epoche e dimostrano che la stima di cui essi godevano
quando imperversava Mani pulite si è assottigliata paurosamente ed è prossima ad
esaurirsi. Qui più che una riforma del sistema giudiziario nel suo complesso,
che il legislatore non è stato capace neanche di cominciare ad abbozzare, urge
un drastico richiamo alle toghe di non rendersi ridicole. Già. La giustizia può
far piangere, ma non deve farsi compatire se desidera conservare un minimo di
dignità.
Un altro contro lo strapotere dei magistrati è Sallusti.
Sallusti: “Ho scoperto il pied a terre di Indro”.
Scrive
Davide Brullo su “Il Giornale”.
Alla fine, sono riusciti a farlo ridere. Ospite nel giardino della Villa
Mussolini in Riccione, venerdì sera, davanti a un popolo piuttosto folto (500
persone circa) Alessandro Sallusti ha inaugurato il ciclo “Riccione Incontra”.
Stimolato dalle domande di Edoardo Sylos Labini, il direttore de il Giornale si
è “sbottonato”, svelando i lati più intimi della sua vita. L’ostinato difensore
di un pensiero “altro”, controcorrente e contro le mode imperanti, notoriamente
impassibile, ha domato la folla con inedita abilità retorica. Ridendo. Sallusti
che ride. In pubblico. Un evento mitologico. Ecco alcuni brani, montati come un
film iridescente, del dialogo.
Gli
esordi, ovvero: un direttore già da bambino. «Il primo giornale penso di averlo
disegnato per le vie di Como, a 9 o 10 anni. Faccio il mestiere che ho sempre
sognato di fare, più per fortuna che per merito, questo è davvero un dono di
Dio. Ero un bambino inquieto e insoddisfatto. Per questo ho preso tante di
quelle botte da mio padre…».
Il
passato ingombrante. «Mio nonno è stato un ufficiale dell’esercito, passato alla
Repubblica Sociale, poi fucilato. Questa storia ha sempre gravato sulla mia
famiglia, come un peso insormontabile».
Il
Battaglione San Marco: il militare necessario. «Non sono mai stato uno studente
modello. Ho fatto l’Istituto tecnico e in anni in cui tutti erano ammessi agli
Esami di Stato, mi fermarono. Una vergogna. Immediatamente mi diressi allo
sportello del distretto militare. Mi dissero che se firmavo come volontario per
il Battaglione San Marco avrei potuto partire dopo due settimane. Firmai. Il
militare ha cambiato la mia vita in modo determinante, per questo penso che sia
necessario ripristinare la leva obbligatoria. E quando penso ai nostri marò,
beh, penso che questo Paese ha ormai perso il senso dell’onore».
Con Don
Giussani sulla spider rossa. Considerazioni sulla fede. «Ho cominciato all’Ordine,
che era il giornale più scalcagnato di Como, legato alla Curia, che dopo poco,
in effetti, chiuse. Fui dirottato a Il Sabato, dove ero noto più che
altro perché andavo in redazione con la spider rossa. Così un giorno Don
Giussani viene a far visita alla nostra redazione e mi pretende. “Mi porti a
fare un giro sulla tua spider rossa?”. Certo, dico io. In macchina, però, per
vincere il mio imbarazzo, dico a Giussani che non sono di Comunione e
Liberazione. Lui scoppia a ridere, “ma cosa vuoi che mi importi, io non so
neanche se credo in Dio!”. Giussani era davvero un uomo straordinario. Mi
ritengo un cattolico. Ma non sono un uomo baciato dalla vera fede».
Ersilio
Tonini e l’esistenza di Dio. «Quando diventai caporedattore di Avvenire fui
convocato a Ravenna dall’allora presidente del giornale, il Cardinale Ersilio
Tonini. Di fronte a una minestrina – è sempre stato secco, magrissimo – mi
disse, “il suo è un compito difficile perché dovrà mediare tra centinaia di
Vescovi che la pensano diversamente su tutto. Anche sull’esistenza di Dio”».
1987:
gli anni con Indro Montanelli. «Il Giornale non era un quotidiano, era un
salotto. Assistere alle riunioni di redazione, con Montanelli a fare da regista
sornione, era come andare al cinema gratis. Ricordo che un giorno il direttore,
verso mezzanotte, passò da noi giovani, che parlavamo di donne. Scoccò la
battuta folgorante: “non è che a me non mi tira più, è che non so più quando mi
tira!”».
1994:
il grande scoop. «Quando ero al Corriere della Sera pubblicai la notizia
del premier Berlusconi indagato. Era la prima volta che veniva indagato un
Presidente del Consiglio, giornalisticamente era uno scoop. All’epoca il
direttore era Paolo Mieli. Il giorno dopo successe il finimondo, con
perquisizioni della polizia e interrogatori. Nascosi le carte e i nastri che
denunciavano l’indagine nella borsa di mia moglie. Poco dopo si aprì il caso di
Primo Greganti, tesoriere della sinistra, e Mieli fu costretto a scusarsi in
diretta Rai. La differenza di trattamento tra il caso Berlusconi e il caso
Greganti mi fece capire che per me era ora di lasciare il Corriere: non
sopportavo più il clima opprimente, il fiancheggiamento delle procure. Volevo la
mia libertà».
“Libero” nasce davanti alla salamella. «Conobbi Vittorio Feltri quando ero
direttore de La Provincia. Dopo un incontro pubblico, ci offrirono delle
salamelle. Lì mi disse, su due piedi, “vieni con me a fondare un giornale?”.
Accettai. Cominciò allora una avventura editoriale entusiasmante. Il concetto
giornalistico di Feltri? Eccolo: quando scrivi di una persona dì che è uno
stronzo, quando parli di un Paese dì che è un Paese di merda».
100mila
copie per una Maserati. «All’inizio non avevamo un soldo. Ci fu anche un
imprenditore riminese, Stefano Patacconi, che mise un po’ di soldi dentro Libero,
ma poi si suicidò. Ci aiutarono gli Angelucci, ma il giornale viaggiava intorno
alle 20mila copie. Un giorno, un po’ abbattuto, Feltri mi getta un depliant che
presentava la nuova Maserati. Nacque una sfida. Se fossimo arrivati a 100mila
copie mi avrebbe regalato una Maserati. Le superammo. Ma la Maserati durò poco:
l’ho venduta perché consumava troppo e perché era ridicolo girare in Maserati».
Berlusconi e Renzi: differenze al telefono. «Ho girato per 12 giornali e
svariati editori, beh, nessuno è più liberale di Silvio Berlusconi e di suo
fratello Paolo. Il difetto di Berlusconi è che è troppo buono e rispettoso degli
avversari, altrimenti sarebbe ancora Presidente del Consiglio. Telefona quando
hai un problema, è di una solidarietà infinita. Al contrario, Matteo Renzi
telefona quando è arrabbiato. Un giorno mi ha telefonato incazzato nero,
insultandomi. Diciamo che sono modi diversi di fare politica».
1
dicembre 2012: l’arresto e la vergogna. «Una vicenda pazzesca, che la dice lunga
su questo Paese. La Digos fece irruzione durante una riunione del Giornale,
interrompendola, per procedere all’arresto per diffamazione e omesso soccorso.
In realtà, mi aspettavano all’uscita del Giornale, perciò dormii tre
giorni in redazione, scoprendo, tra l’altro, il pied a terre di
Montanelli… Così, furono costretti a irrompere. Mi scortarono per portarmi a
casa. Pretesi il carcere. Uscii con i poliziotti, che mi portarono in Questura
con l’accusa di evasione. Intervenne perfino il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, per commutare la pena da detentiva in pecuniaria. Mentre mi
riportarono a casa mi telefonò Berlusconi: “senti Alessandro, abbiamo capito la
tua posizione, ma se evadi ancora ti faccio fare il giro del quartiere a calci
nel sedere”».
Juventino represso. «Sono della Juventus, lo ammetto. Un giorno, un po’ per
sfida, andai a San Siro con Berlusconi. Milan-Juventus. Dopo cinque minuti segna
il Milan. Tutti esultano, io mi esprimo con un tiepido applauso. Le televisioni
Sky mi riprendono. Poco dopo sono beccato da un sms di mio figlio, “Infame”».
Amo
Daniela (mica la Santanché). «Amo Daniela e stimo la Santanché, che non amo.
Stare con Daniela è semplice, stare con Santanché è molto complicato».
Un po’
di cronaca: Grecia. «Sono tra quelli che hanno sperato per il “No” al
referendum. Giusto per vedere la Merkel in difficoltà. Ma adesso mi pare che
Tsipras abbia già calato le braghe».
Caso
Berlusconi. «Berlusconi è un uomo di genio. Non è mica caduto per le
“Olgettine”, come vogliono farci credere, ma perché non voleva allinearsi a
Francia e Germania».
Isis. «A forza di non essere noi stessi, siamo noi che abbiamo issato le
bandiere dell’Isis. Sono per le radici cristiane nella Costituzione europea e
per i Crocefissi nelle scuole».
Gay. «Uno Stato non deve tutelare l’amore: altrimenti perché non posso sposarmi
con due donne o con il mio cane? Compito di uno Stato è tutelare l’unione che
produce nuovi cittadini, i figli. Per il resto, è giusto che ogni persona si ami
come desidera. Quando mia nipote mi confessò di essere lesbica le risposi:
“abbiamo qualcosa in comune, ci piace la stessa cosa!”».
"La politica
ha delegato alla magistratura tre grandi questioni politiche, il terrorismo, la
mafia, la corruzione, e alcuni magistrati sono diventati di conseguenza
depositari di responsabilità tipicamente politiche". A dirlo è Luciano
Violante, ex presidente della Camera e esponente del Partito democratico.
Secondo il giurista, inoltre, "la legge Severino testimonia il grado di
debolezza" della politica perché non è "possibile che occorra una legge per
obbligare i partiti a non candidare chi ha compiuto certi reati". "È in atto un
processo di spoliticizzazione della democrazia che oscilla tra tecnocrazia e
demagogia", ha aggiunto, "Ne conseguono ondate moralistiche a gettone tipiche di
un Paese, l’Italia, che ha nello scontro interno permanente la propria cifra
caratterizzante". Colpa anche di Silvio Berlusconi, che "ha reso ancora
più conflittuale la politica italiana", ma anche della sinistra che "lo ha
scioccamente inseguito sul suo terreno accontentandosi della modesta identità
antiberlusconiana". "Ma neanche la Resistenza fu antimussoliniana, si era
antifascisti e tanto bastava", aggiunge. Quanto alle sue parole sulla legge
Severino e la decadenza del Cavaliere, Violante aggiunge: "Ho solo detto
che anche Berlusconi aveva diritto a difendersi. Quando ho potuto spiegarmi alle
assemblee di partito ho ricevuto applausi, ma oggi vale solo lo slogan, il
cabaret. Difficile andare oltre i 140 caratteri di Twitter". E sulle toghe
aggiunge: "Pentiti e intercettazioni hanno sostituito la capacità investigativa.
Con conseguenze enormi. Occorrerebbe indicare le priorità da perseguire a
livello penale, rivedendo l’obbligatorietà dell’azione che è un’ipocrisia
costituzionale resa necessaria dal fatto che i pubblici ministeri sono, e a mio
avviso devono restare, indipendenti dal governo".
Io quelli di
Forza Italia li rispetto, scrive Filippo Facci su “Libero Quotidiano”.
Conoscendoli, singolarmente, li rispetto molto meno: ma nell'insieme potrebbero
anche sembrare appunto dei lealisti, dei coerenti, delle schiene dritte, gente
che ha finalmente trovato una linea del Piave intesa come Berlusconi, come capo,
come leader, come rappresentante di milioni di italiani che non si può
cancellare solo per via giudiziaria: almeno non così. Non con sentenze infarcite
di «convincimenti» e prove che non lo sono. Dunque rispetto quelli di Forza
Italia - anche se in buona parte restano dei cavalier-serventi - perché tentano
di fare quello che nella Prima Repubblica non fu fatto per Bettino Craxi e per
altri leader, consegnati mani e piedi alla magistratura assieme al primato della
politica. Solo che, dettaglio, Forza Italia ha perso: ha perso quella di oggi e
ha perso quella del 1994. E non ha perso ieri, o un mese fa, cioè con
Napolitano, la Consulta, la legge Severino, la Consulta, la Cassazione: ha
colpevolmente perso in vent'anni di fallimento politico sulla giustizia.
Dall’altra c’è qualcuno che ha vinto, anche se elencarne la formazione ora è
complicato: si rischia di passare dal pretenzioso racconto di un’ormai stagliata
«jurecrazia» - fatta di corti che regolano un ordine giuridico globale -
all'ultimo straccione di pm o cronista militante. Resta il dato essenziale:
vent’anni fa la giustizia faceva schifo e oggi fa identicamente schifo,
schiacciata com'è sul potere che la esercita; e fa identicamente schifo, per
colpe anche sue, la giustizia ad personam legiferata da Berlusconi, che in
vent'anni ha solo preso tempo - molto - e alla fine non s'è salvato. Elencare
tutte le forzature palesi o presunte per abbatterlo, magari distinguendole dalle
azioni penali più che legittime, è un lavoro da pazzi o da memorialistica
difensiva: solo la somma delle assoluzioni - mischiate ad amnistie e
prescrizioni - brucerebbe una pagina. Basti l'incipit, cioè il celebre mandato
di comparizione che fu appositamente spedito a Berlusconi il 21 novembre 1994
per essere appreso a un convegno Onu con 140 delegazioni governative e 650
giornalisti: diede la spallata decisiva a un governo a discapito di un
proscioglimento che giungerà molti anni dopo. L’elenco potrebbe proseguire sino
a oggi - intralciato anche da tutte le leggi ad personam che Berlusconi fece per
salvarsi - e infatti è solo oggi che Berlusconi cade, anzi decade. Ciò che è
cambiato, negli ultimi anni, è la determinazione di una parte della magistratura
- unita e univoca come la corrente di sinistra che ne occupa i posti chiave - a
discapito di apparenze che non ha neanche più cercato di salvare. I processi per
frode legati ai diritti televisivi non erano più semplici di altri, anzi, il
contrario: come già raccontato, Berlusconi per le stesse accuse era già stato
prosciolto a Roma e pure a Milano. Ciò che è cambiato, appunto, è la
determinazione dei collegi giudicanti a fronte di quadri probatori tuttavia
paragonabili ai precedenti: ma hanno cambiato marcia. Si poteva intuirlo dai
tempi atipici che si stavano progressivamente dando già al primo grado del
processo Mills, che filò per ben 47 udienze in meno di due anni e fece lavorare
i giudici sino al tardo pomeriggio e nei weekend; le motivazioni della sentenza
furono notificate entro 15 giorni (e non entro i consueti 90) così da permettere
che il ricorso in Cassazione fosse più che mai spedito. Ma è il processo
successivo, quello che ora ha fatto fuori Berlusconi, ad aver segnato un record:
tre gradi di giudizio in un solo anno (alla faccia della Corte Europea che ci
condanna per la lunghezza dei procedimenti) con dettagli anche emblematici, tipo
la solerte attivazione di una sezione feriale della Cassazione che è stata
descritta come se di norma esaminasse tutti i processi indifferibili del Paese:
semplicemente falso, la discrezionalità regna sovrana come su tutto il resto. Il
paradosso sta qui: nel formidabile e inaspettato rispetto di regole teoriche -
quelle che in dieci mesi giudicano un cittadino nei tre gradi - al punto da
trasformare Berlusconi in eccezione assoluta. Poi, a proposito di
discrezionalità, ci sono le sentenze: e qui si entra nel fantastico mondo
dell'insondabile o di un dibattito infinito: quello su che cosa sia
effettivamente una «prova» e che differenza ci sia rispetto a convincimenti e
mere somme di indizi. Il tutto sopraffatti dal dogma che le sentenze si
accettano e basta: anche se è dura, talvolta. Quando uscirono le 208 pagine
della condanna definitiva in Cassazione, in ogni caso, i primi commenti dei
vertici piddini furono di pochi minuti dopo: un caso di lettura analogica. E,
senza scomodare espressioni come «teorema» o «prova logica» o peggio «non poteva
non sapere», le motivazioni della sentenza per frode fiscale appalesavano una
gigantesca e motivata opinione: le «prove logiche» e i «non poteva non sapere»
purtroppo abbondavano e abbondano. «È da ritenersi provato» era la frase più
ricorrente, mentre tesi contrarie denotavano una «assoluta inverosimiglianza».
Su tutto imperava l’attribuzione di una responsabilità oggettiva: «La qualità di
Berlusconi di azionista di maggioranza gli consentiva pacificamente qualsiasi
possibilità di intervento», «era assolutamente ovvio che la gestione dei diritti
fosse di interesse della proprietà», «la consapevolezza poteva essere
ascrivibile solo a chi aveva uno sguardo d’insieme, complessivo, sul complesso
sistema». Il capolavoro resta quello a pagina 184 della sentenza, che riguardava
la riduzione delle liste testimoniali chieste dalla difesa: «Va detto per
inciso», è messo nero su bianco, «che effettivamente il pm non ha fornito alcuna
prova diretta circa eventuali interventi dell’imputato Berlusconi in merito alle
modalità di appostare gli ammortamenti dei bilanci. Ne conseguiva l'assoluta
inutilità di una prova negativa di fatti che la pubblica accusa non aveva
provato in modo diretto». In lingua italiana: l’accusa non ha neppure cercato di
provare che Berlusconi fosse direttamente responsabile, dunque era inutile
ammettere testimoni che provassero il contrario, cioè una sua estraneità. Ma le
sentenze si devono accettare e basta. Quando Berlusconi azzardò un
videomessaggio di reazione, in settembre, Guglielmo Epifani lo definì
«sconcertante», mentre Antonio Di Pietro fece un esposto per vilipendio alla
magistratura e Rosy Bindi parlò di «eversione». Il resto - la galoppata per far
decadere Berlusconi in Senato - è cronaca recente, anzi, di ieri, Il precedente
di Cesare Previti - che al termine del processo Imi-Sir fu dichiarato
«interdetto a vita dai pubblici uffici» - è pure noto: la Camera ne votò la
decadenza ben 14 mesi dopo la sentenza della Cassazione. Allora come oggi, il
centrosinistra era dell’opinione che si dovesse semplicemente prendere atto del
dettato della magistratura, mentre il centrodestra pretendeva invece che si
entrasse nel merito e non ci si limitasse a un ruolo notarile. Poi c’è il
mancato ricorso alla Corte Costituzionale per stabilire se gli effetti della
Legge Severino possano essere retroattivi: la Consulta è stata investita di
infinite incombenza da una ventina d’anni a questa parte - comprese le leggi
elettorali e i vari «lodi» regolarmente bocciati – ma per la Legge Severino il
Partito democratico ha ritenuto che la Corte non dovesse dire la sua. Il 30
ottobre scorso, infine, la Giunta per il regolamento del Senato ha stabilito che
per casi di «non convalida dell’elezione» il voto dovesse essere palese, volontà
ripetuta ieri dal presidente del Senato: nessun voto segreto o di coscienza,
dunque. Poi - ma è un altro articolo, anzi, vent'anni di articoli - ci sono le
mazzate che il centrodestra si è tirato da solo. La Legge Severino, come detto.
Il condono tombale offerto a Berlusconi dal «suo» ministro Tremonti nel 2002 -
che l'avrebbe messo in regola con qualsivoglia frode fiscale – ma che al
Cavaliere non interessò. Il demagogico inasprimento delle pene per la
prostituzione minorile promosso dal «suo» ministro Carfagna nel 2008. Però,
dicevamo, non ci sono solo gli autogol: c’è il semplice non-fatto o non-riuscito
degli ultimi vent’anni. Perché nei fatti c’era, e c’è, la stessa magistratura.
Non c’è la separazione delle carriere, lo sdoppiamento del Csm, le modifiche
dell’obbligatorietà dell’azione penale, l’inappellabilità delle sentenze di
assoluzione, la responsabilità civile dei giudici, i limiti alle
intercettazioni. Ci sono state, invece, le leggi sulle rogatorie, la Cirami, i
vari lodi Maccanico-Schifani-Alfano, l’illegittimo impedimento: pannicelli caldi
inutili o, per un po’, utili praticamente solo a lui. Per un po’. Solo per un
po’. Fino al 27 novembre 2013.
CARMINE
SCHIAVONE. MAGISTRATI: ROMA NOSTRA!
"Ondata
di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici,
Napoli capitale dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto»
un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori".
O la
statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso
di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi
agli orali vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che
rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della
popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza:
erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della
commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli
esaminatori.
DELINQUENTE
A CHI?
“Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Parla l’ex capo dei Casalesi. La
camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno politici, magistrati e
forze dell’ordine mafiosi.
CARMINE
SCHIAVONE. MAGISTRATI: ROMA NOSTRA!
"Ondata
di ricorsi dopo il «trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici,
Napoli capitale dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto»
un terzo degli aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori".
O la
statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale concorso
di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici ammessi
agli orali vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli, che
rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della
popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza:
erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della
commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli
esaminatori.
"Noi
avevamo la nostra idea. Dovevamo formare, per la fine del millennio, i nostri
giovani come degli infiltrati dentro lo Stato: quindi dovevano diventare
magistrati, poliziotti, carabinieri e perché no, anche ministri e presidenti del
Consiglio. Per avere i nostri referenti nelle istituzioni".
"I mafiosi non sono solo i Riina o i Provenzano. I soggetti
collusi con la mafia sono ovunque, sono nelle istituzioni pubbliche, siedono
anche in Parlamento". Così il presidente del Tribunale di Palermo, Leonardo
Guarnotta, al convegno “La mafia non è solo un problema meridionale”,
organizzato a Palermo il 29 novembre 2013 dall'associazione Espressione Libre.
"In mancanza di sanzioni, ma soprattutto in assenza di una autoregolamentazione
deontologica, la responsabilità politica rimarrà impunita, nulla più che un pio
desiderio, con la conseguenza che si è arrivati a candidare e fare eleggere a
Palermo, politici sotto processo per concorso esterno in associazione per
delinquere di tipo mafioso, come Marcello Dell'Utri e Calogero Lo Giudice" ha
detto ancora Guarnotta al convegno. Il riferimento a Dell'Utri e Lo Giudice
arriva nella parte della relazione di Leonardo Guarnotta, quando parla di lotta
alla mafia perché "è indispensabile l'impegno della società civile perché la
partita, cioè la lotta alla mafia, che non possiamo assolutamente permetterci di
perdere, si gioca nella quotidianità", ha detto il presidente del Tribunale di
Palermo. Guarnotta poi ha voluto rimarcare che questa lotta si gioca "nelle
scelte, individuali e collettive, non escluse le scelte elettorali, cioè le
scelte che vengono fatte dai segretari di partito nel selezionare i candidati,
da inserire nelle liste e quelle che operano gli elettori nell'esercizio del
diritto-dovere di designare i loro rappresentanti al Parlamento e nelle
istituzioni".
FIGLI DI
QUALCUNO E FIGLI DI NESSUNO.
L’Italia
dei figli di qualcuno e dei figli di nessuno,
scrive Luigi Sanlorenzo su “Sicilia Informazioni”. Quel termometro, ancora per
poco infrangibile, dell’indignazione degli italiani ha raggiunto in queste ore
un nuovo picco alla notizia dell’intervento del Ministro della Giustizia Anna
Maria Cancellieri in favore della scarcerazione per motivi umanitari di Giulia
Ligresti. Già ora montano polemiche roventi, immaginabili paragoni con vicende
simili, richieste di dimissioni e promesse di giustificazioni che occuperanno i
giornali e le televisioni in interminabili dietrologie, pindariche rievocazioni,
ardite ipotesi. Ma non c’è da preoccuparsi, perché prima o poi, una cortina
fumogena sarà sapientemente fatta posare sui fatti. Proprio per tale ragione,
questo articolo ha la pretesa di soffermarsi su una diversa e più pressante
preoccupazione degli italiani circa il diverso destino dei figli di nessuno e
dei figli di qualcuno. E’ noto come il decantato benessere italiano, i
cosiddetti anni del boom che interessarono gli anni ’50 e ’60, si fondò su due
principali eventi sociali: la politica industriale sorretta dagli ingenti fondi
del Piano Marshall nel centro nord del Paese e l’accesso ai ruoli della Pubblica
Amministrazione – ed alle migliaia di enti collegati – di intere coorti di
giovani del Mezzogiorno mediante centinaia di concorsi che rappresentarono in un
Sud maggiormente scolarizzato, una risposta occupazionale e un inedito e rapido
ascensore sociale. Grazie alla possibilità per milioni di diplomati e decine di
migliaia di laureati di accedere ad un posto stabile e sicuro, anche se non
sempre disponibile nella regione di nascita, la società italiana nel complesso
passò nel volgere di un decennio dai bisogni ai desideri, alimentando consumi
alti e medio alti e inaugurando stili di vita molto vicini a quelli dei Paesi
europei più avanzati, se non, in molti casi, degli Stati Uniti del tempo. Per la
prima volta nella storia, il figlio di un contadino poteva diventare qualcuno,
rompendo così l’atavico destino riservato a chi lo aveva preceduto. Per la prima
volta il neo dottore, diventato funzionario ministeriale, impiegato di una banca
pubblica, medico della mutua o semplicemente, assolto l’obbligo scolastico,
usciere alla Provincia o portantino in un ospedale, poteva a propria volta
sognare un futuro ancora migliore per i figli che, numerosi, – i baby boomers –
sarebbero venuti al mondo. Certo, dopo i primi anni, i concorsi divennero sempre
più politicizzati e all’insegna della raccomandazione ma il “borghese piccolo
piccolo” che alberga in tutti noi sapeva che far studiare un figlio avrebbe
comunque portato prima o poi, alle soglie del fatidico concorso, varcate le
quali altri sogni potevano diventare realtà: una famiglia, un sorriso assicurato
da parte di una banca lieta di offrire un mutuo per la casa, l’autovettura di
dimensioni crescenti in proporzione alla carriera, l’assistenza sanitaria, le
ferie al mare o all’estero, magari, presto, la seconda casa per le vacanze. Con
il crollo rovinoso di quel mondo, che pur in modo imperfetto e non sempre
trasparente, sembrava voler realizzare i migliori auspici della Costituzione
Repubblicana, i giovani italiani si sono trovati come coloro cui un uragano
scoperchia la casa. Cresciuti ed educati nella prima parte della propria vita in
famiglia e a scuola con la certezza delle opportunità garantite ai propri
genitori, scelta una facoltà universitaria più con l’occhio al “concorso” che
alla propria reale vocazione, si sono trovati davanti il vuoto. Mentre essi
precipitavano nel baratro del precariato infinito del corpo e dell’anima,
risuonavano da ogni possibile mezzo di comunicazione le ipocrisie di una classe
dirigente farisaica e compromessa. Era giusto infatti che i ministri dei nuovi
governi mettessero in guardia i giovani dall’illusione del posto fisso e li
spronassero a mettersi in gioco. La doppiezza di tale morale emerge oggi quando
si scopre, sempre più spesso, che proprio i figli di quei ministri avevano tutti
già un posto fisso, grazie sicuramente all’influenza di mamma e papà. Mario
Monti ha un figlio, Giovanni Monti, ora 39enne. Ripercorriamo la sua carriera: a
20 anni è già associato per gli investimenti bancari per la Goldman Sachs, banca
d’affari in cui il padre ha ricoperto il ruolo di International Advisor. A 25
anni diventa consulente di direzione da Bain & company e ci rimane fino al 2001.
Dal 2004 al 2009, ha lavorato a Citigroup e in Morgan & Stanley occupandosi in
particolare di transazioni economico-finanziarie sui mercati di Europa, Medio
Oriente e Africa, alle dipendenze dirette degli uffici centrali di New York. La
figlia di Elsa Fornero – l’indimenticabile, sensibile fino alle lacrime,
Ministro del Lavoro che dopo aver chiamato i giovani “choosy”, ovvero con poco
spirito di adattamento e dopo aver consigliato a tutti di “tornare a lavorare la
terra” tacciò gli italiani di essere “scansafatiche” – Silvia Deaglio, ha soli
24 anni quando ottiene un incarico presso un prestigioso college di Boston e 30
quando inizia ad insegnare medicina. Diventa associata all’università di Torino,
l’università dove mamma e papà hanno la cattedra, a soli 37 anni. Il figlio di
Annamaria Cancellieri per la quale gli italiani devono liberarsi dell’idea del
posto fisso vicino ai genitori, Piergiorgio Peluso, appena laureato, inizia una
carriera sfolgorante: dall’Arthur Andersen a Mediobanca, fino a Aeroporti di
Roma, Credit Suisse, Unicredit e Fondiaria Sai, dove è direttore generale
guadagnando circa 500mila euro all’anno. Il resto sarà cronaca dei prossimi
giorni. Certamente i citati sono tutti giovani preparati e in gamba ma
probabilmente ambiti da multinazionali anche per altre ragioni. Essi comunque
non saranno stati certo delle menti così eccezionali rispetto a migliaia di
altri coetanei preparati e volenterosi che ormai alle soglie dei 40 anni non
avranno mai una famiglia propria, una casa o una pensione. In una democrazia i
figli di “nessuno” come chi scrive, possono salire la scala sociale soltanto se
messi alla prova del merito comparativo e dei meccanismi dei concorsi da
reinventare modernamente nel nostro disperato Paese. Diverso è infatti il
destino dei figli di qualcuno che, nella vita, “qualcuno” diventano comunque,
spesso ben oltre le proprie reali capacità. Con qualche eccezione di chi, per
sensibilità personale o scelta esistenziale, decide di rifiutare i privilegi a
di rischiare una vita normale e di cui essere il vero, spesso drammatico,
protagonista. La mattina del 15 novembre 2000 il corpo senza vita di Edoardo
Agnelli, 46 anni, venne trovato da un pastore cuneese, Luigi Asteggiano, presso
la base del trentacinquesimo pilone del viadotto autostradale Generale “Franco
Romano” della Torino-Savona, nei pressi di Fossano. La sua Croma scura, con il
motore ancora acceso e il bagagliaio socchiuso, era parcheggiata a lato della
carreggiata del viadotto che sovrasta il fiume Stura di Demonte. La magistratura
concluse presto le indagini formulando l’ipotesi del suicidio. Nelle rare
interviste concesse alla stampa, il figlio del più noto Avvocato della storia
italiana, aveva affermato di voler prendere le distanze dai valori del
capitalismo e di volersi dedicare a studi di teologia. Edoardo Agnelli non
nascondeva di simpatizzare per il marxismo-leninismo in chiave mistica e verso
l’Iran sciita; secondo voci non confermate negli ultimi anni aveva cambiato
persino nome, assumendo un nome islamico. Era comparso in pochissime occasioni
pubbliche e in qualche manifestazione religiosa o antinuclearista. I tentativi
di inserirlo in attività collaterali del grande gruppo aziendale di famiglia,
tra cui anche una breve esperienza nel Consiglio d’Amministrazione della
Juventus nel 1986, non avevano dato buon esito. Edoardo era diverso. La fine di
Edoardo Agnelli, contrapposta all’aridità e all’egoismo di una borghesia che si
auto perpetua non attraverso i meriti ma grazie alla fitta trama di relazioni ed
alleanze che vanno ben oltre gli schieramenti ufficiali nella vita politica o
delle cordate imprenditoriali, mi ha sempre ricordato la figura di Hanno
Buddenbrook, la saga della cui famiglia fu il testo pretesto della mia tesi di
laurea, nel lontano 1980. Hanno Buddenbrook è l’ultimo discendente dei
Buddenbrook, fiorente famiglia della borghesia mercantile tedesca, di cui il
romanzo racconta attraverso tre generazioni la progressiva decadenza che segna
la decomposizione di un certo tipo di società. Hanno ne incarna l’epilogo,
attraverso la sua inettitudine, che tanto più poeticamente risalta in quanto
diviene icona di un’intera epoca che tramonta, schiacciata dal peso dei suoi
riti, dei suoi mascheramenti, dei suoi valori opprimenti. Nei giorni scorsi
Rachid Khadiri Abdelmoula, il 27enne marocchino torinese, dopo una vita passata
a vendere accendini e fazzoletti tra Palazzo Nuovo e la Mole di giorno e a
studiare di notte, si è laureato in ingegneria al Politecnico. Il “marocchino”
(così definisce se stesso, scherzando su provenienza e senso dato in Italia al
termine) più famoso d’Italia è tornato oggi a far parlare di sè per una scelta
decisamente controcorrente. Rachid sta infatti resistendo in questi giorni alle
lusinghe della televisione commerciale rispondendo con insistiti “no, grazie”
alle reiterate proposte che arrivano da Endemol per partecipare all’edizione
2014 del Grande Fratello. Tra lo stupore di tutti ha dichiarato: “I miei valori
sono altrove. Non mi riconosco neanche un po’ in una trasmissione che non trovo
seria ed educativa. Cosa ci andrei a fare? A recitare? Il successo è un mondo di
nicchia, lo stringono in pochissimi. Gli altri si illudono, poi rimangono
spiazzati quando la fama svanisce. Ai sogni bisogna obbedire. Il mio è di fare
l’ingegnere con la cravatta. Come mi vedo tra dieci anni? Spero di aver
svoltato. Non in uno studio televisivo, ma in uno di progettisti.” Nel Capitolo
38 dedicato alle cause della decadenza di Roma , l’illuminista Edward Gibbon,
autore de The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776) ha
scritto: “ essa fu conseguenza naturale della sua grandezza. La prosperità portò
a maturazione il principio della decadenza…Invece di chiederci perché fu
distrutto, dovremmo sorprenderci che abbia retto tanto a lungo”. Un monito
estremamente contemporaneo che dovrebbe bastare ad una società come la nostra
che ha smarrito da tempo anche il ricordo delle energie vitali da cui nacque e
che sembra ogni giorno di più di intravedere nelle storie esemplari dei tanti
figli di immigrati che, forse, rifaranno l’Italia.
E che dire
ancora.
Non ci sono anormali, ma normali diversi,
scrive Michele
Marzano su “La Repubblica”. Pochi giorni fa, il Tribunale dei Minori di Roma ha
autorizzato una coppia ad adottare un bambino straniero, a patto però che il
bimbo fosse "perfettamente sano". La decisione è stata subito contestata non
solo dall'Aibi (l'associazione Amici dei bambini) - che intende presentare un
esposto alla Procura generale della Cassazione - ma anche dal Presidente del
Tribunale dei minori, Melita Cavallo, che spera che una cosa del genere "non si
ripeta più". Ma al di là di queste contestazioni più che opportune, che cosa
rivela l'utilizzo di questo tipo di espressioni? Chi di noi può definirsi
"perfettamente sano"? All'epoca del mito della perfezione, sembra scontato ed
evidente poter giudicare le persone e valutarle in base ad una serie di criteri
reputati oggettivi. Come se l'intelligenza, la salute e la bellezza potessero
essere veramente calcolate e misurate. Come se il valore di una persona
dipendesse dalla sua capacità o meno di corrispondere a determinati criteri. E
se tutto ciò fosse solo il retaggio di un determinismo biologico e genetico
ormai desueto? Se il valore di una persona fosse altrove, non solo perché la
perfezione non esiste, ma anche perché, molto spesso, sono proprio coloro che
sembrano "oggettivamente sani" che poi si rivelano "soggettivamente malati"?
Come spiegava bene Georges Canguilhem negli anni Sessanta, la salute non è
un'entità fissa. Anzi, varia a seconda dei contesti e delle persone, e solo chi
soffre può veramente valutare il proprio stato di salute. Ecco perché non esiste
alcuna definizione oggettiva della normalità e dell'anormalità. Tanto più che le
persone sono tutte differenti l'una dall'altra e che, inevitabilmente, ognuno
presenta "un'anomalia" rispetto agli altri. "L'anormale non è ciò che non è
normale", scrive in proposito Canguilhem, "ma è piuttosto un normale
differente". Peccato che, nonostante tutto, la differenza continui ancora oggi
ad essere identificata con l'inferiorità, e che persista un'insopportabile
intolleranza nei confronti delle fragilità umane, al punto da illudersi che la
felicità dipenda dal proprio essere "perfettamente sani". La fragilità, in sé,
non è un problema. Anzi, è proprio nel momento in cui ci fermiamo un istante e
cerchiamo di entrare in contatto con noi stessi, che ci rendiamo poi conto che
questa nostra fragilità può diventare un punto di forza. Perché ci aiuta a
crescere e a cambiare. Perché ci rivela qualcosa di noi che per tanto tempo, a
torto, abbiamo fatto di tutto per ignorare. Soprattutto quando capiamo che
l'essere umano non è una semplice somma di competenze più o meno sviluppate, e
che i successi, come ricorda sempre Georges Canguilhem, sono spesso dei
"fallimenti ritardati". Speriamo che lo capiscano anche i giudici quando
autorizzano o meno una coppia ad adottare. Non solo perché l'essere
"perfettamente sano" è un'espressione priva di senso, ma anche perché l'amore
dei genitori non può certo dipendere dallo stato di salute dei propri figli.
E poi c’è
l’anormalità fatta normalità
con un commento di Susanna Tamaro. «La notizia dei tre miliardi sottratti allo
Stato da parte di 5.000 dipendenti pubblici, che si aggiunge a quella dei finti
poveri, dei falsi ciechi o dei turlupinatori di pensioni che ogni giorno vengono
«scoperti» dalla Guardia di Finanza, non può che turbare - dove «turbare» è un
eufemismo - le tante persone oneste di questo Paese, sempre più perseguitate da
un Fisco che li ritiene gli unici «privilegiati» interlocutori. Non è populismo
affermare che molti dei nostri problemi economici sarebbero in parte risolvibili
con una bella e definitiva pulizia degli sprechi e degli assurdi privilegi che
l’apparato statale permette e concede a tutti coloro che sono riusciti a
infilarsi sotto le sue ali mafiosamente protettive. Com’è possibile, infatti, ci
chiediamo noi contribuenti, che per dieci, venti, trent’anni una persona
percepisca una pensione di invalidità come cieco pur essendo perfettamente
vedente, mentre una nostra qualsiasi minima mancanza, che sia una multa o un
mancato pagamento di un contributo, viene immediatamente sanzionata e punita con
severità? Quanti ciechi ci vogliono per non vedere un finto cieco? Come ci
interroghiamo anche - e purtroppo sappiamo già la risposta - su quanti di questi
5.073 dipendenti dello Stato che hanno rubato, truffato, corrotto avranno come
conseguenza la perdita del loro posto di lavoro. Non sono un’esperta di
amministrazione statale, ma temo che la risposta sia «nessuno». Questi uomini e
donne che hanno tradito il patto di fiducia etico su cui si regge la società,
hanno anche danneggiato i loro colleghi che lavorano con serietà e dedizione.
Quali conseguenze avrà questo tradimento? Forse soltanto una multa o il
trascinarsi in un processo che durerà anni e che finirà in una bolla di sapone.
Il messaggio che ci viene costantemente dato dallo Stato è che in fondo le
nostre azioni non sono influenti, che il comportarsi bene o male non cambia
nulla, se si ha un posto garantito. Il messaggio che quindi passa alle
generazioni future è quello che il merito e l’etica in Italia non hanno alcun
peso, cosa che peraltro viene confermata in ogni ambito della nostra società,
dall’università alla pubblica amministrazione. A volte, quando guardo i politici
immersi nelle loro costanti e sterili polemiche televisive, mi domando: si
rendono veramente conto dello stato di esasperazione della parte sana del nostro
Paese? Credo proprio di no. Se si rendessero conto, infatti, agirebbero di
conseguenza, senza timore dell’impopolarità, sfrondando, pulendo, liberandoci da
tutto ciò che è inutile, offensivo e dannoso. È la mancanza di questa semplice
azione a spingere sempre più italiani verso l’indifferenza, il cinismo, il
disinteresse o tra le braccia dei movimenti che afferrano le viscere e le
torcono, perché è lì che, alla fine, si annida la disperazione degli onesti. È
su questo che riflettevo, andando in bicicletta per le colline umbre, desolata
dallo spettacolo che ormai accompagna ogni mia escursione. Avevo appena superato
la carcassa di un televisore abbandonato in mezzo ai rovi; doveva essere un
lancio recente, dato che la settimana scorsa non c’era, come non c’era neppure
il water di porcellana rovesciato in un fosso, sulla via del ritorno. Anche lui
una new entry nel mio paesaggio ciclistico. Chi, come i nostri politici, viaggia
sempre in automobile forse non sa che quasi la totalità dei bordi delle nostre
strade e autostrade è costellato di rifiuti e spazzatura. Ogni metro quadrato è
invaso da bottiglie di acqua minerale, lattine, scatole di sigarette, pannolini,
preservativi, batterie di automobili, plastiche: tutto viene allegramente
scaraventato fuori dai finestrini. Se poi si abbandonano le strade asfaltate e
si imboccano quelle bianche, il panorama diventa ancora più orrendamente
variegato: frigoriferi, lavatrici, pneumatici di tutte le dimensioni, reti da
letto sfondate, materassi, divani, poltrone, computer, bidet, carcasse di
biciclette o di motorino e spesso anche automobili senza targa, per non parlare
delle lastre di amianto, residui di pollai e di stalle, maldestramente nascosti
sotto pochi centimetri di terra. E tutto questo non accade soltanto nella terra
dei fuochi, ma anche nella verde e felice Umbria. Bisogna aver il coraggio di
dirlo apertamente: il nostro Paese - il meraviglioso giardino d’Europa -
è una discarica a cielo aperto, di cui la «Terra dei fuochi» non è che la punta
di un iceberg. Questo disprezzo per il luogo in cui viviamo, oltre a provocare
un enorme danno all’ambiente e al turismo, è uno specchio fedele dell’assenza di
senso civico che permea ormai tutto il Paese e di cui la classe politica è
stata, fino ad ora, la garante. Dopo di me il diluvio, potrebbe assurgere a
nostro motto nazionale. Il fatto che esistano, in ogni comune, delle isole
ecologiche in cui smaltire ciò che non serve più cambia solo in parte le cose,
perché questi luoghi hanno orari e leggi da rispettare, e perché mai dovrei
rispettare un orario e una legge, se posso non farlo? Per anni, camminando in
montagna, mi sono arrabbiata vedendo tutto quello che veniva abbandonato
lungo i sentieri. Poi ho capito che quello sporco riguardava anche me, che
arrabbiarsi e non fare niente mi rendeva complice del degrado. Così ho
cominciato a raccogliere bottigliette di plastica, rifiuti e lattine come
fossero fiori, riportandoli a valle con me. È questo che tutti noi dovremmo
fare. Ciò che è fuori è sempre lo specchio di ciò che è dentro. L’immondizia che
devasta il nostro Paese non è che la manifestazione del degrado etico che
pervade ogni ambito della nostra società. Così, pedalando desolata, pensavo:
come sarebbe se ogni comune, ogni quartiere di città, mettesse a disposizione di
noi cittadini dei mezzi per permetterci di raccogliere in prima persona i
rifiuti abbandonati criminalmente per strada o nei boschi. E poi sarebbe anche
bello che tutta questa spazzatura, invece di venir immediatamente smaltita e
dimenticata, lasciando spazio all’arrivo di nuova, venisse portata nelle piazze
principali dei paesi e dei quartieri e affidata alle mani esperte di ragazzi
diplomati alle varie Accademie di belle arti, per venir trasformata, grazie alla
loro creatività, in temporanei monumenti alla nostra inciviltà. Così, durante la
passeggiata domenicale, prendendo un caffè o conversando con gli amici, tutti
noi potremmo ammirare per un anno gli oggetti che abbiamo abbandonato: guarda,
la mia vecchia lavatrice, il mio bidet, il televisore della nonna! Sarebbe
istruttivo che poi tutti questi precari monumenti al nostro degrado venissero
fotografati e raccolti in un delizioso libretto dal titolo: «Ciò che eravamo,
ciò che non vogliamo più essere». Susanna Tamaro».
LA TERRA
DEI CACHI, DEI PARLAMENTI ABUSIVI E DELLE LEGGI, PIU’ CHE NULLE: INESISTENTI.
La Terra dei
Cachi (di Belisari, Conforti, Civaschi, Fasani) è la canzone cantata da Elio e
le Storie Tese al Festival di Sanremo 1996, classificatasi al secondo posto
nella classifica finale e vincitrice del premio della critica. Prima nelle
classifiche temporanee fino all'ultima serata, il secondo posto nell'ultima
provocò molte polemiche su presunte irregolarità del voto, confermate dalle
indagini dei carabinieri che confermarono che La terra dei cachi era stata la
canzone più votata. Il testo racconta la vita e le abitudini dell'Italia
travolta da scandali su scandali (il pizzo, episodi criminali mai puniti, la
malasanità) e piena di comportamenti che caratterizzano il cittadino italiano
nel mondo, come la passione per il calcio, la pizza e gli spaghetti.
Parcheggi
abusivi, applausi abusivi,
Villette
abusive, abusi sessuali abusivi;
Tanta voglia
di ricominciare abusiva.
Appalti
truccati, trapianti truccati,
Motorini
truccati che scippano donne truccate;
Il visagista
delle dive è truccatissimo.
Papaveri e
papi, la donna cannolo,
Una lacrima
sul visto: Italia sì, Italia no.
Italia sì,
Italia no, Italia bum, la strage impunita.
Puoi dir di
sì, puoi dir di no, ma questa è la vita.
Prepariamoci
un caffè, non rechiamoci al caffè:
C'è un
commando che ci aspetta per assassinarci un pò.
Commando sì,
commando no, commando omicida.
Commando pam,
commando prapapapam,
Ma se c'è la
partita
Il commando
non ci sta e allo stadio se ne va,
Sventolando il
bandierone non più il sangue scorrerà.
Infetto sì?
Infetto no? Quintali di plasma.
Primario sì,
primario dai, primario fantasma.
Io fantasma
non sarò, e al tuo plasma dico no;
Se dimentichi
le pinze fischiettando ti dirò:
"Fi fi fi fi
fi fi fi fi, ti devo una pinza.
Fi fi fi fi fi
fi fi fi, ce l'ho nella panza".
Viva il
crogiuolo di pinze, viva il crogiuolo di panze. Eh
Quanti
problemi irrisolti, ma un cuore grande così.
Italia sì,
Italia no, Italia gnamme, se famo dù spaghi.
Italia sob,
Italia prot, la terra dei cachi.
Una pizza in
compagnia, una pizza da solo;
Un totale di
due pizze e l'Italia è questa qua.
Fufafifi,
fufafifi, Italia evviva.
Squerellerellesh, cataraparupai,
Italia
perfetta, perepepè nainananai.
Una pizza in
compagnia, una pizza da solo;
In totale
molto pizzo ma l'Italia non ci sta.
Italia sì,
Italia no, scurcurrillu currillo.
Italia sì: uè.
Italia no,
spereffere fellecche.
Uè, uè, uè,
uè,uè.
Perchè la
terra dei cachi è la terra dei cachi.
«Una società
sciapa e infelice in cerca di connettività».Così il Censis definisce la
situazione sociale italiana nel suo 47mo illustrato a Roma dal direttore
generale Giuseppe Roma e dal presidente Giuseppe De Rita. Una società, quella
italiana, che sembra sempre ad un passo dal crollo ma che non crolla. «Negli
anni della crisi - si legge nel rapporto del Censis - abbiamo avuto il dominio
di un solo processo, che ha impegnato ogni soggetto economico e sociale: la
sopravvivenza. C’è stata la reazione di adattamento continuato (spesso il puro
galleggiamento) delle imprese e delle famiglie. Abbiamo fatto tesoro di ciò che
restava nella cultura collettiva dei valori acquisiti nello sviluppo passato (lo
«scheletro contadino», l’imprenditorialità artigiana, l’internazionalizzazione
su base mercantile), abbiamo fatto conto sulla capacità collettiva di
riorientare i propri comportamenti (misura, sobrietà, autocontrollo), abbiamo
sviluppato la propensione a riposizionare gli interessi (nelle strategie
aziendali come in quelle familiari). Siamo anche una «società sciapa e infelice»
secondo il Censis «senza fermento e dove circola troppa accidia, furbizia
generalizzata, disabitudine al lavoro, immoralismo diffuso, crescente evasione
fiscale, disinteresse per le tematiche di governo del sistema, passiva
accettazione della impressiva comunicazione di massa». Di conseguenza siamo
anche «infelici, perché viviamo un grande, inatteso ampliamento delle
diseguaglianze sociali». A giudizio dei ricercatori del Censis si sarebbe «rotto
il “grande lago della cetomedizzazione”, storico perno della agiatezza e della
coesione sociale. Troppa gente non cresce, ma declina nella scala sociale. Da
ciò nasce uno scontento rancoroso, che non viene da motivi identitari, ma dalla
crisi delle precedenti collocazioni sociali di individui e ceti». Ciò avrebbe
determinato una vera e propria fuga all’estero. Nell’ultimo decennio il numero
di italiani che hanno trasferito la propria residenza all’estero è più che
raddoppiato, passando dai circa 50mila del 2002 ai 106mila del 2012. Ma è stato
soprattutto nell’ultimo anno che l’aumento dei trasferimenti è stato
particolarmente rilevante: (+28,8% tra il 2011 e il 2012). Una reazione al grave
disagio sociale, all’ instabilità lavorativa e sottoccupazione che interessa il
25,9% dei lavoratori: una platea di 3,5 milioni di persone ha contratti a
termine, occasionali, sono collaboratori o finte partite Iva. Ci sono poi 4,4
milioni di italiani che non riescono a trovare un’occupazione «pure
desiderandola». Per il Censis «2,7 milioni sono quelli che cercano attivamente
un lavoro ma non riescono a trovarlo, un universo che dallo scoppio della crisi
è quasi raddoppiato (+82% tra il 2007 e il 2012)». Ci sono poi 1,6 milioni di
italiani che, «pur disponibili a lavorare, hanno rinunciato a cercare
attivamente un impiego perché convinti di non trovarlo». Cresce sempre più il
disinteresse per la politica: il 56% degli italiani (contro il 42% della media
europea) non ha attuato nessun tipo di coinvolgimento civico negli ultimi due
anni, neppure quelli di minore impegno, come la firma di una petizione. Più di
un quarto dei cittadini manifesta una lontananza pressoché totale dalla
dimensione politica, non informandosi mai al riguardo. Al contrario, si
registrano nuove energie difensive in tanta parte del territorio nazionale
contro la chiusura di ospedali, tribunali, uffici postali o presidi di
sicurezza. Tuttavia il Censis vede anche dei segnali positivi e di tenuta
sociale. «Si registra una sempre più attiva responsabilità imprenditoriale
femminile (nell’agroalimentare, nel turismo, nel terziario di relazione),
l’iniziativa degli stranieri, la presa in carico di impulsi imprenditoriali da
parte del territorio, la dinamicità delle centinaia di migliaia di italiani che
studiano e/o lavorano all’estero (sono più di un milione le famiglie che hanno
almeno un proprio componente in tale condizione) e che possono contribuire al
formarsi di una Italia attiva nella grande platea della globalizzazione». Nuove
energie si sprigionano inoltre in due ambiti che permetterebbero anche
l’apertura di nuovi spazi imprenditoriali e di nuove occasioni di lavoro. «Il
primo -si legge nel rapporto- è il processo di radicale revisione del welfare.
Il secondo è quello della economia digitale: dalle reti infrastrutturali di
nuova generazione al commercio elettronico, dalla elaborazione intelligente di
grandi masse di dati, dallo sviluppo degli strumenti digitali ai servizi
innovativi di comunicazione, alla crescita massiccia di giovani “artigiani
digitali”». Il nuovo motore dello sviluppo, secondo il Censis, potrebbe essere
la connettività (non banalmente la connessione tecnica) fra i soggetti coinvolti
in questi processi». Se infatti «restiamo una società caratterizzata da
individualismo, egoismo particolaristico, resistenza a mettere insieme esistenze
e obiettivi, gusto per la contrapposizione emotiva, scarsa immedesimazione
nell’interesse collettivo e nelle istituzioni» avremmo anche raggiunto il punto
più basso dal quale non potrà che derivare un progressivo superamento di questa
«crisi antropologica». Per fare connettività, secondo il Censis, non si può
contare sulle istituzioni «perché autoreferenziali, avvitate su se stesse,
condizionate dagli interessi delle categorie, avulse dalle dinamiche che
dovrebbero regolare, pericolosamente politicizzate, con il conseguente declino
della terzietà necessaria per gestire la dimensione intermedia fra potere e
popolo». Neanche la politica può sviluppare questa connettività perché «più
propensa all’enfasi della mobilitazione che al paziente lavoro di discernimento
e mediazione necessario per fare connettività, scivolando di conseguenza verso
l’antagonismo, la personalizzazione del potere, la vocazione maggioritaria, la
strumentalizzazione delle istituzioni, la prigionia decisionale in logiche
semplificate e rigide». Se dunque, conclude il Censis, «istituzioni e politica
non sembrano in grado di valorizzarla, la spinta alla connettività sarà in
orizzontale, nei vari sottosistemi della vita collettiva. A riprova del fatto
che questa società, se lasciata al suo respiro più spontaneo, produce frutti più
positivi di quanto si pensi».
Quella che
emerge è una nazione senza scrupoli, che lucra su ogni fonte di guadagno
fregandosene delle leggi, della salute della gente e del territorio. Scorie
tossiche nelle campagne, rigassificatori a un chilometro dai templi di
Agrigento, la decadenza dei Sassi di Matera beneficiari di finanziamenti per la
tutela di milioni di euro. L’annientamento di due giudici e dei loro tecnici,
avviato e pianificato con precisione maniacale da politici e colleghi, e
approvato senza batter ciglio da un Consiglio Superiore della Magistratura che
anziché proteggerli dagli attacchi, li consegna agli sciacalli per voce di
Letizia Vacca (non me ne voglia il bovino): “due cattivi magistrati”. Il “non
sapevo” oggi non è più tollerato, perché se un giorno De Magistris sarà punito
dal Csm nonostante la Procura di Salerno dice che contro di lui è in atto un
complotto, se la Forleo perderà la funzione di Gip per aver fatto scoprire
all’Italia gli alpinisti della sinistra, questo avverrà di fronte ad una nazione
cosciente, che forse allora reagirà. Ignorantia legis non excusat.
La certezza
della pena non esiste più. Ci troviamo in una situazione di «indulto
quotidiano», in cui tutti parlano ma nessuno fa. Il capo della Polizia non usa
mezzi termini per definire lo stato della certezza della pena in Italia.
«Viviamo una situazione di indulto quotidiano - dice alle commissioni Affari
Costituzionali e Giustizia del Senato - di cui tutti parlano. Ma su cui non si è
fatto nulla negli ultimi anni». La pena, aggiunge, «oggi è quando di più incerto
esiste in Italia»; un qualcosa che rende «assolutamente inutile» la risposta
dello Stato e «vanifica» gli sforzi di polizia e magistratura. «Non gioco a fare
il giurista - prosegue il capo della Polizia - nè voglio entrare nelle
prerogative del Parlamento, ma quella che abbiamo oggi è una situazione
vergognosa. La criminalità diffusa in Italia ha un segmento di fascia
delinquenziale ben identificato che si chiama immigrazione clandestina» ha
aggiunto il capo della polizia. «Il 30 per cento degli autori di reato di
criminalità diffusa sono immigrati clandestini, ma questa media nazionale del 30
per cento va disaggregata». Così, ha proseguito il capo della polizia, si
scopre, che se al Sud i reati commessi da clandestini incidono relativamente
poco («i reati compiuti da irregolari si attesta intorno al 30 per cento»), al
Nord e in particolare nel Nord est «si toccano picchi del 60-70 per cento». La
maggior parte degli immigrati clandestini entra in Italia non attraverso gli
sbarchi ma con un visto turistico. «Solo il 10 per cento dei clandestini entra
nel nostro Paese attraverso gli sbarchi a Lampedusa- dice il capo della polizia-
mentre il 65-70 per cento arriva regolarmente e poi si intrattiene
irregolarmente». E conclude: «Il 70 per cento di quei crimini commessi nel Nord
est da irregolari è compiuta proprio da chi arriva con visto turistico e poi
rimane clandestinamente sul nostro territorio». Per contrastare la
clandestinità, riflette Manganelli, «occorre quindi non solo il contrasto
all'ingresso, ma il controllo della permanenza sul territorio dei clandestini».
Ma le randellate sono riservate anche alla polizia. "La polizia ha una cultura
deviata delle indagini perché pensa che identificare una persona che partecipa a
una manifestazione consenta, poi, di attribuirle tutti i reati commessi
nell’ambito della stessa manifestazione". A sottolinearlo il sostituto
procuratore generale della Cassazione Alfredo Montagna nella sua requisitoria
del 27 novembre 2008 innanzi alla prima sezione penale della Cassazione
nell’ambito dell’udienza per gli scontri avvenuti a Milano, l’11 marzo 2006 a
corso Buenos Aires, durante una manifestazione antifascista non autorizzata
promossa dalla sinistra radicale dei centri sociali e degli autonomi per
protestare contro un raduno della formazione di estrema destra "Forza Nuova". Lo
ha detto in contrarietà ai suoi colleghi dei gradi di giudizio precedenti.
"Quello
affermato per la Diaz deve valere anche per i cittadini"
"La Giustizia deve essere amministrata - ha proseguito Montagna - con equità e
non con due pesi e due misure: quel che è stato affermato per i poliziotti della
Diaz, nel processo di Genova, deve valere anche per il cittadino qualunque e non
solo per i colletti bianchi. Se è vero, come è vero nel nostro ordinamento che è
personale il principio della responsabilità penale, questo deve valere per tutti
mentre ho l’impressione che nel nostro Paese oggi, si stia allargando la
tendenza ad una minor tutela dei soggetti più deboli, come possono essere i
ragazzi un pò scapestrati". Montagna ha aggiunto che "non può passare, alla
pubblica opinione, un messaggio sbagliato per cui sui fatti della Diaz i giudici
decidono in maniera differente rispetto a quando si trovano a giudicare episodi
come quelli di corso Buenos Aires". Invece i giudici hanno deciso in modo
differente: per i poliziotti e i loro dirigenti assoluzione quasi generale; per
i ragazzi condanne confermate per tutti.
Ma le stoccate
vengono portate su tutto il sistema. "Profili di patologie emergono nel settore
dei lavori pubblici e delle pubbliche forniture, nonché nella materia
sanitaria, fornendo un quadro di corruzione ampiamente diffuso". Lo ha
sottolineato il procuratore generale della Corte dei Conti, nella Relazione
all'apertura dell'anno giudiziario della magistratura contabile. Il Pg ha
aggiunto che "in particolare l'accertamento del pagamento di tangenti è
correlato ad artifici ed irregolarità connesse a fattispecie della più diversa
natura, quali la dolosa alterazione di procedure contrattuali, i trattamenti
preferenziali nel settore degli appalti d'opera, la collusione con le ditte
fornitrici, la illecita aggiudicazione, la irregolare esecuzione o
l'intenzionale alterazione della regolare esecuzione degli appalti di opere,
forniture e servizi". Comportamenti illeciti di cui e' conseguenza "il pagamento
di prezzi di gran lunga superiori a quelli di mercato o addirittura il pagamento
di corrispettivi per prestazioni mai rese".
L’Italia non
crede più nelle istituzioni che dovrebbero guidarla. Il potere "esercita il
comando senza obiettivi e senza principi, perde ogni rapporto con la realtà del
Paese", diventa autoreferenziale e alla fine forma "una società separata", con
una sua lingua, le sue gazzette, i suoi clan, i suoi privilegi. Questa "società
separata ha le finestre aperte solo su se stessa", denuncia il Rapporto Italia
dell'Eurispes. In realtà, sottolinea l'Istituto di studi economici e sociali, la
politica non c'è più: è estinta, grazie alla tenacia dei poliburocrati, i
burocrati dei due poli, ora quasi tutti in "overdose", sopraffatti dai loro
stessi abusi.
È una
fotografia impietosa quella scattata dal Censis nel suo Rapporto sulla
situazione sociale del Paese. L’Italia, secondo l’istituto di ricerca
socioeconomica presieduto da Giuseppe De Rita, è un Paese apatico, senza
speranza verso il futuro, nel quale sono sempre più evidenti, sia a livello di
massa sia a livello individuale, «comportamenti e atteggiamenti spaesati,
indifferenti, cinici, prigionieri delle influenze mediatiche». Gli italiani si
percepiscono, scrive il Censis, come «condannati al presente senza profondità di
memoria e di futuro», vittime di fittizi «desideri mai desiderati» come l’ultimo
cellulare alla moda e in preda spesso a «narcisismo autolesionistico», come è
testimoniato dal fenomeno del «balconing». Quella italiana sarebbe, in sostanza,
una società «pericolosamente segnata dal vuoto».
"Una
mucillagine sociale che inclina continuamente verso il peggio".
Così il Censis
descrive la realtà italiana, costituita da una maggioranza che resta "nella
vulnerabilità, lasciata a se stessa", "più rassegnata che incarognita", in
un'inerzia diffusa "senza chiamata al futuro".
La realtà
diventa ogni giorno "poltiglia di massa - spiega il Rapporto sulla situazione
sociale del paese - indifferente a fini e obiettivi di futuro, ripiegata su se
stessa"; la società è fatta di "coriandoli" che stanno accanto per pura inerzia.
Una minoranza
industriale, dinamica e vitale, continua nello sviluppo, attraverso un'offerta
di fascia altissima del mercato, produzioni di alto brand, strategie di nicchia,
investimenti all'estero; cresce così la voglia di successo degli imprenditori e
il loro orgoglio rispetto al mondo di finanza e politica.
Ma "siamo
dentro una dinamica evolutiva di pochi e non in uno sviluppo di popolo": "la
minoranza industriale va per proprio conto, il governo distribuisce
'tesoretti'", ma lo sviluppo non filtra perché non diventa processo sociale e la
società sembra adagiata in un'inerzia diffusa.
Lo sviluppo di
una minoranza non ha saputo rilanciare i consumi e la maggioranza si orienta per
acquisizioni low cost e su beni durevoli, senza un clima di fiducia.
L'italiano
medio dovunque giri lo sguardo sembra pensare di fare esperienza del peggio:
nella politica, nella violenza intrafamiliare, nella micro-criminalità e nella
criminalità organizzata, nella dipendenza da droga e alcool, nella debole
integrazione degli immigrati, nella disfunzione delle burocrazie, nella bassa
qualità dei programmi tv.
La minoranza
industriale, dinamica e vitale, non ce la fa a trainare tutti, visto che é
concentrata sulla conquista di mercati ricchi e lontani, con prodotti a prezzo
così alto che non possono scatenare effetto imitativo.
La pur
indubbia ripresa - fa notare il Censis - rischia di essere malata se non si
immette fiducia nel futuro.
La classe
politica, scossa dalla ventata di antipolitica, non può fare da collettore di
energie.
Solo delle
minoranze "possono trovare la base solida da cui partire" e "sprigionare le
energie necessarie per uscire dallo stallo odierno"; si tratta delle minoranze
che fanno ricerca e innovazione, giovani che studiano all'estero, professionisti
che esplorano nuovi mercati; chi ha scelto di vivere in realtà locali ad alta
qualità della vita; minoranze che vivono l'immigrazione come integrazione, che
credono in un'esperienza religiosa e sono attente alla persona, che hanno scelto
di appartenere a gruppi, movimenti, associazioni, sindacati.
Le diverse
minoranze dovranno gestire da sole una sfida faticosa, immaginando spazi nuovi
di impegni individuali e collettivi: una sfida assolutamente necessaria - per il
Censis - per allontanare l'inclinazione al peggio che "fa rasentare l'ignominia
intellettuale e un'insanabile noia".
Il presidente
del Censis, De Rita: “Italia rassegnata e furba senza senso del peccato. Lo
Stato ha perso autorità morale e sta saltando.”
Nella reazione
dell’opinione pubblica ai ripetuti scandali, c’è una sorta di rassegnazione al
peggio, un atteggiamento diverso rispetto all’era Tangentopoli, eppure questo
approccio non stupisce il presidente del Censis Giuseppe De Rita: «Sì, in giro
c’è una rassegnazione vera, ma anche furba. Chiunque di noi può ascoltare grandi
dichiarazioni indignate: “Qui sono tutti mascalzoni!”. La gente ragiona così:
sento tutti parlare male di tutti e anche io faccio lo stesso. Dopodiché però
non scatta la molla: e io che faccio? Non scatta per l’assenza di codici ai
quali ubbidire. Non scatta perché non c’è più un vincolo collettivo. Tutto può
essere fatto se io stesso ritengo giusto che sia fatto».
La profondità
e l’autorevolezza della sua lettura della società e del costume italiano già da
tempo hanno fatto di Giuseppe De Rita un’autorità morale, una dei pochissimi
intellettuali italiani che è impossibile incasellare.
«Siamo passati
dal grande delitto ai piccoli delitti. Dall’Enimont al piccolo appalto. Ma
questa è la metafora del Paese. A furia di frammentare, anche i reati sono
diventati più piccoli e ciascuno se li assolve come vuole. E’ entrato in crisi
il senso del peccato, ma lo Stato che dovrebbe regolare i comportamenti
sconvenienti, non ha più l’autorità morale per dire: quel reato è veramente
grave. E allora salta lo Stato. Come sta accadendo adesso. Se sei un piccolo
ladruncolo, cosa c’è di meglio che prendersela col grande ladro? Se fai
illegalmente il secondo lavoro da impiegato pubblico, poter dire che quelli lì
erano ladri e si sono mangiati tutto, non è un alibi, ma è una messa in canto
della propria debolezza. Le formichine italiane hanno fatto il Paese, ma hanno
preso tutto quello che era possibile dal corpaccione pubblico. Noi che
predicavamo le privatizzazioni “alte”, non abbiamo capito che il modo italico di
privatizzare era tradurre in interesse privato qualsiasi cosa. Un fenomeno di
massa: ognuno si è preso il suo pezzetto di risorsa pubblica. La classe
dirigente della Seconda Repubblica non è stata soltanto la “serie B” della
Prima, ma le sono mancati riferimenti di autorità morale. Una classe dirigente
si forma sotto una qualche autorità etica. De Gasperi si era formato
nell’Austria-Ungheria, il resto della classe dirigente democristiana, diciamoci
la verità, si è formata in parrocchia. La classe dirigente comunista si era
formata in galera o nella singolare moralità del partito. Questa realtà di
illegalità diffusa ha inizio con don Lorenzo Milani. Con don Milani e
l’obiezione di coscienza. Ci voleva una autorità morale come la sua per dire che
la norma della comunità e dello Stato è meno importante della mia coscienza. E’
da lì che inizia la stagione del soggettivismo etico. Un’avventura che prende
tre strade. La prima: la libertà dei diritti civili. Prima di allora non dovevi
divorziare, non dovevi abortire, dovevi fare il militare, dovevi obbedire allo
Stato e poi sei diventato libero di fare tutto questo. Seconda strada: la
soggettività economica, ciascuno ha voluto essere padrone della propria vita,
non vado sotto padrone, mi metto in proprio. E’ il boom delle imprese. La terza
strada, la più ambigua: la libertà di essere se stessi e quindi di poter
giudicare tutto in base ad un criterio personale. Il marito è mio e lo cambio se
voglio, il figlio è mio e lo abortisco se voglio. L’azienda è mia e la gestisco
io. Io stesso, certe volte parlando con i miei figli, dico: il peccato è mio, me
lo “gestisco” io».
Il Csm, è la
convinzione del capo dello Stato nella cerimonia al Quirinale di commiato dai
componenti del Csm uscenti e di saluto a quelli entranti, deve «contrastare
decisamente oscure collusioni di potere ed egualmente esposizioni e
strumentalizzazioni mediatiche, a fini politici di parte o a scopo di
"autopromozione personale"». Il 31 luglio 2010 l'inquilino del Quirinale cita
«fenomeni di corruzione di trame inquinanti che turbano e allarmano, apparendo
essi tra l’altro legati all’operare di "squallide consorterie"».
Per il Colle è
importante «alzare la guardia nei confronti di deviazioni che finiscono per
colpire fatalmente quel bene prezioso che è costituito dalla credibilità morale
e dall'imparzialità e dalla terzietà del magistrato». «Già nella risoluzione
adottata dal Csm il 20 gennaio 2010 - ricorda Napolitano nel discorso di saluto
dei nuovi componenti del Csm - si è mostrata consapevolezza della percezione da
parte dell'opinione pubblica che, alcune scelte consiliari siano in qualche
misura condizionate da logiche diverse, che possono talvolta affermarsi in
"pratiche spartitorie", rispondenti ad "interessi lobbistici, logiche
trasversali, rapporti amicali o simpatie e collegamenti politici"».
Nel documento
base della ‘Settimana sociale’, di Agosto 2010, la Cei definisce l’Italia
“un Paese senza classe dirigente”.Nel documento è possibile leggere: “L’Italia è
un paese senza classe dirigente, senza persone che per ruolo politico,
imprenditoriale, di cultura, sappiano offrire alla nazione una visione e degli
obiettivi condivisi e condivisibili”.
L’Italia è un
Paese «sfilacciato», addirittura ridotto «a coriandoli», che ha paura del
futuro. È dirompente la radiografia che il presidente dei vescovi italiani, ha
fatto aprendo i lavori del Consiglio permanente della Cei.
“La verità è
che ‘il Paese da marciapiede’ i segni del disagio li offre (e in abbondanza) da
tempo, ma la politica li toglie dai titoli di testa, sviando l’attenzione con le
immagini del ‘Presidente spazzino’, l’inutile ‘gioco dei soldatini’ nelle città,
i finti problemi di sicurezza, la lotta al fannullone”. Questo scrive Famiglia
Cristiana. Ciò svia l’attenzione dai problemi economici del Paese, e con il
rischio “di provocare una guerra fra poveri, se questa battaglia non la si
riconduce ai giusti termini, con serietà e senza le ‘buffonate’, che servono
solo a riempire pagine di giornali”.
Il Vaticano
non recepisce più automaticamente, come fonte del proprio diritto, le leggi
italiane. Tre i motivi principali di questa drastica scelta: il loro numero
esorbitante, l'illogicità e l'amoralità di alcune norme. Lo riferisce
l'Osservatore Romano all’atto di presentazione della nuova legge della Santa
Sede sulle fonti del diritto firmata da Benedetto XVI, vigente dal primo gennaio
2009 e in sostituzione della legge del 7 giugno 1929.
E che dire
della malattia dei politici. Poltronismo, poltronite. La malattia è presto
definita: raccogliere sotto lo stesso corpo più incarichi possibili. La prima
poltrona dà potere e visibilità. La seconda fiducia e tranquillità. Se casco lì,
rimango in piedi qui. O viceversa.
La Prima
Repubblica aveva molti difetti ma alcune virtù nascoste. Tra queste separare in
modo indiscutibile la guida degli enti locali con l'impegno da parlamentare. Il
divieto, contenuto in una legge del 1957 e limitato ai centri con più di
ventimila abitanti e alle province, tutte, trovava fondamento nell'idea di
offrire parità di condizioni ai candidati. Un deputato che fosse in corsa per
fare il sindaco aveva più possibilità di captare voti. Dunque avrebbe violato la
par condicio. Per anni norma osservata, e disciplina dei sensi unici assoluta.
Con Tangentopoli il mercato della politica si è però ristretto. Molti
presentabili sono divenuti impresentabili. Molti politici in carriera si sono
ritrovati in panchina. Molti altri colleghi addirittura oltre le tribune, fuori
dal gioco, alcuni dietro le sbarre.
Col favore
delle tenebre, nel silenzio assoluto e nella distrazione collettiva, il 2 giugno
del 2002 la Giunta per le elezioni, organo politico a cui sono affidati poteri
giurisdizionali, cambia i sensi, inverte i passaggi. Chi fa il sindaco di una
città che abbia più di ventimila abitanti o il presidente della Provincia non
può candidarsi a deputato o senatore. Ma chi è parlamentare può. Senso inverso
possibile. La cosa è piaciuta ai più: fare il sindaco-deputato è molto meglio
che fare soltanto il sindaco. E se è vero che le indennità non sono cumulabili è
certo che le prerogative invece lo sono. Esempio su tutte: l'immunità.
E quindi è
iniziata la processione. Prima quello, poi quell'altro. Dopo di te io. E allora
io. Un deputato è sindaco a Viterbo, un senatore è sindaco a Catania; una
deputata è presidente della Provincia di Asti, un senatore presiede quella di
Avellino. Un deputato è sindaco a Brescia, un collega è presidente a Napoli. E
via così...
I più hanno
trasmesso ai nuovi uffici la stessa foto di rappresentanza data agli uffici
parlamentari. Quando serve siamo qui. Col tesserino. Quando non serve siamo lì.
Con la fascia tricolore. E' un bel segno in questi tempi di crisi: più poltrone
per tutti.
Da una ricerca
emergono i difetti del “belpaese”. Italiani maleducati, arroganti e corrotti,
con scarso rispetto per l'ambiente e le diversità. I più viziosi? Senza ombra di
dubbio, i politici seguiti, a ruota, da sindacalisti, imprenditori e banchieri.
Inizia con in
esclusiva dell'indagine, curata dal sociologo Enrico Finzi, che il 'Messaggero
di “Sant’Antonio” ha commissionato ad Astra Ricerche, istituto di ricerca
demoscopica di cui Finzi è presidente.
Uno zoom sui
nuovi vizi dal quale emerge una radiografia 'in presa diretta' sull'Italia.
''Nell'anteprima dell'indagine pubblicata in questo numero della Rivista, si
possono trovare le prime istantanee - afferma il direttore della rivista, padre
Ugo Sartorio - ossia quali sono i nuovi vizi più diffusi, le cause e,
soprattutto, l'identikit degli italiani più 'viziosi'''.
In testa alla
classifica dei vizi ci sono i politici, secondo il 78% degli interpellati;
seguono i sindacalisti al secondo posto, 40% circa, e poi i giovani, i
giornalisti e gli immigrati, attorno al 35%. Tra i nuovi vizi più diffusi
l'arroganza e la maleducazione, la corruzione, la disonestà, il consumismo, ma
anche l'indifferenza e l'irresponsabilità.
Al primo
posto, per quanto riguarda i vizi nella società, troviamo la maleducazione: ben
nove su dieci abitanti del Belpaese puntano il dito contro questo vizio.
Al terzo
posto, col 77% delle indicazioni, incontriamo il menefreghismo. In stretta
connessione, con un valore di poco inferiore (74%), quel tipo di degenerazione
etica che si traduce nella disonestà e anche nella corruzione.
Insomma, la
più aspra preoccupazione della gente riguarda in generale l'imbarbarimento della
vita e delle relazioni interpersonali, fondato sul trionfo dell''io isolato
dagli altri' e sul venir meno dell'etica personale e collettiva.
Di diversa
natura, ''ma in fondo non così dissimile'', è il quinto macro-difetto, lamentato
dal 71% dei 18-79enni: ''lo scarso rispetto per la natura e per l'ambiente''.
Il 49% del
campione indica come vizio più grave ''il carrierismo e la competizione senza
regole e senza freni, essi stessi determinati dall'egoismo o dal considerare gli
altri solo un mezzo per raggiungere i propri obiettivi. Al penultimo posto in
questa triste classifica - rileva il presidente di Astra ricerche - ecco il
dilagare tra gli italiani dell'immaturità e spesso dell'infantilismo.
Infine il 42%
denuncia la crescita nella nostra società dell'intolleranza (a volte religiosa,
a volte politica, spesso culturale, spessissimo sportiva): quell'incapacità di
accettare e anzi di valorizzare la pluralità delle opinioni e dei comportamenti
che rende democratica e civile, oltre che moralmente solida, qualunque civiltà.
Una
fotografia, quella voluta dal 'Messaggero di sant'Antonio', che aiuta a rilevare
attraverso un'ottica il più possibile imparziale i tratti di un Paese dai mille
volti.
Un occhio agli
italiani anche da parte straniera, e il risultato per noi non è proprio dei
migliori.
Impietosa
analisi del Belpaese dove regna "una dilagante impunità e uno standard di vita
in declino".
"L'Italia è
oggi una terra inondata da corruzione, decadenza economica, noia politica,
dilagante impunità e uno standard di vita in declino".
E' l'impietosa
analisi che fa del nostro Paese il Los Angeles Times in occasione delle elezioni
politiche del 2008 per la scelta del "62esimo governo in 63 anni". Elezioni
nelle quali gli elettori potranno scegliere fra "rei condannati" o "ballerine
della tv". Il titolo dell'articolo di Tracy Wilkinson è: "In Italia il crimine
paga e vi può far eleggere".
Il Los Angeles
Times descrive l'Italia - un tempo "leggendaria icona di cultura" - come un
Paese dove la gestione di un'impresa "è un'esperienza torbida e frustrante, a
meno di non essere la Mafia, oggi il più grande business in Italia".
Un Paese dove
"il sistema giudiziario raramente funziona", e "i parlamentari sono i più pagati
d'Europa ma, secondo l'opinione di molti, i meno efficaci, una elite che si
autoperpetua" e sembra "voler trascinare giù il Paese con sé".
Un' Italia
ormai in ginocchio, con una classe politica "iper-pagata" preda dell'
"immobilismo" e del "trasformismo" che sta inesorabilmente perdendo
"legittimità"' tra i cittadini stanchi e disillusi. E' un quadro nero della
Penisola, il Paese "peggio governato d'Europa", quello che il professor Martin
Rhodes traccia nella pagina dei commenti del Financial Times.
I giornali lo
dicono chiaramente: non siamo più emblema di stile, ma quintessenza della
maleducazione. "Dimenticatevelo il Bel Paese. Musica rap strombazza da una radio
portatile e un pallone rotola sul vostro asciugamano mentre una mamma italiana
urla a suo figlio insabbiato. Questa è la vita da spiaggia, almeno alla maniera
italiana" sentenzia il Sydney Morning Herald. Ma non solo: "un turista visto una
sola volta viene considerato non una persona, bensì un’incombenza" (The
Guardian), "nelle code ai musei ti ritrovi spinto addirittura da suore" si
sostiene su travelpod.com. E ancora, "ci sono preservativi usati ovunque ad
inquinare i parchi protetti" (italy.net), mentre in città "la colonna sonora
simbolica dell'Italia è il ronzio del motore a due marce degli scooter che
sfrecciano ignorando le regole tra il traffico impenetrabile" (New York Times).
Immagine
italiana all'estero: sempre più opaca.
È il quadro che emerge da una ricerca sulla stampa estera dell’Osservatorio
Giornalistico Internazionale Nathan il Saggio (www.nathanilsaggio.com), reso
noto dall’Agenzia KlausDavi, che ha monitorato le principali testate straniere
(dal New York Times a Le Monde, dall’Herald Tribune al Der Spiegel) e i più
importanti portali di informazioni turistiche sul tema "l’Italia vista dagli
altri". Ne scaturisce un’analisi critica e a volte dura da parte della stampa
estera che denota l’opacizzazione dell’immagine dello stile italiano all’estero.
"Che fine ha
fatto la dolce vita?", il titolo di un articolo del Guardian, pare essere
emblematico di questo cambiamento di percezione nei confronti del paese del
sole. Da simpatici burloni, pronti ad accogliere con il sorriso gli ospiti e
pieni del celeberrimo fascino Italian Style riconosciuto in tutto il mondo, gli
italiani di oggi riempiono le colonne della stampa estera per maleducazione ed
eccessi di arroganza e furbizia. Per strada sono sempre pronti a fischiare le
ragazze, concentrati solo sul proprio aspetto fisico e gettano immondizia
ovunque (The Sidney Morning Herald). Nella classifica compare la città di
Viareggio, "invasa d’estate dalla solita calca italiana stravaccata sotto gli
ombrelloni e sempre impegnata a far squillare i cellulari" (Times) e "meta di
chi vuol esibire il proprio status" (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Segue
Rimini con le sue spiagge sovrappopolate e addirittura da evitare, secondo
Liberation. Alberghi non accoglienti e infestati da ragni (Focus), valgono a
Bibione la terza posizione in questa classifica. Chiudono Varigotti, perla della
costa ligure che però è invasa da parcheggiatori e bagni abusivi (Abc), e
Amalfi, dove strombazzate e insulti in auto sono la normalità (The Globe and
Mail).
Questo per
quanto riguarda l'Italia degli adulti. E i nostri figli ??
Cresce fra le
ragazzine il fenomeno della microprostituzione: sesso a scuola e sul web per
arrotondare la “paghetta”.
Ricordate,
appena qualche anno fa, quando si parlava di immagini spinte che gli adolescenti
facevano girare con i telefonini? Allora quel fenomeno, che era ai suoi albori,
venne inquadrato in una specie di patologia “esibizionistica” imitativa fra
teenagers. Capitarono anche casi di video “hard” di ragazzine, destinati
all’auto-contemplazione all’interno della coppia o al ristretto giro delle
amicizie più intime, diffusi, invece, sempre tramite i cellulari, ad intere
scolaresche ed intercettati anche dagli allibiti genitori. Alcuni di questi
episodi divennero casi di cronaca anche in Emilia, a Bologna e Modena, con
povere ragazze messe in piazza in quel modo, e genitori costretti a rivolgersi
ai carabinieri.
Si parlò poi
di “bullismo elettronico”, quando, oltre alle scene di sesso precoce, vennero
fatte circolare dai cellulari anche immagini girate a scuola di pestaggi (anche
ai danni di minorati) o di “scherzi pesanti” a professori (ricordate il caso di
Lecce della professoressa in perizoma, palpeggiata dagli alunni?). Ci si
interrogò allora sul bisogno dei giovani di “apparire” a tutti i costi, di
“visibilità” anche negativa, per esistere….
Ebbene a
distanza di pochi anni, il fenomeno ha cambiato definizione e modalità: non più
“esibizionismo”, non più “bullismo”, non più violenza gratuita, non più gratuita
ostentazione… nel senso che le ragazzine continua a riprendersi o a farsi
riprendere in situazioni “osè”, ma adesso pretendono di essere pagate. Il
fenomeno si sta cioè convertendo in “microprostituzione” a scuola o tramite web.
Una forma di prostituzione per così dire “under”, estemporanea, praticata per lo
più fra coetanei (per questo la si chiama “micro”), ma è certo alta la
possibilità che queste stesse ragazze possano diventare anche “prede” di adulti
senza scrupoli, ed ovviamente più danarosi dei loro compagni di classe.
Il fenomeno è
osservato ed in preoccupante espansione. Per molte ragazze sta diventando
“normale” concedere prestazioni sessuali, o ritrarsi in pose erotiche tramite la
webcam o gli stessi cellulari, in cambio di soldi per arrotondare la paghetta
dei genitori. Paghetta che magari la crisi può aver un po’ ristretto.
E che dire
delle leggi?
Guida pratica
comune del Parlamento Europeo, del Consiglio e della Commissione destinata a
coloro che partecipano alla redazione dei testi legislativi delle istituzioni
europee.
La redazione
degli atti deve essere:
chiara,
facilmente comprensibile, priva di equivoci;
semplice,
concisa, esente da elementi superflui;
precisa, priva
di indeterminatezze.
Tale regola
ispirata al buon senso è espressione di principi generali del diritto come i
seguenti:
l’uguaglianza
dei cittadini davanti alla legge, nel senso che la legge deve essere accessibile
e comprensibile a tutti;
la certezza
del diritto, in quanto l’applicazione della legge deve essere prevedibile.
Invece in
Italia così non è. L'aspirante dannunziano Roberto Calderoli ha fatto un
miracolo: denunciata la presenza di 29.100 leggi inutili, ne ha bruciate in un
bel falò 375.000, scrive Gian Antonio Stella su “Il Corriere della Sera”. Fatti
i conti, lavorando 12 ore al giorno dal momento in cui si è insediato, più di
una al minuto: lettura del testo compresa. Wow! Resta il mistero dell’ingombro
di quelle appena fatte. Stando al «Comitato per la legislazione» della Camera, i
soli decreti del governo attuale hanno sfondato la media di 2 milioni di
caratteri l’uno: 56 decreti, 112 milioni di caratteri. Per capirci:
l’equivalente di 124,4 tomi di 500 pagine l’uno. Dicono le rappresentanze di
base dei vigili del fuoco che quella del ministro è stata «una sceneggiata degna
del Ventennio». E c’è chi sottolinea che i roghi di carta, in passato, hanno
sempre contraddistinto i tempi foschi. Per non dire delle perplessità sui
numeri: se la relazione della commissione parlamentare presieduta da Alessandro
Pajno e più volte citata da Calderoli aveva accertato «circa 21.000 atti
legislativi, di cui circa 7.000 anteriori al 31 dicembre 1969», come ha fatto lo
stesso Calderoli a contarne adesso 375.000? Al di là le polemiche, tuttavia,
resta il tema: fra i faldoni bruciati ieri nel cortile di una caserma dei
pompieri (lui avrebbe voluto fare lo show a Palazzo Chigi ma Gianni Letta, poco
marinettiano, si sarebbe opposto...) c’erano soltanto antichi reperti
burocratici quali l’enfiteusi o anche qualcosa di più recente? Prendiamo
l’articolo 7 delle norme sul fondo perequativo a favore delle Regioni: «La
differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1, calcolate con le modalità
di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell’articolo 6 e il gettito
regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l’esclusione delle
variazioni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria nonché
dall’emersione della base imponibile...». Il ministro Calderoli concorderà: un
delirio. Il guaio è che non si tratta di una legge fatta ai tempi in cui
Ferdinando Petruccelli della Gattina scriveva «I moribondi del Palazzo
Carignano». È una legge del governo attuale, presa mesi fa ad esempio di demenza
burocratese da un grande giornalista non certo catalogabile fra le «penne
rosse»: Mario Cervi. Direttore emerito del Giornale berlusconiano. Eppure c’è di
peggio. Nel lodevolissimo sforzo di rendere più facile la lettura e
quindi il rispetto delle leggi, il governo approvò il 18 giugno 2009 una legge
che aveva un articolo 3 titolato «Chiarezza dei testi normativi». Vi si scriveva
che «a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme
vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite,
modificate, abrogate o derogate; b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in
disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati
dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in
forma sintetica e di chiara comprensione, il testo...». Insomma: basta con gli
orrori da azzeccagarbugli. Eppure, ecco il comma dell’articolo 1 dell’ultimo
decreto milleproroghe del governo in carica: «5-ter. È ulteriormente prorogato
al 31 ottobre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies
dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al
31 dicembre 2009 dall’articolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31». Cioè?
Boh...È questo il punto: che senso c’è a incendiare un po' di scatoloni
di detriti burocratici che parlano di «concessioni per tranvia a trazione
meccanica» o di «acquisto di carbone per la Regia Marina» se poi gli spazi
svuotati da quelle regole in disuso vengono riempiti da nuove norme ancora più
confuse, deliranti, incomprensibili? La risposta è in un prezioso libretto
curato dal preside della facoltà di lettere e filosofia di Padova Michele
Cortellazzo. Si intitola: Le istruzioni per le operazioni degli uffici
elettorali di sezione tradotte in italiano. Sottotitolo: Omaggio al ministero
dell’Interno. Non fosse una cosa seria, potrebbe essere scambiata per satira: se
le regole elettorali fossero comprensibili, perché mai dovrebbero essere
«tradotte in italiano»? Anche negli armadi impolverati delle legislazioni
straniere esistono mucchi di leggi in disuso. Un sito internet intitolato «gogna
del legislatore scemo» ne ha steso un elenco irresistibile. In certi Stati del
Far West americano è proibito «pescare restando a cavallo». Nell’Illinois chi
abbia mangiato aglio può essere incriminato se va a teatro prima che siano
trascorse quattro ore. A Little Rock dopo le 13 della domenica non si può
portare a spasso mucche nella Main Street. Ogni tanto, senza farla tanto lunga,
i legislatori svuotano i magazzini. Magari cercando di non fare gli errori
sui quali, nello sforzo di fare in fretta, era incorsa la "ramazza" di
Calderoli, la quale, come via via hanno segnalato i giornali consentendo di
rimediare alle figuracce, aveva spazzato via per sbaglio anche il trasferimento
della capitale da Firenze a Roma, l’istituzione della Corte dei Conti o le norme
che consentono a un cittadino di non essere imputato per oltraggio a pubblico
ufficiale se reagisce ad atti arbitrari o illegali. Ciò che più conta, però, è
fare le leggi nuove con chiarezza. Se no, ogni volta si ricomincia da capo. Qui
no, non ci siamo. E a dirlo non sono i «criticoni comunisti» ma il Comitato
parlamentare per la legislazione presieduto dal berlusconiano Antonino Lo
Presti. Comitato che due mesi fa spiegò che i decreti del governo Prodi, già
gonfi di parole, numeri e codicilli, contenevano mediamente 1 milione e 128 mila
caratteri. Quelli del governo Berlusconi, a forza di voler tener dentro tutto,
hanno superato i 2 milioni. E sarebbe questa, la semplificazione? Ci siamo
liberati delle ottocentesche norme sulla «riproduzione tramite fotografia di
cose immobili» per tenerci oggi astrusità come i rimandi «all’articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può essere prevista l’applicazione
dell’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell’articolo 1, comma
853...»? Ma dai...
Non basta sono
gli stessi legislatori ad essere illegittimi, quindi abusivi. Incostituzionalità
della Legge elettorale n. 270/2005. Dal Palazzo della Consulta, 4 dicembre 2013.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme
della legge n. 270/2005 che prevedono l’assegnazione di un premio di maggioranza
– sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica – alla lista
o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che
non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei
seggi assegnati a ciascuna Regione. La Corte ha altresì dichiarato
l’illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono la presentazione di
liste elettorali “bloccate”, nella parte in cui non consentono all’elettore di
esprimere una preferenza. Le motivazioni saranno rese note con la pubblicazione
della sentenza, che avrà luogo nelle prossime settimane e dalla quale dipende la
decorrenza dei relativi effetti giuridici. Resta fermo che il Parlamento può
sempre approvare nuove leggi elettorali, secondo le proprie scelte politiche,
nel rispetto dei principi costituzionali.
Il Porcellum è
illegittimo, dice la Corte costituzionale. Bocciato il premio di maggioranza,
bocciate le liste bloccate. La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale
delle norme sul premio di maggioranza, per Camera e Senato, attribuito alla
lista o alla coalizione che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e non
abbiano avuto almeno 340 seggi a Montecitorio e il 55 per cento dei seggi
assegnati a ogni regione, a Palazzo Madama. Contrarie alla Carta anche le norme
sulle liste «bloccate»,perché non consentono all’elettore di dare una
preferenza. Accoglie in toto il ricorso contro la legge elettorale del
2005, l’Alta Corte. Ma nella lunga camera di consiglio è battaglia. Perché dopo
il voto unanime sull’ammissibilità del ricorso e poi sull’eliminazione del
premio di maggioranza, sulla terza questione ci si spacca 7 a 8. Sembra che i
giudici più vicini alla sinistra, dal presidente Gaetano Silvestri a Sabino
Cassese e Giuliano Amato (di nomina presidenziale), allo stesso Sergio
Mattarella (scelto dal parlamento e padre del sistema precedente), volessero che
l’Alta Corte affermasse che abolite le liste bloccate ci fosse la «reviviscenza»
del vecchio sistema. Ma la manovra non sarebbe riuscita perché si sarebbero
opposti lo stesso relatore Giuseppe Tesauro, il vicepresidente Sergio
Mattarella, i giudici Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo e altri scelti da
Cassazione e Consiglio di Stato.
GLI EFFETTI
GIURIDICI INCONTESTABILI: SONO DA CONSIDERARSI INESISTENTI, QUINDI NON
LEGITTIMATI A LEGIFERARE, A DECRETARE ED A NOMINARE CHI E’ STATO ELETTO CON UNA
LEGGE INCOSTITUZIONALE, QUINDI INESISTENTE. INESISTENTI SONO, ANCHE, GLI ATTI DA
QUESTI PRODOTTI: NORME GIURIDICHE O NOMINE ISTITUZIONALI.
L'abrogazione
di una norma giuridica, ossia la sua perdita di efficacia, può avvenire mediante
l'emanazione di una norma successiva di pari grado o di grado superiore. Fanno
eccezione le leggi temporanee nelle quali l'abrogazione è indicata con il
termine della durata indicata dal Legislatore.
L'articolo 15
delle Preleggi delinea tre distinti casi di abrogazione: Art. 15 Abrogazione
delle leggi. "Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per
dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove
disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già
regolata dalla legge anteriore." Nel caso in cui la norma è abrogata, in
tutto o in parte, mediante una legge posteriore con esplicito riferimento alla
norma precedente si parla di "abrogazione espressa". Quando l'abrogazione
deriva dall'incompatibilità delle precedenti norme con quelle emanate
successivamente si parla di "abrogazione tacita". Infine, quando una
nuova legge disciplina un'intera materia già regolamentata, conferendogli una
nuova sistematicità logico-giuridica, le precedenti norme sono abrogate. In
quest'ultimo caso si parla di "abrogazione implicita".
Abrogazione
per incostituzionalità.
Una norma
giuridica può essere abrogata anche mediante sentenza di incostituzionalità
pronunciata dalla Corte Costituzionale. Articolo 136 – Costituzione. "Quando
la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto
avente forza di legge [cfr. art. 134], la norma cessa di avere efficacia dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è
pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali."
Abrogazione
per referendum.
Infine, un altro fenomeno estintivo di una norma giuridica previsto dal nostro
ordinamento giuridico è dato dal referendum abrogativo. Articolo 75 –
Costituzione. "E` indetto referendum popolare [cfr. art. 87 c. 6] per
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente
valore di legge [cfr. artt. 76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi
tributarie e di bilancio [cfr. art. 81], di amnistia e di indulto [cfr. art.
79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80].
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata
se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le
modalità di attuazione del referendum."
Abrogazione
per desuetudine.
Nell'ordinamento giuridico italiano non è valida l'abrogazione per desuetudine.
L'abrogazione di una norma giuridica, ossia la sua perdita di efficacia, può
avvenire mediante l'emanazione di una norma successiva di pari grado o di grado
superiore. Fanno eccezione le leggi temporanee nelle quali l'abrograzione è
indicata con il termine della durata indicata dal Legislatore.
L'abrogazione
è l'istituto mediante il quale il legislatore determina la cessazione ex nunc
(non retroattiva) dell'efficacia di una norma giuridica. Si distingue dalla
deroga (posta in essere da una norma speciale o eccezionale) in quanto una norma
"derogata" resta in vigore per la generalità dei casi, mentre una norma abrogata
cessa di produrre effetti giuridici. Si distingue dall'annullamento, che priva
retroattivamente di efficacia una norma. Tutte le norme giuridiche si sviluppano
necessariamente su due piani, quello temporale e quello spaziale. In questo
scritto sarà la dimensione temporale ad essere presa in considerazione. Questo
implica che si muovano i primi passi da una norma ulteriore rispetto a quelle
citate in precedenza.
L'articolo 11
delle Preleggi disciplina il principio di irretroattività della legge: "la
legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Il
significato di tale regola è che una norma non può essere applicata a situazioni
di fatto o a rapporti giuridici sorti e conclusisi anteriormente alla sua
entrata in vigore. Il principio di irretroattività, previsto dall'articolo 11
delle Preleggi, è ripreso dall'articolo 25 della Costituzione il quale lo
codifica, meglio lo costituzionalizza, limitatamente all'ambito penale,
disponendo, per assicurare un'esigenza di certezza ai comportamenti dei
consociati, che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore prima del fatto commesso". La previsione
costituzionale del principio di irretroattività delle leggi, anziché definire,
almeno in ambito penale, le problematiche sottese alla efficacia delle norme nel
tempo apre delle problematiche ulteriori soprattutto quando viene letto in
combinato con l'articolo 2 del codice penale. L'articolo 2 del codice penale
statuisce che "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge
del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito
per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi
è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se la legge del
tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica
quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile".
Quanto detto
analiticamente vale per gli att. Per quanto riguarda le persone elette con norme
abrogate perché ritenute incostituzionali?
Nel diritto la
nullità è una delle massime sanzioni in quanto opera di diritto (ipso iure) cioè
non è richiesto l'intervento del giudice: l'atto nullo è inefficace di diritto.
Nel codice civile si ha un atto nullo quando manca di uno degli elementi
essenziali o risulta in contrasto con norme imperative. Anche la nullità degli
atti amministrativi è riconducibile a questa disciplina avendo però, ovviamente,
elementi essenziali diversi e norme imperative differenti da rispettare. La
conseguenza della nullità è la stessa: l’atto è come mai esistito. Le cause di
nullità, quindi, sono:
- Casi
previsti dalla legge, nel diritto amministrativo non basta il semplice contrasto
con una norma ma occorre che tale norma preveda come conseguenza della sua
inosservanza la nullità dell’atto. Ecco perché si parla più propriamente di casi
previsti dalla legge.
-
Inottemperanza alle sentenze, può essere considerato un sottoinsieme della
categoria dei casi previsti dalla legge, in quanto una legge prevede che nel
caso che un atto non si conformi ad un precedente giudicato sia nullo.
- Mancanza
degli elementi essenziali, si cerca di applicare l’art. 1325 c.c. per
individuare gli elementi degli atti amministrativi.
Partendo dal
suddetto articolo la giurisprudenza ha individuato gli elementi essenziali degli
atti amministrativi in:
- soggetto, è
nullo l’atto il cui autore non sia identificabile;
- oggetto, è
nullo l’atto avente un oggetto inesistente, indeterminato o indeterminabile, o
inidoneo (espropriare un bene demaniale);
- forma, vige
il principio di libertà della forma ma in alcuni casi si ritiene che sia
essenziale una certa forma, perché richiesta da una disposizione espressa o
dalla prassi. In tali casi il difetto di forma causa nullità dell’atto;
- contenuto, è
nullo l’atto con contenuto indeterminato, indeterminabile, inidoneo o illecito
(autorizzare ad uccidere, autorizzare un’attività non definita, ecc…);
- causa, si
discute se sia elemento essenziale e quindi causa di nullità, o consista
nell’interesse pubblico specifico che l’atto deve perseguire e in tal caso la
sua violazione comporta illegittimità per eccesso di potere.
- Difetto
assoluto di attribuzione (incompetenza assoluta), può essere considerato un
sottoinsieme in quanto corrisponde alla mancanza di un elemento essenziale: il
soggetto.
Si ha
incompetenza assoluta quando l’atto emanato era di competenza non-amministrativa
oppure di altra amministrazione (Regione che interviene in materie statali è
incompetenza assoluta). La c.d. carenza di potere, che non è prevista
espressamente tra le cause di nullità, se ha quando l’amministrazione adotta un
atto senza che sussistessero i presupposti legali che la autorizzassero ad
emanarlo. Le conseguenze della nullità prevedono che l’atto sia privo di
efficacia giuridica in maniera retroattiva, cioè le eventuali attività già
svolte risultano prive di giustificazione.
Non è necessario che l’atto nullo sia eliminato, è sufficiente la sentenza
dichiarativa del giudice competente.
La nullità è assoluta (può essere chiesta da chiunque, anche d’ufficio) ed è
imprescrittibile.
Spiego meglio.
Gli atti sono invalidi quando risultano difformi da ciò che la legge stabilisce.
Possono essere: inesistenti (o nulli), o annullabili.
1.
Inesistenza.
È la mancanza di un elemento essenziale che comporta la totale nullità
dell'atto. I principali casi sono:
a)
inesistenza del soggetto;
quando l'atto non può essere considerato espressione del pubblico potere poiché
emanato da un soggetto non appartenente alla pubblica amministrazione;
b)
incompetenza assoluta per territorio;
quando l'atto
è stato emanato da un organo della pubblica amministrazione ma al di fuori della
sua sfera di competenza territoriale;
c)
incompetenza assoluta per materia;
è inesistente quello emanato da un organo della pubblica amministrazione in una
materia che la legge attribuisce a un altro potere pubblico;
d)
inesistenza dell'oggetto;
è inesistente quando manca il destinatario o quando l'oggetto è indeterminato,
indeterminabile o inidoneo: ad es., l'atto di matrimonio tra due persone dello
stesso sesso;
e)
inesistenza per mancanza di forma essenziale;
si verifica quando la legge prevede che l'atto sia espresso in un certo modo
(solitamente per iscritto) ed esso è emanato in modo diverso.
2.
Annullabilità.
L'atto amministrativo è annullabile quando, pur presentando tutti gli elementi
essenziali previsti dall'ordinamento, è stato formato in modo diverso da quanto
stabilito dalle norme sulla sua emanazione, ed è pertanto illegittimo;
l'illegittimità deve riguardare uno dei suoi elementi essenziali. Mentre non
esiste un testo normativo che indichi le cause di inesistenza dell'atto
amministrativo, la legge rd 1024 26/6/1924 26 prevede espressamente i vizi di
illegittimità che rendono l'atto annullabile: l'incompetenza relativa, l'eccesso
di potere e la violazione di legge.
a)
Incompetenza relativa.
Mentre l'incompetenza assoluta si riscontra solo tra organi di diverse
amministrazioni, e produce l'inesistenza dell'atto, quella relativa si verifica
tra organi dello stesso settore di amministrazione e costituisce uno dei tre
vizi di legittimità dell'atto che lo rendono annullabile. Essa si verifica nei
seguenti casi:
- quando un
organo gerarchicamente inferiore emana un atto di competenza di quello
superiore;
- quando un
organo esercita la potestà di un altro organo dello stesso settore di
amministrazione;
- quando un
organo emana un atto riservato all'ambito territoriale di un altro organo del
medesimo ramo di amministrazione.
b)
Eccesso di potere.
Si riscontra nei casi in cui la pubblica amministrazione utilizza il potere di
cui è dotata per conseguire uno scopo diverso da quello stabilito dalla legge, o
quando il provvedimento appare illogico, irragionevole o privo di
consequenzialità tra premesse e conclusioni. L'eccesso di potere è configurabile
soltanto per gli atti discrezionali e mai per quelli vincolati.
c)
Violazione di legge.
Comprende tutte le cause di illegittimità non previste nei due punti precedenti:
si verificano casi di violazione di legge quando, ad es., non sono rispettate le
regole sul procedimento amministrativo, quando manca la forma prevista dalla
legge, quando mancano i presupposti per l'emanazione dell'atto. L'atto
illegittimo, fino a quando non viene annullato, è efficace e può essere
eseguito. L'annullamento che ha efficacia retroattiva non si verifica di diritto
ma dev'essere fatto valere dagli interessati ed essere pronunciato o con un
provvedimento della pubblica amministrazione o con una sentenza del giudice
amministrativo; in seguito a essi l'atto si considera come mai emanato e gli
effetti eventualmente prodotti vengono annullati; anziché annullato può essere
suscettibile di convalida o di sanatoria.
La
inesistenza? L’ ultima parola, come sempre, alla giurisprudenza, scrive Sergio
De Felice. Ancora una volta il diritto amministrativo mima e mutua le
categorie giuridiche del provvedimento (in particolare, le sue invalidità) dal
diritto civile e dal diritto romano, le madri di tutti i diritti. Si conferma
l’assunto di quel grande autore secondo il quale il civile è il diritto, il
penale è il fatto, l’amministrativo è il nulla, se non altro, perché esso deve
rivolgersi alle altre branche del diritto per disciplinare le categorie
patologiche (come dimostra il tentativo di costruzione negoziale del
provvedimento).
E’ noto che la
disciplina delle invalidità (in particolare della annullabilità, che richiede
l’intervento del giudice) deriva dalla sovrapposizione, in diritto romano, dello
jus civile e del diritto pretorio, e dalla integrazione, quindi, del
diritto processuale con quello sostanziale. Quanto ai confini tra l’atto nullo e
l’atto inesistente, ferma restando la chiara distinzione in teoria generale,
tanto che l’una appartiene al mondo del giuridicamente rilevante, l’altra
no, nella pratica, occorrerà vedere in quale categoria verranno comprese le
fattispecie prima liquidate sotto la generale e onnicomprensiva
“nullità-inesistenza” dell’atto amministrativo. Sotto tale aspetto, mentre non
desteranno problemi pratici, i cosiddetti casi di scuola (atto emesso ioci
o docendi causa, la violenza fisica), maggiori problemi, al limite tra
nullità e inesistenza, creeranno altre fattispecie, come il caso
dell’usurpatore di pubbliche funzioni (art. 347 c.p.), i casi più gravi di
funzionario di fatto, i casi di imperfezione materiale (per non
completamento della fattispecie), il difetto di sottoscrizione di un
atto. Ancora una volta, sarà la giurisprudenza amministrativa a chiarire se
residuano ipotesi di inesistenza, quali sono i requisiti essenziali dell’atto ai
sensi dell’art. 21 septies e così via. Allo stesso modo, la
giurisprudenza dovrà affrontare i nodi tra il rimedio della azione dichiarativa
di nullità, il rapporto con la disapplicazione o inapplicazione, che considera
l’atto tamquam non esset e non lo applica (e che perciò dovrebbe
riguardare solo gli atti imperativi), ne prescinde, ma non lo espunge
definitivamente dal sistema - mentre la nullità dichiara che l’atto è di
diritto difforme dall’ordinamento. La giustizia amministrativa conferma ancora
una volta, ed è chiamata a confermare, il suo ruolo di creatrice del
diritto amministrativo. Essa è senz’altro giurisdizione (lo conferma la
sentenza n.204/2004 della Corte Costituzionale); essa è amministrazione (judgér
l’administration est administrer) quando compara interessi (nella fase
cautelare) o quando entra in punto di contatto, annullando l’atto, o
quando sostituisce un segmento di attività, nella giurisdizione di
merito. Soprattutto, nella specie, la giurisprudenza si conferma il
legislatore di fatto del diritto amministrativo, avendo, il legislatore
nazionale ripreso dagli orientamenti consolidati in via giurisprudenziale le
varie definizioni di invalidità, di nullità, conseguimento dello scopo, i casi
di esecutorietà e così via. Resta la osservazione finale che sarà la
giurisprudenza a completare (vel adiuvandi, vel supplendi, vel
corrigendi) l’opera del legislatore del 2005. Venuta meno la fiducia nel
mito della completezza della legge, è chiaro che il legislatore non è né
completo, né perfetto (né, d’altronde, deve esserlo). Osservava la dottrina
commercialistica a seguito della invenzione della categoria della inesistenza
delle delibere assembleari (nata proprio per contrastare la rigida regola,
voluta dal legislatore, della generale annullabilità a pena di decadenza, e la
tassatività delle nullità delle delibere agli artt. 2377-2379 c.c.), che il
legislatore non è onnipotente, ma è il giudice che adegua la norma al fatto,
che trova il punto di equilibrio del sistema, unendo “ li mezzi alle regole e
la teoria alla pratica”. La storia, e anche il futuro, della invalidità
del provvedimento, ma in realtà tutto il diritto amministrativo, poggeranno
ancora una volta, emulando una espressione della dottrina francese, sulle
ginocchia del Consiglio di Stato.
Legge
Elettorale: ITALIA allo sbando ! Il popolo non riconosce più l’autorità dello
Stato !
Non sono un esperto di diritto Costituzionale ma, alla luce della sentenza
della Corte Costituzionale che ha stabilito l’illegittimità del Porcellum,
immagino che qualsiasi semplice cittadino come il sottoscritto, si ponga
numerosi interrogativi ai quali, almeno apparentemente, non risulta agevole
trovare risposta, scrive Paolo Cardenà. Certo che, in prima istanza, una
sentenza di questo genere stimolerebbe il dubbio se questa possa avere effetto
retroattivo o meno. Perché, nel primo caso, si determinerebbero effetti
sconvolgenti di difficile immaginazione. Ciò deriverebbe dal fatto che, a rigor
di logica, essendo incostituzionale una legge elettorale, sarebbero illegittimi
anche tutti gli effetti prodotti in virtù di una norma incostituzionale. Quindi,
già da otto anni, i parlamentari eletti con questa legge avrebbero occupato una
posizione in maniera illegittima, poiché in contrasto con lo spirito
costituzionale e quindi con quanto affermato dalla Consulta. Ne deriverebbe che
sarebbero illegittimi anche tutti gli atti normativi (e non solo) prodotti in
questo periodo. Di conseguenza tutte le leggi varate e tutti gli atti compiuti
dal Parlamento sarebbero affetti dal vizio di illegittimità.
Pensate: secondo questa logica sarebbe illegittima anche la semplice fiducia
votata ai vari governi che si sono succeduti in questo periodo, che sarebbero
essi stessi illegittimi, quindi naturalmente non abilitati a formare o porre in
essere alcuna azione di governo: decreti compresi. Sarebbero illegittime leggi,
modifiche costituzionali (Fiscal Compact compreso), nomine dei vari organi dello
Stato di competenza del Parlamento, o la nomina stessa del Capo dello Stato e
quant’altro prodotto da organi che, in tutto questo tempo, hanno operato per
effetto di attribuzioni derivanti da atti parlamentari formati da un parlamento
illegittimo, quindi fuori dal perimetro costituzionale. Pensate ancora agli
effetti economici e sociali prodotti in tutto questo periodo. Tutto sarebbe
affetto dal vizio di legittimità. Quanto affermato trova fondamento giuridico
nel fatto che si suole farsi discendere detta efficacia retroattiva dal fatto
che la norma caducata è viziata da nullità e quindi non può produrre ab
origine alcun effetto giuridico. Tuttavia autorevoli commentatori e
costituzionalisti avvertono come un’applicazione così radicale e generalizzata
di tale principio possa determinare gravi inconvenienti. Potrebbero invero
prodursi effetti profondamente sconvolgenti sul piano sociale, ovvero oneri
economici insopportabili, rispetto a situazioni da molto tempo cristallizzate.
In fattispecie del genere si afferma che la pronuncia costituzionale, nel suo
concreto risultato, non aderirebbe affatto alla propria funzione, in quanto
darebbe luogo ad un grave turbamento della convivenza. Facendo una semplice
ricerca in rete, ci si accorgerebbe che quanto appena affermato trova sostegno
in numerose sentenze della Cassazione, della Corte Costituzionale, del Consiglio
di Stato e dei Tribunali di merito che sono stati chiamati dirimere la
problematica relativa a rapporti costituitisi in base ad una norma dichiarata
successivamente incostituzionale.
Ve ne riporto alcune:
“Mentre l’efficacia retroattiva della dichiarazione di
illegittimità costituzionale è giustificata dalla stessa eliminazione della
norma che non può più regolare alcun rapporto giuridico salvo che si siano
determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, in ipotesi di successione di
legge – dal momento che la norma anteriore è pienamente valida ed efficace fino
al momento in cui non è sostituita – la nuova legge non può che regolare i
rapporti futuri e non anche quelli pregressi, per i quali vale il principio che
la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui si p realizzata la
situazione giuridica o il fatto generatore del diritto. (Cass. civile, sez. 28
maggio 1979, n. 311 in giustizia civile mass 1979 fasc. 5)”.
“L’efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale di norma di legge non si estende ai rapporti
esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della
Corte Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai
consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni
giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più
impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del
decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri
atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale. (Trib. Roma 14
febbraio 1995)”.
“Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno
effetto retroattivo, inficiando fin dall’origine la validità e l’efficacia della
norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni
giuridiche “consolidate” per effetto di eventi che l’ordinamento giuridico
riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudica,
l’atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza.
(Cass. civ. sez. III 28 luglio 1997 n. 7057).”
“La retroattività delle sentenze interpretative additive,
pronunciate dalla Corte costituzionale, trova il suo naturale limite nella
intangibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici ormai esauriti in epoca
precedente alla decisione della Corte ( Fattispecie nella quale il provvedimento
di esclusione dai corsi speciali I.S.E.F. è stato impugnato in sede
giurisdizionale e in quella sede è stato riconosciuto legittimo con sentenza
passata in giudicato, con conseguente intangibilità del relativo rapporto) (Con.
giust. amm. Sicilia 24 settembre 1993, n. 319).”
“Sebbene la legge non penale possa avere efficacia retroattiva,
tale retroattività, specialmente nel settore della c.d. interpretazione
legislativa autentica, incontra limiti nelle singole disposizioni costituzionali
e nei fondamentali principi dell’ordinamento, tra i quali va annoverata
l’intangibilità del giudicato, nella specie giudicato amministrativo, in quanto
il suo contenuto precettivo costituisce un modo di essere non più mutabile della
realtà giuridica; pertanto, l’amministrazione non può più esimersi ancorché sia
intervenuta una nuova legge (nella specie, la l. 23 dicembre 1992 n. 498 art.
13) dall’ottemperare al giudicato, dovendosi anzi ritenere, onde il legislatore,
adottando la norma d’interpretazione autentica, abbia comunque inteso escludere
dalla sua applicazione le situazioni coperte dal giudicato. (Consiglio di Stato
a. plen., 21 febbraio 1994, n. 4).”
“Il principio secondo il quale l’efficacia retroattiva delle
pronunce della Corte Costituzionale recanti dichiarazione de illegittimità
costituzionale incontra il limite della irrevocabilità degli effetti prodotti
dalla norma invalidata nell’ambito dei rapporti esauriti, è applicabile alle
sentenze così dette additive. (Consiglio di Stato sez. VI, 20 novembre 1995).
Quindi, tutto il ragionamento proposto, di fatto, a quanto sembra, risolve la
questione degli effetti retroattivi della pronuncia della Corte Costituzionale.
Ma se da una parte risulta risolta la questione della retroattività della
pronuncia, non altrettanto può dirsi riguardo al da farsi, stante un quadro reso
ancor più complesso dalla fragile condizione dell’Italia e dalla necessità di
approvare la Legge di Stabilità al vaglio delle aule parlamentari. Infatti, sia
la citata giurisprudenza che la stessa dottrina, sembrerebbero convergere sul
fatto che siffatta pronuncia della Corte, dovrebbe produrre effetti sui rapporti
futuri, quindi, a parer di chi scrive, su tutti gli atti e i fatti che dovrebbe
compiere il parlamento in carica, dalla data di effetto della pronuncia della
Corte. Tuttavia, secondo quanto si legge nella stampa nazionale sembrerebbe che
la consulta abbia lasciato qualche margine di manovra al Parlamento. Secondo
quanto riportato da Il Messaggero, l’efficacia delle novità decise dalla Corte
si avrà dal momento in cui le motivazioni della sentenza saranno pubblicate e
questo avverrà nelle prossime settimane. Un’indicazione offerta esplicitamente
dalla Corte, il che indica che la Consulta ha in qualche modo voluto mettere in
mora il Parlamento, affinchè si affretti a legiferare o a sanare i punti
illegittimi dell’attuale legge. Resta fermo che le Camere possono approvare una
nuova legge elettorale “secondo le proprie scelte politiche, nel rispetto dei
principi costituzionali” sottolinea la Consulta. La corte ha respinto tutti e
due i punti sottoposti al giudizio di costituzionalità: premio di maggioranza e
preferenze. In ogni caso “L’efficacia della sentenza della Corte Costituzionale
sulla legge elettorale decorrerà dal momento in cui le motivazioni saranno
pubblicate». Le motivazioni della sentenza, informa una nota di Palazzo della
Consulta, saranno rese note con la pubblicazione della sentenza, che avrà luogo
nelle prossime settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi
effetti giuridici. Da ciò, a parere di chi scrive, se ne deriverebbe che il
Parlamento, dalla data di deposito delle motivazioni, decadrebbe dalla
possibilità di legiferare in ogni materia, salvo la riforma della legge
elettorale che superi la carenza di legittimità del Porcellum. Ma per un quadro
di riflessione più ampio e concreto, bisognerà comunque attendere il deposito
delle motivazioni. Il Parlamento è (dovrebbe essere) il tempio più elevato della
democrazia popolare. Ancorché la giurisprudenza sani l’illegittimità degli atti
consolidati, rimane comunque il fatto che questo Parlamento risulta illegittimo
da un punto di vista sostanziale e morale rispetto ai principi di democrazia
sanciti dalla Costituzione, e naturalmente appartenenti ad uno stato di diritto.
Napolitano, anch’esso eletto in maniera illegittima, dopo gli strappi alla
democrazia perpetrati in questi anni, dovrebbe rimuovere tutti gli elementi che
compromettono l’esercizio libero della democrazia e quindi, dal momento di
efficacia della sentenza, limitare l’azione del Parlamento alla sola riforma
della legge elettorale da concludersi in tempi strettissimi. Dopodiché,
sciogliere le camere e portare a nuove elezioni ristabilendo la democrazia di
questo Paese. In mancanza di questo, il rischio è proprio quello che la
popolazione non riconosca più l’autorità dello Stato, con tutte le imprevedibili
e nefaste conseguenze che ne deriverebbero, che troverebbero terreno fertile in
animi esasperati da anni di crisi e in questa classe politica.
Il
Parlamento abusivo rischia l'arresto.
Dopo la
bocciatura del Porcellum, associazioni e sindacati pronti a bloccare le prossime
leggi. Pioggia di ricorsi in arrivo, scrive Antonio Signorini su “Il Giornale”.
Illegittimo il sistema elettorale che ha portato quasi mille parlamentari a
Roma. Illegittime le leggi che hanno approvato o che, più verosimilmente,
approveranno in seguito. Il sospetto è al momento quasi solo un argomento da
accademia, materia per i giuristi. Ma il tema c'è e su questo ragionamento
stanno rizzando le antenne, avvocati, associazioni, sindacati e, più in
generale, tutti quelli che hanno qualche conto aperto con la legge di Stabilità
o con altri provvedimenti approvati o all'esame del Parlamento. Per tutti questi
soggetti, la decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo
il sistema elettorale, può diventare un argomento da spendere in tribunale. Ad
accennarlo per prima è stato il presidente emerito della Corte costituzionale
Pietro Alberto Capotosti. «In teoria - ha detto in un'intervista a Qn - dovremmo
annullare le elezioni due volte del presidente della Repubblica, la fiducia data
ai vari governi dal 2005, e tutte le leggi che ha fatto un Parlamento
illegittimo. Sennonché il passato si salva applicando i principi sulle
situazioni giuridiche esaurite».
Il futuro no, quindi. E se la questione venisse posta, spiega un avvocato, non
sarebbe respinta. Tra i provvedimenti che il Parlamento eletto con la legge
incostituzionale dovrà approvare c'è appunto la «finanziaria» del governo Letta.
I consumatori già affilano le armi. Il presidente di Adusbef Elio Lannutti
individua i temi sui quali dal suo punto di vista varrebbe la pena giocare la
carta della illegittimità. «Staremo a vedere, ma nella legge ci sono dei
provvedimenti che vanno a favore delle banche come la rivalutazione delle quote
Bankitalia. Una truffa. Poi ci sono 19,4 miliardi di euro per le banche e la
questione della Cassa depositi e prestiti, ormai diventata peggio dell'Iri».
«Se il Parlamento non fosse abilitato a fare le leggi ci troveremmo di fronte a
una situazione allucinante», aggiunge Rosario Trefiletti, presidente di
Federconsumatori. «Io ho sostenuto la nascita del governo delle larghe intese,
ma se la prospettiva è che ogni legge votata dalle Camere finisca al Tar, a
questo punto sarebbe meglio andare a elezioni».
Tutto dipende da cosa scriverà la Consulta nelle motivazioni. Ed è possibile che
alla fine i giudici costituzionali cerchino di salvare gli atti prodotti durante
la legislatura. «La Corte - spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi -
regola l'efficacia delle sentenze e dirà che l'efficacia vale dalla prossima
legislatura». Il nodo è politico, spiega Rienzi. La legge elettorale è
illegittima, i parlamentari dovrebbero approvarne una nuova. «Ma siccome nessuno
vuole farlo, alla fine si realizzerà quello che volevano Letta e Alfano». Cioè
che arrivare a fine legislatura con questo Parlamento e questa legge. Se
succederà una cosa è certa: gli avvocati dello Stato avranno molto lavoro.
Perché la sentenza è piombata in un momento che ad alcuni sarà sembrato
politicamente perfetto (per fare durare il governo e il mandato parlamentare),
ma pessimo per la politica economica. In piena sessione di bilancio, con diversi
capitoli della legge sui quali sono stati annunciati ricorsi. Ad esempio sul
capitolo pubblico impiego con gli insegnanti delle sigle autonome (dalla Gilda
allo Snals-Confsal all'Anief) sul piede di guerra per il blocco degli stipendi.
Poi le mancate rivalutazioni delle pensioni. Per non parlare del capitolo casa.
Tutti temi sui quali sarà chiamato a pronunciarsi un Parlamento - secondo la
Consulta - eletto con una legge illegittima.
Avete presente le nane bianche?
La morte delle stelle che lascia nel cielo un lucore che a noi sembra una stella
viva ed è invece la traccia di un astro “imploso” secoli fa? Bene, l’Italia è
quest’illusione ottica, questo effetto visivo che è solo una truffa, scrive
Marco Ventura su “Panorama”. È questa l’impressione che ho, l’associazione
d’idee con la decisione della Corte Costituzionale sulla incostituzionalità del
Porcellum. La legge elettorale con la quale siamo andati a votare nelle
politiche degli ultimi otto-nove anni era fasulla, illegittima, contraria alla
Costituzione. Bisognerebbe riavvolgere la pellicola a rifare tutto da capo.
Barrare con un rigo le liste di eletti, la composizione dei Parlamenti, e poi le
fiducie date ai governi. Uno, due, tre, quattro esecutivi. E tutto ciò che
consegue dalla ripartizione dei seggi a Montecitorio e a Palazzo Madama.
Comprese le nomine pubbliche e la composizione della Consulta che ha sancito
l’illegittimità del Porcellum. Tutto per l’ennesima sentenza tardiva, per i
tempi di una giustizia che non riesce a restaurare la legittimità perché non può
modificare a ritroso gli effetti delle situazioni che riconosce, fuori tempo
massimo, contro la legge. Contro la Carta fondamentale. È un po’ come le
decisioni della Sacra Rota. Matrimonio nullo. È stato uno sbaglio.
Ma il problema non riguarda soltanto il Porcellum. È di pochi giorni fa la
notizia che il procuratore del Lazio della Corte dei Conti, Raffaele De
Dominicis, ha sollevato questione di legittimità davanti alla Consulta sul
finanziamento pubblico dei partiti. “Tutte le disposizioni a partire dal 1997 e
via via riprodotte nel 1999, nel 2002, nel 2006 e per ultimo nel 2012” hanno,
scrive, “ripristinato i privilegi abrogati col referendum del 1993” grazie ad
“artifici semantici, come il rimborso al posto del contributo; gli sgravi
fiscali al posto di autentici donativi; così alimentando la sfiducia del
cittadino e l’ondata disgregante dell’anti-politica”. Se la Consulta (tra quanti
mesi o anni?) darà ragione alla Corte dei Conti, i partiti dovranno restituire
quello che hanno continuato a intascare in tutti questi anni? Voi ci credete che
succederà? Io no. E che dire delle eccezioni di costituzionalità che neppure
arrivano alla Consulta, ma che si trascinano in un silenzio assordante finché
qualcuno, sull’onda di qualche rivoluzione cultural-politica, solleverà il
problema? Mi riferisco alla responsabilità civile dei magistrati, per la quale
siamo stati condannati dall’Europa. E che è uno scandalo per un Paese che
pretende di appartenere al novero delle culture giuridiche civili e liberali.
Nel Paese nel quale il cavillo è elevato al rango di Discrimine Massimo, nella
patria dei legulei e degli avvocati, nel paradiso della casta giudiziaria, il
cittadino è senza difese, privo di tutele, schiavo dei tempi della giustizia che
dalla piccola aula di tribunale fino alle sale affrescate della Consulta
dispensa sentenze intempestive e controverse, contaminate dai tempi della
politica. Col risultato che nella patria delle toghe che esercitano un potere
superiore anche a quello del popolo e dei suoi rappresentanti, non c’è pace né
giustizia, e le regole in vigore oggi domani potrebbero rivelarsi una truffa tra
dieci anni. Sempre ai nostri danni. Chi mai ci risarcirà del Porcellum? Chi mai
ci risarcirà della lentezza della giustizia e dell’irresponsabilità dei
magistrati? Chi mai ci risarcirà dei soldi pubblici destinati a chi non ne aveva
diritto?
Filippo Facci:
La Casta? Siete solo dei pezzenti. Siete dei pezzenti, avete lasciato tutto in
mano ai giudici e siete ancora lì a fare calcoli, a preventivare poltrone.
I giudici arrestano o no, sequestrano conti, fermano
cantieri, giudicano se stessi e cioè altri giudici, non pagano
per i propri errori, decidono se questo articolo sia diffamatorio, se una
conversazione debba finire sui giornali, se una cura sia regolare o no, se un
bambino possa vedere il padre, se un Englaro possa terminare la
figlia, se uno Welby possa terminare se stesso, i giudici fanno
cose buone e colmano il ritardo culturale e legislativo che voi
avete creato in vent’anni, ma i giudici fanno anche un sacco di porcate,
e sono in grado di svuotare e piegare ogni leggina che voi gli offriate
su un piatto d’argento. Ma siete voi pezzenti che glielo avete
lasciato fare. Siete voi che avete lasciato sguarniti gli spazi dei quali loro -
o l’Europa - non hanno potuto non occuparsi. E non è che captare il ritardo
culturale e legislativo fosse impresa da rabdomanti: della necessità di
cambiare il Porcellum lo sapevano tutti, anche i cani, il Porcellum lo
odiano tutti, da anni, e voi esistereste solo per questo, per
cambiarlo, siete in Parlamento espressamente per questo, e proprio per questo
sareste stati eletti: se non fosse che non siete neanche degli eletti. Ma lo
abbiamo già detto, che cosa siete. E, ormai, c’è una sola cosa
che rende ingiustificata l’antipolitica: che non c’è più la politica. Ci siete
voi.
Parlamento
dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, anch’essa illegittima perché
nominata dal Parlamento e dal Capo dello Stato, anch’esso nominato dal
Parlamento Gli effetti sono che la sentenza di incostituzionalità del Parlamento
è anch’essa illegittima, perché nominata proprio da un Organo abusivo.
Magari fosse
incostituzionale solo il Parlamento, qui siamo tutti incostituzionali, compreso
il Capo dello Stato (perchè eletto da un Parlamento illegittimo), e per lo
stesso motivo tutte le leggi votate da organismi legislativi illegittimi, e la
stessa Corte Costituzionale a rotazione. Paradossalmente, se la corte
costituzionale è illegittima, la stessa sentenza di i incostituzionalità è
illegittima: paradossale ma assolutamente vero. Mi pare uno dei paradossi
filosofici, siamo senza organi istituzionali legittimi e quindi indirettamente
nelle mani di chiunque abbia potere effettivo, visto che il potere formale non
c'è più.
Elementare…….Watson! Il modo di dire più tipico attribuito ad Holmes è la frase
"Elementare, Watson!" ("Elementary, my dear Watson!"), quando egli
spiega, con una certa sufficienza, all'amico medico la soluzione di un caso.
Il governo
dei giudici?
Si chiede
Domenico Ferrara su “Il Giornale”. Dal Porcellum all'Ilva, da Stamina
alle province e altro ancora. Ormai la magistratura ha preso il posto del
Parlamento. Quando fu coniata, l'espressione descriveva l'atteggiamento
delle toghe conservatrici della Corte Suprema degli Stati Uniti che per lungo
tempo si opposero alle riforme di Roosvelt e del Congresso, ergendosi a
impropria opposizione politica. A distanza di decenni, in Italia, la
magistratura ha fatto passi da gigante e si è seduta direttamente sui banchi
del governo. Parliamo in senso figurato, per carità, epperò l'immagine
rispecchia fedelmente la fotografia degli ultimi anni della vita politica
italiana. Complice, per non dire colpevole, un Parlamento inetto,
incapace di legiferare di suo pugno (chi ricorda a quando risale l'ultima legge
propugnata dal Transatlantico?) e svuotato da ogni funzione di rappresentanza,
la magistratura – ora contabile ora amministrativa ora ordinaria – ha spesso
dettato l'agenda politica, interpretato norme non scritte o financo imposto
decisioni non suffragate da legittimità popolare e rappresentativa. L'ultima
decisione della Consulta in materia di legge elettorale – arrivata
peraltro dopo otto anni di vacatio decisionis – è solo la punta
dell'iceberg. Basti citare il caso dell'Ilva di Taranto, dove i giudici hanno
pure ammesso di aver preso il posto delle istituzioni. Emblematiche le
dichiarazioni dell'Anm: “La vicenda dell’Ilva è un chiaro esempio del fallimento
di altri poteri dello Stato, delle altre autorità che dovevano prevenire questa
situazione. Non è che la magistratura si diverta a fare supplenza: è costretta a
intervenire di fronte a certe ipotesi di reato con gli strumenti propri del
codice". E che dire del taglio alle superpensioni? Bocciato dalla Corte
Costituzionale, che ha salvato la casta dei pensionati ricchi, di quelli cioè
che incassano pensioni da 90mila euro lordi l'anno (e tra questi ci sono anche i
magistrati, guarda caso). Nessun taglio: si sarebbe trattato di un provvedimento
discriminatorio perché toccava i redditi dei soli pensionati e non di tutti i
lavoratori. Amen. Lo stesso dicasi per la Legge 40, approvata dal
Legislatore e dalla volontà popolare. Stessa fine per spesometro e redditometro,
cassati e corretti dalla Corte dei Conti, la stessa che si è opposta
all'abolizione delle province (motivando la decisione con “basse
possibilità di risparmio per gli enti e paventando il rischio di confusione
amministrativa nel periodo transitorio”). Ha suscitato critiche anche la
decisione sul metodo Stamina presa dal Tar del Lazio, accusato di essersi
sostituito ai medici e al governo e di non aver preso in considerazione i pareri
del comitato scientifico e di alcuni premi Nobel. Poi c'è la magistratura
ordinaria che a volte è passata alle cronache per le diverse interpretazioni
date a una legge. Solo per fare un esempio: a Genova un giudice ha pensato bene
di non applicare la legge Bossi-Fini nei confronti di un immigrato. Motivazione?
Contrasta – a suo dire - con una norma europea. E ancora: dall'affidamento di
minori a coppie omosessuali, alle tematiche sul lavoro, passando per i temi
etici e altro ancora, la magistratura è sempre lì, pronta a colmare il vuoto o
il ritardo della politica, o ancora di più pronta a sostituirsi ad essa. Con
buona pace della sovranità popolare.
«Abusivi».
Li chiama proprio così, l’avvocato Gianluigi Pellegrino
intervistato da Tommaso Montesano su “Libero Quotidiano”, i 148 deputati
eletti a Montecitorio grazie al premio di maggioranza del Porcellum, dichiarato
incostituzionale. Un premio contro cui lui, prima ancora della pronuncia della
Corte costituzionale, già a marzo 2013 aveva presentato ricorso alla Giunta
delle elezioni della Camera. Non ci sarebbe niente di particolare se Gianluigi
Pellegrino, figlio del noto avvocato e politico leccese, Giovanni Pellegrino,
più volte in Parlamento, non fosse che è il legale di fiducia del Partito
Democratico. Gianluigi Pellegrino, come il padre, amministrativista di fama
nazionale, è attivissimo nel campo del centrosinistra per aver condotto nelle
aule giudiziarie battaglie sulla legge elettorale, sui quesiti
referendari, perché si andasse a elezioni anticipate per il consiglio
regionale. Fu lui, per esempio, a investire il Tar del Lazio per spingere l’ex
presidente della Regione Lazio a rassegnare finalmente le dimissioni (gesto al
quale era legata la tempistica per l’indizione del voto del 2013). E’ certo,
però, che la famiglia Pellegrino non ha remore a lavorare con i fascisti. La
prova è lì, sul cornicione all’ingresso: anno XII dell’Era Fascista. Era il 1934
e Benito Mussolini era in città a inaugurare questo sanatorio, lavori diretti
dall’ingegnere Oronzo Pellegrino, padre del senatore Giovanni. Si parla a Lecce
dell’ex ospedale Galateo. È questo l’ospedale che
venne utilizzato per la cura della tubercolosi prima, per quella del cancro al
polmone poi.
Adesso il
giurista incalza: «La mancata convalida delle 148 elezioni è doverosa. Ho
presentato in tal senso una memoria in Giunta».
Non sarebbe
meglio attendere il deposito delle motivazioni della sentenza da parte della
Corte?
«Ci sono già
alcuni punti fermi che sono più che sufficienti».
Quali,
avvocato?
«La Corte ha
emesso una sentenza in parte additiva, cambiando il contenuto delle norme
laddove ha previsto l’incostituzionalità del voto ai listoni bloccati senza la
possibilità di esprimere almeno una preferenza. Una disposizione solo per il
futuro».
E l’altra
parte della sentenza, quella sul premio di maggioranza?
«Una pronuncia
di tipo classico. Con la quale la Corte ha ritenuto illegittimi i commi da due a
cinque dell’articolo 82 del testo unico sull’elezione della Camera così come
modificato dal Porcellum. Quei commi sono stati cassati».
E questo
che incidenza ha sul Parlamento attuale?
«Nel momento
in cui la Giunta delle elezioni affronterà la convalida degli eletti, la
procedura dovrà essere compiuta senza applicare i commi che sono stati eliminati
dalla Corte».
Ma cosa
succede se a Montecitorio, fiutato il pericolo, procedono alle convalide prima
che la sentenza produca i suoi effetti?
«Sarebbe un
atto indecoroso ed eversivo dinanzi al quale mi aspetterei l’intervento del
presidente della Repubblica. E comunque non ci sarebbe il tempo. Devono ancora
essere convalidate le elezioni di tutti i deputati. L’articolo 17 del
regolamento della Camera stabilisce che alla convalida degli eletti provveda in
via definitiva, alla fine di tutti i conteggi e dopo la proposta della Giunta,
l’Aula».
Perché la
convalida a tempo di record sarebbe un atto eversivo?
«Già a marzo
ho impugnato l’elezione dei deputati promossi grazie al premio. E ora il premio
è ufficialmente incostituzionale. Rigettare il ricorso ora è impossibile se non
con un atto eversivo».
Come deve
avvenire l’espulsione degli abusivi?
«Con lo stesso
iter adottato per Silvio Berlusconi. La Giunta delle elezioni deve proporre
all’Aula della Camera, e la Camera votare, la mancata convalida dei 148
deputati».
Al loro
posto chi dovrebbe subentrare?
«Quei seggi
andrebbero ripartiti in base ai voti ottenuti. La gran parte andrebbe a Forza
Italia, poi, a cascata, al M5S, Scelta civica e così via. Una piccola parte
andrebbe anche al Pd».
Un
terremoto che avrebbe effetti sui numeri della maggioranza che sostiene il
governo.
«Non è
importante e non si tratta di una motivazione giuridica. Il rischio è un altro».
Che
pericoli vede all’orizzonte?
«Si scatenerà
una pressione sulla Corte costituzionale perché i giudici, in sede di stesura
delle motivazioni della sentenza, dicano qualche parola in più a favore della
salvezza dei deputati sub judice».
Quanto è
alto il rischio che ci sia una valanga di ricorsi da parte dei possibili
subentranti qualora il Parlamento non procedesse sulla strada delle mancate
convalide?
«Premesso che
sarebbe un imbroglio, so già che molti di loro si stanno muovendo. E potranno
anche chiedere i danni puntando ad ottenere, oltre alla proclamazione, le
rispettive indennità per i cinque anni di legislatura. Un ulteriore danno per le
casse dello Stato».
LO SPRECO
DI DENARO PUBBLICO PER GLI ESAMI DI AVVOCATO.
L’opinione
di un saggista, Antonio Giangrande, che sul tema qualcosa ne sa.
In un mondo
caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi
sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla
rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o
perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che
cazzo di vita è?
A proposito
degli avvocati, si può dissertare o credere sulla irregolarità degli esami
forensi, ma tutti gli avvocati sanno, ed omertosamente tacciono, in che modo,
loro, si sono abilitati e ciò nonostante pongono barricate agli aspiranti della
professione. Compiti uguali, con contenuto dettato dai commissari d’esame o
passato tra i candidati. Compiti mai o mal corretti. Qual è la misura del merito
e la differenza tra idonei e non idonei? Tra iella e buona sorte?
Detto questo,
quanto si risparmierebbe per le casse dello Stato a far cessare la farsa degli
annuali esami di avvocato?
Gli emolumenti
per migliaia di Commissari d’esame diversificati per gli esami scritti ed orali.
Gli oneri per gli impiegati dello Stato. Le spese della transumanza dei compiti.
Le spese di vitto, alloggio e trasferte per i candidati. Spese astronomiche per
codici spesso inutili. Problemi psicologici non indifferenti per i candidati.
Non sarebbe meglio, almeno una volta far decidere chi non ha interesse in
conflitto e si estinguesse questa inutile prova che serve solo a far
pavoneggiare chi non ha merito? I bravi, se sono bravi, si vedono sul campo.
L’avvocato è tale solo se ha lo studio pieno di gente. Chi ha studiato tanti
anni, che faccia un periodo di tirocinio con cause limitate, e poi sia valutato
dal mercato, anziché farsi giudicare dai primi di questo mondo.
SONO BRAVI
I COMUNISTI. NIENTE DIRITTO DI DIFESA PER I POVERI.
Di seguito un
comunicato dei Giuristi Democratici che entra nel merito delle modifiche che il
governo Letta ha imposto col voto di fiducia sulla legge di stabilità. “Non se
ne è parlato molto, ma nella nuova legge di stabilità sono state introdotte, e
già approvate al Senato, alcune importanti variazioni economiche anche in
materia di giustizia: innanzitutto la riduzione di un 30% dei compensi per i
difensori (ma anche per i consulenti tecnici, gli ausiliari e gli investigatori
autorizzati) dei soggetti ammessi al cosiddetto “gratuito patrocinio”. Le
spettanze che possono essere liquidate per la difesa dei soggetti non abbienti,
già ridotte perchè calcolate in base ai valori medi e decurtate del 50%
subiscono così un'ulteriore drastica riduzione. Gli effetti sono facilmente
prevedibili: sempre meno avvocati, consulenti, investigatori privati si
renderanno disponibili a difendere chi si trova nelle condizioni per accedere al
patrocinio a spese dello stato; si parla di persone che possono vantare il non
invidiabile primato di percepire un reddito lordo di poco più di 10.000 euro di
reddito l'anno. Sempre meno difesa per chi non può, sempre meno garanzie, sempre
meno diritti. Verso il basso, ovviamente. Dal punto di vista dell'avvocatura,
ovviamente, questa ulteriore riduzione dei compensi (che vengono materialmente
erogati, lo ricordiamo per i profani, dopo qualche anno dalla conclusione dei
procedimenti) rende la remunerazione di questa attività difensiva inferiore ad
ogni limite dignitoso. Se lo Stato per difendere un poveraccio ti paga meno di
un quarto di una parcella media quanti saranno i professionisti seri ad
accettare la mancetta posticipata di alcuni anni dal lavoro svolto ? Altro che
dignità della professione forense, altro che diritto alla difesa, altro che
importanza del ruolo professionale... Aumentano poi i costi di notifica e, last
but not least, viene chiarito che, in caso di ricorsi con i quali vengono
impugnati più atti, il contributo unificato va conteggiato in relazione ad ogni
singolo atto impugnato, anche in grado d'appello. Si tratta, tipicamente, dei
ricorsi in materia amministrativa, in cui è ordinario impugnare l'atto
principale unitamente ai presupposti. Quando si pensa che il contributo
unificato, in queste materie, è normalmente di 600 euro, ben si comprende che la
giustizia amministrativa diventa veramente un lusso per pochi. Come Giuristi
Democratici riteniamo intollerabile questo continuo attacco alla giustizia
sostanziale operata sempre verso il basso, a scapito dei soggetti più deboli che
incappano nel sistema giustizia o che al sistema giustizia non possono accedere.
Pensiamo cosa significa l'applicazione di questi tagli in danno delle migliaia
di detenuti prodotto delle leggi criminogene di cui la legislazione ha fatto
autentico abuso in questi anni, in materia di stupefacenti, in materia di
ingresso e soggiorno degli stranieri, in materia di recidiva. Pensiamo cosa
significano questi aumenti per le centinaia di comitati di cittadini che si
muovono contro grandi e piccole opere devastanti nei territori. Non possiamo
quindi che esprimere una profonda e ragionata avversità alle misure economiche
che il governo vuol mettere in campo nel settore giustizia e chiedere la
cassazione senza rinvio di queste disposizioni, che rappresentano un vero e
proprio attentato al diritto di giustizia dei cittadini meno abbienti.”
MENTRE PER
LE LOBBIES LE PORTE SONO SEMPRE APERTE.
I deputati del
Movimento 5 Stelle hanno usato espressioni altrettanto forti contro lo
strapotere delle lobby in Parlamento. Scandaloso - hanno ribadito ancora in aula
durante il voto per la legge di Stabilità del Governo Letta - che il Partito
democratico si faccia comandare a bacchetta non dal segretario o dal premier
bensì da abili lobbisti che hanno facile accesso alle stanze che contano. Nel
ruolo del censore c'è questa volta Girgis Giorgio Sorial, il giovane deputato
grillino che nel corso del dibattito in Aula ha usato più volte toni e parole
tutt'altro che diplomatiche all'indirizzo del partito del premier. «Questo
governo - ha aggiunto - è fallimentare e fallito perché permette agli squali di
mettere mano ai conti dello Stato. Mentre lavoravamo in commissione c'erano in
giro lobbisti di ogni genere. Mercanteggiavano e barattavano la sicurezza degli
incarichi con la garanzia che i propri privilegi e interessi non sarebbero stati
toccati». Sorial ha quindi ricordato il nome del relatore Maino Marchi (Pd), non
casuale, a suo giudizio, «per una legge che deve essere chiamata marchetta».
Sorial si è spinto oltre e ha rivelato il nome del presunto lobbista che avrebbe
avuto l'impudenza di vantarsi al telefono, proprio nell'anticamera della
commissione Bilancio, di aver «fatto bloccare l'emendamento che prevedeva il
taglio delle pensioni d'oro». In Aula la protesta dei grillini non ha
risparmiato nemmeno la faccia di Luigi Tivelli, ex funzionario della Camera e,
secondo i parlamentari del Movimento 5 Stelle, lobbista di area Pd. Mentre
Sorial stigmatizzava il dilagare dell'attività lobbista dentro le istituzioni, i
suoi colleghi mostravano volantini con sopra la faccia dell'«indagato».
Raggiunto al telefono dalle agenzie di stampa il diretto interessato ha smentito
la sua «funzione», giustificando la sua presenza alla Camera per ricerche
documentali per un libro. «Quelle parole al telefono? Con i miei amici siamo
soliti usare ironia e iperboli, figure retoriche che i grillini non conoscono».
Proprio come
uno stipendio. Con regolarità. Mensilmente, racconta Pier Francesco Borgia su
“Il Giornale. Ad alcuni senatori e deputati arriverebbero ogni mese
finanziamenti da parte di alcune multinazionali che farebbero attività di lobby
sfruttando soprattutto l'ingordigia dei nostri rappresentanti politici. Questo
almeno il senso dell'accusa lanciata dalla puntata delle Iene andata in onda su
Italia Uno il 19 maggio 2013. Nel servizio si vede un assistente parlamentare
ripreso di spalle che con la voce alterata racconta il sistema utilizzato da
alcune multinazionali per far passare emendamenti «favorevoli». Il meccanismo,
racconta la gola profonda, è semplice. «Ci sono multinazionali che hanno a libro
paga alcuni senatori». Come funziona il meccanismo? «Semplice - spiega il
portaborse - un emissario della società viene da noi a Palazzo Madama e ci
consegna i soldi per i parlamentari per cui lavoriamo». Le cifre? Si tratterebbe
di operazioni che prevedono addirittura una sorta di tariffario: «Per quel che
mi riguarda - spiega l'intervistato - conosco due multinazionali, una del
settore dei tabacchi e un'altra nel settore dei videogiochi e delle slot machine
ed entrambe elargiscono dai mille ai duemila euro ogni mese». La tariffa,
inoltre, cambia «a seconda dell'importanza del senatore e quindi, se è molto
influente, sale fino a 5mila euro». Lo scopo è facile da intuire. Questi
parlamentari si devono impegnare a far passare emendamenti favorevoli su leggi
che interessano le stesse aziende. Per fare un esempio preciso, l'anonimo
portaborse cita le sale Bingo per le quali «si sono formati due gruppi,
partecipati sia da uomini del centro sinistra che da uomini del centro destra. I
due gruppi fanno capo ad ex ministri del centro sinistra». Inutile precisare che
questo tipo di attività di lobby non è corretta e, anzi, viola non solo codici
morali ma anche le leggi scritte, nonché i patti con gli elettori. Immediata la
reazione di Pietro Grasso, presidente dell'aula del Senato. «Dal servizio delle
Iene - si legge in una nota di Palazzo Madama - emerge la denuncia di un
comportamento che, se provato, sarebbe gravissimo. Purtroppo la natura di
denuncia, anonima nella fonte e nei destinatari, rende difficile procedere
all'accertamento della verità. Spero quindi che gli autori del servizio e il
cittadino informato di fatti così gravi provvedano senza indugio a fare una
regolare denuncia alla Procura, in modo da poter accertare natura e gravità dei
fatti contestati». Il servizio delle Iene non si limita a questa grave denuncia.
La trasmissione mostra, poi, il diffuso malcostume, da parte dei parlamentari,
di rimborsare in nero i loro assistenti. Molti «portaborse» prenderebbero, a
quanto riferiscono Le iene, 800 euro in nero al mese pur disponendo del regolare
tesserino per entrare a Palazzo Madama. La confessione di questo sfruttamento e
questo malcostume arriva ovviamente in forma anonima: «Il 70% dei colleghi si
trova nelle mie stesse condizioni», racconta la gola profonda spiegando di
lavorare in nero da circa dieci anni e di essere stato assistente «sia di un
senatore di destra che di un senatore di sinistra». Tutta colpa dell'autodichìa,
dice il questore del Senato ed esponente grillina Laura Bottici: «All'interno di
Palazzo Madama, dove si approvano le leggi, non hanno validità le leggi stesse
ma solo i regolamenti interni. È questo il vero problema». È vero che modificare
i regolamenti parlamentari è altrettanto complicato che redigere nuove leggi.
Tuttavia non è su questo aspetto che si focalizza l'attenzione del presidente
del Senato. «Giorni fa ho evidenziato - ricorda Grasso - l'esigenza di una legge
che disciplini, in maniera chiara e trasparente, l'attività lobbistica che al
momento, seppur sempre presente, si muove in maniera nascosta».
LA LOBBY
DEI DENTISTI E LA MAFIA ODONTOIATRICA.
In una sequela
di corpi nudi, da quale particolare tra loro riconosceresti un indigente? Dai
denti, naturalmente! Guardalo in bocca quando ride e quando parla e vedrai una
dentatura incompleta, cariata e sporca.
In fatto di
salute dentale gli italiani non si rivolgono alla ASL. I dentisti della ASL ci
sono, eppure è solo l'8% degli italiani ad avvalersi dei dentisti pubblici. Nel
92% dei casi gli italiani scelgono un dentista privato. Più che altro ad
influenzare la scelta per accedere a questa prestazione medica è perché alla
stessa non è riconosciuta l’esenzione del Ticket. Ci si mette anche la
macchinosità burocratica distribuita in più tempi: ricetta medica; prenotazione,
pagamento ticket e finalmente la visita medica lontana nel tempo e spesso a
decine di km di distanza, che si protrae in più fasi con rinnovo perpetuo di
ricetta, prenotazione e pagamento ticket. La maggiore disponibilità del privato
sotto casa a fissare appuntamenti in tempi brevi, poi, è la carta vincente ed
alla fine dei conti, anche, la più conveniente. Ciononostante la cura dei denti
ci impone di aprire un mutuo alla nostra Banca di fiducia.
Il diritto
alla salute dei denti, in questo stato di cose, in Italia, è un privilegio
negato agli svantaggiati sociali ed economici.
LA
VULNERABILITA’ SOCIALE. Può essere definita come quella condizione di svantaggio
sociale ed economico, correlata di norma a condizioni di marginalità e/o
esclusione sociale, che impedisce di fatto l’accesso alle cure odontoiatriche
oltre che per una scarsa sensibilità ai problemi di prevenzione e cura dei
propri denti, anche e soprattutto per gli elevati costi da sostenere presso le
strutture odontoiatriche private. L’elevato costo delle cure presso i privati,
unica alternativa oggi per la grande maggioranza della popolazione, è motivo di
ridotto accesso alle cure stesse anche per le famiglie a reddito medio - basso;
ciò, di fatto, limita l’accesso alle cure odontoiatriche di ampie fasce di
popolazione o impone elevati sacrifici economici qualora siano indispensabili
determinati interventi.
Pertanto, tra
le condizioni di vulnerabilità sociale si possono individuare tre distinte
situazioni nelle quali l’accesso alle cure è ostacolato o impedito:
a) situazioni
di esclusione sociale (indigenza);
b) situazioni
di povertà:
c) situazioni
di reddito medio – basso.
Perché il
Servizio Sanitario Nazionale e di rimando quello regionale e locale non
garantisce il paritetico accesso alle cure dentali? Perché a coloro che
beneficiano dell’esenzione al pagamento del Ticket, questo non è applicato alla
prestazione odontoiatrica pubblica?
Andare dal
dentista gratis è forse il sogno di tutti, visti i conti che ci troviamo
periodicamente a pagare e che non di rado sono la ragione per cui si rimandano
le visite odontoiatriche, a tutto discapito della salute dentale. Come avrete
capito, insomma, non è così semplice avere le cure dentistiche gratis e spesso,
per averle, si devono avere degli svantaggi molto forti, al cui confronto la
parcella del dentista, anche la più cara, non è nulla. E' però importante sapere
e far sapere che, chi vive condizioni di disagio economico o ha malattie gravi,
può godere, ma solo in rare Regioni, di cure dentistiche gratuite a totale
carico del Sistema Sanitario Nazionale. Diciamo subito che non tutti possono
avere questo diritto: le spese odontoiatriche non sono assimilabili a quelle di
altre prestazioni mediche offerte nelle ASL, negli ospedali e nelle cliniche
convenzionate di tutta Italia. Inoltre, qualora si rendano necessarie protesi
dentarie o apparecchi ortodontici, questi sono a carico del paziente: vi sono
però alcune condizioni particolari che permettono, a seconda dei regolamenti
regionali, di ottenere protesi dentali gratuite e apparecchi a costo zero o
quasi. Le regioni amministrano la sanità, e dunque anche le cure dentistiche,
con larghe autonomie che a loro volta portano a differenze anche sostanziali da
un luogo all'altro. Bisogna, quando si nasce, scegliersi il posto!
Alla fine del
racconto, la morale che se ne trae è una. E’ possibile che la lobby dei dentisti
sia così forte da influenzare le prestazioni sanitarie delle Asl italiane e gli
indirizzi legislativi del Parlamento? In tempo di crisi ci si deve aspettare un
popolo di sgangati senza denti, obbligati al broncio ed impediti al sorriso da
una ignobile dentatura?
«Siamo un
paese di gente che, presi uno ad uno, si definisce onesta. Per ogni male che
attanaglia questa Italia, non si riesce mai a trovare il responsabile. Tanto, la
colpa è sempre degli altri!». Così afferma il dr Antonio Giangrande, noto
saggista di fama mondiale e presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie,
sodalizio antimafia riconosciuto dal Ministero dell’Interno. Associazione fuori
dal coro e fuori dai circuiti foraggiati dai finanziamenti pubblici.
«Quando ho
trattato il tema dell’odontoiatria, parlando di un servizio non usufruibile per
tutti, non ho affrontato l’argomento sulla selezione degli odontoiatri. Non ho
detto, per esempio, che saranno processati a partire dal prossimo 6 marzo 2014 i
26 imputati rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Bari Michele Parisi
nell'ambito del procedimento per i presunti test di ingresso truccati per
l'ammissione alle facoltà di odontoiatria e protesi dentaria delle Università di
Bari, Napoli, Foggia e Verona, negli anni 2008-2009. Ho scritto solo un articolo
asettico dal titolo eclatante.»
Questo
articolo è stato pubblicato da decine di testate di informazione. E la reazione
dei dentisti non si è fatta attendere, anche con toni minacciosi. Oggetto degli
strali polemici è stato, oltre che Antonio Giangrande, il direttore di “Oggi”.
«I Dentisti
non sono mafiosi bensì gli unici che si prendono cura dei cittadini». ANDI
protesta con Oggi per una delirante lettera pubblicata. Così viene definito
l’articolo. Il 14 gennaio 2014 sul sito del settimanale Oggi, nella rubrica “C’è
posta per noi”, è stata pubblicata una missiva del dott. Antonio
Giangrande presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie dal titolo “La
lobby dei dentisti e la mafia odontoiatrica”. Nella nota Giangrande analizza il
bisogno di salute orale e le difficoltà del servizio pubblico di dare le
risposte necessarie chiedendosi se tutto questo non è frutto del lavoro della
lobby dei dentisti talmente potente da influenzare le prestazioni sanitarie
delle Asl e le decisioni del Parlamento. ANDI, per tutelare l’immagine dei
dentisti liberi professionisti italiani, sta valutando se intraprendere azioni
legali nei confronti dell’autore della lettera e del giornale. Intanto ha
chiesto di pubblicare la nota che riportiamo sotto. La Redazione di Oggi ha
scritto il 24.1.2014 alle 16:59, Il precedente titolo della lettera del Dottor
Giangrande era fuorviante e di questo ci scusiamo con gli interessati. Qui di
seguito l’intervento dell’Associazione Nazionale Dentisti italiani, a nome del
Presidente Dott. Gianfranco Prada, in risposta allo stesso Dottor Giangrande. «A
nome dei 23 mila dentisti italiani Associati ad ANDI (Associazione Nazionale
Dentisti Italiani) che mi onoro di presiedere vorrei rispondere alla domanda che
il dott. Antonio Giangrande, presidente dell’Associazione Contro tutte le Mafie
ha posto sul suo giornale il 14 gennaio. “E’ possibile che la lobby dei dentisti
sia così forte da influenzare le prestazioni sanitarie delle Asl italiane e gli
indirizzi legislativi del Parlamento? In tempo di crisi ci si deve aspettare un
popolo di sgangati senza denti, obbligati al broncio ed impediti al sorriso da
una ignobile dentatura?” La risposta è no. No, dott. Giangrande non c’è una
lobby di dentisti così forte da influenzare le scelte della sanità pubblica. La
causa di quanto lei scrive si chiama spending review o se vogliamo utilizzare un
termine italiano dovremmo dire tagli: oltre 30 miliardi negli ultimi due anni
quelli per la sanità. Poi io aggiungerei anche disinteresse della politica verso
la salute orale che non ha portato, mai, il nostro SSN ad interessarsi del
problema. Vede dott. Giangrande lei ha ragione quando sostiene che un sorriso in
salute è una discriminante sociale, ma non da oggi, da sempre. Ma questo non per
ragioni economiche, bensì culturali. Chi fa prevenzione non si ammala e non ha
bisogno di cure. Mantenere sotto controllo la propria salute orale costa
all’anno quanto una signora spende alla settimana dalla propria parrucchiera. Ed
ha anche ragione quando “scopre” che le cure odontoiatriche sono costose, ma non
care come dice lei. Fare una buona odontoiatria costa e costa sia al dentista
privato che alla struttura pubblica, che infatti non riesce ad attivare un
servizio che riesca a soddisfare le richieste dei cittadini. Inoltre, oggi, lo
stato del SSN quasi al collasso, non consente investimenti nell’odontoiatria:
chiudono i pronto soccorso o vengono negati prestazioni salva vita. Ma le
carenze del pubblico nell’assistenza odontoiatrica non è neppure di
finanziamenti, è di come questi soldi vengono investiti. Qualche anno fa il
Ministero della Salute ha effettuato un censimento per capire le attrezzature ed
il personale impiegato da Ospedali ed Asl nell’assistenza odontoiatrica e da
questo è emerso che i dentisti impiegati utilizzano gli ambulatori pubblici in
media per sole 3 ore al giorno. Ma non pensi sia per negligenza degli operatori,
molto spesso è la stessa Asl che non può permettersi di attivare il servizio per
più tempo. Non ha i soldi. Però poi succede anche che utilizzi le strutture
pubbliche per dare assistenza odontoiatrica a pagamento e quindi per rimpinguare
i propri bilanci. Come mai non ci indigna per questo? Il problema non è di
carenza di attrezzature (mediamente quelle ci sono) sono i costi per le cure.
Una visita odontoiatria è molto più costosa di una visita di qualsiasi altra
branca della medicina. Pensi quando il suo dermatologo o cardiologo la visita e
poi allo studio del suo dentista in termini di strumenti, attrezzature e
materiali utilizzati. Anche con i pazienti che pagano il ticket l’Asl non riesce
a coprire neppure una piccola parte dei costi sostenuti per effettuare la cure.
Da tempo chiediamo ai vari Ministri che negli anni hanno trascurato l’assistenza
odontoiatrica di dirottare quegli investimenti in un progetto di prevenzione
odontoiatrica verso la fasce sociali deboli e i ragazzi. Una seria campagna di
prevenzione permetterebbe di abbattere drasticamente le malattie del cavo orale,
carie e malattia parodontale, diminuendo drasticamente la necessità di
interventi costosi futuri come quelli protesici. Invece nelle nostre Asl e negli
ospedali non si previene e non si cura neppure, perché costa troppo curare, così
si estraggono solo denti… creando degli “sdentati” che avranno bisogno di
protesi. Dispositivo che il nostro SSN non può erogare. Ma molto spesso lo fa a
pagamento. Pensi, dott. Giangrande, siamo talmente lobbie che l’unico progetto
di prevenzione pubblica gratuito attivo su tutto il territorio nazionale è reso
possibile da 35 anni dai dentisti privati aderenti all’ANDI. Stesso discorso per
l’unico progetto di prevenzione del tumore del cavo orale, 6 mila morti all’anno
per mancata prevenzione. Per aiutare gli italiani a tutelare la propria salute
orale nell’immediato basterebbe aumentare le detrazioni fiscali della fattura
del dentista (oggi è possibile detrarre solo il 19%) ma questo il Ministero
dell’Economia dice che non è possibile. Però da anni si permette ai cittadini di
detrarre oltre il 50% di quanto spendono per ristrutturare casa o per comprare
la cucina. Come vede, caro dott. Giangrande, il problema della salute orale è
molto serio così come molto serio il problema della mafia. Ma proprio perché
sono problemi seri, per occuparsene con competenza bisogna sforzarsi di
analizzare il problema con serietà e non fare le proprie considerazioni
utilizzando banali lunghi comuni. In questo modo insulta solo i dentisti
italiani che sono seri professionisti e non truffatori o peggio ancora mafiosi.
Fortunatamente questo i nostri pazienti lo sanno, ecco perché il 90% sceglie il
dentista privato e non altre strutture come quelle pubbliche o i low cost.
Perché si fida di noi, perché siamo seri professionisti che lavorano per
mantenerli sani. Aspettiamo le sue scuse. Il Presidente Nazionale ANDI, Dott.
Gianfranco Prada».
Antonio
Giangrande, come sua consuetudine, fa rispondere i fatti per zittire polemiche
strumentali e senza fondamento, oltre che fuorvianti il problema della iniquità
sociale imperante.
Palermo.
Morire, nel 2014, perché non si vuole - o non si può - ricorrere alle cure di un
dentista.
Da un ospedale all'altro: muore per un ascesso. Quando il
dolore è diventato insopportabile ha deciso di rivolgersi ai medici, ma la
situazione è precipitata, scrive Valentina Raffa
su “Il Giornale”, martedì 11/02/2014. Una
storia alla Dickens, con la differenza però che oggi non siamo più nell'800 e
romanzi sociali come «Oliver Twist», «David Copperfield» e «Tempi difficili»
dovrebbero apparire decisamente anacronistici. Eppure... Eppure succede che ai
nostri giorni si possa ancora morire per un mal di denti. Un dolore a un molare
che la protagonista di questa drammatica vicenda aveva cercato di sopportare.
Difficile rivolgersi a un dentista, perché curare un ascesso avrebbe richiesto
una certa spesa. E Gaetana, 18enne di Palermo, non poteva permettersela. Lei si
sarebbe dovuta recare immediatamente in Pronto soccorso. Quando lo ha fatto,
ossia quando il dolore era divenuto lancinante al punto da farle perdere i
sensi, per lei non c'era più nulla da fare. È stata accompagnata dalla famiglia
all'ospedale Buccheri La Ferla, di Palermo, dove avrebbe risposto bene alla
terapia antibiotica, ma purtroppo il nosocomio (a differenza del Policlinico)
non dispone di un reparto specializzato. Quando quindi la situazione si è
aggravata, la donna è stata portata all'ospedale Civico. Ricoverata in 2^
Rianimazione, i medici hanno tentato il possibile per salvarle la vita. A quel
punto, però, l'infezione aveva invaso il collo e raggiunto i polmoni. L'ascesso
al molare era divenuto fascite polmonare. L'agonia è durata giorni. La vita di
Gaetana era appesa a un filo. Poi è sopraggiunto il decesso. Le cause della
morte sono chiare, per cui non è stata disposta l'autopsia. Nel 2014 si muore
ancora così. E pensare che esiste la «mutua». Ma Gaetana forse non lo sapeva.
Sarebbe bastato recarsi in ospedale con l'impegnativa del medico di base. è una
storia di degrado, non di malasanità: ci sono 4 ospedali a Palermo con servizio
odontoiatrico. Ma nella periferia tristemente famosa dello Zen questa non è
un'ovvietà.
Morire di
povertà. Gaetana Priola, 18 anni, non aveva i soldi per andare
dal dentista scrive “Libero Quotidiano”. La giovane si è spenta all'ospedale
civico di Palermo, dove era ricoverata dai primi giorni di febbraio 2014. A
ucciderla, un infezione polmonare causata da un ascesso dentale mai
curato. All'inizio del mese, la giovane era svenuta in casa senza più
dare segni di vita. I medici le avevano diagnosticato uno choc settico
polmonare, condizione che si verifica in seguito a un improvviso
abbassamento della pressione sanguigna. Inizialmente, Gaetana era stata
trasportata al Bucchieri La Ferla e, in seguito, era stata
trasferita nel reparto di rianimazione del Civico. Le sue condizioni sono
apparse da subito come gravi. I medici hanno provato a rianimarla ma, dopo una
settimana di cure disperate, ne hanno dovuto registrare il decesso.
Disperazione e dolore nel quartiere Zen della città, dove la vittima risiedeva
insieme alla famiglia.
All'inizio era
un semplice mal di denti, scrive “Il Corriere della Sera”. Sembrava un dolore da
sopportare senza drammatizzare troppo. Eppure in seguito si è trasformato in un
ascesso poi degenerato in infezione. Una patologia trascurata, forse anche per
motivi economici, che ha provocato la morte di una ragazza di 18 anni, Gaetana
Priolo. La giovane, che abitava a Palermo nel quartiere Brancaccio, non si era
curata; qualcuno dice che non aveva i soldi per pagare il dentista. Un
comportamento che le è stato fatale: è spirata nell'ospedale Civico per uno
«shock settico polmonare». Le condizioni economiche della famiglia della ragazza
sono disagiate ma decorose. Gaetana era la seconda di quattro figli di una
coppia separata: il padre, barista, era andato via un paio di anni fa. Nella
casa di via Azolino Hazon erano rimasti la moglie, la sorella maggiore di
Gaetana, il fratello e una bambina di quasi cinque anni. Per sopravvivere e
mantenere la famiglia la madre lavorava come donna delle pulizie. «È stata
sempre presente, attenta, una donna con gli attributi», dice Mariangela D'Aleo,
responsabile delle attività del Centro Padre Nostro, la struttura creato da don
Pino Puglisi, il parroco uccisa dalla mafia nel '93, per aiutare le famiglie del
quartiere in difficoltà. L'inizio del calvario per Gaetana comincia il 19
gennaio scorso: il dolore è insopportabile tanto da far perdere i sensi alla
diciottenne. La ragazza in prima battuta viene trasportata al Buccheri La Ferla
e visitata al pronto soccorso per sospetto ascesso dentario. «Dopo due ore
circa, in seguito alla terapia, essendo diminuito il dolore, - afferma una nota
della direzione del nosocomio - è stata dimessa per essere inviata per
competenza presso l'Odontoiatria del Policlinico di Palermo». Dove però Gaetana
non è mai andata. Si è invece fatta ricoverare il 30 gennaio al Civico dove le
sue condizioni sono apparse subito gravi: in seconda rianimazione le viene
diagnosticata una fascite, un'infezione grave che partendo dalla bocca si è già
diffusa fino ai polmoni - dicono all'ospedale -. I medici fanno di tutto per
salvarla, ma le condizioni critiche si aggravano ulteriormente fino al decesso
avvenuto la settimana scorsa. Al momento non c'è nessuna denuncia della famiglia
e nessuna inchiesta è stata aperta. «È un caso rarissimo - spiega una dentista -
ma certo non si può escludere che possa accadere». Soprattutto quando si
trascura la cura dei denti. Ed è questo un fenomeno in crescita. «L'11% degli
italiani rinuncia alle cure perchè non ha le possibilità economiche, e nel caso
delle visite odontoiatriche la percentuale sale al 23% - denuncia il segretario
nazionale Codacons, Francesco Tanasi - In Sicilia la situazione è addirittura
peggiore. Chi non può permettersi un medico privato, si rivolge alla sanità
pubblica, settore dove però le liste d'attesa sono spesso lunghissime, al punto
da spingere un numero crescente di utenti a rinunciare alle cure».
“È un caso
rarissimo – spiega una dentista – ma certo non si può escludere che possa
accadere”, scrive “Canicattiweb”. Soprattutto quando si trascura la cura dei
denti. Ed è questo un fenomeno in crescita. Il Codacons si è schierato subito al
fianco dei familiari e dei cittadini indigenti. “Il caso della 18enne morta a
Palermo a causa di un ascesso non curato per mancanza di soldi, è uno degli
effetti della crisi economica che ha colpito la Sicilia in modo più drammatico
rispetto al resto d’Italia”. “L’11% degli italiani rinuncia alle cure mediche
perché non ha le possibilità economiche per curarsi, e nel caso delle le visite
odontoiatriche la percentuale sale al 23% – denuncia il segretario nazionale
Codacons, Francesco Tanasi – Ed in Sicilia la situazione è addirittura peggiore.
Chi non può permettersi cure private, si rivolge alla sanità pubblica, settore
dove però le liste d’attesa sono spesso lunghissime, al punto da spingere un
numero crescente di utenti a rinunciare alle cure. Tale stato di cose genera
emergenze e situazioni estreme come la morte della ragazza di Palermo. E’
intollerabile che nel 2014 in Italia si possa morire per mancanza di soldi –
prosegue Tanasi – Il settore della sanità pubblica deve essere potenziato per
garantire a tutti le prestazioni mediche, mentre negli ultimi anni abbiamo
assistito a tagli lineari nella sanità che hanno prodotto solo un peggioramento
del servizio e un allungamento delle liste d’attesa”.
Bene, cari
dentisti, gli avvocati adottano il gratuito patrocinio, ma non mi sembra che voi
adottiate il “Pro Bono Publico” nei confronti degli indigenti. Pro bono
publico (spesso abbreviata in pro bono) è una frase derivata dal
latino che significa "per il bene di tutti". Questa locuzione è spesso usata per
descrivere un fardello professionale di cui ci si fa carico volontariamente e
senza la retribuzione di alcuna somma, come un servizio pubblico. È comune nella
professione legale, in cui - a differenza del concetto di volontariato -
rappresenta la concessione gratuita di servizi o di specifiche competenze
professionali al servizio di coloro che non sono in grado di affrontarne il
costo.
UNIONE
EUROPEA: ITALIA 60 MILIARDI DI CORRUZIONE. CHI CAZZO HA FATTO I CONTI?
Il 3 febbraio
2014 Cecile Malmstrom, commissario europeo per gli affari interni, presenta il
primo rapporto sulla corruzione nell’Unione, stimata in 120 miliardi di euro,
scrive Emilio Casalini su “Il Corriere della Sera” . Nel capitolo dedicato
all’Italia si ricorda che la nostra Corte dei Conti ha valutato la corruzione
italiana in 60 miliardi di euro. La maggior parte dei giornali, tg, agenzie di
stampa ribatte a caratteri cubitali la notizia per cui metà della corruzione
europea è in Italia. I due dati però non sono omogenei né sovrapponibili. Il
nostro in particolare lo troviamo nel discorso per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario 2012, dove a pagina 100 si legge che "Se l’entità monetizzata della
corruzione annuale in Italia è stata correttamente stimata in 60 miliardi di
euro dal Saet "... sarebbe un’esagerazione. Quindi nemmeno la Corte dei Conti ha
mai fatto calcoli di prima mano, ma si riferisce, ritenendolo peraltro
esagerato, al rapporto di un altro organismo, il Saet, ossia il Servizio
Anticorruzione e Trasparenza. Quest'ultimo però, a pagina 10 nel suo rapporto
del 2009, ha scritto esattamente l’opposto, ossia che “le stime che si fanno
sulla corruzione, 50-60 miliardi l’anno, senza un modello scientifico, diventano
opinioni da prendere come tali, ma che complice la superficialità dei
commentatori e dei media, aumenta la confusione e anestetizza qualsiasi slancio
di indignazione e contrasto”. Solo opinioni dunque. Il Servizio Anticorruzione
negli anni successivi continua a spiegare che si tratta di cifre inventate e
cita (a pagina 130) perfino il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban
Ki-moon, il quale “ha confermato l’infondatezza della fantasiosa stima di 60
miliardi di euro quale costo della corruzione ogni anno in Italia". Quella cifra
sembra essere troppo alta perfino per noi! Ma da dove è nata allora questa cifra
che da molti anni tutti ripetono come un mantra? Forse da un semplice calcolo,
magari citato in un convegno. Nel 2004 la Banca Mondiale aveva pubblicato un
rapporto in cui teorizzava che la corruzione del mondo fosse stimabile in mille
miliardi di dollari. Considerato il Pil globale dell’epoca, la corruzione
corrispondeva quindi ad oltre il 3% del Pil mondiale. Applicando la stessa
percentuale al PIL italiano, ecco saltare fuori la cifra tonda di 60 miliardi.
Una cifra inventata ma citata ormai anche dalle istituzioni comunitarie. Ma la
cosa più grave, come dice il primo rapporto della Saet, è che un elemento che
non si misura, non si gestisce, e quindi non si combatte, non si contrasta.
FATTI DI
CRONACA, DISFATTI DI GIUSTIZIA.
Quello che
la gente non capisce……e quello che non si osa dire.
Colloquio
con il dr Antonio Giangrande, scrittore e sociologo storico, noto per i suoi
saggi d’inchiesta letti in tutto il mondo e per i suoi articoli pubblicati in
tutta Italia, ma ignorato dai media generalisti foraggiati dallo Stato.
«Da anni
racconto ai posteri ed agli stranieri quello che in Italia non si osa dire. In
tema di Giustizia la gente si spella le mani ad osannare quelli che certa
politica e certa informazione ha santificato: ossia, i magistrati. Dico questo
senza alcun pregiudizio e, anzi, con il rispetto che devo ad amici e magistrati
che stimo ed ai quali questa percezione, che non credo sia mio esclusivo
patrimonio, non rende il giusto merito. Bene. Io, nei miei testi e nei miei
video, parlo di chi, invece da innocente non ha voce. Racconto le loro storie,
affinchè in un’altra vita venga reso a loro quella giustizia che in questa
realtà gli è negata. Un indennizzo o un risarcimento per quello che gli è stato
tolto e mai più gli può essere reso. La dignità ed ogni diritto. Specialmente se
poi le pene sono scontate nei canili umani. Cosa orrenda se io aborro questa
crudeltà e perciò, addirittura, non ho il mio cane legato alle catene. Ogni
città ha le sue storie di ingiustizie da raccontare che nessuno racconta. La mia
missione è farle conoscere, pur essendo irriconoscenti le vittime. Parlo di
loro, vittime d’ingiustizia, ma parlo anche delle vittime del reato. Parlo
soprattutto dell’ambiente sociale ed istituzionale che tali vicende trattano.
Vita morte e miracoli di chi ha il potere o l’indole di sbagliare e che, con i
media omertosi, invece rimane nell’ombra o luccica di luce riflessa ed
immeritata. Sul delitto di Sarah Scazzi ad Avetrana, il mio paese, ho raccontato
quello che in modo privilegiato ho potuto vedere, ma non è stato raccontato. Ma
non solo di quel delitto mi sono occupato. Nel libro su Perugia mi sono occupato
del delitto di Meredith Kercher. Per esempio.
FIRENZE. 30
gennaio 2014. Ore 22.00 circa.
Come volevasi dimostrare. Ogni volta che un delitto si basa su indizi aleatori
che si sottopongono a contrastanti interpretazioni, i magistrati condannano, pur
sussistendo gravi dubbi che lasciano sgomenti l'opinione pubblica. Condannano
non al di là del ragionevole dubbio e lo fanno per non recare sgarbo ai colleghi
dell'accusa. I sensitivi hanno delle sensazioni e li palesano, spesso non
creduti. I pubblici ministeri, in assenza di prove, anch’essi hanno delle
sensazioni. Solo che loro vengono creduti dai loro colleghi. Sia mai che venga
lesa l’aurea di infallibilità di chi, con un concorso all’italiana, da un giorno
all’altro diventa un dio in terra. Osannato dagli italici coglioni, che pur
invischiati nelle reti dell’ingiustizia, nulla fanno per ribellarsi.
«Grazie a quei
giudici coscienziosi e privi di animosità politica che spero sempre di trovare -
ha detto Silvio Berlusconi riferendosi ai suoi guai giudiziari - gli italiani
potranno comprendere appieno la vera e propria barbarie giudiziaria in cui
l’Italia è precipitata. Una degenerazione dei principali capisaldi del diritto -
ha, infine, concluso - che ha riservato a me e alle persone che mi stimano e mi
vogliono bene un’umiliazione e, soprattutto, un dolore difficilmente
immaginabili da parte di chi non vive l’incubo di accuse tanto ingiuste quanto
infondate».
Se lo dice lui
che è stato Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana?
Silvio
Berlusconi:
«Venti anni di guerra contro di me. In Italia giustizia ingiusta per tutti».
Raffaele
Sollecito: «Io
sono innocente. Come mi sento? Vorrei che gli altri si mettessero al mio posto.
E’ così...».
Sabrina
Misseri: «Io
non c'entro niente, sono innocente».
Alberto
Stasi:
«Io sono innocente».
Queste sono
solo alcune delle migliaia di testimonianze riportate nei miei saggi. Gente
innocente condannata. Gente innocente rinchiusa in carcere. Gente innocente
rinchiusa in carcere addirittura in attesa di un giudizio che arriverà con i
tempi italici e rilasciato da magistrati che intanto si godono le loro ferie
trimestrali.
Questo può
bastare a dimostrare la mia cognizione di causa?
Quale altro
ruolo istituzionale prevede l’impunità di fatto per ogni atto compiuto
nell’esercizio del proprio magistero? Quale altro organo dello Stato è il
giudice di se stesso?
Di questa
sorte meschina capitata ai più sfortunati, la maggioranza dei beoti italici se
ne rallegra. Il concetto di Schadenfreude potrebbe anche venire parafrasato come
"compiacimento malevolo". Il termine deriva da Schaden (danno) e
Freude (gioia). In tedesco il termine ha sempre una connotazione negativa.
Esiste una distinzione tra la "schadenfreude segreta" (un sentimento privato) e
la "schadenfreude aperta" (Hohn). Un articolo del New York Times
del 2002 ha citato una serie di studi scientifici sulla Schadenfreude, che ha
definito come "delizia delle disgrazie altrui".
Ecco perché
Antonio Giangrande è orgoglioso di essere diverso.
In un mondo
caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi
sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla
rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o
perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che
cazzo di vita è?
Noi siamo
animali. Siamo diversi dalle altre specie solo perché siamo viziosi e ciò ci
aguzza l’ingegno.
Al di là
delle questioni soggettive è il sistema giustizia ed i suoi operatori (Ministri,
magistrati, avvocati e personale amministrativo) che minano la credibilità di un
servizio fondamentale di uno Stato di Diritto.
Noi, miseri
umani, prima di parlare o sparlare dei nostri simili, facciamo come dice il
nostro amico Raffaele Sollecito: “Vorrei che gli altri si mettessero al mio
posto”. Quindi, facciamolo! Solo allora si vedrà che la prospettiva di giudizio
cambia e di conseguenza si possono cambiare le cose. Sempre che facciamo in
tempo, prima che noi stessi possiamo diventare oggetto di giudizio. Ricordiamoci
che quello che capita agli altri può capitare a noi, perché gli altri, spesso,
siamo proprio noi. Oggi facciamo ancora in tempo. Basta solo non essere ignavi!»
LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA. DA QUALE PULPITO
ARRIVA LA PREDICA, SE LO STATO E’ IL PRIMO EVASORE IN ITALIA?
«Siamo un
paese di truffatori, o, magari, qualcuno ha interesse a farci passare come
tali». Così afferma il dr Antonio Giangrande, noto saggista di fama mondiale e
presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, sodalizio antimafia
riconosciuto dal Ministero dell’Interno. Associazione fuori dal coro e fuori dai
circuiti foraggiati dai finanziamenti pubblici.
Evasione fiscale, buco di 52 miliardi nel 2013.
In base alle indagini delle Fiamme Gialle, l'evasione fiscale italiana del
2013 è pari a 51,9 miliardi di euro, scrive Angelo
Scarano su “Il Giornale”. Le evasioni fiscali in Italia
sono all'ordine del giorno: niente scontrino, niente fatture,
insomma, niente di niente. È così, oggi lo Stato italiano ha scoperto che nelle
sue casse c'è un buco di 51,9 miliardi di euro non versati:
colpa delle società italiane, che per non incappare nel Fisco hanno attuato i
tanto famosi "trasferimenti di comodo", spostando le proprie residenze o le basi
delle società nei cosiddetti paradisi fiscali -
Cayman, Svizzera, Andorre -. Quanto agli oltre ottomila evasori totali scoperti,
hanno occultato redditi al fisco per 16,1 miliardi, mentre i ricavi non
contabilizzati e i costi non deducibili riferibili ad altri fenomeni evasivi -
dalle frodi carosello ai reati tributari fino alla piccola evasione - ammontano
a 20,7 miliardi, una cifra più che consistente. Il totale dell'IVA evasa dagli
italiani sarebbe di circa 5 miliardi: un dato che non sorprende, se si considera
che secondo una recente ricerca della Guardia di finanza su 400.000 controlli
effettuati, il 32% delle attività almeno un paio di volte hanno emesso uno
scontrino falso, o non lo hanno emesso proprio. Per frodi e reati
fiscali, lo scorso anno sono state denunciate 12.726 persone, con 202
arresti. Nei confronti dei responsabili delle frodi fiscali, i finanzieri hanno
avviato procedure di sequestro di beni mobili, immobili, valuta e conti correnti
per 4,6 miliardi di euro. Oltretutto, in Italia sono presenti 14.220 lavoratori
completamente in nero, scoperti nel 2013, e 13.385 irregolari, impiegati da
5.338 datori di lavoro. Con una media di una su tre società che non emette
scontrini, non sorprende come l'evasione sia arrivata a cifre stellari, e come
tendenzialmente è destinata ad aumentare col tempo.
I datori di lavoro versano i contributi (altrimenti è un reato).
Lo stato il primo evasore fiscale: INPDAP non versa i contributi come fanno le
aziende ordinariamente.
Lo Stato è il primo evasore contributivo. Secondo stime attendibili (ma non
ufficiali) il datore di lavoro di oltre 3 milioni di persone avrebbe mancato di
versare circa 30 miliardi di contributi. Risultato? Un buco enorme nell'Inpdap
che poi è stato scaricato sull'Inps con un'operazione di fusione alquanto
discutibile. Non ha versato all'INPDAP i contributi previdenziali dei suoi
dipendenti...
Cresce il buco nei conti dell'INPS. Nel
2015 lo Stato dovrà sborsare 100 miliardi per ripianare l'ammanco dell'istituto.
Prendendoli da pensionati e contribuenti.
Inps, Mastrapasqua al governo: "Allarme conti". Ma Saccomanni lo smentisce,
scrive Il Fatto Quotidiano. Il presidente dell'istituto scrive ai ministri
Saccomanni e Giovanni: "Valutare un intervento dello Stato per coprire i deficit
dell'ex Inpdap, altrimenti le passività aumenteranno". L'ultimo bilancio segnava
un rosso di quasi 10 miliardi. E a "La Gabbia" su La7 aveva detto: "Possiamo
sopportare solo 3 anni di disavanzo". Angeletti: "Avvertimento tardivo" e
Bonanni chiede di fare chiarezza.
Lo stato italiano non ha versato per anni i contributi
pensionistici ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e quindi li ha fatti
confluire nell’Inps, ponendoli a carico di coloro che la sventura pose a
lavorare nel comparto produttivo.
Forse che i pensionati italiani non saranno solidali con i poveri dipendenti
delle pubbliche amministrazioni?
Cerchiamo di raccontare la questione del
presunto buco dell’Inps come se fossimo dei privati e non
mamma Stato, scrive Nicola Porro su “Il Giornale”. La cosa in fondo è
semplice. Un paio di anni fa il governo Monti ha deciso di fondere nella grande
Inps, la più piccola Inpdap. È il fondo previdenziale che si occupa dei 2,8
milioni di pensionati pubblici. E ovviamente dei prossimi dipendenti statali che
andranno in quiescenza. Il motivo formale era nobile: ridurre di 100 milioni il
costo di queste burocrazie. In fondo, Inps e Inpdap facevano e fanno lo stesso
mestiere: incassano i contributi sociali da lavoratori e datori di lavoro e
pagano le pensioni. Si è rivelato, dobbiamo presumere senza malizia, come un
modo di annacquare un gigantesco buco di bilancio. Se fossimo dei
privati sarebbe una bancarotta, più o meno fraudolenta. E vi
spieghiamo perché. L’Inpdap è nato nel 1994. Prima lo Stato italiano la faceva
semplice e male. Non pagava i contributi per i propri dipendenti pubblici,
ritenendola una partita di giro. Perché accantonare risorse per le future
pensioni pubbliche, si saranno detti i furbetti della Prima repubblica? Paghiamo
il dovuto, cioè apriamo la cassa, solo quando la pensione sarà maturata. Se
volete si tratta di una variazione ancora peggiore rispetto allo schema Ponzi
(dal grande truffatore italo americano) del metodo retributivo. Quando nel 1994
si crea l’ente previdenziale si pone dunque il problema. Come facciamo?
Semplice, da oggi in poi la Pubblica amministrazione è costretta a pagare anno
per anno i suoi contributi, così come tutti i datori privati lo fanno ogni mese
con l’Inps, al suo fondo di riferimento: l’Inpdap, appunto. Il sistema diventa
così corretto e identico a quello di un’azienda privata: il costo del personale
pubblico, in questo modo, diventa fedele alla realtà e pari (anche in termini di
cassa) a stipendio netto, più tasse e contributi sociali. Ma restava un
problema. Cosa fare con i contributi che si sarebbero dovuti versare nel
passato? La genialata se la inventa il governo Prodi nel 2006 insieme al
ministro del lavoro Damiano. All’Inpdap (semplifichiamo per farci
capire) lo Stato avrebbe dovuto dare più di 8 miliardi di euro di contributi non
versati, ma maturati dai dipendenti pubblici. Una bella botta. E anche all’epoca
avevamo bisogno di fare i fighetti con l’Europa. Per farla breve, lo Stato non
ha trasferito gli 8 miliardi all’Inpdap, ma ha fatto come lo struzzo: ha
anticipato volta per volta ciò che serviva per pagare i conti. Di modo che alla
fine dell’anno i saldi con l’Europa quadrassero. I nodi vengono al pettine
quando Monti decide di fondere l’Inps con l’Inpdap. Antonio Mastrapasqua, che è
il super boss delle pensioni private, sa fare bene i suoi conti. E appena si
accorge che gli hanno mollato il pacco inizia a tremare. Un imprenditore
privato che omettesse di versare i contributi per i propri dipendenti, pur
assumendosi l’impegno di pagare la pensione quando maturasse, verrebbe
trasferito in un secondo a Regina Coeli o a San Vittore. In più, il
medesimo imprenditore privato non dovendo versare ogni anno i contributi
all’Inps, potrebbe fare il fenomeno con le banche o la Borsa, dicendo di avere
molta più cassa di quanto avrebbe se dovesse andare a versare ogni mese il
dovuto. Un mega falso in bilancio da 8 miliardi, questo è ciò che plasticamente
è emerso fondendo l’Inpdap nell’Inps. Mastrapasqua resta un servitore dello
Stato e, secondo il cuoco, non lo ammetterebbe neanche a sua nonna, ma la
fusione dei due enti ha in buona parte compromesso molti degli sforzi fatti per
mettere ordine nel suo carrozzone (che tale in buona parte purtroppo resta). Si
è dovuto sobbarcare un’azienda fallita e non può prendersela più di tanto con il
suo principale creditore: che si chiama Stato Italiano. La morale è sempre
quella. Mentre i privati chiudono, falliscono, si disperano per pagare
tasse e contributi sociali, lo Stato centrale se ne fotte. Come diceva
il marchese del Grillo: «Io so io e voi nun siete un cazzo.»
C'è soltanto una categoria professionale che invece sta versando
molti più contributi di quanto riceve in termini di assegni pensionistici,
scrive Andrea Telara su “Panorama”. Si tratta degli iscritti alla Gestione
Separata, cioè quel particolare fondo dell'Inps in cui confluiscono i versamenti
previdenziali dei lavoratori precari (come i collaboratori a progetto) e dei
liberi professionisti con la partita iva, non iscritti agli Ordini. Nel 2013, il
bilancio della Gestione Separata sarà in attivo per oltre 8 miliardi di euro. Va
detto che questo risultato ha una ragion d'essere ben precisa: tra i precari
italiani e tra le partite iva senza Ordine, ci sono infatti molti giovani ancora
in attività, mentre i pensionati di questa categoria sono pochissimi (il
rapporto è di 1 a 6). Non si può tuttavia negare che, se non ci fossero i
contributi della Gestione Separata, il bilancio dell'Inps sarebbe in una
situazione ancor peggiore di quella odierna. In altre parole, oggi ci sono in
Italia quasi 2 milioni di lavoratori precari e di partite iva che tengono in
piedi i conti dell'intero sistema previdenziale e che pagano una montagna di
soldi per mantenere le pensioni di altre categorie, compresi gli assegni d'oro
incassati da qualche ex-dirigente d'azienda. tema dei «contributi pensionistici
silenti», che vengono versati dai lavoratori precari, parasubordinati e libero
professionisti privi di un ordine di categoria, alla gestione separata
dell’Inps. Contributi che però non si trasformano in trattamenti previdenziali,
poiché quei cittadini non riescono a maturare i requisiti minimi per la
pensione: e che restano nelle casse dell’ente pubblico per pagare quelle degli
altri. È un assetto che penalizza proprio i giovani e i precari,
che con maggiore difficoltà raggiungono i 35 anni di anzianità, visto che nel
mercato legale del lavoro si entra sempre più tardi e in modo intermittente.
Anche quando si matura il minimo di contribuzione richiesto, la pensione non
supera i 400-500 euro. Ad aggravare la condizione di questa fascia di
popolazione è anche l’elevata aliquota dei versamenti, quasi il 27 per cento
della retribuzione: una quota che per la verità fu stabilita nel 2006 dal
governo di Romano Prodi su pressione dei sindacati. Peraltro il problema non
tocca esclusivamente i lavoratori trentenni, sottoposti al regime contributivo,
ma anche i più anziani, soggetti a quello retributivo, che richiede almeno
vent’anni di attività per maturare la pensione.
L’ITALIA,
IL PAESE DEI NO. LA SINDROME DI NIMBY.
Vengo anch'io.
No, tu no (1967 - Fo, Jannacci)
Inserita
nell'album omonimo (che contiene una schidionata di brani indimenticabili: si va
da "Giovanni, telegrafista" a "Pedro, Pedreiro", da "Ho visto un re" a "Hai
pensato mai", quest'ultima versione in lingua della stupenda "Gastu mai pensà"
di Lino Toffolo), "Vengo anch'io. No, tu no" (1967) porta Enzo Jannacci in cima
alle classifiche di vendite, con esiti commerciali mai più ripetuti nel corso
della sua lunga carriera. Assai accattivante nell'arrangiamento, attraversato da
elementi circensi, la canzone divenne una sorta di inno di tutti gli esclusi
d'Italia dai grandi rivolgimenti in atto - siamo, ricordiamolo, nel '68 - perchè
snobbati dall'intellighenzia dell'epoca. Grazie a versi beffardi e surreali,
scritti da Jannacci in sostituzione di quelli originariamente vergati perlopiù
da Dario Fo e maggiormente ancorati al reale, il brano s'imprime nella memoria
collettiva, diviene una sorta di tormentone nazionale, contribuisce in larga
misura a far conoscere ad un pubblico più vasto la figura di un artista
inclassificabile quanto geniale.
Si potrebbe
andare tutti quanti allo zoo comunale
Vengo anch'io?
No tu no
Per vedere
come stanno le bestie feroci
e gridare
"Aiuto aiuto e` scappato il leone"
e vedere di
nascosto l'effetto che fa
Vengo anch'io?
No tu no
Vengo anch'io?
No tu no
Vengo anch'io?
No tu no
Ma perché?
Perché no
Si potrebbe
andare tutti quanti ora che è primavera
Vengo anch'io?
No tu no
Con la bella
sottobraccio a parlare d'amore
e scoprire che
va sempre a finire che piove
e vedere di
nascosto l'effetto che fa
Vengo anch'io?
No tu no
Vengo anch'io?
No tu no
Vengo anch'io?
No tu no
Ma perché?
Perché no
Si potrebbe
poi sperare tutti in un mondo migliore
Vengo anch'io?
No tu no
Dove ognuno
sia già pronto a tagliarti una mano
un bel mondo
sol con l'odio ma senza l'amore
e vedere di
nascosto l'effetto che fa
Vengo anch'io?
No tu no
Vengo anch'io?
No tu no
Vengo anch'io?
No tu no
Ma perché?
Perché no
Si potrebbe
andare tutti quanti al tuo funerale
Vengo anch'io?
No tu no
per vedere se
la gente poi piange davvero
e scoprire che
è per tutti una cosa normale
e vedere di
nascosto l'effetto che fa
Vengo anch'io?
No tu no
Vengo anch'io?
No tu no
Vengo anch'io?
No tu no
Ma perché?
Perché no
No, no e
354 volte no. La sindrome Nimby (Not in my back yard, "non nel mio
cortile") va ben oltre il significato originario.
Non solo contestazioni di comitati che non vogliono nei dintorni di casa
infrastrutture o insediamenti industriali: 354, appunto, bloccati solo nel 2012
(fonte Nimby Forum). Ormai siamo in piena emergenza Nimto – Not in my term of
office, "non nel mio mandato" – e cioè quel fenomeno che svela l’inazione
dei decisori pubblici. Nel Paese dei mille feudi è facile rinviare decisioni e
scansare responsabilità. La protesta è un’arte, e gli italiani ne sono
indiscussi maestri. Ecco quindi pareri "non vincolanti" di regioni, province e
comuni diventare veri e propri niet, scrive Alessandro Beulcke su “Panorama”.
Ministeri e governo, in un devastante regime di subalternità perenne, piegano
il capo ai masanielli locali. Tempi decisionali lunghi, scelte rimandate e
burocrazie infinite. Risultato: le multinazionali si tengono alla larga, le
grandi imprese italiane ci pensano due volte prima di aprire uno stabilimento.
Ammonterebbe così a 40 miliardi di euro il "costo del non fare" secondo le
stime di Agici-Bocconi. E di questi tempi, non permettere l’iniezione di
capitali e lavoro nel Paese è una vera follia.
NO TAV, NO
dal Molin, NO al nucleare, NO all’ingresso dei privati nella gestione
dell’acqua: negli ultimi tempi l’Italia è diventata una Repubblica fondata sul
NO?
A quanto pare la paura del cambiamento attanaglia una certa parte dell’opinione
pubblica, che costituisce al contempo bacino elettorale nonché cassa di
risonanza mediatica per politici o aspiranti tali (ogni riferimento è puramente
casuale). Ciò che colpisce è la pervicacia con la quale, di volta in volta, una
parte o l’altra del nostro Paese si barrica dietro steccati culturali,
rifiutando tutto ciò che al di fuori dei nostri confini è prassi comune. Le
battaglie tra forze dell’ordine e manifestanti NO TAV non si sono verificate né
in Francia né nel resto d’Europa, nonostante il progetto preveda
l’attraversamento del continente da Lisbona fino a Kiev: è possibile che solo in
Val di Susa si pensi che i benefici dell’alta velocità non siano tali da
compensare l’inevitabile impatto ambientale ed i costi da sostenere? E’
plausibile che sia una convinzione tutta italica quella che vede i treni ad alta
velocità dedicati al traffico commerciale non rappresentare il futuro ma, anzi,
che questi siano andando incontro a un rapido processo di obsolescenza? Certo,
dire sempre NO e lasciare tutto immutato rappresenta una garanzia di
sicurezza,soprattutto per chi continua a beneficiare di rendite di posizione
politica, ma l’Italia ha bisogno di cambiamenti decisi per diventare finalmente
protagonista dell’Europa del futuro. NO?
Il Paese
dei "No" a prescindere. Quando rispettare le regole è (quasi) inutile.
In
Italia non basta rispettare le regole per riuscire ad investire nelle grandi
infrastrutture. Perché le regole non sono una garanzia in un Paese dove ogni
decisione è messa in discussione dai mal di pancia fragili e umorali della
piazza. E di chi la strumentalizza, scrive l’imprenditore Massimiliano Boi. Il
fenomeno, ben noto, si chiama “Nimby”, iniziali dell’inglese Not In My
Backyard (non nel mio cortile), ossia la protesta contro opere di interesse
pubblico che si teme possano avere effetti negativi sul territorio in cui
vengono costruite. I veti locali e l’immobilismo decisionale ostacolano progetti
strategici e sono il primo nemico per lo sviluppo dell’Italia. Le contestazioni
promosse dai cittadini sono “cavalcate” (con perfetta par condicio) dalle
opposizioni e dagli stessi amministratori locali, impegnati a contenere ogni
eventuale perdita di consenso e ad allontanare nel tempo qualsiasi decisione
degna di tale nome. Dimenticandosi che prendere le decisioni è il motivo per il
quale, in definitiva, sono stati eletti. L’Osservatorio del Nimby
Forum (nimbyforum.it) ha verificato che dopo i movimenti dei cittadini (40,7%) i
maggiori contestatori sono gli amministratori pubblici in carica (31,4%) che
sopravanzano di oltre 15 punti i rappresentanti delle opposizioni. Il sito
nimbyforum.it, progetto di ricerca sul fenomeno delle contestazioni territoriali
ambientali gestito dall'associazione no profit Aris, rileva alla settima
edizione del progetto che in Italia ci sono 331 le infrastrutture e impianti
oggetto di contestazioni (e quindi bloccati). La fotografia che emerge è quella
di un paese vecchio, conservatore, refrattario ad ogni cambiamento. Che non
attrae investimenti perché è ideologicamente contrario al rischio d’impresa. Il
risultato, sotto gli occhi di tutti, è la tendenza allo stallo. Quella che i
sociologi definiscono “la tirannia dello status quo”, cioè dello stato di
fatto, quasi sempre insoddisfacente e non preferito da nessuno. A forza di "no"
a prescindere, veti politici e pesanti overdosi di burocrazia siamo riusciti
(senza grandi sforzi) a far scappare anche le imprese straniere. La statistica è
piuttosto deprimente: gli investimenti internazionali nella penisola valgono 337
miliardi, la metà di quelli fatti in Spagna e solo l’1,4% del pil, un terzo in
meno di Francia e Germania. Un caso per tutti, raccontato da Ernesto Galli Della
Loggia. L’ex magistrato Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, città assurta
come zimbello mondiale della mala gestione dei rifiuti, si è insediato come
politico “nuovo”, “diverso”, “portatore della rivoluzione”. Poi, dicendo “no” ai
termovalorizzatori per puntare solo sulla raccolta differenziata, al molo 44
Area Est del porto partenopeo, ha benedetto l’imbarco di 3 mila tonn di
immondizia cittadina sulla nave olandese “Nordstern” che, al prezzo di 112 euro
per tonn, porterà i rifiuti napoletani nel termovalorizzatore di Rotterdam. Dove
saranno bruciati e trasformati in energia termica ed elettrica, a vantaggio
delle sagge collettività locali che il termovalorizzatore hanno voluto. Ma senza
andare lontano De Magistris avrebbe potuto pensare al termovalorizzatore di
Brescia, dove pare che gli abitanti non abbiano l’anello al naso. Scrive Galli
Della Loggia: “Troppo spesso questo è anche il modo in cui, da tempo, una
certa ideologia verde cavalca demagogicamente paure e utopie, senza
offrire alcuna alternativa reale, ma facendosi bella nel proporre soluzioni che
non sono tali”.
«C’è un
disegno, che lacera, scoraggia e divide e quindi è demoniaco, al quale non
dobbiamo cedere nonostante esempi e condotte disoneste, che approfittano del
denaro, del potere, della fiducia della gente, perfino della debolezza e delle
paure. E’ quello di dipingere il nostro Paese come una palude fangosa dove tutto
è insidia, sospetto, raggiro e corruzione. - Aprendo i lavori del parlamentino
dei vescovi italiani del 27-30 gennaio 2014 , il presidente della Cei, Angelo
Bagnasco, rassicura sulla tenuta morale del paese e chiede a tutti – di reagire
ad una visione esasperata e interessata che vorrebbe accrescere lo smarrimento
generale e spingerci a non fidarci più di nessuno. L’Italia non è così - afferma
il cardinale - nulla – scandisce – deve rubarci la speranza nelle nostre forze
se le mettiamo insieme con sincerità. Come Pastori – rileva il porporato – non
possiamo esimerci dal dire una parola sul contesto sociale che viviamo,
consapevoli di dover dare voce a tanti che non hanno voce e volto, ma che sono
il tessuto connettivo del Paese con il loro lavoro, la dedizione, l’onestà.»
L’ITALIA
DEI COLPI DI STATO.
Letta, Renzi e
tutti i governi "non eletti". La "staffetta" non è certo una novità della
politica italiana, tra ribaltoni e svolte di ogni tipo (che durano meno di un
anno), scrive Sabino Labia su “Panorama”.
E sono tre. Stiamo parlando del terzo
governo, in tre anni o poco più, non eletto dal popolo ma creato, senza arte ne
parte, nella segreteria di un partito con l’avallo autorevole del Quirinale.
Già, perché con la nascita del governo Renzi (il sessantesimo della storia
Repubblicana) che, a suo dire, mai sarebbe andato a Palazzo Chigi senza passare
dalle urne, ma passando solo dalla sede del Pd, sembra di aver fatto l’ennesimo
tuffo nel passato. E pensare che ci eravamo convinti che questo tipo di
operazione appartenesse a una di quelle mitiche alchimie politiche che tanto
deliziavano i partiti della Prima Repubblica, quando i governi non nascevano
dalle consultazioni elettorali, ma nella segreteria della DC. E, invece, la
Seconda Repubblica e, con ogni probabilità visti i presupposti, anche la Terza
Repubblica si avvarrà della facoltà di stabilire l’inquilino di Palazzo Chigi
sulla fiducia non dei cittadini ma dei nominati e, per non farci mancare nulla,
anche dei non nominati visto che Renzi è soltanto il sindaco di Firenze. In
fondo siamo passati da Piazza del Gesù a via del Nazareno. Elencare tutte quelle
volte che, dal 1948 a oggi, si è stabilita la fine di un esecutivo, non
basterebbe un libro. Per citarne solo alcuni:
- Governo Letta (2013) composto da un'ammucchiata di centro destra e centro
sinistra, nato dopo lo sciagurato tentativo di Bersani di coinvolgere l’universo
mondo.
- Governo Monti (2011), nato dopo il Friedman-gate dello spread che inseguiva
Berlusconi.
- Governo D’Alema (1998), nato dopo il boicottaggio/sabotaggio al primo governo
Prodi.
- Governo Dini (1995), nato dopo il ribaltone della Lega, alleata di Berlusconi.
- Governo Ciampi (1993), dopo il sacco dei conti correnti del governo D’Amato.
- Governo De Mita (1988), nato come la vera e unica staffetta, quella con il
governo Craxi.
- Governi Rumor/Colombo (1970), Tra l’agosto del 1969 e l’agosto 1970 si ebbe il
record di crisi e governi, ben quattro. Ma quelli erano anni veramente
difficili.
- Governo Tambroni (1960), nato dopo la decisione presa all’interno della
segreteria della Dc di far cadere il governo Segni.
E, proprio in questa occasione, il 25 febbraio 1960 il presidente del Senato,
Cesare Merzagora, pronunciò a Palazzo Madama un durissimo discorso contro il
Parlamento attaccando i partiti che sostenevano la maggioranza che, nel chiuso
delle segreterie, avevano stabilito di far cadere il secondo Governo presieduto
da Antonio Segni sostituendolo con un esecutivo guidato da Tambroni. Per di più,
Segni, aveva deciso di dimettersi senza fare alcun passaggio dalle Camere.
“Se i partiti politici, all’interno dei loro organi statutari, dovessero
prendere le decisioni più gravi sottraendole ai rappresentanti del popolo, tanto
varrebbe - lo dico, naturalmente, per assurdo – trasformare il Parlamento in un
ristretto comitato esecutivo. Risparmieremmo tempo e denaro…". Se poi
vogliamo aggiungere un po’ di statistica abbinata alla scaramanzia, che come si
sa in Italia non guasta mai, ebbene tutti questi governi non hanno mai avuto una
durata superiore a un anno. Prepariamoci ad aggiornare il pallottoliere.
Il Colpo di Stato continua: Renzi sarà il 27mo premier non eletto dal Popolo,
scrive Giovanni De Mizio su “Ibtimes”. Mentre continua la sfilata di volti noti
e meno noti della politica italiana nel palazzo del Quirinale per le
consultazioni del presidente della (ancora per poco) Repubblica Giorgio "Primo"
Napolitano e mentre Matteo Renzi, primo ministro in pectore, si riscalda a bordo
campo facendo stretching in Piazza della Signoria a Firenze prima di recarsi (a
piedi) a Roma, la politica al di fuori del Palazzo continua a rimarcare che il
futuro ex-sindaco di Firenze sarà il terzo premier di seguito a non essere stato
eletto dal popolo, e come tale privo di legittimazione democratica. Si
tratta di un argomento, tuttavia, errato: Renzi non sarà il terzo, bensì il
ventisettesimo premier scelto senza mandato popolare a legittimarlo. È
un colpo di stato, senza dubbio alcuno, e, a giudicare dalla storia d'Italia del
dopoguerra, si tratta di un colpo di stato che parte da lontano, con il chiaro
intento di rovesciare la Repubblica per restaurare la Monarchia così come era
prima dello Statuto Albertino, possibilmente completando lo svuotamento del
Parlamento in atto già da diversi anni. Ne è la prova, fra le altre cose,
la volontà di Renzi di mutare il Senato in una camera a parziale nomina regia,
pardon, presidenziale. Il colpo di stato attualmente in atto nasce
probabilmente a metà degli anni Cinquanta quando, nel corso della Seconda
legislatura, si successero ben sei presidenti del Consiglio: De Gasperi, Pella,
Fanfani, Scelba, Segni e Zoli. Curiosità: le elezioni si tennero in base alla
legge elettorale "truffa" del 1953, che la Corte Costituzionale avrebbe potuto
censurare (oppure no), se solo fosse stata istituita (sarebbe "nata" solo nel
1956). Tralasciando De Gasperi (che fallì nell'ottenere la fiducia a causa delle
forze monarchiche, carbonare e amatriciane), il primo premier della seconda
legislatura, Giuseppe Pella, è dichiaratamente un presidente tecnico,
come lo è stato Mario Monti (entrambi, tra l'altro, sono stati ministri
degli Esteri e del Bilancio ad interim, a confermare che il complotto, come la
Storia, si ripete), e la sua squadra di governo era formata da numerosi ministri
altrettanto tecnici. Siamo nel 1953 e Pella ha più o meno la stessa età che
avrebbe avuto Monti anni più tardi: dubitiamo sia una coincidenza.
Nel gennaio 1954 è Amintore Fanfani ad essere incaricato di formare un governo:
anche Fanfani non aveva vinto le elezioni, neppure le primarie del
proprio partito, visto che sarebbe stato eletto segretario della DC solo nel
giugno successivo (peraltro da un congresso, e non attraverso regolari, libere e
democratiche elezioni). Il tentativo delle forze reazionarie, comunque,
non va a buon fine, poiché Fanfani non riesce a ottenere la fiducia. Un brutto
presagio per il governo Renzi? Lo sapremo nei prossimi giorni. Ciò che avvenne
dopo è ancora più disarmante: Mario Scelba riuscì poi a formare un governo, ma
fu sostituito da Mario Segni quando fu eletto presidente della Repubblica
Giovanni Gronchi, grazie ai voti, guarda caso, dei monarchici.
La Storia si ripeterà, abbastanza simile, anche in seguito, con il governo
Tambroni. Ma gli esempi sono tanti anche nella storia successiva: le
staffette e la nomina di presidenti del Consiglio che non hanno vinto le
elezioni sono state a lungo una regola della Repubblica italiana, a
testimonianza del fatto che si tratta di un tentativo ultradecennale di
spogliare il popolo dei suoi diritti; basti pensare al fatto che in Italia
vi sono stati 62 governi in 18 legislature (una media di 3,44 governi a
legislatura), presieduti da 26 presidenti del consiglio (2,39 governi per
premier). Solo due presidenti del Consiglio sono rimasti in carica (in
più governi) dalle elezioni fino alla scadenza naturale della legislatura: De
Gasperi e
Berlusconi.
Ciò dimostra non certo che il ricambio degli inquilini di palazzo Chigi
è fisiologico data la natura del sistema politico italiano nonché il dettato
costituzionale (sempre formalmente rispettato), bensì che il complotto
per il ripristino della Monarchia in Italia ha più forza di quanto si pensi. Da
dove nasce l'equivoco? Nasce dal fatto che, secondo la Costituzione, il
presidente del Consiglio è nominato dal presidente della Repubblica e deve avere
la fiducia delle Camere. Il popolo elegge il Parlamento ed è questi che decide
se una persona può essere o meno il presidente del Consiglio, e può anche
togliergli la fiducia per darla a un'altra persona, sempre nominata dal Capo
dello Stato. I Padri Costituenti hanno insomma tolto al popolo il
diritto di eleggere il proprio presidente del Consiglio sin dalla nascita della
Repubblica: a ben guardare, insomma, la Repubblica italiana ha avuto
ventisei presidenti del Consiglio (su ventisei) non eletti dal popolo, e Renzi,
pertanto, si avvia ad essere non il terzo, bensì il ventisettesimo perpetuatore
di questa ignobile tradizione che ormai da oltre sessant'anni infanga
l'articolo 1 della Costituzione, secondo la quale, al secondo comma, la
sovranità appartiene al Popolo, che viene sottratta ad ogni legislatura.
Il complotto, insomma, continua. Nota per chi non se ne fosse
accorto. Il presente articolo ha un chiaro intento satirico:
l'articolo 1 della Costituzione prevede che la sovranità popolare sia esercitata
nelle forme e nei limiti della Costituzione stessa.
La carta fondamentale prevede che il presidente del Consiglio non abbia
legittimazione popolare (non è eletto dal popolo), poiché l'Italia è una
Repubblica parlamentare, ovvero il popolo è sovrano attraverso il Parlamento e
non attraverso altri organi, men che meno monocratici. Asserire una presunta
incostituzionalità (o peggio) delle nomine di Monti, Letta e (eventualmente)
Renzi significa ignorare la storia d'Italia, la sua Costituzione e spingere
(ulteriormente) verso un pericoloso presidenzialismo populista privo di un
adeguato sistema di pesi e contrappesi che eviti derive ancora peggiori di
quelle che l'Italia sta sperimentando da una trentina di anni, ovvero più o meno
da quando il declino del Belpaese ha impiantato i propri semi nella penisola.
Con questo non vogliamo dire che il presidenzialismo sia un male, ma solo che è
necessario modificare l'equilibrio costituzionale per evitare gravi storture e
menomazioni della democrazia italiana (come avvenute, per altre ragioni, negli
ultimi decenni di quasi-presidenzialismo de facto). In sintesi. Un presidente
del Consiglio (nella pienezza dei propri poteri) è tale se, e solo fin quando,
ha la fiducia di una maggioranza parlamentare: solo per rifarsi alla storia
recente,
Berlusconi
è caduto nel novembre 2011 perché ad ottobre, benché non sfiduciato, non aveva
più una maggioranza in Parlamento, tanto che il rendiconto dello Stato fu
approvato solo grazie all'assenza delle opposizioni; stesso discorso per Monti,
che ha perso la fiducia dopo l'uscita dalla maggioranza del PDL, e per Letta,
che ha perso l'appoggio del suo stesso partito, il PD. Queste situazioni sono
state una costante nella storia italiana, se si considera che la prima crisi di
governo scoppiata in Parlamento risale al primo governo Prodi: in tutti gli
altri casi (tranne il Prodi II) la crisi si è sempre consumata fuori dal
Parlamento. Allo stesso modo è stata rispettata la Costituzione nella formazione
dei governi che si sono via via succeduti negli anni. La staffetta può non
piacere, ma ciò che sta accadendo in queste ore è la regola, non l'eccezione, e
che soprattutto
si sta rispettando il dettato democratico espresso dalla
Costituzione che tanti difensori all'amatriciana della Carta stessa continuano a
dimenticare
(così come non viola la Costituzione il non presentarsi alle consultazioni del
Capo dello Stato). E provoca un senso di vergogna essere costretti a ripetere
l'ovvio per via di una diffusa ignoranza delle regole costituzionali anche da
chi dovrebbe conoscerle a memoria viste le poltrone su cui sono seduti.
L'ignoranza è forza, pare.
Sono giorni
che su Internet e nel Paese reale, il popolo protesta perché Renzi andrà a
Palazzo Chigi senza elezioni, scrive Fabio Brinchi Giusti su “L’Inkiesta”. “Ma
il premier non dovremmo eleggerli noi?” Si domanda la gente mormorando rabbiosa
contro la democrazia scippata. A volte non sono solo le persone comuni, a volte
si uniscono al coro anche coloro che dovrebbero aiutarli a capire come
giornalisti e politici. “No ai premier nominati” “Il popolo deve scegliere” e
magari per gettare benzina sul fuoco, si urla anche al golpe. Il guaio che è
spesso le voci che urlano contro i governi non-eletti sono le stesse che poi
urlano “Giù le mani dalla Costituzione” e “La Costituzione non si tocca”. Ma per
difenderla la Costituzione prima andrebbe perlomeno letta. E capirla. Perché è
la Costituzione ad aver dato all’Italia un sistema dove il Presidente del
Consiglio non viene eletto dal popolo. Il popolo elegge il Parlamento e vota i
partiti. Dopo le elezioni i partiti eletti vanno dal Presidente della Repubblica
e il Presidente della Repubblica sulla base delle indicazioni ricevute nomina il
Presidente del Consiglio. Se quest’ultimo perde il consenso della maggioranza
dei parlamentari cade e il gioco di cui sopra si ripete. I partiti vanno dal
Capo dello Stato e il Capo dello Stato cerca un nuovo nome (oppure lo stesso se
quest’ultimo è in grado di riunire di nuovo una maggioranza). Se non si trova un
nome si va ad elezioni anticipate. In tutto questo sistema il popolo non ha voce
in capitolo. O meglio lo ha indirettamente tramite i suoi rappresentanti, ma non
attraverso votazioni! È così dal 1948, anzi è così da sempre perché a livello
nazionale il nostro Paese non ha mai conosciuto l’elezione diretta del capo del
Governo. A partire dagli anni ’90 una serie di riforme ha introdotto l’elezione
diretta dei sindaci o poi dei leader degli enti locali e il passaggio alla legge
elettorale maggioritaria (il cosiddetto Mattarellum poi abolito nel 2005) ha
favorito questa tendenza anche a livello nazionale dove le coalizioni di
centrodestra e centrosinistra si sono sempre presentate agli elettori guidate da
un leader-candidato che in caso di vittoria è poi andato a Palazzo Chigi. Ma non
essendo cambiata la Costituzione, di fatto, la scelta del Presidente del
Consiglio è rimasto un potere nelle mani del Parlamento e del Presidente della
Repubblica. E gli elettori sulla scheda elettorale hanno continuato a sbarrare
il simbolo di un partito e non il nome di una persona. I governi in Italia si
formano così e dunque è perfettamente costituzionale e legittimo la nascita di
un governo non votato dagli elettori. Lo è anche se si regge su una maggioranza
completamente modificata da cambi di casacca e voltagabbana vari. Se non vi
piace questo sistema, pensateci la prossima volta che urlate: “La Costituzione
non si cambia!”.
PER LA
TUTELA DEI DIRITTI DEGLI INDIGENTI. PRO BONO PUBLICO OBBLIGATORIO.
«Non è
possibile che nel 2014 gli indigenti muoiano per i denti o sono detenuti pur
innocenti. Se i comunisti da 70 anni non lo hanno ancora fatto, propongo io la
panacea di questi mali.»
Così afferma
il dr Antonio Giangrande, noto saggista di fama mondiale e presidente
dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, sodalizio antimafia riconosciuto dal
Ministero dell’Interno. Associazione fuori dal coro e fuori dai circuiti
foraggiati dai finanziamenti pubblici.
«Al fine di
rendere effettivo l’accesso ai servizi sanitari e legali a tutti gli indigenti,
senza troppi oneri per le categorie professionali interessate, presento ai
parlamentari, degni di questo incarico, questa mia proposta di legge:
PER LA TUTELA
DEI DIRITTI DEGLI INDIGENTI
PRO BONO
PUBLICO OBBLIGATORIO
“Per tutelare
i diritti dei non abbienti si obbliga, a mo' di PRO BONO PUBLICO, gli esercenti
un servizio di pubblica necessità, ai sensi dell'art.359 c.p., a destinare il 20
% della loro attività o volume di affari al servizio gratuito a favore degli
indigenti.
E' indigente
chi percepisce un reddito netto mensile non maggiore di 1.000 euro, rivalutato
annualmente in base all’inflazione.
L'onere ricade
sulla collettività, quindi, ai fini fiscali e contributivi, ogni attività pro
bono publico, contabilizzata con il minimo della tariffa professionale, è
dedotta dal reddito complessivo.
Le attività
professionali svolte in favore degli indigenti sono esentati da ogni tributo o
tassa o contributo.
Sono abrogate
le disposizioni di legge o di regolamenti incompatibili con la presente legge.”
NON VI
REGGO PIU’.
Il testo più
esplicito e diretto di Rino dà il titolo all'album uscito nel 1978.
"Nuntereggaepiù" è un brillante catalogo dei personaggi che invadono radio,
televisioni e giornali. Clamorosa la coincidenza con quello che succederà nel
1981, quando la magistratura scopre la lista degli affiliati alla P2 di Licio
Gelli, loggia massonica in cui compaiono alcuni nomi citati nella filastrocca di
Rino.
A dispetto del
titolo, nel brano non c'è un briciolo di reggae. Il titolo gioca sull'assonanza
fra il genere musicale giamaicano e la coniugazione romanesca del verbo reggere.
Come già era accaduto in "Mio fratello è figlio unico", il finale è dissonante
rispetto al tema trattato, con l'introduzione di una frase d'amore:
" E allora
amore mio ti amo
Che bella sei
Vali per sei
Ci giurerei. "
È uno sfottò
come un altro per dire: "Vabbè, visto che vi ho detto tutte 'ste cose, visto che
tanto la canzone non fa testo politico, la canzone non è un comizio, il
cantautore non è Berlinguer né Pannella, allora a questo punto hanno ragione
quelli che fanno solo canzoni d'amore..". Possiamo immaginare che, oggi,
sarebbero entrati di diritto nella filastrocca Umberto Bossi o Antonio Di Pietro
per la politica, Fabio Fazio e Maria De Filippi o il Grande Fratello per la
tivvù, calciatori super pagati come Totti, Vieri e Del Piero e chissà quante
altre invadenti presenze del nostro quotidiano destinate a ronzarci intorno per
altri vent'anni. Quando incide la versione spagnola, che in ottobre scala le
classifiche spagnole, "Corta el rollo ya" ("Dacci un taglio”), inserisce
personaggi di spicco dell'attualità iberica, come il politico Santiago Carrillo,
il calciatore Pirri (che più avanti sarà vittima di un rapimento), la soubrette
Susana Estrada e altri.
Qui sta la grandezza di Rino Gaetano, se leggete oggi il testo di "Nun te reggae
più" vi accorgerete che i personaggi citati sono quasi tutti ancora sulla
breccia e, se scomparsi o ritirati dalla vita pubblica, hanno lasciato un segno
indelebile nel loro campo, si pensi a Gianni Brera o all'avvocato Agnelli, o a
Enzo Bearzot che, un anno dopo la dipartita del cantautore calabrese, regalerà
con la sua nazionale (Causio, Tardelli, Antognoni) il terzo mondiale di calcio
dopo quarantaquattro anni.
Abbasso e Alè
(nun te reggae più)
Abbasso e Alè
(nun te reggae più)
Abbasso e Alè
con le canzoni
senza patria o
soluzioni
La castità
(Nun te reggae più)
La verginità
(Nun te reggae più)
La sposa in
bianco, il maschio forte,
i ministri
puliti, i buffoni di corte
..Ladri di
polli
Super-pensioni
(Nun te reggae più)
Ladri di stato
e stupratori
il grasso
ventre dei commendatori,
diete
politicizzate,
Evasori
legalizzati, (Nun te reggae più)
Auto blu,
sangue blu,
cieli blu,
amori blu,
Rock & blues
(Nun te reggae più!)
Eja-eja alalà,
(Nun te reggae più)
DC-PSI (Nun te
reggae più)
DC-PCI (Nun te
reggae più)
PCI-PSI,
PLI-PRI
DC-PCI, DC DC
DC DC
Cazzaniga,
(nun te reggae più)
avvocato
Agnelli,
Umberto
Agnelli,
Susanna
Agnelli, Monti Pirelli,
dribbla Causio
che passa a Tardelli
Musiello,
Antognoni, Zaccarelli.. (nun te reggae più)
..Gianni
Brera,
Bearzot, (nun
te reggae più)
Monzon,
Panatta, Rivera, D'Ambrosio
Lauda, Thoeni,
Maurizio Costanzo, Mike Bongiorno,
Villaggio,
Raffà e Guccini..
Onorevole
eccellenza
Cavaliere
senatore
nobildonna,
eminenza
monsignore,
vossia
cheri, mon
amour!.. (Nun te reggae più!)
Immunità
parlamentare (Nun te reggae più!)
abbasso e alè!
Il numero
cinque sta in panchina
si e' alzato
male stamattina
– mi sia
consentito dire: (nun te reggae più!)
Il nostro è un
partito serio.. (certo!)
disponibile al
confronto (..d'accordo)
nella misura
in cui
alternativo
alieno a ogni compromess..
Ahi lo stress
Freud e il
sess
è tutto un
cess
si sarà la
ress
Se
quest'estate andremo al mare
soli soldi e
tanto amore
e vivremo nel
terrore
che ci rubino
l'argenteria
è più prosa
che poesia...
Dove sei tu?
Non m'ami più?
Dove sei tu?
Io voglio, tu
Soltanto tu,
dove sei tu? (Nun te reggae più!)
Uè paisà
(..Nun te reggae più)
il bricolage,
il '15-18, il
prosciutto cotto,
il '48, il
'68, le P38
sulla spiaggia
di Capo Cotta
(Cardin
Cartier Gucci)
Portobello,
illusioni,
lotteria,
trecento milioni,
mentre il
popolo si gratta,
a dama c'è chi
fa la patta
a sette e
mezzo c'ho la matta..
mentre vedo
tanta gente
che non ha
l'acqua corrente
e nun c'ha
niente
ma chi me
sente? ma chi me sente?
E allora amore
mio ti amo
che bella sei
vali per sei
ci giurerei
ma è meglio
lei
che bella sei
che bella lei
vale per sei
ci giurerei
sei meglio tu
nun te reg più
che bella si
che bella no
nun te reg
più!
NUN TE REGGAE
PIÙ, NUN TE REGGAE PIÙ, NUN TE REGGAE PIÙ...
LA LIBERTA'
Giorgio Gaber (1972)
Vorrei essere
libero, libero come un uomo.
Vorrei essere
libero come un uomo.
Come un uomo
appena nato che ha di fronte solamente la natura
e cammina
dentro un bosco con la gioia di inseguire un’avventura,
sempre libero
e vitale, fa l’amore come fosse un animale,
incosciente
come un uomo compiaciuto della propria libertà.
La libertà non
è star sopra un albero,
non è neanche
il volo di un moscone,
la libertà non
è uno spazio libero,
libertà è
partecipazione.
Vorrei essere
libero, libero come un uomo.
Come un uomo
che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia
e che trova
questo spazio solamente nella sua democrazia,
che ha il
diritto di votare e che passa la sua vita a delegare
e nel farsi
comandare ha trovato la sua nuova libertà.
La libertà non
è star sopra un albero,
non è neanche
avere un’opinione,
la libertà non
è uno spazio libero,
libertà è
partecipazione.
La libertà non
è star sopra un albero,
non è neanche
il volo di un moscone,
la libertà non
è uno spazio libero,
libertà è
partecipazione.
Vorrei essere
libero, libero come un uomo.
Come l’uomo
più evoluto che si innalza con la propria intelligenza
e che sfida la
natura con la forza incontrastata della scienza,
con addosso
l’entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo
e convinto che
la forza del pensiero sia la sola libertà.
La libertà non
è star sopra un albero,
non è neanche
un gesto o un’invenzione,
la libertà non
è uno spazio libero,
libertà è
partecipazione.
La libertà non
è star sopra un albero,
non è neanche
il volo di un moscone,
la libertà non
è uno spazio libero,
libertà è
partecipazione.
“LIBERTÀ È
PARTECIPAZIONE” – Dal testo di Gaber alla
realtà che ci circonda.
Così cantava
il mitico Gaber in una delle sue canzoni “La libertà non è star sopra un
albero, non è neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione.” Come rispondereste alla domanda “chi è colui che
può definirsi libero?”, certamente molti diranno subito “colui
che può fare ciò che vuole, esprimere le proprie opinioni,
manifestare la propria fede e via discorrendo” … invece non proprio. Non
proprio perché questa sarebbe anarchia o per lo meno la rasenterebbe; per capire
meglio il significato di tale termine, allora, prendiamo in esame la frase di
Gaber libertà è partecipazione: partecipare, filologicamente
inteso significa “essere parte di …” e quindi essere inseriti in un dato
contesto. Libertà non è dunque dove non esistono limitazioni ma bensì
dove queste vigono in maniera armoniosa e, naturalmente, non oppressiva. Posso
capire che la cosa strida a molti ma se analizzata in maniera posata si potrà
evincere come una società senza regole sia l’antitesi di sé stessa.
Dove sta la libertà, allora? Innanzitutto comincerei parlando di rispetto:
rispetto per l’altro, per le sue idee, per la sua persona:
se non ci rispettiamo vicendevolmente non otterremo mai un vivere civile e
quindi alcuna speranza di libertà. La libertà è un diritto innegabile.
Chi ha il diritto di stabilire quali libertà assegnare a chi? Pensiamo
agli schiavi di ieri e , purtroppo, anche di oggi: perché negare loro le
libertà? Per la pigrizia di chi gliele nega, chiaramente; su questo si basa il
rapporto padrone-schiavo (anche quello hegeliano del servo-padrone), sulla forza
ed il terrore, terrore non dell’asservito ma del servito. Dall’Antichità al
Medioevo, dal Rinascimento ad oggi gli uomini hanno sempre tentato di esercitare
la propria egemonia sugli altri, secondo diritti divini, di nobiltà di natali,
tramite l’ostentazione della propria condizione economica e via discorrendo,
falciando così in pieno il diritto alla libertà di alcuni. “Libertà è
partecipazione”, tale frase continua a ronzarmi in testa e mi sprona ad
esortare: rispettiamoci per essere liberi… a tali parole mi sovviene la seconda
strofa del nostro inno nazionale (di cui pochi, ahime, conoscono
l’esistenza, poiché molti ritengono che il nostro inno sia costituito d’una sola
strofa):
“Noi
fummo da secoli
calpesti, derisi,
perché non siam popolo,
perché siam divisi.
Raccolgaci un’unica bandiera,
una speme:
di fonderci insieme
già l’ora suonò.”
e quindi
l’invito della terza strofa: “Uniamoci, amiamoci”
Dignità,
rispetto dell’altro, partecipazione,
lievi seppur necessarie limitazioni: questi sono gli ingredienti per
un’ottima ricetta di libertà, non certo paroloni da politicanti come “lotta alla
criminalità”, “lotta all’evasione fiscale”, “lotta alle cricche”,
giusto per citare le più quotate in questi ultimi tempi. La libertà
necessita di semplicità, non certo di pompose cerimonie: essa è bella come
una ragazza a quindici-sedici anni (o per lo meno, rifacendomi allo
Zibaldone leopardiano), tutta acqua e sapone e sempre con un
sorriso gentile pronto per tutti. Forse è anche per questo che gli uomini
raffigurano la Libertà come una giovane donna…!
IO SE FOSSI
DIO di Giorgio Gaber – 1980
Io se fossi
Dio
E io potrei
anche esserlo
Se no non vedo
chi.
Io se fossi
Dio non mi farei fregare dai modi furbetti della gente
Non sarei mica
un dilettante
Sarei sempre
presente
Sarei davvero
in ogni luogo a spiare
O meglio
ancora a criticare, appunto
Cosa fa la
gente.
Per esempio il
cosiddetto uomo comune
Com'è noioso
Non commette
mai peccati grossi
Non è mai
intensamente peccaminoso.
Del resto
poverino è troppo misero e meschino
E pur sapendo
che Dio è il computer più perfetto
Lui pensa che
l'errore piccolino
Non lo veda o
non lo conti affatto.
Per questo io
se fossi Dio
Preferirei il
secolo passato
Se fossi Dio
rimpiangerei il furore antico
Dove si amava,
e poi si odiava
E si ammazzava
il nemico.
Ma io non sono
ancora nel regno dei cieli
Sono troppo
invischiato nei vostri sfaceli.
Io se fossi
Dio
Non sarei mica
stato a risparmiare
Avrei fatto un
uomo migliore.
Si, vabbè, lo
ammetto
non mi è
venuto tanto bene
ed è per
questo, per predicare il giusto
che io ogni
tanto mando giù qualcuno
ma poi alla
gente piace interpretare
e fa ancora
più casino.
Io se fossi
Dio
Non avrei
fatto gli errori di mio figlio
E specialmente
sull'amore
Mi sarei
spiegato un po' meglio.
Infatti voi
uomini mortali per le cose banali
Per le cazzate
tipo compassione e finti aiuti
Ci avete
proprio una bontà
Da vecchi un
po' rincoglioniti.
Ma come siete
buoni voi che il mondo lo abbracciate
E tutti che
ostentate la vostra carità.
Per le
foreste, per i delfini e i cani
Per le
piantine e per i canarini
Un uomo oggi
ha tanto amore di riserva
Che neanche se
lo sogna
Che vien da
dire
Ma poi coi
suoi simili come fa ad essere così carogna.
Io se fossi
Dio
Direi che la
mia rabbia più bestiale
Che mi fa
male e che mi porta alla pazzia
È il vostro
finto impegno
È la vostra
ipocrisia.
Ce l'ho che
per salvare la faccia
Per darsi un
tono da cittadini giusti e umani
Fanno passaggi
pedonali e poi servizi strani
E tante altre
attenzioni
Per
handicappati sordomuti e nani.
E in queste
grandi città
Che scoppiano
nel caos e nella merda
Fa molto
effetto un pezzettino d'erba
E tanto spazio
per tutti i figli degli dèi minori.
Cari
assessori, cari furbastri subdoli altruisti
Che usate gli
infelici con gran prosopopea
Ma io so che
dentro il vostro cuore li vorreste buttare
Dalla rupe
Tarpea.
Ma io non sono
ancora nel regno dei cieli
Sono troppo
invischiato nei vostri sfaceli.
Io se fossi
Dio maledirei per primi i giornalisti e specialmente tutti
Che certamente
non sono brave persone
E dove cogli,
cogli sempre bene.
Signori
giornalisti, avete troppa sete
E non sapete
approfittare della libertà che avete
Avete ancora
la libertà di pensare, ma quello non lo fate
E in cambio
pretendete
La libertà di
scrivere
E di
fotografare.
Immagini
geniali e interessanti
Di presidenti
solidali e di mamme piangenti
E in questo
mondo pieno di sgomento
Come siete
coraggiosi, voi che vi buttate senza tremare un momento:
Cannibali,
necrofili, deamicisiani, astuti
E si direbbe
proprio compiaciuti
Voi vi buttate
sul disastro umano
Col gusto
della lacrima
In primo
piano.
Si, vabbè, lo
ammetto
La scomparsa
totale della stampa sarebbe forse una follia
Ma io se fossi
Dio di fronte a tanta deficienza
Non avrei
certo la superstizione
Della
democrazia.
Ma io non sono
ancora nel regno dei cieli
Sono troppo
invischiato nei vostri sfaceli.
Io se fossi
Dio
Naturalmente
io chiuderei la bocca a tanta gente.
Nel regno dei
cieli non vorrei ministri
Né gente di
partito tra le palle
Perché la
politica è schifosa e fa male alla pelle.
E tutti quelli
che fanno questo gioco
Che poi è un
gioco di forze ributtante e contagioso
Come la febbre
e il tifo
E tutti quelli
che fanno questo gioco
C' hanno certe
facce
Che a vederle
fanno schifo.
Io se fossi
Dio dall'alto del mio trono
Direi che la
politica è un mestiere osceno
E vorrei dire,
mi pare a Platone
Che il
politico è sempre meno filosofo
E sempre più
coglione.
È un uomo a
tutto tondo
Che senza mai
guardarci dentro scivola sul mondo
Che scivola
sulle parole
E poi se le
rigira come lui vuole.
Signori dei
partiti
O altri
gregari imparentati
Non ho nessuna
voglia di parlarvi
Con toni
risentiti.
Ormai le
indignazioni son cose da tromboni
Da guitti un
po' stonati.
Quello che
dite e fate
Quello che
veramente siete
Non merita
commenti, non se ne può parlare
Non riesce più
nemmeno a farmi incazzare.
Sarebbe come
fare inutili duelli con gli imbecilli
Sarebbe come
scendere ai vostri livelli
Un gioco così
basso, così atroce
Per cui il
silenzio sarebbe la risposta più efficace.
Ma io sono un
Dio emotivo, un Dio imperfetto
E mi dispiace
ma non son proprio capace
Di tacere del
tutto.
Ci son delle
cose
Così tremende,
luride e schifose
Che non è
affatto strano
Che anche un
Dio
Si lasci
prendere la mano.
Io se fossi
Dio preferirei essere truffato
E derubato, e
poi deriso e poi sodomizzato
Preferirei la
più tragica disgrazia
Piuttosto che
cadere nelle mani della giustizia.
Signori
magistrati
Un tempo così
schivi e riservati
Ed ora con la
smania di essere popolari
Come cantanti
come calciatori.
Vi vedo così
audaci che siete anche capaci
Di metter
persino la mamma in galera
Per la vostra
carriera.
Io se fossi
Dio
Direi che è
anche abbastanza normale
Che la
giustizia si amministri male
Ma non si
tratta solo
Di corruzioni
vecchie e nuove
È proprio un
elefante che non si muove
Che
giustamente nasce
Sotto un segno
zodiacale un po' pesante
E la bilancia
non l'ha neanche come ascendente.
Io se fossi
Dio
Direi che la
giustizia è una macchina infernale
È la follia,
la perversione più totale
A meno che non
si tratti di poveri ma brutti
Allora si che
la giustizia è proprio uguale per tutti.
Io se fossi
Dio
Io direi come
si fa a non essere incazzati
Che in
ospedale si fa morir la gente
Accatastata
tra gli sputi.
E intanto nel
palazzo comunale
C'è una bella
mostra sui costumi dei sanniti
In modo tale
che in questa messa in scena
Tutto si
addolcisca, tutto si confonda
In modo tale
che se io fossi Dio direi che il sociale
È una schifosa
facciata immonda.
Ma io non sono
ancora nel regno dei cieli
Sono troppo
invischiato nei vostri sfaceli.
Io se fossi
Dio
Vedrei
dall'alto come una macchia nera
Una specie di
paura che forse è peggio della guerra
Sono i
soprusi, le estorsioni i rapimenti
È la camorra.
È l'impero
degli invisibili avvoltoi
Dei pescecani
che non si sazian mai
Sempre
presenti, sempre più potenti, sempre più schifosi
È l'impero dei
mafiosi.
Io se fossi
Dio
Io griderei
che in questo momento
Son proprio
loro il nostro sgomento.
Uomini seri e
rispettati
Cos'ì normali
e al tempo stesso spudorati
Così sicuri
dentro i loro imperi
Una carezza ai
figli, una carezza al cane
Che se non
guardi bene ti sembrano persone
Persone buone
che quotidianamente
Ammazzano la
gente con una tal freddezza
Che Hitler al
confronto mi fa tenerezza.
Io se fossi
Dio
Urlerei che
questi terribili bubboni
Ormai son
dentro le nostre istituzioni
E anzi, il
marciume che ho citato
È maturato tra
i consiglieri, i magistrati, i ministeri
Alla Camera e
allo Senato.
Io se fossi
Dio
Direi che
siamo complici oppure deficienti
Che questi
delinquenti, queste ignobili carogne
Non nascondono
neanche le loro vergogne
E sono tutti i
giorni sui nostri teleschermi
E mostrano
sorridenti le maschere di cera
E sembrano
tutti contro la sporca macchia nera.
Non ce n'è
neanche uno che non ci sia invischiato
Perché la
macchia nera
È lo Stato.
E allora io se
fossi Dio
Direi che ci
son tutte le premesse
Per anticipare
il giorno dell'Apocalisse.
Con una
deliziosa indifferenza
E la mia
solita distanza
Vorrei vedere
il mondo e tutta la sua gente
Sprofondare
lentamente nel niente.
Forse io come
Dio, come Creatore
Queste cose
non le dovrei nemmeno dire
Io come
Padreterno non mi dovrei occupare
Né di violenza
né di orrori né di guerra
Né di tutta
l'idiozia di questa Terra
E cose simili.
Peccato che
anche Dio
Ha il proprio
inferno
Che è questo
amore eterno
Per gli
uomini.
IL
CONFORMISTA
di Giorgio Gaber – 1996
Io sono un
uomo nuovo
talmente nuovo
che è da tempo che non sono neanche più fascista
sono sensibile
e altruista
orientalista
ed in passato sono stato un po' sessantottista
da un po’ di
tempo ambientalista
qualche anno
fa nell'euforia mi son sentito come un po' tutti socialista.
Io sono un
uomo nuovo
per carità lo
dico in senso letterale
sono
progressista al tempo stesso liberista
antirazzista e
sono molto buono
sono
animalista
non sono più
assistenzialista
ultimamente
sono un po' controcorrente son federalista.
Il conformista
è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta,
il conformista
ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa
è un
concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani
e quando ha
voglia di pensare pensa per sentito dire
forse da buon
opportunista si adegua senza farci caso
e vive nel suo
paradiso.
Il conformista
è un uomo a tutto tondo che si muove senza consistenza,
il conformista
s'allena a scivolare dentro il mare della maggioranza
è un animale
assai comune che vive di parole da conversazione
di notte sogna
e vengon fuori i sogni di altri sognatori
il giorno
esplode la sua festa che è stare in pace con il mondo
e farsi largo
galleggiando
il conformista
il
conformista.
Io sono un
uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario
sono
femminista
son
disponibile e ottimista
europeista
non alzo mai
la voce
sono pacifista
ero
marxista-leninista e dopo un po' non so perché mi son trovato cattocomunista.
Il conformista
non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone
il conformista
aerostato evoluto che è gonfiato dall'informazione
è il risultato
di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie
poi sfiora il
mondo con un dito e si sente realizzato
vive e questo
già gli basta e devo dire che oramai
somiglia molto
a tutti noi
il conformista
il
conformista.
Io sono un
uomo nuovo
talmente nuovo
che si vede a prima vista
sono il nuovo
conformista.
Una canzone
molto ironica quella di Giorgio Gaber, un’analisi su chi sia veramente
il conformista e proprio per questo proviamo prima di tutto a capire noi
cosa sia il conformismo, perchè senza di quello non possiamo comprendere cosa ci
voglia dire Gaber con questa canzone.
Il termine
conformismo indica una tendenza a conformarsi ad opinioni, usi, comportamenti e
regole di un determinato gruppo sociale. Attenzione però qui stiamo parlando di
gruppo sociale qualunque e non per forza quello “dominante” (come in genere
molti pensano) che sarebbe anche piuttosto difficile da identificare visto che
la nostra società è molto grande, complessa ed esistono infinite sfumature.
Questo vuol dire che se apparteniamo ad un gruppo sociale che accettiamo in modo
assoluto allora siamo conformisti rispetto a quel gruppo. Il prete per esempio è
un conformista rispetto al suo gruppo sociale di preti che a loro volta fanno
riferimento al Papa. Chi per esempio appartiene ad una famiglia malavitosa e fa
il bullo a scuola insieme ad altri bulli suoi amici che disturbano, rubano ecc.
è un conformista rispetto al suo gruppo sociale di delinquenti. Molti giovani
pensano ingenuamente che conformismo vuol dire solo mettersi giacca, cravatta e
comportarsi bene, mentre anticonformismo vuol dire mettersi maglietta, jeans e
comportarsi male, ma non è così.
Con questa
canzone Gaber prende in giro il conformista, facendone notare tutte le sue
possibili caratteristiche che lo contraddistinguono e allo stesso tempo ne fa
emergere tutta una serie di contraddizioni: guardiamo per esempio alla prima
strofa in cui il conformista nel giro di pochi anni passa prima ad essere “fascista“,
per poi diventare “orientalista“, ricordandosi però di essere stato un
“sessantottista” e da tempo anche “ambientalista” e pure “socialista“!
Da subito quindi una forte critica implicita all’uomo conformista, che alla fine
continuando a cambiare idea, risulta essere tutto tranne che conformista.
Questa successione di cambio di idee improvvise, seguendo la massa a seconda di
cosa sia più comodo e non secondo ciò in cui si creda veramente, porta Gaber a
dare lui stesso la definizione del conformista moderno:
“Il conformista è uno che di
solito sta sempre dalla parte giusta,
il conformista ha tutte le
risposte belle chiare dentro la sua testa
è un concentrato di opinioni che
tiene sotto il braccio due o tre quotidiani
e quando ha voglia di pensare
pensa per sentito dire
forse da buon opportunista si
adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso”
La critica
dunque è forte, un uomo che non è quasi più in grado di pensare con la sua
testa, ma si adegua alle circostanze creandosi un mondo tutto suo in cui vivere
senza problemi e senza lotte. Ma come è abituato a fare, Gaber lancia
una frecciatina a tutti noi, perchè guardandoci in faccia, probabilmente i primi
ad essere conformisti siamo proprio noi:“e devo dire che oramai somiglia
molto a tutti noi, il conformista“.
LA
DEMOCRAZIA di Giorgio Gaber – 1997
Dopo anni di
riflessione sulle molteplici possibilità che ha uno stato di organizzarsi ho
capito che la democrazia... è il sistema più democratico che ci sia. Dunque c’è
la dittatura, la democrazia e... basta. Solo due. Credevo di più. La dittatura
chi l’ha vista sa cos’è, gli altri si devono accontentare di aver visto solo la
democrazia. lo, da quando mi ricordo, sono sempre stato democratico, non per
scelta, per nascita. Come uno che appena nasce è cattolico, apostolico, romano.
Cattolico pazienza, apostolico non so cosa sia, ma anche romano... Va be’, del
resto come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario c’è scritto che
la parola "democrazia" deriva dal greco e significa "potere al popolo".
L’espressione è poetica e suggestiva. Sì, ma in che senso potere alta popolo?
Come si fa? Questo sul vocabolario non c’è scritto. Però si sa che dal ‘45, dopo
il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto di
voto. È nata così la “Democrazia rappresentativa” nella quale tu deleghi un
partito che sceglie una coalizione che sceglie un candidato che tu non sai chi
sia e che tu deleghi a rappresentarti per cinque anni. E che se io incontri ti
dice: “Lei non sa chi sono io!” Questo è il potere del popolo. Ma non è solo
questo. Ci sono delle forme ancora più partecipative. Per esempio il referendum
è addirittura una pratica di “Democrazia diretta”... non tanto pratica,
attraverso la quale tutti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se
mia nonna deve decidere sulla Variante di Valico Barberino-Roncobilaccio ha
qualche difficoltà. Anche perché è di Venezia. Per fortuna deve dire un “Sì” se
vuoi dire no e un “No” se vuoi dire sì. In ogni caso ha il 50% di probabilità di
azzeccarla. Comunque il referendum ha più che altro un valore folkloristico,
perché dopo aver discusso a lungo sul significato politico dei risultati tutto
resta come prima. Un altro grande vantaggio che la democrazia offre a mia nonna,
cioè al popolo, è la libertà di stampa. Nei regimi totalitari, per esempio
durante il fascismo, si chiamava propaganda e tu non potevi mai sapere la
verità. Da noi si chiama “informazione”, che per maggior chiarezza ha anche il
pregio di esser pluralista. Sappiamo tutto. Sappiamo tutto, ma anche il
contrario di tutto. Pensa che bello. Sappiamo che l’Italia va benissimo, ma che
va anche malissimo. Sappiamo che l’inflazione è al 3, o al 4, o al 6, o anche al
10%. Che abbondanza! Sappiamo che i disoccupati sono il 12% e che aumentano o
diminuiscono a piacere, a seconda di chi lo dice. Sappiamo dati, numeri,
statistiche. Alla fine se io voglio sapere quanti italiani ci sono in Italia,
che faccio? Vado sulla Variante di Valico Barberino-Roncobilaccio e li conto:
Zzzz! Chi va al sud. Zzzz! Chi va al nord! Altro che Istat! Comunque è
innegabile che fra un regime totalitario e uno democratico c’è una differenza
abissale. Per esempio, durante il fascismo non ti potevi permettere di essere
antifascista. In democrazia invece si può far tutto, tranne che essere
antidemocratici. Durante il fascismo c’era un partito solo al potere. O quello o
niente. In democrazia invece i partiti al potere sono numerosi e in crescita.
Alle ultime elezioni, fra partiti, liste autonome, liste di area, gruppi misti,
eccetera, ce ne sono stati duecentoquarantotto. Più libertà di cosi si muore!
Del resto una delle caratteristiche della democrazia è che si basa
esclusivamente sui numeri… come il gioco del Lotto, anche se è meno casuale, ma
più redditizio. Più largo è il consenso del popolo, più la democrazia, o chi per
lei, ci guadagna. Quello del popolo è sempre stato un problema, per chi governa.
Se ti dà il suo consenso vuoi dire che ha capito, che è cosciente, consapevole,
e anche intelligente. Se no è scemo. Comunque l’importante è coinvolgere più
gente possibile. Intendiamoci, la democrazia non è nemica della qualità. È la
qualità che è nemica della democrazia. Mettiamo come paradosso che un politico
sia un uomo di qualità. Mettiamo anche che si voglia mantenere a livelli alti.
Quanti lo potranno apprezzare? Pochi, pochi ma buoni. No, in democrazia ci
vogliono i numeri, e che numeri. Bisogna allargare il consenso, scendere alla
portata di tutti. Bisogna adeguarsi. E un’adeguatina oggi, un’adeguatina
domani... e l’uomo di qualità a poco a poco ci prende gusto... e “tac”, un’altra
abbassatina... poi ce n’è un altro che si abbassa di più, e allora anche lui...
“tac”... “tac”... ogni giorno si abbassa di cinque centimetri. E così, quando
saremo tutti scemi allo stesso modo, la democrazia sarà perfetta.
DESTRA-SINISTRA di Giorgio Gaber – 2001
Destra-Sinistra
è un singolo di Giorgio Gaber, pubblicato nel 2001, tratto dall'album La mia
generazione ha perso.
La canzone
vuol mettere ironicamente in risalto le presunte differenze tra destra e
sinistra politiche, delle quali è una bonaria critica. Tutta la canzone verte
infatti su luoghi comuni anziché sulle differenze di tipo idealistico, ed è lo
stesso Gaber a specificare che, attualmente, le differenze fra le due parti sono
ormai minime, e che chi si definisce di una fazione rispetto ad un'altra lo fa
per mera «ideologia», e per «passione ed ossessione» di una diversità che «al
momento dove è andata non si sa». In altre parole, la differenza fra chi si
definisce di una parte piuttosto che dall'altra è solamente ostentata, ed è
nulla per quanto riguarda il lato pratico.
Tutti noi ce
la prendiamo con la storia
ma io dico che
la colpa è nostra
è evidente che
la gente è poco seria
quando parla
di sinistra o destra.
Ma cos'è la
destra cos'è la sinistra...
Ma cos'è la
destra cos'è la sinistra...
Fare il bagno
nella vasca è di destra
far la doccia
invece è di sinistra
un pacchetto
di Marlboro è di destra
di
contrabbando è di sinistra.
Ma cos'è la
destra cos'è la sinistra...
Una bella
minestrina è di destra
il minestrone
è sempre di sinistra
tutti i films
che fanno oggi son di destra
se annoiano
son di sinistra.
Ma cos'è la
destra cos'è la sinistra...
Le scarpette
da ginnastica o da tennis
hanno ancora
un gusto un po' di destra
ma portarle
tutte sporche e un po' slacciate
è da scemi più
che di sinistra.
Ma cos'è la
destra cos'è la sinistra...
I blue-jeans
che sono un segno di sinistra
con la giacca
vanno verso destra
il concerto
nello stadio è di sinistra
i prezzi sono
un po' di destra.
Ma cos'è la
destra cos'è la sinistra...
I collant son
quasi sempre di sinistra
il reggicalze
è più che mai di destra
la pisciata in
compagnia è di sinistra
il cesso è
sempre in fondo a destra.
Ma cos'è la
destra cos'è la sinistra...
La piscina
bella azzurra e trasparente
è evidente che
sia un po' di destra
mentre i
fiumi, tutti i laghi e anche il mare
sono di merda
più che sinistra.
Ma cos'è la
destra cos'è la sinistra...
L'ideologia,
l'ideologia
malgrado tutto
credo ancora che ci sia
è la passione,
l'ossessione
della tua
diversità
che al momento
dove è andata non si sa
dove non si
sa, dove non si sa.
Io direi che
il culatello è di destra
la mortadella
è di sinistra
se la
cioccolata svizzera è di destra
la Nutella è
ancora di sinistra.
Ma cos'è la
destra cos'è la sinistra...
Il pensiero
liberale è di destra
ora è buono
anche per la sinistra
non si sa se
la fortuna sia di destra
la sfiga è
sempre di sinistra.
Ma cos'è la
destra cos'è la sinistra...
Il saluto
vigoroso a pugno chiuso
è un antico
gesto di sinistra
quello un po'
degli anni '20, un po' romano
è da stronzi
oltre che di destra.
Ma cos'è la
destra cos'è la sinistra...
L'ideologia,
l'ideologia
malgrado tutto
credo ancora che ci sia
è il
continuare ad affermare
un pensiero e
il suo perché
con la scusa
di un contrasto che non c'è
se c'è chissà
dov'è, se c'é chissà dov'é.
Tutto il
vecchio moralismo è di sinistra
la mancanza di
morale è a destra
anche il Papa
ultimamente
è un po' a
sinistra
è il demonio
che ora è andato a destra.
Ma cos'è la
destra cos'è la sinistra...
La risposta
delle masse è di sinistra
con un lieve
cedimento a destra
son sicuro che
il bastardo è di sinistra
il figlio di
puttana è di destra.
Ma cos'è la
destra cos'è la sinistra...
Una donna
emancipata è di sinistra
riservata è
già un po' più di destra
ma un figone
resta sempre un'attrazione
che va bene
per sinistra e destra.
Ma cos'è la
destra cos'è la sinistra...
Tutti noi ce
la prendiamo con la storia
ma io dico che
la colpa è nostra
è evidente che
la gente è poco seria
quando parla
di sinistra o destra.
Ma cos'è la
destra cos'è la sinistra...
Ma cos'è la
destra cos'è la sinistra...
Destra-sinistra
Destra-sinistra
Destra-sinistra
Destra-sinistra
Destra-sinistra
Basta!
IO NON MI
SENTO ITALIANO di Giorgio Gaber – 2003
La canzone "Io
non mi sento italiano" è tratta dall'omonimo album uscito postumo di Giorgio
Gaber, nel gennaio 2003, titolo che all'apparenza è di forte impatto evocativo
che sa di delusione, di rabbia, di denuncia. Ma poi, per ribilanciare
l'affermazione, basta leggere la frase nel seguito, “Io non mi sento italiano,
ma per fortuna o purtroppo lo sono”, c'è un grande concetto all'interno, quello
di appartenenza, a cui Gaber è legato, che lascia trasparire la sua dolcezza,
nonostante il sentimento di sdegno di cui si fa portavoce. Stupisce, e non poco,
a distanza di anni, la modernità del testo, l'attualità delle situazioni, che
già allora Giorgio Gaber raccontava come quotidianità di quel paese, in quel
periodo storico. Album registrato poco prima della sua scomparsa, fu scritto con
Sandro Luporini, pittore di Viareggio, suo compagno di scrittura in tutte le sue
produzioni più importanti musicali e teatrali. Giorgio Gaber, è il suo nome
d'arte, si chiama in effetti Giorgio Gaberscik e nasce a Milano il 25 gennaio
1939 (scompare a Montemagno di Camaiore il 1º gennaio 2003), da padre di origine
istriane-goriziano slovene e madre veneziania. Inizia a suonare la chitarra da
bambino a 8-9 anni per curare un brutto infortunio ad un braccio. Diventa un
ottimo chitarrista e, con le serate, da grande, si pagherà gli studi
universitari. E' il 1970 l'anno della svolta artistica di Giorgio Gaber. Gaber è
celebre ma si sente “ingabbiato”, costretto a recitare un ruolo nella parte di
cantante e di presentatore televisivo. Rinuncia così alla grandissima notorietà,
si spoglia del ruolo di affabulatore e porta "la canzone a teatro" (creando il
genere del teatro canzone). Gaber si presenta al pubblico così com'è, ricomincia
da capo. Per questo crea un personaggio che non recita più un ruolo, il «Signor
G», recita se stesso. Quindi un signore come tutti, “una persona piena di
contraddizioni e di dolori”.
TESTO - Io non
mi sento italiano - parlato:
Io G. G. sono
nato e vivo a Milano.
Io non mi
sento italiano
ma per fortuna
o purtroppo lo sono.
Mi scusi
Presidente
non è per
colpa mia
ma questa
nostra Patria
non so che
cosa sia.
Può darsi che
mi sbagli
che sia una
bella idea
ma temo che
diventi
una brutta
poesia.
Mi scusi
Presidente
non sento un
gran bisogno
dell'inno
nazionale
di cui un po'
mi vergogno.
In quanto ai
calciatori
non voglio
giudicare
i nostri non
lo sanno
o hanno più
pudore.
Io non mi
sento italiano
ma per fortuna
o purtroppo lo sono.
Mi scusi
Presidente
se arrivo
all'impudenza
di dire che
non sento
alcuna
appartenenza.
E tranne
Garibaldi
e altri eroi
gloriosi
non vedo alcun
motivo
per essere
orgogliosi.
Mi scusi
Presidente
ma ho in mente
il fanatismo
delle camicie
nere
al tempo del
fascismo.
Da cui un bel
giorno nacque
questa
democrazia
che a farle i
complimenti
ci vuole
fantasia.
Io non mi
sento italiano
ma per fortuna
o purtroppo lo sono.
Questo bel
Paese
pieno di
poesia
ha tante
pretese
ma nel nostro
mondo occidentale
è la
periferia.
Mi scusi
Presidente
ma questo
nostro Stato
che voi
rappresentate
mi sembra un
po' sfasciato.
E' anche
troppo chiaro
agli occhi
della gente
che tutto è
calcolato
e non funziona
niente.
Sarà che gli
italiani
per lunga
tradizione
son troppo
appassionati
di ogni
discussione.
Persino in
parlamento
c'è un'aria
incandescente
si scannano su
tutto
e poi non
cambia niente.
Io non mi
sento italiano
ma per fortuna
o purtroppo lo sono.
Mi scusi
Presidente
dovete
convenire
che i limiti
che abbiamo
ce li dobbiamo
dire.
Ma a parte il
disfattismo
noi siamo quel
che siamo
e abbiamo
anche un passato
che non
dimentichiamo.
Mi scusi
Presidente
ma forse noi
italiani
per gli altri
siamo solo
spaghetti e
mandolini.
Allora qui mi
incazzo
son fiero e me
ne vanto
gli sbatto
sulla faccia
cos'è il
Rinascimento.
Io non mi
sento italiano
ma per fortuna
o purtroppo lo sono.
Questo bel
Paese
forse è poco
saggio
ha le idee
confuse
ma se fossi
nato in altri luoghi
poteva andarmi
peggio.
Mi scusi
Presidente
ormai ne ho
dette tante
c'è un'altra
osservazione
che credo sia
importante.
Rispetto agli
stranieri
noi ci
crediamo meno
ma forse
abbiam capito
che il mondo è
un teatrino.
Mi scusi
Presidente
lo so che non
gioite
se il grido
"Italia, Italia"
c'è solo alle
partite.
Ma un po' per
non morire
o forse un po'
per celia
abbiam fatto
l'Europa
facciamo anche
l'Italia.
Io non mi
sento italiano
ma per fortuna
o purtroppo lo sono.
Io non mi
sento italiano
ma per fortuna
o purtroppo
per fortuna o
purtroppo
per fortuna
per fortuna lo
sono.
Ci sedemmo
dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati. Ci sono
uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono più
bravi, ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono
quelli che lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili. Citazioni di
Bertolt Brecht.
Povera
Italia. Povera Calabria,
scrive Luciano regolo, direttore de “L’Ora della Calabria”.
Non sono renziano, ma neppure lettiano o berlusconiano o
alfaniano o grillino. Anzi vi confesso che non voto da un bel po', specialmente
da quando, dirigendo un settimanale nazionale popolare a vasta tiratura, ebbi
modo di toccare con mano quali e quanti mali attraversino trasversalmente i
nostri partiti e come difficilmente i vari leader del nostro scenario politico
si tirino indietro dal lobbysmo che domina in Italia. Tuttavia trovo questa
staffetta Letta-Renzi ancora più inquietante. Per mesi abbiamo sentito dire a
destra e manca che Letta doveva restare in sella per emergenze basilari nella
vita del nostro Paese, dalla crisi economica alla riforma elettorale. Ora invece
si cambia registro. Ma non si va a nuove elezioni, la volontà popolare, in tutto
questo, viene sempre più messa da parte. La scusa è che senza nuove regole per
le elezioni si rischierebbe di avere nuovamente una maggioranza troppo risicata
per garantire la stabilità governativa. Ma se non si è avuto fino ad ora quel
certo senso di responsabilità necessario per mettere da parte gli interessi e i
protagonismi personali per arrivare a questo (minimo) obiettivo perché mai le
cose dovrebbero cambiare con Renzi premier? Non sarebbe stato più equo e più
democratico chiedere agli elettori di andare alle urne, magari esercitando il
proprio diritto di voto riflettendo un po' di più, visto quello che stiamo
tuttora vivendo? Napolitano avrà pure le sue buone ragioni, anche se a volte
riesce difficile condividerle. Però, lo spazio non se l'è preso da solo, gli è
dato da tutta una situazione, da tutto un cecchinaggio diffuso e mirato al
proprio tornaconto personale. Il sospetto è che il "cancro" della voglia
sconfinata di poltrone oramai dilaghi e la faccia da padrona fino ad annientare
anche il minimo rispetto per tutte quelle famiglie italiane che stanno versando
in condizioni di gravissime difficoltà. La gente si toglie la vita per i debiti
(di qualche giorno fa la drammatica scelta dell'editore Zanardi), la gente è
disperata. Ma il palazzo continua imperterrito nelle sue logiche. E il male si
riverbera dal centro alla periferia, con le stesse modalità. La Calabria ne è un
esempio eclatante. Guerre intestine nella destra, guerre intestine a sinistra
(difficile che queste sospirate primarie del Pd siano la panacea per vecchie e
croniche conflittualità). Intanto i rifiuti ci sommergono, intanto la
'ndrangheta erode sempre più spazi della società civile, intanto la
disoccupazione lievita, al pari della malasanità. Povera Italia, povera
Calabria.
E poi c’è
lei, la fonte di tutti i mali.
Magistratura, la casta e le degenerazioni,
scrive Andrea Signini su “Rinascita”. “IMAGISTRATI SONO INCAPACI E CORROTTI, NE
CONOSCO MOLTISSIMI”. Il Presidente Francesco Cossiga (Sassari, 26 Luglio 1928 –
Roma, 17 Agosto 2010), appartenente ad una famiglia di altissimi magistrati e
lui stesso capo del Consiglio Superiore della Magistratura, intervistato dal
giornalista Vittorio Pezzuto, disse: “La maggior parte dei magistrati attuali
sono totalmente ignoranti a cominciare dall’amico Di Pietro che un giorno mi
disse testualmente: “Cosa vuoi, appena mi sarò sbrigato questi processi, mi
leggerò il nuovo codice di procedura penale”. Nel corso della medesima
intervista Cossiga sottolineava le scadenti qualità dei membri della
magistratura, li definiva “incapaci a fare le indagini”. Da Presidente della
Repubblica inviò i carabinieri a Palazzo dei Marescialli. Accadde nel 91, il 14
novembre, quando il presidente-picconatore ritirò la convocazione di una
riunione del plenum nella quale erano state inserite cinque pratiche sui
rapporti tra capi degli uffici e loro sostituti sull’assegnazione degli
incarichi. Cossiga riteneva che la questione non fosse di competenza del plenum
e avvertì che se la riunione avesse avuto luogo avrebbe preso «misure esecutive
per prevenire la consumazione di gravi illegalità». I consiglieri del Csm si
opposero con un documento e si riunirono. In piazza Indipendenza, alla sede del
Csm, affluirono i blindati dei carabinieri e due colonnelli dell’Arma vennero
inviati a seguire la seduta. Ma il caso fu risolto subito, perché il
vicepresidente, Giovanni Galloni, non permise la discussione. Invitato a dare
una spiegazione sull’incredibile ed ingiustificato avanzamento di carriera
toccato ai due magistrati (Lucio di Pietro e Felice di Persia) noti per aver
condannato ed arrestato Enzo Tortora e centinaia di persone innocenti
nell’ambito dello stesso processo (tutti rilasciati dopo mesi di carcere per
imperdonabili errori macroscopici), Cossiga rispose: “Come mi è stato spiegato,
la magistratura deve difendere i suoi, soprattutto se colpevoli”. La sicurezza
di quanto affermava il Presidente Cossiga gli proveniva da una confessione
fattagli da un membro interno di cui non rivelò mai il nome ma risulta evidente
che si tratti di un personaggio di calibro elevatissimo, “Un giovane membro del
Consiglio Superiore della Magistratura, appartenente alla corrente di
magistratura democratica, figlio di un amico mio, il quale mi è ha detto: “Noi
dobbiamo difendere soprattutto quei magistrati che fanno errori e sono colpevoli
perché sennò questa diga che noi magistrati abbiamo eretto per renderci
irresponsabili ed incriticabili crolla”! invitato a dare delle spiegazioni sul
come mai il nostro sistema (comunemente riconosciuto come il migliore al Mondo)
fosse così profondamente percorso da fatali fratture, Cossiga tuonò: “La colpa
di tutto questo è della DC! Lì c’è stato chi, per ingraziarsi la magistratura,
ha varato la famosa “Breganzola” che prevede l’avanzamento di qualifica dei
magistrati senza demerito. Ci pronunciammo contro quella Legge in quattro: uno
era l’Avvocato Riccio, il deputato che poi fu sequestrato ed ucciso in Sardegna;
Giuseppe Gargani, io ed un altro. Fummo convocati alla DC e ci fu detto che
saremmo stati sospesi dal gruppo perché bisognava fare tutto quello che dicevano
di fare i magistrati altrimenti avrebbero messo tutti in galera”. Questo breve
preambolo ci deve servire come metro per misurare, con occhio nuovo, quanto più
da vicino possibile, l’attuale situazione italiana. Dal 1992 (mani pulite), ad
oggi, di acqua sotto ai ponti ne è passata assai. E tutta questa acqua, per
rimanere nel solco dell’allegoria, ha finito con l’erodere i margini di garanzia
della classe politica (vedi perdita delle immunità dei membri del Parlamento –
1993) espandendo quelli dei membri della magistratura. Membri i quali, poco alla
volta, hanno preferito fare il “salto della scimmia” passando da un ramo
all’altro (dal ramo giudiziario a quello legislativo e/o esecutivo) e ce li
siamo ritrovati in politica come missili (di Pietro, de Magistris, Grasso,
Ingroia, Finocchiaro…). Pertanto, quella che da decenni a questa parte viene
rivenduta al popolo italiano come una “stagione di battaglia contro la
corruzione politica”, in realtà nascondeva e tutt’ora nasconde ben altro. Il
potere legislativo (facente capo al Parlamento), quanto il potere esecutivo
(facente capo al governo), si sono ritrovati in uno stato di progressiva
sofferenza indotta dalla crescente ed inarrestabile affermazione del potere
giudiziario (facente capo alla magistratura). Che le cose stiano così, è fuor di
dubbio! E “La cosa brutta è che i giornalisti si prestino alle manovre politiche
dei magistrati” [Cossiga Ibid.]. Ecco spiegato come mai ci si ostini a ritenere
“mani pulite” una battaglia alla corruzione e non già una battaglia tra i tre
poteri dello Stato. Ma, scusate tanto, e il POPOLO?!? No, dico, siamo o non
siamo noi italiani ed italiane – e non altri popoli diversi dal nostro – a
pagare sulla nostra pelle lo scotto generato dalle conseguenze di queste
“scalate al potere”? Non siamo forse noi quelli/e che stanno finendo dritti in
bocca alla rovina totale, alla disperazione ed al suicidio di massa? COSA CI
STANNO FACENDO DI MALE E’ PRESTO DETTO. Innanzi tutto, il riflesso peggiore che
ci tocca subìre è dato dal fatto che, dal precedente (prima di “mani pulite”)
clima culturale in cui eravamo usi vivere sentendoci protetti dalla magistratura
(vedi garanzia di presunzione d’ innocenza), ci siamo ritrovati catapultati in
un clima orrido in cui è “la presunzione di colpevolezza” a dettare il ritmo. E,
di conseguenza, tutto il discorso è andato a gambe all’aria e le nostre libertà,
nonché le nostre sovranità sono andate in fumo. E poi, chi di voi può affermare
di non aver mai sentito ripetere sino alla nausea frasi del tipo “Lo deve
stabilire la magistratura”, oppure “Lo ha stabilito una sentenza” od anche “Lo
ha detto in giudice”; e allora? Forse queste persone (che restano sempre
impiegati statali al servizio dello Stato e di chi vi abita) discendono dallo
Spirito Santo? Sono o non sono esseri umani? E se lo sono allora posso
commettere degli sbagli, sì o no? E se sbaglia un magistrato le conseguenze sono
letali, sì o no? E allora per quale ragione da 22 anni a questa parte si sta
facendo di tutto per collocarli nell’olimpo della saggezza? Perché è possibile
sputtanare un esponente del ramo legislativo o di quello esecutivo e GUAI se si
fa altrettanto con uno del ramo giudiziario? L’ex magistrato ed ex politico
Antonio Di Pietro (definito da Cossiga “Il famoso cretino… che ha nascosto cento
milioni in una scatola delle scarpe” e “Ladro” che si è laureato “Probabilmente
con tutti 18 e si è preso pure l’esaurimento nervoso per prepararsi la Laurea”
quando era a capo dell’IDV ci ha assillato per anni, farcendo all’inverosimile i
suoi discorsi con frasi come quelle succitate. E come lui, ma dall’altro lato
della barricata, Silvio Berlusconi ha infarcito i suoi discorsi contro la
magistratura corrotta e bla bla bla. Ci hanno fatto un vero e proprio lavaggio
del cervello, arrivando a dividere la popolazione in due: una parte garantista
ed una giustizialista. Il vecchio e amatissimo strumento del “dividi et impera”
inventato dai nostri avi latini per esercitare il potere sulla massa ignorante.
Ma se due terzi della medesima torta sono marci e putrescenti (il potere
legislativo e quello esecutivo), possibile che il rimanente terzo (potere
giudiziario) sia l’unico commestibile? Certo che non lo è, è ovvio! La
corruzione, in magistratura è a livelli raccapriccianti, “E’ prassi dividere il
compenso con il magistrato. Tre su quattro sono corrotti” confessa Chiara
Schettini (nomen omen) impiegata statale con la qualifica di giudice presso il
Tribunale dei Fallimenti di Roma, anzi ex, visto che le hanno messo le manette
ai polsi e poi sbattuta in galera con gravissime accuse di corruzione e
peculato. Ricostruiamo quello che la stampa di regime non osa nemmeno sfiorare.
“SONO PIU’ MAFIOSA DEI MAFIOSI” DICE SPAVALDAMENTE IL GIUDICE DI ROMA. La gente
normale, quella che lavora per guadagnare e consegnare il bottino allo Stato
vampiro, lo sa molto bene: se si può, meglio non fare causa! Si perde tempo, si
perdono soldi e non si sa se ti andrà bene. E, stando a quanto sta emergendo da
una prodigiosa inchiesta di cui prima o poi anche la stampa di regime sarà
costretta a parlare, l’impressione poggia su basi solidissime. E sarebbe bene
prendere le distanze da certa gente… più pericolosa dei delinquenti veri. In una
elaborazione di un articolo de Il Fatto Quotidiano del 31 Dicembre 2013 apparsa
l’1 Gennaio 2014 sul sito malagiustiziainitalia.it, si parla di “Perizie
affidate a consulenti dall’ampio potere discrezionale e dai compensi
stratosferici, mazzette spartite anche con i giudici. Un crocevia affaristico in
cui è coinvolto il vertice dell’ufficio [quello di Roma]”, in riferimento alla
vicenda che ha visto coinvolta Chiara Schettini di cui abbiamo appena accennato.
La stessa Schettini, chiama in causa (è il caso di dire) anche la magistratura
umbra, passivamente prona ai desiderata di quella romana: insabbiare gli
esposti, far finta di nulla ed attendere che trascorrano i tempi era l’ordine da
eseguire. Sotto interrogatorio, la Schettini ha confessato al giudice (onesto e
che ringraziamo a nome di tutti i lettori e le lettrici di signoraggio.it): “Si
entrava in camera di consiglio e si diceva questo si fa fallire e questo no”.
Chi si esprime così non è un temibile boss della mala ma è sempre lei, il
veramente temibile giudice Schettini, lei sì appartenente al ramo pulito del
potere, proprio quello!!! Nella sua crassa arroganza venata di ottusa
prosaicità, ella ricorreva sovente ad uscite agghiaccianti, sfornando un gergo
truce da gangster matricolato. Intercettata telefonicamente mentre parlava col
curatore fallimentare Federico Di Lauro (anche lui in galera) minacciava di
farla pagare al suo ex compagno: “Guarda, gli ho detto, sono più mafiosa dei
mafiosi, ci metto niente a telefonare ai calabresi che prendono il treno, te
danno una corcata de botte e se ne vanno” (da Il Fatto, 8 Luglio 2013, R. Di
Giovacchino). Non finisce qui. Sempre questo giudice donna, in un’altra
intercettazione che ha lasciato di stucco gli inquirenti che l’hanno più e più
volte riascoltato il nastro, parlando con un ignoto interlocutore, minacciava il
“povero” Di Lauro in questi termini: “Io a Di Lauro l’avrei investito con la
macchina… Lui lavorava con la banda della Magliana”. Ciliegina sulla torta:
parlando al telefono con un perito del Tribunale, riferendosi all’insistenza di
un Avvocato che non aveva intenzione di piegarsi supinamente al comportamento
della Schettini, commentava: “Il suo amico Massimo [l’Avvocato insistente Ndr.]
ha chiesto la riapertura di due procedimenti. Una rottura senza limiti. Gli dica
di non insistere perché non domani, né dopo domani ma fra 10 anni io lo
ammazzo”. Alla faccia della magistratura a cui tocca attenersi! Alla faccia
delle parole del magistrato “che c’azzecckkhhA” Di Pietro colui il quale, dopo
il salto della scimmia ci ha assillato ripetendo come un disco scassato che
dobbiamo “affidarci alla magistratura”! come no! Si accomodi lei Di Pietro,
prima di noi (senza balbettare come le accadde quando se la vide bruttina a
Milano). Nell’articolo della Di Giovacchino leggiamo inoltre: “L’amico Massimo
è in realtà l’avvocato Vita. Mai ricevuto minacce? “Non da Grisolia, però mi
hanno telefonato persone con accento calabrese, consigli…”. Messaggi? “Mi
dicevano lasci perdere la vecchietta…” La “vecchietta” è Diana Ottini, un tipo
tosto, La giudice le consegnò 500 mila euro stipulando una promessa di vendita
posticipata di 10 anni, affinché acquistasse la sua casa dal Comune. Ma venuto
il momento lei la casa se l’è tenuta e il Tribunale le ha dato ragione. Non è
andata altrettanto bene a Francesca Chiumento, altra cliente dell’avvocato Vita,
che da anni si batte per riconquistare il “suo” attico in via Germanico: 170
metri quadri, terrazza su tre livelli, che il padre aveva acquistato dagli eredi
di Aldo Fabrizi. La casa finì all’asta, nei salotti romani si parla ancora della
polizia arrivata con le camionette. Anche quell’asta porta la firma della
Schettini: la famiglia Chiumento era pronta a pagare, a spuntarla fu un medico
del Bambin Gesù che offrì 50 mila euro di meno. L’appartamento di via Germanico
alla fine fu rivenduto per 1 milione e 800 mila euro a una coppia importante.
Lei figlia di un costruttore, che ha tirato su villaggi turistici tra Terracina
e Sperlonga, lui avvocato della banca che aveva offerto il mutuo ai legittimi
proprietari” [Il Fatto Ibid.]. E pensare che questa sguaiata stipendiata statale
ha campato una vita sulle spalle di noi contribuenti ed ha potuto nascondere le
sue malefatte per anni dietro la protezione del ruolo affidatole dallo Stato e
di persone della sua medesima risma. Tutti suoi colleghi e colleghe.
Allucinante. Semplicemente allucinante. Solamente dopo essersi impaurita a causa
dei giorni trascorsi in prigione, ha confessato che il suo ex compagno
“Trafficava anche con il direttore di una filiale di Unicredit su 900 mila euro
gliene dava 200 mila” come stecca [malagiustizia. Ibid.]. L’organizzazione
funzionava a gonfie vele, il timore di essere scoperti non li sfiorava nemmeno:
‘Non ti preoccupare [la rincuorava il compagno, quello della stecca
all’Unicredit] sarà rimesso tutto perfettamente”. Suscita la ripugnanza leggere
la storia di questa squallida persona la quale, nel frattempo, con lo stipendio
da funzionario statale è riuscita ad accumulare un patrimonio di quasi 5 milioni
di euro (quasi 10 miliardi di Lire) oltre ad attici a Parigi e Miami, ville a
Fregene, un rifugio a Madonna di Campiglio… A proposito: il figlio della
carcerata si è rivelato meno sveglio della mamma ma comunque fatto della
medesima pasta! Infatti, mentre alla madre venivano serrati i polsi con le
manette, lui riceveva l’sms in cui la madre stessa gli ordinava di fare “quello
che sa” (Il Fatto, ibid.). Si avete proprio capito bene. Il figlio diciottenne,
evidentemente al corrente delle attività della madre (e del padre) ed istruito a
dovere su come agire in caso di necessità, si è prontamente attivato rendendosi
complice della vicenda facendo sparire la valigetta col contante, frutto di una
delle corruzioni cui la madre era avvezza. Solo che le sue limitate capacità
hanno consentito, a chi ha effettuato la perquisizione, di ritrovare tutto
all’istante. Ed il Consiglio Superiore della Magistratura dormiva in questi
anni? Certo che no! Provvedeva, come fa spessissimo, a trasferirla presso la
procura di l’Aquila per ragioni di incompatibilità ambientale. Non sarebbe male
saperne di più su questa scelta curiosa. Che questa sia una vicenda riguardante
un pugno di magistrati e non tutti i componenti della magistratura è
lapalissiano, scontato ed evidente. E CI MANCHEREBBE ALTRO! Ma sappiate che il
punto della questione non è arrivare a pronunciare frasi vuote quanto idiote del
genere “Sono tutti uguali. Tra cani non si mordono…” qui c’è solo da fare una
cosa: il POPOLO deve riconoscere il proprio ruolo di SOVRANO! E poi, non resta
che risalire alla fonte del problema e, per farlo, NOI uomini e donne della
cosiddetta “società civile” abbiamo il dovere di emanciparci. Se c’intendessimo
(mi ci metto dentro anch’io – sebbene non sia un tifoso) di finanza e Stato come
di calcio e cucina, con l’aiuto dei nostri veri angeli custodi seri (ed in
magistratura ce ne sono eccome), il nostro futuro sarebbe radioso. Ripartire da
un punto fermo è cogente. Tale punto risiede nella battaglia “persa contro la
magistratura che è stata perduta quando abbiamo abrogato l’immunità
parlamentare, che esistono in tutto il Mondo, ovvero quando Mastella, da me
avvertito, si è abbassato il pantalone ed ha scritto sotto dittatura di
quell’associazione sovversiva e di stampo che è l’Associazione Nazionale
Magistrati” – F. Cossiga, Di Pietro… Ibid.
Non
dimentichiamoci che di magistrati parliamo e delle loro ambizioni.
Il giudice
"pagato" con prostitute di lusso. Quell'ambizione: «Dovevo fare il mafioso».
Il profilo di un magistrato finito nell'occhio del ciclone per i
suoi rapporti molto stretti con il boss Lampada, già condannato a quattro anni
di carcere e sospeso dal servizio, scrive “Il Quotidiano Web”. Il giudice
Giancarlo Giusti, arrestato e posto ai domiciliari il 14 febbraio 2014 dalla
squadra mobile di Reggio Calabria, era stato condannato dal gup di Milano a 4
anni di reclusione il 27 settembre 2012 ed il giorno successivo aveva tentato il
suicidio nel carcere milanese di Opera in cui era detenuto. Soccorso dalla
polizia penitenziaria, era stato poi ricoverato in ospedale in prognosi
riservata. Successivamente aveva ottenuto gli arresti domiciliari. Giusti, dal
2001 giudice delle esecuzioni immobiliari a Reggio Calabria e poi dal 2010 gip a
Palmi, era stato arrestato per corruzione aggravata dalle finalità mafiose il 28
marzo 2012 nell’ambito di una inchiesta della Dda di Milano sulla presunta cosca
dei Valle-Lampada e, in particolare, in un filone relativo alla cosiddetta "zona
grigia". La Dda di Milano gli ha contestato di essere sostanzialmente a “libro
paga” della 'ndrangheta. In particolare, i Lampada, sempre secondo l’accusa, non
solo gli avrebbero offerto ''affari”, ma avrebbero anche appagato quella che il
gip di Milano, nell’ordinanza di custodia cautelare, aveva definito una vera e
propria “ossessione per il sesso”, facendogli trovare prostitute in alberghi di
lusso milanesi. Per il giudice di Palmi il clan organizzava viaggi nel nord
Italia e incontri con alcune escort. Una ventina di fine settimana di piacere al
Nord, in cui gli venivano messe a disposizione prostitute con le quali avrebbe
intrattenuto rapporti in un hotel della zona del quartiere San Siro. L’inchiesta
che scoperchia qualche figura della “zona grigia” che protegge, favorisce, aiuta
o in qualche modo è amica della ‘ndrangheta tra Milano e Reggio Calabria allinea
numerosi episodi, e ovviamente si avvale di alcune intercettazioni telefoniche e
ambientali. Eccone una che riguarda proprio Giancarlo Giusti, invitato a Milano,
all’hotel Brun. La toga non paga mai. Per lui il conto è saldato da un boss del
calibro di Giulio Lampada, per una spesa totale di 27mila euro. Senza parlare di
quanto costavano le ragazze, tutte identificate. C’era la ceca Jana,
quarantenne, le russe Zhanna 36 anni, ballerina al Rayto de Oro, a La Tour, al
Venus, e altri night di Milano e del nord, ed Elena, 41 anni, la kazaca Olga, 34
anni, e la slovena Denisa, 27 anni. Giusti, per telefono, si lascia andare: «...
Dovevo fare il mafioso, non il giudice...» Giusti e Lampada sono ovviamente in
ottimi rapporti, il magistrato gli dice che arriva a Milano «la settimana che
entra o la prossima... Dipende dal cugino del tuo caro amico medico!... di
Giglio!! no?!», e Giglio sta per Vincenzo, il collega magistrato, presidente del
tribunale per le misure di prevenzione del tribunale di Reggio Calabria, come
conferma lo stesso Lampada. Parlando del “medico”, che si chiama pure lui
Vincenzo Giglio. Ecco uno stralcio delle intercettazioni:
LAMPADA
(riferendosi al magistrato Vincenzo Giglio): «...Del nostro Presidente, dobbiamo
dire!!... Il Presidente delle misure di prevenzione di tutta Reggio Calabria!
Sai che dobbiamo fare?.....».
GIUSTI: «...
che facciamo, che facciamo??».
LAMPADA: «lo
convochiamo qualche giorno su a Milano e lo invitiamo... come la vedi tu?».
GIUSTI: «...
minchia!! guarda!! dobbiamo parlarne col medico!!!...(ride)...».
LAMPADA: «Non
dirgli nulla che ti ho detto che è un mese che non ci sentiamo!».
GIUSTI: «...
Tu ancora non hai capito chi sono io... sono una tomba, peggio di.. ma io dovevo
fare il mafioso, non il Giudice... però l’idea di portarci il Presidente a
Milano non è male, sai?!... Lo vorrei vedere di fronte ad una steccona!!».
BELLA ITALIA, SI’. MA ITALIANI DEL CAZZO!!!
Italiani del Cazzo, sì. Italiani che, anzichè prender a forconate i potenti
impuniti, responsabili della deriva italica, per codardia le loro ire le
rivolgono a meridionali ed extracomunitari. D’altro canto, per onestà
intellettuale, bisogna dire che i meridionali questi strali razzisti se li
tirano, perchè nulla fanno per cambiare le loro sorti di popolo occupato ed
oppresso dalle forze politiche ed economiche nordiche.
Radio Padania. Radio Vergogna. Scandali e le mani della giustizia sulla Lega
Padania. Come tutti. Più di tutti. I leghisti continuano a parlare, anziché
mettersi una maschera in faccia per la vergogna. Su di loro io, Antonio
Giangrande, ho scritto un libro a parte: “Ecco a voi i leghisti: violenti,
voraci, arraffoni, illiberali, furbacchioni, aspiranti colonizzatori. Non
(ri)conoscono la Costituzione Italiana e la violano con disprezzo”. Molti di
loro, oltretutto, sono dei meridionali rinnegati. Terroni e polentoni: una
litania che stanca. Terrone come ignorante e cafone. Polentone come mangia
polenta o, come dicono da quelle parti, po’ lentone: ossia lento di
comprendonio. Comunque bisognerebbe
premiare per la pazienza il gestore della pagina Facebook “Le perle di Radio
Padania“, ovvero quelli che per fornire una “Raccolta di frasi, aforismi e perle
di saggezza dispensate quotidianamente dall’emittente radiofonica “Radio Padania
Libera” sono costretti a sentirsela tutto il giorno. Una gallery di perle
pubblicate sulla radio comunitaria che prende soldi pubblici per insultare i
meridionali.
Questa è la mia proposta di riforma costituzionale senza intenti discriminatori.
PRINCIPI COSTITUZIONALI
L'ITALIA E' UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA E FEDERALE FONDATA SULLA LIBERTA'. I
CITTADINI SONO TUTTI UGUALI E SOLIDALI.
I RAPPORTI TRA CITTADINI E TRA CITTADINI E STATO SONO REGOLATI DA UN NUMERO
RAGIONEVOLE DI LEGGI, CHIARE E COERCITIVE.
LE PENE SONO MIRATE AL RISARCIMENTO ED ALLA RIEDUCAZIONE, DA SCONTARE CON LA
CONFISCA DEI BENI E CON LAVORI SOCIALMENTE UTILI.
E' LIBERA OGNI ATTIVITA' ECONOMICA, PROFESSIONALE, SOCIALE, CULTURALE E
RELIGIOSA. IL SISTEMA SCOLASTICO O UNIVERSITARIO ASSICURA L'ADEGUATA
COMPETENZA. LE SCUOLE O LE UNIVERSITA' SONO RAPPRESENTATE DA UN PRESIDE O UN
RETTORE ELETTI DAGLI STUDENTI O DAI GENITORI DEI MINORI. IL PRESIDE O IL RETTORE
NOMINA I SUOI COLLABORATORI, RISPONDENDO DELLE LORO AZIONI PRESSO LA COMMISSIONE
DI GARANZIA.
LO STATO ASSICURA AI CITTADINI OGNI MEZZO PER UNA VITA DIGNITOSA.
IL LAVORO SUBORDINATO PUBBLICO E PRIVATO E' REMUNERATO SECONDO EFFICIENZA E
COMPETENZA. LE COMMISSIONI DISCIPLINARI SONO COMPOSTE DA 2 RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI E PRESIEDUTE DA UN DIRIGENTE PUBBLICO O AZIENDALE.
LO STATO CHIEDE AI CITTADINI IL PAGAMENTO DI UN UNICO TRIBUTO, SECONDO IL SUO
FABBISOGNO, SULLA BASE DELLA CONTABILITA' CENTRALIZZATA DESUNTA DAI DATI
INCROCIATI FORNITI TELEMATICAMENTE DAI CONTRIBUENTI, CON DEDUZIONI PROPORZIONALI
E DETRAZIONI TOTALI. AGLI EVASORI SONO CONFISCATI TUTTI I BENI. LO STATO
ASSICURA A REGIONI E COMUNI IL SOSTENTAMENTO E LO SVILUPPO.
E' LIBERA LA PAROLA, CON DIRITTO DI CRITICA, DI CRONACA, D'INFORMARE E DI ESSERE
INFORMARTI.
L'ITALIA E' DIVISA IN 30 REGIONI, COMPRENDENTI I COMUNI CHE IVI SI IDENTIFICANO.
IL POTERE E' DEI CITTADINI. IL CITTADINO HA IL POTERE DI AUTOTUTELARE I SUOI
DIRITTI.
I SENATORI E I DEPUTATI, IL CAPO DEL GOVERNO, I MAGISTRATI, I DIFENSORI CIVICI
SONO ELETTI DAI CITTADINI CON VINCOLO DI MANDATO. ESSI RAPPRESENTANO,
AMMINISTRANO, GIUDICANO E DIFENDONO SECONDO IMPARZIALITA', LEGALITA' ED
EFFICIENZA IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DEI CITTADINI. ESSI SONO
RESPONSABILI DELLE LORO AZIONI E GIUDICATI DA UNA COMMISSIONE DI GARANZIA
CENTRALE E REGIONALE.
GLI AMMINISTRATORI PUBBLICI NOMINANO I LORO COLLABORATORI, RISPONDENDONE DEL
LORO OPERATO.
LA COMMISSIONE DI GARANZIA, ELETTA DAI CITTADINI, E' COMPOSTA DA UN SENATORE, UN
DEPUTATO, UN MAGISTRATO, UN RETTORE, UN DIFENSORE CIVICO CON INCARICO DI
PRESIDENTE. LA COMMISSIONE CENTRALE GIUDICA IN SECONDO GRADO E IN MODO ESCLUSIVO
I MEMBRI DEL GOVERNO. ESSA GIUDICA, ANCHE, SUI CONTRASTI TRA LEGGI E TRA
FUNZIONI.
IL DIFENSORE CIVICO DIFENDE I CITTADINI DA ABUSI OD OMISSIONI AMMINISTRATIVE,
GIUDIZIARIE, SANITARIE O DI ALTRE MATERIE DI INTERESSE PUBBLICO. IL DIFENSORE
CIVICO E' ELETTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO, DEL CONSIGLIO
REGIONALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE.
I 150 SENATORI SONO ELETTI PROPORZIONALMENTE, CON LISTE REGIONALI, TRA I
MAGISTRATI, GLI AVVOCATI, I PROFESSORI UNIVERSITARI, I MEDICI, I GIORNALISTI.
I 300 DEPUTATI SONO ELETTI, CON LISTE REGIONALI, TRA I RESTANTI RAPPRESENTANTI
LA SOCIETA' CIVILE.
IL PARLAMENTO VOTA E PROMULGA LE LEGGI PROPOSITIVE E ABROGATIVE PROPOSTE DAL
GOVERNO, DA UNO O PIÙ PARLAMENTARI, DA UNA REGIONE, DA UN COMITATO DI CITTADINI.
IL GOVERNO, ENTRO 30 GIORNI DALLA LEGGE, EMANA I REGOLAMENTI ATTUATIVI DI
CARATTERE FEDERALE. LE REGIONI, ENTRO 30 GIORNI DALLA LEGGE, EMANANO I
REGOLAMENTI ATTUATIVI DI CARATTERE REGIONALE.
LA PRESENTE COSTITUZIONE SI MODIFICA CON I 2/3 DEL VOTO DELL’ASSEMBLEA PLENARIA,
COMPOSTA DAI MEMBRI DEL PARLAMENTO, DEL GOVERNO E DAI PRESIDENTI DELLE GIUNTE E
DEI CONSIGLI REGIONALI. ESSA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE DEL
SENATO.
Invece c'è chi vuole solamente i meridionali: föra,o
foeura, di ball.
L'Indipendentismo padano, da Wikipedia,
l'enciclopedia libera. La bandiera della Padania proposta dalla Lega Nord, con
al centro il Sole delle Alpi. L'indipendentismo padano o secessionismo
padano è un'ideologia politica nata negli anni novanta del XX secolo e
promossa storicamente dal partito politico Lega Nord, che cita testualmente nel
proprio statuto l'indipendenza della Padania. L'ideologia è stata sostenuta o è
sostenuta anche da altri partiti, come la Lega Padana, alternativa alla Lega
Nord, da essi considerata filo-romana, e da figure, afferenti nella loro
storia politica alla Lega Nord, come lo scrittore Gilberto Oneto, il politologo
Gianfranco Miglio e Giancarlo Pagliarini. La Padania per alcuni geografi
economici di inizio Novecento, corrispondeva al territorio italiano sito a nord
degli Appennini. Gli indipendentisti padani di fine Novecento affermano che un
territorio comprensivo di gran parte dell'Italia settentrionale (la Lega Padana
teorizza una Padania formata da quattro nazioni: Subalpina, Lombarda,
Serenissima e Cispadana) o centro-settentrionale (la Lega Nord estende più a sud
tale confine), di estensione territoriale differentemente definita dai partiti
stessi, e da essi stessi ribattezzato "Padania" (toponimo sinonimo di val
padana, la valle del fiume Po, in latino Padus), sarebbe abitato da
popoli distinti per lingua, usi, costumi e storia, chiamati nazioni della
Padania e riconducibili, nelle loro differenze, a un unico popolo padano e che
sarebbero stati resi partecipi contro la loro volontà del Risorgimento e,
conseguentemente, dello Stato italiano; pertanto propugnano la secessione di
queste nazioni dalla Repubblica Italiana e la creazione di una repubblica
federale della Padania rispettosa delle peculiarità di ciascuna di esse. A
fronte di alcuni geografi che ad inizio XX secolo solevano dividere il Regno
d'Italia in Padania ed Appenninia, sino agli anni ottanta il termine Padania
era principalmente usato con significato geografico per la pianura Padana, ma
anche con accezione poetica, come dimostra l'opera dello scrittore Gianni Brera
e nell'ambito di studi linguistici ed etnolinguistici nonché socio-economici. Il
termine acquisisce, a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, un significato
politico - ovverosia comincia a essere utilizzato per indicare la Padania come,
a seconda delle posizioni, reale o pretesa entità politica -, grazie al suo
utilizzo costante da parte degli esponenti e dei simpatizzanti del partito
politico Lega Nord, nato il 22 novembre 1989 dall'unione di vari partiti
autonomisti dell'Italia settentrionale originatesi nel decennio precedente, tra
i quali la Lega Lombarda, fondata il 10 marzo 1982 da Umberto Bossi, che diviene
guida del nuovo movimento politico. Grazie al successo politico del partito e ai
mezzi di comunicazione di massa, tale accezione politica del termine è entrata
da allora a far parte della lingua corrente e del dibattito politico. La Lega
propose inizialmente un'unione federativa della macro-regione Padania, dotata di
autonomia, con le restanti parti dello Stato italiano, come forma di
riconoscimento e tutela delle peculiarità etnico-linguistiche delle nazioni
della Padania. Fallito il progetto e raggiunto un successo elettorale
considerevole promosse il concetto di secessione della Padania dall'Italia,
proclamata il 15 settembre 1996 a Venezia. La secessione è stata,
successivamente al Congresso di Varese, messa parzialmente da parte a favore
della Devoluzione, ovverosia del trasferimento di parte significativa delle
competenze legislative e amministrative dallo Stato centrale alle regioni, e del
federalismo fiscale. Una prima riforma della costituzione verso una maggiore
autonomia delle regioni è stata approvata nel 2001. Una seconda riforma sempre
in questo senso del 2005 è stata invece bocciata con il referendum
costituzionale del 2006.
« Noi,
popoli della Padania, solennemente proclamiamo: la Padania è una Repubblica
federale indipendente e sovrana. Noi offriamo, gli uni agli altri, a scambievole
pegno, le nostre vite, le nostre fortune e il nostro sacro onore.»
(Umberto Bossi, dichiarazione d'indipendenza della Padania, 15 settembre 1996)
Il 15 settembre 1996 a Venezia, nel corso di una manifestazione della Lega Nord,
Umberto Bossi ha proclamato, al culmine della politica secessionista del
partito, l'indizione di un referendum per l'indipendenza della Padania e ha
battezzato il nuovo soggetto istituzionale con il nome di Repubblica Federale
della Padania. Il 25 maggio 1997 si è svolto il "Referendum per l'Indipendenza
della Padania". Oltre al SI/NO per il referendum, si è votato anche per il
Presidente del "Governo Provvisorio della Repubblica Federale della Padania" e
per sei disegni di legge di iniziativa popolare da presentare al Parlamento
italiano. La Lega Nord ha predisposto i seggi elettorali in tutti i Comuni della
supposta Padania. La Repubblica Federale della Padania non è stata mai
riconosciuta formalmente da alcuno stato sovrano, né dalle altre forze politiche
italiane. L'unico supporto in tal senso è venuto dal partito svizzero della Lega
dei Ticinesi. In seguito alla dichiarazione d'indipendenza furono avviate delle
inchieste giudiziarie a Venezia, Verona, Torino, Mantova e Pordenone per
attentato all'unità dello stato, poi archiviate, e si ebbero scontri tra forze
dell'ordine e militanti leghisti in Via Bellerio a Milano, sede della Lega Nord.
Per quanto la dichiarazione di secessione non abbia comportato la reale
separazione della Padania dall'Italia, la Lega Nord ha da allora promosso e
continua a promuovere attivamente la concezione della Padania come entità
politica attraverso la creazione e il mantenimento di strutture e organi
rappresentativi delle Nazioni della Padania nonché attraverso la
promozione di iniziative sportive e sociali di carattere indipendentista o
quantomeno autonomista: ha costituito un Governo padano con un proprio
parlamento, ha designato Milano capitale della Padania, il Va, pensiero
di Giuseppe Verdi suo inno ufficiale, il Sole delle Alpi verde in campo bianco
sua bandiera ufficiale, il verde come colore nazionale, ha creato le lire padane
e i francobolli padani, una propria Guardia Nazionale, un proprio ente sportivo
riconosciuto nel CONI sport Padania e, come organi di stampa ufficiali,
il quotidiano La Padania, il settimanale Il Sole delle Alpi, l'emittente
radiofonica Radio Padania Libera e l'emittente televisiva TelePadania. Vi
fu anche la formazione spontanea, tra i militanti leghisti, delle cosiddette
camicie verdi. La Lega Nord ha anche creato una Nazionale di calcio della
Padania, non riconosciuta né a livello italiano, né a livello internazionale.
Questa selezione Padana ha vinto per 3 volte consecutive il mondiale per le
nazioni non riconosciute, la VIVA World Cup, battendo la selezione del Samiland
(2008), quella del Kurdistan (2009) e quella della Lapponia (2010). Inoltre il
partito padano sponsorizza il concorso di bellezza Miss Padania, aperto a tutte
le giovani donne residenti in una regione della Padania da almeno 10 anni
consecutivi e di età compresa tra i 17 e i 28 anni. Tra i requisiti necessari
per partecipare al concorso vi è anche l'obbligo di non rilasciare dichiarazioni
non in linea con gli ideali dei movimenti che promuovono la Padania. Nel 2009 la
Lega Nord, in particolare tramite Umberto Bossi, promosse la realizzazione del
film storico Barbarossa, coprodotto dalla Rai. Il film, incentrato sulle
vicende della Lega Lombarda nel XII secolo, non ebbe buon riscontro né di
critica né di pubblico. Il 2011 ha visto la prima edizione dell'evento
ciclistico Giro di Padania. Il 26 ottobre 1997 la Lega Nord organizzò le prime
elezioni per i 210 seggi del Parlamento Padano. Circa 4 milioni di Italiani
residenti nelle regioni settentrionali, 6 secondo il Partito, si recarono ai
seggi e scelsero tra diversi partiti padani. Il Parlamento della Padania, creato
nel 1996 e oggi denominato Parlamento del Nord, ha sede nella Villa Bonin
Maestrallo di Vicenza, che ha sostituito l'originale sede a Bagnolo San Vito in
Provincia di Mantova. Si affianca al Governo della Padania, con sede a Venezia,
che, storicamente, è stato guidato prima da Giancarlo Pagliarini (1996-97), da
Roberto Maroni (1997-98), da Manuela Dal Lago (1998-99) ed è attualmente guidato
da Mario Borghezio (dal 1999). Nell'esecutivo presieduto da Pagliarini, Fabrizio
Comencini era Ministro degli esteri, subito dimessosi fu sostituito da Enrico
Cavaliere, Giovanni Fabris della Giustizia, Alberto Brambilla del Bilancio e
Giovanni Robusti, capo dei Cobas del latte, dell'Agricoltura. Nel governo
presieduto da Maroni, il cui vice era Vito Gnutti, è stato introdotto un
Ministero dell'Immigrazione, presieduto da Farouk Ramadan. L'esecutivo guidato
da Manuela Dal Lago comprendeva Giancarlo Pagliarini come vice presidente e
Ministro dell'Economia, Giovanni Fabris alla Giustizia, Alessandra Guerra agli
Esteri, Flavio Rodeghiero alla Cultura e all'Istruzione, Giovanni Robusti
all'Agricoltura, Roberto Castelli ai Trasporti, Francesco Formenti all'Ambiente,
Sonia Viale agli Affari Sociali e della Famiglia, Alfredo Pollini, presidente
della Guardia Nazionale Padana, alla Protezione Civile, Francesco Tirelli, del
CONI sport Padania, allo Sport e Roberto Faustinelli, presidente di Eridiana
Records, allo Spettacolo. Secondo l'art. 2 dello Statuto 2012, la Lega Nord
considera il Movimento come una Confederazione delle Sezioni delle seguenti
Nazioni: La Lega afferma dunque che il progetto della Padania comprende tutte le
otto regioni dell'Italia settentrionale più le regioni dell'Italia centrale
Toscana, Umbria e Marche, mentre al 2011 la sua attività si è estesa anche in
Abruzzo e Sardegna. Il territorio rivendicato dalla Lega Nord come costituente
la Padania comprende 160.908 km² di Italia, ossia il 53,39% del territorio
dell'Italia (di 301.340 km²) e il 56,15% della sua popolazione (vedere tabella
sottostante). Le rivendicazioni politiche padane ricomprendono quindi un
territorio maggiore di quello riconducibile al significato geografico del
termine Padania, che è geograficamente riferito alla sola Pianura Padana.
La linea apertamente secessionista fatta propria dalla Lega Nord portò, tra il
1996 e il 2000, a un isolamento del movimento nel panorama politico italiano,
col risultato che, nelle zone dove il radicamento leghista era minore, i suoi
candidati alle elezioni amministrative erano nettamente svantaggiati rispetto a
quelli di centrodestra e di centrosinistra, generalmente appoggiati da più
liste. Per cercare di rimediare a questa situazione, nel settembre del 1998
Bossi lanciò il cosiddetto Blocco padano, una coalizione formata dalla
Lega Nord con diverse liste in rappresentanza di varie categorie sociali e
produttive del territorio. Già alle elezioni amministrative dell'aprile 1997
altre liste che si richiamavano apertamente all'indipendentismo avevano
affiancato la Lega Nord: Agricoltura padana; Lavoratori padani; Padania pensione
sicura; Non chiudiamo per tasse! - Artigianato, commercio, industria. Il
risultato di queste liste fu complessivamente molto modesto, e nella maggior
parte dei casi esse non riuscirono a portare i candidati leghisti al
ballottaggio. Le ultime tre liste ottennero complessivamente l'1,1% al comune di
Milano e lo 0,8% al comune di Torino. L'Agricoltura padana ebbe l'1,9% alla
provincia di Pavia e i Lavoratori padani lo 0,9% alla provincia di Mantova. Un
risultato di un certo rilievo fu però ottenuto dai Lavoratori padani
nell'autunno dello stesso anno al comune di Alessandria, dove con il 4,4%
contribuirono alla rielezione del sindaco uscente Francesca Calvo ed ebbero
diritto a tre consiglieri. Nel 1998 il Blocco padano, di cui il coordinatore
doveva essere il parlamentare europeo ed ex sindaco di Milano Marco Formentini,
fu annunciato come costituito fondamentalmente da cinque partiti, oltre alla
Lega: Terra (evoluzione di Agricoltura padana, con a capo Giovanni Robusti,
portavoce dei Cobas del latte); Lavoratori padani; Pensionati padani (evoluzione
di Padania pensione sicura, con a capo Roberto Bernardelli); Imprenditori padani
(evoluzione di Non chiudiamo per tasse!); Cattolici padani (già presentatosi
alle elezioni per il Parlamento della Padania del 1997, con a capo Giuseppe
Leoni). A questi si unirono a seconda dei casi anche liste civiche di portata
locale, che talvolta ebbero maggior fortuna: a Udine Sergio Cecotti raggiunse il
ballottaggio e fu poi eletto sindaco grazie all'apporto di due liste civiche,
senza che i partiti "regolari" del Blocco padano fossero presenti. La coalizione
nel suo complesso risentì del calo di consensi generalizzato subito dalla Lega
Nord, tanto che dopo il 1999 non fu più ripresentata se non in maniera
sporadica, anche perché la Lega Nord, entrando a pieno titolo nella Casa delle
Libertà, trovò alleati di maggiore consistenza elettorale.
Lega secessionista: ora vuole il Veneto indipendente, scrive "Globalist". L'1 e
il 2 marzo 2014 i gazebo per la raccolta firme. Dopo oltre vent'anni di lotta
per la Padania, ancora in Italia, ora il Carroccio riparte dal Nord Est.
Che la voglia di secessione della Lega
non si sia mai placata, è cosa nota. A volte viene messa da parte, per lasciare
spazio ad altre battaglie come quella contro l'euro o contro lo ius soli, ma
comunque è sempre lì, appesa alla mente del segretario Matteo Salvini e dei suoi
compagni. E così ogni tanto torna a galla, come in questi giorni. E se tutto il
Nord non si può staccare, almeno ci si può provare con una sua parte. Come il
Veneto, ad esempio. "La Lega corre, la Lega c'è. La voglia d'indipendenza è
tanta, sia da Roma, sia da Bruxelles" ha detto Salvini, intervendo a Verona con
i vertici regionali del Carroccio per presentare la raccolta firme per il
referendum per l'indipendenza del Veneto, che si terrà sabato e domenica in
tutta la regione. "L'indipendenza da Bruxelles - ha aggiunto - è necessaria
perchè fuori dall'euro riparte la speranza, riparte il lavoro, ripartono gli
stipendi. L'indipendenza da Roma perchè sostanzialmente l'Italia ormai è un
Paese fallito". Ogni anno, è la considerazione del segretario, "il Veneto regala
21 miliardi allo stato italiano ricevendo in cambio servizi da poco o niente".
Dopo oltre 20 anni di tentativi secessionisti, dunque, la Lega riparte dal
Nord-Est. Perché magari, potrebbe essere il pensiero, l'indipendenza si può
ottenere a piccoli passi visto che la Padania, nonostante il loro impegno,
continua a restare in Italia. "I veneti sono uniti da una lingua e da una
cultura e hanno diritto alla propria autodeterminazione - ha detto la senatrice
leghista, Emanuela Munerato -. Solo compatti e votando sì a questo referendum
potremo fare scuola e aprire la strada anche alle altre regioni decretando
l'inizio della fine del centralismo romano che sta uccidendo la nostra cultura e
la nostra economia".
Non solo legisti.....
Grillo chiama gli italiani alla
secessione. Sul suo blog il comico contro
«l'arlecchinata» dei mille popoli, scrive Barbara
Ciolli “Lettera 43”. Altro che Lega Nord, anche Beppe Grillo, leader del
Movimento 5 Stelle, archiviate le espulsioni dal partito, grida alla secessione.
Peggio ancora, al big bang, all'«effetto domino di un castello di carta», alla
diaspora dei mille «popoli, lingue e tradizioni che non hanno più alcuna ragione
di stare insieme» e «non possono essere gestiti da Roma». «Un'arlecchinata»
bella e buona, a detta del comico ligure che ha postato sul suo blog l'ennesima
e forse maggiore provocazione: «E se domani l'Italia si dividesse, alla fine di
questa storia, iniziata nel 1861, funestata dalla partecipazione a due guerre
mondiali e a guerre coloniali di ogni tipo, dalla Libia all'Etiopia» scrive il
Beppe, suo malgrado, nazionale, parafrasando ironicamente - e populisticamente -
la canzone di Mina? Sotto, il testo apparso l'8 marzo 2014 in Rete: «Italia,
incubo dove la democrazia è scomparsa. Non può essere gestita da Roma». «Quella
iniziata nel 1861 è una storia brutale, la cui memoria non ci porta a gonfiare
il petto, ma ad abbassare la testa. Percorsa da atti terroristici inauditi per
una democrazia assistiti premurosamente dai servizi deviati (?) dello Stato.
Quale Stato? La parola "Stato" di fronte alla quale ci si alzava in piedi e si
salutava la bandiera è diventata un ignobile raccoglitore di interessi privati
gestito dalle maitresse dei partiti. E se domani, quello che ci
ostiniamo a chiamare Italia e che neppure più alle partite della Nazionale ci
unisce in un sogno, in una speranza, in una qualunque maledetta cosa che ci
spinga a condividere questo territorio che si allunga nel Mediterraneo, ci
apparisse per quello che è diventata, un'arlecchinata di popoli, di lingue, di
tradizioni che non ha più alcuna ragione di stare insieme? La Bosnia è appena al
di là del mare Adriatico. Gli echi della sua guerra civile non si sono ancora
spenti. E se domani i Veneti, i Friulani, i Triestini, i Siciliani, i Sardi, i
Lombardi non sentissero più alcuna necessità di rimanere all'interno di un
incubo dove la democrazia è scomparsa, un signore di novant'anni decide le sorti
della Nazione e un imbarazzante venditore pentole si atteggia a presidente del
Consiglio, massacrata di tasse, di burocrazia che ti spinge a fuggire all'estero
o a suicidarti, senza sovranità monetaria, territoriale, fiscale, con le imprese
che muoiono come mosche. E se domani, invece di emigrare all'estero come hanno
fatto i giovani laureati e diplomati a centinaia di migliaia in questi anni o di
"delocalizzare" le imprese a migliaia, qualcuno si stancasse e dicesse "Basta!"
con questa Italia, al Sud come al Nord? Ci sarebbe un effetto domino. Il
castello di carte costruito su infinite leggi e istituzioni chiamato Italia
scomparirebbe. È ormai chiaro che l'Italia non può essere gestita da Roma da
partiti autoreferenziali e inconcludenti. Le regioni attuali sono solo fumo
negli occhi, poltronifici, uso e abuso di soldi pubblici che sfuggono al
controllo del cittadino. Una pura rappresentazione senza significato. Per far
funzionare l'Italia è necessario decentralizzare poteri e funzioni a livello di
macroregioni, recuperando l'identità di Stati millenari, come la Repubblica di
Venezia o il Regno delle due Sicilie. E se domani fosse troppo tardi? Se ci
fosse un referendum per l'annessione della Lombardia alla Svizzera,
dell'autonomia della Sardegna o del congiungimento della Valle d'Aosta e
dell'Alto Adige alla Francia e all'Austria? Ci sarebbe un plebiscito per
andarsene. E se domani...» Si attendono reazioni.
ADDIO AL SUD.
"Addio al sud" di Angelo Mellone, scrive Paolo Tripaldi su “Il Corriere Romano”.
Verrà un giorno in cui tutti i meridionali d'Italia, sparsi un po' ovunque,
faranno rientro in patria per sconfiggere definitivamente tutti i mali che hanno
affossato per anni il Sud. "Addio al Sud", poema dello scrittore tarantino
Angelo Mellone, non è una resa bensì una voglia di rinascita, una chiamata alle
armi contro il Sud malato e incapace di riscatto. Un poema che parla al cuore e
allo stomaco di ogni meridionale e che cerca di farla finita con ogni
stereotipo, con il piangersi addosso e con il pensare che le colpe siano sempre
degli altri. "Il punto di vista di questa voce narrante - scrive Andrea Di
Consoli nella prefazione di Addio al Sud - è il punto di vista di chi è scampato
a un naufragio, cioè di chi, senza sapere bene da cosa, si è salvato da un male
ineffabile". Mellone ci ricorda però che anche se lontani il Sud continua a
chiamare: "Tu, chiunque sarai, i vestiti e i profumi e l'accento che saprai
sfoggiare, sempre da lì vieni. Da lì. Lì dove la salsedine non dà tregua e
l'umido fa sudare d'inverno e sconfigge qualsiasi acconciatura e il sole,
quando c'è, e si fa tramonto, ti uccide di bellezza". Lo sapeva bene Leonida di
Taranto, poeta del III secolo a.c., che aveva scelto l'esilio dalla propria
patria per non essere schiavo dei romani e che aveva scritto in un suo celebre
epitaffio: "riposo molto lontano dalla terra d'Italia e di Taranto mia Patria e
ciò m'è più amaro della morte". L'Addio al Sud di Angelo Mellone è un addio ai
mali del meridione: alla criminalità, all'assistenzialismo, alla
industrializzazione selvaggia che ha inquinato i territori, al nuovo fenomeno
del turismo predatorio. E' un invito anche ad abbandonare il 'pensiero
meridiano' del sociologo Franco Cassano. "Smettiamola con la follia del
pensiero meridiano - scrive Mellone - questa scemenza dell'attesa, dell'andare
lento, della modernità differente, della sobrietà della decrescita", tutte
scusanti "al difetto meridionale dell'amor fati". Mellone passa in rassegna
tutti gli episodi che negli ultimi anni hanno affossato ancora di più il Sud: il
fenomeno del caporalato, i fatti di Villa Literno, gli omicidi di camorra. Il
racconto ci consegna immagini di una sottocultura del sud che partendo
dall'omicidio di Avetrana giunge fino ai fenomeni populisti di Luigi de
Magistris e Nichi Vendola. "Voglio tornare a Sud a fare la guerra - scrive
Angelo Mellone - senza quartiere, senza paese, senza tregua, senza compromessi,
con le micce del carbonaro di patria folle, con le ruspe spianando strade a un
esercito che si tiene per mano, con la sola divisa dipinta dell'amore infedele
che testardamente continui ad amare”. Addio al Sud, che nel sottotitolo e’
chiamato “un comizio furioso del disamore”, è in realtà un atto d’amore per una
terra che è sempre nel centro del cuore.
Perché è impossibile dire addio al Sud.
Il Meridione ha ancora la forza per rialzarsi, scrive Aldo Cazzullo su “Il
Corriere della Sera”. Di Sud, in Italia, si parla tanto e si ragiona
poco. E così le domande che si ponevano i grandi meridionalisti - i Cuoco, i
Salvemini, i Fortunato - da decenni restano senza risposta: perché il Meridione
italiano, terra di assoluta bellezza e di immense potenzialità, continua a
galleggiare nel sottosviluppo e non impedire che i suoi figli migliori, quelli
che Piercamillo Falasca ha definito «Terroni 2.0», facciano la valigia per
emigrare (anche con un pizzico di risentimento)? A questa domanda prova a
rispondere un poema civile scritto da Angelo Mellone, Addio al Sud,
definito nel sottotitolo «un comizio furioso del disamore» (Irradiazioni, pp.
80, 8, prefazione di Andrea Di Consoli), una sorta di orazione civile tecno-pop
congegnata come reading teatrale. Mellone ribalta due cliché dominanti. Il primo
è quello del brigantaggio: qui l'autore trova il coraggio, da meridionale, di
ammettere - in quanto «fottuto nazionalista» - che avrebbe scelto di arruolarsi
con l'esercito italiano per combattere i Carmine Crocco e i Ninco Nanco, per
«piantare tricolori su antiche maledizioni». Il secondo oggetto polemico di
Addio al Sud è il nuovo meridionalismo, ovvero quel «pensiero meridiano»
- sostenuto, ad esempio, dal sociologo Franco Cassano - che vorrebbe un Sud
lento, sobrio, canicolare, che cammina a piedi e ammicca al mito della
decrescita o all'idea del Meridione italiano come avanguardia di un'improbabile
«alternativa allo sviluppo». Al contrario, il Sud di Mellone anela alla
velocità, alla modernità, sia pure a una modernità intrisa di miti antichi e di
antichi caratteri comunitari. Scrive Di Consoli nella prefazione: «Questo
poema è, in definitiva, una dolorosa "possibilità di prendere congedo", ma è
anche una possibilità della rifondazione di un patto "oscuro", ancestrale, e che
dunque può essere tramandato nei tempi come accade in tutte le comunità che
hanno conosciuto la diaspora, o il suo fantasma». Mellone infatti non sigla una
lettera di abbandono dall'identità meridionale, ma rilancia la sfida immaginando
che il Sud migliore - emigrato ovunque negli ultimi anni - a un certo punto
decida di tornare a casa. In quel momento, dice l'autore, il Sud potrà
finalmente essere salutato:
«Finita la guerra prenderò congedo
e solo allora dirò a mia figlia
e solo allora dirò a mio figlio:
tu questo sei.
Anche tu porti cenere, ulivo e salsedine.
Adesso anche tu vieni da Sud».
Quasi un congedo militare, anche se "i fuoriusciti" e i figli saranno chiamati,
allorquando terminerà la fatica di Sisifo dell'eterno rientro - che è quasi un
giorno d'attesa biblica - a una guerra civile contro il male del Sud: il
fatalismo, il degrado, l'incuria del territorio, la dissoluzione del legame
sociale, l'accettazione di un modello predatorio di turismo che rischia di
distruggere nel breve periodo le bellezze meridionali. Difficile da
argomentare, ma questo testo è un "addio" ed è anche un foglio di chiamate alle
armi, e in questa contraddizione c'è tutta la modernità della posizione
ineffettuale, e dunque estetizzante, di Mellone, che alla maniera di Pasolini si
considera, rispetto al Sud, «con lui e contro di lui». Il suo è un appassionato
"addio" al Mezzogiorno del rancore, della malavita, dell'inciviltà, della
subcultura televisiva. È però anche un disperato e struggente ricordo di una
giovinezza meridionale, al cui centro c'è Taranto, della quale Mellone ricorda
le icone (il calciatore Erasmo Jacovone), le tragedie (l'Ilva, la mattanza
criminale degli anni '80), gli aspetti più "privati" (la prematura morte del
padre, la vendita della casa di famiglia). La narrazione scorre per icone,
fotogrammi, eventi: dal delitto di Avetrana al matrimonio di Sofia Coppola, dai
nuovi populismi (Vendola, de Magistris) alla camorra, dal caso Claps alla piaga
del caporalato, Mellone attraversa e scandaglia con straordinaria velocità, e
con alternarsi di registro basso e alto, l'immaginario contemporaneo collettivo
del Meridione. Scrive per esempio su Sarah Scazzi: «Prendete tutta questa
pornografia dell'incubo d'amore simboleggiata dallo scarto incolmabile tra il
viso di Sarah Scazzi e il piercing, ripeto: il piercing, della cugina culona
Sabrina Misseri di anni venti e due che forse a Taranto e nemmeno a Lecce sarà
mai andata ma a Uomini e donne ha conosciuto il piercing che al padre dovrà
essere parso roba da bestie all'aratro e non da esseri umani oggi le borgate di
Pasolini sono i paesi del Sud in entroterra come Avetrana, tuguri dischiusi al
mondo solo grazie all'antenna parabolica». Pugliese trapiantato a Roma,
giornalista, scrittore, ora dirigente Rai, Angelo Mellone fa parte di quella
generazione nata nei primi anni ’70 che da un giorno all’altro si sono ritrovati
senza luoghi del dibattere e del confronto. Caduti i muri e le cortine, con essi
sono crollati anche le sezioni e i partiti, luoghi simbolo del confronto e della
sfida dialettica. E per chi aveva qualcosa da dire o da scrivere la strada è
improvvisamente diventata ripida e scoscesa. Ma impegno e determinazione
premiano sempre e se i luoghi non esistono, chi vuol farcela se li crea. La
notorietà raggiunta nella capitale non gli ha fatto dimenticare le origini
pugliesi, tarantine per la precisione. Una città che negli ultimi anni è balzata
agli onori delle cronache prima per un tremendo dissesto di bilancio, poi per
una sconsiderata gestione degli impianti industriali presenti sul territorio. E
per dimostrare l’amore a l’attaccamento alla sua terra, Mellone ha ideato e
messo in scena due monologhi poetici che andranno a far parte di una trilogia
dedicata a Taranto: “Addio al Sud” e “Acciaiomare”. Quest’ultimo in particolare
è una lunga requisitoria, (J’accuse!, direbbe Zola) nei confronti di un lembo di
terra che oltre ad avergli offerto la vita lo ha costretto troppo presto a fare
i conti con la morte. Ma quello scritto e cantato per la città di Taranto
rimanendo pur sempre un eroico canto d’amore. «Acciaiomare. Il canto
dell’industria che muore» (Marsilio Editore), tributo di amore e rabbia verso la
propria terra martoriata. Un racconto impetuoso e rutilante, dedicato ai 500
caduti del siderurgico di Taranto, che diventa anche l’occasione per un reading
teatrale che, mescolando parole, musica, immagini e rumori industriali, alza il
sipario sull’industria morente del Sud che ha nell’ILVA il suo occhio del
ciclone. Con lui sul palco, Raffaella Zappalà, Dj set Andrea Borgnino e Video di
Marco Zampetti. Dopo il successo di «Addio al Sud. Un comizio furioso del
disamore», Angelo Mellone scrive il secondo capitolo di una trilogia sulla sua
terra, sempre nella forma di monologo poetico, di comizio civile e lirico.
«AcciaioMare» è, in particolare, un canto funebre e peana d’amore, ma anche
requisitoria e arringa al tempo stesso, invettiva ed engagez-vous, per un Sud e
per una città (Taranto) al centro di uno dei più grandi casi
economico-industriali al mondo. Mellone, in un caleidoscopio di immagini e
ricordi, di luoghi e persone, di visioni ed emozioni, «scioglie all’urna un
cantico» che ha la rabbia di una rivendicazione e l’amore di un figlio, il
respiro della planata e la precisione del colpo secco. Perché "acciaio" a
Taranto vuol dire tante, troppe cose, per chi ci vive e per chi da lì proviene.
Lo scrittore (anche giornalista e dirigente di Radio Rai) concluderà la sua
trilogia nel 2014, ma questo suo secondo lavoro è senz’altro quello più
«doloroso»: con queste pagine Mellone si augura, infatti, di risvegliare «un
minimo di coscienza» sul dramma del declino industriale italiano, nell’illusione
di trasformare il Belpaese in una nazione di terziario avanzato, dimenticando
così la Fabbrica e gli operai. Ma ora quei 500 e più eroi e martiri dell’acciaio
(tra i quali c’è anche il papà di Mellone) hanno grazie a questo libro il loro
"canto corale" e un sentito risarcimento alla loro memoria. Pagine toccanti
dedicate soprattutto a suo padre, che Mellone accende di passione e rabbia,
laddove racconta «di quando acciaio chiamava mare e su questa costa di Sparta
nasceva l’industria della navi d’Impero e dei toraci siderurgici. Voglio
raccontarti una storia d’amore. D’amore che muore». Così, che lo scorso mese
d’agosto 2013 Mellone prese subito le difese «di un orgoglio siderurgico
impacchettato in fretta e furia» per far posto «all’ondata
ambientalqualunquista». E trasfromò le sue vacanze in un’indagine del suo
passato. C’era una volta un ragazzino che quando a pranzo c’erano fave e cicoria
restava digiuno. Sua madre voleva a tutti costi che le mangiasse, altrimenti
pancia vuota. Oggi quel ragazzino mangerebbe tutti i giorni a pranzo e a cena il
piatto principe della cucina pugliese. Che cosa è cambiato? Del piatto nulla,
solo che allora gli era imposto oggi è una libera scelta.
Il vero Sud lo riscopri solo dal finestrino del treno. "Meridione
a rotaia". Angelo
Mellone conclude la sua trilogia lirica sul Meridione italiano, giungendo anche
all’ultima fermata di un viaggio che è un canto appassionato e dolente, ma al
tempo stesso un grido di rabbia, per la sua terra.
Un ritorno nella propria terra, che è stata abbandonata anni prima con rabbia.
Un ritorno a Meridione, compiuto con il mezzo che più associamo al viaggio: il
treno. Sui treni sono partiti i primi emigrati meridionali, sulle carrozze di
treni locali scassati, regionali in perenne ritardo, Intercity improbabili,
l’Autore fa macchina indietro e, da Roma, arriva a Taranto. In mezzo a partenza
e arrivo si alternano situazioni grottesche, aneddoti, ricordi, memorie
dolorose, persino una pagina dedicata ai fanti meridionali mandati al massacro
nella Prima guerra mondiale. Tutte queste pagine, che Mellone ci regala con lo
stile consueto delle sue “orazioni civile”, accostano il tema tradizionale del
ritorno a quello, nuovo per l’autore, di una riflessione sull’amore, che viaggia
a ritroso attraverso due figure femminili e una singolare disquisizione sui
tacchi... E dunque, se l’amore è contesto, radici, terra, e «Meridione tiene
sempre i piedi per terra», per trovare amore autentico a Sud bisogna tornare. E
questo fa, Meridione a rotaia, nelle scorribande tra paesini, locomotori diesel,
vagoni stipati di varia umanità, stazioni metropolitane e stazioncine di
montagna. Offrendo, alla fine, un affresco di meridionalità divertente,
surreale, commuovente. Un tempo si tornava in
rotaia per restare, oggi per ripartire. Ma il lento viaggio verso casa porta
alle radici e invita a trovare la propria strada, scrive
Giuseppe De Bellis su "Il Giornale". I treni che
vanno a Sud sono diversi. D'aspetto, d'odore, d'umore. Non hanno niente di
professionale. Non hanno cravatte e collane di perle. Il professionista che dal
Nord sale su un treno verso casa, la vecchia casa del padre, è come Clark Kent
che toglie l'abito di Superman. Via il vestito da lavoro nobile, su quello
dell'essere umano così com'è. Perché è un viaggio nell'anima, quello che si sta
per fare. È incredibile quanto il ritorno a Sud sia ancora nel 2014 legato al
treno. Controintuitivo e persino antistorico. Da Milano a Bari ci vogliono più
di otto ore, contro un'ora e un quarto d'aereo. Da Roma a Reggio Calabria, sei
ore di treno contro le... Eppure chi è del Sud sa che in una conversazione con
un altro meridionale arriverà a questo punto. - «Sai che “vado giù?”? Solo
sabato e domenica». - «Come, ti fai tutto quel viaggio in treno per stare solo
due giorni?». Il viaggio in treno è dato per scontato, perché ancestralmente è
ormai sinonimo di trasferimento Nord-Sud. Puoi «salire» come vuoi, ma sembra che
tu debba sempre «scendere» in treno. Perché è ricordo, memoria, passato che
torna, è emigrazione e immigrazione. Noi terroni siamo legati alla ferrovia
anche al di là della nostra volontà. Angelo Mellone lo sa perché appartiene alla
categoria: professionista meridionale che per obbligo, passione e capacità è
stato costretto a lasciare casa e andare verso Nord. Ha portato la testa e il
corpo a Roma, ha mantenuto l'anima a Taranto. È uno degli intellettuali sudisti
che meglio ha raccontato in questi ultimi anni la nuova questione meridionale,
espressione tanto abusata quanto inevitabile. Lo fa anche ora, con il suo
Meridione a rotaia (Marsilio, pagg. 92, euro 10), che chiude quella che lui
stesso ha definito «trilogia delle radici». Il treno è il mezzo per tornare e
tornando raccontare che cos'è il Sud e soprattutto com'è il rapporto tra quelle
radici e chi le ha dovute lasciare superficialmente e poi scopre di avercele
comunque attaccate al corpo e allo spirito: «Noi meridionali siamo fatti così.
Amiamo la terra che abbiamo abbandonato quando la lasciamo, e la odiamo se ci
costringe a restare o ci rende impossibile partire. In questo ha ragione Mario
Desiati: la letteratura presuppone sempre una partenza. Un momento di
straniamento, un distacco, una mancanza. Nel mio caso un'irrequietezza che è
tutto il mio riassunto di meridionale atipico, innamorato di una terra ma
distante, antropologicamente, dall'“andare lento” meridionalista. Preferisco
viaggiare, consumare suole e bruciare le radici che poi voglio conservare. In
questo sentimento pendolare sta il senso di Meridione a rotaia. Che è, a suo
modo, un ritorno. Un viaggio a ritroso trasognato, surreale, infelice, virile,
spavaldo, intimista, appresso alla memoria, dove si incontrano donne, amici,
nemici, loschi figuri, personaggi improbabili, odori, panorami, sfondi e valigie
di ricordi». Mellone parte da una casa posticcia di Roma per tornare a Taranto,
dove è nato, cresciuto, l'Ilva gli ha tolto il padre, dandogli un dolore che
nessuno potrà mai placare, ma nonostante il quale non ha ceduto all'idea che
quello stabilimento fosse solo morte e non anche vita per tanta gente. È lì che
torna a bordo di questo treno che è reale e onirico allo stesso tempo. Sceglie
la formula del poema per rendere magico e però duro questo viaggio. Cita luoghi,
paesaggi, facce, pensieri che sono familiari a ciascun meridionale che quel
viaggio l'ha fatto davvero o anche con la fantasia. Perché è un dovere tornare,
anche quando non si ha voglia. Perché è inevitabile farlo. Un viaggio che non è
come gli altri, perché non porta a scoprire nulla che non si sappia già, ma è un
modo per trovare la strada. La propria: «Meridione restituisce sempre/ ciò che
avevi smarrito...». «Ritorno a Sud allora/ è condizione necessaria/ polvere a
polvere, sasso a sasso/ tratturo a tratturo, chianca a chianca/ complanare a
complanare, binario a binario specialmente/ al momento in cui il corpo sudato/
in discesa puzza/ e l'alito impasta/ la lingua assetata/ per riacciuffare i
brandelli di tutto quello/ che ho abbandonato». È un libro malinconico, come
dice Mellone, è l'ammissione della sconfitta di chi ha combattuto se stesso
pensando di poter essere meridionale senza fare ritorno al Sud. Ecco, dal Sud
non si può scappare, anche quando si emigra: te lo porti dentro esattamente come
i settentrionali si portano dentro il Nord. Ciò che contraddistingue le nuove
generazioni di fuggiaschi da una terra che non può dare non perché non abbia, ma
perché è schiava dei propri vizi, è un orgoglio differente: prima si tornava per
rimanere, per dire «ce l'ho fatta, ho combattuto lontano, ho vinto, adesso torno
dalla mia amata». Era lo stesso spirito di un soldato mandato al fronte con
l'unico obiettivo di riabbracciare una ragazza diventata donna o bambini
diventati adolescenti. Ora si torna per ripartire, per tenersi agganciati,
emigrati con l'elastico che ti riporta indietro fisicamente o idealmente. La
sconfitta di Mellone è in un certo senso una vittoria. Perché ammettere di non
riuscire a sganciarsi dalle proprie radici è una forza spacciata per debolezza
solo per un gioco di forze che fa leva sulla maledizione della nostalgia. Si
perde se si rincorre il Sud come passato, si vince se il Sud è vissuto oggi come
consapevolezza di non poterne fare a meno. Accettare di essere comunque terrone
a qualunque latitudine. Il treno porta giù, un altro mezzo ti può portare in
qualunque altro luogo senza farti dimenticare chi sei e da dove vieni. A chi
appartieni? Così si dice al Sud quando ti chiedono chi sia la tua famiglia. È
un'espressione meravigliosa: si appartiene a qualcuno, si appartiene anche ai
luoghi che vivono dentro di te. «Amore fatto di terra», dice Mellone. «Amore per
la terra».
Ciononostante i nordisti, anzichè essere grati al contributo svolto dagli
emigrati meridionali per il loro progresso sociale ed economico, dimostrano
tutta la loro ingratitudine.
FENOMENOLOGIA RANCOROSA DELL’INGRATITUDINE.
“Ingrati.
La sindrome rancorosa del beneficiato”.
Libro di Maria Rita Parsi, Mondadori 2011. Cos'è la "sindrome rancorosa del
beneficato"? Una forma di ingratitudine? Ben di più. L'eccellenza
dell'ingratitudine. Comune, per altro, ai più. Senza che i molti ingrati
"beneficati" abbiano la capacità, la forza, la decisionalità interiore, il
coraggio e, perfino, l'onestà intellettuale ed etica di prenderne atto. La
"sindrome rancorosa del beneficato" è, allora, quel sordo, ingiustificato
rancore (il più delle volte covato inconsapevolmente; altre volte, invece,
cosciente) che coglie come una autentica malattia chi ha ricevuto un beneficio,
poiché tale condizione lo pone in evidente "debito di riconoscenza" nei
confronti del suo benefattore. Un beneficio che egli "dovrebbe" spontaneamente
riconoscere ma che non riesce, fino in fondo, ad accettare di aver ricevuto. Al
punto di arrivare, perfino, a dimenticarlo o a negarlo o a sminuirlo o,
addirittura, a trasformarlo in un peso dal quale liberarsi e a trasformare il
benefattore stesso in una persona da dimenticare se non, addirittura, da
penalizzare e calunniare. Questo nuovo libro di Maria Rita Parsi parla
dell'ingratitudine, quella mancanza di riconoscenza che ognuno di noi ha
incontrato almeno una volta nella vita. Attraverso una serie di storie
esemplari, l'analisi delle tipologie di benefattori e beneficati, il decalogo
del buon benefattore e del beneficato riconoscente e un identikit interattivo,
l'autrice insegna a riconoscere l'ingratitudine e a difendersene, arginare i
danni e usarla addirittura per rafforzarsi.
La culla
dell'ingratitudine. Quand’è che proviamo riconoscenza per qualcuno? A prima
vista diremmo che la proviamo verso tutti coloro che ci hanno aiutato, ma non è
così. Quelli che si amano non la provano, scrive Francesco Alberoni su “Il
Giornale”. Quand’è che proviamo riconoscenza per qualcuno? A prima vista
diremmo che la proviamo verso tutti coloro che ci hanno aiutato, ma non è così.
Quelli che si amano non la provano. Pensate a due innamorati. Ciascuno fa tutto
quello che può per l’amato ma nessuno sente un debito di riconoscenza. Chi si
ama non tiene una contabilità del dare e dell’avere: i conti sono sempre pari.
Solo quando l’amore finisce riappare la contabilità e ciascuno scopre di aver
dato più di quanto non abbia ricevuto. Però anche fra innamorati ci sono dei
momenti in cui il tuo amato ti dona qualcosa di straordinario, qualcosa che non
ti saresti mai aspettato ed allora ti viene voglia di dirgli un «grazie» che è
anche riconoscenza. Insomma la riconoscenza nasce dall’inatteso, da un «di più».
Perciò la proviamo spesso verso persone con cui non abbiamo nessun rapporto ma
che ci fanno del bene spontaneamente. Per esempio a chi si getta in acqua per
salvarci rischiando la vita, a chi ci soccorre in un incidente, a chi ci cura
quando siamo ammalati. Ma anche a chi ci aiuta a scoprire e a mettere a frutto i
nostri talenti nel campo della scienza, dell’arte, della professione per cui,
quando siamo arrivati, gli siamo debitori. La riconoscenza è perciò nello stesso
tempo un grazie e il riconoscimento dell'eccellenza morale della persona che ci
ha aiutato. Quando proviamo questo sentimento, di solito pensiamo che durerà
tutta la vita, invece spesso ce ne dimentichiamo. E se quella persona ci ha
fatto veramente del bene allora la nostra è ingratitudine. Ma la chiamerei una
ingratitudine leggera, perdonabile. Perché purtroppo c’è anche una ingratitudine
cattiva, malvagia. Vi sono delle persone che, dopo essere state veramente
beneficiate, anziché essere riconoscenti, provano del rancore, dell’odio verso i
loro benefattori. Ci sono allievi che diventano i più feroci critici dei loro
maestri e dirigenti che, arrivati al potere diffamano proprio chi li ha
promossi. Da dove nasce questa ingratitudine cattiva? Dal desiderio sfrenato di
eccellere. Costoro pretendono che il loro successo sia esclusivamente merito
della propria bravura e si vergognano ad ammettere di essere stati aiutati. Così
negano l’evidenza, aggrediscono il loro benefattore. E quanti sono! State
attenti: quando sentite qualcuno diffamare qualcun altro, spesso si tratta di
invidia o di ingratitudine malvagia. Guardatevi da questo tipo di persone.
QUALCHE
PROVERBIO AFORISMO
Amico
beneficato, nemico dichiarato.
Avuta la
grazia, gabbato lo santo.
Bene per male
è carità, male per bene è crudeltà.
Chi non dà a
Cristo, dà al fisco.
Chi rende male
per bene, non vedrà mai partire da casa sua la sciagura.
Comun servizio
ingratitudine rende.
Dispicca
l’impiccato, impiccherà poi te.
Fate del bene
al villano, dirà che gli fate del male.
Il cane che ho
nutrito è quel che mi morde.
Il cuor
cattivo rende ingratitudine per beneficio.
Il mondo
ricompensa come il caprone che dà cornate al suo padrone.
L’ingratitudine converte in ghiaccio il caldo sangue.
L’ingratitudine è la mano sinistra dell’egoismo.
L’ingratitudine è un’amara radice da cui crescono amari frutti.
L’ingratitudine nuoce anche a chi non è reo.
L’ingratitudine taglia i nervi al beneficio.
Maledetto il
ventre che del pan che mangia non si ricorda niente.
Non c’è cosa
più triste sulla terra dell’uomo ingrato.
Non far mai
bene, non avrai mai male.
Nutri il corvo
e ti caverà gli occhi.
Nutri la serpe
in seno, ti renderà veleno.
Quando è
finito il raccolto dei datteri, ciascuno trova da ridire alla palma.
Render nuovi
benefici all’ingratitudine è la virtù di Dio e dei veri uomini grandi.
Tu scherzi col
tuo gatto e l’accarezzi, ma so ben io qual fine avran quei vezzi
Val più un
piacere da farsi che cento di quelli fatti.
In amore, chi
più riceve, ne è seccato: egli prova la noia e l’ingratitudine di tutti i
ricchi.
Philippe
Gerfaut
L’ingratitudine è sempre una forma di debolezza. Non ho mai visto che uomini
eccellenti fossero ingrati.
Johann
Wolfgang Goethe,
Massime e riflessioni, 1833 (postumo)
Spesso
l’ingratitudine è del tutto sproporzionata al beneficio ricevuto.
Karl Kraus,
Di notte, 1918
Ci sono assai
meno ingrati di quanto si creda, perché ci sono assai meno generosi di quanto si
pensi.
Charles de
Saint-Evremond,
Sugli ingrati, XVII sec.
Il cuore
dell’uomo ingrato somiglia alle botti delle Danaidi; per quanto bene tu vi possa
versare dentro, rimane sempre vuoto.
Luciano di
Samosata,
Scritti, II sec.
Un solo
ingrato nuoce a tutti gli infelici.
Publilio
Siro,
Sentenze, I sec. a.c.
Quando di un
uomo hai detto che è un ingrato, hai detto tutto il peggio che puoi dire di lui.
Fenomenologia rancorosa dell'ingratitudine.
La rabbia dell'ignorare il beneficio
ricevuto. Le relazioni d'aiuto contraddistinguono i diversi momenti del ciclo
vitale di una persona e ne favoriscono l'autonomia e l'indipendenza. Esiste
tuttavia la possibilità che nella sottile dinamica di dipendenza/indipendenza,
caratterizzante questo tipo di rapporto, alla gratitudine per un beneficio
ricevuto si sostituisca un sentimento d'ingratitudine, di rancore e di rabbia
verso il "benefattore".
Questo lavoro di Andrea Brundo prende in esame i fenomeni connessi alle
relazioni d'aiuto e i processi collegati alla costruzione della personalità nel
corso dell'età evolutiva (a partire dall'iniziale rapporto diadico
madre-figlio). In base a questa ipotesi, chi prova rancore non ha avuto la
possibilità di sperimentare, aggregare ed elaborare contenuti affettivi
significativi nelle prime fasi della vita. Ignora, quindi, l'esistenza di
autentiche relazioni d'affetto. È incapace di viverle, proprio per la mancanza
di informazioni e per la carenza dei relativi schemi cognitivi. Il "rancoroso",
pur potendo ammettere l'aiuto ricevuto, non è in grado di essere riconoscente
perché ignora i contenuti affettivi che sono dietro la relazione di aiuto.
Non potendoli riconoscere in se stesso non li può trovare neanche negli
altri. L'incapacità di provare gratitudine è sostenuta da una generale
difficoltà a condividere sentimenti e contenuti psichici. Nelle relazioni che
instaura, la condivisione non è mediata dalla sfera affettiva, ma dalle
prevalenti esigenze dell'io. Chi manca delle informazioni atte a soddisfare le
proprie necessità può ricorrere all'aiuto dell'altro che le possiede. Ciò
comporta, sul piano relazionale, il riconoscimento dell’autorevolezza e del
relativo "potere" di chi dispone le conoscenze. Nel momento in cui si deve
predisporre ad accettare le informazioni, il beneficiato, con prevalente
modalità narcisistica va incontro ad una serie di difficoltà legate a:
non sapere;
essere in una posizione
subordinata di "potere";
fidarsi e considerare giusta
l'informazione ricevuta;
disporsi a ridefinire i
propri schemi cognitivi e stili comportamentali;
vivere il disagio provocato
dal contenuto affettivo associato all'informazione-aiuto.
Nel caso in cui le
informazioni risultino troppo complesse rispetto alla rappresentazione della
realtà del soggetto, lo sforzo per elaborarle e integrarle nei propri schemi
mentali è eccessivo. A questo punto tale soggetto preferisce ricorrere a una
modalità più semplice, quale è quella antagonista, e si mette contro la persona
che lo sta aiutandolo. E ancora. Quando il divario tra l'immagine di sé (in
termini di sistema di credenze, schemi cognitivi, stili comportamentali, ecc.) e
le implicazioni di mutamento insite nelle informazioni-aiuto si rivela
insostenibile, il beneficiato non può accettare di cambiare e il peso di questa
difficoltà viene proiettato sul beneficiante. L'informazione donata e non
elaborata rimane a livello dell'io, ristagna e diventa un qualcosa di stantio,
di "rancido", di inespresso che risulta insopportabile. Un qualcosa che alimenta
un incessante rimuginio, sostenuto anche dalla vergogna e dal senso di colpa.
Nasce l'esigenza di eliminare il fastidio e il senso di oppressione, esigenza
che conduce all'odio verso la causa (il beneficiante) di tanto "dolore". Si
instaura così un circolo vizioso nel pensiero a cui solo gli sfoghi rabbiosi
possono dare un minimo, seppur temporaneo, sollievo. Gli eccessi di rabbia
costituiscono l'unica soluzione per tentare una comunicazione (impossibile)
attraverso la naturale via dell'affettività. Pertanto, il rancore trova un’auto
giustificazione in quanto permette di manifestare al mondo e alla persona
beneficante contenuti mentali che non trovano altre modalità espressive.
Altra storica menzogna è stata sbugiardata da "Mai più terroni. La fine della
questione meridionale" di Pino Aprile. Come abbattere i pregiudizi che
rendono il meridione diverso? Come mettere fine a una questione costruita ad
arte sulla pelle di una parte d'Italia? La risposta sta anche negli strumenti di
comunicazione odierni, capaci di abbattere i confini, veri o fittizi, rompere
l'isolamento, superare le carenze infrastrutturali. E se per non essere più
"meridionali" bastasse un clic? Con la sua solita vis polemica, Pino Aprile ci
apre un mondo per mostrare quanto questo sia vero, potente e dilagante. "Ops...
stanno finendo i terroni. Ma come, già? E così, da un momento all'altro?"
Terroni a chi? Tre libri sul pregiudizio antimeridionale. Come è
nata e come si è sviluppata la diffidenza verso il Sud. Tre libri ne
ricostruiscono le origini e provano a ipotizzarne gli scenari.
"Negli ormai centocinquant'anni di unità italiana il Mezzogiorno non ha mai
mancato di creare problemi". D'accordo, la frase è netta e controversa. Sulla
questione meridionale, nell'ultimo secolo e mezzo, si sono sprecati fiumi di
inchiostro, tonnellate di pagine, migliaia di convegni. In gran parte dedicati
all'indagine sociologica, al pregiudizio politico o alla rivendicazione
identitaria. Ciò che colpisce allora di "La palla al piede" di Antonino
De Francesco (Feltrinelli) è lo sguardo realistico e l'approccio
empirico. De Francesco è ordinario di Storia moderna all'Università degli studi
di Milano, ma definire il suo ultimo lavoro essenzialmente storico è quantomeno
limitativo. In poco meno di duecento pagine, l'autore traccia l'identikit di
un pregiudizio, quello antimeridionale appunto, nei suoi aspetti sociali,
storici e politici. Lo fa rincorrendo a una considerevole pubblicistica per
niente autoreferenziale, che non si ostina nel solito recinto storiografico. Il
risultato si avvicina a una controstoria dell'identità italiana e, al tempo
stesso, a un'anamnesi dei vizi e dei tic dell'Italia Unita. Ma per raccontare
una storia ci si può ovviamente mettere sulle tracce di una tradizione e
cercare, attraverso le sue strette maglie, di ricostruire una vicenda che ha il
respiro più profondo di una semplice schermaglia localistica. E' quello che
accade nel "Libro napoletano dei morti" di Francesco Palmieri
(Mondadori). Racconta la Napoli eclettica e umbratile che dall’Unità d'Italia
arriva fino alla Prima guerra mondiale. Per narrarla, si fa scudo della voce del
poeta napoletano Ferdinando Russo ricostruendo con una certa perizia filologica
e una sottile verve narrativa le luci e le smagliature di un'epopea in
grado di condizionare la realtà dei giorni nostri. Ha il respiro del pamphlet
provocatorio e spiazzante invece l'ultimo libro di Pino Aprile, "Mai più
terroni" (Piemme), terzo volume di una trilogia di successo (Terroni
e Giù al Sud i titoli degli altri due volumi). Aprile si domanda se oggi
abbia ancora senso dividere la realtà sulla base di un fantomatico
pregiudizio etnico e geografico che ha la pretesa di tagliare Nord e Sud. E
si risponde che no, che in tempi di iperconnessioni reali (e virtuali), quelli
stereotipo è irrimediabilmente finito. "Il Sud - scrive - è un luogo che non
esiste da solo, ma soltanto se riferito a un altro che lo sovrasta". Nelle nuove
realtà virtuali, vecchie direzioni e punti cardinali non esistono più, relegati
come sono a un armamentario che sa di vecchio e obsoleto.
D'altronde siamo abituati alle stronzate dette da chi in mala fede parla e le
dice a chi, per ignoranza, non può contro ribattere. Cominciamo a dire: da quale
pulpito viene la predica. Vediamo in Inghilterra cosa succede. I sudditi inglesi
snobbano gli italiani. Ci chiamano mafiosi, ma perché a loro celano la verità.
Noi apprendiamo la notizia dal tg2 delle 13.00 del 2 gennaio 2012. Il loro
lavoro è dar la caccia ai criminali, ma alcuni ladri non sembrano temerle: le
forze di polizia del Regno sono state oggetto di furti per centinaia di migliaia
di sterline, addirittura con volanti, manette, cani ed uniformi tutte sparite
sotto il naso degli agenti. Dalla lista, emersa in seguito ad una richiesta
secondo la legge sulla libertà d'informazione, emerge che la forza di polizia
più colpita è stata quella di Manchester, dove il valore totale degli oggetti
rubati arriva a quasi 87.000 sterline. Qui i ladri sono riusciti a fuggire con
una volante da 10.000 sterline e con una vettura privata da 30.000.
E poi. Cosa sarebbe oggi la Germania se avesse sempre onorato con puntualità il
proprio debito pubblico? Si chiede su “Il Giornale” Antonio Salvi, Preside
della Facoltà di Economia dell’Università Lum "Jean Monnet". Forse non a
tutti è noto, ma il Paese della cancelliera Merkel è stato protagonista di uno
dei più grandi, secondo alcuni il più grande, default del secolo scorso,
nonostante non passi mese senza che Berlino stigmatizzi il comportamento vizioso
di alcuni Stati in materia di conti pubblici. E invece, anche la Germania, la
grande e potente Germania, ha qualche peccatuccio che preferisce tenere
nascosto.
Polentoni (mangia polenta o come dicono loro po' lentoni, ossia lenti di
comprendonio) e terroni (cafoni ignoranti) sono pregiudizi da campagna
elettorale inventati ed alimentati da chi, barbaro, dovrebbe mettersi la
maschera in faccia e nascondersi e tacere per il ladrocinio perpetrato anche a
danno delle stesse loro popolazioni.
Ma si sa parlar male dell'altro, copre le proprie colpe.
Terroni a chi? Tre libri sul pregiudizio antimeridionale. Come è nata e come si
è sviluppata la diffidenza verso il Sud. Tre libri ne ricostruiscono le origini
e provano a ipotizzarne gli scenari.
"Negli ormai centocinquant'anni di unità italiana il Mezzogiorno non ha mai
mancato di creare problemi". D'accordo, la frase è netta e controversa. Sulla
questione meridionale, nell'ultimo secolo e mezzo, si sono sprecati fiumi di
inchiostro, tonnellate di pagine, migliaia di convegni. In gran parte dedicati
all'indagine sociologica, al pregiudizio politico o alla rivendicazione
identitaria. Ciò che colpisce allora di "La palla al piede" di Antonino
De Francesco (Feltrinelli) è lo sguardo realistico e l'approccio empirico. De
Francesco è ordinario di Storia moderna all'Università degli studi di Milano, ma
definire il suo ultimo lavoro essenzialmente storico è quantomeno limitativo. In
poco meno di duecento pagine, l'autore traccia l'identikit di un pregiudizio,
quello antimeridionale appunto, nei suoi aspetti sociali, storici e politici. Lo
fa rincorrendo a una considerevole pubblicistica per niente autoreferenziale,
che non si ostina nel solito recinto storiografico. Il risultato si avvicina a
una controstoria dell'identità italiana e, al tempo stesso, a un'anamnesi dei
vizi e dei tic dell'Italia Unita. Ma per raccontare una storia ci si può
ovviamente mettere sulle tracce di una tradizione e cercare, attraverso le sue
strette maglie, di ricostruire una vicenda che ha il respiro più profondo di una
semplice schermaglia localistica. E' quello che accade nel "Libro napoletano
dei morti" di Francesco Palmieri (Mondadori). Racconta la Napoli eclettica e
umbratile che dall’Unità d'Italia arriva fino alla Prima guerra mondiale. Per
narrarla, si fa scudo della voce del poeta napoletano Ferdinando Russo
ricostruendo con una certa perizia filologica e una sottile verve
narrativa le luci e le smagliature di un'epopea in grado di condizionare la
realtà dei giorni nostri. Ha il respiro del pamphlet provocatorio e spiazzante
invece l'ultimo libro di Pino Aprile, "Mai più terroni" (Piemme), terzo
volume di una trilogia di successo (Terroni e Giù al Sud i titoli
degli altri due volumi). Aprile si domanda se oggi abbia ancora senso dividere
la realtà sulla base di un fantomatico pregiudizio etnico e geografico che ha la
pretesa di tagliare Nord e Sud. E si risponde che no, che in tempi di
iperconnessioni reali (e virtuali), quelli stereotipo è irrimediabilmente
finito. "Il Sud - scrive - è un luogo che non esiste da solo, ma soltanto se
riferito a un altro che lo sovrasta". Nelle nuove realtà virtuali, vecchie
direzioni e punti cardinali non esistono più, relegati come sono a un
armamentario che sa di vecchio e obsoleto.
Il sud? Una palla al piede? “La palla al piede. Una storia del pregiudizio
antimeridionale” è il libro di Antonino De Francesco. Declinata in negativo, è
tornata a essere un argomento ricorrente nei discorsi sulla crisi della società
italiana. Sprechi di risorse pubbliche, incapacità o corruzione delle classi
dirigenti locali, attitudini piagnone delle collettività, forme diffuse di
criminalità sono stati spesso evocati per suggerire di cambiare registro nei
riguardi del Mezzogiorno. I molti stereotipi e luoghi comuni sono di vecchia
data e risalgono agli stessi anni dell'unità, ma quel che conta è la loro radice
propriamente politica. Fu infatti la delusione per le difficoltà incontrate nel
Mezzogiorno all'indomani dell'unificazione a cancellare presto l'immagine di un
Sud autentico vulcano di patriottismo che nel primo Ottocento aveva dominato il
movimento risorgimentale. Da allora lo sconforto per una realtà molto diversa da
quella immaginata avrebbe finito per fissare e irrobustire un pregiudizio
antimeridionale dalle tinte sempre più livide ogni qual volta le vicende dello
stato italiano andarono incontro a traumatici momenti di snodo. Il libro rilegge
la contrapposizione tra Nord e Sud dal tardo Settecento sino ai giorni nostri.
Si capisce così in che modo il pregiudizio antimeridionale abbia costituito una
categoria politica alla quale far ricorso non appena l'innalzamento del livello
dello scontro politico lo rendesse opportuno. Per il movimento risorgimentale il
Mezzogiorno rappresentò sino al 1848 una terra dal forte potenziale
rivoluzionario. Successivamente, la tragedia di Pisacane a Sapri e le modalità
stesse del crollo delle Due Sicilie trasformarono quel mito in un incubo: le
regioni meridionali parvero, agli occhi della nuova Italia, una terra
indistintamente arretrata. Nacque così un'Africa in casa, la pesante palla al
piede che frenava il resto del paese nel proprio slancio modernizzatore. Nelle
accuse si rifletteva una delusione tutta politica, perché il Sud, anziché un
vulcano di patriottismo, si era rivelato una polveriera reazionaria. Si
recuperarono le immagini del meridionale opportunista e superstizioso,
nullafacente e violento, nonché l'idea di una bassa Italia popolata di lazzaroni
e briganti (poi divenuti camorristi e mafiosi), comunque arretrata, nei
confronti della quale una pur nobile minoranza nulla aveva mai potuto. Lo
stereotipo si diffuse rapidamente, anche tramite opere letterarie,
giornalistiche, teatrali e cinematografiche, e servì a legittimare vuoi la
proposta di una paternalistica presa in carico di una società incapace di
governarsi da sé, vuoi la pretesa di liberarsi del fardello di un mondo reputato
improduttivo e parassitario. Il libro ripercorre la storia largamente
inesplorata della natura politica di un pregiudizio che ha condizionato
centocinquant'anni di vita unitaria e che ancora surriscalda il dibattito in
Italia. I meridionali sono allegri e di buon cuore ma anche «oziosi, molli e
sfibrati dalla corruzione». Sono simpatici e affettuosi, è un altro giudizio
sempre sulla gente del Sud, ma pure «cinici, superstiziosi, pronti a rispondere
con la protesta di piazza a chi intende disciplinarli». A separare il barone di
Montesquieu e Giorgio Bocca, (sono dette da loro queste opinioni sul
Mezzogiorno), vi sono circa 250 anni. Eppure nemmeno i secoli contano e fanno la
differenza quando si tratta di sputar sentenze sul meridione. Così scrive
Mirella Serri su “La Stampa”. Già, proprio così. Credevamo di esser lontani
anni luce dall’antimeridionalismo (il suo viaggio nell’Inferno
del Sud, Bocca lo dedica alla memoria di Falcone e di Borsellino), pensavamo di
essere comprensivi e attenti alle diversità? Macché, utilizziamo gli stessi
stereotipi di tantissimi lustri fa: è questa la provocazione lanciata dallo
storico Antonino De Francesco in un lungo excursus in cui esamina tutte le
dolenti note su
"La palla al
piede. Una storia del pregiudizio antimeridionale".
La nascita dei pregiudizi sul Sud si verifica, per il professore, nel secolo dei
Lumi, quando numerosi viaggiatori europei esplorarono i nostri siti più
incontaminati e selvaggi. E diedero vita a una serie di luoghi comuni sul
carattere dei meridionali che si radicarono dopo l’Unità d’Italia e che hanno
continuato a crescere e a progredire fino ai nostri giorni. E non basta. A farsi
portavoce e imbonitori di questa antropologia negativa sono stati spesso
artisti, scrittori, registi, giornalisti, ovvero quell’intellighentia anche del
Sud che l’antimeridionalismo l’avrebbe dovuto combattere accanitamente.
Uno dei primi a intuire questa responsabilità degli intellettuali fu il
siciliano Luigi Capuana. Faceva notare a Verga che loro stessi, i maestri
veristi, avevano contribuito alla raffigurazione del siculo sanguinario con
coltello e lupara facile. E che sulle loro tracce stava prendendo piede il
racconto di un Mezzogiorno di fuoco con lande desolate, sparatorie, sgozzamenti,
rapine, potenti privi di scrupoli e plebi ignare di ordine e legalità. Ad
avvalorare questa narrazione che investiva la parte inferiore dello Stivale
dettero il loro apporto anche molti altri autori, da Matilde Serao, che si
accaniva sui concittadini partenopei schiavi dell’attrazione fatale per il gioco
del lotto, a Salvatore di Giacomo, che dava gran rilievo all’operato della
camorra in
Assunta Spina.
Non fu esente dall’antimeridionalismo nemmeno il grande Eduardo De Filippo che
in
Napoli
milionaria
mise in luce il sottomondo della città, fatto di mercato nero, sotterfugio,
irregolarità. Anche il cinema neorealista versò il suo obolo antisudista con
film come
Rocco e i suoi
fratelli
di Luchino Visconti, testimonial dei cruenti e insondabili rapporti familiari e
sociali dei meridionali. Pietro Germi, ne
In nome della
legge,
e Francesco Rosi, ne
Le mani sulla
città,
vollero denunciare i mali del Sud ma paradossalmente finirono per evidenziare i
meriti degli uomini d’onore come agenzia interinale o società onorata nel
distribuire ai più indigenti lavori e mezzi di sussistenza, illegali ovviamente.
A rendere la Sicilia luogo peculiare del trasformismo politico che contaminerà
tutto lo Stivale ci penserà infine il
Gattopardo
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. In generale prevale il ritratto di un Sud
antimoderno e clientelare, palla al piede del Nord. Milano, per contrasto, si
fregerà dell’etichetta di «capitale morale», condivisa tanto dal meridionalista
Salvemini quanto da Camilla Cederna, non proprio simpatizzante del Sud.
Quest’ultima, per attaccare il presidente della Repubblica Giovanni Leone, reo
di aver fatto lo scaramantico gesto delle corna in pubblico, faceva riferimento
alla sua napoletanità, sinonimo di «maleducazione, smania di spaghetti,
volgarità». «L’antimeridionalismo con cui ancora oggi la società italiana si
confronta non è così diverso da quello del passato», commenta De Francesco. Non
c’è dubbio.
Benvenuti al Sud,
che di questi antichi ma persistenti pregiudizi ha lanciato la parodia, si è
posizionato al quinto posto nella classifica dei maggiori incassi in Italia di
tutti i tempi. Come un vigile che si materializza nell’ora di punta o un
poliziotto che sopraggiunge nel vivo della rissa. Dopo le polemiche sugli afrori
dei napoletani, dopo le dispute sul bidet dei Borbone e sulle fogne dei Savoia,
mai libro è arrivato più puntuale. Edito da Feltrinelli, «La palla al piede» di
Antonino De Francesco è, infatti, come recita il sottotitolo, «una storia del
pregiudizio antimeridionale». E come tale non solo capita a proposito, ma riesce
anche a dare ordine a una materia per molti versi infinita e dunque
inafferrabile. Cos’è del resto l’antimeridionalismo? «È — spiega l’autore a
Marco Demarco su “Il Corriere della Sera” — un giudizio tanto sommario quanto
inconcludente, che nulla toglie e molto (purtroppo) aggiunge ai problemi
dell’Italia unita, perché favorisce il declino nelle deprecazioni e permette
alle rappresentazioni, presto stereotipate, di prendere il sopravvento». Non
solo. «Ed è — aggiunge De Francesco — anche un discorso eversivo, perché corre
sempre a rimettere in discussione il valore stesso dell’unità italiana». Fin qui
la quarta di copertina, ma poi, all’interno, pagina dopo pagina, ecco i testi,
le tesi, i personaggi che hanno affollato la scena dello scontro tra
meridionalisti e antimeridionali: da Boccaccio a Matilde Serao, da Montesquieu a
Prezzolini, passando per Cuoco e Colletta, per Lauro e Compagna, per Mastriani e
Totò. Fino a Indro Montanelli, che commentando il milazzismo picchia duro sui
siciliani e scrive che «se in Italia si compilasse una geografia dell’abbraccio
ci si accorgerebbe che più si procede verso le regioni in cui esso
rigogliosamente fiorisce, e più frequente si fa l’uso del coltello e della
pistola, della lettera anonima e dell’assegno a vuoto»; o a Camilla Cederna, che
addirittura mette in forse la religiosità del presidente Leone: «Tutt’al più —
scrive in piena campagna per le dimissioni — il suo è un cristianesimo di
folclore...». Materiali preziosi, alcuni noti e altri no, ma tutti riletti
all’interno di uno schema molto chiaro. Che è il seguente: negli anni di fuoco a
ridosso dell’unità d’Italia, l’antimeridionalismo nasce molto prima del
meridionalismo, non ha lasciato testimonianze meritevoli di interesse sotto il
profilo culturale, ma, «ha svolto un preciso ruolo normativo nell’immaginario
sociale del mondo». Ha creato, cioè, categorie mentali, visioni e schemi
interpretativi che hanno condizionato politiche e strategie, alleanze e scelte
di campo. In questo senso, l’antimeridionalismo si è rivelato per quello che
davvero è: niente altro che uno strumento della lotta politica.
L’antimeridionalismo appare e scompare, va e viene, morde e fugge, ma sempre
secondo le convenienze del momento storico, del contesto. Così a Masaniello può
accadere una volta di assurgere a simbolo del riscatto meridionale e di essere
messo sullo stesso asse rivoluzionario che porta fino al ’99, quando del Sud
serve l’immagine tutta tesa al riscatto liberatorio; un’altra di precipitare a
testimonianza del velleitarismo plebeo, di un ribellismo pari a quello dei
briganti, quando del Sud bisogna dare invece l’idea di un mostro da abbattere.
Sulla stessa altalena possono salirci anche interi territori, come la Sicilia.
Quella pre-garibaldina immaginata dalle camicie rosse è tutto un ribollire di
passioni civili e di ansie anti borboniche; quella post-garibaldina descritta
dai militari piemontesi è violenta, barbara, incivile. È andata così anche con
il Cilento di Pisacane: prima dello sbarco, era la terra promessa del sogno
risorgimentale; dopo, la culla del tradimento e del popolo imbelle. Perfino la
considerazione della camorra cambia secondo il calcolo politico. Nel 1860 la
stampa piemontese, prova ne è «Mondo illustrato», arriva perfino a elogiarla,
ritenendola capace di dare organizzazione ai lazzaroni favorevoli al cambio di
regime. Ma poi la scena si ribalta. Con Silvio Spaventa comincia l’epurazione
del personale sospetto inserito negli apparati statali e la «Gazzetta del
Popolo» prontamente plaude. Come strumento della battaglia politica,
l’antimeridionalismo non viene usato solo nello scontro tra Cavour e Garibaldi,
ma diventa una costante. Liberali e democratici lo usano per giustificare le
rispettive sconfitte. E come alibi usano sempre il popolo, che di colpo diventa
incolto, superstizioso, asociale, ingovernabile. Ai socialisti succede di
peggio. Negli anni del positivismo, arrivano, sulle orme di Lombroso, a
cristallizzare il razzismo antimeridionale. Niceforo parla di due razze, la
peggiore, la maledetta, è naturalmente quella meridionale; mentre Turati, in
polemica con Crispi, vede un Nord tutto proiettato nella modernità e un Sud che
è «Medio Evo» e «putrefatta barbarie». Prende forma così quel dualismo culturale
che vede ovunque due popoli, uno moderno e l’altro arretrato, dove è chiaro che
il secondo, come già ai tempi di Cuoco, giustifica il primo. Ma questo dualismo
finisce per mettere in trappola anche la produzione culturale. I veristi, ad
esempio, raccontano con passione la vita degli ultimi, della minorità sociale.
Ma come vengono lette a Milano queste storie? Chi fa le dovute differenze? Il
dubbio prende ad esempio Luigi Capuana quando decide di polemizzare con
Franchetti e Sonnino per come hanno descritto la Sicilia. Capuana addebita
addirittura a se stesso, a Federico De Roberto e soprattutto all’amico Giovanni
Verga, la grave responsabilità di aver favorito, con i loro racconti e con i
loro romanzi, la ripresa dei luoghi comuni sull’isola. Credevamo di produrre
schiette opere d’arte — scrive avvilito a Verga — «e non abbiamo mai sospettato
che la nostra sincera produzione, fraintesa o male interpretata, potesse venire
adoperata a ribadire pregiudizi, a fortificare opinioni storte, a provare
insomma il contrario di quel che era nostra sola intenzione rappresentare alla
fantasia dei lettori». E in effetti, commenta De Francesco, l’opera di Verga,
nel corso degli anni Settanta, aveva liquidato l’immagine di una Sicilia esotica
e mediterranea a tutto vantaggio della costruzione di potenti quadri di miseria
e di atavismo. Il libro si chiude con il caso Bocca, forse il più emblematico
degli ultimi anni. Inviato nel Sud sia negli anni Novanta, sia nel 2006.
Racconta sempre la stessa Napoli, persa tra clientele, degrado e violenza
criminale, ma la prima volta piace alla sinistra; la seconda, invece, la stessa
sinistra lo condanna senza appello. La ragione? Prima Bassolino era
all’opposizione, poi era diventato sindaco e governatore.
Ed a proposito di Napoli. “Il libro napoletano dei morti” di Francesco Palmieri.
Bella assai è Napoli. E non nel senso sciuè sciuè. E’ bella perché sta
archiviando una menzogna: quella di essere costretta allo stereotipo e infatti
non ha più immondizia per le strade. Non ha più quella patina di pittoresco
tanto è vero che il lungomare Caracciolo, chiuso al traffico, è come un
ventaglio squadernato innanzi a Partenope. C’è tutto un brulicare di vita nel
senso proprio della qualità della vita. Ovunque ci sono vigili urbani, tante
sono le vigilesse in bici, sono sempre più pochi quelli che vanno senza casco e
quelli che li indossano, i caschi, anche integrali, non hanno l’aria di chi sta
per fare una rapina. E’ diventata bella d’improvviso Napoli. Sono uno spasso gli
ambulanti abusivi che se ne scappano per ogni dove inseguiti dalla forza
pubblica e se qualcuno crede che il merito sia di De Magistris, il sindaco, si
sbaglia. Se Napoli è tornata capitale – anche a dispetto di quella persecuzione
toponomastica che è la parola “Roma”, messa dappertutto per marchiare a fuoco la
sconfitta dell’amato Regno – il motivo è uno solo: Francesco Palmieri ha scritto
“Il Libro napoletano dei Morti” e le anime di don Ferdinando Russo e quelle dei
difensori di Gaeta hanno preso il sopravvento sui luoghi comuni. Dall'Unità
d'Italia alla Prima guerra mondiale, Napoli vive il suo periodo più splendido e
più buio. Un'epopea di circa sessant'anni non ancora raccontata e che ne ha
segnato il volto attuale. Le vicende avventurose dei capitani stranieri,
arrivati per difendere la causa persa dei Borbone, s'intrecciano con quelle di
camorristi celebri e dei loro oscuri rapporti con il nuovo Stato italiano. L'ex
capitale si avvia verso il Novecento tra contraddizioni storiche e sociali
risolte nel sangue o in un paradossale risveglio culturale. Ma, quando calerà il
sipario sul drammatico processo Cuocolo, un clamoroso assassinio in Galleria
rivelerà che la camorra non è stata sconfitta. E il "prequel" della futura
Gomorra. Narratore dell'intera vicenda è il poeta Ferdinando Russo. Celebre un
tempo e amato dalle donne, da giornalista ha coraggiosamente denunciato la
malavita ma è stato attratto dai codici antichi di coraggio della guapparia.
Russo cerca il fil rouge che collega i racconti dei cantastorie napoletani alla
tragica fine dei capitani borbonici: questo nesso lo ritrova nell'ineffabile
enigma della Sirena Partenope, la Nera, l'anima stessa di Napoli, che si rivela
nel coltello dei camorristi o irretisce incarnata in quelle sciantose di cui fu
vittima egli stesso, prima con un grande amore perso poi sposando un'altra che
invece non amò.
“Il libro napoletano dei morti” è un viaggio alle radici di Gomorra, scrive Luca
Negri su “L’Occidentale”. Esiste un antico Libro egiziano dei morti, anche uno
tibetano. In poche parole, si tratta di affascinanti manuali di sopravvivenza
per l’anima nei regni dell’oltretomba. La versione italica, universalmente nota
per l’altissimo valore poetico, è la Commedia di Dante. Commedia appunto perché
il finale è lieto: l’anima non si perde negli inferi, fra demoni, ma ascende a
Dio, come pressappoco succede nelle versioni egizia e tibetana. Ora il lettore
italiano ha a disposizione anche “Il libro napoletano dei morti” (Mondadori,
nella collana Strade Blu), che non è un manuale per cittadini partenopei ed
italiani prossimi alla fine. O forse sì, lo è. Soprattutto se consideriamo la
città sotto il Vesuvio come paradigmatica dei nodi irrisolti della nostra
esausta storia patria. Comunque, è un romanzo, un grande romanzo, il migliore
uscito quest’anno, a nostro giudizio. Per lo stile felicissimo che combina
momenti lirici, squarci storici, immagini cinematografiche. E poi riesce a
toccare temi universali, partendo da un luogo e da un tempo ben precisi: Napoli
negli anni che corrono dalla conquista garibaldina all’avvento del fascismo.
L’autore si chiama Francesco Palmieri, è un maestro di Kung Fu napoletano che
nella vita fa il giornalista e si occupa di economia e Cina. Uno che conosce
bene misteri d’oriente, vicende e canzoni della sua città e come va la vita. Per
raccontare il suo libro dei morti, Palmieri è entrato nell’esistenza e nella
lingua di Ferdinando Russo, poeta, giornalista, romanziere e paroliere di
canzoni (la più nota è “Scetate”) nato ovviamente a Napoli nel 1866 e morto nel
1927. Russo era amico di d’Annunzio, firma di punta del quotidiano il Mattino,
partenopeo verace che detestava la napoletanità di maniera delle commedie di
Eduardo Scarpetta e nelle cantate di Funiculì funicolà. Per lui, come per
l’amico-nemico Libero Bovio (autore di “Reginella”), le canzoni con il mandolino
rappresentavano il Romanticismo esploso a Napoli con cinquant’anni di ritardo
sul resto d’Europa, non roba da cartolina. Russo era una persona seria ed
onorata, un guappo, cultore di Giordano Bruno e conoscitore di molti camorristi
ma sempre spregiatore della camorra. E con i suoi occhi e le sue parole vere e
immaginarie, in versi e prosa, Palmieri ci racconta proprio la degenerazione
della camorra: dalla confraternita fondata e regolata nel 1842 nella Chiesa di
Santa Caterina a Formello, figlia di “semi spagnoli e nere favole mediterranee”
alle spietate bande di “malavitosi senza norma e senza morale”. Al guappo armato
solo di scudiscio e coltello, talvolta della sola minacciosa presenza, si
sostituiscono “facce patibolari” bramose di soldi e potere, vigliacche al punto
da imbracciare solo armi da fuoco, che male modellano le mani di chi le usa.
Russo, fin da bambino, si ispirava al teatrino dei Pupi, si sentiva un paladino,
un Rinaldo sempre in lotta contro il male: il traditore Gano di Magonza. E vide
gli antichi paladini reincarnati negli stranieri che combatterono per la causa
persa dei Borbone contro i Piemontesi invasori. Non solo per il piacere di
“tirare una sassata sulla faccia di liberali biondi”, ma per difendere “più che
un principe, un principio”. Franceschiello diventava un novello Carlo Magno,
sconfitto, però da un’imponente macchina bellica che nemmeno schifava il
fomentare odi e delazioni e l’ammazzare cristiani appena sospettati di simpatia
per l’insorgenza, per i “briganti”. A proposito, Palmieri e Russo ci ricordano
che lo Stato risorgimentale si servì proprio della camorra per garantire
l’ordine nel regno conquistato ed assicurarsi il successo nel plebiscito del
1860. Il processo di corruzione dell’”Onorata Società” ben s’accompagnò a quello
del neonato Regno d’Italia; anzi, i rapporti si fecero sempre più stretti, i
fili più inestricabili, al di là di tutte le repressioni di facciata e della
professione retorica di antimafia. Sconfitti zuavi e lealisti, non rimarrà che
cercare la “presenza dei paladini nelle notti scugnizze”, fra i guappi non
ancora degenerati in spietati assassini ed avidi imprenditori senza scrupoli e
freni. Ma è sempre più difficile, la cavalleria scompare, i proiettili uccidono
anche gli innocenti. La camorra, circondata da una nazione irrisolta e corrotta,
svela il suo volto, la sua dipendenza dal “perenne problema demoniaco” legato
alla doppia natura della Sirena Partenope che come vuole la tradizione giace
sotto Napoli; creatura bellissima e mostruosa “che fu madre di quei pezzenti
tarantati, di cantanti e sciantose, di camorristi” e poeti come Russo. Siamo
allora sull’orlo del baratro, sotto il vulcano, a Gomorra, come epicentro delle
tensioni italiche. E allora serve più che mai “una mano capace di trasformare
qualsiasi cosa in Durlindana”, in spada da paladino. Con la consapevolezza
evangelica che fare il crociato, “crociarsi”, significa saper portare la propria
croce. Ed aiutare i propri simili in questo “strabiliante Purgatorio umano che
ci avvampa tra merda e sentimenti”.
"Mai più terroni. La fine della questione meridionale" di Pino Aprile. Come
abbattere i pregiudizi che rendono il meridione diverso? Come mettere fine a una
questione costruita ad arte sulla pelle di una parte d'Italia? La risposta sta
anche negli strumenti di comunicazione odierni, capaci di abbattere i confini,
veri o fittizi, rompere l'isolamento, superare le carenze infrastrutturali. E se
per non essere più "meridionali" bastasse un clic? Con la sua solita vis
polemica, Pino Aprile ci apre un mondo per mostrare quanto questo sia vero,
potente e dilagante. "Ops... stanno finendo i terroni. Ma come, già? E così, da
un momento all'altro?" Così Pino Aprile inizia, nel modo provocatorio che gli è
congeniale, questo suo pamphlet, che affronta l'annosa e scontata Questione
meridionale da un'angolatura completamente diversa. In un mondo che sta
cambiando a incredibile velocità, ha ancora senso definire la realtà in base a
criteri geografici, come quelli di Nord e Sud, che nell'interpretazione dei più
portano con sé una connotazione meritocratica ormai superata? E possibile
utilizzare ancora definizioni di questo tipo quando internet, la Rete, sta
tracciando una mappa che non tiene più conto dei vecchi confini, anzi se ne è
liberata per ridisegnare uno spazio davvero globale, senza Sud e senza Nord, di
cui fa parte la nuova generazione, tutta, figli dei "terroni" compresi? No, dice
Aprile, tutto questo è irrimediabilmente finito, passato, travolto dal vento
delle nuove tecnologie che, spinto da molte volontà, sta creando un futuro
comune, un futuro che unisce, invece di dividere. Forse i padri non se ne sono
ancora accorti, ma i figli sì, lo sanno, così come sanno che quella che hanno
imboccato è una strada di non ritorno. "Il Sud è un luogo che non esiste da
solo, ma soltanto se riferito a un altro che lo sovrasta." Ma nello spazio
virtuale, lo spazio dei giovani di tutti i paesi, le direzioni non esistono più.
Boom di vendite, dice Antonino Cangemi su “Sicilia Informazioni”. E’ quasi una
regola: ogni libro di Pino
Aprile scatena un boom di
vendite e un mare di polemiche.
Così è accaduto con “Terroni”
e con “Giù al Sud”. Nel primo il giornalista raccontava,
all’anniversario del secolo e mezzo dell’Unità d’Italia, stragi, violenze,
saccheggi, sottaciuti dalla storiografia ufficiale, commessi dal Settentrione
contro il Meridione per accentuarne la subalternità, provocando le ire dei
“nordisti” e le perplessità della maggior parte degli storici accademici. Nel
secondo il meridionalista Aprile ribadiva le denunce contro i soprusi subiti dal
Sud Italia, ma nello stesso tempo individuava nel Meridione le risorse migliori
per “salvare l’Italia”. Nelle librerie “Mai
più terroni”, un pamphlet edito da Piemme che
già dal sottotitolo, “La fine della questione meridionale”, preannuncia
dibattiti accesi.
Molti si chiederanno: come mai Pino Aprile paladino delle ragioni dei “terroni”,
che non ha esitato a denunciare, in modo eclatante, i torti subiti dalla gente
del Sud per opera di governi filosettentrionali, adesso cambia registro sino a
sostenere che la questione meridionale non esiste più? Che cosa è successo nel
giro di pochi anni? Lo si scopre leggendo l’agile saggio. Che sostiene una
teoria piuttosto originale. E, secondo alcuni, azzardata. Nell’era industriale
la distanza tra Nord e Sud si accentuava perché rilevava la posizione geografica
dei luoghi dove si produceva ricchezza. Poiché le fabbriche, o la stragrande
maggioranza di esse, si trovavano nel Settentrione, i meridionali erano
costretti a spostarsi per lavorare e, con l’emigrazione, a vivere in un rapporto
di sudditanza. Tutto è ora cambiato con l’avvento di internet. Nella stagione
che si è da ultimo avviata, definita da Aprile l’era del Web, la geografia dei
territori non assume più rilievo. La rete ha annullato le distanze geografiche,
e non importano più dove sono collocate le imprese, la condizione delle
sovrastrutture, se le autostrade o le ferrovie funzionano nel Nord e sono
dissestate nel Meridione, tanto non occorre percorrerle grazie alla magia
telematica. Almeno per i giovani, che a colpi di clic possono cambiare la
realtà, dare sfogo al proprio estro creativo, inventare nuove fonti di
ricchezza. Non a caso, sostiene l’autore, oggi l’omologazione del web ha fatto
sì che tanta ricchezza sia concentrata in Paesi del Sud del mondo, quali ad
esempio la Cina e l’India. D’altra parte, secondo Aprile “il Sud è un
luogo che non esiste da solo, ma soltanto se riferito a un altro che lo
sovrasta”. Non vi sarà perciò più Sud e non vi saranno più “terroni” per effetto
della rete che permette di viaggiare restando seduti e di superare ogni barriera
geografica. Niente più sopraffazioni e prevaricazioni. Alla fine la spunta,
nella competizione democratica del web, chi è più creativo. Ipse dixit Aprile.
E’ proprio cosi, o le sue analisi peccano di superficialità? La discussione è
aperta. Da "Terroni" a "Mai più terroni", spiega
Lino Patruno su “La
Gazzetta del Mezzogiorno”. Dal sottotitolo del primo libro («Tutto
quello che è stato fatto perché gli italiani del Sud diventassero meridionali»)
al sottotitolo di questo («La fine della questione meridionale»). È l’itinerario
di Pino Aprile: dalla denuncia di 150 anni ai danni del Sud, alla profezia che
fra poco il Sud non sarà più Sud e che gli italiani del Sud non saranno più
figli di una patria minore. Ci si chiede cosa sia successo in due soli anni. E
come il giornalista-scrittore pugliese dai libri tanto vendutissimi quanto
contestatissimi possa passare dalla rabbia per le verità nascoste sulla
conquista del Sud, alla convinzione che nonostante tutto il Sud è entrato nella
nuova era della parità di condizioni di partenza. Esagerazione ora o prima?La
risposta è nelle stesse parole di Aprile: «Per condannare i meridionali a uno
stato di minorità civile ed economica, sono state necessarie prima le armi e i
massacri, poi è bastato isolarli. Ma il web è viaggiare senza percorrere spazi:
scompare, così, lo svantaggio di ferrovie mai fatte e treni soppressi, di
autostrade e aeroporti mancanti. Il Sud è, da un momento all’altro, alla pari. E
può prendere il largo, su quella pista, perché per la prima volta, dopo 150
anni, è nelle stesse condizioni dei concorrenti». Dire web è dire Internet. Che
annulla le distanze: tu puoi stare in un qualsiasi posto del mondo e lavorare
per qualsiasi altro posto del mondo. E con Internet vale il tuo talento davanti
al computer e basta, anche se stai, chessò, a Matera, unica città italiana senza
il treno delle Ferrovie dello Stato. In questo senso Internet annulla anche le
differenze di opportunità fra i territori. Con un computer un cittadino in
Bangladesh ha le stesse possibilità di lavoro di un cittadino degli Stati Uniti.
Così Internet può cancellare anche l’attuale svantaggio del Sud, la sua
perifericità geografica: che lo Stato in 150 anni ha accentuato invece di
ridurla.
Come? Creando un divario nelle infrastrutture fra Centro Nord e Sud che supera
1140 per cento. E non solo infrastrutture materiali (dalle autostrade agli
aeroporti, appunto), ma anche immateriali (ricerca, formazione, sicurezza) e
sociali (scuole, ospedali, assistenza). Ecco perché il terrone per la prima
volta in 150 anni potrà cessare di emigrare. Facendo da casa ciò che finora può
fare soltanto andando via. E dimostrandosi, se lo è, bravo quanto un
privilegiato italiano del Centro Nord che finora ha avuto più possibilità di lui
perché la produzione di oggetti e il lavoro crescono dove ci sono più mezzi a
disposizione: a cominciare dalle infrastrutture. Il «capitale sociale», beni
pubblici alla base di qualsiasi sviluppo. Aprile ci ha abituato allo sguardo
lungo. Dopo quello all’indietro sulle bugie storiche verso il Sud, ecco ora
quello immaginifico su un futuro possibile a favore del Sud. Col superamento di
un ritardo tanto tenace e mortificante quanto mai affrontato con leggi e mezzi
necessari. E col sospetto che si fingesse di cambiare qualcosa per lasciare
tutto come prima. In poche parole: la ricchezza di una parte del Paese basata
sulla minore ricchezza dell’altra. Con Internet oggi si fanno la metà dei lavori
del mondo. E se finora il vantaggio del Nord era sfornare merci, ora il
vantaggio del Sud è poter sfornare idee. E di idee i giovani terroni scoppiano:
ecco la grande occasione comunicata con la perentorietà della rivelazione. Ovvio
che non tutto spunti per magia: anche i computer sono meno al Sud, e non c’è in
Italia quella banda larga che li faccia funzionare da computer e non da catorci.
Ma la forza evocativa, la visione di Aprile è contagiosa e irresistibile anche
quando suona più controversa e forse (stavolta) troppo ottimistica. Ma col
pessimismo non si fa nulla. E poi leggiamo questa sua sorta di libro-testamento:
ci sono racconti su ciò che fanno i giovani sudisti proiettati nel domani
tecnologico da convincere che il futuro d’Italia è proprio qui. Cose
entusiasmanti che nessuno avrebbe potuto immaginare (soprattutto in Puglia),
meno che mai chi non guarda, sentenzia. Come nessuno avrebbe potuto immaginare,
conclude Aprile, che ciò che non è riuscito ai padri, può riuscire ai figli.
Cosicché presto sarà solo un ricordo che per un secolo e mezzo fummo terroni. “Giù
al Sud. Perché i terroni salveranno l’Italia” di Pino Aprile è il
racconto di un’Italia ancora spaccata in due, di rancori non sopiti, di ferite
non rimarginate, dove i ricordi di un passato di sudditanza e soprusi non sono
stati cancellati. Ma è anche la storia di nuove generazioni, colte ed
intraprendenti, che fanno ribaltare atavici pregiudizi. Già autore di "Terroni",
l’autore conosce bene la Storia e si è documentato con serietà e rigore prima di
stendere denunce e dare aggiornamenti sulle nuove risorse. In questo viaggio giù
al sud si incontrano realtà inattese, che stimolano e inorgogliscono. Il libro
può essere letto per capitoli separati, ognuno spunto di riflessione. Lucida ed
interessante l’analisi della nuova generazione di trentenni meridionali,
colti, scaltri e fantasiosi, affamati di storia, di ricostruzione dell’identità
meridionale, avvertita come risorsa economica e personale. Esenti da quel senso
di inferiorità che spesso ha frenato e ancora frena i loro padri, si sentono e
sono cittadini del mondo, un mondo in cui si muovono sicuri. Forte è l’interesse
per l’antropologia in Calabria: è una necessità di sapere di
sé, è un “bisogno di passato”, di recupero di un terreno perduto.
Come l’Odisseo omerico, il cui futuro è nella sua radice: ha già fatto il
viaggio e ora torna a casa, per essere completo. Hanno desiderio e capacità di
riscatto, usano i problemi come risorse, hanno idee, e le portano avanti con
creatività e fiducia. Sono interessati alla riscoperta di nomi e bellezze, di
luoghi e di cose, dalla toponomastica all’agricoltura, alla produzione di olii,
vini, pani; forte l’orgoglio e il senso di appartenenza, per una terra
“ritrovata”, per la forza fisica e morale delle sue donne, per la musica che si
miscela alla poesia di antichi testi grecanici, che i giovani studiano e
tramandano. In questo viaggio si incontra la Murgia, “giardino
di ulivi, ricamo di vigne, regione di orgoglio” grazie alla tenacia dei suoi
abitanti, che dalla sterile roccia hanno fatto emergere terra grassa e feconda.
E poi la Puglia, dove “un deserto si è fatto un orto” a
prezzo di un lavoro disumano. Benessere e convivenza anche a Riace,
altra tappa di questo percorso, dove nel convivere e condividere di Calabresi ed
extra-comunitari integrati, o di passaggio, si evidenzia un forte senso di
ospitalità e umanità, e così a Sovereto, luogo di accoglienza per stranieri e
tossicodipendenti, luogo di rinascita fisica e morale. Esaltanti le tante storie
di giovani coraggiosi, ricchi di ingegno ed iniziative, che restano nella loro
terra, rendendola migliore. Di contro, altri emigrati sembrano voler prendere le
distanze dai luoghi natii, rinnegando le proprie origini, disprezzando ciò che
si è perso e sopravalutando ciò che si è acquisito, in una sorta di “amputazione
della memoria”.
La minorità del Calabrese è atavica, è un senso di inferiorità non scalfito dal
tempo. Le privazioni subite, l’espoliazione delle antiche ricchezze, hanno
costruito ed alimentato la minorità meridionale.
Ma bisogna reagire, esorta l’autore, cercando la solidarietà e l’appoggio di
tutti al Nord, perché tutti sappiano, perché si raggiunga un equilibrio perduto.
I testi di Pino Aprile sono il tentativo di un riscatto storico, quello di
un’Italia che 160 anni fa aveva una propria identità di stato e che dopo l’Unità
l’ha persa, col dominio del Nord sul Sud; sono un’esortazione, soprattutto per i
giovani, al recupero di questa identità. Questo testo è una guida, ricca,
aggiornata, colta, che va al di là ed oltre i luoghi e la Storia, è un compendio
di storie personali e familiari, che si intersecano col territorio, sino a
trasformarlo, ad arricchirlo, a renderlo appetibile. Le pagine più belle sono
quelle descrittive, in cui i luoghi fisici si trasformano in luoghi dell’anima;
Vieste e il suo faraglione, la cui sommità uno stilita rubava ad un gabbiano;
Aliano, in Lucania, nella valle dell’Agri, “fra due marce muraglie di terra
lebbrosa, tagliata dal fiume e dai suoi affluenti, disciolta dalla pioggia,
butterata dal sole, che asciuga e svuota gli alveoli di creta.” … e la loro
struggente bellezza si fonde nella malinconia dell’abbandono, mentre l’animo si
perde nel sublime di fronte ai calanchi “orridi, belli e paurosi”. La
presenza di elementi naturali, come il mare, il vento e l’energia che da essi si
crea, conferisce forza e pathos ai movimenti dell’uomo sulla terra, rendendo le
vicende umane grandiose. Lo sguardo dell’autore ha il privilegio della
lontananza, che consente una visione d’insieme, quindi più completa e reale. Le
sue parole trasudano orgoglio di appartenenza, ampiezza di orizzonti, fisici e
mentali. Sono arrivato alla fine del libro, ma non sono riuscito a trovare una
risposta alla domanda che mi ero fatta leggendo il sottotitolo del libro: perché
i terroni dovrebbero salvare l'Italia? Così commenta Rocco Biondi. Non vedo un
motivo plausibile che dovrebbe spingere i meridionali, che per 150 anni sono
stati annientati dalla cultura e dall'economia nordista, ad avere un qualsiasi
interesse ad impegnarsi in un qualche modo per risollevare le sorti dell'Italia
cosiddetta unita. Questa convinzione mi proviene dall'attenta lettura fatta a
suo tempo di "Terroni" ed ora di "Giù al Sud". I due libri di Pino Aprile sono
accomunati dal riuscito tentativo di indicare possibili strade di "guerriglia
culturale" per far uscire i meridionali dalla minorità cui sono stati condannati
dagli artefici della malefica unità. La strada maestra è stata ed è la ricerca
della "propria storia denigrata e taciuta". E questa fame di storia è avvertita
come risorsa economica e personale. Si cercano i documenti, si scrive l'altra
storia, quella della stragrande maggioranza degli abitanti del Sud che dopo il
1860 si sono opposti alla invasione piemontese. Si scoprono i nostri padri
briganti, che hanno lottato e sono morti per la loro terra, le loro famiglie, la
loro patria. Si dà vita a progetti artistici che hanno come protagonista il
proprio passato, del quale non ci si vergogna più. Per andare avanti bisogna
ripartire da quel che eravamo e da quel che sapevamo. I nostri antenati subirono
e si auto-imposero la cancellazione forzosa della verità storica. Bisogna
riscoprirla questa verità se vogliamo diventare quello che meritiamo di essere.
Nel Sud i guai arrivarono con l'Unità. Le tasse divennero feroci per «tenere in
piedi la bilancia dei pagamenti del nuovo Stato e concorsero a finanziare
l'espansione delle infrastrutture nel Nord».A danno del Sud, dove le
infrastrutture esistenti vennero smantellate. Messina, perno commerciale
dell'intera area dello Stretto, perse il privilegio di porto franco, con
scomparsa di molte migliaia di posti di lavoro. La Calabria, che oggi appare
vuota e arretrata, era partecipe di fermenti e traffici della parte più avanzata
d'Europa. In Calabria si producevano bergamotto, seta, gelsomino, lavanda,
agrumi, olio, liquirizia, zucchero di canna. Per favorire l'industria del Nord
si provocò il crollo dell'agricoltura specializzata del Sud, chiudendo i suoi
mercati che esportavano oltralpe. Scrive Pino Aprile: «L'Italia non è solo elmi
cornuti a Pontida, pernacchie padane e bunga bunga».L'Italia è anche la somma di
tantissime singolarità positive esistenti nel Sud. E il suo libro è la
narrazione, quasi resoconto, degli incontri avuti con queste realtà nei suoi
viaggi durati tre anni dopo l'uscita di "Terroni". Pino Aprile si chiede ancora:
«Perché la classe dirigente del Sud non risolve il problema del Sud, visto che
il Nord non ha interesse a farlo?». E risponde: perché la classe dirigente
nazionale è quasi tutta settentrionale, perché il Parlamento è a trazione
nordica, perché le banche sono tutte settentrionali o centrosettentrionali,
perché l'editoria nazionale è quasi esclusivamente del Nord, perché la grande
industria è tutta al Nord e solo il 7,5 per cento della piccola e media
industria è meridionale. E allora che fare? «Finché resterà la condizione
subordinata del Sud al Nord - scrive Pino Aprile -, la classe dirigente del Sud
avrà ruoli generalmente subordinati. Quindi non "risolverà", perché dovrebbe
distruggere la fonte da cui viene il suo potere delegato. Si può fare; ma si
chiama rivoluzione o qualcosa che le somiglia. E può essere un grande, pacifico
momento di acquisizione di consapevolezza, maturità. Succede, volendo».E non ci
si può limitare alla denuncia, bisogna lasciarsi coinvolgere direttamente e
personalmente, per governare questi fenomeni.
Negli Stati Uniti d'America i persecutori hanno saputo pacificarsi con le loro
vittime indiane, riconoscendo il loro sacrificio ed onorandole. In Italia questo
non è ancora avvenuto, gli invasori piemontesi non hanno ancora riconosciuto le
motivazioni della rivolta contadina e dei briganti. Noi meridionali dobbiamo
pretendere questo riconoscimento. Noi meridionali l'unità l'abbiamo subita, non
vi è stata un'adesione consapevole. Nei fatti essa unità è consistita nel
progressivo ampliamento del Piemonte, con l'applicazione forzata delle sue
leggi, strutture, tasse e burocrazia. Il Sud, ridotto a colonia, doveva smettere
di produrre merci, per consumare quelle del Nord: da concorrente, a cliente. Non
è vero che la mafia esiste solo al Sud. Milano è la principale base operativa
per 'ndrangheta e mafia siciliana, dove si trasforma il potere criminale in
potere economico, finanziario, politico. Stiamo per uscire dalla minorità, dopo
un sonno di un secolo e mezzo, il Sud sembra aprire gli occhi. Lo sconfitto
smette di vergognarsi di aver perso e recupera il rispetto per la propria
storia. L'interesse primario dei meridionali non deve essere quello di salvare
l'Italia, ma quello di valorizzare se stessi. Solo indirettamente e
conseguentemente, forse, potrà avvenire il salvataggio dell'Italia intera.
SE NASCI IN
ITALIA…
Quando si
nasce nel posto sbagliato e si continua a far finta di niente.
Steve Jobs è
cresciuto a Mountain View, nella contea di Santa Clara, in California. Qui, con
il suo amico Steve Wozniak, fonda la Apple Computer, il primo aprile del 1976.
Per finanziarsi, Jobs vende il suo pulmino Volkswagen, e Wozniak la propria
calcolatrice. La prima sede della nuova società fu il garage dei genitori: qui
lavorarono al loro primo computer, l’Apple I. Ne vendono qualcuno, sulla carta,
solo sulla base dell’idea, ai membri dell’Homebrew Computer Club. Con l’impegno
d’acquisto, ottengono credito dai fornitori e assemblano i computer, che
consegnano in tempo. Successivamente portano l’idea ad un industriale, Mike
Markkula, che versa, senza garanzie, nelle casse della società la somma di
250.000 dollari, ottenendo in cambio un terzo di Apple. Con quei soldi Jobs e
Wozniak lanciano il prodotto. Le vendite toccano il milione di dollari. Quattro
anni dopo, la Apple si quota in Borsa.
Io sono
Antonio Giangrande, noto autore di saggi pubblicati su Amazon, che raccontano
questa Italia alla rovescia. A tal fine tra le tante opere da me scritte vi è
“Italiopolitania. Italiopoli degli italioti”. Di questo, sicuramente, non gliene
fregherà niente a nessuno. Fatto sta che io non faccio la cronaca, ma di essa
faccio storia, perché la quotidianità la faccio raccontare ai testimoni del loro
tempo. Certo che anche di questo non gliene può fregar di meno a tutti. Ma una
storiella raccontata da Antonio Menna che spiega perché, tu italiano, devi darti
alla fuga dall’Italia, bisogna proprio leggerla. Mettiamo che Steve Jobs sia
nato in Italia. Si chiama Stefano Lavori. Non va all’università, è uno
smanettone. Ha un amico che si chiama Stefano Vozzini. Sono due appassionati di
tecnologia, qualcuno li chiama ricchioni perchè stanno sempre insieme. I due
hanno una idea. Un computer innovativo. Ma non hanno i soldi per comprare i
pezzi e assemblarlo. Si mettono nel garage e pensano a come fare. Stefano Lavori
dice: proviamo a venderli senza averli ancora prodotti. Con quegli ordini
compriamo i pezzi. Mettono un annuncio, attaccano i volantini, cercano
acquirenti. Nessuno si fa vivo. Bussano alle imprese: “volete sperimentare un
nuovo computer?”. Qualcuno è interessato: “portamelo, ti pago a novanta giorni”.
“Veramente non ce l’abbiamo ancora, avremmo bisogno di un vostro ordine
scritto”. Gli fanno un ordine su carta non intestata. Non si può mai sapere. Con
quell’ordine, i due vanno a comprare i pezzi, voglio darli come garanzia per
avere credito. I negozianti li buttano fuori. “Senza soldi non si cantano
messe”. Che fare? Vendiamoci il motorino. Con quei soldi riescono ad assemblare
il primo computer, fanno una sola consegna, guadagnano qualcosa. Ne fanno un
altro. La cosa sembra andare. Ma per decollare ci vuole un capitale maggiore.
“Chiediamo un prestito”. Vanno in banca. “Mandatemi i vostri genitori, non
facciamo credito a chi non ha niente”, gli dice il direttore della filiale. I
due tornano nel garage. Come fare? Mentre ci pensano bussano alla porta. Sono i
vigili urbani. “Ci hanno detto che qui state facendo un’attività commerciale.
Possiamo vedere i documenti?”. “Che documenti? Stiamo solo sperimentando”. “Ci
risulta che avete venduto dei computer”. I vigili sono stati chiamati da un
negozio che sta di fronte. I ragazzi non hanno documenti, il garage non è a
norma, non c’è impianto elettrico salvavita, non ci sono bagni, l’attività non
ha partita Iva. Il verbale è salato. Ma se tirano fuori qualche soldo di
mazzetta, si appara tutto. Gli danno il primo guadagno e apparano. Ma il giorno
dopo arriva la Finanza. Devono apparare pure la Finanza. E poi l’ispettorato del
Lavoro. E l’ufficio Igiene. Il gruzzolo iniziale è volato via. Se ne sono andati
i primi guadagni. Intanto l’idea sta lì. I primi acquirenti chiamano entusiasti,
il computer va alla grande. Bisogna farne altri, a qualunque costo. Ma dove
prendere i soldi? Ci sono i fondi europei, gli incentivi all’autoimpresa. C’è un
commercialista che sa fare benissimo queste pratiche. “State a posto, avete una
idea bellissima. Sicuro possiamo avere un finanziamento a fondo perduto almeno
di 100mila euro”. I due ragazzi pensano che è fatta. “Ma i soldi vi arrivano a
rendicontazione, dovete prima sostenere le spese. Attrezzate il laboratorio,
partire con le attività, e poi avrete i rimborsi. E comunque solo per fare la
domanda dobbiamo aprire la partita Iva, registrare lo statuto dal notaio, aprire
le posizioni previdenziali, aprire una pratica dal fiscalista, i libri contabili
da vidimare, un conto corrente bancario, che a voi non aprono, lo dovete
intestare a un vostro genitore. Mettetelo in società con voi. Poi qualcosa per
la pratica, il mio onorario. E poi ci vuole qualcosa di soldi per oliare il
meccanismo alla regione. C’è un amico a cui dobbiamo fare un regalo sennò il
finanziamento ve lo scordate”. “Ma noi questi soldi non ce li abbiamo”. “Nemmeno
qualcosa per la pratica? E dove vi avviate?”. I due ragazzi decidono di chiedere
aiuto ai genitori. Vendono l’altro motorino, una collezione di fumetti. Mettono
insieme qualcosa. Fanno i documenti, hanno partita iva, posizione Inps, libri
contabili, conto corrente bancario. Sono una società. Hanno costi fissi. Il
commercialista da pagare. La sede sociale è nel garage, non è a norma, se
arrivano di nuovo i vigili, o la finanza, o l’Inps, o l’ispettorato del lavoro,
o l’ufficio tecnico del Comune, o i vigili sanitari, sono altri soldi. Evitano
di mettere l’insegna fuori della porta per non dare nell’occhio. All’interno del
garage lavorano duro: assemblano i computer con pezzi di fortuna, un po’
comprati usati un po’ a credito. Fanno dieci computer nuovi, riescono a
venderli. La cosa sembra poter andare. Ma un giorno bussano al garage. E’ la
camorra. Sappiamo che state guadagnando, dovete fare un regalo ai ragazzi che
stanno in galera. “Come sarebbe?”. “Pagate, è meglio per voi”. Se pagano,
finiscono i soldi e chiudono. Se non pagano, gli fanno saltare in aria il
garage. Se vanno alla polizia e li denunciano, se ne devono solo andare perchè
hanno finito di campare. Se non li denunciano e scoprono la cosa, vanno in
galera pure loro. Pagano. Ma non hanno più i soldi per continuare le attività.
Il finanziamento dalla Regione non arriva, i libri contabili costano, bisogna
versare l’Iva, pagare le tasse su quello che hanno venduto, il commercialista
preme, i pezzi sono finiti, assemblare computer in questo modo diventa
impossibile, il padre di Stefano Lavori lo prende da parte e gli dice “guagliò,
libera questo garage, ci fittiamo i posti auto, che è meglio”. I due ragazzi si
guardano e decidono di chiudere il loro sogno nel cassetto. Diventano garagisti.
La Apple in Italia non sarebbe nata, perchè saremo pure affamati e folli, ma se
nasci nel posto sbagliato rimani con la fame e la pazzia, e niente più.
DIRITTO E
GIUSTIZIA. I TANTI GRADI DI GIUDIZIO E L’ISTITUTO DELL’INSABBIAMENTO.
In Italia,
spesso, ottenere giustizia è una chimera. In campo penale, per esempio, vige un
istituto non previsto da alcuna norma, ma, di fatto, è una vera consuetudine.
In contrapposizione al Giudizio Perenne c’è l’Insabbiamento.
Rispetto al
concorso esterno all’associazione mafiosa, un reato penale di stampo togato e
non parlamentare, da affibbiare alla bisogna, si contrappone una norma non
scritta in procedura penale: l’insabbiamento dei reati sconvenienti.
A chi è privo
di alcuna conoscenza di diritto, oltre che fattuale, spieghiamo bene come si
forma l’insabbiamento e quanti gradi di giudizio ci sono in un sistema che a
livello scolastico lo si divide con i fantomatici tre gradi di giudizio.
Partiamo col
dire che l’insabbiamento è applicato su un fatto storico corrispondente ad un
accadimento che il codice penale considera reato.
Per il sistema
non è importante la punizione del reato. E’ essenziale salvaguardare, non tanto
la vittima, ma lo stesso soggetto amico, autore del reato.
A fatto
avvenuto la vittima incorre in svariate circostanze che qui si elencano e che
danno modo a più individui di intervenire sull’esito finale della decisione
iniziale.
La vittima,
che ha un interesse proprio leso, ha una crisi di coscienza, consapevole che la
sua querela-denuncia può recare nocumento al responsabile, o a se stessa: per
ritorsione o per l’inefficienza del sistema, con le sue lungaggini ed anomalie.
Ciò le impedisce di proseguire. Se si tratta di reato perseguibile d’ufficio,
quindi attinente l’interesse pubblico, quasi sempre il pubblico ufficiale omette
di presentare denuncia o referto, commettendo egli stesso un reato.
Quando la
denuncia o la querela la si vuol presentare, scatta il disincentivo della
polizia giudiziaria.
Ti mandano da
un avvocato, che si deve pagare, o ti chiedono di ritornare in un secondo tempo.
Se poi chiedi l’intervento urgente delle forze dell’ordine con il numero verde,
ti diranno che non è loro competenza, ovvero che non ci sono macchine, ovvero di
attendere in linea, ovvero di aspettare che qualcuno arriverà………
Quando in
caserma si redige l’atto, con motu proprio o tramite avvocato, scatta il
consiglio del redigente di cercare di trovare un accordo e poi eventualmente
tornare per la conferma.
Quando l’atto
introduttivo al procedimento penale viene sottoscritto, spesso l’atto stanzia in
caserma per giorni o mesi, se addirittura non viene smarrito o dimenticato…
Quando e se
l’atto viene inviato alla procura presso il Tribunale, è un fascicolo come tanti
altri depositato su un tavolo in attesa di essere valutato. Se e quando….. Se il
contenuto è prolisso, non viene letto. Esso, molte volte, contiene il nome di un
magistrato del foro. Non di rado il nome dello stesso Pubblico Ministero
competente sul fascicolo. Il fascicolo è accompagnato, spesso, da una
informativa sul denunciante, noto agli uffici per aver presentato una o più
denunce. In questo caso, anche se fondate le denunce, le sole presentazioni
dipingono l’autore come mitomane o pazzo.
Dopo mesi
rimasto a macerare insieme a centinaia di suoi simili, del fascicolo si chiede
l’archiviazione al Giudice per le Indagini Preliminari. Questo senza aver svolto
indagini. Se invece vi è il faro mediatico, allora scatta la delega delle
indagini e la comunicazione di garanzia alle varie vittime sacrificali. Per
giustificare la loro esistenza, gli operatori, di qualcuno, comunque, ne
chiedono il rinvio a giudizio, quantunque senza prove a carico.
Tutti i
fascicoli presenti sul tavolo del Giudice per l’Udienza Preliminare contengono
le richieste del Pubblico Ministero: archiviazione o rinvio a giudizio. Sono
tutte accolte, a prescindere. Quelle di archiviazione, poi, sono tutte accolte,
senza conseguire calunnia per il denunciante, anche quelle contro i magistrati
del foro. Se poi quelle contro i magistrati vengono inviate ai fori competenti a
decidere, hanno anche loro la stessa sorte: archiviati!!!
Il primo grado
si apre con il tentativo di conciliazione con oneri per l’imputato e
l’ammissione di responsabilità, anche quando la denuncia è infondata, altrimenti
la condanna è già scritta da parte del giudice, collega del PM, salvo che non ci
sia un intervento divino, (o fortemente terrestre sul giudice), o salvo che non
interviene la prescrizione per sanare l’insanabile. La difesa è inadeguata o
priva di potere. Ci si tenta con la ricusazione, (escluso per il pm e solo se il
giudice ti ha denunciato e non viceversa), o con la rimessione per legittimo
sospetto che il giudice sia inadeguato, ma in questo caso la norma è stata
sempre disapplicata dalle toghe della Cassazione.
Il secondo
grado si apre con la condanna già scritta, salvo che non ci sia un intervento
divino, (o fortemente terrestre sul giudice), o salvo che non interviene la
prescrizione per sanare l’insanabile. Le prove essenziali negate in primo grado,
sono rinegate.
In terzo grado
vi è la Corte di Cassazione, competente solo sull’applicazione della legge.
Spesso le sue sezioni emettono giudizi antitetici. A mettere ordine ci sono le
Sezioni Unite. Non di rado le Sezioni Unite emettono giudizi antitetici tra
loro. Per dire, la certezza del diritto….
Durante il
processo se hai notato anomalie e se hai avuto il coraggio di denunciare gli
abusi dei magistrati, ti sei scontrato con una dura realtà. I loro colleghi
inquirenti hanno archiviato. Il CSM invece ti ha risposto con una frase
standard: “Il CSM ha deliberato l’archiviazione non essendovi provvedimenti di
competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di censure ad attività
giurisdizionale”.
Quando il
processo si crede che sia chiuso, allora scatta l’istanza al Presidente della
Repubblica per la Grazia, ovvero l’istanza di revisione perchè vi è stato un
errore giudiziario. Petizioni quasi sempre negate.
Alla fine di
tutto ciò, nulla è definitivo. Ci si rivolge alla Corte Europea dei diritti
dell’Uomo, che spesso rigetta. Alcune volte condanna l’Italia per denegata
giustizia, ma solo se sei una persona con una difesa capace. Sai, nella Corte ci
sono italiani.
Per i
miscredenti vi è un dato, rilevato dal foro di Milano tratto da un articolo di
Stefania Prandi del “Il Fatto Quotidiano”. “Per le donne che subiscono
violenza spesso non c’è giustizia e la responsabilità
è anche della magistratura”. A lanciare l’accusa sono avvocate e
operatrici della Casa di accoglienza delle donne maltrattate di
Milano che puntano il dito contro la Procura della Repubblica di
Milano, “colpevole” di non prendere sul serio le denunce delle
donne maltrattate. Secondo i dati su 1.545 denunce per
maltrattamento in famiglia (articolo 572 del Codice penale) presentate da donne
nel 2012 a Milano, dal Pubblico ministero sono arrivate 1.032
richieste di archiviazione; di queste 842 sono state accolte
dal Giudice per le indagini preliminari. Il che significa che più della metà
delle denunce sono cadute nel vuoto. Una tendenza che si
conferma costante nel tempo: nel 2011 su 1.470 denunce per maltrattamento ci
sono state 1.070 richieste di archiviazione e 958
archiviazioni. Nel 2010 su 1.407 denunce, 542 sono state archiviate.
«La tendenza è
di archiviare, spesso de plano, cioè senza svolgere alcun
atto di indagine, considerando le denunce manifestazioni di
conflittualità familiare – spiega Francesca Garisto,
avvocata Cadmi – Una definizione, questa, usata troppe volte in modo acritico,
che occulta il fenomeno della violenza familiare e porta alla
sottovalutazione della credibilità di chi denuncia i maltrattamenti
subiti. Un atteggiamento grave da parte di una procura e di un tribunale
importanti come quelli di Milano». Entrando nel merito della
“leggerezza” con cui vengono affrontati i casi di violenza, Garisto
ricorda un episodio accaduto di recente: «Dopo una denuncia di violenza
anche fisica subita da una donna da parte del marito, il pubblico
ministero ha richiesto l’archiviazione de plano qualificandola
come espressione di conflittualità familiare e giustificando la violenza fisica
come possibile legittima difesa dell’uomo durante un litigio».
Scarsa anche
la presa in considerazione delle denunce per il reato di stalking
(articolo 612 bis del codice penale). Su 945 denunce fatte nel 2012, per 512 è
stata richiesta l’archiviazione e 536 sono state archiviate. Per il reato di
stalking quel che impressiona è che le richieste di archiviazione e le
archiviazioni sono aumentate, in proporzione, negli anni. In passato, infatti,
la situazione era migliore: 360 richieste di archiviazione e
324 archiviazioni su 867 denunce nel 2011,
235 richieste di archiviazione e 202
archiviazioni su 783 denunce nel 2010. Come stupirsi, dunque,
che ci sia poca fiducia nella giustizia da parte delle donne?
Manuela Ulivi, presidente Cadmi ricorda che soltanto il 30 per
cento delle donne che subiscono violenza denuncia. Una percentuale bassa dovuta
anche al fatto che molte, in attesa di separazione, non
riescono ad andarsene di casa ma sono costrette a rimanere a vivere con il
compagno o il marito che le maltrattata. Una scelta forzata dettata spesso dalla
presenza dei figli: su 220 situazioni di violenza seguite dal
Cadmi nel 2012, il 72 per cento (159) ha registrato la presenza di minori, per
un totale di 259 bambini.
Non ci
dobbiamo stupire poi se la gente è ammazzata per strada od in casa. Chiediamoci
quale fine ha fatto la denuncia presentata dalla vittima. Chiediamoci se chi ha
insabbiato non debba essere considerato concorrente nel reato.
Quando la
giustizia è male amministrata, la gente non denuncia e quindi meno sono i
processi, finanche ingiusti. Nonostante ciò vi è la prescrizione che per i più,
spesso innocenti, è una manna dal cielo. In queste circostanze vien da dire:
cosa hanno da fare i magistrati tanto da non aver tempo per i processi e
comunque perché paghiamo le tasse, se non per mantenerli?
GIUSTIZIA
DA MATTI E MOSTRI A PRESCINDERE.
Giustizia
da matti.
L'ultima follia delle toghe: un'indagine sul morso di Suarez, scrive Filippo
Facci su “Libero Quotidiano”. Una giornata come un’altra, quella di ieri 8
luglio 2014: assolvono i vertici di una delle prime aziende italiane (Mediaset)
dopo aver però condannato il fondatore, condannano intanto il pluri-governatore
dell’Emilia Romagna che perciò si dimette, aprono un’inchiesta surreale sul
morso di Suarez a Chiellini - non l’inchiesta della Fifa: un'altra inchiesta
tutta italiana - e per finire la magistratura apre, di passaggio, anche
un’indagine sul concorso per magistratura. Questo senza contare le polemiche per
gli sms inviati da un sottosegretario alla giustizia (un magistrato) i quali
invitavano a votare un candidato per le elezioni del Csm, e senza contare,
appunto, le elezioni del Csm, e senza contare, ancora, le dure parole del
procuratore generale milanese Manlio Minale in polemica con l’archiviazione
dell’esposto del procuratore aggiunto Alfredo Robledo contro il procuratore capo
Edmondo Bruti Liberati per presunte irregolarità nelle assegnazioni - prendete
respiro - dopodiché Bruti Liberati ha provveduto a nuove assegnazioni che hanno
portato a un nuovo esposto del procuratore aggiunto Robledo: tutto chiaro, no?
Una giornata come un’altra, quella di ieri: e non dite che la magistratura sia
un potere ormai incontrollabile e irresponsabile, perché potrebbero punirvi e
togliervi i benefici di legge, non dite che la magistratura occupi ormai tutta
la scena e, ormai priva di contrappesi, si stia cannibalizzando e al tempo
stesso respinga qualsiasi riforma che possa farla riassomigliare a qualcosa di
normale: non fate i berlusconiani, non fate i renziani travestiti. Da che cosa
dovremmo incominciare? Quanto dovrebbe essere lungo, questo articolo, se davvero
volessimo approfondire i vari addendi della giornata di ieri? Anche perché è la
somma che lascia storditi. La Procura di Roma ha aperto un’indagine sul morso di
Suarez durante Uruguay-Italia: l’ipotesi è violenza privata. Che dire? Come
commentare? Cioè: davvero in questo preciso momento c’è un pubblico dipendente -
ciò che è un magistrato - che sta occupandosi di questa sciocchezza per via di
una denuncia del Codacons? E che gliene frega, al Codacons, del morso degli
uruguaiani? Ma soprattutto: che ce ne frega, a noi, in un Paese che affoga nelle
cause arretrate e dove gli imprenditori rinunciano ai contenziosi perché
durerebbero 15 anni?
Poi c’è
l’indagine della magistratura sul concorso per magistratura: e qui, invece, che
cosa dovremmo pensare? Già è assurdo che basti un pubblico concorso, subito dopo
gli studi universitari, per trascorrere tutta la vita da magistrato e percorrere
automaticamente tutte le tappe di una lunga carriera: ma - domanda - è solo una
battuta chiedersi che razza di magistrati possano uscire da un concorso
truccato? Il concorso è quello del 25 e 26 e 27 giugno scorsi: un candidato ha
denunciato una serie di irregolarità, il solito impiccione di un Codacons ha
chiesto l’accesso ai verbali della commissione, c’è stata un’interrogazione
parlamentare bipartisan, su un banco hanno trovato tre codici vidimati e
timbrati dalla commissione nonostante il regolamento ne vietasse l’utilizzo: non
male. Una candidata è stata scoperta mentre scriveva un tema prima ancora che la
traccia venisse dettata: e questa ragazza, se passerà il concorso, finirà sino
alla Cassazione. Stiamo facendo i brillanti e gli spiritosi? Rischiamo di
scivolare, dite, nel qualunquismo anticasta? Ovunque rischiamo di scivolare, in
verità, ci siamo già scivolati: è da almeno vent’anni che questo Paese è
subordinato all’azione sempre più discrezionale delle magistrature: procure e
tribunali avanzano in territori che appartenevano alla politica e l’imprigionano
come i laccetti che imbrigliavano Gulliver. Quando non ci sarà più nessun
mediocre politico con cui prendercela, forse, sarà a tutti più chiaro.
Strage
Borsellino, errori o depistaggi? Ecco la storia “Dalla parte sbagliata”.
In libreria nei primi giorni di luglio 2014 il volume di Rosalba De Gregorio,
legale di sette imputati ingiustamente condannati nel primo processo su via
D'Amelio, e Dina Lauricella, giornalista di Servizio pubblico. La redazione de
“Il Fatto Quotidiano” ne anticipa un brano. “Chi si nasconde dietro quel tanto
vituperato «terzo livello» che ha legato mafia e pezzi delle Istituzioni
attraverso il «papello», ha verosimilmente lo stesso profilo di chi ha ucciso il
giudice Borsellino e di chi per 22 anni ci ha dato in pasto una storia da due
lire, alla quale abbiamo voluto credere per sedare la diffusa ansia di giustizia
che ha scosso il Paese nell’immediato dopo strage”, scrivono l’avvocato Rosalba
Di Gregorio e la giornalista Dina Lauricella nel libro “Dalla parte sbagliata”,
edito da Castelvecchi, con prefazione del magistrato Domenico Gozzo.Tre
processi, 15 anni di indagini, 11 persone ingiustamente condannate all’ergastolo
e un nuovo processo, il “borsellino quater” che sta rimettendo tutto in
discussione. Che cosa sappiamo oggi della strage di via d’Amelio e della morte
di Paolo Borsellino? Davvero poco se consideriamo che la procura di
Caltanissetta ha chiesto la revisione del vecchio processo. Un nuovo pentito,
Gaspare Spatuzza, ha rimescolato le carte e oggi in aula, chi stava sul banco
degli imputati, siede fra le parti civili. È il caso “dell’avvocato di mafia”
Rosalba Di Gregorio, che da oltre vent’anni grida al vento le anomalie di un
processo che si è basato sulle affermazioni di uno dei pentiti più anomali che i
nostri tribunali abbiano mai visto, Vincenzo Scarantino. Per tutti e tre i gradi
di giudizio ha inutilmente difeso 7 degli imputati condannati all’ergastolo
(oggi tornati in libertà grazie alle dichiarazioni di Spatuzza), e nel libro
racconta, con l’impeto e la passione che le è propria, in una sorta di diario di
bordo, questi lunghi anni di processi e sentenze. Dina Lauricella, inviata di
Servizio Pubblico, riavvolge il nastro di questa oscura storia del nostro Paese
provando a riguardarla da una nuova prospettiva. I due punti di osservazione
speciale sono quelli dell’ex pentito Vincenzo Scarantino e dell’avvocato Di
Gregorio, legale di numerosi boss di Cosa Nostra, tra cui Bernardo Provenzano,
Michele Greco e Vittorio Mangano. “Un racconto che parte dal basso, sicuramente
di parte, dalla parte sbagliata, per costringerci all’esercizio di tornare
indietro nel tempo, per sbarazzarci della confusione accumulata negli anni e,
atti alla mano, rimettere al posto giusto le poche pedine certe”. Le stesse
sulle quali, a 22 anni di distanza, è tornata ad indagare la procura di
Caltanissetta. Seri e rodati cronisti, formati nell’aula bunker di Palermo
durante il maxi processo, arrivati per primi sulle macerie e sui corpi dilaniati
di via d’Amelio, hanno una fitta al cuore al pensiero che nei successivi 15 anni
di vicende giudiziarie hanno visto, sentito e raccontato una storia che è
crollata all’improvviso mostrandosi in tutta la sua fragilità. È stato l’ex
procuratore generale di Caltanissetta Roberto Scarpinato a chiedere che i
processi «Borsellino» e «Borsellino bis» venissero revisionati a seguito delle
rivelazioni del nuovo collaboratore, Gaspare Spatuzza. È per questo che tre anni
fa, undici imputati, di cui sette condannati all’ergastolo, sono tornati in
libertà. Clamoroso errore giudiziario o vile depistaggio che sia, la storia è da
riscrivere e chi ha penna non dovrebbe risparmiare inchiostro. Ne serve molto
per raccontare fedelmente i punti salienti dei tre processi che dal 1996 al 2008
hanno indagato sull’omicidio Borsellino. Sarebbe una semplificazione
giornalistica dire che dobbiamo buttare all’aria tutti questi anni per colpa di
Scarantino o di chi ha creduto in lui. Le sentenze del Borsellino ter, infatti,
sopravvivono al terremoto Spatuzza, ma non è un caso: in questo processo
Scarantino non ha alcun ruolo. Carcere a vita per l’allora latitante Bernardo
Provenzano e per altri 10 imputati di grosso calibro, nessuno dei quali tirato
in ballo da Scarantino. Questo troncone scaturisce infatti dalle dichiarazioni
di mafiosi doc come Giovanni Brusca, Salvatore Cancemi, Giovan Battista Ferrante
o Calogero Ganci. Il processo che la Procura di Catania dovrà revisionare,
quando Caltanissetta stabilirà se Scarantino è o meno un calunniatore, come
emerso dalle dichiarazioni di Spatuzza, è il Borsellino bis. È qui che Enzino fa
da pilastro. Faticherà a distinguere i nomi dei mafiosi che coinvolge, non li
riconoscerà in foto, talvolta si contraddirà, ma a fronte di un’informativa del
Sisde che metteva in luce la sua parentela con il boss Salvatore Profeta, ha
goduto di una fiducia che si è rivelata a dir poco esagerata.
Mostri a
prescindere. Misteri e depistaggi. Finti pentiti e inchieste sballate.
La strage palermitana di via Mariano D’Amelio, dove il 19 luglio 1992 morirono
Paolo Borsellino e 5 agenti di scorta, non è soltanto uno dei peggiori drammi
italiani: è anche uno dei più velenosi ingorghi giudiziari di questo Paese,
scrive Rosalba Di Gregorio su “Panorama”. Tre processi, decine d’imputati, 7
persone ingiustamente condannate all’ergastolo e tenute in carcere 18 anni per
le false verità (incassate senza riscontri dai magistrati) del pentito Vincenzo
Scarantino. Poi una nuova inchiesta, partita nel giugno 2008, ha iniziato a
ribaltare tutto grazie alle rivelazioni (stavolta riscontrate) di Gaspare
Spatuzza. Nel marzo 2013, a Caltanissetta, è iniziato un nuovo procedimento,
con nuovi imputati: il "Borsellino quarter". Da oltre 21 anni Rosalba Di
Gregorio, avvocato di Bernardo Provenzano e altri boss di Cosa nostra, contesta
nei tribunali le anomalie di una giustizia che si è mostrata inaffidabile come
alcuni dei suoi peggiori collaboratori. Con Dina Lauricella, giornalista di
Servizio pubblico, la penalista cerca adesso di riannodare i fili di una delle
vicende più sconcertanti della nostra giustizia e lo fa in un libro difficile e
duro, ma spietatamente onesto: Dalla parte sbagliata (Castelvecchi editore, 190
pagine, 16,50 euro). Per capire la portata del disastro d’illegalità di cui si
occupa il libro, bastano poche righe della prefazione scritta da Domenico Gozzo,
procuratore aggiunto a Caltanissetta: "Non ha funzionato la polizia. Non ha
funzionato la magistratura. Non hanno funzionato i controlli, sia disciplinari
sia penali. Non ha funzionato il Csm (...). Solo un avvocato di mafia ha gridato
le sue urla nel vuoto". Urla che non sono bastate a evitare mostruosi errori
giudiziari, per i quali nessun magistrato pagherà, e sofferenze indicibili per
le vittime di tanta malagiustizia. Panorama pubblica ampi stralci del diario di
una visita dell’avvocato Di Gregorio a un cliente sottoposto al "regime duro"
del 41 bis nel carcere di Pianosa, appena un mese dopo via D’Amelio. Piombino,
agosto 1992. Sotto il sole, all’imbarco, fa caldissimo anche se sono le 8 del
mattino. Consegno i documenti e aspetto, ci sono altri due o tre colleghi e
dobbiamo imbarcarci per Pianosa. Passano due ore di attesa e io cerco di capire
perché mi sento ansiosa: in fondo, al carcere, ci vado da tanti anni. Alcuni
colleghi mi hanno detto di vestirmi con abiti che possono essere buttati via,
perché a Pianosa c’è troppa sporcizia, e ho indossato zoccoletti di legno,
pantaloni di cotone e una maglia: tutto rigorosamente senza parti metalliche e
sufficientemente brutto. Aspettiamo ancora, sotto il sole, e non si capisce
perché. Tutte le autorizzazioni per i colloqui sono in regola e, infastidita
dall’attesa, vado al posto di polizia per capire. "È per colpa sua se ancora
non si parte". Non avevano previsto avvocati donne! Stanno convocando il
personale femminile che si occupa dei colloqui dei detenuti con i parenti. Si
parte. Il panorama è unico e spettacolare. Siamo arrivati a Pianosa e ci
accolgono poliziotti e grossi cani che si lanciano ad annusarci appena scesi da
una traballante passerella di legno. Meno male che non soffro di vertigini e non
ho paura dei cani! Benvenuti a Pianosa. Sbarcati sull’isola, ci informano che è
vietato avvicinarsi al mare, che non potremo acquistare né acqua, né altro:
dovremo stare digiuni e assetati fino alle 17 sotto il sole, perché non c’è
"sala avvocati", né luogo riparato ove attendere, né è consentito andare allo
"spaccio delle guardie". (...) La perquisizione per me non è una novità, penso
per rassicurarmi. E sbaglio. Nella stanzetta lurida, spoglia, vengo controllata
col metal detector. Non suona perché non ho nulla di metallico addosso e allora
sto per andarmene. Mi intimano di fermarmi, bisogna perquisire. Ma che
significa? La perquisizione manuale non ha senso visto che non ho oggetti
metallici. Chiedo a una delle due donne addette alla perquisizione perché ha
indossato i guanti di lattice. Le due si guardano e una bisbiglia: "No, forse a
lei no, perché fa l’avvocato". Ma che vuol dire? Ho imparato subito e ho
sperimentato anche in successive visite, che a Pianosa nessuno sorride, tutti
sembrano incazzati, gli avvocati sono i difensori dei mostri e quindi sembra che
l’ordine sia di trattarli male: loro sono lo Stato e noi i fiancheggiatori
dell’antistato. Questa etichetta, nei processi per le stragi del ’92, ce la
sentiremo addosso, ma in modo diverso, forse più subdolo, certamente più
sfumato: a Pianosa, invece, è proprio disprezzo. (...) Finalmente esco da
quella stanzetta, sudata, anche innervosita, e passo nell’altra stanza a
riprendermi il fascicolo di carte processuali, le sigarette e la penna per
prendere appunti. O, almeno, pensavo di riprendere queste cose, ma la mia penna
è "pericolosa" e mi danno una bic trasparente. Le mie sigarette resteranno lì,
perché, per perquisire il pacchetto, sono state tutte tirate fuori e sparse sul
bancone sporchissimo. Le mie carte processuali vengono lette, giusto per la
sacralità del diritto di difesa. Sono di nuovo con i miei colleghi e sono
nervosissima. Ci fanno salire su una jeep, con due del Gom, il Gruppo operativo
mobile del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che, seduti davanti
a noi, ci puntano i mitra in faccia, lungo tutto il percorso che va dal punto di
approdo alla "Agrippa". Terra battuta, campetti coltivati dai detenuti: gli
altri detenuti di Pianosa, non quelli del 41 bis. (...) Entriamo nella "sala
colloqui", se così può definirsi quella stanza stretta, divisa in due, per
tutta la sua lunghezza, da un muro di cemento ad altezza di tavolino, sormontato
dal famoso "vetro del 41 bis". Come sedile c’è un blocco di cemento, alle
nostre spalle c’è il "blindato" che viene chiuso rumorosamente. I rumori di
Pianosa sono particolari: non senti parlare nessuno, la consegna pare sia il
silenzio, senti solo rumori metallici, forti, sinistri, nel silenzio dell’isola.
Non parlano nemmeno i 5 detenuti che ci portano dall’altro lato del vetro. I
"boss" – fra loro c’erano anche incensurati, ma questo si scoprirà con 19 anni
di ritardo – hanno lo sguardo terrorizzato, si limitano ad abbassare la testa,
entrano già con la testa bassa e alle loro spalle viene rumorosamente chiuso il
"blindato". Provo a chiedere, per educazione, come stiano, ma nessuno risponde.
Io sono uscita da lì senza aver sentito la voce di nessuno di loro. Ma che
succede? Perché, anziché guardare me o ascoltarmi, questi guardano, verso
l’alto, alle mie spalle? Mi giro di scatto e vedo che lo sportellino del
blindato dietro di me, quello che era stato chiuso al mio ingresso, è stato
aperto e una guardia del Gom li osserva. No, forse è più giusto dire che li
terrorizza con lo sguardo. (...) Torno sulla jeep e sono sconvolta. Per pochi
minuti di non-colloquio, sono stata trattata come un delinquente. (...) Ho
parlato con giornalisti, con colleghi, con magistrati, al mio ritorno da Pianosa
e mi sono sentita dire che, in fondo, non ero obbligata ad andarci e che la
mafia aveva fatto le stragi. Inutile ribattere che alcuni di quelli che erano a
Pianosa erano presunti innocenti, persone in attesa di giudizio: in tempo di
guerra le garanzie costituzionali vengono sospese. (...) "In ogni caso" mi ha
detto un avvocato civilista illuminato "se hanno arrestato loro, vuol dire che,
come minimo, si sono messi nelle condizioni di essere sospettati". E già... Un
vantaggio estetico, però, c’è stato sicuramente. Alla mia seconda visita a
Pianosa ho trovato i miei assistiti in forma fisica migliore: tutti magri,
asciutti, quasi ossuti, direi. Il cibo razionato e immangiabile ha la sua
influenza sulla dieta. (...) Nel ’94 sono stati arrestati, grazie a Vincenzo
Scarantino, anche i futuri condannati (oggi scarcerati) del processo Borsellino
bis: tra questi, Gaetano Murana, Cosimo Vernengo, Giuseppe Urso e Antonino
Gambino erano incensurati e furono accusati da Scarantino di concorso nella
strage di via D’Amelio. Di questi solo Nino Gambino sarà assolto dalla grave
accusa d’aver partecipato al massacro del 19 luglio ’92. Gli altri, assolti in
primo grado dopo la ritrattazione di Scarantino, saranno condannati e poi
riarrestati a seguito dell’ulteriore ritrattazione della ritrattazione del
"pentito a corrente alternata". Oggi, dopo Gaspare Spatuzza, sono scarcerati.
Tutti, comunque, erano stati amorevolmente accolti nelle carceri di Pianosa e
Asinara. Uno di questi, a Pianosa, ha subìto una lesione alla retina, per lo
"schiaffo" di una guardia del Gom. A un altro sono state fratturate le costole.
(...) Racconta, oggi, Tanino Murana: "Appena entrato a Pianosa dopo
l’interrogatorio del gip, mi hanno portato alla “discoteca". La discoteca è il
nome che i detenuti hanno dato alle celle dell’isolamento, perché li si balla
per le percosse e per la paura. "Eppure" dice Tanino "so che dal ’92 al ’94, che
è quando arrivai io, si stava peggio. Alcuni detenuti mi hanno detto, poi,
quando li ho incontrati in altre carceri, che all’inizio il trattamento era
peggiore". E perché non glielo hanno raccontato subito, mentre eravate a
Pianosa? "Lì non si poteva parlare: si doveva stare in silenzio nelle celle a
tre, o quattro posti. Le guardie del Gom non ci volevano sentire neppure
bisbigliare. Ma questo vale da quando ci portavano in sezione. Alla discoteca si
stava in cella singola". Era l’isolamento. L’accoglienza al supercarcere
prevedeva, per iniziare, che il detenuto si spogliasse completamente e, nudo,
iniziasse a fare le flessioni sulle gambe... tante, fino a non avere più fiato
e, nel frattempo, veniva preso a botte dalle guardie, cinque, sei, otto... "Non
lo so quanti erano... a un certo punto non capivi più nulla e trascinandoti di
peso, ti portavano, nudo e stremato, fino alla cella, in discoteca,
scaraventandoti dentro la stanzetta spoglia e sporca". Qui iniziava la seconda
parte del trattamento: perquisizioni, flessioni, acqua e brodaglia razionati,
botte, di giorno e di notte, per non farti dormire. "Appena ti addormentavi
entravano le guardie, alcune pure incappucciate, spesso ubriache e davano pugni,
calci, schiaffi... Dopo un po’ di tempo ho chiesto che mi uccidessero, non ce la
facevo più". (...) Ma cosa vi davano da mangiare? "Una pagnotta al giorno, due
tetrapak di acqua e poi se riuscivi a mangiarlo, il piatto del giorno". Cosa
sarebbe? "Una brodaglia in cui, accanto a qualche pezzetto, o filo di pasta,
galleggiava roba di qualunque genere". E cioè? "Io una volta ho trovato pure un
preservativo". Ecco perché erano tutti magri e asciutti. Ecco perché, quando
Scarantino, nel corso del processo Borsellino, il 15 settembre ’98, ha
raccontato il suo trattamento a Pianosa, i detenuti sono rimasti impassibili e
noi avvocati avevamo voglia di vomitare. All’epoca, non volendo prestare fede a
Scarantino, neppure in ritrattazione, ho cercato di documentarmi. Ho trovato una
sentenza del pretore di Livorno10, a carico di due guardie del Gom, processate a
seguito della denuncia di un ex ospite di Pianosa, per fatti accaduti in
quell’isola "dal luglio ’92 all’08/01/94". (...)
La sentenza
(...) riporta il racconto del denunciante, giunto a Pianosa il 20 luglio ’92.
"Manganellate, strattoni, pedate, sputi e schiaffi", sia all’entrata, sia
all’uscita per andare all’aria. E se "all’aria" non ci andavi, il "trattamento"
ti veniva fatto in cella. Il tragitto lungo il corridoio era scivoloso (cera, o
detersivo, secondo altre fonti), così si cadeva a terra, diventando bersaglio
del "cordone " di 10 o 20 uomini del Gom, che si schieravano nel corridoio, a
dare libero sfogo al comportamento "animalesco". Racconta il denunciante – ma
non è solo lui, oggi, a riferirlo – che nello shampoo si trovava l’olio,
nell’olio si trovava lo shampoo e la pasta era a volte "condita" con i
detersivi. Nessuno all’epoca denunciava nulla, perché avevano tutti paura di
essere uccisi. Preferivano sopportare le angherie, le botte, gli scherzi,
"l’inutile crudeltà" come dice la sentenza. (...) A cosa serviva tanta
violenza? Scarantino, che narra d’averla subita tutta quella violenza, sostiene
d’essersi determinato a fare il "falso" pentito, perché non era capace più di
resistere e non solo alle costrizioni fisiche. Oggi, e nel tempo, ascoltando i
racconti di ex detenuti di Pianosa, ti accorgi che il ricordo più vivo sembra
quello delle torture psicologiche: le percosse hanno certamente segnato quei
corpi, ma te le narrano in modo quasi distaccato. Le hanno subite e, sembra,
ormai quasi metabolizzate.
Presentazione
su “La Valle dei Templi di Nico Gozzo, procuratore aggiunto di Caltanissetta,
“Dalla parte sbagliata – La morte di Paolo Borsellino e i depistaggi di via
D’Amelio”. Un boato, sei morti, tanti misteri. Il 19 luglio del 1992
un’autobomba esplodeva in via D’Amelio uccidendo Paolo Borsellino e i cinque
agenti di scorta. A ventidue anni di distanza, nonostante le inchieste, i
processi, le condanne e le successive assoluzioni, oggi ne sappiamo tanto quanto
prima, tranne che per il fatto di aver preso coscienza che molto di più,
rispetto la strage mafiosa, si cela dietro quell’evento criminale che ha visto
falsi pentiti autori di depistaggi che ci hanno portati sempre più lontani dalla
verità. Fallimenti dell’apparato investigativo e giudiziario, carenze e
incongruenze che emergono sempre più chiare dalle carte processuali, che ci
obbligano a fare i conti con una realtà che vorremmo inconsciamente ignorare e
che ci mettono dinanzi ad una domanda alla quale non abbiamo una risposta da
dare: furono soltanto madornali errori giudiziari o qualcosa di diverso e molto
più grave si cela dietro le tante anomalie che hanno caratterizzato l’intera
vicenda? “Dalla parte sbagliata – La morte di Paolo Borsellino e i depistaggi di
via D’Amelio” è il libro della giornalista palermitana Dina Lauricella e
dell’avvocato Rosalba Di Gregorio che racconta questi venti anni di indagini e
processi, partendo dalle dichiarazioni del pentito Vincenzo Scarantino, ambigua
figura le cui dichiarazioni sono spesso state smentite, per arrivare ad una
certa antimafia parolaia e spesso fine a sé stessa alla quale forse poco importa
che venga una volta per tutte fatta chiarezza sull’attentato che il 19 luglio
del 1992 provocò la morte del Giudice Paolo Borsellino e di altri cinque
innocenti caduti nell’adempimento del loro dovere. Non avrei mai pensato di
dover scrivere dell’ “Avvocato del diavolo” – come ignominiosamente viene
definita Rosalba Di Gregorio – difensore di fiducia di imputati dai cognomi
“pesanti” quali Bontate,Pullarà, Vernengo, Marino Mannoia, Mangano, per finire
con Provenzano, se non fosse stato per questo libro e per la coltre di silenzio
con cui è stata artatamente coperta ogni sua presentazione. Ho conosciuto
personalmente l’Avvocato Rosalba Di Gregorio e l’ho conosciuta in quelle aule
giudiziarie laddove era in corso un processo per strage contro i vertici di Cosa
Nostra. Lei “dalla parte sbagliata”, difensore di fiducia del boss o ex tale, io
per scriverne “dalla parte giusta”, accanto ai familiari di vittime innocenti di
mafia. In quell’aula non c’erano gli antimafiosi di professione, né, purtroppo,
i tanti giornalisti che oggi artatamente ignorano la Di Gregorio. È facile fare
antimafia così. Facile come porre il marchio di mafiosità a chi per ragioni
professionali si trova a difendere “la parte sbagliata”, il “mostro”. Senza
entrare nel merito del diritto, del codice deontologico della professione e su
quel sacrosanto diritto alla difesa che è consentito ad ogni imputato,
dell’Avvocato Di Gregorio ho avuto modo di apprezzare la professionalità, le
doti umane e il contegno mantenuto durante le udienze che – a differenza di
tanti difensori di cosiddette “persone per bene” che ho avuto modo di incontrare
in questi anni – non l’hanno mai spinta ad andare oltre quella che era la difesa
del proprio assistito avendo rispetto per l’altrui dolore e per il lavoro e la
professionalità del rappresentante legale della controparte. Se questo libro
dovesse servire anche a mettere un solo tassello al posto giusto per cercare di
ricostruire quello che realmente accadde nel ‘92, sarebbe molto più di quanto
tanti di coloro che si professano antimafiosi hanno dato come contributo ad una
Verità che forse in molti vorrebbero venisse taciuta per sempre. Se si è alla
ricerca della Verità, perchè ignorare o censurare chi può dare un contributo?
Perchè non conoscere o voler non fare conoscere le opinioni di chi per ragioni
professionali ha seguito le vicende osservandole da un’ottica diversa ma non per
questo meno valida o totalmente non rispondente a verità? Del resto – piaccia o
meno -, ad oggi, la ricostruzione più verosimile di quei tragici eventi sembra
essere proprio quella che emerge dal libro la cui esistenza si vorrebbe fosse
ignorata. La prossima manifestazione in cui si parlerà del libro si terrà a
Trieste il 12 luglio, organizzata da Libera, che da due anni è riuscita a
coinvolgere i parenti di Walter Cosina, morto anche Lui nella strage del
19/7/92. Questi parenti dimenticati, di Vittime trattate come se fossero di
serie” b”, hanno tanta fame anche Loro di Verità.
Questa la
prefazione di Domenico Gozzo, procuratore aggiunto di Caltanissetta, al libro
“Dalla parte sbagliata”, di Rosalba Di Gregorio e Dina Lauricella, edito da
Castelvecchi: “Normalmente chi scrive la prefazione ha piena conoscenza del
libro. Io ammetto di non averla, e per questo la mia è una «prefazione anomala».
Ma conosco le autrici. E di loro parlerò. Conosco la vicenda, di cui non parlo,
ma penso di avere il dovere, dopo le prime sentenze vicine al giudicato, di
stimolare una riflessione che sino ad oggi è, incredibilmente, mancata. E
allora, parlando in primis delle autrici, dico che Dina Lauricella mi è sembrata
una giornalista indipendente e autonoma. Non fa parte di cordate, e pensa con la
sua testa. Qualità rare e importanti. Quanto all’avvocato Di Gregorio,
«l’avvocato del Diavolo», cosa dire? Rosalba è una persona che ha una faccia
sola. Ha sempre detto, ostinatamente, le stesse cose sul processo di via
D’Amelio. Ha sempre detto le stesse cose sui collaboratori. A viso aperto,
sopportando, secondo me, conseguenze che l’hanno fatta diventare «un avvocato di
mafia», del Diavolo, appunto. Rosalba non è un avvocato di mafia. È un avvocato.
E la parola «avvocato» non dovrebbe sopportare ulteriori specifiche. A meno che
non si voglia indicare, con quel termine, che si occupa soprattutto di processi
di mafia. Il che farebbe anche di principi del Foro antimafia «avvocati di
mafia». E a Milano, chi difende i corruttori, come dovremmo chiamarli? «Avvocati
della corruzione»? La verità è che la «colpa» di Rosalba è di difendere, e bene,
i mafiosi. Ma è una colpa questa? E può essere all’origine di una «messa
all’indice» professionale? La verità è che dovremmo limitarci ad ammettere i
nostri errori. Dopo le sentenze già intervenute sulBorsellino quater, e senza
discutere di prove, dobbiamo o no discutere di questa giustizia, di questa
stampa, di questa società, che secondo me, negli anni Novanta, hanno, almeno in
parte, fallito? Dobbiamo discutere di chi ha consegnato per 17 anni le chiavi
della vita di sette persone innocenti per il reato di strage ad un falso
pentito, Scarantino? Dobbiamo avere il coraggio di discutere di una regola,
quella della «frazionabilità» delle dichiarazioni dei collaboranti, che forse
andrebbe ripensata, perché consente a «collaboranti» scarsamente credibili in
via generale di essere utilizzati «per ciò che serve», aprendo il fianco a
possibili strumentalizzazioni probatorie? Dobbiamo discutere del fatto che, pur
con tutte le considerazioni contenute nelle passate tre sentenze sulla poca
credibilità di Scarantino – il processo basato sulle sue dichiarazioni è
arrivato sino all’ultimo grado, ed è stato approvato anche in Cassazione? Cosa
non ha funzionato? Abbiamo il dovere di chiedercelo. Perché io penso che in
questa triste storia nessuno dei relè dello Stato democratico ha funzionato a
dovere. Non ha funzionato la Polizia. Non ha funzionato la Magistratura. Non
hanno funzionato i controlli, sia disciplinari sia penali. Non ha funzionato
il Csm. Non ha funzionato la cosiddetta Dottrina. Ma, soprattutto, non ha
funzionato la «libera stampa», che dovrebbe essere, e non lo è stata, il vero
cane da guardia di una democrazia. Solo un «avvocato di mafia» ha gridato le sue
urla nel vuoto. Sin quando, fortunatamente, grazie a nuove prove, la stessa
Giustizia ha avuto il coraggio di autoriformarsi. Ma alti sono i prezzi pagati
per questo, soprattutto all’interno delle forze dell’ordine. È accettabile tutto
questo? Sono accettabili questi 17 anni? E, soprattutto, dobbiamo chiederci con
trepidazione: potrebbe nuovamente accadere, magari sta già riaccadendo, quanto è
avvenuto in quella occasione? E allora, per evitarlo, devono assisterci i
principi generali delle democrazie cosiddette «occidentali». Il diritto di
difesa non è un optional. È un principio cardine delle democrazie, per
l’appunto, «di diritto». Il difensore di un mafioso non può divenire, per il
solo fatto di difendere un mafioso, inattendibile e pericoloso. La verità la può
dire un famoso procuratore antimafia, come anche un «avvocato di mafia». Come
tutti e due possono andare dietro ad abbagli. Tutto questo, lo capisco, ci
costringe a una fatica immane: non ragionare per schemi (buono-cattivo;
mafioso-antimafioso) ma ragionare con la nostra testa. Criticando. Leggendo.
Facendoci le nostre personali idee. Ma in questo deve aiutarci una stampa
autenticamente indipendente. Una stampa che non si schieri né a favore «a
priori», né contro «a priori». E necessitiamo di una magistratura aperta ad
essere criticata (se le critiche non sono preconcette), e rispettosa dei diritti
della difesa. Perché il processo, ricordiamocelo, è, come dicevano i romani,
actus trium personarum, è un rito che richiede il necessario intervento di tre
persone: il Giudice, il Pubblico Ministero, e la Difesa. Solo così, tenendo in
debito conto tutti questi attori, si può arrivare ad accertare una «verità
processuale» che assomigli il più possibile alla Verità. In ultimo, qualche
breve considerazione, permettetemi, sul cosiddetto fronte antimafia: ilmovimento
antimafia, che è di importanza basilare in uno Stato democratico, deve però
essere anch’esso democratico, e rispettoso delle opinioni di tutti. «Non
condivido la tua idea, ma darei la vita perché tu la possa esprimere», diceva
qualcuno più saggio di me. Isoliamo gli intolleranti per mestiere. Perché
dobbiamo viverci tutti insieme, in questo nostro Stato. E dobbiamo edificarlo
tutti insieme, su solide basi di verità, anche a costo di ammettere verità
scomode. È un debito, questo della verità, che tutti dobbiamo pagare a chi, in
quegli anni, perse la vita per una idea di Giustizia e di antimafia.
Rosalba Di
Gregorio. Si laurea in Giurisprudenza all’Università di Palermo nel 1979. Nel
periodo di praticantato fa esperienza politica nel Partito radicale.
L’esperienza più impegnativa dell’inizio della professione sarà il primo
maxiprocesso di Palermo, dove, assieme all’avv. Marasà, difenderà una decina di
imputati, tra i quali Vittorio Mangano. Dall’esperienza del maxiprocesso e
dall’«incontro» in aula con i primi pentiti nascerà il libro L’altra faccia
dei pentiti (La Bottega di Hefesto, 1990).
Dina
Lauricella. Palermitana «doc», vive a Roma da 14 anni. Ha scritto per diversi
quotidiani e settimanali. Nel 2007 entra a far parte della squadra di inviati di
Annozero. Per Michele Santoro firma diversi speciali, tra cui La Mafia
che cambia, nella quale parla in tv per la prima volta Angelo Provenzano, il
figlio del super boss. Stato criminale, la puntata di Servizio
Pubblico con ospite Vincenzo Scarantino, trae spunto da questo libro.
Bombe,
omicidi e stragi in Sicilia: ecco tutte le accuse a “faccia da mostro”.
Pentiti lo additano, quattro procure lo indagano: Giovanni Aiello, ex poliziotto
col volto sfregiato, sarebbe in realtà un sicario per delitti ordinati da pezzi
deviati dello Stato, oltre che dai padrini. Dall'eversione nera degli anni '70
all'uccisione di Falcone e Borsellino: la storia scritta da Attilio Bolzoni e
Salvo Palazzolo su “La Repubblica”. Ci sono almeno quattro uomini e una donna
che l'accusano di avere ucciso poliziotti come Ninni Cassarà e magistrati come
Falcone e Borsellino, di avere fornito telecomandi per le stragi, di avere messo
in giro per l'Italia bombe "su treni e dentro caserme". Qualcuno dice che a
Palermo ha assassinato pure un bambino. Su di lui ormai indagano tutti,
l'Antimafia e l'Antiterrorismo. Sospettano che sia un sicario per delitti su
commissione, ordinati da Cosa Nostra e anche dallo Stato. Lo chiamano "faccia da
mostro" e ha addosso il fiato di un imponente apparato investigativo che vuole
scoprire chi è e che cosa ha fatto, da chi ha preso ordini, se è stato
trascinato in un colossale depistaggio o se è davvero un killer dei servizi
segreti specializzato in "lavori sporchi". Al suo fianco appare di tanto in
tanto anche una misteriosa donna "militarmente addestrata ". Nessuno l'ha mai
identificata. Forse nessuno l'ha mai nemmeno cercata con convinzione. Vi
raccontiamo per la prima volta tutta la storia di Giovanni Aiello, 67 anni,
ufficialmente in servizio al ministero degli Interni fino al 1977 e oggi
plurindagato dai magistrati di Caltanissetta e Palermo, Catania e Reggio
Calabria. Vi riportiamo tutte le testimonianze che l'hanno imprigionato in una
trama che parte dal tentativo di uccidere Giovanni Falcone all'Addaura fino
all'esplosione di via Mariano D'Amelio, in mezzo ci sono segni che portano al
delitto del commissario Cassarà e del suo amico Roberto Antiochia,
all'esecuzione del poliziotto Nino Agostino e di sua moglie Ida, ai suoi
rapporti con la mafia catanese e quella calabrese, con terroristi della destra
eversiva come Pierluigi Concutelli. E con l' intelligence . Anche se,
ufficialmente, "faccia da mostro" non è mai stato nei ranghi degli 007. Negli
atti del nuovo processo contro gli assassini di Capaci — quello che coinvolge i
fedelissimi dei Graviano — che sono stati appena depositati, c'è la
ricostruzione della vita e della carriera di un ex poliziotto dal passato
oscuro. La sua scheda biografica intanto: "Giovanni Pantaleone Aiello, nato a
Montauro, provincia di Catanzaro, il 3 febbraio del 1946, arruolato in polizia
il 28 dicembre 1964, congedato il 12 maggio 1977, residente presso la caserma
Lungaro di Palermo fino al 28 settembre 1981, sposato e separato con l'ex
giudice di pace.., la figlia insegna in un'università della California". Reddito
dichiarato: 22 mila euro l'anno (ma in una recente perquisizione gli hanno
sequestrato titoli per un miliardo e 195 milioni di vecchie lire), ufficialmente
pescatore. Sparisce per lunghi periodi e nessuno sa dove va, racconta a tutti
che la cicatrice sulla guancia destra è "un ricordo di uno scontro a fuoco in
Sardegna durante un sequestro di persona", ma nel suo foglio matricolare è
scritto che "è stata causata da un colpo partito accidentalmente dal suo fucile
il 25 luglio 1967 a Nuoro". Il suo dossier al ministero dell'Interno, allora:
qualche encomio semplice per avere salvato due bagnanti, un paio di punzioni,
per molti anni una valutazione professionale "inferiore alla media", un
certificato sanitario che lo giudicano "non idoneo al servizio per turbe
nevrotiche post traumatiche ". Dopo il congedo è diventato un fantasma fino a
quando, il 10 agosto del 2009, è stato iscritto nel registro degli indagati "in
riferimento all'attentato dell'Addaura e alle stragi di Capaci e di via
D'Amelio". Il 23 novembre del 2012 tutte le accuse contro di lui sono state
archiviate. Ma dopo qualche mese "faccia da mostro" è scivolato un'altra volta
nel gorgo. È sotto inchiesta per una mezza dozzina di delitti eccellenti in
Sicilia e per alcuni massacri, compresi attentati ai treni e postazioni
militari. Le investigazioni — cominciate dalla procura nazionale antimafia di
Pietro Grasso — ogni tanto prendono un'accelerazione e ogni tanto
incomprensibilmente rallentano. Forse troppe prudenze, paura di toccare fili ad
alta tensione. Ma ecco chi sono tutti gli accusatori di Giovanni Aiello e che
cosa hanno detto di lui. Il primo è Vito Lo Forte, picciotto palermitano del
clan Galatolo. La sintesi del suo interrogatorio: "Ho saputo che ci ha fatto
avere il telecomando per l'Addaura, ho saputo che era coinvolto nell'omicidio di
Nino Agostino e che era un terrorista di destra amico di Pierluigi Concutelli,
che ha fatto attentati su treni e caserme, che ha fornito anche il telecomando
per via D'Amelio". Poi Lo Forte parla del clan Galatolo che progettava
intercettazioni sui telefoni del consolato americano di Palermo, ricorda "un
uomo con il bastone" amico di Aiello che è un pezzo grosso dei servizi, che ogni
tanto a "faccia da mostro" regalavano un po' di cocaina. Dice alla fine: "Era un
sanguinario, non aveva paura di uccidere". E racconta che Aiello, il 6 agosto
1985, partecipò anche all'omicidio di Ninni Cassarà e dell'agente Roberto
Antiochia: "Me lo riferì Gaetano Vegna della famiglia dell'Arenella. Dopo,
alcuni uomini d'onore erano andati a brindare al ristorante di piazza Tonnara.
Insieme a loro c'era anche Aiello, che aveva pure sparato al momento
dell'omicidio, da un piano basso dell'edificio". Il secondo accusatore si chiama
Francesco Marullo, consulente finanziario che frequentava Lo Forte e il
sottobosco mafioso dell'Acquasanta. Dichiara: "Ho incontrato un uomo con la
cicatrice in volto nello studio di un avvocato palermitano legato a
Concutelli... Un fanatico di estrema destra... dicevano che quello con la
cicatrice fosse uomo di Contrada (il funzionario del Sisde condannato per
concorso esterno in associazione mafiosa, ndr) ". Il terzo che punta il dito
contro Giovanni Aiello è Consolato Villani, 'ndranghetista di rango della cosca
di Antonino Lo Giudice, boss di Reggio Calabria: "Una volta lo vidi... Mi colpì
per la particolare bruttezza, aveva una sorta di malformazione alla mandibola...
Con lui c'era una donna, aveva capelli lunghi ed era vestita con una certa
eleganza". E poi: "Lo Giudice mi ha parlato di un uomo e una donna che facevano
parte dei servizi deviati, vicini al clan catanese dei Laudani, gente
pericolosa. In particolare, mi diceva che la donna era militarmente addestrata,
anche più pericolosa dell'uomo ". E ancora: "Lo Giudice aggiunse pure che questi
soggetti facevano parte del gruppo di fuoco riservato dei Laudani, e che avevano
commesso anche degli omicidi eclatanti, tra cui quello di un bambino e di un
poliziotto e che erano implicati nella strage di Capaci". Il quarto accusatore,
Giuseppe Di Giacomo, ex esponente del clan catanese dei Laudani, di "faccia da
mostro" ne ha sentito parlare ma non l'ha mai visto: "Il mio capo Gaetano
Laudani aveva amicizie particolari… In particolare con un tale che lui indicava
con l'appellativo di “ vaddia” (guardia, in catanese, ndr). Laudani intendeva
coltivare il rapporto con “ vaddia” in quanto appartenente alle istituzioni ".
Per ultima è arrivata la figlia ribelle di un boss della Cupola, Angela
Galatolo. Qualche settimana fa ha riconosciuto Aiello dietro uno specchio: "È
lui l'uomo che veniva utilizzato come sicario per affari molto riservati, me lo
hanno detto i miei zii Raffaele e Pino". Tutte farneticazioni di pentiti che
vogliono inguaiare un ex agente di polizia? E perché mai un pugno di
collaboratori di giustizia si sarebbero messi d'accordo per incastrarlo? Fra
tanti segreti c'è anche quello di un bambino ucciso a Palermo. Ogni indizio
porta a Claudio Domino, 10 anni, assassinato il 7 ottobre del 1986 con un solo
colpo di pistola in mezzo agli occhi. Fece sapere il mafioso Luigi Ilardo al
colonnello dei carabinieri Michele Riccio: "Quell'uomo dei servizi di sicurezza
con il viso sfigurato era presente quando fecero fuori il piccolo Domino". Poi
uccisero anche il mafioso: qualcuno aveva saputo che voleva pentirsi. La figlia
ribelle di un boss della Cupola ha incastrato l'uomo misterioso che chiamano
"faccia da mostro". L'ha indicato come "un sicario" al servizio delle cosche più
potenti di Palermo. È un ex poliziotto, forse anche un agente dei servizi
segreti. Ed è sospettato di avere fatto stragi e delitti eccellenti in Sicilia.
"Ne sono sicura, è lui", ha confermato Giovanna Galatolo dietro un vetro
blindato. Così le indagini sulla trattativa Stato-mafia, sulle uccisioni di
Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino - ma anche quelle sul fallito attentato
all'Addaura e probabilmente sugli omicidi di tanti altri funzionari dello Stato
avvenuti a Palermo - dopo più di vent'anni di depistaggi stanno decisamente
virando verso un angolo oscuro degli apparati di sicurezza italiani e puntano su
Giovanni Aiello. Ufficialmente è solo un ex graduato della sezione antirapine
della squadra mobile palermitana, per i magistrati è un personaggio chiave
"faccia da mostro" - il volto sfigurato da una fucilata, la pelle butterata -
quello che ormai si ritrova al centro di tutti gli intrighi e di tutte le
investigazioni sulle bombe del 1992. "È lui l'uomo che veniva utilizzato come
sicario per affari che dovevano restare molto riservati, me lo hanno detto i
miei zii Raffaele e Pino", ha confessato Giovanna Galatolo, l'ultima pentita di
Cosa Nostra, figlia di Vincenzo, mafioso del cerchio magico di Totò Riina, uno
dei padrini più influenti di Palermo fra gli anni 80 e 90, padrone del
territorio da dove partirono gli squadroni della morte per uccidere il
consigliere Rocco Chinnici e il segretario regionale del partito comunista Pio
La Torre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e il commissario Ninni Cassarà.
"È lui", ha ripetuto la donna indicando l'ex poliziotto dentro una caserma della
Dia. Un confronto "all'americana", segretissimo, appena qualche giorno fa. Da
una parte lei, dall'altra Giovanni Aiello su una piattaforma di legno in mezzo a
tre attori che si sono camuffati per somigliargli. "È lui, non ci sono dubbi. Si
incontrava sempre in vicolo Pipitone (il quartiere generale dei Galatolo, ndr)
con mio padre, con mio cugino Angelo e con Francesco e Nino Madonia", ha
raccontato la donna davanti ai pubblici ministeri dell'inchiesta-bis sulla
trattativa Stato-mafia Nino Di Matteo, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia.
Un riconoscimento e poi qualche altro ricordo: "Tutti i miei parenti lo
chiamavano "lo sfregiato", sapevo che viaggiava sempre fra Palermo e Milano...
". La figlia del capomafia - che otto mesi fa ha deciso di collaborare con la
giustizia rinnegando tutta la sua famiglia - aveva con certezza identificato
Giovanni Aiello come amico di Cosa Nostra anche in una fotografia vista in una
stanza della procura di Caltanissetta, quella che indaga sulle uccisioni di
Falcone e Borsellino. Dopo tante voci, dopo tanti sospetti, adesso c'è qualcuno
che inchioda lo 007 dal passato impenetrabile, scivolato in un gorgo di
inchieste con le ammissioni di qualche altro pentito e di alcuni testimoni.
Sembra finito in una morsa, da almeno un anno Giovanni Aiello è indagato dai
magistrati di quattro procure italiane - quella di Palermo e quella di
Caltanissetta, quella di Catania e quella di Reggio Calabria - che tentano di
ricostruire chi c'è, oltre ai boss di Cosa Nostra, dietro i massacri dell'estate
siciliana del 1992. E anche dietro molti altri delitti importanti degli anni
Ottanta. Ora, con le nuove rivelazioni di Giovanna Galatolo, la posizione
dell'ex poliziotto è diventata sempre più complicata. Questa donna è la
depositaria di tutti i segreti del suo clan, per ordine del padre faceva la
serva ai mafiosi, cucinava, stirava, spesso lavava anche gli abiti sporchi di
sangue, sentiva tutto quello che dicevano, vedeva entrare e uscire dalla sua
casa i boss. E anche Giovanni Aiello. Giovanna Galatolo parla pure del fallito
attentato dell'Addaura, 56 candelotti di dinamite che il 21 giugno del 1989
dovevano far saltare in aria Giovanni Falcone sugli scogli davanti alla sua
villa. Erano appostati lì gli uomini della sua famiglia, i Galatolo. C'era anche
Giovanni Aiello? E "faccia da mostro" è coinvolto nell'uccisione di Nino
Agostino, il poliziotto assassinato neanche due mesi dopo il fallito attentato
dell'Addaura - il 5 agosto - insieme alla moglie Ida? Il padre di Nino Agostino
ha sempre raccontato che "un uomo con la faccia da cavallo" aveva cercato suo
figlio pochi giorni prima del delitto. Era ancora Giovanni Aiello? La sua
presenza è stata segnalata sui luoghi di tanti altri omicidi palermitani. Tutti
addebitati ai Galatolo e ai Madonia. Lui, l'ex agente della sezione antirapine
(quando il capo della Mobile era quel Bruno Contrada condannato per i suoi
legami con la Cupola) ha sempre respinto naturalmente ogni accusa, affermando
anche di non avere più messo piede in Sicilia dal 1976, anno nel quale si è
congedato dalla polizia. Una dichiarazione che si è trasformata in un passo
falso. Qualche mese fa la sua casa di Montauro in provincia di Catanzaro - dove
Giovanni Aiello è ufficialmente residente - è stata perquisita e gli hanno
trovato biglietti recenti del traghetto che da Villa San Giovanni porta a
Messina, appunti in codice, lettere, titoli per 600 milioni di vecchie lire,
articoli di quotidiani che riportavano notizie su boss come Bernardo Provenzano
e su indagini del pool antimafia palermitano, assegni. Dopo quella
perquisizione, gli hanno notificato a casa un ordine di comparizione per il
confronto con la Galatolo, ha accettato presentandosi con il suo avvocato. Il
riconoscimento di Giovanni Aiello segue di molti anni le confidenze di un
mafioso al colonnello dei carabinieri Michele Riccio. Il confidente si chiamava
Luigi Ilardo e disse: "Noi sapevamo che c'era un agente a Palermo che faceva
cose strane e si trovava sempre in posti strani. Aveva la faccia da mostro". Era
il 1996. Poco dopo quelle rivelazioni Luigi Ilardo - tradito da qualcuno che era
a conoscenza del suo rapporto con il colonnello dei carabinieri - fu ucciso.
Anche lui parlava di Giovanni Aiello? Le confessioni della Galatolo stanno
aprendo una ferita dentro la Cosa Nostra palermitana. Non solo misteri di Stato
e connivenze ma anche un terremoto all'interno di quel che rimane delle famiglie
storiche della mafia siciliana. "Come donna e come persona non posso essere
costretta a stare con uomini indegni, voglio essere libera e non appartenere più
a quel mondo, per questo ho deciso di dire tutto quello che so", così è
cominciata la "liberazione" di Giovanna Galatolo che una mattina dell'autunno
del 2013 si è presentata al piantone della questura di Palermo con una borsa in
mano. Ha chiesto subito di incontrare un magistrato: "Ho 48 anni e la mia vita è
solo mia, non me la possono organizzare loro". Del suo passato, la donna ha
portato con sé solo la figlia. L'uomo del mistero che chiamano "faccia da
mostro" l'abbiamo trovato in un paese della Calabria in riva al mare. È
sospettato di avere fatto omicidi e stragi in Sicilia, come killer di Stato. È
un ex poliziotto di Palermo, ha il volto sfregiato da una fucilata. Vive da
eremita in un capanno, passa le giornate a pescare. Quando c'è mare buono prende
il largo sulla sua barca, "Il Bucaniere". Ogni tanto scompare, dopo qualche mese
torna. Nessuno sa mai dove va. Sul suo conto sono girate per anni le voci più
infami e incontrollate, accusato da pentiti e testimoni "di essere sempre sul
luogo di delitti eccellenti" come ufficiale di collegamento tra cosche e servizi
segreti. È davvero lui il sicario a disposizione di mafia e apparati che avrebbe
ucciso su alto mandato? È davvero lui il personaggio chiave di tanti segreti
siciliani? L'uomo del mistero nega tutto e per la prima volta parla: "Sono qui,
libero, mi addossano cose tanto enormi che non mi sono nemmeno preoccupato di
nominare un avvocato per difendermi". Ha 67 anni, si chiama Giovanni Aiello e
l'abbiamo incontrato ieri mattina. Abita a Montauro, in provincia di Catanzaro.
Da questo piccolo comune ai piedi delle Serre - il punto più stretto d'Italia
dove solo trentacinque chilometri dividono il Tirreno dallo Jonio - sono
ripartite le investigazioni sulle stragi del 1992. L'ex poliziotto trascinato
nel gorgo di Palermo l'abbiamo incontrato ieri mattina, davanti al suo casotto
di legno e pietra sulla spiaggia di contrada Calalunga. Sotto il canneto la sua
vecchia Land Rover, in un cortile le reti e le nasse. "La mia vita è tutta qui,
anche mio padre e mio nonno facevano i pescatori", ricorda mentre comincia a
raccontare chi è e come è scivolato nella trama. È alto, muscoloso, capelli
lunghi e stopposi che una volta erano biondi, grandi mani, una voce roca. Dice
subito: "Se avessi fatto tutto quello di cui mi accusano, lo so che ancora i
miei movimenti e i miei telefoni sono sotto controllo, dovrei avere agganci con
qualcuno al ministero degli Interni, ma io al ministero ci sono andato una sola
volta quando dovevo chiedere la pensione d'invalidità per questa". E si tocca la
lunga cicatrice sul lato destro della sua faccia, il segno di un colpo di
fucile. Tira vento, si chiude il giubbotto rosso e spiega che quello sfregio è
diventata la sua colpa. Inizia dal principio, dal 1963: "In quell'anno mi sono
arruolato in polizia, nel 1966 i sequestratori della banda di Graziano Mesina mi
hanno ridotto così durante un conflitto a fuoco in Sardegna, trasferito a
Cosenza, poi a Palermo". Commissariato Duomo, all'anti-rapine della squadra
mobile, sezione catturandi. Giovanni Aiello fa qualche nome: "All'investigativa
c'era Vittorio Vasquez, anche Vincenzo Speranza, un altro funzionario. Comandava
Bruno Contrada (l'ex capo della Mobile che poi è diventato il numero 3 dei
servizi segreti ed è stato condannato per mafia, ndr) e poi c'era quello
che è morto". Di quello "che è morto", Boris Giuliano, ucciso il 21 luglio del
1979, l'ex poliziotto non pronuncia mai il nome. Giura di non avere più messo
piede a Palermo dal 1976, quando ha lasciato la polizia di Stato. Dice ancora:
"Tutti quegli omicidi e quelle stragi sono venuti dopo, mai più stato a Palermo
neanche a trovare mio fratello". Poliziotto anche lui, congedato nel 1986 dopo
che una bomba carta gli aveva fatto saltare una mano. Giovanni Aiello passeggia
sul lungomare di Montauro e spiega quale è la sua esistenza. Mare, solitudine.
Pochissimi amici, sempre gli stessi. Sarino e Vito. L'ex poliziotto torna alla
Sicilia e ai suoi orrori: "So soltanto che mi hanno messo sott'indagine perché
me l'hanno detto amici che sono stati ascoltati dai procuratori, anche mio
cognato e la mia ex moglie. E poi tutti frastornati a chiedermi: ma che hai
fatto, che c'entri tu con quelle storie? A me non è mai arrivata una carta
giudiziaria, nessuno mi ha interrogato una sola volta". Ha mai conosciuto Luigi
Ilardo, il mafioso confidente che accusa un "uomo dello Stato con il viso
deturpato" di avere partecipato a delitti eccellenti? "Ilardo? Non so chi sia".
Mai conosciuto Vito Lo Forte, il pentito dell'Acquasanta che parla della
presenza di "faccia da mostro" all'attentato all'Addaura del giugno 1989 contro
il giudice Falcone? "Mai visto". Mai conosciuto il poliziotto Nino Agostino,
assassinato nell'agosto di quello stesso 1989? "No". E suo padre Vincenzo, che
dice di avere visto "un poliziotto con i capelli biondi e il volto sfigurato"
che cercava il figlio qualche giorno prima che l'uccidessero? "Non so di cosa
state parlando". L'uomo del mistero si tira su la maglia e fa vedere un'altra
cicatrice. Una coltellata al fianco destro. "Un altro regalo che mi hanno fatto
a Palermo". E ancora: "Tutti parlano di me come faccia da mostro, ma non credo
di essere così brutto". Continua a raccontare, del giorno che passò la visita
per entrare in Polizia: "Pensavo di essere stato scartato, invece una mattina mi
portarono in una caserma fuori Roma e mi accorsi che io, con il mio metro e 83
di altezza, ero il più basso". Estate 1964. "Molto tempo dopo ho saputo che
tutti noi, 320 giovanissimi poliziotti ben piantati, eravamo stati selezionati
come forza di supporto - non so dove - per il golpe del generale Giovanni De
Lorenzo". La famosa estate del "rumore di sciabole" contro il primo governo di
centrosinistra, il "Piano Solo". Il primo intrigo dove è finito Giovanni Aiello.
Forse non l'ultimo. Forse. Di certo è che su di lui oggi indagano, su impulso
della direzione nazionale antimafia, quattro procure italiane. Quelle di Palermo
e Caltanissetta per le bombe e la trattativa, quelle di Reggio Calabria e
Catania per i suoi presunti contatti con ambienti mafiosi. I dubbi su "faccia da
mostro" sono ancora tanti. Non finiscono mai.
Quando di
un’inchiesta si appropriano i mass media, vincono le illazioni, i sospetti, i
teoremi su una colpevolezza che viene data per certa quando ancora nessun
giudice si è pronunciato. Il libro diventa un circostanziato atto d’accusa
contro il circuito infernale che da troppi anni lega parte della magistratura a
pezzi dell’informazione. Il dr Antonio Giangrande, cittadino avetranese, autore
di decine di saggi, tra cui i libri su Sara Scazzi, denuncia in tutta Italia:
ora basta questa barbarie !!!
Maurizio
Tortorella, vicedirettore di “Panorama”, discute con tempi.it del rapporto fra
procure e redazioni: «Non è dignitoso che un giornalista faccia “copia e
incolla” dei documenti che la procura gli passa sottobanco». Carcerazione
preventiva e giustizia politicizzata. Due argomenti che nella serata di venerdì,
all’incontro “Aspettando giustizia” organizzato da Tempi a Milano, hanno
avuto profonda risonanza. Le testimonianze del generale Mori, di Renato Farina e
di Ottaviano Del Turco sono rappresentative di una giustizia che si mischia con
la stampa, diventando una raffigurazione inquietante della società italiana.
Tempi.it ne parla con Maurizio Tortorella, vicedirettore di Panorama
e autore di un bel libro, La gogna (Boroli editore).
Quando
nascono i primi processi a mezzo stampa?
«Tutto
comincia con Tangentopoli. Anzi, ancora prima, quando nel 1989 una nuova
modifica alla procedura penale cambia il procedimento tradizionale. Mentre prima
le indagini erano portate avanti congiuntamente da due magistrati, il pubblico
ministero e il giudice istruttore, che avanzavano congiuntamente, da quel
momento il pm diventava l’unico titolare dell’azione penale. La polizia
giudiziaria inizia a dipendere da lui. Per un tempo illimitato il pm decide su
intercettazioni, perquisizioni e arresti, ecc. Nella sua azione diventa
completamente libero. Ogni atto, poi, passa al vaglio del giudice preliminare,
ma solo successivamente all’azione del pm. Non appena l’atto va a finire tra le
mani dell’avvocato difensore dell’imputato e del giudice, diventa
automaticamente pubblicabile. Spesso i pm hanno “amici” che lavorano in testate
giornalistiche di cui condividono la visione politica. Questa stampa non aspetta
la fine del processo, né tantomeno intervista la controparte, per gettare fango
su imputati di cui non è ancora stabilita la colpevolezza».
Perché si è
modificata la procedura penale?
«Si intendeva
migliorare le nostre procedure penali. Il nostro codice aveva caratteristiche
arretrate, ben lontane da quelle europee, considerate più moderne. Ma la cura è
stata peggiore della malattia che si voleva debellare. Questo meccanismo
infernale funziona anche laddove l’avvocato dell’indagato rifiuti di ritirare
l’interrogatorio. È il caso di Guido Bertolaso. Sono usciti sulla stampa dei
virgolettati di un interrogatorio che non potevano che venire dall’accusa,
perché la difesa ha rifiutato il ritiro dei documenti. A quanto pare, è
necessario sentire soltanto l’accusa per redigere un articolo».
La “gogna”
mediatica colpisce tutti indiscriminatamente o ha una certa predilezione verso
un colore politico?
«Il garantismo
non è un’idea molto praticata in Italia. Un tempo, fino agli anni Settanta, era
la sinistra a essere garantista, a fronte di una destra forcaiola che chiedeva
più galera, pene pesanti e l’uso della custodia cautelare. Adesso, le parti si
sono invertite. È la sinistra forcaiola a chiedere misure pesantissime, mentre
il centrodestra ha un orientamento garantista».
Pubblicare
stralci di documenti prima della sentenza segue la deontologia professionale?
«Si dovrebbero
ascoltare più voci e diversi punti di vista prima di toccare temi così delicati.
Trovo mortificante che in troppi casi un pezzo si risolva aspettando che dalla
procura arrivino delle carte. Non è dignitoso che un giornalista faccia “copia e
incolla” dei documenti che la procura gli passa sottobanco. Se consideri che il
pm di Palermo, dopo che Panorama ha pubblicato parte dell’intercettazione
tra il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e l’ex ministro Nicola
Mancino, ha smentito di aver passato lui stesso le carte, giustificandosi che
Panorama non è un giornale “amico”, ti spaventi. Perché significa che ci
sono media “amici” e media “nemici”. E quelli amici, inevitabilmente, sono dello
stesso colore politico del magistrato in questione».
La
carcerazione preventiva e le lungaggini della giustizia italiana aiutano “la
gogna”?
«Certo. Nello
Rossi, procuratore aggiunta a Roma e appartenente a Magistratura democratica,
ammette che oggi ha più impatto un arresto di una sentenza di primo grado.
Perché? Sul piano emotivo, l’immediatezza di un arresto ha più effetto di una
sentenza, che impiega anni prima di essere confermata o smentita. Nessuno più
segue i processi – come quello di Ottaviano Del Turco – perché questi si
svolgono sui giornali. Il vero processo è di carta.
Sbattere il
mostro in prima pagina: quando l’orco è uno di noi, scrive in un suo editoriale
Raffaella De Grazia. Massimo e Carlo, padri di famiglia realizzati e felici.
Massimo e Carlo, lavoratori stacanovisti dalla vita senza ombre. Sono i vicini
di casa ideali, i mariti fedeli, coloro ai quali affidereste volentieri i vostri
figli, gli amici di mille bevute al bar, mentre si guarda l’ennesima partita di
calcio. Se è vero ciò che sostiene Goya – e cioè che “Il sonno della ragione
genera mostri” – allora Massimo e Carlo sono gli esempi più eclatanti di come,
spesso, la ricerca dell’esecutore di crimini tanto efferati quanto immotivati
che macchiano di sangue il nostro Bel Paese debba essere indirizzata poco
lontano dalle sempre meno rassicuranti mura domestiche, più vicino a quella che
l’uomo medio, erroneamente, denomina la “zona sicura”. Il “mostro”, identificato
comunemente come lo sconosciuto, lo “straniero” che porta via la serenità ad una
piccola comunità pare essere, invece, sempre più spesso un componente della
stessa. E’ inserito perfettamente nel tessuto sociale del paese che gli ha dato
i natali, contribuisce all’economia autoctona, conosce tutto di tutti. Nessuno
dei suoi parenti o amici ha però idea del suo “lato oscuro”, delle sue
perversioni inconfessabili, nemmeno nell’attimo stesso in cui il mostro le
confessa, lasciando attoniti persino i più diffidenti tra i suoi conterranei. Il
caso di Avetrana ha fatto tristemente “scuola” in tal senso. Come dimenticare lo
sgomento di parenti, amici e vicini di casa nel conoscere la vera, presunta
natura della famiglia Misseri, umili braccianti fuori le mura domestiche ma, al
contempo, spietati killer di una 15enne, peraltro loro stretta parente? Eventi
drammatici come il caso di Sarah Scazzi hanno catalizzato l’attenzione
mediatica, generando un’ondata di morboso interesse attorno a simili
crimini dettati dall’odio. Nello stesso periodo in cui le indagini sull’omicidio
della piccola Sarah proseguivano – tra dichiarazioni ufficiali e smentite mezzo
stampa – un’altra piccola, innocente creatura spariva, inghiottita dal nulla. Si
trattava della 13enne Yara Gambirasio, grande sorriso e voglia di vivere appieno
la sua adolescenza, oramai alle porte. Il mostro che ha privato la 13enne Yara
del suo bene più prezioso – il diritto alla vita – è stato cercato ovunque. Sin
dagli istanti successivi alla sua sparizione, però, il dito dell’intera comunità
di Brembate di Sopra e non solo era stato puntato solo contro un operaio
extracomunitario. Qual era la sua colpa? Ai compaesani di Yara era forse
sembrato più facile “sbattere in prima pagina” un “corpo estraneo” alla propria
comunità? Erano tanti i dubbi che circolavano attorno ad un caso così complesso,
con pochi reperti a disposizione. Di certo c’è che mai nessun abitante di
Brembate avrebbe immaginato di dover cercare il mostro proprio vicino a casa
propria, di identificarlo nelle vesti dell’ uomo qualunque, sposato, incensurato
e papà di tre figli piccoli. Ancora più cruenta è stata la svolta nel terribile,
triplice omicidio di Motta Visconti. Cristina, Giulia e Gabriele hanno perso la
vita per mano di una persona talmente vicina a loro da risultare assolutamente
insospettabile. Ricordiamo, quasi sempre, più facilmente i nomi dei killer che
delle proprie vittime, quando non dovrebbe essere così. Difficilmente,
però, dimenticheremo quei volti, visibilmente felici nelle foto di rito, la cui
esistenza è stata strappata via per motivi tanto futili quanto squallidi. Voleva
un’altra donna il “papà-mostro” che, nella notte d’esordio “mondiale” della
nostra Nazionale, ha ucciso senza pietà sua moglie ed i suoi due piccoli bimbi,
di appena 5 anni e 20 mesi. Una storia raccapricciante che, man mano che il
tempo passa, si arricchisce di orpelli sempre più orridi. Un altro mostro dalla
faccia pulita, che sorride beffardo abbracciando sua moglie. Un altro mostro da
sbattere in prima pagina, per non dimenticare l’orrore perpetrato dall’uomo
comune.
Di che ci
stupiamo?
Yara, fermato
un uomo. E’ già il killer, scrive “Il Garantista”. Non è detto che sia la fine
del giallo iniziato quattro anni fa ma di sicuro, dopo mesi di stasi apparente
nelle indagini, si configura come una svolta cruciale l’arresto di uomo di
quaranta anni accusato di essere l’assassino di Yara Gambirasio.
A riferire della cattura del presunto colpevole è il ministro dell’Interno in
persona: «Le forze dell’ordine, d’intesa con la magistratura, hanno
individuato l’assassino di Yara Gambirasio. E’ una persona dello stesso paese
dove viveva la vittima»- annuncia Alfano. Ad incastrare l’uomo, un muratore
della provincia di Bergamo, sposato e padre di tre figli, sarebbe stata
l’analisi del suo Dna che è stato ritenuto dagli esperti sovrapponibile con le
tracce biologiche ritrovate sul corpo di Yara ( che era astato rinvenuto il 21
febbraio 2011 dopo quasi un anno di estenuanti ricerche). Per maggiori dettagli
Alfano invita ad essere pazienti e aspettare le prossime ore.
Pazienza di cui però il ministro e la maggior parte dei media non
hanno dato prova additando un uomo che non è nemmeno ancora stato messo sotto
processo come inequivocabilmente colpevole.
Caso Yara,
così la stampa sbatte il mostro in prima pagina, scrive Angela Azzaro
su “Il Garantista”. Un presunto colpevole – al
solito – che diventa senza dubbio l’assassino. Un fermato che viene dato – al
solito – in pasto alla rabbia del popolo. Le indagini sull’omicidio di Yara
Gambirasio sono diventate una brutta pagina di giornalismo e politica, e
stavolta non è colpa della magistratura. Anzi, la procura di Bergamo, a poche
ore dal fermo di Massimo Giuseppe Borsetti, è dovuta intervenire in polemica con
il ministro dell’Interno. Perché Alfano aveva dato la notizia parlando di
“assassino”. Sentenza già emessa. Il procuratore Francesco Dettori
si è sentito obbligato a intervenire, per correggere: «Volevamo il massimo
riserbo. Questo anche a tutela dell’indagato in relazione al quale, rispetto
alla Costituzione, esiste la presunzione di innocenza». Il capo del Viminale –
ex ministro della Giustizia – questi dettagli del diritto non li conosce bene.
Perciò ha tuonato, mettendo da parte ogni dubbio: il popolo italiano «aveva il
diritto di sapere e ha saputo per essere rassicurato». L’intervento di
Alfano ha provocato un vero e proprio linciaggio. Rafforzati
dall’intervento del ministro, quasi tutti i giornali, sia nella versione
cartacea ma soprattutto in quella on line, hanno dato libero sfogo alla caccia
al mostro. Il muratore fermato è diventato immediatamente il reietto, la sua
foto sbattuta in prima pagina. Con facebook ci vogliono pochi secondi, si entra
nei profili, si prende l’immagine e si fa girare con scritto: è lui il killer.
Ma è facile anche prendere altre foto, come quelle con i tre figli, due bambine
e un bambino, o quelle con la moglie, adesso chiusi in casa per paura di
ripercussioni. La caccia al mostro: giornali all’assalto. Tra i titoli
peggiori letti ieri, spicca quello di Repubblica. “E’
lui l’assassino di Yara”, dove le virgolette servono formalmente per riprendere
la dichiarazione di Alfano, sostanzialmente sono un modo per condannare ma
salvandosi la coscienza. Senza ipocrisie, Libero (“Preso l’assassino di
Yara”) e il Giornale che mette insieme Yara e il caso di Motta Visconti
(“Schifezze d’uomini”). Su molti quotidiani campeggiava la foto del “colpevole”
e vicino, quasi citazione di un mondo che fu, la parola “presunto”. A non
mettere in prima pagina la foto del mostro solo pochi giornali, tra cui il
Corriere (che la pubblica all’interno, ma l’aveva pubblicata sull’home-page
dell’on line) e l’Unità. Per il resto un lancio di pietre virtuali e
l’indicazione della via dove abita la famiglia del fermato, fosse mai che
qualcuno voglia provare a farla pagare a loro. Un caso esemplare di gogna
mediatica. Certo, non è la prima volta che assistiamo a
processi sommari di questo tipo. Sempre più spesso in Italia la presunzione di
innocenza è un valore costituzionale di cui vergognarsi. Sono tanti i casi
soprattutto di cronaca che diventano processi pubblici, senza né primo, né
secondo, né terzo grado di giudizio. La sentenza è immediata, la condanna certa.
E poco importa se poi nelle aule di tribunale mancano le prove certe. Questa
volta però è accaduto qualcosa di più grave: un ministro dell’Interno che
dovrebbe far rispettare le regole è stato il primo a “tradirle” in nome del
clamore e della pubblicità personale che avrebbe potuto ricavare dalla vicenda.
Del resto, bisogna dire che non è la prima volta che i giornali annunciano la
cattura dell’assassino di Yara. Con la stessa certezza di oggi descrissero come
mostro un ragazzetto egiziano, arrestato 24 ore dopo l’omicidio, e che – si
seppe dopo un paio di settimane – con l’omicidio non c’entrava niente di niente
ed era stato fermato per un clamoroso errore degli inquirenti. Proprio
un caso come questo, così estremo, ci aiuta a capire ancora meglio come
il rispetto delle regole sia fondamentale. Tutto fa pensare che Massimo
Giuseppe Borsetti sia colpevole, ma proprio per questo dobbiamo essere
cauti, per far sì che il processo si svolga nel migliore dei modi, senza
interferenze e senza decidere al posto dei giudici. Solo così si può garantire
una giustizia giusta e non processi sommari. Ma soprattutto solo in questo modo
possiamo evitare di diventare meno umani, più incivili. Il sangue richiama
sangue. La parola assassino solletica gli istinti peggiori. Dopo l’arresto del
presunto assassino di Yara e dopo la confessione di Carlo Lissi di aver ucciso
lui la moglie e due figli a Motta Visconti, sul web è partita una gara a chi la
sparava più grande. Dall’ergastolo alle pene corporali. Fino alla richiesta di
ripristinare la pena di morte, avanzata da Stefano Pedica, esponente della
direzione del Pd, e dal suo compagno di partito, il senatore Stefano Esposito.
Yara:
l'oscenità della giustizia-spettacolo, scrive Marco Ventura su “Panorama”. La
cattura del presunto killer doveva avvenire senza clamori, proteggendo innocenti
e minori. Invece, nel tritacarne, ci sono finiti tutti. Uno spettacolo immondo,
inaccettabile, folle. Senza nulla di umano, di corretto, di giustificato. È la
vicenda-spettacolo della cattura del presunto assassino di Yara Gambirasio. Una
storia terribile, data in pasto senza le dovute cautele - complici autorità e
giornalisti - a una pubblica opinione insieme respinta e attratta, attonita ma
anche, forse, perversamente golosa dei particolari raccapriccianti, addirittura
piccanti, di uno dei più clamorosi delitti di cronaca degli ultimi anni: Yara,
la ragazzina di 13 anni uccisa il 26 novembre 2010 e ritrovata dopo tre mesi.
Questa tragedia è diventata un thriller, un giallo, uno show, un noir,
una gara a chi annuncia per primo la chiusura del caso (che non c’è). A chi
ricama meglio. Sui giornali, in televisione, su Twitter. Senza ritegno, senza
alcun rispetto per le famiglie coinvolte. Un intreccio sul quale ha
improvvidamente alzato il sipario il ministro dell’Interno, Angelino Alfano,
quando secondo i magistrati non erano ancora concluse le operazioni di convalida
del fermo del presunto assassino, Massimo Giuseppe Bossetti. Da dove cominciare
per dire quanto dovremmo provare disagio per noi stessi, per questo paese, per
chi ha gestito la vicenda? Potrei cominciare da un’ipotesi che oggi pare assurda
ma che troppi errori giudiziari inducono a non considerare così improbabile:
l’ipotesi che l’arrestato sia innocente. A dispetto delle notizie trapelate sul
test del Dna confrontato con la macchia di sangue rinvenuta sugli slip della
vittima. A dispetto delle convinzioni degli inquirenti (i primi però a invitare
alla cautela, perché la prova del Dna non è certa al mille per mille, parliamo
sempre di probabilità). L’altro elemento è la quantità di vite umane gettate nel
tritacarne di una troppo affrettata divulgazione delle indagini. Adulti e
minori, padri e patrigni, figli e figlie, gemelli, fratelli e fratellastri,
madri, amanti, cugini, suoceri, amici... Ormai sappiamo tutto (dell’accusa). Il
carpentiere sarebbe figlio illegittimo della relazione tra un autista morto (e
riesumato) e una donna sposata. L’autista ha una vedova e tre figli (che non
c’entrano nulla ma si ritrovano sulle prime pagine dei giornali: un imprenditore
“di successo”, una madre “felice” e un idraulico “stimato”). I cronisti di “Repubblica”
scrivono che tacciono, “introvabili dietro i loro citofoni nel centro di
Clusone”. Già. L’assedio è cominciato, chissà quanto dovrà durare. C’è la madre
del presunto assassino, che nega la relazione clandestina ma nessuno le crede e
viene descritta come “la donna dei misteri”, barricata dietro le persiane della
sua casa di Terno d’Isola. Addirittura i giornalisti abbozzano sentenze: lei
assicura che Massimo “è figlio naturale di mio marito”, e così “tenta
di salvarlo dalle accuse che lo hanno travolto”. Ecco i sospetti, nascosti
dietro punti interrogativi. Lei cerca “di difendere anche di fronte all’evidenza
quel segreto inconfessabile che solo gli esami del Dna hanno potuto svelare? E
soprattutto: è stata lei negli ultimi mesi più consapevole del figlio che il
cerchio delle indagini si stava stringendo attorno a Massimo?”. Già, perché
tutti a chiedersi se Massimo sapesse, a sua volta, di essere figlio illegittimo
di un altro padre. E con lui la sorella gemella. Poi c’è il terzo figlio,
fratellastro di Massimo, di nome e di fatto del padre che non sa più se credere
alla moglie e affronta il rovello di un possibile adulterio di oltre
quarant’anni fa. Poi ci sono i figli del presunto omicida. Che sono piccoli,
hanno 13, 10 e 8 anni. Da chi hanno saputo che il padre è accusato di un delitto
così efferato? Come potranno proteggersi se l’altro giorno, durante il primo
interrogatorio di Bossetti, tutti sapevano tutto e qualcuno pensava al
linciaggio? C’è la moglie del presunto assassino, e madre dei tre bambini (la
madre, suocera dell’arrestato, viene fotografata mentre si affaccia a una
finestra col cane). Ovviamente diventa titolo sui giornali che lei non fornisca
un alibi al marito. Dice di non ricordare. “È strano, molto strano”,
osserva il “Corriere della Sera”. “Perché quel 26 novembre del 2010
quando Yara sparì all’improvviso, la notizia circolò velocemente. E già durante
la notte cominciarono le ricerche diventate poi mobilitazione di centinaia di
persone per giorni e giorni”. Fino al 26 febbraio 2011, quando fu ritrovata.
“Possibile che una persona della zona, per di più mamma, non ricordi che cosa
ha fatto quella sera?”. Io dico: è possibile eccome. “Che non abbia
tenuto a mente ogni dettaglio e spostamento del marito, dei figli, degli altri
familiari. Il dubbio è che lei sappia tutto, ma abbia così deciso di marcare la
distanza dall’uomo diventato il mostro”. Ma se sono passati tre anni e
mezzo! Ma come si fa a tranciare sospetti così. Non mi è piaciuto neppure
l’incontro del Procuratore di Brescia, Pier Luigi Maria Dell’Osso, con i
giornalisti, quelle risate sull’adulterio e sulla gemella di Bussetti come
“complicazione” per le indagini. Tutto assurdo, tutto fuori luogo. E dire che
invece il questore di Bergamo, Fortunato Finolli, ha correttamente e
ripetutamente precisato che il caso non è per nulla chiuso, che bisogna ancora
fare accertamenti e che poi dovrà tenersi il processo, “con le dovute risultanze
e il dovuto contraddittorio”. Era tanto difficile mantenere questa linea?
Infine, la parte più tragica, quella dei genitori di Yara, costretti a leggere
dopo tanti anni che nelle tre pagine con cui il pubblico ministero dispone il
fermo di Bossetti ci sono quelle righe che fanno titolo sui giornali: “con
l’aggravante di avere adoperato sevizie e avere agito con crudeltà”. Sì, i
genitori di Yara sono i più cauti e taciturni. Gli unici, quasi, all’altezza di
questo mare di sofferenze. E sono quelli che hanno sofferto (e soffrono) di più.
Non spetta a un ministro condannare un indagato, scrive Riccardo Arena su “Il
Post”. l processo penale si celebra solo nelle aule di giustizia (e non sui
giornali). La sentenza di condanna viene pronunciata solo da un giudice (e non
da un Ministro dell’Interno). Ogni imputato è presunto non colpevole fino a
condanna definitiva. Sono questi concetti ovvi per un Paese che si dice civile.
Concetti che evidentemente non sembrano così ovvi per il Ministro dell’Interno
Angelino Alfano. Ministro che si è affrettato ad emettere la sua condanna
definitiva nei confronti di un indagato. “Le forze dell’ordine” ha sentenziato
Alfano “hanno individuato l’assassino di Yara”. Una frase categorica capace di
superare la necessità di celebrare un processo. Un’affermazione lapidaria che si
è sostituita a tre gradi di giudizio: Corte d’Assise, Corte d’Appello e Corte di
Cassazione. Eppure nessuna norma attribuisce al Ministro dell’Interno il compito
di emettere sentenze né di diffondere notizie che riguardano esclusivamente le
attività istituzionali dei magistrati. Attività dei magistrati che, soprattutto
quando riguardano casi che sono nella fase delle indagini, necessitano del
massimo riserbo. Riserbo che se violato potrebbe nuocere alle indagini stesse.
Ma c’è dell’altro. La gogna politica di Alfano ha prodotto anche una gogna
mediatica su tanti giornali. Una gogna mediatica fatta di titoli in prima pagina
che hanno riportato tra le virgolette la sentenza emessa da Alfano: “Yara, preso
l’assassino”. È la contaminazione dell’errore. È l’epidemia del decadimento.
Resta infine un ultima perplessità: perché il ministro Alfano si è spinto tanto
oltre? Al momento non è dato saperlo, anche se è preferibile non pensare al
peggio. Ovvero che lo abbia fatto per ragioni di visibilità. Approfittare
dell’omicidio di una tredicenne per andare sui giornali sarebbe una condotta
davvero inqualificabile. Forse anche peggiore che fingersi giudice.
Caso Scazzi.
La pubblica opinione è la "Cavia" di chi ha il potere di trasmettere formule
retoriche elementari e ripetitive..., scrive Gilberto Migliorini. Alla fine il
topolino partorisce la montagna. Forse l’opera strapperà il primato À la
recherche du temps perdu in sette volumi di Marcel Proust. Non tanto per la
lunghezza quanto per il tema della rievocazione come oeuvre cathédrale,
con quella memoria spontanea e creativa. Come era del tutto logico prevedere,
tutto un sistema di sillogismi (teoremi) può risultare una corposa esercitazione
di verità apodittiche e dimostrazioni congetturali. Quando ci si avventura sulla
strada delle inferenze induttive, quando si dimenticano i fatti e si introducono
interpretazioni senza metterle al vaglio di altri fatti, quando non si tiene
conto che i testimoni sono suggestionabili dal sistema mediatico e che più ci si
allontana nel tempo da un evento tanto più subentrano fisiologicamente
mille cose a inquinare e deformare la memoria… si finisce per dar credito alle
fantasie, alle illazioni e alle deduzioni senza base empirica, scambiando per
prove quelli che sono solo indizi lacunosi e inconsistenti, ricostruzioni di
fantasia. Ne nasce un mastodontico zibaldone da leggere come una prolissa
inventio di accadimenti, magari anche avvincente, ma priva di quella che si
suole chiamare verosimiglianza. Il caso ricorda il feuilleton, quel
romanzo d’appendice pubblicato a episodi e rivolto a un pubblico di massa, di
bocca buona. I detrattori direbbero di un sottogenere letterario che anticipa
certi moderni rotocalchi o le novelle di riviste prevalentemente
femminili. Non a caso una delle opere più famose è i Misteri di Parigi
(Les Mystères de Paris), di Eugène Sue, romanzo pubblicato a puntate, fra il
1842 e il 1843 su Le Journal des Débats. Non è da dimenticare che dai Misteri
di Parigi trarrà ispirazione Victor Hugo con la prima versione de I
miserabili (intitolata Les mystères) e Alexandre Dumas (padre), con
il suo Edmond Dantès. Il romanzo d'appendice inaugura quella letteratura
di massa che ai giorni nostri è andata annacquandosi nel genere dei rotocalchi e
soprattutto nei format televisivi nazional-popolari. L’attuale romanzo
d’appendice televisivo ha perso qualsiasi velleità letteraria per
diventare soltanto un sistema di gossip salottiero con divagazioni
psico-sociologiche da accatto, connotate da una sorta di narcisismo retorico da
libro cuore (Les Mystères de Paris conservava invece ispirazione e
perfino denuncia dei mali sociali, contro la società del suo tempo, contro un
sistema giudiziario ed economico incapace di punire i veri colpevoli,
anticipando le più complesse e approfondite analisi del naturalismo dei fratelli
Goncourt, di Zola e del verismo italiano). Tutta la storia relativa al caso di
Avetrana è ricca di misteri, cominciando dalle strane confessioni di Michele, ma
nello stesso tempo risulta un caso senza capo né coda, un insieme di fotogrammi
spaiati e senza logica. Nulla che abbia la parvenza di un mosaico dove le
tessere si embricano con naturale verosimiglianza, sembra piuttosto un collage
dove tutto ha l’apparenza di un quadro surreale, quasi un sogno con un incubo al
risveglio. Evidentemente c’è un’altra verità che sfugge alla comprensione. Solo
un’indagine che riparta da zero può riuscire a mettere insieme le tessere del
puzzle senza pregiudizi e senza teoremi, con esiti che potrebbero risultare del
tutto imprevedibili, forse perfino ribaltando ruoli e status dei personaggi. Di
certo e assodato, c’è solo il corpo della povera ragazza in fondo al pozzo e
quelle strane narrazioni di Michele, con un carattere vagamente onirico, e quei
sogni che fanno da contraltare a una vicenda avvolta in una sorta di
fantasia spettrale. Tanti operatori del settore criminologico (omicidi
irrisolti) che affollano gli studi televisivi dimostrano notevoli capacità
dialettiche quando discettano di cold case. Un florilegio di analisi e di
affermazioni fondate su fantasticherie, dicerie, astruserie, pressapochezze…
i classici ragionamenti per assurdo, sillogismi formulati senza il ben che
minimo riscontro, tutto sulle spalle di poveri cristi messi alla berlina
e senza che nessun settore del parlamento italiano abbia niente da ridire,
rappresentanti politici solitamente così pronti ad attivarsi quando si invocano
i diritti inalienabili della difesa per uno di loro fino al completamento di
tutto l’iter giudiziario. Due imputate sono tenute in galera con motivazioni a
dir poco sorprendenti in attesa dei successivi gradi di giudizio. Ovvio che due
donne di estrazione contadina - che tutto un sistema massmediatico ha provveduto
a rappresentare come diaboliche e perverse assassine - sono in grado con la loro
rete di connivenze e di conoscenze non solo di inquinare le prove servendosi del
loro mostruoso sistema di supporto e di protezione, ma, fidando su relazioni
internazionali distribuite in vari paesi, possono proditoriamente sottrarsi con
la fuga in qualche paradiso fiscale dove hanno accumulato cospicue risorse
finanziarie grazie alla loro attività come bracciante agricola e estetista a
tempo perso. Un sistema di linciaggio morale nei confronti di altri presunti
colpevoli di omicidio (fino a sentenza definitiva), o semplicemente di persone
entrate per caso in qualche cold case, va avanti ormai da anni (salvo
qualche meritoria eccezione di opinionisti garantisti) in trasmissioni
televisive che fanno illazioni e ricavano teoremi non già attraverso inchieste
basate su dei fatti - mediante una meticolosa e obiettiva ricerca di riscontri,
magari sul modello della controinchiesta tesa a sottolineare i dubbi e le
incongruenze a favore del più debole o del meno ‘simpatico e fotogenico’ - ma su
delle interpretazioni capziose con l’unico fine di creare audience
indipendentemente da criteri di verità, obiettività e trasparenza. A questo si
aggiungono sedicenti esperti che forniscono interpretazioni scientifiche
senza indicare alcun criterio epistemologico, ma solo sulla base di
considerazioni empiriche o semplicemente di impressioni soggettive.
Semplificazioni che farebbero inorridire qualunque investigatore serio abituato
a esercitare il dubbio e a relativizzare le conclusioni in ragione della
complessità della realtà investigativa (con tutte le sue implicazioni giuridiche
e metodologiche). Si tratta dei limiti di qualsiasi stereotipo di indagine
applicato a situazioni che non sono mai quelle di laboratorio in cui si possono
individuare con assoluta certezza le variabili (dipendenti e indipendenti) in
una situazione controllata. Programmi con opinionisti che parlano spesso senza
cognizione di causa, senza veri strumenti interpretativi, senza esperienza sul
campo… ma influenzando e orientando un’opinione pubblica educata alla
superficialità. Un processo di retroazione che finisce per determinare una sorta
di profezia che si autoadempie attraverso l’individuazione di colpevoli sulla
base esclusivamente di una influenza mediatica che nei casi più estremi diventa
psicosi collettiva e ricerca di un capro espiatorio. Tutto questo avviene
soprattutto in periodi di crisi, quando le difficoltà socio-economiche delle
famiglie e la ricerca di compensazioni alle frustrazioni e all’angoscia del
futuro determinano situazioni di stress e il bisogno di scaricare tensioni e
difficoltà emozionali attraverso identificazioni proiettive e protagonismi per
interposta persona. Da anni si effettua una sorta di teatro dell’assurdo con
giudizi sommari attraverso format ammantati di approfondimento informativo con
un circo di opinionisti dall’aria da Sherlock Holmes, armati vuoi di un
armamentario da detective improvvisato e vuoi con teorie vagamente
neo-lombrosiane, frenologiche, o vuoi semplicemente con il supporto
dell’autorevolezza presenzialista di volti da sempre incorniciati nel rettangolo
del televisore. La locuzione in dubbio pro reo assume un valore puramente
teorico se non entra a far parte dei processi di inferenza logica già nella fase
preliminare delle indagini, come forma mentis, in caso contrario, una volta
presa una strada è come viaggiare sui binari della ferrovia andando in capo al
mondo (un mondo per lo più inventato attraverso teoremi fantasiosi e prove(tte)
abborracciate con molta fantasia e zero riscontri. Il dubbio investigativo
dovrebbe costituire l’abito mentale di qualsiasi ricerca in qualsiasi ambito.
Quel dubbio metodico che consente di tornare continuamente sui propri passi per
verificare che qualche perverso particolare possa aver messo l’indagine su una
strada sbagliata. Con l’avvento delle prove scientifiche, armi notoriamente a
doppio taglio se usate come verifica, e non come falsificatori potenziali, si
possono davvero fare danni notevoli. Alcuni sanno lavorare con metodo e
consapevolezza, ma altri scambiano un indizio per un passepartout che in
quattro e quattr’otto risolve un caso miracolosamente. Siamo tutti in pericolo
di errore giudiziario, e senza voler fare di ogni erba un fascio, perché il
lavoro dell’inquirente e del giudice è duro, difficile e oneroso (e in qualche
caso molto pericoloso quando si ha a che fare con la delinquenza organizzata
come la storia del nostro paese dimostra con veri eroi che hanno pagato con la
vita l’abnegazione e il servizio alla collettività). Occorre però dire che
spesso si ha l’impressione che la categoria si chiuda a riccio in una
autodifesa, a prescindere, quando qualcuno dei suoi rappresentanti non si
dimostra all’altezza...Il caso di Michele Misseri è poi emblematico. Si tratta
di un contadino che in più di un’occasione ha dimostrato di trovarsi in un grave
stato confusionale, che ha accumulato una serie di confessioni (narrazioni)
diverse, contraddittorie e inattendibili, un teste che porta indizi senza prove,
che dichiara cose senza riscontri (nessun elemento che attesti che nella casa di
via Deledda sia avvenuto un delitto, nessun elemento che dimostri che la sua
auto abbia trasportato un cadavere, nessun elemento che provi che lui abbia
infilato il cadavere nel pozzo, nessuna prova che la povera Sarah abbia
raggiunto la casa di via Deledda. L’uomo, in palese stato di sofferenza
psichica, non viene sottoposto a perizia psichiatrica per capire qualcosa di più
della sua personalità, se per caso non sia stato invece semplice testimone di
qualcosa che lo ha sconvolto emotivamente. Tornando ai mass media e alla loro
utilizzazione, occorre dire che l’influenza sull’opinione pubblica è tale da
determinarne l’orientamento e da influenzarne l’interesse puntando sulla
spettacolarizzazione e facendo leva sulla curiosità morbosa e sul giudizio di
pancia, abituando il target a dare valutazioni basate sull’emotività e sul
disimpegno. Tale atteggiamento è tanto più diseducativo quanto più trasforma
l’audience in un modello di elettore sempre meno informato e che offre risposte
pavloviane. Non a caso i cold case, in quanto casi irrisolti e
problematici, rappresentano un test di influenza e un banco di prova su un
target sprovvisto di autonomi e adeguati strumenti interpretativi, sempre più
influenzabile attraverso l’uso di format che ne orientano le scelte e le
modalità di reazione, con input emozionali programmati secondo il vecchio e
inossidabile modello SR. Il caso in parola risulta emblematico, dal punto di
vista mediatico, della facilità con la quale l’opinione pubblica può essere
influenzata utilizzando una comunicazione basata su formule retoriche elementari
e ripetitive e senza mai mettere in dubbio i contenuti espressi
dall’autorevolezza del mezzo televisivo…
Quando la
giustizia semina morti si chiama ingiustizia: Mimino Cosma è uno dei tanti
uccisi dalla malagiustizia? Scrive Massimo Prati sul suo Blog, Volando
Controvento. Per tanti di noi è difficile capire cosa significhi vivere nello
stress e cosa lo stress porti in dote al fisico umano. Parlo in special modo dei
giovani, di quelli fortunati che non hanno mai avuto a che fare con le disgrazie
e vivono ancora nella leggerezza della loro età senza mai essere passati fra
quelle brutte esperienze che cambiano il modo di vedere la vita. Inoltre, non
tutte le persone soffrono in maniera cruenta lo stress: questo perché non siamo
tutti uguali, non tutti reagiamo alla stessa maniera e non tutti siamo costretti
a vivere quelle tragedie familiari che stroncano il pensiero e marciscono la
speranza. Eppure i periodi stressanti esistono e prima o poi toccano a tutti
noi. Chi non trova lavoro e non sa come andare avanti soffre di stress. Chi ha
una famiglia e non sa come mantenerla soffre di stress. Una donna incinta che
non si sente pronta a diventare madre soffre di stress. Suo marito, a cui un
figlio cambierà radicalmente la vita, soffrirà di stress. Chi subisce la morte
improvvisa di un padre o di una madre, perdendo un punto di riferimento
importante, soffre di stress. Chi subisce la morte improvvisa di un figlio,
perdendo quanto di più caro aveva al mondo, soffre di stress. Lo stress è sempre
dietro l'angolo, pronto a colpire chiunque nei momenti meno attesi. Anche le
persone a cui pare andare tutto bene. Per capire a cosa portino i periodi
stressanti, possiamo far riferimento a diversi studi scientifici. Ad esempio il
Brain and Mind Research Institute dell'Università di Sydney, ha
pubblicato una ricerca sul Medical Journal of Australia in cui stabilisce
che l'infarto è provocato dallo stress che eventi diversi possono scatenare
nell'uomo. Ma non è lo stress da lavoro che uccide, non è quello che si prova in
ufficio o in una catena di montaggio. No, a uccidere è quello provocato da fatti
imprevisti, straordinari, e da tragedie familiari. Un altro studio, questa volta
dei ricercatori della Ohio State University, pubblicato sul "Journal
of Clinical Investigation" nell'agosto del 2013, ha cercato di stabilire
come i tumori possano svilupparsi in caso di stress. Da tempo immemore la
scienza ha ipotizzato una correlazione fra stress e cancro, senza però mai
individuare un nesso concreto che portasse a una conferma della supposizione. Ma
la ricerca non ha smesso di studiare e sperimentare, ed ora gli scienziati
statunitensi hanno trovato nel gene ATF3 la possibile chiave per lo sviluppo e
la diffusione delle metastasi, con la conseguente morte per cancro. In
particolare si può dire che il gene era già conosciuto e già si sapeva che si
attivava in condizione di stress. Ciò che gli esperimenti hanno dimostrato è che
il gene non solo uccide le cellule sane, ma agendo in modo irregolare aiuta
anche la proliferazione delle metastasi. "Se il corpo è in perfetto
equilibrio - ha affermato lo scienziato Tsonwin Hai - non è un gran
problema. Quando il corpo è sotto stress, però, cambia il sistema immunitario. E
il sistema immunitario è una lama a doppio taglio". Detto questo c'è da star
certi che l'essere indagati in un caso criminale dal grande profilo
pregiudizievole, e dalla grande eco mediatica (essere indagati da una procura,
ormai si è capito, significa anche essere additati dai compaesani a causa del
pregiudizio iniettato nel popolo da giornalisti e opinionisti sapientoni), porta
stress al fisico che più facilmente può subire un infarto o una malattia
incurabile. Per averne conferma si potrebbe cadere nella tentazione di ricordare
sin da subito il compianto Enzo Tortora, morto di tumore dopo anni di tortura
mediatica e pregiudizi. Ma non serve scomodare il caso più eclatante della
nostra stampa, perché tanti più gravi (ma meno pubblicizzati) stanno a
dimostrare che chi viene indagato, se innocente, soffre in maniera esponenziale
di stress, quello stress che può portare alla morte. Prendiamone alcuni e
partiamo da Don Giorgio Govoni, che dal '97 al 2000 fu perseguitato dai
magistrati che lo additavano a pedofilo-satanista. Nell'ultima udienza a cui
assistette, il pubblico ministero lo dipinse come un rifiuto della società, come
capo di una setta perversa, e chiese per lui 14 anni di carcere. Il giorno dopo
Don Giorgio, agitatissimo, si presentò nello studio del suo legale: aveva
bisogno di sfogarsi e di sentire una voce amica. Ma non riuscì a parlargli
perché morì di infarto in sala d'attesa. Fu condannato da morto Don Giorgio. Per
il giudice, dopo 57 udienze e 300 testimoni (un processo costosissimo), era lui
a dire messa nei cimiteri della zona, era lui l'uomo vestito di nero che diceva
"diavolo nostro", invece che Padre nostro, mentre i satanisti in maschera
lanciavano bambini per aria o li sgozzavano gettandoli nel fiume. Ma c'erano
davvero satanisti in quei cimiteri? No, non c'erano satanisti e non c'erano
abusi. Tutto venne allestito da un Pm che si basò su quanto stabilito da una
psicologa dei servizi sociali di Modena. Ma i procuratori si accanirono e quella
brutta storia rovinò la vita anche ad altri. Parlo di una madre che quando le
portarono via il figlio si gettò dalla finestra, parlo anche dei coniugi Covezzi
che nel '98 se ne videro portar via 4 di figli dai magistrati. L'assoluzione
definitiva per loro è giunta nel 2013, ma Delfino Covezzi non se l'è goduta
perché subito dopo è morto senza poter rivedere i quattro figli strappatigli
dalla giustizia e dati in adozione quindici anni prima del verdetto definitivo
(solo in primo grado fu condannato). Storie allucinanti di sofferenza e stress
incessante che portano anzitempo alla morte e crescono solo per il propagarsi
del pregiudizio, lo stesso che ancora oggi fa dire a tanti italiani che Enzo
Tortora qualcosa aveva fatto, altrimenti non sarebbe stato indagato. Storie
allucinanti come quella di Giovanni Mandalà che assieme a Giuseppe Gullotta fu
condannato per aver ucciso due carabinieri (strage di Alcamo Marina). Giovanni
si è sempre proclamato innocente, come Giuseppe a cui la stampa l'anno passato
ha dedicato tante parole perché ha chiesto allo Stato 69 milioni di euro
per aver trascorso 22 anni in carcere da innocente. Ma il signor Mandalà non è
riuscito ad arrivare alla sentenza di assoluzione. Lui è morto nel '98. Morto
dopo aver subito il dolore assoluto, vittima di un tumore. Come in carcere è
morto Michele Perruzza, un uomo incastrato in una storia che ha attinenze con
quella di Avetrana. Forse non la ricorderete, perché contemporanea al delitto di
via Poma (Simonetta Cesaroni) e perché in pochi giorni i magistrati dissero di
aver scoperto la verità: e come sempre i giornalisti si defilarono senza
approfondire né chiedersi se le accuse mosse dalla procura fossero reali.
Michele Perruzza nel 1990 abitava in una piccola frazione di Balsorano,
provincia de L'Aquila, dove viveva anche sua nipote, la piccola Cristina
Capoccitti di soli sette anni. Il 23 agosto, dopo cena, Cristina uscì di casa
per giocare all'esterno. Ma quando sua madre la chiamò perché si stava facendo
buio, la bimba non rispose. Le ricerche si protrassero per tutta la notte, poi
arrivò l'alba e il corpo di Cristina venne visto: la bimba era svestita e aveva
la testa spaccata. Due giorni dopo un ragazzo di 13 anni, Mauro Perruzza (figlio
di Michele e cugino di Cristina), confessò l'omicidio. Stavano facendo un gioco,
disse, quasi erotico. Poi lei cadde sbattendo la testa su una pietra e lui, per
paura, la strangolò. Ma gli inquirenti non gli credettero, non ce lo vedevano ad
uccidere la cugina e così lo interrogarono per ore fino a fargli dire che era
stato suo padre a uccidere e che lui lo aveva visto perché si trovava a 50 metri
dal luogo del crimine. Ma questa fu solo la sua seconda versione, nel tempo ne
fornì 17 e tutte diverse. Però non appena inserì suo padre, un'auto corse fino
alla sua casa per arrestarlo: era l'alba del 26 agosto e nessuno verificò le
parole del ragazzo. Quando in caserma gli passò davanti in manette, i
giornalisti lo sentirono urlare: "Scusami papà, sono stato costretto!". In
effetti il ragazzo, si scoprirà poi, era stato intimidito di brutto. In ogni
caso suo padre non fece più ritorno a casa. Ma mai accusò il figlio per quel
crimine. Così anche sua moglie che mai ha detto qualcosa contro suo figlio. Come
sempre se non ci sono prove si ragiona di pregiudizio usando il solito
ragionamento del: "Perché un figlio dovrebbe incolpare il padre se non è
colpevole?". Che equivale al moderno: "Perché un padre dovrebbe incolpare la
figlia se non è colpevole?". Così, basandosi su un pregiudizio, in un processo
in cui l'avvocato del sempliciotto muratore Perruzza era lo stesso che difendeva
suo figlio, inconcepibile, il 15 marzo del '91 ci fu una prima condanna
all'ergastolo. In paese ormai tutti erano certi della colpevolezza del Perruzza
e quella sera si festeggiò la condanna coi fuochi d'artificio. Il pregiudizio
della gente era nato da un obbrobrio investigativo e giudiziario in cui non
mancava neppure un'audiocassetta scomparsa (era quella di un interrogatorio in
cui, si dice, si sentivano distintamente i colpi di un pestaggio). Alcuni
giornalisti, solo un paio a dire il vero, muovendosi con sapienza cercarono di
entrare nella verità. Ma non era facile e Gennaro De Stefano (uno dei pochi
giornalisti veri, purtroppo morto anni fa) venne anche intimidito grazie a un
poliziotto che mise della droga nella sua auto prima di una perquisizione (sei
mesi dopo il fatto De Gennaro, per nulla intimidito, fu scagionato e risarcito
con tante scuse). Tralasciando il resto di questa infame storia che procurò solo
dolore, arrivo alla fine. Le Perizie stabilirono che il figlio, da dove aveva
detto di trovarsi non poteva vedere il padre uccidere Cristina. Ma sia in
appello che in cassazione le accuse della procura tennero e nel settembre del
'92 la condanna divenne definitiva. Lo sconcerto subentrò poi, quando in un
processo parallelo (celebrato a Sulmona e non a L'Aquila) si scoprì che sulle
mutandine di Cristina c'era il dna del cugino Mauro, non dello zio. Per cui la
giustizia si trovò agli estremi: la cassazione nel '92 aveva stabilito che
Michele era colpevole oltre ogni ragionevole dubbio, ma nel '98 un giudice,
grazie a buone perizie, certificava nelle sue motivazioni l'innocenza di Michele
Perruzza. Si poteva a quel punto rifare il processo, ma la procura del capoluogo
abruzzese si oppose e alla fine vinsero i procuratori (fra l'altro, il giudice
che aveva condannato all'ergastolo il Perruzza in quel periodo era diventato
procuratore generale de L'Aquila). Comunque lo strazio e lo stress accesero in
maniera esponenziale la sofferenza di Michele Perruzza quando questi capì che
nessuno avrebbe fatto nulla per aiutarlo. Morì nel gennaio del 2003 a causa di
un infarto e le sue ultime parole furono: "Dite a tutti che non ho ucciso io
Cristina". Le disse in punto di morte ai medici dell'ambulanza che inutilmente
cercarono di salvargli la vita. Storie di ordinaria follia? Casi rari che non
fanno testo e non gettano ombre su una giustizia da decenni malata? Una
giustizia spesso falsa e coadiuvata dai media che iniettano il pregiudizio delle
procure nelle vene del popolo? In Italia ci sono sacerdoti con le palle. Uno si
chiama Don Mario Neva e col suo gruppo (Impsex) da tempo cerca di salvare le
ragazze costrette a battere sulle strade. Lui dieci anni fa disse: "Nel ’600 si
credeva di combattere la peste uccidendo gli 'untori', innocenti accusati di
spargere unguenti mortiferi. Un rito crudele quanto inutile che solo dopo 200
anni ebbe giustizia e cessò. Oggi sta succedendo lo stesso. In buona fede
allora, in buona fede oggi: ma è una buona fede che mette radici profonde e
diventa madre di ogni inquisizione". Ed è proprio così. Nulla è peggio del
pregiudizio e nulla è peggio dello stress che uccide chi sa di essere vittima di
una ingiustizia giudiziaria. La vergogna non vive in chi non ha cuore, ma si
amplifica in chi il cuore lo ha più grande. Ed arrivo a Cosimo Cosma, morto a
causa di un tumore che nessuno può dire lo avrebbe certamente colpito senza lo
stress dovuto alle accuse della procura di Taranto. Mimino non era un santo, ma
con lui la giustizia si è sbizzarrita e ha dimostrato di avere una doppia
personalità (e una doppia morale), perché mentre veniva condannato a Taranto per
aver occultato il corpo di una ragazzina di 15 anni (Sarah Scazzi), a Brindisi
subiva la medesima sorte per qualcosa che risulta essere l'esatto contrario: per
aver messo le mani addosso a chi aveva violentato una ragazza di 16 anni (questa
è l'accusa a cui la difesa ha risposto chiedendo al giudice di riconoscere che
il violentatore al momento del fatto non era in grado di intendere e volere). Un
po' come dire che per la nostra giustizia un missionario può con una mano dare a
un bimbo un pezzo di pane e con l'altra mollargli uno schiaffo. Non c'è logica
in certe accuse, lo so, ma fin quando non si metteranno paletti e regole vere da
rispettare, tutto e il contrario di tutto potrà essere dimostrato dal potere
giuridico consolidato. Perché a tutt'oggi c'è chi può iniziare indagando A ed
arrivare a condannare C senza alcun problema. Perché se non convince la versione
di A si gira la frittata e si manda in galera B. E e se non è possibile
incastrare solo B si gira la pentola in verticale e si condanna anche C. Basta
volere e con sogni e veggenze alla fine si può anche dire che non era una
frittata ma una paella, così da mettere in atto un gioco di prestigio buono per
condannare chiunque. Il problema è che, tranne i soliti noti (e sono pochi),
nessuno protesta: la maggioranza dei media sparge il pregiudizio e anche grazie
a loro, con nulla in mano se non pochi indizi, c'è chi può indagare e condannare
chiunque e credere, e far credere, di essere nel giusto. E se qualche avvocato
in gamba dimostra che non è zuppa quanto portato dai procuratori in tribunale,
per i pubblici ministeri c'è sempre la possibilità giuridica di cambiare la
formula e le ricostruzioni e far credere zuppa il pan bagnato. Questo perché
quando si entra nella categoria degli indagati, per i magistrati e la pubblica
opinione non si è più persone e il dolore che si prova quando nessuno ti crede
non figura essere dolore per chi accusa: in fondo, possono soffrire i
numeri? L'essere umano per certe istituzioni non esiste e il dolore che una
accusa fondata su congetture lascia in dote, come lo stress che si prova nel
sentirsi già giudicati prima del processo finale, passa in secondo piano. Ma non
solo gli indagati sono numeri. Forse non vi rendete conto che tutti noi siamo
solo stupidi numeri scritti in sequenza su una qualche cartella o documento: sia
per la sanità che per la giustizia che per i comuni e il governo. Numeri da
allevare in provetta per gli scopi altrui, tifosi che vengono plagiati dalle
istituzioni e vogliono solo vincere, nei campi di calcio come nella politica e
nei tribunali, e a cui non importa di come si giochi la partita, se si fanno
entrate oltre il limite, se agli avversari che giocano in inferiorità numerica
saltano caviglia e perone, se l'arbitro non si dimostra imparziale, se qualcuno
muore. Fin quando non toccherà a noi di subire tutto va bene, anche lo sport che
non è più sport, la politica che non è più politica e la giustizia che non è più
giustizia. Tanto la pubblica opinione alla fine darà ragione a chi comanda
preferendo mettere in campo la volgarità dell'offesa. Tanto i media non daranno
risalto alla notizia scomoda e nessuno si indignerà se i carcerati che si
proclamano innocenti si suicidano dopo aver perso la speranza, se gli imputati
che si proclamano innocenti muoiono di infarto o di tumore a causa di uno stress
infinito, se chi ha mandato in carcere gli innocenti, morti e non, invece di
venir cacciato dalla magistratura continua a incassare i suoi 100.000 euro
all'anno e a far carriera...
Nicola Izzo: "Così i pm mi hanno rovinato".
L’intervista di Giacomo Amadori su “Libero Quotidiano”. In questi giorni in
Parlamento si sta discutendo di riforma della giustizia e responsabilità civile
dei magistrati. Sono migliaia in Italia le persone rovinate dagli errori
giudiziari delle toghe. E sicuramente uno dei casi più celebri è quello del
prefetto Nicola Izzo. Da qualche mese è in pensione, ma sino al novembre 2012
era il vicecapo vicario della Polizia, quasi il comandante in pectore vista la
battaglia contro la malattia che stava conducendo l’allora numero uno Antonio
Manganelli. Un gruppo di agguerriti pm napoletani gli ha stroncato la carriera
indagandolo per turbativa d’asta nell’ambito di un’inchiesta sull’appalto per il
Centro elaborazione dati della Polizia. Lo scorso maggio il gip di Roma, dove il
fascicolo era stato trasferito per competenza, ha prosciolto Izzo da ogni
accusa. Lui ora resta alla finestra, in attesa che qualcuno lo risarcisca per un
danno tanto grande.
Dottor Izzo, quanti milioni di euro dovrebbero darle per
ripagarla di questo clamoroso errore giudiziario?
«Non saprei cosa risponderle. Si parla, ormai da troppi anni, dei malanni della
giustizia senza trovare un rimedio. Io comunque ho sempre pensato che chi
sbaglia deve rispondere: l’irresponsabilità crea i presupposti per aumentare gli
errori e formare il convincimento in chi li commette di esercitare un potere
incontrollato».
Il gip che ha archiviato il procedimento contro di lei e altri 14
indagati vi ha prosciolti senza ombre. Non fa male avere questo riconoscimento
dopo aver lasciato la Polizia?
«Fa male perché in tutto il procedimento ci sono una serie di “travisamenti” che
avrebbero, se valutati correttamente e con accertamenti approfonditi,
consentito, anziché immaginifiche ricostruzioni giudiziarie, l’immediata
archiviazione del tutto, senza creare danni irreparabili. L’inesistenza di
qualsiasi ipotesi collusiva tra noi indagati era di un’evidenza solare».
I pm sembra che non abbiano brillato in precisione. Per esempio
siete stati accusati di aver fatto vincere aziende senza Nos (nullaosta di
sicurezza), mentre in realtà tutte ne erano in possesso. Come è possibile
mettere nero su bianco un’accusa del genere senza averla verificata?
«Questa, al pari di alcune altre accuse, è una delle cose più strabilianti e
gravi. Come si fa a riportare tra i capi di imputazione fatti neanche accertati,
ma solo frutto della propria immaginazione? C’era da fare un semplice
accertamento cartaceo, lo stesso che hanno fatto le difese. Bastava consultare
gli archivi degli enti deputati al rilascio del Nos».
L’inchiesta è stata trasferita a Roma per competenza. Ma non era
chiaro sin dall’inizio che quella presunta turbativa d’asta, se mai ci fosse
stata, era stata consumata nella Capitale (dove si tenne la gara) e non a
Napoli?
«Dico solo che dal 20 dicembre del 2012, data in cui la Procura Generale della
Cassazione aveva individuato la competenza della Procura di Roma, abbiamo dovuto
attendere il luglio 2013 per la trasmissione di tutti gli atti da Napoli, con la
conseguenza che la procura di Roma ha dovuto emettere due distinti decreti di
chiusura indagini per la “rateizzazione”, forse dovuta, mi passi il termine, a
“dimenticanze” nella trasmissione dei documenti».
Certi pm sono innamorati dei loro fascicoli e se ne separano mal
volentieri. Non vorrei infierire, ma per il giudice della Capitale «tutte le
condizioni necessarie al regolare svolgimento della gara erano state seguite».
Ma allora perché tenervi sotto processo per tanti anni?
«Non voglio infierire neanche io, credo solo che in questo clamoroso caso di
malagiustizia ci siano, per chi ha la responsabilità di farlo, sufficienti
elementi per accertare l’inconsistenza e la fantasia dei capi di imputazione e
la leggerezza con cui è stata condotta l’indagine».
Pensa che qualcuno risponderà di questo svarione?
«Spero di scoprirlo presto».
In questa vicenda anche i media hanno contribuito al suo
calvario. Per esempio hanno dato ampio risalto alla lettera anonima di un
“corvo” che collegava il suicidio di un suo stretto collaboratore alle pressioni
gerarchiche che avrebbe subito per alterare le procedure di gara. Ma la vicenda
processuale ha raccontato un’altra verità.
«La morte del collega, anche per l’affetto che nutrivo per lui, è la vera
tragedia nel contesto di questa vicenda. I verbali delle nostre riunioni di
lavoro raccontano una verità molto diversa da quella immaginata dal “corvo”,
verbali da cui emergono le richieste del mio collaboratore di maggiori risorse
economiche per finanziare imprevisti progettuali e le mie pressanti pretese di
giustificazioni per questi nuovi costi. Nell’ultima riunione il collega
ammetteva di non conoscere il progetto a suo tempo elaborato, ma di essere
convinto che avremmo dovuto ricorrere a inconsueti ampliamenti dei contratti,
con l’ utilizzo di ulteriori risorse economiche».
Di fronte a tale affermazione come ha reagito?
«Nonostante fossi convinto della sua buona fede, lo richiamai molto fermamente a
essere più attento e a documentarsi prima di reclamare altri fondi, anche perché
qualsiasi superficialità poteva causare dei dispiaceri. È questo in sintesi il
prologo della tragedia sulla quale ho sempre tenuto il più stretto riserbo per
non ledere l’immagine di una persona onesta e perbene».
In questa storia c’è stata anche un’altra morte prematura. Per
qualcuno pure in questo caso si sarebbe trattato di suicidio…
«Questa notizia non è un refuso di stampa, viene da un’affermazione del Gip di
Napoli che a proposito di un dirigente di polizia ha scritto: «anch’egli
recentemente deceduto in circostanze oggetto di accertamento, come emerso nel
corso degli interrogatori». Di questi accertamenti e interrogatori non ho
trovato traccia, se non nell’affermazione falsa, «si è suicidato», fatta dal pm
nel corso dell’interrogatorio di un teste. Il figlio del compianto funzionario
ha dovuto smentire la circostanza «assurda» con due comunicati in cui dichiarava
che il padre era deceduto naturalmente, «stroncato da un infarto».
Perché secondo lei la lettera del “corvo” spunta sui giornali 3-4
mesi dopo la sua spedizione? Secondo lei c’era un piano dietro a quella strana
fuga di notizie?
«Il ministro dell’Interno, all’epoca Anna Maria Cancellieri, non ha ritenuto di
disporre alcuna inchiesta per scoprire questi motivi e quindi non posso avere
certezze sul punto. Di certo, però, quell’azione va contestualizzata:
nell’estate del 2012 ci trovavamo in un grave momento di crisi del vertice della
Pubblica Sicurezza e vi erano grandi fermenti per la sua sostituzione. Gli
artefici della lettera non erano dei passanti: hanno potuto manipolare i
documenti sull’attività del Ministero di cui erano in possesso, falsandone i
contenuti, e hanno diffuso la lettera utilizzando tecnologie così sofisticate da
rendere non identificabili i mittenti neanche per i tecnici della Polizia delle
comunicazioni».
Il “corvo” ha trovato anche spazio sui giornali…
«Quel documento anonimo è stato accolto con favore in importanti redazioni che
hanno così dato risalto mediatico a una realtà travisata e falsa. Tanto falsa
che oggi vi sono tre direttori di testate nazionali e vari giornalisti rinviati
a giudizio per diffamazione, ma questo a differenza delle farneticazioni di un
anonimo sembra che non sia una notizia degna di nota».
Potremmo definirla una “congiurina” contro la sua eventuale
candidatura forte a Capo della Polizia?
«Certo i malpensanti possono opinare che vi sia dietro un vile, ma astuto
manovratore, qualche puffo incapace di altro che possa aver ordito un qualche
“disegno” per bruciare il mio nome per la successione di Manganelli, ma io non
sono un malpensante e quindi mi ostino a credere che sia stato il “fato”».
Subito dopo le notizie di stampa che facevano riferimento al
“corvo”, lei ha deciso di presentare le dimissioni. Qualcuno ha fatto pressioni
per ottenere quel suo passo indietro?
«Assolutamente no, tutt’altro. Il ministro Cancellieri le respinse. Ma io non
sono un personaggio da operetta, come ce ne sono molti in questo Paese, che
presenta le dimissioni per incassarne il rigetto. In quel momento c’era un’ombra
su di me ed era giusto fare un passo indietro. Per senso dello Stato».
Che cosa le ha fatto più male in questa vicenda, dal punto di
vista umano? Di fronte a quelle ricostruzioni fantasiose, non ha avuto la
sensazione di essere prigioniero di un castello kafkiano?
«Ho avuto modo in questo periodo di approfondire Kafka, e posso risponderle
prendendo in prestito una frase “del traduttore”, Primo Levi: «Si può essere
perseguiti e puniti per una colpa non commessa, ignota, che il “tribunale” non
ci rivelerà mai; e tuttavia, di questa colpa si può portar vergogna, fino alla
morte e forse anche oltre». Tutto questo lo sto provando sulla mia pelle. E
nessuno vi potrà porre mai rimedio».
Lo scandalo del Viminale. Il corvo fa dimettere Izzo, ma la Cancellieri dice no.
Il ministro dell'Interno ha respinto le dimissioni del vice di Manganelli dopo
l'esposto anonimo su appalti pilotati, scrive “Libero Quotidiano”. Il ministro
dell'Interno: "Abbiamo preso molto seriamente la vicenda. Quello che vogliamo è
che il Viminale resti una casa di vetro e un punto di riferimento per il Paese”.
Aperta un'inchiesta. Si è dimesso il vice capo della Polizia, prefetto Nicola
Izzo, chiamato in causa dal corvo nell’inchiesta sui presunti appalti truccati
al Viminale. Izzo ha inviato questa mattina una email al Capo della Polizia,
prefetto Antonio Manganelli e al ministro dell’Interno, Annamaria Cancellieri
che però ha ha respinto le dimissioni, perché "credo, ha detto il ministro, che
una persona non possa essere giudicata sulla base di un esposto anonimo sul
quale non abbiamo ancora riscontri". Intanto la Procura di Roma procede
nell'inchiesta partita in seguito dell’esposto anonimo inviato nei giorni scorsi
al ministro dell’Interno dove si faceva riferimento a presunte violazioni e
illeciti nel conferimento di appalti per l’acquisto di apparecchiature
tecnologiche. L'inchiesta è stata avviata dal procuratore capo, Giuseppe
Pignatone, che ha affidato il fascicolo all’aggiunto Francesco Caporale, che
guida da poco il pool dei magistrati per i reati contro la pubblica
amministrazione. L’esposto anonimo, composto da una ventina di pagine, indica
episodi circostanziati e diversi illeciti che sarebbero stati compiuti
dall’ufficio logistico del Viminale, incaricato delle gare d’appalto per
l’acquisto degli impianti tecnologici. Da parte sua, nelle scorse ore, Izzo si
era difeso da ogni accusa:"Diffamato per fatti che mi sono estranei: da vicecapo
vicario non mi occupo della gestione di appalti". In una nota ha scritto: "Sono
citato ignominiosamente in un esposto anonimo, che potrebbe essere redatto a
carico di chiunque e con qualsiasi contenuto - scrive Izzo - per acquisti di cui
ho conoscenza solo per la funzione strategica dei beni e non delle procedure per
la loro materiale acquisizione. Chi ha costruito l’anonimo, si è nascosto
abilmente, dimostrando la sua conoscenza delle tecnologie avanzate e del settore
degli appalti, usando la mail di persone ignare; e tale modalità forse merita
qualche riflessione sui nobili intenti dell’autore". Prosegue Izzo: "Nello
scritto, l’anonimo segnala anomalie sulle procedure amministrative adottate,
procedure per le quali, in alcuni casi e per quanto mi consta, le stazioni
appaltanti, diverse tra loro e non solo interne al dipartimento della Ps, si
sono consultate con gli organi istituzionali preposti e in tutti i casi, a
conclusione degli appalti, sono state sottoposte al vaglio e registrate, senza
alcun rilievo, dalla Corte dei Conti". Izzo conclude che "nonostante la natura
anonima dell’esposto non dovrebbe dare luogo a seguiti e in presenza di un
quadro di sostanziale regolarità, l’Amministrazione ha trasmesso gli atti alla
Procura per gli eventuali approfondimenti. La morte del compianto Saporito per
le sue tragiche modalità merita solo dolore e rispetto e non vili e strumentali
insinuazioni. Per il Cen sono stato interrogato circa due anni e mezzo fa e
attendo fiducioso il giudizio della magistratura". “Il corvo? Ci piacerebbe
conoscerlo, vedere se sono uno, due o quanti sono”, sostiene il ministro
dell’Interno, Anna Maria Cancellieri ribadendo che oltre all’inchiesta della
magistratura, “di cui attendiamo gli esiti” sono in corso accertamenti
all’interno del Viminale: “Abbiamo preso molto seriamente la vicenda -conclude-
perchè non sappiamo chi volesse colpire” il corvo, “forse aveva anche un
interesse personale. Quello che vogliamo è che il Viminale resti una casa di
vetro e un punto di riferimento per il Paese”.
Lo dice anche il capo della polizia. "I magistrati sono dei cialtroni".
Manganelli al telefono col prefetto Izzo: "Vergognoso che le notizie sui
processi vengano passate ai giornali per fare clamore", scrive “Libero
Quotidiano”. "E' una cosa indegna". Veramente mi disgusta il fatto che io debba
leggere sul giornale, momento per momento, 'stanno per chiamare la dottoressa
Tizio, la stanno chiamando...l'hanno interrogato...la posizione si aggrava'". E
ancora: "Perchè se no qua diamo per scontato che tutto viene raccontato dai
giornali, che si fa il clamore mediatico, che si va a massacrare la gente prima
ancora di trovare un elemento di colpevolezza". E poi ancora: "A me pare molto
più grave il fatto che un cialtrone di magistrato dia indebitamente la notizia
in violazione di legge...". Chi parla potrebbe essere Silvio Berlusconi, che
tante volte si è lamentato di come le notizie escano dai tribunali prima sui
giornali che ai diretti interessati. E invece, quelle che riporta il Corriere
della Sera, sono parole pronunciate nel giugno 2010 nientemeno che del capo
della polizia Antonio Manganelli, al telefono col prefetto Nicola Izzo, ex
vicario della polizia. Si lamenta, Manganelli, della fuga di notizie a proposito
del caso degli appalti per il centro elettronico e per gli altri interventi
previsti dal patto per la sicurezza, indagine condotta dalla procura di Napoli e
che portò a una serie di provvedimenti tra cui l'arresto del prefetto Nicola
Fioriolii e l'interdizione dai pubblici uffici per i prefetti Nicola Izzo e
Giovanna Iurato.
L’ANTIMAFIA DEI RECORD.
Il pm Antimafia della Procura di Bari Isabella Ginefra ha chiesto 58 condanne,
35 assoluzioni e un non luogo a procedere per prescrizione nei confronti dei 103
imputati (gli altri 9 deceduti) nel processo chiamato «Il canto del cigno» su
una presunta associazione mafiosa operante sulla Murgia barese tra Gravina e
Altamura negli anni Novanta, finalizzata a traffico e spaccio di droga,
detenzione di armi ed esplosivi, estorsioni, 8 tentati omicidi, ferimenti e
conflitti a fuoco tra clan rivali, scrive “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Il
procedimento penale fu avviato nel 1997 dall'allora pm antimafia barese Leonardo
Rinella quando, nel corso del processo alla mafia murgiana denominato «Gravina»
nei confronti di oltre 160 persone, alcuni imputati decisero di collaborare con
la giustizia rivelando nuovi particolari sulle attività illecite dei clan
Mangione e Matera-Loglisci, all'epoca - secondo la Procura - in stretto contatto
con i gruppi criminali baresi di Savino Parisi, Antonio Di Cosola, Giuseppe
Mercante, Andrea Montani ed altri. Tra i capi di questa presunta associazione
mafiosa c'erano, secondo l'accusa, Vincenzo Anemolo, ritenuto un «figlioccio»
del boss Savinuccio, e suo fratello Raffaele, il defunto Francesco Biancoli (il
camorrista che avrebbe battezzato Parisi), Bartolo D'Ambrosio (ucciso nel 2010)
e il suo ex alleato, poi rivale, Giovanni Loiudice (processato e assolto per
l'omicidio del boss), Emilio Mangione e suo nipote Vincenzo, Nunzio Falcicchio,
soprannominato «Lo scheletro». L'indagine, ereditata negli anni successivi dai
pm Antimafia Michele Emiliano ed Elisabetta Pugliese, portò nel marzo 2002
all'arresto di 131 persone. Per oltre 200 fu poi chiesto il rinvio a giudizio ma
soltanto 94 sono ancora imputate per quei fatti. Gli altri sono stati giudicati
con riti alternativi o prosciolti. A quasi vent'anni dai fatti contestati sulla
base degli accertamenti dei Carabinieri di Bari e Altamura, la Procura chiede
ora condanne comprese fra 10 e 4 anni di reclusione per 58 di loro. Tra i reati
ritenuti ormai prescritti ci sono due tentati omicidi del 1994 e del 1997 e
alcuni episodi di spaccio. Stando all'ipotesi accusatoria quella murgiana era
una vera e propria «associazione armata di stampo mafioso-camorristico» promossa
e organizzata da «padrini e figliocci». Agli atti del processo, durato oltre
sette anni, ci sono prove dei «battesimi», le cerimonie di affiliazione, e
l'esatta ricostruzione dei ruoli all'interno del clan sulla base di una precisa
ripartizione territoriale per la gestione delle attività illecite. Le
discussioni dei difensori sono fissate per le udienze del 16 luglio e del 29
settembre, data in cui è prevista la sentenza.
Niente sentenza per 17 anni. Imputati morti e prescritti. Il pm chiede le
condanne per un'inchiesta antimafia del 1997. Ma alla sbarra di 200 ne restano
solo 58, scrive Gianpaolo Iacobini su “Il Giornale”. A Bari, il processo alla
cosca? Dopo 17 anni arrivano le richieste di condanna in primo grado.
L'antimafia dei record è pugliese. Il primato, però, non è di quelli di cui
andar fieri: per un procedimento penale nato da indagini avviate nel 1997, e
relative a fatti verificatisi agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso,
soltanto adesso la Procura ha avanzato davanti ai giudici richiesta di pena nei
confronti degli imputati. La storia ha un nome simbolico, uno di quelli che
tanto solleticano le cronache ed i giornalisti quando scattano i blitz: «Il
canto del cigno». È il 2 settembre del 2002: i magistrati della Dda barese
Elisabetta Pugliese e Michele Emiliano (proprio lui: l'ex sindaco di Bari)
chiudono con un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 131 persone il
troncone investigativo fiorito 5 anni prima per gemmazione da un altro
maxi-processo. Nel mirino della Direzione distrettuale finiscono gli
appartenenti ad una presunta organizzazione criminale attiva sull'altopiano
delle Murge, nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia, ed i loro collegamenti
con i clan del capoluogo di regione. All'attivo estorsioni, detenzione d'armi,
traffico di droga e ferimenti. Finalizzati, secondo gli inquirenti,
all'affermazione di un'associazione armata di stampo mafioso-camorristico.
«Quest'operazione dimostra come la criminalità barese, dalla fine degli anni '80
ad oggi, abbia creato dei cloni in tutta la provincia», commenta in quei giorni
coi cronisti Emiliano, esprimendo soddisfazione per il lavoro portato a termine.
Ma i processi sono un'altra cosa. Ed in Tribunale il cigno canterà solo a
settembre 2014. Quando il collegio giudicante si determinerà in primo grado
sulle richieste di pena avanzate l'altro ieri - a quasi vent'anni dall'apertura
dell'inchiesta - dal pm antimafia Isabella Ginefra. Che la sua requisitoria l'ha
conclusa sollecitando condanne oscillanti tra i 10 e i 4 anni di reclusione nei
riguardi di 58 degli oltre 200 imputati: gli altri sono stati prosciolti o
processati con riti alternativi. O sono morti. Alcuni per vecchiaia. Qualcuno
per piombo, come Bartolo D'Ambrosio, crivellato a colpi di fucile e pistola nel
2010. Ed il passar del tempo, oltre agli uomini, ha spazzato via con la ramazza
della prescrizione anche molti dei reati contestati, come un paio di tentati
omicidi risalenti al 1994. Farà notizia? No, a giudicare dagli echi di cronaca
che arrivano da Palermo, dove il presidente del tribunale del riesame, Giacomo
Montalbano, con un'ordinanza ha disposto il rinvio d'ufficio a settembre di
tutti i procedimenti che non riguardino detenuti in carcere o ai domiciliari:
pochi i magistrati in organico, troppi i ricorsi che si prevede arriveranno dopo
l'arresto, il 22 giugno, di 91 persone considerate affiliate ai mandamenti
mafiosi di Resuttana e San Lorenzo. La chiamano giustizia. Pare una barzelletta.
LA CHIAMANO GIUSTIZIA, PARE UNA BARZELLETTA. PROCESSI: POCHE
PAGINE DA LEGGERE E POCHI TESTIMONI.
Dopo aver affermato qualche mese fa che se nel nostro Paese si fanno troppe
cause la colpa è del numero eccessivo di avvocati, ora l’illustre magistrato
Giorgio Santacroce, presidente della Corte di Cassazione, interviene per
chiarire (agli avvocati, ovviamente) come vanno redatti i ricorsi da presentare
alla Suprema Corte onde non incorrere in possibili declaratorie di
inammissibilità. Lo ha fatto con una lettera inviata al Presidente del
CNF Guido Alpa dopo il Convegno “Una rinnovata collaborazione tra
magistratura e avvocatura nel quadro europeo” organizzato dal
Consiglio Consultivo dei Giudici Europei del Consiglio d’Europa, dal
CSM e dal CNF. Prendendo spunto dal dibattito scaturito in quella circostanza,
il Dott. Santacroce ha preso carta e penna ed ha scritto una
lettera al Consiglio Nazionale Forense per confermare alcune direttive, ora
finalmente rese “ufficiali” dall’organo deputato a riceverle. Richiamando quanto
già espresso in precedenza sia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
(la quale ha previsto tra le indicazioni pratiche relative alla forma e al
contenuto del ricorso di cui all'art. 47 del Regolamento che «nel caso
eccezionale in cui il ricorso ecceda le 10 pagine il ricorrente dovrà presentare
un breve riassunto dello stesso») e dal Consiglio di Stato (che
ha suggerito di contenere nel limite di 20-25 pagine la lunghezza di memorie e
ricorsi, e, nei casi eccedenti, di far precedere l’esposizione da una distinta
sintesi del contenuto dell’atto estesa non più di 50 righe), il primo Presidente
della Corte ha affermato che anche gli atti dei giudizi di cassazione dovranno
trovare applicazione criteri similari. “Ben potrebbe ritenersi congruo
– scrive il Presidente Santacroce nella lettera indirizzata al CNF
- un tetto di 20 pagine, da raccomandare per la redazione di ricorsi,
controricorsi e memorie. Nel caso ciò non fosse possibile, per l'eccezionale
complessità della fattispecie, la raccomandazione potrà ritenersi ugualmente
rispettata se l'atto fosse corredato da un riassunto in non più di 2-3 pagine
del relativo contenuto. Sembra, altresì, raccomandabile che ad ogni atto, quale
ne sia l'estensione, sia premesso un breve sommario che guidi la lettura
dell'atto stesso. Allo stesso modo è raccomandabile che le memorie non
riproducano il contenuto dei precedenti scritti difensivi, ma, limitandosi ad un
breve richiamo degli stessi se necessario, sviluppino eventuali aspetti che si
ritengano non posti adeguatamente in luce precedentemente, così anche da
focalizzare su tali punti la presumibile discussione orale”. Attenendosi a
tali criteri di massima si potrebbe superare, secondo il primo Presidente - in
molti casi quello scoglio che è l’inammissibilità del ricorso “non già per
la mancanza di concretezza dei motivi del ricorso, ma per la modalità con cui
questo viene presentato, che non rispondono ai canoni accettati dalla
Cassazione”, tra i quali appunto la sinteticità degli atti presentati a sostegno
della presa in esame del dibattimento arrivato a sentenza in Appello”. Lo
spirito dell’iniziativa del Dott. Santacroce è certamente propositivo e
positivo, così come lo è il clima di collaborazione che il Magistrato ha
auspicato in tal senso. Di certo però andrà conciliato con un altro principio -
quello dell’autosufficienza dell’atto - che non poco ha turbato il sonno degli
avvocati in questi ultimi mesi, ossia l’esigenza posta a carico del ricorrente
di inserire nel ricorso o nella memoria la specifica indicazione dei fatti e dei
mezzi di prova asseritamente trascurati dal giudice di merito, nonché la
descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori con eventuale
trascrizione dei passi salienti. Un requisito (l’autosufficienza) che i giudici
della Corte non hanno ritenuto affatto assolto mediante la allegazione di
semplici fotocopie, e questo perché, si è detto, non è compito della Corte
individuare tra gli atti e documenti quelli più significativi e in essi le parti
più rilevanti, “comportando una siffatta operazione un'individuazione e
valutazione dei fatti estranea alla funzione del giudizio di legittimità”.
Da qui la redazione di atti complessi ed articolati, e dunque anche lunghi, nel
timore di non vedere considerato dal parte del Giudice un qualche aspetto o un
qualche documento essenziale ai fini del decidere. Ora, insomma, gli avvocati
avranno un compito in più: conciliare il criterio della brevità dell’atto con
quello dell’autosufficienza. Mica roba da poco….
La conseguenza
è.........La Cassazione boccia un ricorso perché "troppo prolisso".Sotto accusa
l'atto degli avvocati dell'Automobile club d'Ivrea contro una sentenza della
Corte d'Appello di Torino:"Tante pagine inutili". Ma diventa un modello: massimo
venti pagine, scrive Ottavia Giustetti su “la Repubblica”. La dura vita del
giudice di Cassazione: presentate pure il ricorso, avvocati, ma fate in modo che
sia sintetico. Altrimenti state pur certo che sarà respinto. Poche pagine per
spiegare i fatti, niente che comporti uno sforzo inutile per chi legge. Insomma
«non costringeteci» a esaminare pagine e pagine se volete avere qualche speranza
di vincere. Nero su bianco, tra le righe del testo di una recente sentenza della
terza sezione sul ricorso contro una decisione della Corte d’appello di Torino,
i giudici supremi hanno vergato il vademecum della sintesi estrema. Altrimenti:
bocciatura assicurata. Qualche tempo fa lo avevano fatto a proposito dei ricorsi
di legittimità legati al fisco. «La pedissequa riproduzione dell’intero,
letterale, contenuto degli atti processuali - scrivono i magistrati al primo
capoverso che illustra le motivazioni del rigetto del ricorso - è del tutto
superfluo ed equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere
tutto (anche quello di cui non occorre che sia informata) la scelta di quanto
rileva. La conseguenza è l’inammissibilità del ricorso per Cassazione». E, a
quanto pare, è solo un esempio dei pronunciamenti di questo tenore che in questi
mesi agitano le acque nell’ambiente degli avvocati. I forum sul diritto sono
zeppi di commenti taglienti sulla «preziosa risorsa» del giudice che va
«salvaguardata a tutti i costi». Tempi sterminati della giustizia, necessità di
smaltire migliaia di procedimenti arretrati, prescrizione sempre in agguato: è
nell’ambito della lotta a questi ormai cronici problemi del Paese il vademecum
del giudice all’avvocato per evitare sbrodolamenti inutili. E non si può dire
che sia nuova la tendenza a inibire il difensore che non si trasformi ogni volta
in un Marcel Proust del diritto quando chiede giustizia. Ma respingere un
ricorso perché un legale non è stato capace di sintesi da bignami appare come
una novità giuridica importante, dicono gli avvocati. Nel caso della terza
sezione civile sulla sentenza della Corte d’appello di Torino l’oggetto del
contendere erano le spese di gestione dell’Automobile club di Ivrea. Una vicenda
relativamente di poco conto. Ma analoghe prescrizioni si fanno strada e
rischiano di diventare obbligo previsto per legge se sarà approvato uno
specifico emendamento del decreto di riforma della giustizia in discussione in
questi mesi in Parlamento. Il punto che è già stato approvato dalla commissione
affari costituzionali della Camera finisce col prevedere la necessità per gli
avvocati amministrativisti di scrivere i ricorsi e gli altri atti difensivi
entro le esatte dimensioni che sono in via di definizione e sono stabilite con
un decreto del Presidente del Consiglio di Stato. Saranno venti pagine al
massimo i ricorsi d’ora in poi, mentre quel che sconfina è destinato per sempre
all’oblio. Brevità della trattazione, che va in direzione opposta all’abitudine
di molti legali che, con il timore di rientrare nei canoni dell’inammissibilità,
finiscono per presentare ricorsi-fiume.
Ed ancora:
“Inammissibile, prolisso e ripetitivo”. Così i giudici del Consiglio di Stato di
Lecce hanno giudicato il ricorso d’appello presentato dai tredici proprietari
dei terreni interessati dai lavori di allargamento della tanto contestata s.s.
275. Oltre a riconfermare quanto rilevato dal Tribunale amministrativo leccese,
il Consiglio di Stato ha deciso di condannare gli appellanti al rimborso delle
spese di lite, con la sanzione prevista per la violazione del principio di
sinteticità degli atti processuali, introdotta dall’art. 3 del nuovo Codice del
processo amministrativo. “Si deve tener conto – si legge in sentenza –
dell’estrema prolissità e ripetitività dell’appello in esame (di 109 pagine)”.
Il rispetto del dovere di sinteticità, ha sottolineato il Giudice, “costituisce
uno dei modi – e forse tra i più importanti – per arrivare ad una giustizia
rapida ed efficace”. Gli appellanti dovranno rimborsare, dunque, le spese alla
Provincia di Lecce, alla Regione Puglia, al Consorzio Asi, alla Prosal, al CIPE,
all’Anas, al Ministero delle Infrastrutture, al Ministero dell’Ambiente e al
Ministero dei Rapporti con la Regione.
Eh, sì!
Proprio così : lo affermano la Suprema Corte con sentenza n. 11199 del
04.07.2012 e, di recente, il Tribunale di Milano con sentenza del 01.10. 2013,
scrive l’Avv. Luisa Camboni. "Viola il giusto processo l'avvocato che
trascrive nel proprio atto processuale le precedenti difese, le sentenze dei
precedenti gradi, le prove testimoniali, la consulenza tecnica e tutti gli
allegati; il giusto processo richiede trattazioni sintetiche e sobrie, anche se
le questioni sono particolarmente tecniche o economicamente rilevanti". I
Giudici di Piazza Cavour dicono "NO" agli avvocati prolissi. Perché? Perché, a
dire dei Giudici con la toga di ermellino, si violerebbe uno dei principi
cardine, uno dei pilastri fondamentali su cui poggia il nostro sistema
giuridico: il principio del giusto processo, ex art. 111 Cost. "La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. [...]".
Uno dei tanti significati insiti nel menzionato principio, difatti, è quello di
garantire la celerità del processo, celerità che si realizza anche attraverso
atti brevi, ma chiari e precisi nel loro contenuto ( c.d. principio di
sinteticità). Il caso, su cui i Giudici si sono pronunciati, riguardava un
ricorso di oltre 64 pagine e una memoria illustrativa di ben 36 pagine, il cui
contenuto reiterava quello del ricorso. Il principio cui hanno fatto riferimento
per dare un freno, uno STOP a Noi Avvocati, molto spesso prolissi, è il
principio del giusto processo. Difatti, hanno precisato che un atto processuale
eccessivamente lungo, pur non violando alcuna norma, non giova alla chiarezza e
specificità dello stesso e, nel contempo, ostacola l'obiettivo di un processo
celere. Il cosiddetto giusto processo, tanto osannato dalla nostra Carta
Costituzionale, infatti, richiede da Noi Avvocati atti sintetici redatti in modo
chiaro e sobrio: "nessuna questione, pur giuridicamente complessa", a
dire della Suprema Corte, "richiede atti processuali prolissi". L'atto
processuale, dunque, deve essere completo e riportare in modo chiaro la
descrizione delle circostanze e degli elementi di fatto, oggetto della
controversia. Ancora una volta la Suprema Corte ha richiamato l'attenzione di
Noi Avvocati specificando quali sono i principi che ogni operatore di diritto,
nella specie l'Avvocato, deve tener presente nel redigere gli atti: specificità,
completezza, chiarezza e precisione. Nel caso, dunque, di violazione del
principio di sinteticità, ovvero di redazione di atti sovrabbondanti, il giudice
può tenerne conto, in sede di liquidazione delle spese processuali, condannando
la parte colpevole ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Per Noi Avvocati, sulla
base di quanto affermato dai Giudici di Piazza Cavour, non ha valore alcuno il
motto latino "Ripetita iuvant", in quanto le cose ripetute non giovano
alla nostra attività professionale che si estrinseca, nei giudizi civili, in
attività di difesa negli atti, i quali devono essere chiari, sintetici e
precisi. Un'attività di difesa non dipende dalla lungaggine dell'atto, ma
dall'ingegno professionale, ingegno che consiste nell'individuare la giusta
strategia difensiva per ottenere i migliori risultati sia per il cliente, sia
per lo stesso professionista.
"Avvocati
siete troppo prolissi, se volete ottenere giustizia per i vostri assistiti
dovete imparare il dono della sintesi": la Cassazione ormai lo scrive nel testo
delle sentenze. Ecco il parere di un principe del foro torinese, l'avvocato
Andrea Galasso, protagonista nelle battaglie tra Margherita Agnelli e la sua
famiglia e nel processo a Calciopoli.
Avvocato, i
suoi colleghi sono contrari e allarmati, lei cosa ne pensa?
«Da un certo
punto di vista i giudici mi trovano d'accordo perché so che spesso quando ci si
dilunga e si sbrodola volentieri sui fatti è perché si teme di non poter
argomentare bene in punto di diritto. Quindi la Cassazione ha ragione a ritenere
che sia necessaria una buona dote di sintesi anche per non appesantire una
attività che è diventata sempre più pressante».
Quindi,
secondo lei, un bravo avvocato è capace di rimanere nei limiti che la Cassazione
considera legittimi per presentare un ricorso?
«In linea di
massima ritengo di sì. Poi, ovviamente, ci sono casi diversi. La sintesi deve
essere una indicazione generale. poi ogni processo ha la sua storia».
Però
sentenze recenti scrivono proprio nero su bianco che il ricorso può essere
respinto perché è troppo prolisso e costringe la Corte a leggere elementi
inutili. Lei crede che sia corretto?
«No, questo
no. Siamo in un caso di cattiveria intellettuale. Di malcostume alla rovescia».
Tra l'altro
queste indicazioni di brevità estrema condizioneranno sempre di più il lavoro
degli avvocati. È in via di approvazione un emendamento che stabilisce un tetto
di venti pagine per i ricorsi al Tar.
«Questo è un
problema serio che riguarda il rapporto degli avvocati con i consigli
dell'Ordine che evidentemente non sono in grado di far sentire la propria voce
quanto dovrebbero».
Lei crede
che la categoria dovrebbe essere più ascoltata, insomma?
«Beh sì.
Quando si trasformano in legge regole che condizionano così profondamente il
nostro lavoro sarebbe opportuno avere un Ordine degli avvocati capace di
proporsi come interlocutore valido. E invece, evidentemente non è così».
Ma
all'inaudito non c'è mai fine....
Il giudice:
"Troppi testimoni inutili? Pena più alta". E gli avvocati milanesi scioperano.
Gli avvocati si asterranno dalle udienze il 17 luglio 2014 perché ritengono che
siano stati stravolti "alcuni principi cardine del processo accusatorio, ovvero
quelli del contraddittorio nella formazione della prova", scrive “La
Repubblica”. Non sono andate giù agli avvocati penalisti milanesi le parole
pronunciate in aula da un giudice che, in sostanza, di fronte ai legali di un
imputato ha detto che se si insiste per ascoltare testimoni inutili, i
magistrati poi ne tengono conto quando si tratta di calcolare la pena. E così la
Camera penale di Milano, prendendo una decisione clamorosa e dura, anche sulla
base di quel grave "caso processuale" che lede il diritto di difesa, hanno
deciso di proclamare una giornata di astensione nel capoluogo lombardo per il
prossimo 17 luglio. Come si legge in una delibera del consiglio direttivo della
Camera penale,"lo scorso 20 giugno, nell'ambito di un'udienza dibattimentale
celebratasi avanti a una sezione del tribunale di Milano, il presidente del
collegio ha affermato" a proposito dell'esame di testimoni: "Non mi stancherò
mai di ripetere che secondo me quando in un processo si insiste a sentire testi
che si rivelano inutili, ovviamente si può essere assolti, ma se si è condannati
il tribunale ne tiene sicuramente conto ai fini del comportamento processuale"
(che influisce sulla pena). E ha aggiunto: "E mi dispiace che sugli imputati a
volte ricadano le scelte dei difensori". Il giudice che ha usato quelle parole
in udienza sarebbe Filippo Grisolia, presidente dell'undicesima sezione penale.
Il giudice, secondo la Camera penale, ha così violato "l'autonoma determinazione
del difensore nelle scelte processuali, il quale deve essere libero di valutare
l'opportunità o meno di svolgere il proprio controesame". In più il magistrato
ha violato le norme che "riconducono la commisurazione della pena esclusivamente
a fattori ricollegati alla persona dell'imputato", oltre a manifestare "non
curanza per alcuni dei principi cardine del processo accusatorio, ovvero quelli
del contraddittorio nella formazione della prova". I penalisti milanesi, dunque,
preso atto che "le segnalazioni agli uffici giudiziari" fatte in passato "non
hanno ottenuto" lo scopo di "neutralizzare" i comportamenti lesivi del diritto
di difesa, e ritenuta "la gravità del fenomeno che il caso processuale riportato
denuncia", hanno deciso di astenersi dalle udienze e da "ogni attività in ambito
penale" per il 17 luglio prossimo. Con tanto di "assemblea generale" convocata
per quel giorno per discutere "i temi" della protesta. "Questo fenomeno della
violazione del diritto di difesa - ha spiegato il presidente della Camera penale
milanese, Salvatore Scuto - è diffuso ed è emerso con virulenza in questo caso
specifico, ma non va ridotto al singolo giudice che ha detto quello che ha
detto. Questa è una protesta - ha aggiunto - che non va personalizzata, ma che
pone l'indice su un problema diffuso e che riguarda le garanzie dell'imputato e
il ruolo della difesa". La delibera è stata trasmessa anche al presidente della
Repubblica, al presidente del consiglio dei ministri, al ministero della
Giustizia e al Csm, il Consiglio superiore della magistratura.
IL SUD
TARTASSATO.
Sud tartassato: il Meridione paga più di tutti, scrive Lanfranco Caminiti su “Il
Garantista”. Dice la Svimez che se muori e vuoi un funerale come i cristiani, è
meglio che schiatti a Milano, che a Napoli ti trattano maluccio. E non ti dico a
Bari o a Palermo, una schifezza. A Milano si spende 1.444,23 euro per defunto, a
Napoli 988 euro, a Bari 892 euro e 19 centesimi, a Palermo 334 euro. A Palermo,
cinque volte meno che a Milano. Il principe Antonio De Curtis, in arte Totò, si
rivolterà nella tomba, che a quanto pare non c’è nessuna livella, dopo morti. E
checcazzo, e neppure lì terroni e polentoni siamo uguali. E basterebbe solo
questo – il culto dei morti dovrebbe antropologicamente “appartenere” alle
società meridionali, era il Sud la terra delle prefiche, era il Sud la terra
delle donne in nero, era il Sud la terra dei medaglioni con la fotina
dell’estinto che pendono sul petto delle vedove – per dire come questa Italia
sia cambiata e rovesciata sottosopra. Si paga al Sud di più per tutto, per
l’acqua, la monnezza, l’asilo, gli anziani, la luce nelle strade, i trasporti,
insomma per i Lep, come dicono quelli che studiano queste cose: livelli
essenziali delle prestazioni. Essenziali lo sono, al Sud, ma quanto a
prestazioni, zero carbonella. Eppure, Pantalone paga. Paga soprattutto la classe
media meridionale che si era convinta che la civilizzazione passasse per gli
standard nazionali. Paghiamo il mito della modernizzazione. Paghiamo l’epica
della statalizzazione. Paghiamo la retorica della “cosa pubblica”. Paghiamo
l’idea che dobbiamo fare bella figura, ora che i parenti ricchi, quelli del
Nord, vengono in visita e ci dobbiamo comportare come loro: non facciamoci
sempre riconoscere. Paghiamo le tasse, che per questo loro sono avanti e noi
restiamo indietro. Lo Stato siamo noi. Parla per te, dico io. Dove vivo io, un
piccolo paese del Sud, pago più tasse d’acqua di quante ne pagassi prima in una
grande città, e più tasse di spazzatura, e non vi dico com’è ridotto il cimitero
che mi viene pena solo a pensarci. Sono stati i commissari prefettizi – che
avevano sciolto il Comune – a “perequare” i prelievi fiscali. Poi sono andati
via, ma le tasse sono rimaste. Altissime, cose mai viste. In compenso però, la
spazzatura si accumula in piccole montagne. A volte le smantellano, poi si
ricomincia. Non sai mai quando, magari qualcuno dei laureati che stanno a
girarsi i pollici al baretto della piazza potrebbe studiarla, la sinusoide della
raccolta rifiuti. Invece, i bollettini arrivano in linea retta. Con la scadenza
scritta bella grossa. L’unica cosa che è diminuita in questi anni al Sud è il
senso di appartenenza a una qualche comunità più grande del nostro orto privato.
La pervasività dello Stato – e quale maggiore pervasività della sua capacità di
prelievo fiscale – è cresciuta esponenzialmente quanto l’assoluta
privatizzazione di ogni spirito meridionale. Tanto più Stato ha prodotto solo
tanta più cosa privata. E non dico solo verso la comunità nazionale, la Patria o
come diavolo vogliate chiamarla. No, proprio verso la comunità territoriale. Chi
può manda i figli lontano, perché restino lontano. Chi può compra una casa
lontano sperando di andarci il prima possibile a passare gli anni della
vecchiaia. Chi può fa le vacanze lontano, a Pasqua e a Natale, il più esotiche
possibile. Chi non può, emigra. Di nuovo, come sempre. Il Sud è diventato terra
di transito per i suoi stessi abitanti. Come migranti clandestini, non vediamo
l’ora di andarcene. il Sud dismette se stesso, avendo perso ogni identità
storica non si riconosce in quello che ha adesso intorno, che pure ha accettato,
voluto, votato.
C’era una volta l’assistenzialismo.
Rovesciati come un calzino ci siamo ritrovati contro un federalismo
secessionista della Lega Nord che per più di vent’anni ci ha sbomballato le
palle rubandoci l’unica cosa in cui eravamo maestri, il vittimismo. Siamo stati
vittimisti per più di un secolo, dall’unità d’Italia in poi, e a un certo punto
ci siamo fatti rubare la scena da quelli del Nord – e i trasferimenti di
risorse, e le pensioni, e l’assistenzialismo e la pressione fiscale e le camorre
degli appalti pubblici – e l’unica difesa che abbiamo frapposto è stata lo
Stato. Siamo paradossalmente diventati i grandi difensori dell’unità nazionale
contro il leghismo. Noi, i meridionali, quelli che il federalismo e il
secessionismo l’avevano inventato e provato. Noi, che dello Stato ce ne siamo
sempre bellamente strafottuti. Li abbiamo votati. Partiti nazionali, destra e
sinistra, sindaci cacicchi e governatori, li abbiamo votati. Ci garantivano le
“risorse pubbliche”. Dicevano. Ci promettevano il rinascimento, il risorgimento,
la resistenza. Intanto però pagate. Come quelli del Nord. Facciamogli vedere.
Anzi, di più. La crisi economica del 2007 ha solo aggravato una situazione già
deteriorata. E ormai alla deriva. È stata la classe media meridionale
“democratica” l’artefice di questo disastro, con la sua ideologia statalista.
Spesso, loro che possono, ora che le tasse sono diventate insopportabili, ora
che il Sud è sfregiato, senza più coscienza di sé, ora se ne vanno. O mandano i
loro figli lontano. Chi non può, emigra. Di nuovo, come sempre.
Non solo i cittadini italiano sono tartassati, ma sono anche soggetti a dei
disservizi estenuanti.
ITALIANI. LA CASTA DEI "COGLIONI". FACCIAMO PARLARE CLAUDIO
BISIO.
In molti mi hanno scritto chiedendomi il testo del mio monologo effettuato
durante il Festival di Sanremo 2013 il 16 Febbraio scorso. Beh, eccolo. Inoltre
alcuni di voi, sull'onda del contenuto di quel monologo hanno creato una pagina
facebook "Quelli che domenica voteranno con un salmone". Come vedete, l'ho fatto
anch'io...
Sono un italiano. Che emozione... E che paura essere su questo palcoscenico...
Per me è la prima volta. Bello però. Si sta bene… Il problema ora è che cosa
dire. Su questo palco è stato fatto e detto davvero di tutto. E il contrario di
tutto. Gorbaciov ha parlato di perestroika, di libertà, di democrazia… Cutugno
ha rimpianto l’Unione Sovietica. Gorbaciov ha parlato di pace… e Cutugno ha
cantato con l’Armata Rossa… Belen ha fatto vedere la sua farfallina (io potrei
farvi vedere il mio biscione, ma non mi sembra un’ottima idea… è un tatuaggio
che ho sulla caviglia, dopo tanti anni a Mediaset è il minimo…) Ma soprattutto
Benigni, vi ricordate quando è entrato con un cavallo bianco imbracciando il
tricolore? Ecco, la rovina per me è stato proprio Benigni. Lo dico con una sana
invidia. Benigni ha alzato troppo il livello. La Costituzione, l'Inno di Mameli,
la Divina Commedia... Mettetevi nei panni di uno come me. Che è cresciuto
leggendo Topolino... Però, se ci pensate bene, anche Topolino, a modo suo, è un
classico. Con la sua complessità, il suo spessore psicologico, le sue
contraddizioni… Prendete Nonna Papera, che animale è? ... chi ha detto una
nonna? Non fate gli spiritosi anche voi, è una papera. Ma è una papera che dà da
mangiare alle galline. Tiene le mucche nella stalla... Mentre invece Clarabella,
che anche lei è una mucca, non sta nella stalla, sta in una casa con il divano e
le tendine. E soprattutto sta con Orazio, che è un cavallo. Poi si lamentano che
non hanno figli... Avete presente Orazio, che fa il bipede, l’antropomorfo, però
ha il giogo, il morso, il paraocchi. Il paraocchi va bene perché Clarabella è un
cesso, ma il morso?!? Ah, forse quando di notte arriva Clarabella con i tacchi a
spillo, la guêpiere, la frusta: "Fai il Cavallo! Fai il cavallo!" nelle loro
notti sadomaso… una delle cinquanta sfumature di biada. E Qui Quo Qua. Che
parlano in coro. Si dividono una frase in tre, tipo: "ehi ragazzi attenti che
arriva Paperino/ e/ ci porta tutti a Disneyland", oppure: "ehi ragazzi cosa ne
direste di andare tutti/ a/ pescare del pesce che ce lo mangiamo fritto che ci
piace tanto..." ecco, già da queste frasi, pur banali se volete, si può evincere
come a Quo toccassero sempre le preposizioni semplici, le congiunzioni, a volte
solo la virgola: "ehi ragazzi attenti che andando in mezzo al bosco/, /
rischiamo di trovare le vipere col veleno che ci fanno del male" inoltre Quo ha
sempre avuto un problema di ubicazione, di orientamento... non ha mai saputo
dove fosse. Tu chiedi a Qui: "dove sei?" "sono qui!" ... Chiedi a Qua "dove
sei?", e lui: "sono qua!" tu prova a chiederlo a Quo. Cosa ti dice? "sono Quo?"
Cosa vuol dire? Insomma Quo è sempre stato il più sfigato dei tre, il più
insulso: non riusciva né a iniziare né a finire una frase, non era né qui, né
qua... Mario Monti. Mari o Monti? Città o campagna? Carne o Pesce? Lo so. So che
siamo in piena par condicio e non si può parlare di politica. Ma sento alcuni di
voi delusi dirsi: ma come, fra sette giorni ci sono le elezioni. E questo qui ci
parla di mucche e galline... Altri che invece penseranno: basta politica! Io non
voglio nascondermi dietro a un dito, anche perché non ne ho nessuno abbastanza
grosso… decidete voi, volendo posso andare avanti per altri venti minuti a
parlare di fumetti, oppure posso dirvi cosa penso io della situazione politica…
Ve lo dico? Io penso che finché ci sono LORO, non riusciremo mai a cambiare
questo paese. Dicono una cosa e ne fanno un'altra. Non mantengono le promesse.
Sono incompetenti, bugiardi, inaffidabili. Credono di avere tutti diritti e
nessun dovere. Danno sempre la colpa agli altri… A CASA! Tutti a casa!!! (A
parte che quando dici tutti a casa devi stare attento, specificare: a casa di
chi? No perché non vorrei che venissero tutti a casa mia) Vedo facce
spaventate... soprattutto nelle prime file... Lo so, non devo parlare dei
politici, ho firmato fior di contratti, ci sono le penali... Ma chi ha detto che
parlo dei politici? Cosa ve l'ha fatto pensare? Ah, quando ho detto
incompetenti, bugiardi, inaffidabili? Ma siete davvero maliziosi... No, non
parlavo dei politici. Anche perché, scusate, i politici sono in tutto poche
centinaia di persone... cosa volete che cambi, anche se davvero se ne tornassero
tutti a casa (casa loro, ribadisco)? Poco. No, quando dicevo che devono andare
tutti a casa, io non stavo parlando degli eletti. Io stavo parlando degli
elettori... stavo parlando di NOI. Degli italiani. Perché, a fare bene i conti,
la storia ci inchioda: siamo noi i mandanti. Siamo noi che li abbiamo votati. E
se li guardate bene, i politici, ma proprio bene bene bene... è davvero
impressionante come ci assomigliano: I politici italiani… sono Italiani!
Precisi, sputati. Magari, ecco, con qualche accentuazione caricaturale. Come le
maschere della commedia dell'arte, che sono un po' esagerate, rispetto al
modello originale. Ma che ricalcano perfettamente il popolo che rappresentano.
C'è l'imbroglione affarista, tradito dalla sua ingordigia “Aò, e nnamose a
magnà!... A robbin, ‘ndo stai?”; C'è il servitore di due padroni: "orbo da
n'orecia, sordo de n'ocio"… qualche volta anche di tre. Certi cambiano casacca
con la velocità dei razzi… C'è il riccone arrogante...”Guadagno spendo pago
pretendo” C'è la pulzella che cerca di maritarsi a tutti i costi con il riccone,
convinta di avere avuto un'idea originale e che ci rimane male quando scopre che
sono almeno un centinaio le ragazze che hanno avuto la sua stessa identica
idea... C'è il professore dell'università che sa tutto lui e lo spiega agli
altri col suo latino/inglese perfetto: "tananai mingheina buscaret!" Cos’ha
detto? “Choosy firewall spending review” Ah, ecco, ora finalmente ho capito… C'è
quello iracondo, manesco, pronto a menar le mani ad ogni dibattito... “culattoni
raccomandati” Insomma, c'è tutto il campionario di quello che NOI siamo, a
partire dai nostri difetti, tipo l'INCOERENZA. Come quelli che vanno al family
day... ma ci vanno con le loro due famiglie... per forza poi che c'è un sacco di
gente.... E se solo li guardi un po' esterrefatto, ti dicono: "Perché mi guardi
così? Io sono cattolico, ma a modo mio”. A modo tuo? Guarda, forse non te
l'hanno spiegato, ma non si può essere cattolico a modo proprio... Se sei
cattolico non basta che Gesù ti sia simpatico, capisci? Non è un tuo amico,
Gesù. Se sei cattolico devi credere che Gesù sia il figlio di Dio incarnato
nella vergine Maria. Se sei cattolico devi andare in chiesa tutte le domeniche,
confessare tutti i tuoi peccati, fare la penitenza. Devi fare anche le novene,
digiunare al venerdì... ti abbuono giusto il cilicio e le ginocchia sui ceci.
Divorziare: VIETATISSIMO! Hai sposato un farabutto, o una stronza? Capita.
Pazienza. Peggio per te. Se divorzi sono casini… E il discorso sulla coerenza
non vale solo per i cattolici... Sei fascista? Devi invadere l’Abissinia!
Condire tutto con l'olio di ricino, girare con il fez in testa, non devi mai
passare da via Matteotti, anche solo per pudore! Devi dire che Mussolini, a
parte le leggi razziali, ha fatto anche delle cose buone! Sei comunista? Prima
di tutto devi mangiare i bambini, altro che slow food. Poi devi andare a Berlino
a tirare su di nuovo il Muro, mattone su mattone! Uguale a prima! Devi guardare
solo film della Corea… del nord ovviamente. Devi vestirti con la casacca grigia,
tutti uguali come Mao! …mica puoi essere comunista e poi andare a comprarti la
felpa da Abercrumbie Sei moderato? Devi esserlo fino in fondo! Né grasso né
magro, né alto né basso, né buono né cattivo... Né…Da quando ti alzi la mattina
a quando vai a letto la sera devi essere una mediocrissima, inutilissima,
noiosissima via di mezzo! Questo per quanto riguarda la coerenza. Ma vogliamo
parlare dell'ONESTÀ? Ho visto negozianti che si lamentano del governo ladro e
non rilasciano mai lo scontrino, Ho visto fabbriche di scontrini fiscali non
fare gli scontrini dicendo che hanno finito la carta, Ho visto ciechi che
accompagnano al lavoro la moglie in macchina, Ho visto sordi che protestano coi
vicini per la musica troppo alta, Ho visto persone che si lamentano
dell’immigrazione e affittano in nero ai gialli… e a volte anche in giallo ai
neri!, Ho visto quelli che danno la colpa allo stato. Sempre: se cade un
meteorite, se perdono al superenalotto, se la moglie li tradisce, se un piccione
gli caga in testa, se scivolano in casa dopo aver messo la cera: cosa fa lo
stato? Eh? Cosa fa?... Cosa c’entra lo stato. Metti meno cera, idiota! Lo sapete
che nell'inchiesta sulla 'ndrangheta in Lombardia è venuto fuori che c'erano
elettori, centinaia di elettori, che vendevano il proprio voto per cinquanta
euro? Vendere il voto, in democrazia, è come vendere l'anima. E l'anima si vende
a prezzo carissimo, avete presente Faust? Va beh che era tedesco, e i tedeschi
la mettono giù sempre durissima, ma lui l'anima l'ha venduta in cambio
dell'IMMORTALITA'! Capito? Non cinquanta euro. Se il diavolo gli offriva
cinquanta euro, Faust gli cagava in testa. La verità è che ci sono troppi
impresentabili, tra gli elettori. Mica poche decine, come tra i candidati… è
vero, sembrano molti di più, ma perché sono sempre in televisione a sparar
cazzate, la televisione per loro è come il bar per noi... "Ragazzi, offro un
altro giro di spritz" "E io offro un milione di posti di lavoro" e giù a ridere.
"E io rimborso l'imu!” “e io abolisco l'ici!" “Guarda che non c'è più da un
pezzo l'ici" "Allora abolisco l'iva... E anche l'Emy, Evy e Ely!" "E chi sono?
"Le nipotine di Paperina! "Ma va là, beviti un altro grappino e tasi mona!..."
Vedi, saranno anche impresentabili ma per lo meno li conosci, nome e cognome, e
puoi anche prenderli in giro. Invece gli elettori sono protetti dall’anonimato…
alle urne vanno milioni di elettori impresentabili, e nessuno sa chi sono!
Sapete quale potrebbe essere l’unica soluzione possibile? Sostituire
l'elettorato italiano. Al completo. Pensate, per esempio, se incaricassimo di
votare al nostro posto l'elettorato danese, o quello norvegese. Lo prendiamo a
noleggio. Meglio, lo ospitiamo alla pari... Au pair. Carlo, ma chi è quel
signore biondo che dorme a casa tua da due giorni? “Oh, è il mio elettore
norvegese alla pari, domenica vota e poi riparte subito... C'è anche la
moglie”... E per chi votano, scusa? "Mi ha detto che è indeciso tra Aspelünd
Gründblomma e Pysslygar". Ma quelli sono i nomi dell'Ikea!, che tra l’altro è
svedese… "Ma no, si assomigliano… però ora che mi ci fai pensare, effettivamente
ho visto nel suo depliant elettorale che i simboli dei loro partiti sono un
armadio, una lampada, un comodino. Mah. E tu poi, in cambio cosa fai, vai a
votare per le loro elezioni? In Norvegia? "Ah, questo non lo so. Non so se mi
vogliono. Mi hanno detto che prima devo fare un corso. Imparare a non
parcheggiare in doppia fila. A non telefonare parlando ad alta voce in treno. A
pagare le tasse fino all'ultimo centesimo. Poi, forse, mi fanno votare." Si, va
beh, qualche difficoltà logistica la vedo: organizzare tutti quei pullman,
trovare da dormire per tutti... Ma pensate che liberazione, la sera dei
risultati, scoprire che il nostro nuovo premier è un signore o una signora
dall'aria normalissima, che dice cose normalissime, e che va in televisione al
massimo un paio di volte all'anno.
(Lancio di batteria e poi, sull’aria de “L’italiano”)
Lasciatemi votare
con un salmone in mano
vi salverò il paese
io sono un
norvegese…
IL NORD
EVADE PIU’ DEL SUD.
Economia
Sommersa: Il Nord onesto e diligente evade più del Sud, scrive
Emanuela Mastrocinque su “Vesuviolive”. Sono queste le notizie che non
dovrebbero mai sfuggire all’attenzione di un buon cittadino del Sud. Per anni ci
hanno raccontato una storia che, a furia di leggerla e studiarla, è finita con
il diventare la nostra storia, l’unica che abbiamo conosciuto. Storia di miseria
e povertà superata dai meridionali grazie all’illegalità o all’emigrazione, le
due uniche alternative rimaste a “quel popolo di straccioni” (come ci definì
quella “simpatica” giornalista in un articolo pubblicato su “Il Tempo” qualche
anno fa) . Eppure negli ultimi anni il revisionismo del risorgimento ci sta
aiutando a comprendere quanto lo stereotipo e il pregiudizio sia stato utile e
funzionale ai vincitori di quella sanguinosa guerra da cui è nata l‘Italia.
Serviva (e serve tutt‘ora) spaccare l’Italia. Da che mondo e mondo le società
hanno avuto bisogno di creare l’antagonista da assurgere a cattivo esempio, così
noi siamo diventati fratellastri, figli di un sentimento settentrionale razzista
e intollerante. Basta però avere l’occhio un po’ più attento per scoprire che
spesso la verità, non è come ce la raccontano. Se vi chiedessimo adesso, ad
esempio, in quale zona d’Italia si concentra il tasso più alto di evasione
fiscale, voi che rispondereste? Il Sud ovviamente. E invece non è così. Dopo
aver letto un post pubblicato sulla pagina Briganti in cui veniva
riassunta perfettamente l’entità del “sommerso economico in Italia derivante
sia da attività legali che presentano profili di irregolarità, come ad esempio
l’evasione fiscale, che dal riciclaggio di denaro sporco proveniente da attività
illecite e mafiose” abbiamo scoperto che in Italia la maggior parte degli
evasori non è al Sud. Secondo i numeri pubblicati (visibili nell‘immagine
sotto), al Nord il grado di evasione si attesta al 14, 5%, al centro al 17,4%
mentre al Sud solo al 7,9%. I dati emersi dal Rapporto Finale del Gruppo
sulla Riforma Fiscale, sono stati diffusi anche dalla Banca d’Italia. Nel
lavoro di Ardizzi, Petraglia, Piacenza e Turati “L’economia
sommersa fra evasione e crimine: una rivisitazione del Currency Demand Approach
con una applicazione al contesto italiano” si legge “dalle stime a
livello territoriale si nota una netta differenza tra il centro-nord e il sud,
sia per quanto attiene al sommerso di natura fiscale che quello di natura
criminale. Per quanto riguarda infine l’evidenza disaggregata per aree
territoriali, è emerso che le province del Centro-Nord, in media, esibiscono
un’incidenza maggiore sia del sommerso da evasione sia di quello associato ad
attività illegali rispetto alle province del Sud, un risultato che pare
contraddire l’opinione diffusa secondo cui il Mezzogiorno sarebbe il principale
responsabile della formazione della nostra shadow economy. Viene meno, di
conseguenza, la rappresentazione del Sud Italia come territorio dove si
concentrerebbe il maggiore tasso di economia sommersa". E ora, come la
mettiamo?
Si evade il
fisco più al Nord che al Sud. E’ uno dei dati che emerge dal rapporto sulla
lotta all’evasione redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Secondo
Padoan, la somma totale delle principali imposte evase (Iva, Ires, Irpef e Irap)
ammonta a 91 miliardi. Il 52% di questa cifra si attesta dunque nel
Settentrione, contro i 24 miliardi del centro (26% del totale) e i 19,8 miliardi
del Meridione (22%). Il dato è influenzato dal maggior reddito nazionale del
Nord. Soprattutto, scrivono i tecnici del Tesoro, la rabbrividire la percentuale
di verifiche sulle imprese che trova irregolarità fiscali: è 98,1% tra le
grandi, al 98,5% sulle medie e al 96,9% sulle Pmi. Il record tocca agli enti non
commerciali, il 99,2% non è in regola. 100% di `positività´ i controlli sugli
atti soggetti a registrazione. Ad ogni modo, l’evasione effettiva ‘pizzicata’
dall’Agenzia delle Entrate nel 2013, ha rilevato il Mef, ammonta a 24,5
miliardi. La maggiore imposta accertata è così salita dell’87% in sette anni,
rispetto ai 13,1 miliardi del 2006. Un numero in calo rispetto agli anni
2009-2012 e soprattutto rispetto al picco di 30,4 miliardi del 2011.
Ma quale
Sud, è il Nord che ha la palma dell’evasione,
scrive Vittorio Daniele su “Il Garantista”. Al Sud si evade di più che al Nord.
Questo è quanto comunemente si pensa. Non è così, invece, secondo i dati della
Guardia di Finanza, analizzati da Paolo di Caro e Giuseppe Nicotra,
dell’Università di Catania, in uno studio di cui si è occupata anche la stampa
(Corriere Economia, del 13 ottobre). I risultati degli accertamenti effettuati
dalla Guardia di Finanza mostrano come, nelle regioni meridionali, la quota di
reddito evaso, rispetto a quello dichiarato, sia inferiore che al Nord. E ciò
nonostante il numero di contribuenti meridionali controllati sia stato, in
proporzione, maggiore. Alcuni esempi. In Lombardia, su oltre 7 milioni di
contribuenti sono state effettuate 14.313 verifiche che hanno consentito di
accertare un reddito evaso pari al 10% di quello dichiarato. In Calabria, 4.480
controlli, su circa 1.245.000 contribuenti, hanno consentito di scoprire un
reddito evaso pari al 3,5% di quello dichiarato. Si badi bene, in percentuale,
le verifiche in Calabria sono state quasi il doppio di quelle della Lombardia. E
ancora, in Veneto il reddito evaso è stato del 5,3%, in Campania del 4,4% in
Puglia, del 3,7% in Sicilia del 2,9%. Tassi di evasione più alti di quelle delle
regioni meridionali si riscontrano anche in Emilia e Toscana. Alcune
considerazioni. La prima riguarda il fatto che nelle regioni del Nord, dove più
alta è la quota di evasione, e dove maggiore è il numero di contribuenti e
imprese, si siano fatti, in proporzione, assai meno accertamenti che nel
meridione. Poiché, in Italia, le tasse le paga chi è controllato, mentre chi non
lo è, se può, tende a schivarle, sarebbe necessario intensificare i controlli là
dove la probabilità di evadere è maggiore. E questa probabilità, secondo i dati
della Guardia di Finanza, è maggiore nelle regioni più ricche. La seconda
considerazione è che il luogo comune di un’Italia divisa in due, con un Nord
virtuoso e un Sud di evasori, non corrisponde al vero. L’Italia è un paese unito
dall’evasione fiscale. Il fatto che in alcune regioni del Nord si sia evaso di
più che al Sud non ha nulla a che vedere né con l’etica, né con l’antropologia.
Dipende, più realisticamente, da ragioni economiche. L’evasione difficilmente
può riguardare i salari, più facilmente i profitti e i redditi d’impresa. E dove
è più sviluppata l’attività d’impresa? Come scrivevano gli economisti Franca
Moro e Federico Pica, in un saggio pubblicato qualche anno fa della Svimez: «Al
Sud ci sono tanti evasori per piccoli importi. Al Nord c’è un’evasione più
organizzata e per somme gigantesche». Quando si parla del Sud, pregiudizi e
stereotipi abbondano. Si pensa, così, che la propensione a evadere, a violare le
norme, se non a delinquere, sia, per così dire, un tratto antropologico
caratteristico dei meridionali. Ma quando si guardano i dati, e si osserva la
realtà senza la lente deformante del pregiudizio, luoghi comuni e stereotipi
quasi mai reggono. Di fronte agli stereotipi e alle accuse – e quella di essere
evasori non è certo la più infamante – che da decenni, ogni giorno e da più
parti, si rovesciano contro i meridionali, non sarebbe certo troppo se si
cominciasse a pretendere una rappresentazione veritiera della realtà. Insieme a
pretendere, naturalmente, e in maniera assai più forte di quanto non si sia
fatto finora, che chi, al Sud, ha responsabilità e compiti di governo, faccia
davvero, e fino in fondo, il proprio dovere.
Quante
bugie ci hanno raccontato sul Mezzogiorno!
Scrive Pino Aprile su “Il Garantista”. L’Italia è il paese più ingiusto e
disuguale dell’Occidente, insieme a Stati Uniti e Gran Bretagna: ha una delle
maggiori e più durature differenze del pianeta (per strade, treni, scuole,
investimenti, reddito…) fra due aree dello stesso paese: il Nord e il Sud;
tutela chi ha già un lavoro o una pensione, non i disoccupati e i giovani; offre
un reddito a chi ha già un lavoro e lo perde, non anche a chi non riesce a
trovarlo; è fra i primi al mondo, per la maggiore distanza fra lo stipendio più
alto e il più basso (alla Fiat si arriva a più di 400 volte); ha i manager di
stato più pagati della Terra, i vecchi più garantiti e i giovani più precari; e
se giovani e donne, pagate ancora meno. È in corso un colossale rastrellamento
di risorse da parte di chi ha più, ai danni di chi ha meno: «una redistribuzione
dal basso verso l’alto». È uscito in questi giorni nelle librerie il nuovo libro
di Pino Aprile («Terroni ’ndernescional», edizioni PIEMME, pagine 251, euro
16,50). Pubblichiamo un brano, per gentile concessione dell’autore. Quante volte
avete letto che la prova dell’ estremo ritardo dell’Italia meridionale rispetto
al Nord era l’alta percentuale di analfabeti? L’idea che questo possa dare ad
altri un diritto di conquista e annessione può suonare irritante. Ma una qualche
giustificazione, nella storia, si può trovare, perché i popoli con l’alfabeto
hanno sottomesso quelli senza; e í popoli che oltre all’alfabeto avevano anche
”il libro” (la Bibbia, il Vangelo, il Corano, Il Capitale, il Ko Gi Ki…) hanno
quasi sempre dominato quelli con alfabeto ma senza libro. Se questo va preso
alla… lettera, la regione italiana che chiunque avrebbe potuto legittimamente
invadere era la Sardegna, dove l’analfabetismo era il più alto nell’Italia di
allora: 89,7 per cento (91,2 secondo altre fonti); quasi inalterato dal giorno
della Grande Fusione con gli stati sabaudi: 93,7. Ma la Sardegna era governata
da Torino, non da Napoli. Le cose migliorarono un po’, 40 anni dopo l’Unità, a
prezzi pesanti, perché si voleva alfabetizzare, ma a spese dei Comuni. Come
dire: noi vi diamo l’istruzione obbligatoria, però ve la pagate da soli (più o
meno come adesso…). Ci furono Comuni che dovettero rinunciare a tutto, strade,
assistenza, per investire solo nella nascita della scuola elementare: sino
all’87 per cento del bilancio, come a Ossi (un secolo dopo l’Unità, il Diario di
una maestrina, citato in Sardegna , dell’Einaudi, riferisce di «un evento
inimmaginabile »: la prima doccia delle scolare, grazie al dono di dieci
saponette da parte della Croce Rossa svizzera). Mentre dal Mezzogiorno non
emigrava nessuno, prima dell’Unità; ed era tanto primitivo il Sud, che partoriva
ed esportava in tutto il mondo facoltà universitarie tuttora studiatissime:
dalla moderna storiografia all’economia politica, e vulcanologia, sismologia,
archeologia… Produzione sorprendente per una popolazione quasi totalmente
analfabeta, no? Che strano. Solo alcune osservazioni su quel discutibile
censimento del 1861 che avrebbe certificato al Sud indici così alti di
analfabetismo: «Nessuno ha mai analizzato la parzialità (i dati sono quelli
relativi solo ad alcune regioni) e la reale attendibilità di quel censimento
realizzato in pieno caos amministrativo, nel passaggio da un regno all’altro e
in piena guerra civile appena scoppiata in tutto il Sud: poco credibile, nel
complesso, l’idea che qualche impiegato potesse andare in giro per tutto il Sud
bussando alle porte per chiedere se gli abitanti sapevano leggere e scrivere»
rileva il professor Gennaro De Crescenzo in Il Sud: dalla Borbonia Felix al
carcere di Penestrelle. Come facevano a spuntare oltre 10.000 studenti
universitari contro i poco più di 5.000 del resto d’Italia, da un tale oceano di
ignoranza? Né si può dire che fossero tutti benestanti, dal momento che nel
Regno delle Due Sicílie i meritevoli non abbienti potevano studiare grazie a
sussidi che furono immediatamente aboliti dai piemontesi, al loro arrivo.
Sull’argomento potrebbero gettare più veritiera luce nuove ricerche: «Documenti
al centro di studi ancora in corso presso gli archivi locali del Sud dimostrano
che nelle Due Sicilie c’erano almeno una scuola pubblica maschile e una scuola
pubblica femminile per ogni Comune oltre a una quantità enorme di scuole private»
si legge ancora nel libro di De Crescenzo, che ha studiato storia risorgimentale
con Alfonso Scirocco ed è specializzato in archivistica. «Oltre 5.000, infatti,
le ”scuole” su un totale di 1.845 Comuni e con picchi spesso elevati e
significativi: 51 i Comuni in Terra di Bari, 351 le scuole nel complesso; 174 i
Comuni di Terra di lavoro, 664 le scuole; 113 i Comuni di Principato Ultra, 325
le scuole; 102 i Comuni di Calabria Citra, 250 le scuole…». Si vuol discutere
della qualità di queste scuole? Certo, di queste e di quella di tutte le altre;
ma «come si conciliano questi dati con quei dati così alti dell’analfabetismo?
». E mentiva il conte e ufficiale piemontese Alessandro Bianco di Saint-Jorioz,
che scese a Sud pieno di pregiudizi, e non li nascondeva, e poi scrisse quel che
vi aveva trovato davvero e lo scempio che ne fu fatto (guadagnandosi
l’ostracismo sabaudo): per esempio, che «la pubblica istruzione era sino al
1859 gratuita; cattedre letterarie e scientifiche in tutte le città principali
di ogni provincia»? Di sicuro, appena giunti a Napoli, i Savoia chiusero
decine di istituti superiori, riferisce Carlo Alianello in La conquista del Sud.
E le leggi del nuovo stato unitario, dal 1876, per combattere l’analfabetismo e
finanziare scuole, furono concepite in modo da favorire il Nord ed escludere o
quasi il Sud. I soliti trucchetti: per esempio, si privilegiavano i Comuni con
meno di mille abitanti. Un aiuto ai più poveri, no? No. A quest’imbroglio si è
ricorsi anche ai nostri tempi, per le norme sul federalismo fiscale regionale.
Basti un dato: i Comuni con meno di 500 abitanti sono 600 in Piemonte e 6 in
Puglia. Capito mi hai? «Mi ero sempre chiesto come mai il mio trisavolo fosse
laureato,» racconta Raffaele Vescera, fertile scrittore di Foggia «il mio
bisnonno diplomato e mio nonno, nato dopo l’Unità, analfabeta». Nessun Sud,
invece, nel 1860, era più Sud dell’isola governata da Torino; e rimase tale
molto a lungo. Nel Regno delle Due Sicilie la ”liberazione” (così la racconta,
da un secolo e mezzo, una storia ufficiale sempre più in difficoltà) portò
all’impoverimento dello stato preunitario che, secondo studi recenti
dell’Università di Bruxelles (in linea con quelli di Banca d’Italia, Consiglio
nazionale delle ricerche e Banca mondiale), era ”la Germania” del tempo, dal
punto di vista economico. La conquista del Sud salvò il Piemonte dalla
bancarotta: lo scrisse il braccio destro di Cavour. Ma la cosa è stata ed è
presentata (con crescente imbarazzo, ormai) come una modernizzazione necessaria,
fraterna, pur se a mano armata. Insomma, ho dovuto farti un po’ di male, ma per
il tuo bene, non sei contento? Per questo serve un continuo confronto fra i dati
”belli” del Nord e quelli ”brutti” del Sud. Senza farsi scrupolo di ricorrere a
dei mezzucci per abbellire gli uni e imbruttire gli altri. E la Sardegna, a
questo punto, diventa un problema: rovina la media. Così, quando si fa il
paragone fra le percentuali di analfabeti del Regno di Sardegna e quelle del
Regno delle Due Sicilie, si prende solo il dato del Piemonte e lo si oppone a
quello del Sud: 54,2 a 87,1. In tabella, poi, leggi, ma a parte: Sardegna, 89,7
per cento. E perché quell’89,7 non viene sommato al 54,2 del Piemonte, il che
porterebbe la percentuale del Regno sardo al 59,3? (Dati dell’Istituto di
Statistica, Istat, citati in 150 anni di statistiche italiane: Nord e Sud
1861-2011, della SVIMEZ, Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno). E si
badi che mentre il dato sulla Sardegna è sicuramente vero (non avendo interesse
il Piemonte a peggiorarlo), non altrettanto si può dire di quello dell’ex Regno
delle Due Sicilie, non solo per le difficoltà che una guerra in corso poneva, ma
perché tutto quel che ci è stato detto di quell’invasione è falsificato: i
Mille? Sì, con l’aggiunta di decine di migliaia di soldati piemontesi
ufficialmente ”disertori”, rientrati nei propri schieramenti a missione
compiuta. I plebisciti per l’annessione? Una pagliacciata che già gli
osservatori stranieri del tempo denunciarono come tale. La partecipazione armata
dell’entusiasta popolo meridionale? E allora che ci faceva con garibaldini e
piemontesi la legione straniera 11 domenica 4 gennaio 2015 ungherese? E chi la
pagava? Devo a un valente archivista, Lorenzo Terzi, la cortesia di poter
anticipare una sua recentissima scoperta sul censimento del 1861, circa gli
analfabeti: i documenti originali sono spariti. Ne ha avuto conferma ufficiale.
Che fine hanno fatto? E quindi, di cosa parliamo? Di citazioni parziali,
replicate. Se è stato fatto con la stessa onestà dei plebisciti e della storia
risorgimentale così come ce l’hanno spacciata, be’…Nei dibattiti sul tema, chi
usa tali dati come prova dell’arretratezza del Sud, dinanzi alla contestazione
sull’attendibilità di quelle percentuali, cita gli altri, meno discutibili, del
censimento del 1871, quando non c’era più la guerra, eccetera. Già e manco gli
originali del censimento del ’71 ci sono più. Spariti pure quelli! Incredibile
come riesca a essere selettiva la distrazione! E a questo punto è legittimo
chiedersi: perché il meglio e il peggio del Regno dí Sardegna vengono separati e
non si offre una media unica, come per gli altri stati preunitari? Con i numeri,
tutto sembra così obiettivo: sono numeri, non opinioni. Eppure, a guardarli
meglio, svelano non solo opinioni, ma pregiudizi e persino razzismo. Di fatto,
accadono due cose, nel modo di presentarli: 1) i dati ”belli” del Nord restano
del Nord; quelli ”brutti”, se del Nord, diventano del Sud. Il Regno sardo era
Piemonte, Liguria, Val d’Aosta e Sardegna. Ma la Sardegna nelle statistiche
viene staccata, messa a parte. Giorgio Bocca, «razzista e antimeridionale »,
parole sue, a riprova dell’arretratezza del Sud, citava il 90 per cento di
analfabeti dell’isola, paragonandolo al 54 del Piemonte. Ma nemmeno essere di
Cuneo e antimerìdionale autorizza a spostare pezzi di storia e di geografia: la
Sardegna era Regno sabaudo, i responsabili del suo disastro culturale stavano a
Torino, non a Napoli;
2)
l’esclusione mostra, ce ne fosse ancora bisogno, che i Savoia non considerarono
mai l’isola alla pari con il resto del loro paese, ma una colonia da cui
attingere e a cui non dare; una terra altra («Gli stati» riassume il professor
Pasquale Amato, in Il Risorgimento oltre i miti e i revisionismi «erano
proprietà delle famiglie regnanti e potevano essere venduti, scambiati, regalati
secondo valutazioni autonome di proprietari». Come fecero i Savoia con la
Sicilia, la stessa Savoia, Nizza… Il principio fu riconfermato con la
Restaurazione dell’Ancièn Regime, nel 1815, in Europa, per volontà del
cancelliere austriaco Klemens von Metternich). E appena fu possibile, con
l’Unità, la Sardegna venne allontanata quale corpo estraneo, come non avesse mai
fatto parte del Regno sabaudo. Lo dico in altro modo: quando un’azienda è da
chiudere, ma si vuol cercare di salvare il salvabile (con Alitalia, per dire,
l’han fatto due volte), la si divide in due società; in una, la ”Bad Company”,
si mettono tutti i debiti, il personale in esubero, le macchine rotte…
Nell’altra, tutto il buono, che può ancora fruttare o rendere appetibile
l’impresa a nuovi investitori: la si chiama ”New Company”.
L’Italia è
stata fatta così: al Sud invaso e saccheggiato hanno sottratto fabbriche, oro,
banche, poi gli hanno aggiunto la Sardegna, già ”meridionalizzata”. Nelle
statistiche ufficiali, sin dal 1861, i dati della Sardegna li trovate disgiunti
da quelli del Piemonte e accorpati a quelli della Sicilia, alla voce ”isole”, o
sommati a quelli delle regioni del Sud, alla voce ”Mezzogiorno” (la Bad Company;
mentre la New Company la trovate alla voce ”Centro-Nord”). Poi si chiama
qualcuno a spiegare che la Bad Company è ”rimasta indietro”, per colpa sua (e di
chi se no?). Ripeto: la psicologia spiega che la colpa non può essere distrutta,
solo spostata. Quindi, il percorso segue leggi di potenza: dal più forte al più
debole; dall’oppressore alla vittima. Chi ha generato il male lo allontana da sé
e lo identifica con chi lo ha subito; rimproverandogli di esistere. È quel che
si è fatto pure con la Germania Est e si vuol fare con il Mediterraneo.
IGNORANTI IN PARLAMENTO.
"Troppi ignoranti siedono in Parlamento".
La denuncia della scienziata Elena Cattaneo. Vaccini, Ogm, Stamina. Non è
l'Italia ad essere oscurantista, ma la politica a dar retta alle spinte meno
serie della gente. E i media non aiutano, scrive Daniela Minerva su
“L’Espresso”. Elena Cattaneo La rivista "Nature" l'ha salutata con un “Brava
Elena”, attribuendole, giustamente, la vittoria nell'affaire Stamina. Ma
Elena Cattaneo è molto di più. Scienziata dell'Università di Milano, seduta
su una pila di riconoscimenti internazionali, è stata nominata da Giorgio
Napolitano senatore a vita. Ed è convinta che educare la politica alla scienza
sia la mossa vincente. Ma non solo.
Caso Stamina, sperimentazione animale. Ma non solo. Spesso gli
orientamenti degli italiani vanno contro i risultati della scienza. Perché
secondo lei?
«Benchè gli italiani, come tutti, siano
immersi ed indissolubilmente legati a quanto conseguito dalla scienza, succede
che venga vissuta, paradossalmente, come poco accessibile e poco vicina al
sentire dei cittadini. Per un verso gli scienziati dovrebbero fare di più per
spiegare non tanto i risultati ma la fatica, il coraggio, i fallimenti e
raccontare come le conquiste scientifiche sono di tutti e per tutti. Anche i
media hanno la responsabilità di fare da cinghia di trasmissione dei fatti.
Spesso, invece, tra semplificazione del messaggio e ricerca del clamore si
tradisce il significato ed il portato della "nuova conoscenza". Spesso
scienziati e media comunicano il “risultato”, il “prodotto” trascurando il
processo, il percorso che ha condotto a quel risultato. Così i cittadini sono
privati della consapevolezza necessaria per comprendere che una cura, ad
esempio, non è “un coniglio che esce dal cilindro”. Nello stesso tempo li si
priva anche della grande opportunità formativa e costruttiva che il metodo
scientifico porta con sé per chiunque vi si accosti. Così gli italiani non
percepiscono “veramente” cosa significhi fare scienza e quale straordinario
strumento sia per appurare la realtà, ogni giorno, al meglio della nostra
possibilità. Se ne parla poco sui media. Pochissimo in TV. Si predilige una
comunicazione fatta di "narrazioni umorali" anche quando si trattano temi che
obbligherebbero ad ancorarsi ai fatti, a ciò che è stato verificato. Quindi, se
è ovvio che la scienza non possa che dire come stanno le cose, anche quando è
doloroso, i ciarlatani, al contrario, promettono miracoli (che ogni volta si
dissolvono nel nulla). Questo rende la scienza debole, a prima vista, agli occhi
di un pubblico che ha una dieta mediatica composta essenzialmente di grandi
miracoli o grandi catastrofi. Invece, i Paesi in cui i cittadini sanno cosa sia
la scienza hanno grandi vantaggi, prima di tutto il prezioso strumento di
comprendere che il metodo scientifico, nelle condizione date, è l’unico
strumento che consente di appurare al meglio i fatti dell'oggi, coltivando
fiducia nel domani».
I dati dell'Annuario Scienza Tecnologia e Società indicano che,
in maggioranza variabile a seconda dei temi, gli italiani sono sempre meno
ignoranti scientificamente. Che hanno in grande considerazione il lavoro degli
scienziati. Che accettano in maniera strumentale i benefici delle scienze,
soprattutto biomediche. E che sono favorevoli a molte delle innovazioni
scientifiche osteggiate invece dalla politica. (ricerca biotech, fecondazione
assistita ad esempio). E i sociologi della scienza affermano che spesso la
percezione che i politici hanno dei desideri dei cittadini in materie
scientifiche non corrisponda affatto alla realtà di questi desideri. Non è che i
politici sono più antiscientifici degli italiani? Cosa ne pensa?
«La categoria del politico in astratto
rispetto al cittadino è una pericolosa semplificazione. Il tema sotteso alla
domanda è quanto il personale politico del Paese sia in grado di rappresentare
il sentire e il volere dei cittadini in generale. Restando alla scienza, sulla
base dei dati a cui si riferisce, si può osservare come, forse, i cittadini che
si confrontano quotidianamente con le difficoltà e la speranza della vita
abbiano sempre di più il polso di quanto un’innovazione scientifica possa
incidere sul loro benessere e sulla libertà più di quanto, i loro politici,
riescano a immaginare che siano in grado di fare. Politici che, inoltre,
rispondono spesso a logiche di appartenenza che - paradossalmente - potrebbero
allontanarli dal sentire comune e dal comprenderlo e guidarlo in modo più
razionale, basato sulla conoscenza dei fatti. Sulla "antiscientificità dei
politici", da quando frequento le aule parlamentari, posso però testimoniare
come la situazione sia molto eterogenea. Così come vi sono alcuni con profonde
competenze in ambito umanistico e aperti ed interessati anche a capire altre
discipline, vi sono pure parlamentari che su temi scientifici sarebbero pronti a
approvare qualunque legge sulla scorta del sentito dire e senza alcun
indispensabile approfondimento tecnico. Ci sono un bel po’ di esempi: non hanno
alcuna idea di cosa sia in concreto la sperimentazione animale, ma chiedono che
sia abolita; non hanno idea di come si arrivi a identificare un trattamento per
una malattia umana e ti dicono che puoi arrivarci comunque con un computer o un
piattino di cellule. Magari sono anche gli stessi che non capiscono la
differenza tra i ciarlatani e la medicina. Ci sono persino parlamentari che,
ribaltando la realtà delle cose, cercano di far passare lo scienziato come
“persona con pregiudizi”, ad esempio semplicemente perché si avvale delle prove
della scienza per argomentare a sostegno dell’innocuità di specifici Ogm. Alcuni
politici, sempre restando a questo esempio, li definiscono “pericolosi per la
salute umana” e poi accettano che vengano importati a tonnellate per nutrire le
nostre filiere alimentari. Sono posizioni incoerenti oltre che non documentate.
Sta al cittadino, in definitiva, non solo percepire quanto gli sia utile la
scienza, ma orientarsi verso rappresentanti, diciamo così, in grado di
comprendere e includere le conquiste fatte per tutti nelle scelte per il Paese».
Sempre, di fronte a fatti come quello di Stamina o a questioni
come Ogm o vaccini le posizioni si polarizzano: da una parte la comunità
scientifica che afferma le sue conclusioni in maniera apodittica, senza
esplicitare quelli che sono i limiti della conoscenza scientifica. Dall'altra
una parte dell'opinione pubblica che nel formarsi il giudizio fa prevalere un
atteggiamento politico o etico. Sembrano entrambe posizioni fideistiche.
Insomma, l'impressione è che nessuna delle parti abbia un atteggiamento “laico”
che metta in campo i pro e i contro. Cosa ne pensa?
«Non so se la comunità scientifica non
espliciti i limiti della conoscenza scientifica, mi pare piuttosto che, a volte,
rinunci ad adeguare il suo linguaggio alle modalità della divulgazione. Talvolta
in Italia, a differenza dei paesi di cultura anglosassone, c’è una ritrosia di
una parte della comunità scientifica circa l’opportunità di impegnarsi, al pari
dell’attività accademica, nel portare la scienza al pubblico. Parallelamente c’è
un apparato mediatico che, non di rado per incapacità o disinteresse o
tornaconto, trova ben più comodo dello studio e della preparazione che
servirebbe per proporre un ragionamento degno di questo nome, rifugiarsi in
schemi di narrazione ideologici che in questo paese sembrano buoni per ogni
occasione. Molto spesso il giudizio distorto del pubblico, il prevalere di
atteggiamenti incomprensibilmente irrazionali, dipende dalla sciatteria di ciò
che si comunica o dalla sua parzialità, che è anche peggio».
È indubbio che la comunità scientifica in Italia sia meno capace
di influenzare il dibattito pubblico di quanto non lo sia in altri paesi.
Perché?
«Quel che forse fa più male è quando lo
scienziato addirittura si autolimita perché teme che la sua esposizione pubblica
possa nuocere alla carriera, ai finanziamenti o semplicemente alienare simpatie
politiche. Talvolta qualcuno nella comunità scientifica è troppo silente, poco
coraggioso. Oppure si chiude in se stesso forse perché da sempre non
considerato, e questo ha peggiorato le cose. Bisogna anche dire che nel paese
manca un’educazione, anche politica, che ritenga necessario, come avviene in
tante democrazie avanzate, l’ascoltare con serietà massima i dati empirici dei
fenomeni, prima di adottare le scelte di politiche pubbliche decisive per la
società. Questo punto richiama le responsabilità della classe politica, che
troppo spesso ha mostrato di seguire furbescamente il richiamo “della pancia
delle piazze” piuttosto che onorare con senso di responsabilità il proprio
compito, primo fra tutto quello di volere (e far) conoscere prima di deliberare.
Invece, spesso, si sono trattate le raccomandazioni della scienza, legate ai
fatti, come opinioni alla stregua di tutte le altre opinioni. Questo è un atto
di colpevole irresponsabilità, le cui conseguenze gravano poi sugli stessi
cittadini e sui più deboli tra loro, oltre che sulla credibilità delle
istituzioni del nostro paese. La comunità scientifica dal canto suo ha gli
argomenti per essere utile al paese: tirarsi indietro per poi lamentarsi non è
un atteggiamento che condivido. Così come da parte delle Istituzioni, non è
giustificabile che la scienza la si invochi a tratti, spesso come spauracchio,
senza riconoscerne gli indubbi meriti e competenze».
La fiducia nelle istituzioni nel nostro paese è debole. E le
istituzioni scientifiche sono vittima di questo handicap di contesto. Cosa ne
pensa?
«In realtà le competenze in Italia le
abbiamo. Molteplici sono le eccellenze mondiali, proprio in campo scientifico,
di cui possiamo andare orgogliosi. Nell'immediato è necessario che ciascuno
svolga il proprio lavoro al massimo della propria professionalità, cercando le
evidenze e stando lontani dalle convenienze. Così si recupera fiducia. Ciascuna
Istituzione Scientifica rifletta su quali siano gli aspetti su cui può
migliorare nell'aprirsi alla comunità e senza timori si mostri per quel che
quotidianamente fa per la collettività. Per altro, verso lo Stato, dati empirici
alla mano, serve che vi sia un rinnovato impegno -anche di risorse- nel
rilanciare la formazione e le attività del Paese in materie ad alto tasso di
scientificità, perché ogni ritardo arreca un grave danno alla nostra
competitività. Bisogna preservare almeno la ricerca pubblica di base da
politiche squisitamente depressive, rilanciare un patrimonio di conoscenza che
ancora sopravvive, ma che se non difeso (e in questo campo la stasi è
equiparabile alla regressione) potrebbe definitivamente depauperarsi in pochi
anni, "bruciando" molta più speranza per il futuro di quanto si possa immaginare».
Una legge che vieta le sperimentazioni. Pregiudizi su vaccini e Ogm. Poi i
santoni che tengono banco. Nel paese trionfano ignoranti e retrogradi. Anche per
colpa della politica, scrive Daniela Minerva su “L’Espresso”. Una mostra con
ritratti di donatori di cervello La perfezione del cervello da cui nasce il
pensiero umano? Un reticolo di molecole assemblate a caso dall’evoluzione. La
bellezza di uno sguardo capace di rapire il nostro cuore per sempre? Anche. La
gioia di un recupero repentino che illumina mesi di malattia nostra o di un
nostro caro? Episodico, inessenziale al vero decorso del male. Giorni di pioggia
che ci obbligano a un agosto col maglioncino? Irrilevanti per capire se la Terra
si scalda o no. Potremmo continuare per pagine, a elencare tutte le volte che la
scienza ci sbatte la porta delle nostre emozioni in faccia, in una corsa senza
fine a ridurre le nostre esperienze a “episodi”, e a contraddire quel che ci
sembra ovvio. Eppure non possiamo che fidarci. Dobbiamo far tacere la
personalissima percezione del mondo che nasce dalla realtà della nostra vita. La
scienza è la scienza, un’impresa quasi perfetta capace di generare conoscenze
condivise; autocorreggersi e restituirci la cosa più vicina possibile alla
verità. Sappiamo che i risultati di quest’impresa ci sono utili (farmaci,
energia, iPhone e aeroplani), e fin qui ci possiamo dire tutti scientisti. Ma se
si tratta di accettarne le conclusioni anche quando contraddicono le nostre
credenze e le nostre esperienze, allora cominciano i mal di pancia. E nascono i
movimenti: contro gli Ogm, contro i vaccini, contro la sperimentazione animale;
a favore di Stamina... Attorno a questo bisticcio si gioca la capacità del
nostro paese di entrare nella modernità, di seppellire una volta per tutte Don
Benedetto Croce e la sua sciagurata convinzione che le conoscenze scientifiche
altro non siano che robe astratte capaci solo di «mutilare la vivente realtà del
mondo». Basti pensare a quanto «vivente» sia stata la speranza dei genitori
della piccola Celeste che hanno affidato la loro bambina agli intrugli di quel
Vannoni arrivando persino a illudersi che le facessero bene. Noi lo chiamiamo “
caso Stamina ”, ma per decine di persone è stata una viventissima illusione.
Che, come sempre accade quando un santone buca il video, ha contagiato per mesi
l’opinione pubbica, comprensibilmente eccitata all’idea che si potesse fare
qualcosa per quei bambini, ma del tutto indifferente alla notizia, arrivata nei
giorni scorsi della prima terapia a base di cellule staminali scientificamente
dimostrata e registrata dalle autorità europee, scoperta dagli scienziati
dell’università di Modena. Fiumi di inchiostro e ore di talk show per la
baggianata di Stamina, qualche trafiletto per la scoperta dei modenesi.
Colpevoli, forse, di avere messo sotto i nostri occhi dati solidi e
dimostrazioni inoppugnabili della capacità di cura della loro terapia, e non
malati disperati, la «vivente realtà» cara a Don Benedetto. L’affaire Stamina è
una faccenda recente. L’ultima a ricordarci l’opposizione apparentemente
insanabile tra la comunità scientifica con le sue verità e noi con le nostre
esperienze. Che si saldano con sistemi di valori collettivi fino a creare dei
veri e propri movimenti. E così l’Oms aveva un bel puntare a sconfiggere il
morbillo entro il 2015, e noi avevamo un bel pensare alla malattia come a una
piaga dei paesi poveri; il 7 marzo proprio a Roma una bambina di 4 anni, Giulia,
è morta per le complicanze di questa malattia. Non era stata vaccinata. Perché?
Perché, insomma, molte delle conoscenze scientifiche diventano oggetto di
opposizione sociale, anche violenta? Cominciamo col dire che non accade solo in
Italia. Ma in tutte le democrazie occidentali. Se persino una buona fetta degli
americani - coi loro quasi 200 premi Nobel, i più potenti centri di ricerca del
mondo, i milioni di dollari investiti e i migliori scienziati del pianeta - è
convinta che a metterci su questa Terra è stato un signore con la barba bianca
qualche migliaio di anni fa e non un processo durato milioni di anni di
evoluzione della vita. Centinaia di genitori inglesi si oppongono ai vaccini ben
più violentemente dei nostri, forti di un antico principio che lo Stato non può
interferire con le decisioni di una famiglia britannica. I tedeschi sono i
maggiori consumatori di medicine “oliatiche” nel mondo. E i casi di terapie
anticancro miracolose che infiammano l’opinione pubblica sono ovunque all’ordine
del giorno. Quindi, sbagliano quelli che tacciano gli italiani di oscurantismo,
e ignoranza scientifica. Siamo oscurantisti e ignoranti tanto quanto gli altri.
Quel che fa la differenza è che altrove l’opposizione sociale alle conoscenze
scientifiche non trova una sponda politica così forte come quella che trova a
Roma, che non detta le leggi e i provvedimenti come invece fa nel nostro
Parlamento. Lo dimostrano i dati raccolti dall’“Annuario Scienza Tecnologia
Società” (edito da Il Mulino). Stando a quanto riportato nell’edizione 2015
appena pubblicata, ad esempio: «il livello di alfabetismo scientifico dei
cittadini ha raggiunto un picco mai toccato». E, aggiunge Massimiliano Bucchi,
professore di Sociologia della scienza all’Università di Trento: «Lo stereotipo
dell’italiano ottuso è largamente infondato. Ce lo dimostrano i dati raccolti in
questi anni. Che, anzi, esplicitano quanto interesse ci sia per le questioni
scientifiche nel nostro paese. Pensiamo solo al fatto che in nessun’altra parte
del mondo i Festival della scienza sono così frequentati come i nostri; e che
nessuna trasmissione televisiva, del settore, al mondo fa gli ascolti di
Superquark». Già, però, poi abbiamo la peggiore legge sulla sperimentazione
animale possibile, un’opposizione agli Ogm che manipola tutti i ministri
dell’Agricoltura da dieci anni, e una regione come il Veneto che, nel 2007,
scrive un’apposita legge per dire che non è obbligatorio vaccinare i bambini.
Salvo poi scoprire, come ha fatto una ricerca della Asl di Verona, che cinque
anni dopo i tassi di vaccinazione sono rimasti gli stessi. E scoprire che lo
zoccolo duro dei nemici dell’immunizzazione salvavita è composto essenzialmente
da laureati, informati e impegnati politicamente. Proprio come i genitori della
piccola Giulia morta a Roma per le complicanze del morbillo, due medici. Fatti
questi che diventano regola nel panorama italiano narrati dall’Annuario. E che
Bucchi riassume: «L’opposizione ai vaccini, come agli Ogm, come la predilezione
per l’omeopatia sono più diffuse tra le persone scolarizzate. Che si sentono
istruite e quindi competenti a scegliere». Le ricerche dei sociologi indicano
che siamo nel pieno di quella che Bucchi chiama «crisi dei mediatori». La gente
non si informa più sui giornali, dall’amico scienziato, dal medico di famiglia.
Va su Internet. Ma, attenzione, non a cercare vaghezze sui social network, i più
vanno direttamente alla fonte: leggono i lavori scientifici, surfano i siti
delle grandi università, seguono i blog dei ricercatori. Così entrano in
contatto con una marea indistinta di informazioni (tutte attendibilissime), ma
troppe perché un cittadino comune possa orientarsi, e men che meno fare una
sintesi. E allora, di fronte a questo oceano, per farsi un’idea usano il loro
personalissimo sentimento. Il professore della Yale University Dan Kahan si è
chiesto in che modo i cittadini decidano di avere o meno paura degli Ogm, del
riscaldamento globale, delle biotecnologie, o, magari, di fidarsi di Vannoni. E
ha scoperto che lo fanno sulla base di «valori profondi», selezionando con cura
sia le informazioni che sono conformi a questi valori sia riconoscendo
autorevolezza agli esperti che li confermano tenendo, invece, in poco conto
quelli che sostengono posizioni contrarie. E così persone con culture diverse si
formano opinioni diverse sul medesimo fatto, senza tener conto della verità
scientifica. Questo accade, aggiunge Bucchi, perché «i temi su cui l’opinione
pubblica si trova in conflitto con le acquisizioni scientifiche hanno una natura
ibrida. Sono questioni tecniche, ma il pubblico le percepisce come politiche». E
così a formare il giudizio concorrono atteggiamenti che non hanno niente a che
fare con la verità fattuale: la critica alle multinazionali dei semi o dei
farmaci, percepite come invasive e luciferine; il rapporto col cibo; la sfiducia
nelle istituzioni che si allarga a quelle scientifiche; l’adesione a dogmi
religiosi. Atteggiamenti che coagulano gruppi molto coesi, attorno a una
credenza che sembra quasi una fede. E un gruppo molto coeso attorno a una fede
sono anche gli scienziati che oppongono apoditticamente la loro verità mentre
sarebbe di gran lunga meglio, aggiunge Bucchi: «far crescere un atteggiamento
critico, aperto ed equilibrato. Laico». Ovvero spingere l’acceleratore più sulla
validità del metodo scientifico, sul valore del dubbio che muove ogni ricerca
scientifica, sui suoi limiti e le sue potenzialità. Mentre, suggerisce Bucchi:
«I paladini della scienza fanno troppo spesso dichiarazioni di principio».
Altezzosi, spesso odiosi perché chiusi nelle loro torri d’avorio. Ma nello
scontro tra fedi, c’è un convitato di pietra. Che finisce il più delle volte col
prendere le decisioni sbagliate. È la politica che asseconda gli umori dei
movimenti. Sono gli uomini e le donne del Parlamento che si dimostrano i veri
oscurantisti e, chiosa Bucchi: «si comportano pensando di assecondare i desideri
del pubblico. Ma spesso non hanno una rappresentazione corretta di quello che
vogliono davvero i cittadini». I quali, ad esempio, sono nella stragrande
maggioranza (il 67 per cento) favorevoli alla procreazione medicalmente
assistita, regolamentata dal Parlamento con la legge più oscurantista che si
potesse mai scrivere. Legge peraltro confermata da un referendum che chiamava in
causa gli stessi cittadini. Un bel pasticcio. «Non tanto», chiosa Bucchi: «Al
momento di andare a votare il merito passa in secondo piano e prevale
l’affiliazione con la propria parte». Quello che di certo non ha avuto peso sono
state le decine di prese di posizioni degli scienziati che spiegavano come e
perché quella legge non ha senso. Perché, nelle mille sfumature del complesso
rapporto tra gli italiani e la scienza, vi è di certo che la comunità
scientifica è del tutto incapace di influenzare le scelte dei governi. Quando
non ne è completamente subalterna. E l’opinione pubblica lo sa. L’84,4 per cento
degli italiani, secondo l’Annuario 2015, ritiene che la scienza sia «troppo
condizionata dalla politica». Basta vedere la pantomina andata in scena a
L’Aquila. Con i tecnici condannati in primo grado (e poi assolti) perché nei
giorni precedenti il sisma - sostennero i giudici - avevano rassicurato la
popolazione, trasmettendo informazioni «inesatte, incomplete e contraddittorie».
I membri della Commissione tecnico scientifica hanno avallato le dichiarazioni
del vice della Protezione Civile, Bernardo De Bernardinis, il quale ha
rassicurato la popolazione, a suo dire, proprio sulla base delle rassicurazioni
a sua volta ricevute dagli scienziati. Certo non colpevoli perché nessuno può
prevedere un terremoto, ma di certo anche ambigui nell’avallare implicitamente
le rassicurazioni di De Bernardinis. Senza nemmeno suggerire l’ombra del dubbio.
A L’Aquila è andata in scena la subalternità dei tecnici nei confronti della
politica. E la vicenda è una triste parabola dei rapporti tra la scienza e il
potere nel nostro paese. Dove vince sempre la ragion politica.
IGNORANTI NELLA
SOCIETA’ CIVILE.
Calcio, politica e soldi. Tutti i luoghi comuni dell'italiano
medio. Da "i ricchi evadono" al "solito inciucio":
ormai le litanie dilagano. E chi le recita si sente un po' più onesto degli
altri, scrive Massimiliano Parente su “Il Giornale”. Mica c'è bisogno dell'Istat
e dei sondaggi, per capire gli italiani basta vedere di cosa si lamentano in
continuazione, lagne entrate nel linguaggio popolare come tic, frasi fatte che
si sentono ovunque, una volta solo al bar o in famiglia o se prendevi un tassì a
Roma, ormai perfino in televisione. A cominciare dalla considerazione «Solo in
Italia». Solo in Italia ci sono mille parlamentari. Solo in Italia non trovano i
colpevoli dei delitti. Solo in Italia la giustizia funziona male, ovviamente se
per caso tocca noi, se tocca un altro «dovrebbero metterlo dentro e buttare la
chiave», come fanno all'estero. Tanto nessuno conosce l'estero, per questo ogni
legge elettorale te la propongono alla francese, alla tedesca, all'americana,
per mostrare di conoscere il mondo quando non si sa un cavolo neppure di come si
vota in Italia. Coltivando il mito di paesi nordici come la Scandinavia o la
Norvegia, dove i servizi funzionano a meraviglia, dove lo tasse sono bassissime,
basta che non domandi dove sta la Norvegia perché non saprebbero neppure
indicartela sulla carta geografica. Sebbene abbiano sentito Grillo che ti spiega
come lì si ricicli anche la pupù. Ma perché non cerchi lavoro? Perché tanto «non
c'è lavoro», perché «bisogna andare fuori», e poi tutti sono sempre qui, mai che
muovano il sederino, come all'estero appunto. Tanto «è tutto un magna magna», e
«tutti rubano», sempre a sottintendere che chi lo dice non appartiene alla
categoria, sempre a sottolineare una propria specchiatissima onestà, perché solo
in Italia «i ricchi evadono lo tasse», l'hanno visto da Santoro e a Report, te
lo dice il barista che intanto non ti rilascia lo scontrino fiscale e il medico
o l'idraulico che senza fattura, se vuoi, paghi meno, e tu ci stai perché tanto
mica te la scarichi, come in America. E comunque ve lo immaginate un inglese o
in americano che si lamenta del magna magna e dice « it's all an eat eat »?
Tanto «gli italiani so' tutti ignoranti», sbotta quello che non ha mai aperto un
libro e un quotidiano lo sfoglia a scrocco mentre sbocconcella il cornetto,
leggendo solo i titoli, non per altro quanto a lettura di giornali veniamo dopo
la Turchia, e l'editoria è in crisi qui più che altrove, perché se si legge
qualcosa «l'ho letto su internet». Che poi se cerchi lavoro, è noto, «prendono
solo raccomandati», e intanto non è che per caso conosci qualcuno? Troppi
immigrati, «arrivano solo da noi, perché non li mandiamo in Francia e in
Germania?», che però ne hanno più di noi, e al contempo gli italiani sono pure
tutti cattolici (non praticanti, per carità), con un papa che gli immigrati,
cristianamente, li farebbe entrare tutti, per dare da mangiare agli affamati e
da bere agli assetati. Noi al massimo porgiamo l'altra guancia, ma degli altri,
insomma «se ne dovrebbe occupare l'Europa!», la quale Europa quando elargisce i
finanziamenti a noi spariscono non si sa dove, e però «è tutta colpa della
Merkel!». Se non altro stiamo rivalutando Andreotti, Craxi, «loro sì che erano
politici», e quando c'erano loro i nostalgici pensavano a Mussolini, «con lui
non si rubava». In un paese dove «non c'è meritocrazia», e mica se ne lamenta il
laureato a Harvard, se ne lamentano tutti, un popolo di meritevoli, informati,
studiosi, sentono che c'è «la fuga dei cervelli» e si identificano subito col
cervello in fuga. Mai sentito nessuno che ammetta di non essere all'altezza, di
aver studiato poco, di non meritarsi nulla, tutti sanno tutti, in qualsiasi
campo, dalla medicina all'economia. Convintissimi che se i parlamentari si
tagliassero lo stipendio si abbasserebbe il debito pubblico. O almeno potrebbero
«dare l'esempio», quasi che i deputati fossero arrivati in parlamento con
un'astronave e non li avessero votati loro. Perché qui «è tutto un inciucio», e
nel frattempo pure a me scrittore, nel mio piccolo, arrivano in posta sporte di
manoscritti mediocri che vogliono essere letti da gente che non ha mai letto
niente, tanto meno me, ma se glielo fai notare rispondono «Mica sarà peggio di
tanti che pubblicano?». È il diritto alla mediocrità, solo in Italia.
LADRI IN PARLAMENTO. TANGENTOPOLI ED IL POOL MANI PULITE: LA
GENESI.
Giancarlo De Cataldo su “L’Espresso”: L'Italia è una repubblica fondata sullo
scandalo. Dai tempi di Cavour a Mani Pulite: ogni vent’anni un’indagine-choc.
Corsi e ricorsi storici delle tangenti, specchio di un Paese che non cambia. Il
commento dello scrittore-magistrato. La fiction “1992” è bella e coraggiosa.
Racconta - ed è già questo un merito innegabile - la controversa stagione di
Mani Pulite. Lo fa con la disinvolta ferocia narrativa che è il marchio di
fabbrica delle grandi serie. “1992” è televisione avanzata. Ma ha anche un altro
merito. “1992” declina con linguaggio di oggi una vicenda che affonda radici
profonde nella storia d’Italia. Una storia antica: la storia della nostra
corruzione. Una storia cominciata tanti anni fa. Conquistato il Sud grazie
all’impresa dei Mille, il conte di Cavour si mette all’opera per disegnare il
futuro della nuova nazione. Giorgio Asproni, deputato sardo, alta carica
massonica, ex-prete, esponente dell’estrema sinistra mazziniana, nei suoi
impietosi diari annota disgustato l’incessante processione di faccendieri,
ufficiali, imprenditori che assediano l’ufficio di Cavour a Palazzo Carignano.
Tutti a vantare inesistenti meriti patriottici, tutti a implorare un incarico,
una commessa, un’onorificenza. Ciò che l’incendiario Asproni non può sapere è
che in quegli stessi momenti Cavour, il liberale, l’odioso tessitore di trame
che i democratici accusano di essersi impossessato per turpi fini della bandiera
della Patria, proprio Cavour, prova, nei confronti dei questuanti, sentimenti
non molto dissimili. Al punto da bollare i clientes con parole di fuoco. Asproni
e Cavour, ciascuno eroico a suo modo, divisi da visioni radicalmente
inconciliabili della Storia (e della natura umana) su un punto concordano: il
disprezzo per quei molli figuri che non versarono una sola goccia di sangue per
la “causa” e ora si avventano sulla greppia dell’Italia unita. Ma se Asproni li
metterebbe volentieri al muro, corrotti e corruttori, Cavour, secondo il suo
costume, pensa di poterne agevolmente “trarre partito”. Costruire dal nulla
un’identità nazionale è compito arduo, ai limiti dell’impossibile. Nella fase
d’avvio non si può andare tanto per il sottile. Anche gli affaristi servono, e
servono i faccendieri. Cavour opera una scelta di campo destinata a ipotecare
pesantemente il nostro futuro. Il destino fa il resto. Cavour, che forse sarebbe
riuscito a contenere le smanie predatorie nell’alveo della fisiologia
democratica, muore troppo presto. I suoi successori non si riveleranno
all’altezza. Quindici anni dopo l’Unità, nel 1875, un popolano trasteverino
accoltella a morte Raffaele Sonzogno, coraggioso giornalista calato a Roma dal
Nord, animatore di inchieste sul dilagante malaffare post-unitario. Il sicario
viene subito arrestato, ma è chiaro che, secondo uno schema destinato a
ripetersi drammaticamente negli anni, se il pugnale viene dalla strada, l’ordine
è partito dal Palazzo. Dietro l’uccisione di Sonzogno c’è una colossale
speculazione edilizia sui terreni espropriati al Vaticano. Sono coinvolti
banchieri, palazzinari, preti attenti al portafoglio, pezzi della Destra
storica, che uscirà sconfitta dalle elezioni dell’anno dopo, e pezzi della
Sinistra che già pregusta la vittoria, e persino un rampollo “agitato” dell’eroe
dei Due Mondi. Una pregevole compagnia di giro che ritroveremo spesso nella
cronaca del nostro Paese. Troppo, per una nazione appena nata. L’inchiesta,
abilmente pilotata, porta alla condanna del deputato Luciani. Movente: una
questione di corna. Luciani becca una condanna tombale, e invano, per anni,
minaccerà sconvolgenti rivelazioni. Dalla speculazione verranno poste le basi
per uno dei tanti, anch’essi ricorrenti, “sacchi” di Roma. Qualche anno dopo,
nel 1892, un giornale satirico della capitale, “Il carro di Checco”, svela la
vicenda finanziaria che passerà alla storia come “scandalo della Banca Romana”.
Incalzato dal battagliero Napoleone Colajanni, il governo è costretto a nominare
una commissione d’inchiesta. Emergono notevoli reati: si va dalla fabbricazione
e spaccio di monete false al falso in bilancio, dalle false fatturazioni alla
corruzione dei funzionari e deputati incaricati dei controlli, passando per la
costituzione di “fondi neri” riversati nelle tasche di personaggi pubblici.
Coinvolto il gotha politico del tempo, Giolitti in testa, lambita Casa Savoia.
Giolitti, anche se non è più ministro, pretende e ottiene una giurisdizione
“politica”. Il finale è deprimente, con la morte per suicidio di un onorevole
accusato di un reato minore e il proscioglimento generale. Favorito, si disse,
da un’attenta “gestione” dei materiali probatori concordata fra Governo e
vertici della magistratura. Grande e diffusa fu la frustrazione. Un giurista
scrisse che si era consacrata «l’immoralità di chi ha troppo mangiato e che dopo
il pasto pare abbia, come la lupa di Dante, più fame di pria». La stampa, come
sovente accade, deplorò. E tutto ricominciò come prima. Fra l’altro, proprio
mentre si dibatteva della Banca Romana, in Sicilia veniva assassinato Emanuele
Notarbartolo di San Giovanni. Un banchiere onesto che si era messo di traverso
alle speculazioni ordite da quella che, allora, si chiamava “Alta Mafia”. Fu
incriminato per questo omicidio l’onorevole Palizzolo, poi assolto all’esito di
un interminabile processo. Il vecchio liberale Gaetano Mosca parlò di «disfatta
morale». Gli amici festeggiarono la liberazione di Palizzolo noleggiando una
nave con tanto di gran pavese. In tempi più recenti, sembra essersi affermata
una paradossale “legge del venti”. Nel senso che ogni vent’anni circa il Paese
“scopre” uno o più colossali scandali a base di corruzione. Si deplora, si
invocano cambiamenti legislativi, emergono demagoghi più o meno versati
nell’arte di arringare le masse promettendo “pulizia”, si adottano misure
asseritamente restrittive, si fanno esami di coscienza, si va in Tribunale. Nel
1974 alcuni giovani giudici, definiti con un certo risentimento “pretori
d’assalto” (l’anticamera del “giudici ragazzini” di qualche anno dopo), scoprono
che i petrolieri pagano i ministri per ottenere leggi favorevoli alla propria
lobby. Sandro Pertini, Presidente della Camera, li incoraggia a «non guardare in
faccia a nessuno», inclusi i suoi compagni del Partito Socialista. Minaccia, in
caso di insabbiamento, le dimissioni. Il governo cade. Gli imputati sono
giudicati dalla Commissione Parlamentare per i procedimenti di accusa. Pertini
non si dimette. Esito del giudizio: due ministri archiviati, due prescritti, due
assolti dopo qualche tempo. Mani Pulite, si è detto, esplode nel 1992, quindi a
circa vent’anni dallo scandalo dei petroli. Fra il 1992 e il 1993 si consumano
gli ultimi delitti eccellenti e le ultime stragi di mafia. Curiosa coincidenza
con quanto era accaduto esattamente un secolo prima. Ieri corruzione a Roma e
morte di un banchiere onesto in Sicilia, oggi corruzione a Milano e non solo,
piombo e tritolo per politici, giudici e inermi cittadini in Sicilia e non solo.
Quasi a voler sottolineare che gli inconfessabili legami e lo spregiudicato uso
della violenza e della corruttela, col tempo, invece di attenuarsi, si sono
rafforzati. Le stragi mafiose e Mani Pulite suscitarono un’ondata di
indignazione. Furono approvate leggi per favorire il fenomeno del pentitismo e
confiscare i beni dei mafiosi. Una nuova classe politica spazzò via la
precedente: e anche questo era accaduto, cent’anni prima. Poi, col tempo, tutto
si è sopito e troncato. I pentiti sono diventati più o meno degli appestati.
Mani Pulite è oggetto di revisione storiografica critica. Ritocchi normativi
bipartisan hanno reso sempre più disagevole l’operato degli investigatori. A
risvegliare i dormienti, guarda caso a vent’anni da Mani Pulite, gli scandali
Expo, Mose, e, infine, l’inchiesta “Mafia Capitale”. Che, fra l’altro, come
all’epoca del trapasso fra Destra storica e Sinistra, propone uno spaccato di
cointeressenze fra gente che dovrebbe, teoricamente, militare su opposte sponde.
Oggi la stampa deplora. Sono allo studio inasprimenti di pena. Si nominano
authority anticorruzione e assessori alla legalità. Intanto, si vara una legge
punitiva sulla responsabilità civile dei magistrati e si tuona contro il loro
“protagonismo”: senza mai riempire di contenuto questa parola dal suono, si
direbbe, gnostico. Si giura, soprattutto, che è venuto il momento di voltare
pagina. Come diceva Nino Manfredi: «Fusse ca fusse...». Dobbiamo dunque
ritenerci rassegnati e sfiduciati? Ci mancherebbe! A un ragazzo che si affaccia
alla vita non puoi trasmettere il messaggio del “tutto è perduto”. Sarebbe
delittuoso. Però un minimo di onestà intellettuale non disturba, anzi. Bisogna
spiegare che fra corruzione e legalità si combatte una guerra aspra, senza
esclusione di colpi. Che corrotti e corruttori offrono scorciatoie convincenti,
indossano maschere seducenti, vantano - e purtroppo sovente a ragione -
indiscutibili successi. Sono simpatici, mondani, ricchi di fascino, corrotti e
corruttori. “Legalità” è invece una parola astratta che ossessivi, abili
messaggi fanno apparire sempre più ostile, odioso patrimonio di arcigni, e
dunque antipatici, guardiani. “Moralista” fa oggi sorridere, “incorruttibile”
suscita panico. Bisogna spiegare che giudici e poliziotti sono patologi del
sistema, intervengono quando il danno è stato fatto. Bisogna insistere
sull’istruzione e sulla cultura, e persino sull’estetica: si può combattere,
consapevoli della disparità fra le forze in campo, anche per il solo gusto di
non darla vinta alla società dei magnaccioni. E dopo, a casa, magari, tutti a
vedere “1992”, la serie. Con Asproni che digrigna i denti e Cavour che perde un
po’ alla volta il suo ironico sorrisetto.
Così è nata l'inchiesta Mani Pulite. Il verbale dimenticato di Mario Chiesa. Il
primo arrestato di Tangentopoli cerca di bloccare la serie tv "1992". Ma scorda
che fu proprio una sua querela per diffamazione a incastrarlo: ecco
l'interrogatorio integrale che ha fatto esplodere lo scandalo che ha segnato la
fine della Prima Repubblica, scrive Paolo Biondani su “L’Espresso”. L'Italia,
dicono molti storici, è un Paese senza memoria, che proprio per questo è
condannato a ripetere gli errori del passato. Infatti la storia di Tangentopoli
sembra averla dimenticata perfino chi l’ha scritta. Mario Chiesa è stato il
primo arrestato di Mani Pulite, l’inchiesta che vent’anni fa ha travolto il
vecchio sistema dei partiti. L’ingegnere socialista era presidente di un grande
ospizio milanese quando fu ammanettato dai carabinieri, il 17 febbraio 1992, con
una tangente di 7 milioni di lire (3500 euro). Quella bustarella segnò l’inizio
del terremoto legale che nel successivo biennio ha portato i pm milanesi a
ottenere ben 1.233 condanne per corruzione e reati collegati. Nel febbraio
scorso Chiesa ha proposto un ricorso civile d'urgenza diretto a bloccare la
serie televisiva “1992” in programma su Sky: la trama ispirata a Tangentopoli lo
avrebbe «gravemente diffamato», protestava il suo avvocato, definendo «falsa» la
scena dell’arrestato che si disfa di una mazzetta gettandola nel water. Ora
l’Espresso ha recuperato gli storici verbali di Chiesa , scoprendo che
proprio lui, nella prima confessione fiume del 23 marzo 1992, rivelò
quell’episodio all’allora pm Antonio Di Pietro: «Due ore prima dell’arresto, il
geometra M. mi diede altri 37 milioni di lire. Tale somma non fu rinvenuta nella
perquisizione in quanto si trovava in una busta che nascosi nella giacca e poi
gettai nel bagno». Mani Pulite, l'inchiesta che ha cambiato il sistema politico
in Italia, si è consumata in meno di tre anni, tra quel 17 febbraio 1992 e il
dicembre 1994. Anni di crisi economica, sfiducia generale nei partiti, arresti a
catena, stragi di mafia. Ma anche di grandi speranze in un cambiamento profondo,
di aspettative che potesse nascere un'Italia migliore, finalmente libera dal
giogo della corruzione. Speranze poi rivelatesi illusioni, e non per colpa dei
magistrati. L'intera maxi-inchiesta Mani Pulite è nata da quella storia locale
di malaffare politico. Milano, 17 febbraio 1992: Mario Chiesa, presidente
socialista dello storico ospizio Pio Albergo Trivulzio, viene arrestato in
flagrante, nel suo ufficio, mentre nasconde nel cassetto della scrivania una
busta con sette milioni di lire in contanti. È una tangente che gli ha appena
consegnato un piccolo imprenditore taglieggiato di Monza, Luca Magni, il primo
che ha avuto il coraggio di denunciare le continue richieste di soldi in cambio
degli appalti. Quella bustarella è una trappola. La Procura di Milano indaga per
concussione (un reato simile all'estorsione) e ha convinto la vittima a
collaborare. Le banconote sono state fotocopiate in Procura, una ogni dieci è
firmata dall'allora pubblico ministero Antonio Di Pietro e dal capitano dei
carabinieri Roberto Zuliani. La tangente è la metà della somma totale pretesa da
Chiesa: 14 milioni di lire, pari al 10 per cento del valore dell’appalto (140
milioni) per le pulizie del Trivulzio. L’arresto “con le mani nel sacco”, come
titolano i giornali, crea scandalo attorno a un sistema di potere che a Milano è
dominato dal Psi di Bettino Craxi. Come rivelerà solo un successivo atto di
«proroga indagini», l’inchiesta su Mario Chiesa era in realtà in corso
dall’ottobre 1991. A scoperchiare lo scandalo era stato un anziano cronista del
“Giorno”, Nino Leoni: quando pubblica le prime denunce sul Trivulzio, per
sospetti favoritismi a imprese di pompe funebri, Chiesa lo querela. Invece di
scaricare sul giornalista l’onere di provare che ha scritto sempre e soltanto la
verità, per una volta il pm di turno, che è appunto Di Pietro, decide di
indagare seriamente su quell'articolo e apre un “fascicolo alternativo”: si
procederà per diffamazione solo se risulterà infondata la notizia della
corruzione. Quando viene arrestato, quindi, Mario Chiesa è da mesi sotto
intercettazione. E dalle sue telefonate in codice Di Pietro ha già scoperto che
quel politico diventato manager pubblico nasconde miliardi di lire in Svizzera,
su conti battezzati con nomi di acque minerali come Fiuggi e Levissima. Craxi si
sente per la prima volta sotto assedio a Milano e il 3 marzo 1992 tenta di
circoscrivere il caso Chiesa. Intervistato dal Tg3 , il segretario del Psi
dichiara: «Una delle vittime di questa storia sono proprio io... Mi trovo
davanti a un mariuolo che getta un’ombra su tutta l’immagine di un partito che a
Milano, in 50 anni, non ha mai avuto un amministratore condannato per reati
gravi contro la pubblica amministrazione». La frase viene riferita in carcere
all'arrestato, che si sente ormai scaricato e isolato. Il 23 marzo 1992 Mario
Chiesa rompe il muro dell'omertà e firma la sua prima confessione-fiume. Parla
di appalti truccati da decenni. Chiama in causa decine di piccole, medie e
grandi aziende. Rivela di aver diviso i soldi con politici di rango nazionale. È
il primo di una serie di interrogatori che svelano ai magistrati il sistema
della corruzione. Prima c'era solo il «caso Chiesa». Da quel verbale nasce
Tangentopoli. Le confessioni di Chiesa hanno l'effetto della scintilla che
scatena un incendio. I primi imprenditori chiamati in causa per gli appalti
della “Baggina” (come i milanesi chiamano il Trivulzio, perché ha sede sulla
strada per Baggio) cominciano ad ammettere di aver pagato tangenti. E confessano
altre corruzioni, allargando le indagini. Tra i politici, il primo a collaborare
con i magistrati è il socialista Alfredo Mosini: subito dopo l'avviso di
garanzia, si dimette dalla carica di assessore comunale e confessa anni di
spartizioni delle tangenti sugli appalti dell’ospedale Fatebenefratelli, di cui
era stato amministratore. Oltre a Dc, Psi e agli alleati centristi Pri, Psdi e
Pli, a Milano l’inchiesta coinvolge dall’inizio anche il Pci-Pds. Le elezioni
politiche del 5 aprile 1992 segnano il crollo dei due partiti di massa: la Dc
perde 5 punti e scende sotto il 30 per cento; il Pds con Rifondazione comunista
si ferma al 26,6 (meno 4,9 rispetto al 1987). Il Psi di Craxi invece limita il
calo dal 14,3 al 13,6 per cento. La Lega Nord, che in Lombardia aveva già
raggiunto il 18,6 per cento alle amministrative del 1990, sfonda in tutto il
Nord, conquistando 8,7 punti a livello nazionale, e manda in parlamento 55
deputati e 25 senatori, che promettono battaglia contro «Roma ladrona». Il film
della strage di Capaci in cui morirono Giovanni Falcone e la moglie Francesca
Morvillo e con loro gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Collo e
Vito Schifani, è stato ricostruito dopo cinque mesi in un bosco della Toscana
dagli esperti artificieri dell'esercito e dalla Polizia Scientifica della
Polizia di Stato. Un tratto di autostrada, che ricalcava le stesse dimensioni e
caratteristiche del punto in cui è stato sistemato l'esplosivo vicino allo
svincolo di Capaci è stato realizzato nella campagna toscana. E poi gli
artificieri hanno piazzato 600 chili di esplosivo. Seguendo tutte le procedure
per attivare la grande quantità di tritolo. Poi il grande botto. Le telecamere
della polizia scientifica hanno filmato l'esplosione. Un modo per ricostruire la
strage. Un filmato che è agli atti del processo. Gli esperti artificieri hanno
anche ricostruito l'esplosione di via D'Amelio, in cui è stato ucciso Paolo
Borsellino e i poliziotti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina,
Vincenzo Li Muli e Claudio Traina, ripreso dalla telecamere della scientifica.
Si vede una Fiat 126 imbottita di esplosivo che poi viene atta brillare. Il 24
aprile 1992 cade il settimo governo di Giulio Andreotti. Dopo la strage di
Capaci, con i boss di Cosa Nostra che fanno saltare un’autostrada per uccidere
Giovanni Falcone, il giudice anti-mafia che solo da morto diventa un eroe per
tutti, il nuovo clima politico fa salire al Quirinale un notabile democristiano
con fama di galantuomo, Oscar Luigi Scalfaro. A fine giugno diventa presidente
del consiglio Giuliano Amato, alla testa di un quadripartito d’emergenza
Dc-Psi-Psdi-Pli. A Milano, l’inchiesta continua, con un effetto-valanga che
caratterizzerà i primi tre anni di Mani Pulite: ai nuovi arresti seguono ampie
confessioni, che portano ad aprire altre indagini. Sempre in tempi strettissimi.
La prima svolta è del 22 aprile 1992, quando vengono arrestati con un unico
blitz otto imprenditori milanesi. Sono nomi di livello locale: il più noto è
Clemente Rovati, che con la sua Edilmediolanum guida, tra l'altro, la cordata
dei costruttori del terzo anello dello stadio di San Siro (costato 180 miliardi
di lire, contro i 64 preventivati nel 1987). Per il mondo degli affari quella
retata è uno choc. Gli arrestati escono da San Vittore dopo aver confessato uno
dopo l'altro. E da allora decine di imprenditori addirittura anticipano gli
sviluppi dell'inchiesta presentandosi “spontaneamente” in procura. Questo
fenomeno delle “code per confessare” prosegue per tutto il 1993 e si interrompe
definitivamente nel 1994. Una simile massa di ammissioni non si è mai ripetuta
nella storia d'Italia, né prima né dopo. Nel 1992, quando guadagnò l’uscita dal
carcere di San Vittore, uno dei primi inquisiti, il manager dell’Iri-Italstat
Mario Alberto Zamorani, azzardò una previsione che allora sembrava catastrofica:
«Ne arresteranno mille». Col senno di poi, era stato ottimista. La Procura di
Milano ha aggiornato le statistiche dei processi di Mani Pulite per dieci anni,
fino al 15 gennaio 2002, perché poi è caduto tutto in prescrizione. Il bilancio
finale è di 1.233 condanne per corruzione, concussione, finanziamento illecito
dei partiti e relativi falsi in bilancio aziendali. Al conto vanno aggiunte
altre 448 sentenze di “estinzione del reato”, che non sono condanne ma nemmeno
assoluzioni: i giudici spiegano che l'imputato è colpevole, ma non può essere
punito per amnistia, morte dell'accusato e soprattutto per prescrizione (ben 423
casi), cioè per scadenza dei termini massimi di punibilità, che in Italia sono
straordinariamente brevi. Correva l'anno 1992. Il 17 febbraio il pubblico
ministero Antonio Di Pietro chiede e ottiene dal Gip Italo Ghitti un ordine di
cattura per l'ingegner Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio e
membro di primo piano del PSI milanese. È l'avvio di Tangentopoli. Oggi, 23 anni
dopo l'arresto di Mario Chiesa, il giudizio positivo o negativo su Mani Pulite
continua a dividere gli italiani, come una faglia trasversale. Di fronte a
un'inchiesta che in soli trenta mesi è sfociata in più di 1600 verdetti di
colpevolezza a carico di politici, funzionari e imprenditori di alto o altissimo
livello, una cosa è certa: Tangentopoli non è stata un'invenzione dei
magistrati. E tante nuove indagini, dal Mose di Venezia all' Expo di Milano,
confermano che la corruzione in Italia resta un problema enorme.
L’inchiesta «Mani Pulite» a cura di
Massimo Parrini su "Il Corriere della Sera".
Lunedì 17 febbraio 1992. Tangenti,
arrestato presidente Pio Albergo Trivulzio. Mario Chiesa, 47 anni, presidente
socialista del Pio Albergo Trivulzio, è arrestato in flagrante a Milano mentre
riceve una tangente di sette milioni di lire.
Mercoledì 22 aprile 1992. Milano, otto
arresti per tangenti. A Milano otto imprenditori sono arrestati per corruzione,
concussione e abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta Mani pulite. Gli ordini
di cattura nei confronti di Gabriele Mazzalveri, Franco Uboldi, Clemente Rovati,
Giovanni Zaro, Claudio Maldifassi, Giovanni Pozzi, Bruno Greco e Fabio Lasagni
sono stati richiesti dal pubblico ministero Antonio Di Pietro, titolare
dell’inchiesta nata con l’arresto del presidente del Pio Albergo Trivulzio Mario
Chiesa (17 febbraio). Gli arrestati devono rispondere di affari conclusi dal
1979 non con il Pio Albergo Trivulzio ma con altri enti: l’Ipab, l’ente comunale
di assistenza, gli ospedali Fatebenefratelli, Gaetano Pini, Paolo Pini e
Bassini.
Sabato 2 maggio 1992. Milano, avvisi di
garanzia a Tognoli e Pillitteri. Avvisi di garanzia per due ex sindaci di Milano
adesso deputati del Psi: Carlo Tognoli (ricettazione) e Paolo Pillitteri
(ricettazione e corruzione). A tirarli in ballo è stato Mario Chiesa, l’ex
presidente socialista del Pio Albergo Trivulzio dal cui arresto (17 febbraio) è
nato il caso che si sta trasformando in uno scandalo nazionale.
Mercoledì 6 maggio 1992. Tangenti,
arrestato Lodigiani. Mario Lodigiani, vicepresidente e legale rappresentante
della Lodigiani Spa, la quarta impresa edile d’Italia, è arrestato con l’accusa
di aver pagato una tangente di tre miliardi per conto di un consorzio di imprese
che si sono assicurate l’appalto per il quadruplicamento del tratto
Milano-Saronno delle Ferrovie Nord. Finisce in carcere anche Roberto Schellino,
ex direttore tecnico della Cogefar-Impresit (impresa leader del settore, passata
dal gruppo Romagnoli alla Fiat), accusato di aver pagato tangenti per la
costruzione di un padiglione dell’ospedale di Bergamo. Finora sono 20 le persone
finite in carcere nell’ambito dell’indagine Mani pulite: 14 imprenditori, 4
politici, 2 funzionari pubblici.
Venerdì 8 maggio 1992. Tangenti,
confessa Rezzonico (Dc). Augusto Rezzonico, ex senatore democristiano ed ex
presidente delle Ferrovie Nord, confessa di avere intascato una tangente
miliardaria e di averla poi girata a Gianstefano Frigerio, segretario regionale
della Dc: «Erano soldi per il partito».
Martedì 12 maggio 1992. Avviso di
garanzia per Citaristi, tesoriere Dc. Il senatore Severino Citaristi, tesoriere
nazionale della Dc, è raggiunto da un avviso di garanzia per illecito
finanziamento del partito: accusato di aver incassato 700 milioni da un
imprenditore, è il terzo parlamentare a finire sotto inchiesta dopo i socialisti
Carlo Tognoli e Paolo Pillitteri.
Mercoledì 13 maggio 1992. Avviso di
garanzia per Del Pennino (Pri). Antonio Del Pennino, capogruppo del Pri alla
Camera e leader indiscusso dei repubblicani milanesi, è raggiunto da un avviso
di garanzia (si parla di una tangente di un miliardo).
Sabato 23 maggio 1992. Suicida
funzionario Usl: tangenti o falsa laurea? A Milano muore suicida (gas di scarico
dell’auto) Franco Franchi, 54 anni, funzionario Usl e braccio destro di Antonio
Sportelli, amministratore straordinario della USL 75/1 arrestato per aver
intascato una bustarella sugli appalti all’ospedale San Paolo. Oltre al timore
di essere coinvolto nell’indagine Mani pulite, sembra fosse turbato dalla
scoperta (denuncia con lettera anonima) che non aveva mai preso la laurea in
Giurisprudenza inserita nel curriculum. «Sono schiacciato dall’infamia, non
posso resistere» ha scritto nel messaggio lasciato alla moglie.
Mercoledì 27 maggio 1992. Avviso di
garanzia per Cervetti (Pds). Gianni Cervetti, deputato del Pds, riceve un avviso
di garanzia nel quadro dell’inchiesta sui lavori della metropolitana;
Renato Massari, deputato del Psi, riceve un avviso per le tangenti delle
Ferrovie Nord e dell’Atm. A metterli nei guai sono stati il pidiessino Luigi
Carnevale e il socialista Sergio Radaelli: il primo, ex vicepresidente della
Metropolitana Milanese, accusa Cervetti di aver incassato a nome del partito 700
milioni di mazzette; il secondo dice di aver gestito in Svizzera svariati
miliardi del Psi e attacca Massari, leader dei transfughi socialdemocratici
passati al Garofano. Lo sviluppo delle indagini ha intanto portato alla
formazione di un “pool Mani Pulite” diretto dal procuratore capo di Milano
Francesco Saverio Borrelli, coordinato da Gerardo D’Ambrosio e composto, tra gli
altri, da Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo.
Mercoledì 17 giugno 1992. Suicida il
socialista Amorese. Renato Amorese, 49 anni, segretario del Psi di Lodi
interrogato come testimone nelle indagini sullo scandalo delle tangenti, si
toglie la vita sparandosi alla testa con una Beretta calibro 9 nell’auto
parcheggiata in una stradina di campagna a Lodi Vecchio. Ascoltato il 15 giugno,
i magistrati non avevano preso nei suoi confronti alcun provvedimento.
Nell’ultima telefonata a un amico si è sfogato, «mi sputtanano, mi sputtanano»,
alla moglie lascia un biglietto con scritto «Sono un fallito, è per quello che
già sai. Ti chiedo perdono». Su un altro foglio, indirizzato al magistrato
Antonio Di Pietro, ha scritto: «Sono un uomo d’onore. Le ho detto la verità. Le
farò avere il materiale che mi ha chiesto».
Venerdì 3 luglio 1992. Tangentopoli,
Craxi alla Camera: «Tutti colpevoli». Intervenendo nel dibattito della Camera
sulla fiducia al governo Amato, Bettino Craxi, segretario del Psi, sostiene che
tutti i partiti che hanno un apparato, anche piccolo, «hanno fatto ricorso
all’uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale» e che se questa
materia deve essere considerata come un crimine «allora gran parte del sistema
sarebbe un sistema criminale». Conclusione: «Nessun partito è in grado di
scagliare la prima pietra».
Giovedì 9 luglio 1992. Autorizzazione a
procedere per Pillitteri & C. La Camera concede l’autorizzazione a procedere nei
confronti di Carlo Tognoli, Paolo Pillitteri e Renato Massari (Psi), Antonio Del
Pennino (Pri) e Gianni Cervetti (Pds), inquisiti per la vicenda delle tangenti a
Milano. Non è accolta la richiesta di concedere l’autorizzazione per fatti nuovi
che possono emergere nel corso del procedimento. Analoga decisione è presa sulla
possibilità di sottoporre gli inquisiti ad arresti e perquisizioni. A favore
delle autorizzazioni si esprimono tutti i gruppi parlamentari. Votate a
scrutinio segreto, le domande di autorizzazione sono accolte con un grande
margine di voti (più di quattrocento sì per tutti e cinque i deputati). La
richiesta di arresto è respinta a scrutinio palese, 424 contro 113, sconfitti
Lega, Msi-Dn, Rete e parte di Rifondazione Comunista; l’estensione
dell’autorizzazione a procedere a fatti nuovi è respinta (395 contro 144) con
gli stessi schieramenti.
Martedì 14 luglio 1992. Avviso di
garanzia per De Michelis. Tirato in ballo nella vicenda della “bretella d’oro”
dell’aeroporto di Venezia - Tessera, Gianni De Michelis, leader del Psi veneto,
riceve dalla procura un avviso di garanzia per concorso in corruzione. L’ex
ministro si dichiara «colpito e amareggiato per l’utilizzazione in sede
giudiziaria di costruzioni sociopolitiche fantasiose». A Milano nuovi sviluppi
nell’inchiesta di Antonio Di Pietro: arrestato Paolo Scaroni, amministratore
delegato della Techint, avviso di garanzia a Luca Beltrami Gadola, imprenditore
dissidente del Psi. Parte la richiesta di autorizzazione a procedere contro il
senatore Severino Citaristi, segretario amministrativo della Dc.
Giovedì 16 luglio 1992. Arrestato
Ligresti. Il costruttore Salvatore Ligresti è arrestato con l’accusa di concorso
in corruzione aggravata su richiesta dei giudici milanesi: avrebbe pagato
tangenti per la metropolitana e per le Ferrovie Nord. È l’arresto più clamoroso
dall’inizio dell’inchiesta.
Martedì 21 luglio 1992. Tangenti,
suicida messo comunale. Giuseppe Rosato, 39 anni, dipendente comunale sospettato
di aver fatto il cassiere a nome di due ex amministratori del Psi inquisiti, si
impicca all’ospedale di Novara, dove era ricoverato per una crisi depressiva.
Domenica 26 luglio 1992. Tangenti,
suicida l’imprenditore Majocchi. Mario Majocchi, 56 anni, vicepresidente
dell’Ance, l’associazione nazionale dei costruttori edili, e amministratore
delegato della Nessi e Majocchi di Como, una delle maggiori imprese del Comasco,
si uccide nella sua villa in Brianza con un colpo di pistola alla tempia. Il 24
luglio era stato interrogato dal pm Piercamillo Davigo in merito a una tangente
pagata per i lavori sull’autostrada Milano-Serravalle. Non ha lasciato
biglietti.
Mercoledì 2 settembre 1992. Suicida
l’onorevole Moroni. Sergio Moroni, 45 anni, deputato socialista, si suicida a
Brescia sparandosi in bocca con un fucile nella cantina del condominio dove
abitava con la moglie e la figlia: aveva ricevuto due avvisi di garanzia
nell’ambito dell’inchiesta per le tangenti, uno per il troncone che riguarda le
discariche in Lombardia e sulle attività delle Ferrovie Nord, l’altro per i
lavori all’ospedale di Lecco. Dal 1980 al 1987 era stato consigliere regionale
ricoprendo gli incarichi di assessore al Lavoro, alla Sanità, ai Trasporti. Alle
politiche del giugno 1987 era stato eletto alla Camera, poi era entrato a far
parte della direzione nazionale del Psi (responsabile Sanità). Già segretario
regionale del Psi in Lombardia, nel 1991 aveva assunto la responsabilità
nazionale dell’ufficio Regioni. Ammalato da qualche mese (tumore al rene), era
stato ricoverato per tutto luglio all’ospedale San Raffaele di Milano.
Ultimamente era stato in Svizzera: doveva sottoporsi a un intervento chirurgico,
non ancora eseguito perché secondo i medici era troppo debilitato fisicamente.
Non ha lasciato alcun biglietto.
Giovedì 15 ottobre 1992. Avviso di
garanzia per Balzamo (Psi). Vincenzo Balzamo, deputato e segretario
amministrativo del Psi, riceve un avviso di garanzia per corruzione e violazione
della legge sul finanziamento pubblico ai partiti.
Lunedì 26 ottobre 1992. Balzamo colpito
da infarto. Vincenzo Balzamo, deputato e segretario amministrativo del Psi che
il 15 ottobre ha ricevuto un avviso di garanzia per illecito finanziamento del
partito e concorso in corruzione, è colpito da infarto.
Lunedì 2 novembre 1992. Muore Balzamo,
tesoriere del Psi. Vincenzo Balzamo, deputato e segretario amministrativo del
Psi che il 15 ottobre ha ricevuto un avviso di garanzia per illecito
finanziamento del partito e concorso in corruzione, muore per le conseguenze di
un infarto (26 ottobre). Nato nel 1929, da giovane era stato “frontista”,
accanito sostenitore dell’alleanza col Pci, dopo il ’63 era diventato un
riformista, quindi si era legato a Bettino Craxi diventando tra l’altro ministro
dei Trasporti e della Ricerca scientifica. Morente ha mormorato: «La mia
coscienza è a posto».
Martedì 15 dicembre 1992. Avviso di
garanzia per Craxi. All’hotel Raphael di Roma Bettino Craxi, segretario del Psi
ed ex presidente del Consiglio, riceve dai giudici di Milano un avviso di
garanzia con l’accusa di concorso in corruzione, ricettazione e violazione della
legge sul finanziamento pubblico dei partiti: in 18 pagine Antonio Di Pietro e i
suoi colleghi gli contestano 41 episodi di malaffare calcolando bustarelle per
36 miliardi di lire.
Venerdì 8 gennaio 1993. Secondo avviso
di garanzia per Craxi. Bettino Craxi, segretario del partito socialista ed ex
presidente del Consiglio, riceve dai giudici milanesi un secondo avviso di
garanzia. Accusato di corruzione e violazione del finanziamento ai partiti, deve
rispondere di altre due tangenti: trecento milioni di lire per i lavori di
riconversione della centrale nucleare di Montalto di Castro pagati a nome di una
cordata di imprese da Enzo Papi, ex amministratore delegato della Cogefar
Impresit; duecentottanta milioni sborsati da un altro gruppo di aziende per gli
interventi in Valtellina dopo la frana dell’87.
Domenica 24 gennaio 1993. Arrestato il
latitante Manzi. Giovanni Manzi, dirigente socialista ed ex presidente della
società aeroportuale di Milano, latitante dal 10 giugno 1992, è arrestato dopo
essere stato espulso da Santo Domingo.
Venerdì 29 gennaio 1993. Terzo avviso
di garanzia per Craxi. In quella che secondo i magistrati è «la giornata più
importante dell’inchiesta Mani pulite dall’arresto di Mario Chiesa», Bettino
Craxi riceve il suo terzo avviso di garanzia, in cui gli vengono contestati otto
capi d’accusa: quattro concorsi in concussione, una corruzione, tre violazioni
della legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Avviso di garanzia anche per
Gianni De Michelis, per la prima volta accusato da Milano: concussione e
finanziamento illecito insieme al deputato socialista Paris Dell’Unto e al
senatore dc Giorgio Moschetti; concussione per Severino Citaristi (dc, sesto
avviso), finanziamenti illeciti per Bruno Tabacci (Dc). Vengono inoltre eseguiti
sette arresti: il più illustre fra gli ammanettati è Ugo Finetti, socialista, ex
vicepresidente della Regione Lombardia, accusato di concussione e corruzione. A
Roma viene perquisita la sede del Psi.
Mercoledì 3 febbraio 1993. Craxi,
avviso di garanzia n° 4. Bettino Craxi, segretario del Psi ed ex presidente del
Consiglio, riceve il quarto avviso di garanzia: stavolta l’atto di accusa si
basa sulle dichiarazioni di Valerio Bitetto, ex consigliere d’amministrazione
dell’Enel in quota socialista che ha raccontato i meccanismi dei pagamenti delle
tangenti spiegando che alcune mazzette (7 miliardi) destinate al Psi venivano
versate su un conto a Singapore. Replica di Craxi: «Bitetto è un cretino». Nuovi
avvisi di garanzia anche per i socialisti Paolo Pillitteri e Giorgio Gangi (ex
segretario amministrativo) e per il cassiere dc Severino Citaristi. Antonio
Savoia, 51 anni, capogruppo del Pri alla Regione Lombardia, tenta di togliersi
la vita con una miscela di alcol e barbiturici: lo trovano in coma nella sua
macchina in una stradina nell’hinterland milanese, non è in pericolo di vita.
Giovedì 4 febbraio 1993. Polemiche per
blitz Gdf a Montecitorio. La richiesta della Guardia di finanza (del sostituto
procuratore della Repubblica di Milano Gherardo Colombo) alla Camera di
acquisire copie dei bilanci del Psi suscita polemiche: il fallito blitz aveva
per obiettivo il reperimento di carte ufficiali sui bilanci socialisti dal 1985
al ’91, materiale che, almeno fino al ’90, chiunque può ottenere consultando gli
archivi di Montecitorio.
Domenica 7 febbraio 1993. Si
costituisce Larini. Silvano Larini, 57 anni, latitante dal 18 maggio 1992
(“Il latitante d’oro di Tangentopoli”), titolare del “conto Protezione”
appartenente al Psi sul quale la magistratura svizzera ha accolto il 22 gennaio
la richiesta di rogatoria dei giudici milanesi, si costituisce. È praticamente
certo che il suo arrivo nasce da una “trattativa” fra giudici e avvocato, tutto
lascia supporre che sia pronto a parlare: nel primo avviso di garanzia spedito a
Bettino Craxi, la metà dei reati contestati al segretario Psi erano considerati
“in concorso” con Larini e le due posizioni sono intimamente legate.
Mercoledì 10 febbraio 1993. Avviso di
garanzia al ministro Martelli. Tirato in ballo da Silvano Larini, titolare del
“conto Protezione” su cui Roberto Calvi versò sette milioni di dollari, il
socialista Claudio Martelli riceve un avviso di garanzia per concorso in
bancarotta fraudolenta del Banco Ambrosiano (reato di cui si parla anche nella
sesta informazione giudiziaria a Craxi) e si dimette da ministro di Grazia e
giustizia (era il più forte candidato alla successione dello stesso Craxi come
segretario del Psi).
Giovedì 11 febbraio 1993. Craxi si
dimette dalla guida del Psi. Bettino Craxi si dimette da segretario del Psi,
partito che guidava dal 15 luglio 1976. Giovanni Conso è nominato ministro di
Grazia e giustizia (al posto del dimissionario Claudio Martelli).
Sabato 13 febbraio 1993. Avviso di
garanzia per Cagliari (Eni). Gabriele Cagliari, presidente dell’Eni, riceve un
avviso di garanzia per lo scandalo dell’Enimont. L’accusa è “peculato”, i 2.805
miliardi di lire versati per riacquistare le azioni della Montedison paiono ai
magistrati una cifra eccessiva (1.000 miliardi di troppo). Avviso di garanzia
anche per Sergio Castellari, ex direttore generale del ministero delle
Partecipazioni Statali.
Mercoledì 17 febbraio 1993. Arrestata
la segretaria di Craxi. Enza Tomaselli, segretaria di Bettino Craxi, è arrestata
per concorso in corruzione aggravata: l’ha inguaiata Silvano Larini, ex
latitante adesso collaboratore dei giudici che ha raccontato di aver portato
«nella stanza accanto a quella di Craxi, in piazza Duomo 19, tangenti per
sette-otto miliardi». Interrogata dai giudici, la Tomaselli sostiene che a
ritirare quei soldi fu il segretario amministrativo del Psi, Vincenzo Balzamo,
morto d’infarto il 2 novembre 1992. L’ex ministro Gianni De Michelis riceve due
avvisi di garanzia, uno da Milano e uno da Roma. Craxi dice di aver appreso dai
giornali l’invio dell’avviso n° 7.
Venerdì 19 febbraio 1993. Dimissioni
per De Lorenzo e Goria, arresto per Carra. Francesco De Lorenzo (Pli) si dimette
da ministro della Sanità in seguito all’arresto del padre Ferruccio, 89 anni,
presidente dell’Enpam, ai domiciliari con l’accusa di aver intascato una
tangente di un miliardo e settecento milioni; Giovanni Goria (Dc) si dimette da
ministro delle Finanze per le voci sul suo coinvolgimento nello scandalo della
Cassa di risparmio di Asti («accuse ingiuste, non fondate e neppure
argomentate»); Enzo Carra, già portavoce dell’ex segretario della Dc
Arnaldo Forlani, è arrestato dai giudici del pool Mani pulite con l’accusa di
«aver reso false dichiarazioni durante l’interrogatorio del pubblico ministero»:
convocato come testimone dai giudici Di Pietro e Davigo, si è trasformato in
detenuto al termine di un interrogatorio durato oltre cinque ore durante le
quali i due inquirenti hanno cercato invano di sapere da lui i nomi dei
destinatari delle tangenti Enimont.
Lunedì 22 febbraio 1993. Arrestati
Mattioli e Mosconi (Fiat). Francesco Paolo Mattioli, responsabile finanziario
della Fiat, e Antonio Mosconi, amministratore delegato della Toro Assicurazioni,
sono arrestati su richiesta dei giudici di Milano: l’accusa è di concorso in
corruzione e violazione della legge sul finanziamento ai partiti. A tirarli in
ballo è stato Maurizio Prada, cassiere milanese delle mazzette dc, il filone è
quello delle tangenti sul sistema dei trasporti. In un comunicato la Fiat parla
di «vivo stupore» per gli arresti ed esprime a Mosconi e Mattioli «piena
solidarietà» ribadendo «l’assoluta convinzione che i due dirigenti dimostreranno
al più presto la completa estraneità a ogni circostanza venga loro addebitata».
Giovedì 25 febbraio 1993. Trovato il
cadavere di Castellari. Il cadavere di Sergio Castellari, ex direttore generale
del ministero delle Partecipazioni statali coinvolto nelle indagini sulla
maxitangente Enimont, è trovato da due agenti a cavallo su una radura verde in
località Corvino, nella campagna tra Sacrofano e Formello. Scomparso il 17
febbraio, Castellari è morto per un colpo di pistola, la testa morsa dagli
animali rende difficile l’individuazione del foro del proiettile. Resta da
stabilire se si sia trattato di suicidio o omicidio. Orazio Savia, il giudice
che lo accusava, dichiara sconvolto: «Non farò più il pubblico ministero. La
giustizia è così: se si imbatte in un soggetto debole, lo stritola. Lo riduce e
ti riduce, in qualche occasione, in condizioni drammatiche...». Avviso per La
Malfa, arresto per Pesenti. Giorgio La Malfa riceve un avviso di garanzia per
violazione della legge sul finanziamento dei partiti (un contributo di 50
milioni per i manifesti elettorali versato dal finanziere Gianni Varasi) e si
dimette in lacrime da segretario del Pri. L’ingegner Giampiero Pesenti, uno dei
big della finanza italiana, è arrestato per le mazzette promesse nel 1983 dalla
Franco Tosi a Dc e Psi (7 miliardi a testa, respinge le accuse).
Lunedì 1 marzo 1993. Tangentopoli,
arrestato Greganti (Pds). Primo Greganti, 49 anni, ex amministratore del Pci di
Torino adesso iscritto al Pds, è arrestato in base alle dichiarazioni del
manager socialista della Ferruzzi Lorenzo Panzavolta, che lo accusa di avere
intascato una tangente di 621 milioni per conto del Pci. I giudici di Bologna
fanno arrestare Michele De Mita, fratello di Ciriaco, per le vicende legate alla
ricostruzione in Irpinia.
Martedì 2 marzo 1993. De Mita si
dimette. Dopo che il fratello Michele è stato arrestato per le vicende legate
alla ricostruzione in Irpinia, Ciriaco De Mita (Dc) si dimette dalla presidenza
della commissione bicamerale per le riforme istituzionali (al suo posto Nilde
Jotti, Pds).
Venerdì 5 marzo 1993. Tangentopoli, cdm
approva decreto Conso. Il consiglio dei ministri approva un decreto che
depenalizza le violazioni della legge sul finanziamento pubblico dei partiti,
sottrae ai magistrati le inchieste in materia e istituisce un’autorità di
vigilanza. Contro il decreto elaborato dal ministro Giovanni Conso, che appare
all’opinione pubblica un colpo di spugna, si svolgono manifestazioni spontanee e
si pronunciano i giudici di Milano. Scandalo per le manette al Dc Carra. A
Milano Enzo Carra, già portavoce dell’ex segretario della Dc Arnaldo Forlani,
sotto processo con l’accusa di «aver reso false dichiarazioni durante
l’interrogatorio del pubblico ministero», è condotto nell’aula del tribunale in
ferri e catene suscitando l’indignazione di gran parte del mondo politico.
Forlani: «Se la carcerazione preventiva non è applicata correttamente, può
essere come la tortura: i giudici dicono che con questo metodo hanno ottenuto
dei risultati, ma anche la Gestapo li otteneva in questo modo...».
Achille Occhetto, segretario del Pds: «La scena vista in tv mi ha profondamente
turbato».
Lunedì 8 marzo 1993. Tangentopoli,
Scalfaro non firma il decreto Conso. Il presidente della Repubblica
Oscar Luigi Scalfaro rifiuta di controfirmare il decreto Conso: approvato il 5
marzo dal Consiglio dei ministri, prevedeva la depenalizzazione delle violazioni
della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, la sottrazione ai magistrati
delle inchieste in materia, l’istituzione di un’autorità di vigilanza.
Martedì 9 marzo 1993. Arrestato
Cagliari (Eni). Viene arrestato Gabriele Cagliari, presidente dell’Eni: l’accusa
del pool Mani pulite è corruzione aggravata, 4 miliardi di tangenti pagate dal
Nuovo Pignone (Eni) su richiesta dei socialisti Valerio Bitetto e Bartolomeo De
Toma per la fornitura di turbine a gas destinate alle centrali Enel. Con
Cagliari, che si dimette dall’incarico, è arrestato il presidente del Nuovo
Pignone Franco Ciatti. Craxi, autorizzazione a procedere. A Roma la Giunta della
Camera concede l’autorizzazione a procedere contro Bettino Craxi per tutti i
reati contestati: corruzione, violazione della legge sul finanziamento dei
partiti, ricettazione. Saranno possibili anche perquisizioni personali e
domiciliari. Per il definitivo via libera ai giudici servirà però un altro voto
(scrutinio segreto) in aula.
Lunedì 15 marzo 1993. Avviso di
garanzia per Altissimo (Pli). Renato Altissimo riceve un avviso di garanzia e si
dimette da segretario del Pli: l’“informazione” si riferisce a una mazzetta da
50 milioni di lire che l’armatore Giovanni Barbaro gli avrebbe versato come
illecito contributo al partito.
Martedì 30 marzo 1993. Avviso e
dimissioni per il ministro Reviglio. Il ministro delle Finanze Franco Reviglio
si dimette dopo aver ricevuto dal giudice Antonio Di Pietro, al quale si è
presentato spontaneamente, un avviso di garanzia per ricettazione: secondo la
procura milanese, durante il periodo in cui era presidente dell’Eni avrebbe
accettato sei miliardi destinati al Psi di cui conosceva l’illecita provenienza.
Lunedì 5 aprile 1993
Tangentopoli, avvisi per Forlani e Andreotti. I democristiani Giulio Andreotti e
Arnaldo Forlani sono raggiunti da avvisi di garanzia per violazione della legge
sul finanziamento pubblico dei partiti: secondo la Procura di Milano il primo
avrebbe chiesto all’imprenditore Giuseppe Ciarrapico 250 milioni con
destinazione Roberto Buzio, ex segretario di Giuseppe Saragat e tesoriere
occulto del Psdi; il provvedimento contro Forlani è stato provocato dalle
dichiarazioni dell’ex direttore generale dell’Anas Antonio Crespo, che avrebbe
confessato una tangente da un miliardo e 200 milioni “girata” a un uomo di
fiducia dell’ex segretario Dc.
Lunedì 12 aprile 1993. Tangentopoli,
suicidio a Pescara. Valerio Cirillo, 43 anni, consigliere comunale democristiano
di Pescara, si suicida gettandosi dal sesto piano. Indagato e poi prosciolto per
un appalto che ha mandato in carcere quasi tutto il comitato di gestione della
Usl di Pescara di cui faceva parte, lascia un biglietto con scritto: «Sono
innocente, non sono un corrotto».
Venerdì 23 aprile 1993. Romiti si
schiera con il pool di Mani pulite. Dopo che l’Espresso ha rivelato i colloqui
di Cesare Romiti con i magistrati del pool Mani pulite (aperta un’indagine sulla
fuga di notizie), l’amministratore delegato della Fiat scrive una lettera al
Corriere della Sera per chiarire che da qualche settimana «si sono cominciate a
imboccare le vie d’uscita» sulla crisi che sta attraversando il Paese,
aggiungendo che dopo un periodo di inerzia di tutte le istituzioni «sono apparse
di grande rilevanza le iniziative sviluppate dalla magistratura negli ultimi
mesi», «strumento di accelerazione del processo di cambiamento largamente
desiderato». Conclusione: «È apparso evidente che il reale interesse di tutti
quegli imprenditori che fanno veramente industria sia quello di agevolare il più
possibile la piena ricostruzione di quanto avvenuto».
Sabato 24 aprile 1993. Tangentopoli
veneta, suicida ex cassiere Dc. Gino Mazzolaio, 68 anni, ex segretario
amministrativo della Dc di Rovigo, si suicida gettandosi nell’Adige poco lontano
dalla chiesa di Boara Pisani (Padova). Coinvolto in un’inchiesta su alcuni
episodi di corruzione, concussione, turbativa d’asta e violazione della legge
sul finanziamento pubblico dei partiti (appalti per la costruzione di ospedali
in varie località del Veneto), il 16 marzo era stato raggiunto da un ordine di
custodia cautelare firmato dal giudice istruttore del tribunale di Venezia
Carlo Mastelloni su richiesta del sostituto procuratore Carlo Nordio. Lascia
moglie e due figli, cui dedica un biglietto: «Carissimi, non so più resistere a
quanto sta succedendo pur essendo completamente innocente. Vi chiedo scusa per
il gesto che sto per compiere, pregherò per voi da lassù».
Giovedì 29 aprile 1993. La Camera salva
Craxi. La Camera (scrutinio segreto) vota quattro “no” alle richieste di
autorizzazione a procedere avanzate dalla procura di Milano nei confronti
dell’ex segretario del Psi Bettino Craxi: il primo “no” implica per i magistrati
l’impossibilità di ordinare perquisizioni a Roma anche domiciliari e cioè di
mettere le mani su registri, estratti conto, bilanci, contratti e così via (316
no, 245 sì); il secondo “no” riguarda i reati di corruzione continuata e
aggravata commessi a Milano (291-273); il terzo “no” si riferisce alla
ricettazione – consumata a Roma e a Milano – milioni e milioni che sarebbero
finiti nelle tasche dell’ex segretario del Psi e dei quali era nota la
provenienza illecita (307-253); il quarto “no” riguarda un episodio di
corruzione avvenuto in un luogo imprecisato e a una data incerta (304-257). Via
libera alle indagini per un episodio di presunta corruzione avvenuto a Roma
(282-278) e per la ripetuta violazione della legge sul finanziamento dei
partiti, ampiamente ammessa da Craxi (314-244). Di fatto, Craxi viene sottratto
alle richieste inquisitorie del pool di Mani pulite per la stragrande
maggioranza degli episodi criminosi considerati e contestati. In diverse città
si svolgono spontanee manifestazioni di protesta. I ministri del Pds
(Augusto Barbera, Vincenzo Visco, Luigi Berlinguer) e il verde Francesco Rutelli
si dimettono dal governo varato il giorno prima da Carlo Azeglio Ciampi.
Venerdì 30 aprile 1993. Hotel Raphael,
monetine su Craxi. A 24 ore dal “no” della Camera all’autorizzazione a procedere
contro Bettino Craxi, l’ex segretario del Psi è fatto bersaglio di una piogga di
monetine lanciate dai manifestanti che lo aspettano fuori dall’hotel Raphael
(Roma).
Mercoledì 5 maggio 1993. Autorizzazione
a procedere, il voto diventa palese. Dopo le polemiche per i quattro “no” a
scrutinio segreto che il 29 aprile hanno sottratto Bettino Craxi alle inchieste
del pool Mani pulite, la giunta per il regolamento della Camera introduce il
voto palese nell’esame delle autorizzazioni a procedere.
Martedì 11 maggio 1993. Arrestato
Pollini, ex tesoriere del Pci. I carabinieri arrestano Renato Pollini, ex
senatore e fino al 1989 segretario amministrativo del Pci, e Fausto Bartolini,
ex direttore del Conaco (il consorzio delle cooperative rosse di costruzioni),
accusati di corruzione con l’aggravante di aver violato la legge sul
finanziamento dei partiti. I provvedimenti riguardano le tangenti sulle
forniture alle Ferrovie tra l’86 e l’88, un sistema descritto da Giulio
Caporali, ex consigliere pci delle Fs condannato per le “lenzuola d’oro”, che ha
parlato di contributi pagati dalle Coop e imprese private come Sasib, Ansaldo e
Socimi (che avrebbe versato centinaia di milioni su conti esteri del Pci). La
segreteria del Pds respinge ogni coinvolgimento.
Mercoledì 12 maggio 1993. Arrestato
Nobili, presidente dell’Iri. Franco Nobili, presidente dell’Iri, è arrestato a
Roma per corruzione e violazione della legge sul finanziamento pubblico dei
partiti: contro il numero uno della più grande holding pubblica i giudici di
Mani pulite hanno emesso un mandato con nove pagine di contestazioni per il
periodo 1978-1990: tangenti pagate ai partiti per appalti delle centrali Enel di
Brindisi e Montalto.
Mercoledì 19 maggio 1993. Arrestato
Burlando, sindaco di Genova (Pds). Il sindaco di Genova
Claudio Burlando è arrestato con l’accusa di truffa e abuso di atti
d’ufficio: giovane e promettente leader del Pds, è indagato nell’ambito
dell’inchiesta per l’opera colombiana del sottopasso di Caricamento, nella zona
dell’Expo. Finiscono in carcere anche altre sette persone, tra queste il
costruttore edile Emanuele Romanengo, presidente della Sci e del consorzio Irg2,
che ha realizzato l’opera. Burlando è raggiunto anche da un secondo ordine di
custodia cautelare in relazione a un’altra inchiesta sulla mancata realizzazione
di un megaparcheggio in centro.
Domenica 4 luglio 1993. Prodi
interrogato da Di Pietro. Il presidente dell’Iri Romano Prodi viene
interrogato a Milano da Antonio Di Pietro sui rapporti tra l’azienda e i
partiti. Ai giornalisti spiega: «Mi sembra ovvio che chi è stato presidente
dell’Iri per sette anni venga sentito in qualità di persona informata sui
fatti». Prodi, già in carica dal 1982 al 1989, è tornato in carica dopo
l’arresto del suo successore Franco Nobili (12 maggio). Dalla porta chiusa i
giornalisti sentono Di Pietro che urla «...soldi alla Dc....».
Martedì 13 luglio 1993. Arrestato
Garofano (Montedison). Giuseppe Garofano, il “Cardinale” della finanza, ex
presidente della Montedison ricercato da sette mesi per lo scandalo delle
tangenti, è arrestato a Ginevra. Accusato di aver dato 250 milioni alla Dc, gli
avvocati dicono che è pronto a parlare «di tutto e di tutti».
Martedì 20 luglio 1993. Cagliari
suicida a San Vittore. Gabriele Cagliari, 67 anni, ex presidente dell’Eni in
carcere dal 9 marzo (133 giorni), si suicida a San Vittore, soffocato da un
sacchetto di plastica. Il 3 luglio aveva spedito alla moglie Bruna una lettera
arrivata il 5 con l’avvertenza «Da aprire dopo il mio ritorno a casa»: vi
annunciava l’«atto di ribellione» che si apprestava a compiere nel caso in cui i
giudici avessero scelto di tenerlo in galera, un meccanismo studiato a suo dire
«per annichilire e distruggere la persona, non per fare giustizia».
Antonio Di Pietro commenta: «È una sconfitta». Saverio Borrelli: «Purtroppo la
Giustizia nel suo cammino si imbatte in lutti e lascia lutti alle sue spalle...
È un dolore soprattutto per chi guida il carro della giustizia». Il ministro
Giovanni Conso: «Il governo mediterà attentamente sulla questione della custodia
cautelare, per adottare iniziative anche alla luce di quanto risulterà nelle
prossime ore dalle indagini avviate». Alla sede della Dc di piazza del Gesù
(Roma) arriva un fax: «Democristiani, anche solo uno alla volta, ma suicidatevi
tutti. Abbiamo tempo e pazienza. E voglia di godere».
Giovedì 22 luglio 1993. Garofano
coinvolge Gardini. Giuseppe Garofano, ex presidente della Montedison arrestato a
Ginevra il 13 luglio, dichiara che i fondi neri della società erano stati
istituiti da Raul Gardini per pagare le tangenti dell’Enimont.
Venerdì 23 luglio 1993. Suicida
Gardini, in carcere i vertici della Ferruzzi. Raul Gardini, 60 anni, ex leader
del gruppo Ferruzzi, si suicida nella sua abitazione di Milano sparandosi un
colpo alla tempia sul suo letto. Sul comodino lascia un biglietto di sette
parole, l’ultimo messaggio alla moglie, ai figli e alla suocera: «Idina,
Eleonora, Ivan, Maria Speranza, Isa. Grazie». Nessuno ha sentito la detonazione
nell’appartamento del settecentesco Palazzo Belgioioso, in casa c’erano il
figlio Ivan, 24 anni, e il maggiordomo, Franco Brunetti, che alle 8.45 ha aperto
la porta della camera da letto scoprendo il cadavere. Nelle ore successive
scattano gli arresti preannunciati dalle confessioni di Giuseppe Garofano, ex
presidente della Montedison: finiscono in manette Carlo Sama, uomo forte del
gruppo Ferruzzi dopo l’uscita di scena di Gardini; Vittorio Giuliani Ricci,
amministratore della Fermar; Sergio Cusani, finanziere di area socialista; un
quarto ordine di cattura riguarda Giuseppe Berlini, uomo della Ferruzzi in
Svizzera, che si trova a Losanna; il quinto sarebbe stato proprio per Gardini.
Accuse: falso in bilancio, corruzione, violazione del finanziamento ai partiti.
In serata Sama e Cusani vengono portati nel carcere di Opera, Giuliani Ricci
viene rimesso in libertà.
Martedì 24 agosto 1993. Avviso di
garanzia per Stefanini, tesoriere Pds. Marcello Stefanini, tesoriere del Pds,
riceve un avviso di garanzia dal magistrato Tiziana Parenti: riguarda la
tangente pagata da un manager del gruppo Ferruzzi, Lorenzo Panzavolta, a
Primo Greganti, ex funzionario comunista titolare del conto Gabbietta. Per i
lavori alle centrali dell’Enel, Panzavolta versò a Greganti 621 milioni sul
conto svizzero: secondo le confessioni del manager erano per il Pci, secondo
quello che è ormai noto come “il compagno G” erano quattrini elargiti «per
libera scelta» e il Pci non c’entrava nulla. Il senatore Stefanini si dichiara
innocente, il Pds protesta per la violazione del segreto istruttorio.
Venerdì 3 settembre 1993. Enimont,
arrestato il giudice Curtò. Diego Curtò, 68 anni, presidente del Tribunale di
Milano, è il primo magistrato arrestato nell’ambito dell’inchiesta Mani pulite:
è accusato di corruzione aggravata e abuso d’ufficio a fini patrimoniali, 400
mila franchi svizzeri che Vincenzo Palladino, ex custode delle azioni Enimont,
ha raccontato di avergli pagato.
Domenica 19 settembre 1993. Greganti
torna a San Vittore, perquisita sede Pds. Dopo ore di ricerche, Primo Greganti,
l’ex funzionario comunista titolare del conto Gabbietta, si costituisce ai
carabinieri di Castiglione Torinese («ho saputo che i giudici di Milano mi
cercano») e viene ricondotto a San Vittore, dove era già stato recluso dall’1
marzo al 31 maggio, prima di essere scarcerato per decorrenza dei termini (la
detenzione più discussa di tutta l’inchiesta). Stavolta lo accusano di avere
intascato una tangente di 400 milioni, episodio confermato dall’imprenditore
Domenico Gavio, costituitosi nelle stesse ore dopo una latitanza di oltre
tredici mesi. A 24 ore dall’arresto di Marco Fredda, responsabile del patrimonio
del Pds, per la prima volta i carabinieri perquisiscono la sede dell’ex Pci di
via delle Botteghe Oscure.
Lunedì 20 settembre 1993. Tangenti
Sanità, arrestato Poggiolini. Duilio Poggiolini, ex componente del Cip farmaci
ed ex direttore generale del servizio farmaceutico del ministero della Sanità,
ricercato dal 3 luglio nell’ambito dell’inchiesta sulle tangenti per il prezzo
dei medicinali, è arrestato a Losanna in un’azione congiunta della polizia
svizzera, italiana e dell’Interpol: era nascosto in una clinica privata,
ricoverato sotto falso nome, su di lui pendono ben cinque ordinanze di custodia
cautelare per vari episodi di corruzione. Nello scandalo è coinvolta anche la
moglie Pierre De Maria.
Giovedì 30 settembre 1993. Trovato il
“tesoro” di Poggiolini. Aperta la cassaforte di Duilio Poggiolini, ex componente
del Cip farmaci ed ex direttore generale del servizio farmaceutico del ministero
della Sanità arrestato in Svizzera il 20 settembre, il sostituto procuratore di
Napoli Alfonso D’Avino scopre un tesoro stimato in 200-300 miliardi di lire fra
conti bancari, monete, diamanti e altri preziosi: 6.000 sterline d’oro (alcune
risalgono alla prima metà del XIX secolo, le più recenti valgono 130 mila lire
l’una), centinaia e centinaia di Krugerrand sudafricani (560 mila lire l’una),
50 monete dell’antica Roma, alcune delle quali d’oro, recanti le insegne della
gens Antonina e di quella Flavia; 20 diamanti da 1,2 carati ecc.
Giovedì 28 ottobre 1993. Via
all’immunità parlamentare. Dopo un ping pong tra le due Camere andato avanti per
un anno e mezzo con otto votazioni parlamentari, il Senato approva in via
definitiva la riforma dell’immunità parlamentare: mediante la definitiva
modifica dell’art. 68 della Costituzione, l’autorizzazione a procedere a carico
dei parlamentari viene abolita per le indagini e prevista solo per le
perquisizioni, le intercettazioni telefoniche e l’arresto.
Venerdì 29 ottobre 1993. Fondi neri
Sisde, arrestato Malpica. Riccardo Malpica, il prefetto che fino al 1991 ha
diretto il Sisde, è arrestato con l’accusa di concorso in peculato continuato e
aggravato. Il gip Terranova firma anche altri cinque ordini di arresto destinati
a funzionari del Sisde, fra questi Maurizio Broccoletti, ex direttore
amministrativo che 24 ore prima si è presentato in procura con un carico di
documenti (si parla di 49 miliardi finiti in società immobiliari e depositi
all’estero).
Sabato 30 ottobre 1993. Ordine di
custodia per De Benedetti. Carlo De Benedetti, presidente dell’Olivetti, riceve
un ordine di custodia cautelare dai giudici di Roma che indagano sulle forniture
al ministero delle Poste. Ai militari che lo cercano nelle abitazioni di Milano
e Torino viene risposto che è all’estero per il week-end dei Santi e rientrerà
il 2 novembre. Tramite i suoi legali, fa sapere che è pronto a collaborare con i
magistrati.
Martedì 2 novembre 1993. Arresti
domiciliari per De Benedetti. Carlo De Benedetti, presidente dell’Olivetti
colpito da un ordine di custodia cautelare dei giudici di Roma che indagano
sulle forniture al ministero delle Poste, si costituisce all’alba ai carabinieri
di Milano. Condotto nel carcere romano di Regina Coeli, viene interrogato dal
gip Augusta Iannini e dal pm Maria Cordova. A fine giornata gli vengono concessi
gli arresti domiciliari.
Mercoledì 3 novembre 1993. Fondi neri
Sisde, messaggio tv di Scalfaro. Alle 22.30 il presidente della Repubblica
Oscar Luigi Scalfaro respinge con un messaggio televisivo a reti unificate il
tentativo di coinvolgerlo nello scandalo del Sisde: «A questo gioco al massacro
io non ci sto». Secondo Antonio Galati, ex responsabile dei fondi riservati, dal
1982 al 1992 tutti i ministri dell’Interno hanno ricevuto 100 milioni al mese
(unica eccezione Amintore Fanfani).
Martedì 7 dicembre 1993. Arrestato
Patelli, cassiere della Lega. Alessandro Patelli, segretario organizzativo ed ex
cassiere della Lega, viene arrestato per violazione della legge sul
finanziamento pubblico dei partiti, causa un contributo di 200 milioni ricevuto
dal gruppo Ferruzzi alla vigilia delle elezioni 1992. Il mandato di cattura è
stato firmato dal gip Italo Ghitti su richiesta di Antonio Di Pietro. Contro
Patelli ci sono le dichiarazioni di Carlo Sama, ex amministratore del gruppo, e
di Sergio Portesi, responsabile delle relazioni istituzionali della Ferruzzi.
Venerdì 17 dicembre 1993. Processo
Cusani, in aula Craxi e Forlani. Al Palazzo di giustizia di Milano, durante il
processo per le tangenti Ferruzzi Enimont (imputato Sergio Cusani),
Antonio Di Pietro interroga Bettino Craxi, ex segretario del Psi che mostra lo
smalto dei giorni migliori: «I 75 miliardi? Ho letto, ho letto. Ho letto quello
che Sama dice, che ero molto carismatico. E a questo titolo, cioè come omaggio
al mio carisma politico, mi avrebbero messo a disposizione 75 miliardi. Beh, mi
si consenta l’ironia di dire che allora il mio carisma vale 150 volte quello di
Martelli e 200 quello di La Malfa... E una maxipalla questa maxitangente». In
breve: «Tutti sono colpevoli, tutti sapevano». L’ex segretario della Dc
Arnaldo Forlani appare invece pallido e impacciato: la saliva condensata agli
angoli della bocca, tenta di evitare risposte dirette dicendo che non sapeva,
negando anche l’evidenza e scaricando tutto sull’ex tesoriere Severino
Citaristi. I telegiornali mandano in onda la versione pressoché integrale degli
interrogatori.
Mercoledì 13 luglio 1994. Varato il
decreto Biondi. Il governo Berlusconi emana un decreto del ministro della
Giustizia Alfredo Biondi che favorisce gli arresti domiciliari nella fase
cautelare per la maggior parte dei crimini di corruzione. I critici lo chiamano
spregiativamente “decreto salva-ladri”.
Martedì 19 luglio 1994. Ritirato il
decreto Biondi, “Caporetto” del governo. Dopo una settimana di proteste
(l’opposizione, i magistrati, la gente scesa in piazza), il governo lascia
cadere il “decreto Biondi” (“salvaladri”, per i critici) sulla custodia
cautelare, facendolo bocciare dalla commissione Affari Costituzionali. Il
provvedimento pare adesso figlio di nessuno: il ministro della Giustizia
Alfredo Biondi dice che avrebbe preferito un disegno di legge, il ministro
dell’Interno Roberto Maroni avrebbe firmato senza leggere fidandosi della firma
del presidente Scalfaro, che a sua volta si giustifica parlando di “atto
dovuto”. Giuliano Ferrara, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ammette:
«Sì, forse abbiamo peccato di dilettantismo. Ed è vero che la vicenda si è
risolta in una Caporetto».
Venerdì 29 luglio 1994. Arresti
domiciliari per Paolo Berlusconi. Dopo un giorno di latitanza,
Paolo Berlusconi si costituisce. Interrogato per sette ore dai giudici
milanesi, parla dei tre episodi che gli vengono contestati: pagamenti ai
finanzieri che ispezionavano tre società Fininvest (Videotime, Mediolanum,
Mondadori) per un totale di 330 milioni di lire. In serata gli vengono concessi
gli arresti domiciliari.
Martedì 22 novembre 1994. Scoop del
Corriere: invito a comparire per Berlusconi. Il Corriere della Sera rivela che
Silvio Berlusconi, a Napoli per presiedere il vertice internazionale del G7
sulla criminalità organizzata, ha ricevuto dalla Procura di Milano un invito a
comparire: l’ipotesi di reato è concorso in corruzione per le mazzette alla
Guardia di Finanza pagate da Mondadori, Mediolanum e Videotime. Il presidente
del Consiglio accusa i magistrati di aver violato il segreto istruttorio.
Martedì 6 dicembre 1994. Antonio Di
Pietro lascia la magistratura. Finita la requisitoria al processo Enimont,
Antonio Di Pietro, il pm più famoso dell’indagine Mani pulite, annuncia con una
lettera al procuratore capo Francesco Saverio Borrelli l’addio alla
magistratura.
Sabato 3 giugno 1995. Di Pietro nel
registro degli indagati. Antonio Di Pietro sarebbe finito sul registro degli
indagati: nessuno conferma (il registro è teoricamente segreto) ma neppure
smentisce. Il pm di Brescia Fabio Salamone, a capo dell’inchiesta, si limita a
dire: «È una storia delicata di cui non voglio e non posso parlare». L’ex
magistrato di Mani pulite spiega: «Sono stato io stesso a denunciarmi. E a
denunciare. Questa storia dei dossier costruiti nei mie confronti deve finire».
Reato ipotizzato concussione, l’indagine riguarda i soldi che Di Pietro avrebbe
chiesto e ottenuto per ripianare i debiti di gioco di Eleuterio Rea, ex
poliziotto e grande amico del magistrato adesso capo dei vigili urbani milanesi,
600 milioni di lire pagate, secondo le voci, da Giancarlo Gorrini, ex
proprietario della Maa assicurazioni per il cui fallimento è stato condannato a
tre anni e sei mesi. Secondo l’accusa, Di Pietro, all’epoca dei fatti sostituto
procuratore di provincia, sarebbe colpevole anche di appropriazione indebita
causa una Mercedes avuta gratis dalla Maa.
Venerdì 21 luglio 1995. È ufficiale:
Craxi è un latitante. Durante un’udienza nel processo della tangenti pagate per
l’appalto della metropolitana milanese, viene ufficializzata la latitanza di
Bettino Craxi: secondo i magistrati si deve ritenere che l’ex presidente del
Consiglio ed ex segretario del Psi si sia sottratto all’ordinanza di custodia
cautelare, visto che ne è stato abbondantemente informato dai giornali.
Lunedì 20 novembre 1995. La procura
chiede il rinvio a giudizio di Di Pietro. Con le accuse di abuso d’ufficio e
concussione (relative a sette diversi episodi) i pm bresciani Fabio Salamone e
Silvio Bonfigli chiedono il rinvio a giudizio di Antonio Di Pietro. Lo stesso
provvedimento è sollecitato per altri nove indagati, tra cui Paolo Berlusconi e
Cesare Previti, accusati di concorso in concussione.
Giovedì 22 febbraio 1996. Di Pietro:
non luogo a procedere. L’ex magistrato Antonio Di Pietro è prosciolto dalle
accuse di concussione e di abuso d’ufficio (le più gravi): il gip di Brescia
Roberto Spanò decreta il non luogo a procedere perché i fatti non sussistono.
L’accusa più pesante, quella di concussione, riguardava la vicenda del decreto
Gaspari: i pm sostenevano, in sostanza, che Di Pietro nell’89 aveva sfruttato lo
stato di soggezione psicologica di un suo inquisito (il ministro Gaspari) al
fine di ottenere la nomina a direttore del progetto di informatizzazione degli
uffici giudiziari di Milano (decreto che venne approvato dal Consiglio dei
ministri ma che poi – a seguito di vivaci proteste – fu modificato prima della
registrazione alla Corte dei Conti: il nome di Di Pietro fu sostituito con
quello del presidente della Corte d’appello).
Mercoledì 6 marzo 1996. Seconda
vittoria per Di Pietro. Come già il 22 febbraio, il gip di Brescia Roberto Spanò
proscioglie l’ex magistrato di Mani pulite Antonio Di Pietro da due accuse di
concussione e tentata concussione, chiudendo così definitivamente il capitolo
legato all’informatizzazione: i pubblici ministeri accusavano Di Pietro di aver
fatto pressioni, nel ’91, sull’ex vicesegretario regionale della Democrazia
cristiana Francesco Rivolta (da lui inquisito) al fine di diventare capo
dell’ufficio automazione del ministero.
Venerdì 29 marzo 1996. Terza vittoria
per Di Pietro, rinvio a giudizio per i complottatori. Terza vittoria per l’ex
magistrato di Mani pulite Antonio Di Pietro: il gup di Brescia Anna Di Martino
lo scagiona dalle accuse dell’assicuratore Giancarlo Gorrini (vedi 3 giugno
1995): «Non luogo a procedere perché i fatti non sussistono». Vengono invece
rinviati a giudizio i quattro imputati accusati di aver costretto Di Pietro a
lasciare la magistratura (concussione): Paolo Berlusconi, Cesare Previti, Ugo
Dinacci, Domenico De Biase (prosciolti Eleuterio Rea e Paolo Pillitteri).
Secondo i pm Fabio Salamone e Silvio Bonfigli, di fronte alle iniziative di Di
Pietro che aveva alzato il tiro sul presidente del consiglio Silvio Berlusconi
inviandogli un mandato di comparizione (22 novembre 1994), sarebbe scattato un
ricatto: attraverso Paolo Berlusconi e il ministro della Difesa Cesare Previti,
l’assicuratore Giancarlo Gorrini sarebbe stato mandato da Ugo Dinacci, capo
degli ispettori del ministero di Grazia e Giustizia, per raccontare la storia
dei cento milioni e della Mercedes dati a Di Pietro (23 novembre 1994). Subito
dopo – sempre secondo la tesi di Salamone e Bonfigli – ci sarebbero stati una
serie di contatti con Di Pietro e, ottenuto dal magistrato l’impegno a
dimettersi dopo la requisitoria al processo Enimont, l’inchiesta sarebbe stata
rapidamente chiusa chiamando a deporre all’ispettorato Osvaldo Rocca, braccio
destro di Gorrini e amico di Di Pietro, che avrebbe scagionato pienamente il pm
di Mani pulite. Il 6 dicembre l’addio alla toga di Di Pietro avrebbe fatto
rallentare – secondo l’accusa – le indagini su Berlusconi e sulla Fininvest.
Mercoledì 24 aprile 1996. Di Pietro ha
denunciato Salamone e Bonfigli. Si viene a sapere che Antonio Di Pietro ha
denunciato Fabio Salamone e Silvio Bonfigli, promotori delle inchieste su di lui
concluse con tre distinte archiviazioni. In due esposti presentati il 2 e il 22
aprile alla Procura generale di Brescia (e già trasmessi per competenza alla
Procura di Milano, al Csm, alla Procura generale della Cassazione e al ministero
di Grazia e giustizia), oltre a segnalare irregolarità tecniche nelle indagini,
l’ex pm di Mani pulite ha elencato una serie di motivi per i quali Salamone
avrebbe dovuto astenersi dalle inchieste su di lui, sottolineando in particolare
la circostanza – sempre smentita da Salamone – secondo la quale fu proprio Di
Pietro ad avviare le indagini su Filippo Salamone, fratello del magistrato
coinvolto nella Tangentopoli siciliana.
Domenica 15 settembre 1996. Riesplode
Tangentopoli, arrestato Necci (FS). Lorenzo Necci, amministratore delegato delle
Ferrovie dello Stato, è arrestato su richiesta dei magistrati di La Spezia.
Accuse: truffa, associazione per delinquere, falso in bilancio, peculato,
corruzione, abuso in atti d’ufficio. Finiscono in cella anche l’ex deputato dc
Emo Danesi, il banchiere Pierfrancesco Pacini Battaglia e la sua segretaria.
L’inchiesta riguarda l’acquisto da parte delle Ferrovie di quote della società
che gestisce i terminal per container: secondo l’accusa sarebbe stato pagato un
prezzo gonfiato, con fondi girati poi a Necci.
Giovedì 19 settembre 1996. Pacini
Battaglia: «Si è pagato per uscire da Tangentopoli». Uno dei tanti colloqui
captati dalle Fiamme gialle nell’ambito dell’inchiesta che ha portato tra
l’altro all’arresto di Pierfrancesco Pacini Battaglia scatena una polemica che
potrebbe riguardare l’intera portata dell’istruttoria milanese su Tangentopoli:
«Io sono uscito da Mani pulite – dice il banchiere in un nastro dell’11 gennaio
– soltanto perché si è pagato, non cominciamo a rompere i coglioni: quelli più
bravi di noi non ci sono nemmeno entrati, forse se io avessi studiato la strada
prima non sarei nemmeno entrato in Mani pulite». A quel «si è pagato» vengono
date due chiavi di lettura opposte: una, legittimista, l’interpreta come
sinonimo di coinvolgimento penale, Pacini Battaglia a Milano è plurindagato, ha
dovuto chiamare in causa amici, consegnare conti miliardari e subire un
gravissimo danno di immagine. Questo sarebbe il “prezzo pagato”. Il banchiere,
però, è sempre sfuggito all’arresto, viene considerato un maestro del pentimento
a rate, in diversi esposti più o meno anonimi è indicato come «un miracolato».
«Non so esattamente che cosa intendesse con quella frase – replica il
procuratore capo di Milano Francesco Saverio Borrelli – ma se Pacini Battaglia
intende che sono stati pagati dei soldi, si assume tutte le responsabilità. E
sono responsabilità molto gravi, ve lo assicuro». Il pm di Brescia Fabio
Salamone include Pacini Battaglia e il suo avvocato Rosario Lucibello fra i
testimoni chiesti dall’accusa nel processo che si aprirà a Brescia il 23
settembre.
Lunedì 23 settembre 1996. Inizia il
processo sul complotto contro Di Pietro. Alla II sezione del Tribunale di
Brescia inizia il processo contro Paolo Berlusconi, l’ex ministro della Difesa
Cesare Previti, il capo degli 007 del ministero Ugo Dinacci e l’ispettore
Domenico De Biase, accusati di aver ordito un complotto per costringere Antonio
Di Pietro a lasciare la magistratura. Attraverso il suo avvocato Massimo Dinoia,
Di Pietro decide di costituirsi parte civile: in apparenza è una contraddizione,
ma la mossa, spiega il legale riaccendendo vecchie polemiche con i pm, è dettata
dal timore che l’accusa, chiamando a testimoniare persone che nulla hanno a che
vedere con la vicenda, trasformi il dibattimento in un processo a Di Pietro per
fatti dai quali è già stato scagionato. I pm Fabio Salamone e Silvio Bonfigli si
oppongono alla richiesta, ma il tribunale, presieduto da Francesco Maddalo,
accoglie la costituzione di parte civile. Di Pietro al Tg1: nessun favore a
Pacini Battaglia. A poche ore dall’inizio del processo bresciano contro i
presunti autori del complotto che lo avrebbe costretto a lasciare la
magistratura, l’ex pm di Mani pulite Antonio Di Pietro concede una lunga
intervista (un monologo) al Tg1 con la quale respinge le accuse del banchiere
Pierfrancesco Pacini Battaglia, che in una telefonata intercettata dalla Guardia
di Finanza ha detto di aver pagato per evitare la galera (vedi 19 settembre
1996). Intervista di Antonio Di Pietro al Tg1, lunedì 23 settembre 1996.
«Preferisco mantenere il riserbo anch’io, perché voglio capire che succede. Ma
una cosa è certa: non c’è mai stato alcun interesse privato, personale, tra noi
e Pacini Battaglia e quindi lui se ha delle cose da dire le dica per dissolvere
tutti i dubbi. Altra cosa certa: se qualcuno dice che con Pacini Battaglia
abbiamo usato i guanti di velluto, si sbaglia di grosso. Esistono quintali di
documenti, lo abbiamo ascoltato per decine di ore, lo abbiamo interrogato almeno
venti volte. All’epoca svelò fatti di eccezionale rilevanza sia dal punto di
vista qualitativo che quantitativo. Ora tutti sanno che cosa è Tangentopoli, ma
all’epoca bisognava scavare, scavare. Certo Pacini Battaglia, come quasi tutti
gli inquisiti di Tangentopoli, ha detto solo una parte di quello che sapeva, ma
non potevamo mica torturarlo. Ho letto che si vanta di aver avuto
un’archiviazione a Milano. Non è vero. Io ho lasciato la procura il 7 dicembre e
non il 6 perché come ultimo atto ho chiesto il rinvio a giudizio di Pacini
Battaglia. A Milano è stato inquisito diverse volte, io ho chiesto decine e
decine di rogatorie in Svizzera proseguite dai miei colleghi... Dice una
mostruosità chi afferma che Pacini ha avuto un trattamento di favore, e se si
dice che lo abbiamo fatto per motivi diversi si dice una calunnia. Ho l’animo
esacerbato. Ho i pubblici ministeri di Brescia che si oppongono a che io mi
costituisca parte civile, ho una campagna diffamatoria che vuol fare passare
l’inchiesta di Mani pulite per un’inchiesta a metà. Chi come me ha vissuto
quell’inchiesta e l’ha fatto con tutta la dedizione possibile si sente offeso e
credo che offesi si sentano anche i miei colleghi quando si sentono attaccati. A
loro va la mia solidarietà. Ho sentito dire che sarei stato io, quel giorno di
marzo del ’93, a mandare via sbrigativamente Pacini. Quell’interrogatorio non
l’ho fatto io e non sono stato io a rimettere in libertà Pacini Battaglia. Chi
ha preso la decisione l’ha presa perché aveva il parere positivo di tutti i
colleghi dopo l’apporto collaborativo di Pacini Battaglia».
Giovedì 10 ottobre 1996. Scalpore per
nuove intercettazioni Pacini Battaglia. Vengono diffuse le trascrizioni di nuove
intercettazioni telefoniche che hanno per protagonista il banchiere
Pierfrancesco Pacini Battaglia, arrestato il 15 settembre nell’ambito
dell’“Operazione container” (l’inchiesta dei magistrati di La Spezia che ha
fatto finire in carcere pure Lorenzo Necci, amministratore delegato delle
Ferrovie dello Stato). Si tratta di virgolettati nei quali Pacini Battaglia
parla di amicizie utili fra i magistrati di Milano, di Roma e di Brescia,
pronuncia una frase che nella trascrizione suona inquietante («A me Di Pietro e
Lucibello mi hanno sbancato»), accenna a un misterioso conto estero intestato a
Mazzoleni, cognome della moglie e del suocero del magistrato simbolo di Mani
pulite. Parlando di Di Pietro e dell’avvocato Rosario Lucibello (suo difensore),
Pacini Battaglia dice all’avvocato Marcello Petrelli: «Se li arrestano per me è
solo un piacere». Di Pietro, ministro dei Lavori pubblici del governo Prodi,
replica con una denuncia depositata nella caserma dei carabinieri di La Spezia:
«Escludo che io o i miei familiari abbiamo una lira all’estero». Lucibello
denuncia lo «stillicidio sospetto» e l’«inaccettabile metodo della
estrapolazione di frasi» che porta a uno «stravolgimento» del significato
complessivo delle intercettazioni.
Giovedì 17 ottobre 1996. Salamone
rimosso dall’inchiesta su Di Pietro. Dopo sei mesi di battaglia a colpi di
esposti, istanze e memorie, Antonio Di Pietro riesce a bloccare il sostituto
procuratore Fabio Salamone, il magistrato autore delle indagini su di lui che
dopo tre proscioglimenti voleva “rifargli il processo”: il procuratore generale
di Brescia Marcello Torregrossa rimuove Salamone (e con lui Silvio Bonfigli)
dalla funzione di pubblico ministero nel processo sul presunto complotto per
costringere l’ex pm di Mani pulite a lasciare la magistratura, la motivazione è
ravvisata in una «grave inimicizia» fra Di Pietro e Filippo Salamone, fratello
del pm. Al posto di Salamone e Bonfigli, Torregrossa designa Raimondo Giustozzi,
che tra lo sconcerto generale si presenta in aula consegnando al presidente
Francesco Maddalo copia del provvedimento della procura generale che – a quanto
si dice – non ha precedenti nella storia giudiziaria.
Giovedì 14 novembre 1996. Di Pietro si
dimette da ministro. Con una lettera a Palazzo Chigi, Antonio Di Pietro si
dimette da ministro dei Lavori pubblici del governo Prodi. Lettera di dimissioni
di Antonio Di Pietro, giovedì 14 novembre 1996. «Sig. Presidente, ho da poco
saputo dal Tg5 che sarei stato sottoposto ad indagini dalla Procura della
Repubblica di Brescia, per un insieme di fatti a me non noti sia perché non li
ho commessi sia perché nessuno me ne ha dato notizia. Sono anni ormai che vengo
sottoposto ad indagini ed accertamenti di ogni tipo – legali ed illegali –
sempre ingiustamente come dimostrano le numerose sentenze di proscioglimento che
mi riguardano. Eppure il tiro al piccione continua perché mi si deve far pagare
ad ogni costo l’unica mia vera colpa (di cui peraltro sono orgoglioso): aver
voluto fare ad ogni costo e fino in fondo il mio dovere. A questo punto dico:
“Basta!”. Basta, con certi magistrati invidiosi e teorizzatori! Basta, con
organi investigativi iperzelanti e fantasiosi! Basta, con la stampa che crea le
notizie prima ancora che accadano! Basta, con i calunniatori prezzolati che
mettono tutti sulla stessa barca solo per salvare i loro mandanti! Basta, con
quegli avvocati che non hanno saputo accettare i verdetti dei giudici ed oggi
cercano scuse per giustificare le loro sconfitte processuali! Basta, dar spazio
e credito a imputati rancorosi e vendicativi! Basta, soprattutto, con chi vuole
usare la mia persona per delegittimare per un verso l’inchiesta Mani pulite e
per l’altro il Governo e le Istituzioni! Tolgo il disturbo e non risponderò più
ad alcuna provocazione. Buon Futuro. Antonio Di Pietro. P.S.: Ti prego vivamente
di non propormi alcun invito al ripensamento, perché le mie dimissioni sono
irrevocabili, come testimonia questa mia doppia firma».
Lunedì 25 novembre 1996. Borrelli: «Di
Pietro disse: “Berlusconi lo sfascio io”». Nonostante siano passati ormai quasi
due anni (6 dicembre 1994), il clamoroso addio di Antonio Di Pietro al pool Mani
pulite fa ancora discutere: al processo di Brescia sul presunto complotto per
farlo dimettere, Francesco Saverio Borrelli, procuratore capo di Milano,
racconta che Di Pietro sostenne fino all’ultimo l’invio dell’avviso di
comparizione all’allora premier Silvio Berlusconi (22 novembre 1994), al punto
da promettere «poi in aula ci vado io e a quello lo sfascio».
Mercoledì 29 gennaio 1997. Di Pietro,
il complotto non ci fu. La Procura di Brescia sentenzia che non ci fu complotto
contro l’ex pm di Mani pulite Antonio Di Pietro per indurlo a lasciare la
magistratura: dopo due giorni di camera di consiglio, Cesare Previti,
Paolo Berlusconi, Ugo Dinacci e Domenico De Biase sono assolti perché «il fatto
non sussiste».
Giovedì 18 febbraio 1999. Nuova
assoluzione per Di Pietro. Sotto processo per corruzione, l’ex pm di Mani pulite
Antonio Di Pietro è assolto dal Gip di Brescia Anna De Martino «perché il fatto
non sussiste». Vengono assolti anche il banchiere tosco-svizzero
Pierfrancesco Pacini Battaglia (secondo l’accusa ne aveva comprato i favori),
l’avvocato Giuseppe Lucibello (secondo l’accusa aveva asseritamente beneficiato
dei favori) e il costruttore Antonio D’Adamo, l’imprenditore sulle cui
confessioni la Procura di Brescia aveva riposto buona parte del destino
dell’inchiesta. In lacrime alla proclamazione del verdetto, poco dopo Di Pietro
è colto da un lieve malore che lo costringe a un passaggio dal pronto soccorso.
Mercoledì 19 gennaio 2000. Muore
Bettino Craxi. Ad Hammamet (Tunisia) muore Bettino Craxi: nato a Milano il 24
febbraio 1934, dal 15 luglio 1976 all’11 febbraio 1993 era stato segretario del
Psi, dal 4 agosto 1983 al 17 aprile 1987 presidente del Consiglio.
Carriera politica terminata causa l’indagine Mani pulite, nel 1994 aveva
lasciato l’Italia (prima che, il 12 maggio, gli venisse ritirato il passaporto).
Era stato condannato con sentenza passata in giudicato a 5 anni e 6 mesi per
corruzione nel processo Eni-Sai (12 novembre 1996), a 4 anni e 6 mesi per
finanziamento illecito per le mazzette della metropolitana milanese (20 aprile
1999); in primo grado era stato condannato a 4 anni e una multa di 20 miliardi
di lire per il caso All Iberian (13 luglio 1998, pena poi prescritta in appello
il 26 ottobre 1999), a 5 anni e 5 mesi per le tangenti Enel (22 gennaio 1999);
in appello era stato condannato a 5 anni e 9 mesi per il conto protezione
(sentenza poi annullata dalla Cassazione con rinvio il 15 giugno 1999), in
appello bis a 3 anni per il caso Enimont (1 ottobre 1999). Era stato inoltre
rinviato a giudizio per i fondi neri Montedison (25 marzo 1998) e per i fondi
neri Eni (30 novembre 1998).
Nota di lettura: per problemi
di spazio, non sono stati inseriti nella cronologia tutti gli esiti processuali
dei personaggi coinvolti nell’inchiesta Mani pulite, bisogna però tenere
presente che alcuni degli arrestati sono stati poi assolti nelle aule di
tribunale.
Mani pulite. Da Wikipedia,
l'enciclopedia libera. L'espressione Mani pulite designa una controversa
stagione degli anni novanta in Italia, caratterizzata da una serie di indagini
giudiziarie condotte a livello nazionale nei confronti di esponenti della
politica, dell'economia e delle istituzioni italiane. Le indagini portarono alla
luce un sistema di corruzione, concussione e finanziamento illecito ai partiti
ai livelli più alti del mondo politico e finanziario italiano detto
Tangentopoli. Furono coinvolti ministri, deputati, senatori, imprenditori,
perfino ex presidenti del Consiglio. Le inchieste furono inizialmente condotte
da un pool della Procura della Repubblica di Milano (formato dai magistrati
Antonio Di Pietro, Piercamillo Davigo, Francesco Greco, Gherardo Colombo,
Tiziana Parenti, Ilda Boccassini e guidato dal procuratore capo Francesco
Saverio Borrelli e dal suo vice Gerardo D'Ambrosio) e allargate a tutto il
territorio nazionale, diedero vita ad una grande indignazione dell'opinione
pubblica e di fatto rivoluzionarono la scena politica italiana. Partiti storici
come la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista Italiano, il PSDI, il PLI
sparirono o furono fortemente ridimensionati, tanto da far parlare di un
passaggio ad una Seconda Repubblica.
Origine dell'espressione. Il primo ad
usare l'espressione Mani pulite fu il politico italiano Giorgio Amendola,
deputato per il Partito Comunista Italiano, in un'intervista a Manlio Cancogni
pubblicata da Il Mondo, il 10 luglio 1975, in risposta alle critiche che
venivano mosse all'onestà nella gestione delle amministrazioni pubbliche allo
stesso PCI: «Ci hanno detto che le nostre mani sono pulite perché non l'abbiamo
mai messe in pasta. Come se non si potessero avere dei grandi affari
amministrando l'opposizione in una certa maniera». L'espressione Mani pulite
fu ripresa e usata, poi dal giornalista e scrittore italiano Claudio Castellacci
in un libro dal titolo omonimo pubblicato nel 1977. Tre anni più tardi il
presidente della Repubblica Sandro Pertini, in un discorso ai giovani, tenuto
nel 1980, disse: «Chi entra in politica, deve avere le mani pulite». In
un'accezione ristretta, l'indagine "Mani pulite" è quella gemmata dal "fascicolo
virtuale" (n. 9520) aperto alla Procura della Repubblica presso il tribunale di
Milano nel 1991 dal pool omonimo. In un'accezione allargata, di "Mani pulite" si
parla anche per le altre indagini per reati contro la pubblica amministrazione
condotte nello stesso periodo dalla procura di Milano (es. ENI-Sai) e, più in
generale ancora, in tutte le altre procure italiane che diedero corso nel
medesimo periodo ad indagini contro il malaffare in politica (si parlò di "Mani
pulite" napoletana per le indagini contro Francesco De Lorenzo, Antonio Gava e
Cirino Pomicino, di "Mani pulite" romana per le indagini su Moschetti, di "Mani
pulite" genovese, piemontese, ecc.).
17 febbraio 1992: la scoperta di Tangentopoli. Mario Chiesa, il
"mariuolo isolato". «Tutto
era cominciato un mattino d'inverno, il 17 febbraio
1992, quando, con un mandato d'arresto,
una vettura dal lampeggiante azzurro si era fermata al Pio Albergo
Trivulzio e prelevava il presidente, l'ingegner
Mario Chiesa, esponente del Partito Socialista
Italiano con l'ambizione di diventare sindaco di
Milano. Lo pescano mentre ha appena intascato
una bustarella di sette milioni, la metà del pattuito, dal proprietario di una
piccola azienda di pulizie che, come altri fornitori, deve versare il suo obolo,
il 10 per cento dell'appalto che in quel caso
ammontava a 140 milioni.» Tangentopoli cominciò il 17 febbraio 1992. Il
pubblico ministero Antonio Di Pietro chiese ed ottenne dal GIP Italo Ghitti un
ordine di cattura per l'ingegner Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo
Trivulzio e membro di primo piano del PSI milanese. Chiesa era stato colto in
flagrante mentre intascava una tangente dall'imprenditore monzese Luca Magni
che, stanco di pagare, aveva chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Magni,
d'accordo coi carabinieri e con Di Pietro, fece ingresso alle 17:30 nell'ufficio
di Mario Chiesa, portando con sé 7 milioni di lire, corrispondenti alla metà di
una tangente richiestagli da quest'ultimo; l'appalto ottenuto dall'azienda di
Magni era infatti di 140 milioni e Chiesa aveva preteso per sé il 10%, quindi
una tangente da 14 milioni. Magni aveva un microfono e una telecamera nascosti
e, appena Chiesa ripose i soldi in un cassetto della scrivania, dicendosi
disponibile a "rateizzare" la transazione, nella stanza irruppero i militari,
che notificarono l'arresto. Chiesa, a quel punto, afferrò il frutto di un'altra
tangente, stavolta di 37 milioni, e si rifugiò nel bagno attiguo, dove tentò di
liberarsi del maltolto buttando le banconote nel water; ma invano. La notizia
fece scalpore e finì sulle prime pagine dei quotidiani e dei telegiornali.
Bettino Craxi, leader dello stesso PSI, con l'obiettivo di ritornare alla
presidenza del Consiglio, dopo le elezioni politiche di primavera, negò,
intervistato dal Tg3, l'esistenza della corruzione a livello nazionale,
definendo Mario Chiesa un mariuolo isolato, una "scheggia impazzita"
dell'altrimenti integro Partito Socialista che "in cinquant'anni di
amministrazione a Milano, non aveva mai avuto un solo politico inquisito per
quei reati".
L'allargamento delle indagini anticorruzione e le elezioni del
1992. Rinchiuso nel carcere di San Vittore, Chiesa in
un primo momento non confessò. Il PM Di Pietro che, nelle indagini
sull'ingegnere aveva scoperto e messo sotto sequestro due conti svizzeri,
"Levissima" e "Fiuggi", chiamò al telefono l'avvocato di Chiesa, Nerio Diodà, e
gli disse: « Avvocato, riferisca al suo cliente che
l'acqua minerale è finita.» Così, sotto interrogatorio, Chiesa rivelò che
il sistema delle tangenti era molto più esteso rispetto a quanto affermato da
Craxi. Secondo le sue dichiarazioni, la tangente era diventata una sorta di
"tassa", richiesta nella stragrande maggioranza degli appalti. A beneficiare del
sistema erano stati politici e partiti di ogni colore, specialmente quelli al
governo come appunto la DC e il PSI. Chiesa fece anche i nomi delle persone
coinvolte. Vista la delicata situazione politica, in piena campagna elettorale,
Antonio Di Pietro mantenne sulle indagini il più assoluto riserbo, mentre alcune
formazioni come la Lega Nord iniziarono a cogliere la sempre più crescente
indignazione popolare per raccogliere voti (con lo slogan "Roma ladrona!").
Altre, come la Dc, sottovalutarono il "peso politico" di Mani Pulite e altri
ancora come Bettino Craxi accusarono la Procura di Milano di muoversi dietro un
«...preciso disegno politico». Le elezioni di aprile furono segnate dal crescere
dell'astensione e dell'indifferenza della popolazione nei confronti di una
politica chiusa e ingabbiata negli stessi schemi dai tempi del dopoguerra,
incapace di rinnovarsi malgrado gli epocali cambiamenti storici di quegli anni.
Il calo di consensi investì quasi tutti i maggiori partiti: la DC calò dal
34,3 % al 29,6; il PSI, che nelle precedenti consultazioni aveva toccato i suoi
massimi storici, scese di un punto percentuale; PRI, PLI e PSDI conservarono le
loro posizioni. Il PDS e PRC, eredi del disciolto PCI, persero complessivamente
un quarto dei voti. I veri vincitori delle elezioni furono la Lega Nord e La
Rete, due formazioni di recente fondazione, sviluppatesi una nell'Italia
settentrionale, l'altra nel Meridione, che registrarono un vero e proprio
boom, facendo della moralizzazione e del rinnovamento politico dei veri e
propri cavalli di battaglia. Subito dopo le elezioni, molti industriali e
politici furono arrestati con l'accusa di corruzione. Le indagini iniziarono a
Milano, ma si propagarono velocemente ad altre città, man mano che procedevano
le confessioni. Una situazione grottesca accadde quando un politico socialista
confessò immediatamente tutti i propri crimini a due carabinieri che erano
arrivati a casa sua, per poi scoprire che i militari erano venuti semplicemente
per notificargli una multa. Fondamentale, per questa espansione esponenziale
delle indagini, fu la diffusa tendenza dei leader politici a privare del proprio
appoggio i politici meno importanti che venivano arrestati; questo fece sì che
molti di questi si sentissero traditi e spesso accusassero altri politici, che a
loro volta ne accusavano altri ancora. Nel Parlamento che si formò, il
quadripartito (DC, PSI, PSDI e PLI) conservava comunque la maggioranza assoluta
dei seggi ma l'ondata di arresti e di avvisi di garanzia lo indebolirono
fortemente. Quando, a maggio, le Camere appena riunite furono chiamate a
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, le votazioni si tennero in un
clima di caos totale (in quegli stessi giorni veniva ucciso il giudice Giovanni
Falcone) e fu affossata dapprima la candidatura di Arnaldo Forlani, poi quella
di Giulio Andreotti. Alla fine, fu eletto il democristiano Oscar Luigi Scalfaro,
candidato dei "moralizzatori". Scalfaro si rifiutò di concedere incarichi ai
politici vicini agli inquisiti: Bettino Craxi, che aspirava a tornare alla
presidenza del Consiglio, dovette rinunciare in favore di Giuliano Amato. Ad
agosto, Craxi attaccò Di Pietro sull'Avanti!, organo del suo partito:
«Non è tutto oro quello che luccica. Presto scopriremo che Di Pietro è
tutt'altro che l'eroe di cui si sente parlare. Ci sono molti, troppi aspetti
poco chiari su Mani Pulite». Il 2 settembre 1992 il politico socialista Sergio
Moroni si uccise. Lasciò una lettera in cui si dichiarava colpevole, affermando
che i crimini commessi non erano per il proprio tornaconto ma a beneficio del
partito, e accusò il sistema di finanziamento di tutti i partiti. Bettino Craxi,
segretario del PSI molto legato a Moroni, si scagliò contro stampa e
magistratura sostenendo che si fosse creato un "clima infame". La figlia Chiara,
politicamente impegnata nel centrodestra negli anni a seguire, sarebbe divenuta
una delle voci più critiche nei confronti di Mani Pulite. A settembre viene resa
nota un'indagine della Procura di Brescia su un ex ufficiale dei carabinieri che
avrebbe girato l'Italia per raccogliere notizie compromettenti sulla vita
privata di Di Pietro. Due suoi amici avrebbero ricevuto offerte in denaro per
rivelare che il magistrato avrebbe fatto uso di droga. L'indagine venne
archiviata. Secondo alcune dichiarazioni dello stesso Craxi, il capo della
polizia, Vincenzo Parisi, lo avrebbe incontrato e gli avrebbe riferito che era
in possesso di tabulati telefonici su contatti fra Di Pietro e l'avvocato
Giuseppe Lucibello su un loro "misterioso" viaggio in Svizzera.
La reazione dell'opinione pubblica.
L'opinione pubblica, dopo l'iniziale smarrimento, si schierò in massa dalla
parte dei PM: la giustificazione stessa della legge sul finanziamento pubblico
ai partiti veniva percepita come priva di senso, visto che per anni era stata
spiegata con le necessità di sostentamento della politica ed ora si scopriva che
ciò non aveva fatto venir meno la corruzione. Nacquero comitati e movimenti
spontanei, furono organizzate fiaccolate di solidarietà con il pool, sui
muri comparvero scritte come "W Di Pietro", "Di Pietro non mollare", "Di Pietro
facci sognare" e "Di Pietro tieni duro!". Si diffusero persino slogan come
"Tangente, tangente. E i diritti della gente?" o "Milano ladrona, Di Pietro non
perdona!", o anche "Colombo, Di Pietro: non tornate indietro!"; vennero
distribuiti orologi rappresentanti "l'ora legale". Nei sondaggi dell'epoca, la
popolarità di Di Pietro e del pool raggiunse la percentuale record
dell'80%, la cosiddetta "soglia dell'eroe".
1993: tentativi di resistenza. La pioggia di avvisi di garanzia.
Nelle elezioni locali di dicembre si confermò la crisi dei partiti tradizionali:
la DC e il PSI persero ciascuno circa la metà dei voti. Le inchieste
proseguirono e si estesero in tutta Italia, offrendo un panorama di corruzione
diffusa dal quale nessun settore della politica nazionale o locale appariva
immune. Politici e imprenditori di primissimo piano furono inquisiti e travolti
da una pioggia di avvisi di garanzia. Tra questi anche Bettino Craxi, che a
febbraio dovette dimettersi da segretario del Partito Socialista. Una mole
ingentissima di procedimenti (72) furono intentati anche contro il tesoriere DC
Severino Citaristi. Sulla spinta delle crescenti proteste popolari, il governo
Amato s'impegnò a sollecitare le dimissioni di ogni suo componente raggiunto da
un avviso di garanzia. Le inchieste toccarono inevitabilmente anche molti
ministri, tanto che l'esecutivo raggiunse una percentuale di dimissioni senza
precedenti. Dopo alcune affermazioni di Umberto Bossi, circa il coinvolgimento
di un personaggio di altissimo livello, gli stessi ambienti della Procura
milanese divulgarono una "velina" alla stampa in cui si precisava che nessuna
delle supreme cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidenti di
camera e Senato, Presidente del consiglio) era nel mirino delle inchieste in
corso. Le indagini fecero emergere anche l'esistenza di conti personali, dove
venivano dirottati i soldi delle tangenti, che venivano sfruttate quindi non
soltanto per sostenere le spese dei partiti. Ad esempio, come avrebbe sancito la
sentenza della Corte d'Appello di Milano del 26 ottobre 1999, Bettino Craxi
utilizzò i fondi provenienti dalle mazzette oltre che per pagare «gli stipendi
dei redattori dell'Avanti!», anche per una serie di impieghi inequivocabilmente
personali:« Non ha alcun fondamento la linea difensiva
incentrata sul preteso addebito a Craxi di responsabilità ‘di posizione’ per
fatti da altri commessi, risultando dalle dichiarazioni di Tradati che egli si
informava sempre dettagliatamente dello stato dei conti esteri e dei movimenti
che sugli stessi venivano compiuti, e dispose prelievi sia a fine di
investimento immobiliare (l’acquisto di un appartamento a New York), sia per
pagare gli stipendi dei redattori dell’Avanti!, sia ancora per versare alla
stazione televisiva Roma Cine Tivù (la denominazione legale di GBR
di cui era direttrice generale Anja Pieroni,
legata a Craxi da rapporti sentimentali) un contributo mensile di cento milioni
di lire. Lo stesso Craxi dispose poi l’acquisto di una casa e di un albergo in
Roma, intestati alla Pieroni». A febbraio, il socialista Silvano Larini
si costituì e confessò la verità sul "conto protezione", che aveva come reale
destinatario il Partito Socialista nelle persone di Martelli (percettore
materiale) e Craxi; Martelli si dimise da Ministro della giustizia e si sospese
dal partito, pregiudicandosi ogni possibilità di succedere a Craxi, che in
quelle ore era dimissionario da segretario nazionale. Martelli sarà poi
condannato in appello nel 2001. Nelle nuove elezioni amministrative del 6 giugno
1993 il Pentapartito conobbe un pesante tracollo: la DC perse nuovamente metà
dei voti e il Partito Socialista praticamente sparì. La Lega Nord divenne la
maggior forza politica dell'Italia settentrionale, conquistando anche la città
di Milano, dove fu eletto sindaco Marco Formentini. L'opposizione di sinistra si
avvicinava alla maggioranza, ma mancava ancora di unità e di comando. La Falange
Armata, formazione eversiva di destra sospettata di legami con i servizi segreti
deviati, mandò il primo messaggio di morte al pool. Secondo le
dichiarazioni di alcuni pentiti, la mafia progettava di eliminare Di Pietro, per
un favore da ricambiare verso un politico del Nord.
Il decreto Conso: il "colpo di spugna".
Il 5 marzo 1993, il governo varò un decreto legge (il decreto
Conso, da Giovanni Conso, il Ministro della Giustizia che lo propose), che
depenalizzava il finanziamento illecito ai partiti e definito per questo il
"colpo di spugna". Il decreto, che recepiva un testo già discusso e approvato
dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, conteneva un controverso
articolo che dava alla legge un valore retroattivo, e che quindi avrebbe
compreso anche gli inquisiti di Mani Pulite. L'allarme che le inchieste di
Tangentopoli rischiavano di insabbiarsi fu lanciato dal pool milanese in
televisione: l'opinione pubblica e i giornali gridarono allo scandalo e il
Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro per la prima volta nella storia
repubblicana rifiutò di firmare un decreto-legge, ritenendolo incostituzionale.
Conso diede le dimissioni; pochi giorni dopo il referendum del 18 aprile
1993 (promosso dal democristiano dissidente Mario Segni), gli elettori votarono
in massa a favore dell'introduzione del sistema maggioritario. Fu un segnale
politico molto forte della sempre più crescente sfiducia nei confronti della
politica tradizionale; il governo Amato, intravedendo nel risultato del
referendum un segnale di sfiducia nei suoi confronti, rassegnò le dimissioni
il 21 aprile. Il Parlamento non riuscì a formare un nuovo governo politico:
Scalfaro decise perciò di affidare ad aprile la presidenza del Consiglio al
governatore della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi, il quale costituì un
governo tecnico, il primo nella storia d'Italia. Ciampi si pose due obiettivi
fondamentali: una nuova legge elettorale che doveva essere scritta "sotto
dettatura" del referendum (approvata alla fine dell'anno, introduceva un
sistema per tre quarti maggioritario) e il rilancio dell'economia (che stava
vivendo una difficilissima stagnazione, con la lira precipitata ai minimi
storici).
La contestazione a Craxi. Il 30 aprile
la Camera dei deputati negò l'autorizzazione a procedere nei confronti di
Bettino Craxi, uno degli inquisiti più celebri di Tangentopoli. Il giorno prima
Craxi si era presentato nell'aula e in un discorso ammise di aver ricevuto
finanziamenti illeciti ma si giustificò sostenendo che i partiti non potevano
sorreggersi con le entrate legali e attaccò l'ipocrisia di coloro che,
all'interno del Parlamento, sostenevano le tesi dei magistrati, ma in realtà
anche loro avevano beneficiato del sistema delle tangenti. Mentre il presidente
della Camera, Giorgio Napolitano, leggeva i risultati delle votazioni, contrari
all'autorizzazione, i deputati della Lega Nord e del MSI insultarono i colleghi
dando loro dei "ladri" e degli "imbroglioni". La mancata autorizzazione scatenò
una reazione violentissima: diversi ministri del neonato governo diedero le
dimissioni per protesta (tra di loro Francesco Rutelli e Vincenzo Visco).
Studenti dei licei romani manifestarono per le strade della Capitale, alcune
Università furono occupate, in molte città le sedi del PSI furono assalite dai
manifestanti; la stessa sezione nazionale in Via del Corso fu oggetto di una
sassaiola, scongiurata da alcune cariche della polizia. Nel pomeriggio i partiti
di sinistra (PDS, Verdi, Partito della Rifondazione Comunista e altri) indissero
una manifestazione a Piazza Navona, mentre il MSI ne allestì una parallela
davanti a Montecitorio: entrambe chiedevano lo scioglimento delle Camere. Al
termine delle manifestazioni, un gruppo di persone si avvicinò all'Hotel
Raphael, nel centro di Roma, che era la residenza capitolina di Craxi. Quando il
leader socialista uscì dall'albergo, i manifestanti gli lanciarono oggetti di
ogni tipo, soprattutto monetine; altri sventolavano banconote (gridando:
«Bettino, vuoi pure queste?»), e nel frattempo venivano scanditi slogan contro
il politico socialista che auspicavano il carcere («Bettino, Bettino il carcere
è vicino») o addirittura il suicidio.
Il caso degli emoderivati infetti. Nel
1993 Duilio Poggiolini e altri importanti personaggi della sanità di allora
vennero indagati per un giro di corruzione a vari livelli, incluse bustarelle
delle case farmaceutiche Bayer e Baxter per il commercio di flaconi di sangue
intero ed emoderivati infetti con AIDS ed epatiti presi da tossicodipendenti,
galeotti e persone con rischiose attività sessuali. Le persone, che in
conseguenza di questo sono state infettate durante le trasfusioni, si sono
costituite parte lesa durante i processi.
La "stagione dei suicidi" e gli attacchi a Di Pietro.
A metà marzo fu reso pubblico uno scandalo per 250 milioni di dollari,
riguardante l'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI). Il flusso di accuse, arresti e
confessioni non si arrestò. Nel frattempo, Di Pietro chiese una rogatoria sui
conti di Craxi a Hong Kong. La Falange Armata inviò una nuova minaccia: «...gli
uccideremo il figlio». A giugno venne arrestato il primo manager Fininvest, Aldo
Brancher. Secondo Marco Travaglio, il 12 luglio Silvio Berlusconi inviava un fax
a Il Giornale, di cui era proprietario, intimando di «sparare a zero sul
pool». Ma i condirettori Indro Montanelli e Federico Orlando si rifiutarono. Il
17 luglio 1993 Il Sabato, settimanale di Comunione e Liberazione,
pubblicò un dossier sulla corruzione nella politica della prima Repubblica, sul
fatto che la magistratura ne sarebbe stata al corrente e sulle presunte
malefatte di Di Pietro, il quale sarebbe stato in combutta con diversi
imprenditori, che in cambio di denaro avrebbe protetto dalle indagini. Il
dossier, che indagava sulle proprietà immobiliari e patrimoniali di Di Pietro
accresciute in modo esponenziale, era attinto da un manoscritto del giornalista
Filippo Facci circolato in forma anonima all'inizio del 1993 dopo essere stato
acquistato da un fantomatico editore irlandese; i suoi contenuti si sarebbero
riversati nelle campagne giornalistiche contro il pool condotte negli
anni successivi, come il dossier Achille e gli altri addebiti che in sede
giudiziaria furono confutati, quando a partire dal 1995 varie sentenze
giudicarono infondate quelle campagne scandalistiche. Il GICO di Firenze
concluse le indagini sull'Autoparco di Milano e sulle protezioni accordate dalla
mafia: con questi addebiti nell'autunno 1993 la Procura di Firenze ordinò tre
mesi di arresti tra gli ufficiali di polizia che collaboravano con il pool
di Milano. Il rapporto del Gico cita, a sostegno della richiesta di arresti,
anche un «collaboratore», Salvatore Maimone, autore di accuse anche a tre
sostituti procuratori milanesi. Maimone poi dichiarò che le accuse ai pm gli
erano state sollecitate ed in ogni caso il processo agli ufficiali di polizia si
concluse con le loro assoluzioni. Il 20 luglio 1993, l'ex-presidente dell'ENI,
Gabriele Cagliari, da oltre 4 mesi di carcere preventivo, si uccise, dopo aver
scritto una lettera in cui accusava i PM di Milano di tenerlo in carcere con
l'intento di farlo confessare; in seguito, sua moglie restituì oltre 6 miliardi
di lire di fondi illegali. Tre giorni dopo si uccise con un colpo di pistola
anche Raul Gardini, presidente del gruppo Ferruzzi-Montedison. Gardini aveva
saputo dal suo avvocato che stava per essere coinvolto nelle indagini di Mani
pulite sulla tangente Enimont. Alcuni ipotizzarono che il suicidio di Gardini
abbia avuto tra le cause scatenanti, oltre al tentativo di eludere il proprio
coinvolgimento nel caso Enimont, anche l'intento di non esporsi a collegamenti
con Cosa Nostra che stavano emergendo dalle indagini; altri ancora ipotizzarono
addirittura che il suicidio fosse in realtà un omicidio premeditato negli
ambienti politici e che si inscrivesse in un disegno di copertura della
corruzione cui appartenne anche il presunto suicidio di Sergio Castellari.
Le tangenti rosse. Il sostituto
procuratore Tiziana Parenti, da poco nel pool milanese, nel marzo 1993
divenne il PM delle "tangenti rosse" al PCI-PDS con le accuse al parlamentare
Marcello Stefanini, tesoriere del Pds, per le tangenti versate dal gruppo
Ferruzzi a Primo Greganti, il cosiddetto "compagno G".
Il processo Cusani. Nel frattempo
iniziò il processo a Sergio Cusani. Cusani era accusato di reati collegati ad
una joint venture tra ENI e Montedison, chiamata Enimont, nella quale
aveva fatto da agente di collegamento tra Raul Gardini e il mondo politico
nazionale: la sua fedeltà alla memoria del suo vecchio patron,
tragicamente defunto, fu probabilmente l'unico argine ad un'ennesima chiamata di
correità dei politici, comunque inquisiti per le dichiarazioni convergenti degli
altri manager del gruppo Ferruzzi (Garofalo e Sama). Ecco perché il
giudizio abbreviato, chiesto a sorpresa dall'imputato e celermente concesso
dalla Procura, si trasformò in un'insperata occasione di confrontare il silenzio
di Cusani con le prove a suo carico, mostrando come esse fossero sufficienti ad
un impianto accusatorio che avrebbe poi retto alla prova anche del successivo
troncone del processo ENIMONT. Il processo fu trasmesso in diretta dalla Rai,
registrando ascolti record: celebri furono gli accesi scontri verbali fra Di
Pietro e l'avvocato di Cusani, Giuliano Spazzali, durante i quali il magistrato
impiegava il suo colorito linguaggio popolare (il cosiddetto "dipietrese"), che
ne aumentarono la popolarità e l'affetto del popolo e sarebbe diventato una
delle sue caratteristiche più famose. Cusani non era una figura di primo piano,
ma nell'affare Enimont erano coinvolti molti politici di primo piano e molti di
loro furono chiamati a deporre come testimoni. Tra questi, l'ex Presidente del
Consiglio, Arnaldo Forlani, che, rispondendo ad una domanda, disse semplicemente
«Non ricordo». Nelle fotocolor e nelle riprese video fatte dai
giornalisti, Forlani appariva molto nervoso e sembrava non rendersi conto della
goccia di saliva che si accumulava sulle sue labbra; questa immagine assurse a
simbolo dell'assenza di self control di chi era per la prima volta
chiamato a rendere conto delle proprie azioni. Bettino Craxi, invece, ammise che
il suo partito aveva ricevuto i fondi illegali, anche se negò che ammontassero a
93 milioni di dollari. La sua difesa fu, ancora una volta, che «lo facevano
tutti» ma la sua deposizione, al contrario delle precedenti, non venne
interrotta dal pubblico ministero d'udienza, Antonio Di Pietro, il quale reagì
alle critiche per questa sua inusuale condotta processuale, dichiarando alla
stampa che per la prima volta vi era stata una piena confessione. Anche la Lega
Nord e il disciolto PCI, che sostenevano pubblicamente i magistrati e le loro
inchieste, furono coinvolti nelle chiamate in correità: sulla base di queste,
nel successivo processo ENIMONT Umberto Bossi e l'ex tesoriere Alessandro
Patelli furono condannati per aver ricevuto 200 milioni di finanziamenti
illegali, mentre le condanne di Primo Greganti e di alcuni esponenti milanesi
toccarono il partito comunista solo marginalmente. Nel processo emerse anche,
che una valigia contenente denaro era pervenuta in Via delle Botteghe Oscure,
nella sede nazionale del PCI, ma le indagini si erano arenate ,dato che non si
erano trovati elementi penalmente rilevanti nei confronti di persone fisiche. In
proposito il Pubblico Ministero Antonio Di Pietro disse: «La responsabilità
penale è personale, non posso portare in giudizio una persona che si chiami
Partito di nome e Comunista di cognome». Alcuni detrattori di Di Pietro
ritengono tuttavia che il PM non abbia fatto il possibile per individuare i
componenti del PCI responsabili di corruzione: ipotesi che Di Pietro liquida
come «un'autentica falsità».
1994: La guerra tra Berlusconi e Di Pietro.
Le Fiamme sporche. Nel frattempo, le indagini si allargarono oltre i confini
della politica: il 2 settembre 1993, fu arrestato il giudice milanese Diego
Curtò. Il 13 marzo 1994, Il Giornale - che dopo le dimissioni polemiche
di Montanelli era passato in mano a Vittorio Feltri - associò il nome di Curtò e
dell'imprenditore Salvatore Ligresti ai magistrati del pool, Davigo, Di
Pietro e Francesco Di Maggio. Sarebbero stati tutti soci di una cooperativa
edilizia. Feltri fu poi condannato per diffamazione, in quanto quella
cooperativa non era mai esistita. Il 15 la Falange Armata minaccia di nuovo Di
Pietro: «Gli metteremo il tritolo sotto la macchina». Il 21 aprile, 80 uomini
della Guardia di Finanza (fu per questo coniato il termine "fiamme sporche") e
300 personalità dell'industria furono accusate di corruzione. A giugno si scoprì
che nell'inchiesta delle "Fiamme sporche" era coinvolta anche la Fininvest.
Alcuni giorni dopo, un manager della Fiat ammise la corruzione con una
lettera a un giornale. Lo stesso giorno, Berlusconi denunciò al PG di Milano,
Giulio Catelani, presunti abusi del pool nelle perquisizioni negli uffici
di Publitalia.
Il decreto Biondi. Nel 1994, Silvio
Berlusconi entrava in politica (con le sue parole, "scende in campo") e a fine
marzo il suo partito vinse le elezioni. Poco dopo la vittoria, Berlusconi
propose pubblicamente a Di Pietro di entrare a far parte del suo governo come
Ministro dell'Interno e a Davigo come Ministro della Giustizia, ma entrambi
rifiutarono. Nel 2006, Berlusconi negò di aver mai chiesto ai due magistrati di
entrare nel suo governo. Nel corso del 1993 ed a seguito della sua testimonianza
al processo Cusani, emersero sempre più prove contro Bettino Craxi: con la fine
della legislatura e l'abolizione dell'autorizzazione a procedere, si fece sempre
più vicina la prospettiva di un suo arresto. Il 15 aprile 1994, con l'inizio
della nuova legislatura in cui non era stato ricandidato, cessò il mandato
parlamentare elettivo e, di conseguenza, venne meno l'immunità dall'arresto. Il
12 maggio 1994 gli venne ritirato il passaporto per pericolo di fuga, ma era già
troppo tardi perché Craxi, come si seppe solo il 18 maggio, era già ad Hammamet,
in Tunisia; il 5 maggio era stato avvistato a Parigi. Il 21 luglio 1995 Craxi fu
dichiarato ufficialmente latitante. Il 13 luglio 1994 il governo emanò un
decreto legge (cosiddetto "decreto Biondi" - dall'allora Ministro della
Giustizia Alfredo Biondi - spregiativamente soprannominato dai critici
"salva-ladri") che favoriva gli arresti domiciliari nella fase cautelare per la
maggior parte dei crimini di corruzione. Il decreto fu votato lo stesso giorno
in cui alle semifinali della Coppa del Mondo, l'Italia sconfiggeva la Bulgaria.
Questa coincidenza alimentò il sospetto che si volesse sfruttare un momento in
cui l'opinione pubblica era distratta dai Mondiali. Qualche giorno dopo furono
diffuse le prime immagini dei politici accusati di corruzione, che uscivano dal
carcere per effetto del decreto Biondi. Fra le scarcerazioni più clamorose vi fu
quella dell'ex Ministro della Sanità Francesco De Lorenzo, che venne persino
contestato da un gruppo di giovani mentre raggiungeva la sua abitazione nel
centro di Roma. L'uscita di De Lorenzo dal carcere provocò numerose polemiche in
quanto la gente trovava particolarmente odiosi i furti ai danni del Servizio
Sanitario Nazionale. che avrebbero rispettato le leggi dello Stato, incluso il
così detto "decreto Biondi", ma che non potevano lavorare in una situazione di
conflitto tra il dovere e la loro coscienza, chiedendo, con un comunicato letto
da Di Pietro in diretta televisiva, di venire "assegnati ad altri incarichi".
L'opinione pubblica insorse indignata: il cosiddetto "popolo dei fax" comunicò
il proprio dissenso alle redazioni dei giornali e delle televisioni. Alleanza
Nazionale e la Lega Nord, alleati di Berlusconi, minacciarono di togliere la
fiducia all'esecutivo. Il decreto viene frettolosamente ritirato: si parlò in
effetti di un "malinteso" e il Ministro dell'Interno, Roberto Maroni, sostenne
che non aveva nemmeno avuto la possibilità di leggerlo. Secondo una
dichiarazione di Roberto Maroni, il decreto sarebbe stato ispirato dal ministro
della Difesa Cesare Previti, avvocato di Berlusconi. Il 28 luglio venne
arrestato Paolo Berlusconi, fratello del premier, con l'accusa di
corruzione.
La denuncia contro il pool.
A settembre, il Ministro per i Rapporti col Parlamento
Giuliano Ferrara annuncia la sua intenzione di denunciare il pool per
attentato alla Costituzione. Verrà denunciato solo Borrelli e in seguito
assolto. Il 29 settembre, Sergio Cusani denunciò i giudici del pool per
diffamazione e d'omissione d'atti d'ufficio. Il generale Giuseppe Cerciello,
imputato nello scandalo delle "fiamme sporche", denunciò Borrelli, Colombo e Di
Pietro al CSM per presunte manovre intorno al Gip Andrea Padalino. I processi
dimostreranno che queste accuse erano tutte invenzioni. Di Pietro prosegui le
sue indagini nei confronti di Berlusconi: il 3 ottobre venne arrestato Giulio
Tradati, altro manager Fininvest, il fratello Paolo fu rinviato a
giudizio. Vennero scoperte nuove prove sui "fondi segreti" di Craxi, tra cui una
super-tangente di 10 miliardi di lire di Berlusconi al leader socialista,
tramite la società offshore All Iberian. Il 14 ottobre il ministro Biondi
fece partire la prima ispezione contro i magistrati. Per gli ispettori, le
inchieste del pool erano tutte corrette. La Falange inviò nuove minacce:
«Di Pietro ha i giorni contati. La sua vita è destinata a finire presto». Il 18
novembre i magistrati trovarono, perquisendo l'abitazione del dirigente di
Canale 5, Massimo Berruti, la prova che Berlusconi avrebbe ordinato di inquinare
le prove sulla corruzione Fininvest. Il 21 novembre, su ordine di Borrelli, i
carabinieri notificavano per telefono a Berlusconi l'invito a comparire e gli
comunicarono due dei tre capi d'imputazione a lui attribuiti. La notizia venne
rivelata in esclusiva l'indomani dal Corriere della Sera e il Cavaliere
accusò i magistrati di aver violato il segreto istruttorio, passando la notizia
al giornale. Si scoprirà poi che erano state fonti vicine al premier a passare
la notizia al Corriere. Le indagini della procura di Brescia videro i magistrati
prosciolti dall'accusa di violazione del segreto (perché il segreto cade nel
momento in cui l'interessato viene a conoscenza dell'invito a comparire) e le
accuse di Berlusconi archiviate. Il 23 novembre l'assicuratore Giancarlo
Gorrini, si recò al Ministero della Giustizia e denunciò Di Pietro: lo avrebbe
ricattato e avrebbe preteso da lui un prestito di 100 milioni senza interessi,
una Mercedes, l'affidamento alla moglie, l'avvocato Susanna Mazzoleni, di tutte
le cause della sua compagnia, l'accollo tutti i debiti contratti alle corse
ippiche da un certo Eleuterio Rea. Il 24, Biondi avviò un'inchiesta parallela e
segreta sul magistrato. Ma il capo degli ispettori, Dinacci, confidò al giudice
De Biasi (incaricato di condurre l'inchiesta) che «Previti ha detto di
distruggere Di Pietro e che Gorrini era stato pagato». Il 26 novembre, Di Pietro
venne avvertito dallo stesso Previti che al Ministero gli stavano preparando una
"polpetta avvelenata". Dopo essersi consultato con i colleghi del pool,
Di Pietro decise di redigere una memoria da inviare al Csm. Poi cambiò idea e il
6 dicembre, dopo l'ultima requisitoria per il processo Enimont, si dimise dalla
magistratura. Fu la fine di Mani pulite. Qualche giorno dopo cade il governo
Berlusconi. L'inchiesta sulle "fiamme sporche" venne trasferita dalla Corte di
Cassazione a Brescia. De Biasi archiviò l'inchiesta su Di Pietro, scagionandolo
completamente: «I fatti non hanno nessuna rilevanza disciplinare».
1995: i complotti contro Di Pietro e i magistrati.
A febbraio la denuncia di Cusani contro Di Pietro fu archiviata
dal Giudice per le indagini preliminari di Brescia. Viene sventato un attentato
contro Gerardo D'Ambrosio. Il Gico di Firenze riaprì l'inchiesta Autoparco. Alla
Procura venne consegnato un dossier di 263 pagine, con accuse precise contro i
magistrati Di Maggio, Nobili, Armando Spataro e Ilda Boccassini. La Procura
archiviò poi, definitivamente, l'inchiesta. In primavera viene riportato da
alcuni giornali che Di Pietro si candiderà alla Camera dei deputati nelle liste
del Polo delle Libertà. Di Pietro, dopo alcuni incontri con Berlusconi e
Previti, negò un suo prossimo ingresso in politica, chiarendo che non avrebbe
appoggiato alcun partito. Il 7 aprile Di Pietro venne denunciato dall'avvocato
Carlo Taormina e dal generale Cerciello per presunte pressioni su un maresciallo
dei carabinieri affinché denunciasse Berlusconi e Cerciello. Il maresciallo
smentisce tutto e l'accusa viene archiviata dal GIP di Brescia. Il 13 aprile
Berlusconi sostiene in un'intervista che Di Pietro gli avrebbe confidato che non
condivideva affatto l'invito a comparire stilato contro di lui, ma l'ormai ex pm
smentisce.
Nuove ispezioni contro il pool.
Il 5 maggio, il Ministro della Giustizia Filippo Mancuso
annunciò una nuova ispezione a Milano. I giudici avrebbero fatto pressioni sugli
ispettori, già inviati da Biondi, affinché scagionassero il pool. Venne
aperta un'inchiesta anche sui suicidi di Gabriele Cagliari e di Sergio Moroni.
Le ispezioni scagionarono totalmente il pool e nella relazione, Mani
Pulite viene difesa per «l'estrema correttezza dell'azione dei magistrati». Il
procuratore generale Catelani avviò un'indagine informale contro Borrelli. Un
settimanale aveva pubblicato le foto del magistrato impegnato a cavalcare un
cavallo con la siglia G.G., la quale corrisponderebbe a Giancarlo Gorrini. In
realtà il cavallo apparteneva a Giovanni Gennari, figlio del noto finanziere
Giuseppe Gennari, colui che nel 1992 fu protagonista della scalata alla Banca
Nazionale dell'Agricoltura (BNA); Borrelli denunciò Catelani al Csm. Il 20
maggio Berlusconi e altri dirigenti Fininvest sono rinviati a giudizio con
l'accusa di aver corrotto la Guardia di Finanza.
Le accuse di Salamone. È a giugno del
1995 che le accuse contro Di Pietro toccarono il culmine. Il PM bresciano Fabio
Salamone interrogò Gorrini e Paolo Pillitteri, quindi iscrisse Di Pietro nel
registro degli indagati per concussione: avrebbe premuto sugli imprenditori
Gorrini e D'Adamo affinché si accollassero i debiti di Rea. L'11 giugno Di
Pietro venne inquisito per un'altra concussione ai danni di Gorrini (un prestito
di 100 milioni, una Mercedes e un pacchetto sinistri dell'assicurazione di
Gorrini a favore dello studio della moglie dell'ex pm, Susanna Mazzoleni). Il 19
sempre Salamone indagava Di Pietro per abuso d'ufficio e per pressioni sui
politici milanesi per far diventare Rea il comandante dei vigili urbani
milanesi. Il quotidiano Il Giornale pubblicò un nuovo scoop contro
Davigo: il magistrato sarebbe stato membro di una cooperativa diretta dal
generale Cerciello, accusato di corruzione. In realtà Davigo aveva lasciato la
cooperativa subito dopo l'ingresso di Cerciello. Berlusconi presentò un esposto
alla Cassazione per presunte fughe di notizie ai suoi danni e per l'accanimento
persecutorio del pool nei confronti delle sue aziende. Il 20 giugno si
diffuse la falsa notizia che Di Pietro sarebbe stato arrestato. Poco dopo, il 30
giugno, Bettino Craxi dalla Tunisia inviava un lungo fax a tutte le redazioni
dei giornali in cui riportava i tabulati telefonici che gli aveva consegnato
Parisi e si dichiarava disponibile a farsi interrogare da Salamone. In una
lettera al Giornale, Craxi spiegò che «...le recenti inchieste stanno
dimostrando che Mani Pulite era tutta un bluff. Avevo ragione io quando
sostenevo che Di Pietro era manovrato». In una successiva missiva, Craxi
denunciò un viaggio di Di Pietro in Costarica, durante il quale egli avrebbe
concordato con "alti esponenti della finanza internazionale" le indagini di Mani
Pulite. Si scoprirà poi che Di Pietro fu mandato colà per ragioni di sicurezza,
in quanto un pentito aveva rivelato che la mafia voleva ucciderlo.
Il dossier Achille e il caso Dinacci.
Nel settembre 1995 Di Pietro denunciò due agenti della sua scorta: anziché
proteggerlo, riferivano ad altri i suoi spostamenti. Denunciò anche l'agente del
Sismi, Roberto Napoli, che confessò di averlo spiato su ordine dei servizi
segreti (il cosiddetto "dossier Achille" ordinato da un mandante sconosciuto per
infangare il pool) dalla fine del 1992. Nel frattempo però Di Pietro
ricevette nuove accuse: avrebbe pagato un affitto a prezzi stracciati per un
appartamento nel centro di Milano e per abuso d'ufficio nel piano
d'informatizzazione della procura di Milano, da lui diretto alla fine degli anni
ottanta. Accuse di ogni tipo (tra cui il falso ideologico e l'abuso d'ufficio)
arrivarono anche contro Davigo, Borrelli, Colombo e altri magistrati milanesi. A
novembre la Procura della Repubblica di Roma indagò contro Borrelli, Davigo,
Colombo e il GIP Italo Ghitti, perché avrebbero ricattato il capo degli
ispettori ministeriali, Ugo Dinacci, tramite un'inchiesta su suo figlio Filippo.
1996: il pool viene scagionato.
Fra la fine e l'inizio del nuovo anno, Di Pietro e il pool vennero via
via scagionati da tutte le accuse. Già a dicembre 1995, il GIP di Brescia
archiviò tutte le inchieste di Salamone. Quest'ultimo venne anzi censurato e
denunciato al Csm: era il fratello di un uomo fatto condannare da Di Pietro a 18
mesi di carcere. Il 16 gennaio 1998 Salamone venne condannato definitivamente
dal Csm. Il 29 marzo, il Gip di Brescia assolse Di Pietro per tutti i reati a
lui ascritti (in particolare per le accuse di Gorrini) con la formule: "i fatti
non sussistono". La Corte d'Appello confermò successivamente questa sentenza il
9 luglio 1997. La sentenza, inoltre, accusava Gorrini di aver concordato le
varie accuse contro Di Pietro insieme a Paolo Berlusconi e a Sergio Cusani. I
sottufficiali dei carabinieri Giovanni Strazzeri e Felice Corticchia vennero
condannati per calunnia nei confronti di Di Pietro. Salamone ha successivamente
denunciato Di Pietro per diffamazione, ma la sua citazione fu successivamente
rigettata dal tribunale civile di Roma il 13 ottobre 2003. In quello stesso anno
(il 1996) si tennero le nuove elezioni politiche anticipate: vince la coalizione
di centrosinistra de L'Ulivo. Romano Prodi era il nuovo presidente del Consiglio
e Di Pietro entrò nel suo governo come Ministro dei Lavori Pubblici. Si dimise
pochi mesi dopo perché raggiunto da nuove accuse. Definitivamente prosciolto,
nel 1997, si candidò al Senato per il centro-sinistra, nel collegio del Mugello
rimasto vacante. Venne eletto con oltre il 66% dei consensi battendo
l'avversario del Polo, Giuliano Ferrara.
Il dopo-Mani pulite. L'apparente
trionfo della "rivoluzione dei giudici" (che si disse aver prodotto una "Seconda
Repubblica" in Italia) si dimostrò di breve durata. Fra la metà degli anni '90
ed i primi anni del nuovo secolo la questione della corruzione politica calò
nell'ordine delle priorità dell'azione pubblica. Simbolo drammatico di questo
ritorno al passato fu il suicidio dell'imprenditore brianzolo Ambrogio Mauri,
regolarmente escluso dagli appalti per la fornitura di automezzi perché si
rifiutava di pagare tangenti, il 21 aprile 1997.
La strategia della prescrizione. Dopo
il 1994 il rischio che i processi venissero cancellati a causa della
prescrizione divenne molto concreto e la cosa era chiara sia ai giudici che ai
politici. Durante questo periodo alcuni scrittori e commentatori politici
ritennero d'individuare una comune volontà di opporsi alla magistratura da parte
di entrambe le coalizioni politiche. Secondo questi opinionisti - che all'epoca
denunciarono un'asserita alleanza politica di fatto contro la magistratura - sia
il Polo sia l'Ulivo (specialmente sotto la leadership di Massimo D'Alema)
avrebbero ignorato le richieste del sistema giudiziario di finanziamenti per
acquistare equipaggiamenti. Secondo gli stessi autori, inoltre, le riforme
giudiziarie promosse dal centrosinistra avrebbero reso i già penosamente lenti
processi italiani ancora più lenti e avrebbero reso più facile e frequente la
caduta in prescrizione di numerosi reati. Al contrario, la totalità della
dottrina ha salutato positivamente l'intento del legislatore di introdurre
nell'ordinamento italiano i principi del primato del contraddittorio e della
parità delle armi tra accusa e difesa - entrambi tipici dei sistemi giuridici
delle democrazie liberali europee - pur manifestando talvolta qualche riserva in
merito alla sua implementazione in concreto.
Craxi e Previti. I destinatari più
illustri delle inchieste condotte dalla magistratura milanese ebbero sorti
diverse. Craxi accumulò diversi anni di condanne definitive e scelse la
latitanza - secondo i suoi sostenitori, l'esilio volontario - ad Hammamet in
Tunisia, dove risiedette dal 1994 fino alla sua morte, avvenuta il 19 gennaio
2000. Nel 1998 invece Cesare Previti, ex manager Fininvest e parlamentare
nelle fila del partito fondato da Berlusconi, evitò il carcere grazie
all'intervento del Parlamento, anche se Berlusconi e i suoi alleati erano
all'opposizione. Il procedimento proseguì e produsse una condanna per corruzione
in atti giudiziari, confermata dalla Cassazione, con la conseguenza della
decadenza dalla carica di deputato nel 2007, a seguito della perdita dei
requisiti di elettorato passivo.
Le elezioni successive al 2001: le vittorie di Berlusconi e
l'affermazione elettorale di Di Pietro. Le elezioni
politiche del 2001 segnarono una nuova vittoria di Silvio Berlusconi e della
Casa delle Libertà, la coalizione che lo sosteneva, i quali ebbero la meglio
sull'Ulivo e sul suo candidato Francesco Rutelli. L'esito elettorale fu
considerato un segnale importante della nuova considerazione che Mani pulite
aveva, a distanza di dieci anni, nell'opinione pubblica: un atteggiamento
indifferente se non ostile per quella che venne considerata una stagione chiusa.
Persino i politici, che all'inizio degli anni novanta avevano sostenuto
apertamente il pool cambiarono idea: la Lega Nord denunciò un uso abusivo
e prevaricatore della giustizia da parte di certa magistratura, Gianfranco Fini
riconobbe i meriti dei giudici nel saper eliminare un sistema corrotto, ma
sostenne che essi non avevano saputo fermarsi entro i propri confini. Antonio Di
Pietro è oggi presidente dell'Italia dei Valori e ha posto al centro della sua
battaglia politica i valori della legalità e della moralizzazione delle
istituzioni. L'ex pubblico ministero (dopo che nel 2000 aveva rotto con la
coalizione di centrosinistra per non dare il suo voto di fiducia al governo di
Giuliano Amato, che per Di Pietro aveva ostacolato come premier le sue
indagini), corse da solo con il movimento "L'Italia dei Valori", ma nonostante
avesse conseguito il 3,9% dei suffragi, in base alla legge elettorale, non
riuscì ad entrare in Parlamento. L'ingresso avvenne poi, nel 2006, a seguito
della vittoria elettorale di Prodi, che lo nominò di nuovo Ministro, e fu
confermato nel 2008 dalla scelta di Veltroni di consentire solo all'IDV
l'apparentamento con il suo Partito Democratico.
Statistiche su Mani pulite. L'inchiesta
Mani pulite, durata due anni e condotta da cinque magistrati, ha portato a 1300
fra condanne e patteggiamenti definitivi. Gli autori del libro Mani pulite,
la vera storia (2002) affermano che dei 430 assolti nel merito (il 19%), non
tutti sono stati riconosciuti estranei ai fatti. Alcuni imputati (gli autori
citano come esempio 250 imputati per le tangenti riguardanti la Cariplo) pur
avendo commesso il fatto, non sono stati ritenuti punibili: i giudici hanno
ritenuto il fatto commesso, ma li hanno assolti con la formula «il fatto non
costituisce reato» in quanto non vennero considerati pubblici ufficiali. In
quest'ottica gli assolti perché riconosciuti estranei ai fatti contestati
scenderebbero a circa 150 (il 6%). Gli autori aggiungono inoltre che di quei 150
molti sono stati assolti grazie alle riforme giudiziarie dell'Ulivo, che tramite
l'art. 513 c.p.p. (giudicato poi incostituzionale) e la riforma denominata
«giusto processo», hanno invalidato le prove di vari procedimenti. Vi è tuttavia
da dire che nel momento in cui vi è una promessa corresponsione in denaro o
altra utilità ad una persona perché questa ponga in essere un determinato atto,
non vi è alcun reato, a meno che quest'ultima non sia appunto un pubblico
ufficiale, nel qual caso possono profilarsi i reati di corruzione o concussione.
Viceversa, come sembra essere avvenuto nella maggioranza dei processi di Mani
Pulite conclusisi con l'assoluzione, la questione attiene ai rapporti tra
privati cittadini che non integrano in alcun modo il fatto-reato. È stato infine
sottolineato da autorevole dottrina come l'orientamento della magistratura nel
suo complesso sia stato, in quel periodo, particolarmente rigorista in ambito di
reati contro la pubblica amministrazione: ciò che sarebbe stato permesso, tra
l'altro, dalla peculiare indeterminatezza di fondo della fattispecie di
concussione (art. 317 c.p.), ritenuta suscettibile di rilievi di
incostituzionalità. È stata infatti ricondotta a "concussione" anche la condotta
del pubblico ufficiale che aveva ricevuto danaro da privati senza aver
esercitato su di loro alcun tipo di pressione, limitandosi a beneficiare degli
effetti dell'operato di chi l'aveva preceduto nella carica (cosiddetta
concussione ambientale). Un tale rigorismo è stato difeso dall'ex
procuratore Gerardo D'Ambrosio, ancora tre lustri dopo:
«Se avessimo ragionato così negli anni 90 non ci sarebbe stata Mani Pulite.
Tutti coloro che indagavamo dicevano che facevano le cose per migliorare la
situazione, ma noi abbiamo scoperto che invece la peggioravano con appalti
inutili e vuoti. Il principio di legalità va difeso sempre e comunque.»
Il costo delle tangenti. Nel 1992
l'economista Mario Deaglio calcolò la ricaduta economica del giro di tangenti
sui conti dello Stato, e quindi, in definitiva, sulle tasche dei cittadini.
Infatti, la lievitazione dei costi degli appalti, finalizzata all'ottenimento
dei margini fraudolenti, nonché i lavori inventati ex novo per generare il giro
di tangenti, ha una ripercussione rilevante sui costi che lo Stato si accolla
nei lavori pubblici, tale che, in alcuni casi, l'esborso per le opere pubbliche
viene ad essere due, tre, quattro e più volte il corrispettivo per analoghe
opere pubbliche realizzate in altri paesi europei. Deaglio ha stimato che il
giro delle tangenti generasse orientativamente:
10 000 miliardi di lire annui di costi per i cittadini;
un indebitamento pubblico fra 150 000 e 250 000 miliardi di lire;
tra 15 000 e 25 000 miliardi di interessi annui sul debito.
Di fatto, il 1992 fu un anno drammatico per i conti dello Stato. Il rapporto
debito/PIL superò il 105%[41]. Il 13 agosto 1992 l'agenzia Moody's
declassò il rating italiano ad Aa2 per via dell'insicurezza degli investimenti
realizzabile in Italia in quel momento.[42] Per porre un argine alla
bancarotta, il governo Amato fu costretto a varare, nell'autunno di quell'anno,
una finanziaria pesantissima per l'epoca: 92 000 miliardi di tasse, con in
aggiunta il prelievo forzato del 6 per mille su tutti i conti correnti bancari
italiani, considerato il vero e proprio "scontrino finale" di Tangentopoli.
La critica storiografica. La rivalutazione di Mani pulite.
Mani pulite è tuttora al centro di un ampio dibattito
storiografico e politico. Le inchieste sono state difese e rivalutate da molti
sostenitori della politica pulita come Beppe Grillo, Marco Travaglio e Peter
Gomez, che hanno scritto libri e articoli in difesa dei magistrati. Molti hanno
visto in Mani pulite una "rivoluzione pacifica della società civile",
riprendendo una definizione di Indro Montanelli.
La proposta di Commissione parlamentare di inchiesta.
Fin dal 1992 venne proposta l'istituzione di una Commissione
parlamentare d'inchiesta su Tangentopoli, per accertare gli illeciti
arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive, nonché per
formulare idonee proposte per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non
giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni a delinquere di
tipo politico. Nella XI Legislatura la Camera dei deputati giunse ad approvare
all'unanimità, il 7 luglio 1993, un testo unificato che recepiva l'esigenza
della Commissione d'inchiesta, ma il relativo disegno di legge si arenò in
Commissione al Senato. Nella successiva legislatura la proposta ottenne un
parere favorevole da parte della Commissione Giustizia del Senato. Ma perse di
spinta propulsiva dopo che fu approvato un emendamento della maggioranza che
puntava ad orientarne i lavori di ricerca "storiografica": esso intendeva
accertare se la conduzione delle inchieste avesse riscontrato omissioni o "zone
bianche"; si trattava di un indirizzo che - non escludendo una conduzione
selettiva o "mirata" di quelle inchieste - andava oggettivamente in consonanza
con la richiesta, avanzata dalla Tunisia, da Bettino Craxi. La proposta - con il
discusso emendamento, che ne stravolgeva il senso originario - fu votata dalla
Camera, nella nuova legislatura, il 3 novembre 1998, durante la quale venne
rigettata, insieme alle varie discordanti proposte avanzate da gli altri gruppi
parlamentari. L'idea di una Commissione d'inchiesta riprese velocità dopo che il
gruppo di Forza Italia depositò il 28 settembre 1999 una proposta di Commissione
bicamerale di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e
amministrativi, delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti
(A.C. 6386); e una proposta identica di Commissione monocamerale, da istituire
presso la Camera dei deputati, sempre ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione. Lo stesso giorno proposte simili furono avanzate dallo Sdi e dai
Ds. Il 21 gennaio 2000, l'allora Presidente del Consiglio Massimo D'Alema
rilanciò l'idea in un intervento alla Camera. Ma anche stavolta le divisioni e
le divergenze fra i vari partiti fecero naufragare il progetto. Lo
"scivolamento" dello strumento dell'inchiesta nell'intento di riscrittura della
storia del decennio passato divenne esplicito nella XIV legislatura.
Paradossalmente, dagli eredi (anche familiari) di Bettino Craxi non giunse che
una riedizione del testo licenziato dalla Camera il 26 gennaio 2000 (vedasi
l'Atto Camera 1427, mentre l'Atto Camera 1867 riproduce il testo del Senato): la
pacatezza della proposta deriva probabilmente dal diverso strumento prescelto
per ottenere la "riabilitazione" del defunto, e cioè i due ricorsi dichiarati
ammissibili dinanzi alla Corte dei diritti umani di Strasburgo. Fu invece
proprio del progetto di legge n. 2019 (d'iniziativa Cicchitto e Saponara) l'aver
proposto l'istituzione di una "Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso
politico della giustizia", che oltre a "disfunzioni" accertasse "l'eventuale
presenza all'interno dell'ordine giudiziario di orientamenti politico-ideologici
e rapporti di interdipendenza con forze politiche parlamentari o extra
parlamentari; l'eventuale influenza di motivazioni politiche sui comportamenti
delle autorità giudiziarie; le conseguenti deviazioni della giustizia
determinate dalla gestione politicamente mirata dell'esercizio dell'azione
penale; l'effettività del principio costituzionale dell'obbligatorietà
dell'azione penale, e l'eventuale esistenza di un esercizio discrezionale e
selettivo della funzione giudiziaria; gli eventuali tentativi di interferenza di
magistrati, singoli o associati, con l'attività parlamentare e di Governo, in
contrasto con il principio costituzionale della separazione dei poteri".
L'introduzione di questo ulteriore, e diverso oggetto dell'inchiesta determinò
l'insuccesso della proposta, che non ebbe più seguito dopo la fine della XIII
legislatura. Da un lato chi riteneva che la propria parte politica fosse vittima
di un uso politico delle indagini, trovatosi al potere con la XIV legislatura,
impegnò il Parlamento non più con proposte di commissioni d'inchiesta ma
direttamente con leggi volte a prevenire il fenomeno denunciato. Chi invece
riteneva che si dovesse indagare se le indagini della magistratura avevano
colpito più qualcuno che qualcun altro (e se ciò sia dipeso solo "dalla facilità
di reperire prove in un caso o di riscontrare un maggior grado di corruzione in
un altro") - ed a tal fine auspicava l'istituzione di una "Commissione che (...)
non dovrebbe occuparsi né di corrotti, né di corruttori, ma della corruzione" -
già all'epoca invitava a diffidare dall'utilizzo dell'inchiesta per riportare al
suo interno la polemica contro determinate inchieste ed in prosieguo giunse a
stigmatizzare le "antiche provenienze" (in tema di schieramenti politici sul
tema giustizia) come un classico caso in cui "i morti hanno afferrato i vivi".
Critiche. Il pool di Mani pulite
e le loro indagini sono stati oggetto di forti critiche. Ad esempio Silvio
Berlusconi ha dichiarato: «I magistrati milanesi
abusavano della carcerazione preventiva per
estorcere confessioni agli indagati» (Silvio Berlusconi, 30 settembre
2002). Mentre taluno sostiene che nessun
esempio sarebbe mai stato trovato per dimostrare tale accusa, altri citano i
casi di alcuni suicidi giudicati eloquenti. Il manager pubblico Gabriele
Cagliari, ex presidente dell'Eni, si soffocò con una busta di plastica nel
carcere di San Vittore il 20 luglio 1993: nella versione poi diffusasi
nell'ambiente politico sarebbe stato vittima della Procura di Milano perché,
prima di compiere l'estremo gesto, avrebbe più volte chiesto ai magistrati di
essere interrogato per chiarire la sua posizione. Risulta però che al momento
del suicidio, per il pool di Di Pietro fosse già uomo libero, visto che ne aveva
già richiesto la sua scarcerazione: Cagliari era tenuto ancora in carcere per un
altro processo milanese, quello sul caso Eni-Sai (uno dei processi che portò
alle condanne definitive di Craxi). Stando a quanto ricostruito successivamente
a Cagliari, sentito dal pubblico ministero Fabio De Pasquale, erano stati
promessi gli arresti domiciliari, probabilmente anche in virtù delle sue
dichiarazioni sulla tangente che Salvatore Ligresti avrebbe pagato a DC e PSI,
ma l'arresto di Ligresti il 19 luglio, che diede una ricostruzione differente
dei fatti, portò la procura a ritenere che un'eventuale scarcerazione di
Cagliari gli avrebbe consentito di inquinare eventuali prove. Pochi giorni dopo,
il 23 luglio, anche l'imprenditore Raul Gardini si tolse la vita in casa a
Milano, poco prima di ricevere l'avviso di garanzia per le indagini nei suoi
confronti. I detrattori di "Mani pulite" sottolineano come la misura cautelare
della custodia in carcere, la massima prevista dall'ordinamento, fosse stata
utilizzata nei confronti di persone per lo più incensurate, socialmente,
lavorativamente e familiarmente inserite, così che qualsiasi pericolo di fuga,
inquinamento probatorio o reiterazione del reato non fosse ragionevolmente
ipotizzabile, o tutt'al più scongiurabile, mediante semplici arresti
domiciliari: tutte misure che avrebbero dovuto essere assunte per limitare
l'impatto delle indagini sulla vita personale dei rei, e che non sarebbero state
assunte per le predominanti esigenze di visibilità dei magistrati inquirenti.
Un'altra critica riguarda il presunto uso politico della giustizia per denigrare
e portare allo scioglimento partiti o movimenti politici. Si ritiene che dalle
inchieste di Mani Pulite siano stati colpiti esclusivamente esponenti politici
della DC o del PSI, e nessun esponente politico di rilievo del PCI. Giulio
Maceratini osserva che questa miratezza delle indagini non poteva essere una
casualità ed è stata consapevolmente voluta per affondare il PSI e la DC e
favorire l'elezione del PCI, che fino ad allora non era mai riuscito a governare
l'Italia tramite le libere elezioni. Maceratini afferma inoltre che sembra
strano che, in un ambiente così corrotto come era l'Italia di quei tempi
descritta dai magistrati di Mani Pulite, il PCI non avesse tratto nessun
beneficio dal sistema politico economico vigente; a queste dichiarazioni
Gianfranco Fini, leader dello stesso partito di Maceratini, risponde che «Qui e
fuori di qui la stragrande maggioranza degli italiani ha un sentimento di
gratitudine per quei magistrati che hanno smascherato il volto perverso del
sistema tangentocrate. Detto questo è evidente che da parte nostra non ci deve
essere alcun timore per ogni indagine che viene fatta». Peraltro alcuni eredi
della tradizione comunista sono apparsi più travagliati in ordine alla questione
della deriva consociativa sottostante alla Prima repubblica, che coinvolgeva
anche il loro partito. In merito a queste critiche è stato fatto notare dal
giornalista Marco Travaglio che «...i primi due politici arrestati in Mani
Pulite erano dell'ex Pci: Soave e Li Calzi. Il pool di Milano inquisì quasi
l'intero vertice del Pci-Pds milanese. E poi le prime elezioni dopo Tangentopoli
non le vinsero le sinistre: le vinse Berlusconi». Inoltre furono indagati anche
Marcello Stefanini, segretario amministrativo nazionale del Pds, successivamente
prosciolto, e Primo Greganti, uomo legato al partito comunista che subì "uno dei
più lunghi periodi di custodia cautelare". Altro addebito - di tipo
eminentemente processuale - fu quello fondato sullo squilibrio conoscitivo tra
magistratura requirente e giudicante, che rendeva necessitate molte delle
decisioni di competenza di quest'ultima (specie quelle cautelari, assunte
necessariamente in assenza di contraddittorio con la difesa): già nel processo a
Cusani la difesa lamentava che alcune decisioni del GIP riproducevano note a
margine e post-it apposti sul fascicolo con la grafia di Antonio Di
Pietro. Ma solo dopo molti anni - terminato il suo lavoro a Milano e quello di
membro elettivo del CSM - il GIP milanese Italo Ghitti ammise che le decisioni
da lui assunte nel 1992-1993 erano spesso pedissequi accoglimenti delle
richieste della Procura della Repubblica, non essendogli possibile o pratico
revisionare tutti gli elementi di prova (che venivano ritenuti fondati spesso
senza neppure aver avuto il tempo di esaminarli): a sua volta, sostenne Ghitti,
lo stesso PM spesso prende per buone le attività di indagine effettuate dalla
polizia giudiziaria, senza un reale riscontro. Nel 1994, il Governo Berlusconi I
inviò degli ispettori per indagare su eventuali scorrettezze commesse dai
magistrati della Procura di Milano, tra cui quelli del pool di Mani
pulite. Nella loro relazione finale, presentata il 15 maggio 1995, gli ispettori
riferirono al nuovo Governo affermando che: ««Nessun rilievo può essere mosso ai
magistrati milanesi, i quali non paiono aver esorbitato dai limiti imposti dalla
legge nell'esercizio dei loro poteri» (relazione
finale degli ispettori inviati dal Governo Berlusconi I, 15 maggio 1995).
Un altro acerrimo critico dei magistrati di Mani pulite è il critico d'arte e
politico Vittorio Sgarbi: i suoi attacchi televisivi ai giudici ed al
giustizialismo raggiunsero livelli tali che la Corte costituzionale, con le
sentenze nn. 10 e 11 del 2000, li sottrasse all'area dell'insindacabilità delle
opinioni espresse da un parlamentare (di cui all'articolo 68, primo comma della
Costituzione).
Tangentopoli nella cultura di massa. Il
termine "Tangentopoli" negli anni successivi all'inchiesta Mani Pulite venne
ripreso per essere adattato ad altri tipi di scandali giudiziari ("affittopoli",
"vallettopoli", ecc..). Il termine, nel periodo delle inchieste, venne
utilizzato anche per un gioco da tavolo, chiamato Tangentopoli, la lunga
corsa della corruzione, realizzato dai giornalisti campani Maurizio Landi e
Mimmo Cordopatri. Nel 1993 usciva poi un videogioco, edito dalla Xenia edizioni
ed ideato da Guglielmo Duccoli e Roberto Piazzolla, dal titolo Il grande
gioco di Tangentopoli, dove si interpretava il "giudice De Petris", che
combatteva a colpi di avvisi di garanzia gli onorevoli di PLI, PSDI e DC, doveva
impedire la crescita della bandiera del PDS e dell'edera del PRI, evitare da
essere colpito dalle inchieste ministeriali sulla magistratura e
contemporaneamente evitare che versioni Pac-matizzate di Bettino Craxi, Paolo
Cirino Pomicino e Pietro Longo si impossessassero del denaro degli appalti
pubblici.
IL POOL DI MANI PULITE.
Un pool, nell'ambito della magistratura italiana è un termine che individua un
gruppo di magistrati che si occupa di una stessa indagine. Esso costituisce un
efficace strumento di indagine, ed uno degli elementi fondamentali che hanno
portato all'istaurazione di diversi processi, ad esempio contro le Brigate Rosse
e Prima Linea, durante gli anni di piombo, al maxiprocesso di Palermo in Italia
contro Cosa Nostra e all'inchiesta di Mani Pulite.
FRANCESCO SAVERIO BORELLI.
Francesco Saverio Borrelli. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Francesco Saverio Borrelli (Napoli, 12 aprile 1930) è un ex magistrato italiano.
Biografia. Figlio di Manlio,
magistrato. Laureato in giurisprudenza con una tesi intitolata Sentimento e
sentenza. È agnostico Pubblico ministero, entrò in magistratura nel luglio
del 1955. Nel dicembre del 1983 divenne Procuratore aggiunto presso il Tribunale
di Milano, e tenne tale incarico fino al maggio del 1988, data in cui divenne
capo dello stesso ufficio. Dal marzo 1999 alla pensione nell'aprile 2002 è stato
procuratore generale della Corte d’appello milanese. La quasi totalità della sua
carriera giudiziaria - circa 40 anni - ha avuto come epicentro il capoluogo
lombardo, dove è stato giudice presso il Tribunale, consigliere della Corte
d'appello, Presidente di sezione del Tribunale, per poi passare all'ufficio del
PM. Nel febbraio 1992, con l'inizio dell'inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio
cominciò l'era di tangentopoli e diresse il pool di magistrati che indagò sullo
scandalo politico cd. di Mani Pulite insieme ad Antonio Di Pietro, Ilda
Boccassini, Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo e si segnalò come uno dei
magistrati più determinati: fu lui, ad esempio, a spedire al leader socialista
Bettino Craxi il primo avviso di garanzia. Dal 1999 al 2002, per sua stessa
richiesta, fu nominato Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano;
finì così la stagione di Mani Pulite. Il 12 gennaio 2002 in questa veste
concluse nella sua relazione, all’inaugurazione dell’anno giudiziario in Corte
d’appello, coniò lo slogan «resistere, resistere, resistere» contro le riforme
del governo Berlusconi. Il 23 maggio del 2006, dopo un grave scandalo che
coinvolse pesantemente il mondo del calcio italiano, fu nominato capo
dell'ufficio indagini FIGC dal commissario straordinario di tale organismo,
Guido Rossi. In seguito alle dimissioni di quest'ultimo nel settembre 2006,
durante un'audizione parlamentare a Montecitorio, Borrelli lasciò a sua volta
l'incarico, per poi ritornare dopo aver parlato con il nuovo commissario
straordinario, Luca Pancalli. Abbandonò definitivamente l'incarico nel giugno
2007. Nel marzo dello stesso anno fu nominato, su proposta del Consiglio
Accademico, Presidente del Conservatorio di Milano. Insieme all'ex collega e
amico Gerardo D'Ambrosio, fu tra i firmatari dell'appello per la candidatura di
Walter Veltroni alla guida del Partito Democratico, in vista delle elezioni del
14 ottobre 2007.
Biografia di Francesco Saverio Borrelli. Napoli 12 aprile 1930. Ex magistrato
(1955-2002). Dal 1992 al 1998 capo della Procura di Milano, divenne noto durante
l’inchiesta del pool Mani pulite. Dal 1999 alla pensione procuratore generale
della Corte d’appello milanese, in seguito è stato capo dell’ufficio indagini
della Federcalcio (maggio 2006-giugno 2007) e presidente del Conservatorio
“Giuseppe Verdi” di Milano (marzo 2007-aprile 2010). Due fratelli maggiori e una
sorella minore, Borrelli nacque dal secondo matrimonio del magistrato Manlio
(figlio e nipote di magistrati) con Amalia Jappelli detta Miette. «Fino a sette
anni non sapevo che i miei fratelli avessero avuto un’altra madre, morta quando
erano piccolissimi. Nessuno mi aveva mai detto nulla. Me lo rivelò un uomo
stupido ridacchiando: “Ma che fratelli, i tuoi sono fratellastri”. Fu uno shock
tremendo. Corsi a casa disperato. Volevo sapere, capire. I miei avevano voluto
salvaguardare l’uguaglianza tra fratelli: non dovevo sentirmi un privilegiato
perché io avevo entrambi i genitori. Mi chetai, ma mi restò a lungo una fantasia
di abbandono, il timore, che più tardi ho saputo comune a molti bambini, di
essere un trovatello. Tremavo nel mio lettino e pregavo che non fosse così».
Dopo due anni a Lecce, nel 1936 la famiglia traslocò a Firenze: maturità al
liceo classico Michelangelo, laurea in giurisprudenza con Piero Calamandrei
(titolo della tesi Sentenza e sentimento) prese il diploma di pianoforte
al conservatorio Cherubini. Dal 1953 a Milano, dove il padre era stato nominato
presidente di Corte d’appello, nel 1955 vinse il concorso per entrare in
magistratura. Dal 1957 sposato con Maria Laura Pini Prato, insegnante di inglese
conosciuta all’università che gli diede i figli Andrea e Federica, passò
vent’anni al Civile, prima in Pretura, poi in Tribunale occupandosi di
fallimenti e diritto industriale, infine in Corte d’Appello. Passato al Penale,
dal ’75 all’82 fu in corte d’Assise, nel 1983 arrivò alla Procura della
Repubblica, nel 1992, l’anno dell’inizio dell’indagine Mani pulite, ne divenne
il capo. Quando, nell’aprile del 2002, Borrelli andò in pensione, a Palazzo
Chigi c’era nuovamente Silvio Berlusconi. Il 3 gennaio di quell’anno, aprendo il
suo ultimo anno giudiziario, l’ex procuratore capo di Milano aveva lanciato lo
slogan «Resistere, resistere, resistere». Nel maggio 2006, in piena Calciopoli,
Guido Rossi lo chiamò a guidare l’ufficio indagini della Federcalcio: «Rifiutare
mi sembrava una vigliaccata». Nel marzo 2007 divenne presidente del
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano (la più prestigiosa università musicale
d’Italia): «È una nuova sfida, l’ennesima che affronto con gioia e un certo
tremore». In contemporanea annunciò l’addio alla Figc: «Per ora mantengo il
posto in Federcalcio, non c’è incompatibilità. Se sono uscito dall’ombra lo devo
solo a Guido Rossi. Dopo la nomina del calcio mi riconoscono tutti, i taxisti e
anche i più giovani. Ma a luglio, con il nuovo statuto da me suggerito,
l’ufficio indagini confluirà nella Procura federale. Non voglio fare il
Procuratore federale: c’è Stefano Palazzi, è molto più giovane di me».
Nell’aprile 2010 il ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, cui spetta la
nomina della carica di presidente degli istituti musicali, gli negò il secondo
mandato triennale alla presidenza del Verdi: «Ragioni evidentemente politiche.
Appartengo a una corporazione che è in odio alle alte sfere della politica.
Evidentemente non devo essere gradito agli esponenti del governo. Ma la mia
amarezza è soprattutto quella di aver saputo della mia mancata conferma in modo
indiretto, senza comunicazione ufficiale. Sono sempre stato abbastanza umile da
accettare le critiche, ma ciò che mi offende è il metodo. Ho lavorato con
passione in questi anni». (Giorgio Dell’Arti Catalogo
dei viventi 2015.
ILDA BOCCASSINI.
Ilda Boccassini. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Ilda Boccassini
(Napoli, 7 dicembre 1949) è un magistrato italiano, procuratore aggiunto della
Repubblica presso il tribunale di Milano.
Biografia. Dopo la laurea in
giurisprudenza entra in magistratura, con funzioni effettive, nel 1979 prestando
servizio dapprima alla Procura della Repubblica di Brescia, e ottenendo poco
dopo il trasferimento alla Procura della Repubblica di Milano. Si occupa, quasi
subito dopo il suo arrivo a Milano, di criminalità organizzata. La sua prima
inchiesta di rilevanza nazionale viene denominata Duomo Connection e ha come
oggetto l'infiltrazione mafiosa nell'Italia settentrionale. L'inchiesta è
portata avanti con la collaborazione di un gruppo di investigatori guidati
dall'allora tenente Ultimo, il capitano divenuto poi famoso per l'arresto di
Totò Riina. Sono gli anni delle prime collaborazioni anche con il giudice
Giovanni Falcone, che sfoceranno in un legame di profonda amicizia. All'inizio
degli anni novanta entra in rotta di collisione con altri colleghi del pool
antimafia milanese e ne viene estromessa dall'allora Procuratore Capo Francesco
Saverio Borrelli, ma porta comunque a termine il processo sulla Duomo
Connection. Dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio, nel 1992, chiede di essere
trasferita a Caltanissetta dove rimane fino al '94 sulle tracce degli assassini
di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Collabora nuovamente con Ultimo alla
cattura di Riina e scopre, in collaborazione con altri magistrati applicati a
quelle indagini, mandanti ed esecutori delle stragi Falcone e Borsellino. Dopo
una breve parentesi alla Procura di Palermo torna a Milano e, su richiesta del
Procuratore Borrelli, si occupa dell'inchiesta denominata Mani pulite
subentrando ad Antonio Di Pietro dimessosi dalla magistratura il 6 dicembre del
1994. Collabora, quindi, con i colleghi Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo,
Armando Spataro e Francesco Greco, seguendo in particolare gli sviluppi delle
inchieste riguardanti Silvio Berlusconi e Cesare Previti. Continua ad operare
presso la Procura di Milano dove si occupa di indagini sulla criminalità mafiosa
e sul terrorismo. Ha diretto a partire dal 2004 le indagini della DIGOS che il
12 febbraio 2007 hanno portato all'arresto di 15 sospetti appartenenti all'ala
movimentista delle Nuove Brigate Rosse, denominata anche Seconda Posizione.
Secondo l'accusa, la presunta organizzazione terroristica, operante nel Nord
Italia, stava preparando attentati contro persone e aziende. Il 28 maggio 2009
il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) l'ha promossa alla
funzione di Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
In seguito indaga sul caso riguardante l'affidamento di una giovane donna
marocchina, definito giornalisticamente caso Ruby, nota negli ambienti
della politica e della moda, che avrebbe compiuto alcuni furti. L'inchiesta
interessa, tra gli altri, l'ex presidente del Consiglio dei Ministri italiano
Silvio Berlusconi che, secondo l'accusa, avrebbe esercitato indebite pressioni
sulla questura di Milano per ottenere suo rilascio e che l'avrebbe pagata in
cambio di prestazioni sessuali quando era ancora minorenne. A causa di
quest'incarico e di altre attività che hanno impegnato le procure della
Repubblica nelle indagini su Silvio Berlusconi per reati quali concorso esterno
in associazione mafiosa, prostituzione minorile, concussione, corruzione,
strage, appropriazione indebita, traffico di droga, riciclaggio di denaro
sporco, abuso d'ufficio, frode fiscale e falso in bilancio, Berlusconi l'ha
indicata fra gli appartenenti ad una frangia della magistratura, da lui definita
"sovietica" e "comunista". Si ricorda l'attacco da parte de Il Giornale che, su
indicazione di Matteo Brigandì, componente del CSM, citato poi in giudizio per
la diffusione dell'informazione stessa, all'inizio del 2011, ricorda che nel
1982 il magistrato era stato sottoposto a provvedimenti disciplinari a causa di
atteggiamenti personali concludendo quindi che la Boccassini non avesse
l'autorità morale per condurre le indagini su Berlusconi. Nel dicembre 2011
viene inclusa dalla rivista statunitense Foreign policy al 57º posto nella lista
delle personalità nel mondo che nel corso del 2011 hanno influenzato l'andamento
del mondo nella politica, nell'economia, negli esteri.
In tempi in cui la magistratura si può accanire contro un Premier e questo,
anziché intervenire sulle anomalie del sistema, personalizzando li accusa di
essere sovversivi e comunisti, ci si chiede cosa accadrà al povero cristo.
Intanto su “Il Giornale” del 27 gennaio 2011 esce quest’articolo “ La doppia
morale della Boccassini”, di Anna Maria Greco su "Il Giornale". Nel 1982 la
Boccassini venne sorpresa in "atteggiamenti amorosi" con un giornalista di Lotta
Continua. Davanti al Csm si difese come paladina della privacy. E fu assolta.
Ora fruga nelle feste di Arcore, ma allora parlò di "tutela della sfera
personale". “Ve la immaginate l’agguerrita pm dello scandaloso «caso-Ruby»,
che ha frugato nelle feste di Arcore e ascoltato le conversazioni pruriginose
delle ragazze dell’Olgettina, nelle vesti della paladina della privacy? Eppure,
per difendere se stessa al Csm da accuse boccaccesche, che definisce
«un’inammissibile interferenza», Ilda Boccassini dichiara: «Sono questioni che
attengono esclusivamente alla sfera della mia vita privata, coperta, come tale,
da un diritto di assoluta riservatezza». Succede molti anni fa, nel 1982, quando
l’allora giovane sostituto alla Procura di Milano viene sottoposta a
procedimento disciplinare. L’accusa, si legge negli atti del Csm, è di «aver
mancato ai propri doveri, per aver tenuto fuori dell’ufficio una condotta tale
da renderla immeritevole della considerazione di cui il magistrato deve godere,
così pure compromettendo il prestigio dell’ordine giudiziario». Diciamo subito
che, l’anno dopo, la Boccassini viene assolta a palazzo de’ Marescialli. E
proprio in nome della tutela alla riservatezza della vita personale. La sezione
disciplinare del Csm, infatti, «nel ribadire il proprio orientamento in materia
di diritto alla privacy del magistrato, ritiene che il comportamento della
dottoressa Boccassini non abbia determinato alcuna eco negativa né all’interno
degli uffici giudiziari, come provano le attestazioni dei colleghi della
Procura, né all’esterno». Il fatto di cui si parla appare banale, perché
riguarda abbracci e baci con un uomo per strada, a due passi dal Palazzo di
Giustizia. «Atteggiamento amoroso», lo definiscono con scandalo nel rapporto di
servizio due guardie di scorta ad un pm aggiunto della Procura. Il «lui» in
questione non è uno sconosciuto, ma un giornalista di «Lotta continua»,
accreditato presso l’ufficio stampa del tribunale. Salteranno fuori altri
episodi e si parlerà anche di rapporti con un cronista dell’Unità. Il tutto va
collocato in un contesto preciso: quello degli Anni di piombo, di scontro,
tensioni, sangue e forte militanza politica anche da parte di magistrati e
giornalisti sulla linea che lo Stato doveva tenere verso i terroristi. Poco
prima di questi fatti, nel 1979, uno dei pm di Milano e cioè Emilio
Alessandrini, era stato ucciso da esponenti di Prima linea mentre andava a
Palazzo di Giustizia. Lo ricorda il Procuratore capo Mauro Gresti, quando si
decide a segnalare la questione e a chiedere il trasferimento d’ufficio della
Boccassini, parlando di altri episodi «disdicevoli» dentro la Procura, legati a
«presunti comportamenti illeciti», tra l’autunno 1979 e l’inverno 1980, che
prima non aveva denunciato. A segnalare incontri molto ravvicinati, violente
liti, riunioni serali in ufficio erano stati un ex-carabiniere addetto alle
pulizie e un tenente colonnello dell’Arma. Gresti sottolinea che a farlo muovere
non fu tanto «lo sconcerto procuratomi dall’esibizione di affettuosità più
consone all’intimità di quattro mura che alla pubblicità di una via, ma
piuttosto lo sconcerto per la constatazione che l’oggetto delle affettuosità
della Boccassini era una persona solita a frequentare gli ambienti della Procura
di Milano per ragioni della sua professione giornalistica». Una persona che più
volte aveva «manifestato il proprio acido dissenso verso la linea della fermezza
adottata dai magistrati della Procura nella lotta al terrorismo e alle sue aree
di supporto», con un «atteggiamento di critica preconcetta all’operato delle
istituzioni». Sembra che il Procuratore si preoccupi di legami personali che
possano favorire fughe di notizie o, addirittura, l’ispirazione di articoli e
campagne di stampa contro il suo ufficio. In particolare, critica la
politicizzazione di magistrati come la Boccassini (già allora aderente alla
corrente di sinistra Magistratura democratica), che avevano anche sottoscritto
un documento di solidarietà per un imputato di terrorismo che, con lo sciopero
della fame, chiedeva di essere trasferito in un carcere normale. E contro le
carceri speciali, sottolinea il Procuratore allegando alcuni articoli,
contemporaneamente scriveva anche il giornalista amico di Ilda. Per Gresti,
quell’iniziativa dei pm era stata «un proditorio attacco all’atteggiamento di
intransigente e ferma lotta all’eversione proprio dei magistrati dell’ufficio
stesso che trattavano di terrorismo, nonché una chiara manifestazione di
dissenso dalla loro linea, del tutto inopportuna e tale da poter sottoporre a
pericoli la loro incolumità personale». In sostanza, dice con durezza il
Procuratore, va bene la libertà d’opinione, ma così si poteva anche
involontariamente «additare come obiettivi da colpire i magistrati impegnati
nella difesa intransigente delle istituzioni». E qui Gresti ricorda proprio
Alessandrini, «barbaramente trucidato dai terroristi in un vile attacco». Questa
lettera al Procuratore generale della Cassazione e al Pg della Corte d’appello è
del giugno 1982, mentre si celebra il processo disciplinare iniziato a dicembre,
che si concluderà con l’assoluzione. È provocata dall’iniziativa di 27 pm (c’è
anche Alfonso Marra, quello dimessosi per la P3), che a marzo insorgono in
difesa della Boccassini, «ingiustamente offesa anche nella sua dignità di donna»
anche da una «pubblicità di per sè umiliante». Parlano di «pettegolezzo» che
incide nella «sfera della riservatezza personale» e di rischio per tutti di
«inammissibile interferenza nella vita privata». Il primo a firmarla è Armando
Spataro, collega della Boccassini alla Procura e suo difensore a Palazzo de’
Marescialli. È lui a redigere la memoria difensiva dell’aprile ’82, in cui
spiega che la pm non è voluta entrare nel merito delle accuse rivoltele in nome
della privacy, ritenendo «umiliante» dover spiegare e giustificare rapporti
personali con un giornalista, di cui Spataro difende la correttezza. E aggiunge:
«Il concreto esplicarsi della vita privata del magistrato, come quella di ogni
cittadino, non può essere soggetto a limiti o divieti precostituiti per legge».
Dunque, non può essere sanzionato alcun rapporto personale con persone che
lavorano nello stesso ambito. Sempre che non si arrivi a comportamenti
scorretti, come «la rivelazione ad un giornalista di notizie coperte da segreto
istruttorio». La difesa non convince e c’è il rinvio a giudizio della
Boccassini. Ma il Pg della Cassazione, Sofo Borghese, chiede la «perentoria
censura» con il trasferimento, non per questioni di sesso, moralità o decoro.
Per lui i comportamenti del pm sono gravi «non certo per il compiaciuto scambio
di vistose affettuosità» vicino al Palazzo di Giustizia, ma perché l’altro è un
giornalista accreditato al tribunale. «Intuibili perciò - afferma il Pg - le
facili battute, il pettegolezzo spicciolo, le maliziose insinuazioni e,
soprattutto, il sospetto - fondato o meno non importa - nell’ambiente
giornalistico, forense o in altri a questi vicini, che la pubblicazione di
talune notizie possa ricollegarsi a privilegiate confidenze». Per Borghese
«urge» intervenire, per «evitare prevedibili intollerabili malintesi o capziose
strumentalizzazioni tali da non consentire di amministrare giustizia nelle
condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario». Il sostituto pg
Antonio Leo sostiene l’accusa, si svolge l’istruttoria, si ascoltano i testi, si
ricostruiscono altre vicende. Tutto per appurare se il pm ha tenuto «in ufficio
o fuori una condotta tale che comprometta il prestigio dell’ordine giudiziario».
Per smontare il capo d’accusa, Spataro fa stralciare gli altri episodi e
sostiene che si tratta solo di un fatto privato che non si è svolto «secondo
modalità illecite o anche solo sconvenienti». È «non soltanto perfettamente
lecito, ma anche assolutamente normale». La sentenza di assoluzione della
sezione disciplinare del Csm, guidata dal vicepresidente Giancarlo de Carolis,
arriva ad aprile ’83.”
Boccassini, una delle famiglie di magistrati più corrotte della storia d’Italia,
scrive “Imola Oggi”. Il paragone fra certi p.m. di Magistratura Democratica e
gli estremisti della Brigate Rosse è sicuramente improprio ma il fanatismo e la
propensione agli affari degli uni e degli altri è sicuramente simile. Ilda
Boccassini appartiene, secondo la stampa, a una delle famiglie di magistrati più
corrotte della storia d’Italia. Suo zio Magistrato Nicola Boccassini fu
arrestato e condannato per associazione a delinquere, concussione corruzione,
favoreggiamento e abuso di ufficio perchè spillò con altri sodali e con ricatti
vari 186 milioni di vecchie lire a un imprenditore. (vendeva processi per un
poker repubblica). Anche suo padre Magistrato e suo cugino acquisito Attilio
Roscia furono inquisiti. Suo marito Alberto Nobili fu denunciato alla procura di
Brescia da Pierluigi Vigna, Magistrato integerrimo e universalmente stimato per
presunte collusioni con gli affiliati di Cosa Nostra che gestivano l’Autoparco
Milanese di via Salamone a Milano. (attacco ai giudici di Milano Repubblica)
(Brescia torna inchiesta autoparco). Non se ne fece niente perchè la denuncia
finì nelle mani del giudice Fabio Salomone, fratello di Filippo Salomone,
imprenditore siciliano condannato a sei anni di reclusione per associazione a
delinquere di stampo mafioso. L’Autoparco milanese di via Salomone era un
crocevia di armi e di droga ha funzionato per 9 anni di seguito (dal 1984 al
1993), fu smantellato dai magistrati fiorentini e non da quelli milanesi e
muoveva 700 milioni di vecchie lire al giorno. A Milano tutti sapevano che cosa
si faceva lì dentro. Visto ciò che è emerso a carico del marito per l’Autoparco
e visto ciò che sta emergendo a carico del giudice Francesco Di Maggio (anche
lui della Procura di Milano) relativamente alla strage di Capaci anche il suo
trasferimento a Caltanisetta nel 1992 appare sospetto. In realtà a quel tempo
sei magistrati massoni della Procura di Milano appoggiavano il progetto di Riina
e Gardini, i quali erano soci, di acquisire Eni e poi di fondare Enimont e
quindi da un lato favorivano l’acquisizione di denaro da parte di Cosa Nostra
tutelando l’Autoparco (700.000.000 di vecchie lire al giorno di movimento di
denaro) tutelando i traffici con il c.d. metodo Ros (502.000.000 di euro di
ammanchi) e simulando con altre inchieste minori (Duomo Connenction, Epaminonda)
un contrasto alla mafia che in realtà non c’era, dall’altro con Di Maggio
intervennero pesantemente in Sicilia già nel 1989 per contrastare un attacco
della FBI americana contro i corleonesi attraverso il pentito Totuccio Contorno
e facendo ricadere la responsabilità delle lettere del corvo su Falcone, poi
attentato simulatamente dalla stessa Polizia. Poi nel 1992 sempre con uomini di
Di Maggio contribuirono alla strage di Capaci ove morì Giovanni Falcone il quale
si opponeva acchè il progetto Enimont, a quel tempo gestito da Andreotti e da
Craxi, tornasse nelle mani di Gardini e di Riina. Ora è noto ormai che anche le
Brigate Rosse eseguirono il sequestro Moro per affarismo e rifiutarono dieci
miliardi di vecchie lire da parte del Papa Paolo VI per liberare Aldo Moro
perchè qualcun altro le remunerò di più. Napolitano ha ben fatto appello più
volte a questi Magistrati di moderarsi. Palamara non c’entra niente con questo
discorso perchè è un buon Magistrato ed è affiliato a Unicost, una corrente di
magistrati seri e responsabili e non a M.D. Il tutto sembrerebbe discutibile se
il parente che si è messo in condizione di essere criticato fosse solo uno. Ma
qui i parenti chiacchierati sono tre. Fra l’altro osservo che
Alberto Nobili, dopo che si è separato dalla Boccassini, è tornato a
essere un magistrato stimato, per cui viene il dubbio che nei casini ce lo abbia
messo lei.
PIERCAMILLO DAVIGO.
Piercamillo Davigo. Da Wikipedia,
l'enciclopedia libera. Piercamillo Davigo (Candia Lomellina, 20 ottobre 1950) è
un magistrato italiano, Consigliere della II Sezione Penale presso la Corte di
Cassazione.
Biografia. Dopo essersi laureato in
giurisprudenza all'Università di Genova è entrato in Magistratura nel 1978. Ha
iniziato la sua carriera come giudice presso il Tribunale di Vigevano; poi dal
1981 è divenuto Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Milano, dove si è occupato prevalentemente di reati finanziari, societari e
contro la Pubblica Amministrazione. In questo contesto ha fatto parte, nei primi
anni Novanta, del pool Mani Pulite, insieme ai colleghi Antonio Di Pietro,
Francesco Saverio Borrelli, Gerardo D'Ambrosio, Ilda Boccassini, Gherardo
Colombo, Francesco Greco, Tiziana Parenti e Armando Spataro. È stato eletto nel
parlamentino dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), nella corrente di
"Magistratura Indipendente". Successivamente è divenuto Consigliere della Corte
d'Appello di Milano. Ricopre il ruolo di Consigliere alla Corte Suprema di
Cassazione, II Sezione Penale, dal 28 giugno 2005. Ha scritto vari libri, di
taglio prevalentemente scientifico. Fra i testi di divulgazione, si ricordano in
particolare La Giubba del Re - Intervista sulla corruzione, scritto in
collaborazione con Davide Pinardi, La corruzione in Italia - Percezione
sociale e controllo penale, scritto a quattro mani con Grazia Mannozzi e
Processo all'italiana con Leo Sisti. Nel 2012 è stato insignito del
Premio Giovenale.
ARMANDO SPATARO.
Armando Spataro. Da Wikipedia,
l'enciclopedia libera. Armando Spataro (Taranto, 16 dicembre 1948) è un
magistrato italiano, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino,
ex procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Milano,
coordinatore del Gruppo specializzato nel settore dell'antiterrorismo, ex
segretario nazionale del Movimento per la giustizia (una delle correnti di
sinistra dell'Associazione nazionale magistrati). Dirigente nazionale della ANM,
di cui è anche segretario distrettuale a Milano.
Biografia. Entra in magistratura il 27
marzo 1975 e l'anno successivo è destinato come Sostituto Procuratore della
Repubblica alla Procura della Repubblica di Milano dove ha svolto tutta la sua
carriera occupandosi prima di sequestri di persona e poi di terrorismo di
sinistra coordinando tutte le inchieste milanesi fino al 1989. Spataro divenne
noto al grande pubblico quando fu incaricato dell'inchiesta sull'incidente
automobilistico che causò la morte di Ronnie Peterson, durante il Gran Premio
d'Italia del 1978. Al termine delle indagini, avanzò la richiesta della condanna
a 8 mesi di reclusione per Riccardo Patrese, invece assolto con formula piena,
per non aver commesso il fatto. Successivamente si è occupato di criminalità
organizzata, traffico internazionale di stupefacenti ed è chiamato a partecipare
alla Direzione distrettuale antimafia dal 1991 (anno della costituzione) al
1998, occupandosi soprattutto di indagini su 'ndrangheta e mafia siciliana. Dopo
le dimissioni di Antonio Di Pietro, avvenute nel 1994, era stato chiamato dal
procuratore generale di Milano Francesco Saverio Borrelli a fare parte del pool
di "Mani pulite". Nel luglio del 1998 è stato eletto componente del Consiglio
superiore della magistratura. Per questo si trasferisce a Roma fino alla
scadenza del mandato (luglio 2002) quando ritorna alla procura di Milano con
funzioni di procuratore della Repubblica aggiunto coordinando dal giugno 2003 il
Dipartimento terrorismo ed eversione responsabile di indagini su terrorismo
interno ed internazionale (in particolare di quello di matrice islamica, tra cui
quelli sull'imam egiziano Abu Omar e su Mohammed Daki, noto per la sentenza di
assoluzione pronunciata dal giudice Clementina Forleo, confermata in appello e
rigettata dalla Cassazione). È autore di numerosi saggi (anche di diritto
processuale comparato), commenti a testi di legge e pubblicazioni varie di
carattere scientifico (riguardante materia di criminalità organizzata e
terroristica e di tecniche investigative) pubblicati su testi vari e su riviste
specializzate. Ha pubblicato anche un'autobiografia professionale, Ne valeva
la pena. Storie di terrorismi e mafie, di segreti di Stato e di giustizia offesa
(Laterza, Roma-Bari 2010): nucleo centrale è la vicenda dell'extraordinary
rendition che ha avuto come vittima Abu Omar (2003) e che ha visto agenti
della CIA agire con la collaborazione del Sismi. L'opposizione del segreto di
Stato da parte dei governi Prodi e Berlusconi è per Spataro l'occasione per
riflettere sui rapporti tra politica e magistratura e sulla violazione dei
diritti umani con il pretesto della sicurezza. Il libro è valso a Spataro il
premio Capalbio 2010 per la sezione Politica e istituzioni. Dal 30 giugno 2014 è
procuratore della Repubblica di Torino, nominato dal plenum del CSM con 16 voti
a favore su 24.
GERARDO D'AMBROSIO.
Gerardo D'Ambrosio Da Wikipedia,
l'enciclopedia libera. (Santa Maria a Vico, 29 novembre 1930 – Milano, 30
marzo 2014) è stato un politico e magistrato italiano, fra i protagonisti di
Mani pulite.
Biografia. Diplomato al liceo classico
e laureato a pieni voti in Giurisprudenza a Napoli nel 1952 con tesi in diritto
amministrativo. Nel 1953 diventa procuratore legale, entra in Magistratura nel
1957. Dopo una breve permanenza alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Nola, viene destinato al Tribunale di Voghera. In seguito viene
trasferito al Tribunale di Milano, dapprima come Pretore Civile (per cinque
anni), poi come Giudice Istruttore Penale. Da rilevare che con
quest'ultimo incarico ha, tra l'altro, condotto l'istruttoria relativa alla
strage di Piazza Fontana. Il 27 ottobre 1975 pronuncia la controversa sentenza
sulla morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli, assolvendo il commissario Calabresi
e gli altri uomini della questura milanese. Nel 1981 è assegnato alla Procura
Generale di Milano con funzione di Sostituto Procuratore Generale, per
otto anni. In questo periodo ha sostenuto l'accusa nei primi processi per
terrorismo e nel processo conseguente allo scandalo dei petroli. Ha condotto
inoltre le istruttorie relative agli illeciti del Banco Ambrosiano, che vedeva
tra gli altri imputati Roberto Calvi. Nel 1989 è stato nominato Procuratore
aggiunto di Milano ed ha diretto dapprima il Dipartimento criminalità
organizzata e, dal 1991, quello dei reati contro la pubblica
amministrazione. Nel 1991 è stato sottoposto con successo ad un trapianto di
cuore. Dal 1992 è tra i protagonisti (insieme a Francesco Saverio Borrelli,
Antonio Di Pietro, Piercamillo Davigo e Gherardo Colombo) del Pool che si
occupa dell'inchiesta Mani pulite: sono gli anni di Tangentopoli,
che gli dà grande notorietà. Nel 1999 è stato nominato Procuratore Capo
della Procura della Repubblica di Milano, contribuendo alla riorganizzazione
degli Uffici, necessitata dalla introduzione del Giudice unico. Nel 2002
è stato collocato a riposo per limiti di età. Il 21 maggio 2012 il consiglio
comunale di Santa Maria a Vico, sua città natale, gli ha negato - con decisione
presa a maggioranza - la cittadinanza onoraria, proposta nei mesi precedenti
dall'associazione culturale locale Ethos Odv. In fase di discussione il
sindaco sammariano Alfonso Piscitelli (Il Popolo della Libertà) ha dichiarato:
«Anche se D'Ambrosio è un nostro illustre cittadino riteniamo non abbia volato
troppo in alto, non sia stato al di sopra delle parti». È deceduto il 30 marzo
2014 all'età di 83 anni.
Collaborazione con giornali. Dal 2003
collaborò col quotidiano L'Unità; cominciò poi a scrivere anche per il
settimanale Oggi. Nel 2005, inoltre, pubblicò presso la Casa editrice RCS
il saggio La giustizia ingiusta.
Politica. In occasione delle Elezioni
politiche 2006, accetta la candidatura proposta dai Democratici di Sinistra, di
un seggio al Senato, risultando eletto nella Regione Lombardia. È stato
componente della II Commissione permanente ("Giustizia") del Senato. Tra
gli altri interventi in Aula, vanno menzionati quelli contro un provvedimento
(poi approvato nell'estate 2006) d'indulto che prevedeva sconti di pena di tre
anni. D'Ambrosio sosteneva che la quantificazione della riduzione di pena era
eccessiva, in quanto sarebbero stati scarcerati molti più detenuti (secondo la
stima di D'Ambrosio, circa 24.000) del previsto (la stima era di 10.000
scarcerazioni). Alle elezioni del 2008 è stato confermato senatore del PD.
GHERARDO COLOMBO.
Gherardo Colombo. Da Wikipedia,
l'enciclopedia libera. Gherardo Colombo (Briosco, 23 giugno 1946) è un ex
magistrato italiano, attualmente ritiratosi dal servizio, divenuto famoso per
aver condotto o contribuito a inchieste celebri quali la scoperta della Loggia
P2, il delitto Giorgio Ambrosoli, Mani pulite, i processi
Imi-Sir/Lodo Mondadori/Sme. Dopo aver conseguito la maturità classica, si
iscrive all'Università Cattolica di Milano, presso la quale si laurea in
giurisprudenza nel 1969. Nel 1979 - dopo aver lavorato per la RAS come
supervisore - entra in magistratura e, dal 1972 al 1979, pera in qualità di
giudice nelle udienze della VII sezione penale della Corte di Milano. Dal 1978
al 1989 è giudice istruttore e, dal 1987 al 1989, fa parte della commissione che
esamina i materiali riguardanti importanti processi contro il crimine
organizzato; l'analisi di tali procedimenti è situata all'interno della riforma
del Codice di Procedura Penale da parte del Ministero di Grazia e Giustizia. Dal
1987 al 1990 partecipa in qualità di osservatore - per conto della Società
Internazionale di Difesa Sociale - alla commissione di esperti per la
cooperazione internazionale nella ricerca e nella confisca dei profitti
illeciti. Dal 1989 al 1992 è consulente per la Commissione parlamentare
d'inchiesta sul terrorismo in Italia, e nel 1993 è consulente per la Commissione
parlamentare d'inchiesta sulla mafia. Dal 1989 è pubblico ministero presso la
Procura della Repubblica di Milano. Fondamentale il suo contributo alle indagini
e ai processi nell'ambito dell'operazione Mani pulite. Nel marzo del 2005
è stato nominato Consigliere presso la Corte di Cassazione A metà febbraio del
2007, in casuale coincidenza dello scadere del 15º anno dall'inizio
dell'inchiesta Mani pulite, comunica le sue dimissioni da magistrato con
lettera al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministero della
Giustizia. Da allora si impegna nell'educazione alla legalità nelle scuole,
attraverso incontri con studenti di tutta Italia, e proprio per tale attività ha
ricevuto il Premio Nazionale Cultura della Pace 2008. Nel settembre 2009 viene
nominato presidente della casa editrice Garzanti Libri. È membro Onorario del
Comitato Scientifico d'Onore della Fondazione Rachelina Ambrosini. Il 5 luglio
2012 viene eletto nel cda della Rai su indicazione del Partito Democratico,
l'elezione è avvenuta da parte della commissione di vigilanza Rai.
FRANCESCO GRECO.
Francesco Greco. Da Giorgio Dell’Arti,
Catalogo dei viventi 2015. scheda aggiornata al 22 settembre 2014. Nato a
Napoli nel 1951. Magistrato. Procuratore aggiunto a Milano, è il coordinatore
del pool sui reati finanziari, titolare tra l’altro delle inchieste del crac
Parmalat e sulle scalate bancarie. Faceva parte del pool di Mani pulite. Figlio
di un ammiraglio, entrò in magistratura nel 1977, arrivò a Milano dopo aver
fatto l’uditore a Roma, «il suo nome acquista una piccola notorietà all’inizio
degli anni Ottanta, quando fa incarcerare Pietro Longo, segretario del Psdi,
responsabile di aver intascato una bustarella» (Il Foglio). «Da un punto di
vista politico, Greco può essere definito così: un cane sciolto molto di
sinistra. Che soprattutto aborre schieramenti e scuderie. Forse è anche per
questo che in 15 anni ha ottenuto tanti successi professionali ma ha fatto poca
(anzi nessuna) carriera. Raccogliendo molto rispetto (non c’è grande avvocato
milanese che non ne parli, anche in privato, più che bene), ma stringendo poche
amicizie» (Angelo Pergolini). Così lo descrive Luigi Bisignani ne L’uomo che
sussurra ai potenti (Chiarelettere, 2013): «Greco non è solo uno preparato,
è anche corretto, garbato e con una caratteristica precisa. Quando ti fa una
domanda sa già qual è la risposta, perché è uno dei pochi che studia davvero
carte e bilanci». Nel maggio 2014 fu fatto il suo nome come presidente di
Equitalia al posto di Attilio Befera, candidatura poi sfumata. «Mentre i
magistrati si azzuffano sull’attribuzione delle grandi inchieste, litigano
davanti al Csm e si dividono in fazioni, lui svetta su tutti per metafisico
potere e per superiorità professionale: è quasi un’algida statua di Fidia
piazzata lassù, in alto, sulle rovine del Partenone. In realtà Francesco Greco,
procuratore aggiunto e capo del pool reati economici e finanziari, è parte molto
attiva nella guerra che ha trasformato in trincea i corridoi al quarto piano del
tribunale: con la sua audizione al Csm si è rivelato come uno degli avversari
più tignosi di Alfredo Robledo, l’altro procuratore aggiunto che va accusando di
parzialità e abusi vari il capo, Edmondo Bruti Liberati. Il dio Greco però non
si espone come un’Ilda Boccassini: non si fa notare, non alza la voce. Sì, è
vero, ispira e firma il “manifesto” dei 62 sostituti favorevoli a Bruti e spinge
per la sua riconferma alla guida della procura. Ma intanto ostenta il lavoro
come strumento purificatore. (…) Una gioventù da extraparlamentare di sinistra,
una maturità spesa dietro a tutte le più importanti inchieste finanziarie
d’Italia, oggi Greco potrebbe essere davvero effigiato come copia moderna e solo
lievemente appesantita di Ermes, l’alato e astuto dio degli scambi: perché anche
lui nella corsa e nel dialogo si è rivelato un dio. Malgrado il fiato corto per
le troppe sigarette, Greco è sempre in corsa per qualche nomina e pronto a
dialogare con la politica. (…) Greco da febbraio (2014 – ndr) è il primo
consulente fiscale del governo di Matteo Renzi sul “dossier Svizzera” per il
rimpatrio dei capitali. Ma è dal lontano 1998 che la politica lo insegue, lo
corteggia, lo considera il terminale più adatto per interloquire con la Procura
di Milano. All’inizio di quell’anno, mentre in Parlamento la commissione
bicamerale pareva in dirittura d’arrivo sulla riforma della giustizia, il suo
presidente Massimo D’Alema spedì Giuliano Amato, ministro delle Riforme, da
Greco: voleva capire proprio da lui se i pm milanesi potessero condividere una
“soluzione politica” alla stagione di Mani pulite. Si incontrarono più volte.
Alla fine Greco, astutamente, disse che quella decisione “spettava al
Parlamento”. E cinque mesi dopo, in giugno, la bicamerale fallì. Poi il
magistrato si ributtò nei fascicoli giudiziari. In primo grado ottenne la prima
seria condanna a 4 anni per Silvio Berlusconi nel processo sulla frode fiscale
Mediaset, che il 1° agosto 2013 si è concluso con la sentenza definitiva che ha
affossato giudiziariamente il Cavaliere. Intanto di Greco e con Greco
la politica si era rimessa a parlare, e molto, già nel 2005: in estate per le
sue inchieste sulle parallele scalate all’Antonveneta e alla Bnl, e per quella
dell’immobiliarista Stefano Ricucci alla Rcs; in dicembre per la voce che lo
voleva successore di Antonio Fazio al vertice della Banca d’Italia. In quel
periodo il pm si occupava del processo per il crac Parmalat, scriveva per il
Sole 24 Ore e sosteneva che “il mercato finanziario italiano è il Far West
dell’Occidente”. Da allora Greco è stato candidato ai più prestigiosi incarichi
istituzionali in campo finanziario e tutti gli ultimi 5 governi, di destra come
di sinistra, gli hanno affidato l’incarico di sovrintendere a qualche
fondamentale riforma. (…) Perché Greco piace a sinistra? Perché di quella parte
è sempre stato. Trascorsi giovanili nell’estrema più dura & arrabbiata (ai tempi
di Tangentopoli esponeva sulla scrivania un ritratto di sé molto barbuto, molto
capelluto, infagottato in un eskimo da battaglia), Greco è stato redattore di
Mob, una rivista che alla fine degli anni Settanta era in prima linea nel
contestare la legislazione antiterrorismo. Dal suo primo ingresso in tribunale,
nel 1977, è stato vicino a Magistratura democratica, corrente di cui certo
sottoscriveva “il rifiuto di un percorso gradualista che abbia come obiettivo la
riforma del sistema capitalista”. Poi, con la vita e i processi, l’uomo si è
moderato. Signorile nei modi come può esserlo il figlio di un ammiraglio
napoletano, appassionato di vela e sci, Greco è stato un grande amico di
Guido Rossi, il re degli avvocati d’affari con il quale per anni ha condiviso le
vacanze alla Maddalena. In quell’isola, nell’estate 2008, Greco è stato
fotografato seduto al bar in amichevole colloquio con Beppe Grillo. Nessuno ha
mai svelato il mistero di quell’incontro, che però resta negli archivi come
segno di un dialogo aperto anche con i 5 stelle. Meno facile è capire perché
Greco piaccia anche a destra. Da quelle parti, è evidente, lo si teme ma lo si
stima. Forse per l’equilibrio da sempre esibito nel ricorso alla custodia
cautelare: dicono che il 23 luglio 1993, alla notizia che Raul Gardini si era
sparato in vista dell’arresto chiesto da Antonio Di Pietro, Greco abbia pianto.
“Non sono mai stato un appassionato di galere e manette” avverte. Tremonti l’ha
introdotto nell’Aspen institute, l’esclusivo circolo bipartisan nel cui
esecutivo siedono Prodi e Gianni Letta, Fedele Confalonieri e Francesco Micheli.
(…) Anche nelle aule di tribunale, va detto, la lunga corsa di Greco ha
incontrato rari ostacoli. (…)» (Maurizio Tortorella) [Pan 29/5/2014]. Sposato
prima con un medico, poi con una collega.
ANTONIO DI PIETRO.
Antonio Di Pietro. Da Wikipedia,
l'enciclopedia libera. Antonio Di Pietro (Montenero di Bisaccia, 2
ottobre 1950) è un politico, avvocato ed ex magistrato italiano.
Ha fatto parte del pool di Mani pulite come sostituto procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Milano; nel 1996 è entrato in politica, e nel
1998 ha fondato il partito Italia dei Valori dal quale, nell'ottobre 2014, si
allontana lasciando tutti gli incarichi. Dal punto di vista ideologico Di Pietro
dichiara di essere di estrazione cattolica e di non essere né di destra né di
sinistra, in un rifuggire dagli estremi che lo porta a considerarsi un liberale
e un uomo di centro. Dopo aver conseguito un diploma di perito elettronico, nel
1971 a 21 anni emigra a Böhmenkirch, in Baden-Württemberg (Germania); la sua
giornata si suddivide fra un lavoro da operaio lucidatore di metalli in una
fabbrica metalmeccanica e un altro, il pomeriggio, in una segheria. Tornato in
Italia, nel 1973, inizia gli studi all'Università degli Studi di Milano presso
la facoltà di giurisprudenza, mentre lavora come impiegato civile
dell'Aeronautica Militare. Nel 1978 termina gli studi universitari conseguendo
la laurea; l'anno successivo, attraverso un pubblico concorso, assume le
funzioni di segretario comunale in alcuni comuni del comasco. Nel 1980 vince un
concorso della Polizia di Stato per Commissario e frequenta la Scuola Superiore
di Polizia. Successivamente viene inviato al IV distretto come responsabile
della Polizia Giudiziaria. Nel 1981, sempre alternando lavoro e studio, vince il
concorso di uditore giudiziario: è assegnato, con funzione di Sostituto
Procuratore, alla Procura della Repubblica di Bergamo. Nel 1985 passa alla
Procura della Repubblica di Milano, dove si occupa soprattutto di reati contro
la pubblica amministrazione. Si fa notare per la sua padronanza degli strumenti
informatici, che gli consente una notevole velocizzazione delle indagini e un
efficiente collegamento dei dati processuali. In questo modo, all'epoca di
Tangentopoli, può svolgere una notevolissima mole di lavoro. Nel 1989 il
Ministero di Grazia e Giustizia lo nomina consulente per l'informazione e membro
di alcune commissioni ministeriali per la riorganizzazione informatizzata dei
servizi della pubblica amministrazione. Nel 1991, in un articolo pubblicato sul
mensile milanese Società civile, Di Pietro sostenne che la tangente data
al politico dall'imprenditore in cambio dell'appalto costituiva un sistema così
pervasivo da rappresentare la norma, nella Milano degli anni novanta; la
tangente, che egli chiamava «dazione ambientale», a suo parere veniva oramai
data talmente per scontata che praticamente non era necessario né chiederla né
proporla: era automatica, «ambientale», appunto. « Più
che di corruzione o di concussione, si deve parlare di dazione ambientale,
ovvero di una situazione oggettiva in cui chi deve dare il denaro non aspetta
più nemmeno che gli venga richiesto; egli, ormai, sa che in quel determinato
ambiente si usa dare la mazzetta o il pizzo e quindi si adegua.» Le prove
di quanto affermato in quell'articolo arriveranno con l'arresto di Mario Chiesa,
il primo tassello di un gigantesco "effetto domino" che dette l'avvio alla fine
della I Repubblica. Quale pubblico ministero di punta del cosiddetto Pool di
Mani pulite, composto anche da altri magistrati come Gherardo Colombo,
Piercamillo Davigo, Ilda Boccassini e Armando Spataro, coordinati da Francesco
Saverio Borrelli, ha messo sotto inchiesta per corruzione centinaia di politici
locali e nazionali, tra cui alcune figure politiche di primo piano, come il
segretario del Partito Socialista Italiano, Bettino Craxi. In riferimento ai
fatti di quegli anni, Di Pietro ha rivelato, durante la puntata dell'8 ottobre
2009 della trasmissione televisiva Annozero, che, pochi giorni prima
della strage di via d'Amelio (19 luglio 1992), in seguito ad una nota riservata
dei ROS che lo indicava come probabile obiettivo di un imminente attentato, fu
messo sotto protezione ed espatriato in Costa Rica, sotto il falso nome di Marco
Canale. « C'era una riservata del ROS che diceva:
"guardate che Borsellino e Di Pietro devono
essere fatti fuori". Io vengo avvertito, tant'è che (...) a me viene dato
un passaporto (...) di copertura a nome Marco Canale.» Il 6 dicembre del
1994, poco prima che si riuscisse a tenere alla Procura di Milano
l'interrogatorio, che era previsto per il 26 novembre, dell'allora Presidente
del Consiglio Silvio Berlusconi, indagato per corruzione, si dimetterà dalla
magistratura. La spiegazione resa all'epoca fu quella di voler evitare "di
essere tirato per la giacca", ma su questo dettaglio si ebbero nel tempo, da
parte dello stesso Di Pietro, varie versioni: Di Pietro prima addusse l'esigenza
che i veleni sul suo conto - dal "poker d'assi" di Rino Formica al dossier de
"Il Sabato", dall'inchiesta del GICO sull'autosalone di via Salomone alle
indagini bresciane attivate dalle denunce degli inquisiti - non danneggiassero
l'immagine della Procura di Milano. Successivamente lamentò come ragione
scatenante la fuga di notizie sull' avviso di garanzia a Berlusconi, reso noto
durante la conferenza di Napoli sul crimine transnazionale mentre Di Pietro si
trovava a Parigi per rogatorie internazionali. Una sentenza assolutoria nei
confronti di diversi imputati, tra cui Paolo Berlusconi e Cesare Previti,
accusati di aver fatto indebite pressioni affinché Di Pietro abbandonasse la
magistratura, ha sostenuto che Di Pietro si fosse già determinato a lasciare la
toga, presumibilmente per darsi alla politica, quando venne avanzata la
richiesta di interrogare Silvio Berlusconi. La sentenza afferma anche che alcuni
fatti ascrivibili al magistrato potevano presentare rilevanza disciplinare.
Subito dopo le elezioni del 27 marzo 1994, Silvio Berlusconi gli chiede di
abbandonare la magistratura e di entrare a far parte del suo governo come
Ministro dell'Interno. Quando il Governo Berlusconi I era in formazione, ci
furono una serie di incontri tra Silvio Berlusconi e Di Pietro, falliti
definitivamente il 7 maggio 1994, con l'ultimo no di Di Pietro a Berlusconi a
qualunque incarico di governo. Di Pietro di fronte a numerosi giornalisti ha
sostenuto che, pur dichiarandosi lusingato, non accettò perché preferiva
continuare il suo lavoro di magistrato, seguendo il consiglio di Francesco
Saverio Borrelli (che avrebbe rivolto, con analogo successo, lo stesso consiglio
a Piercamillo Davigo, cui Ignazio La Russa avrebbe offerto il ministero della
giustizia). Secondo quanto affermato da Cesare Previti nel 1995, a Di Pietro era
stato offerto il ministero degli Interni e quest'ultimo aveva manifestato la sua
disponibilità. Le affermazioni di Previti contrastano con quelle fatte da
Berlusconi durante l'ultima campagna elettorale e nel 1996, quando sostenne di
non aver avuto il tempo di formulare l'offerta in questione, poiché Di Pietro lo
aveva già messo al corrente del fatto che gli era stato sconsigliato di
accettare l'offerta. Nel luglio del 1995 in un interrogatorio presso la procura
di Brescia circa i suoi rapporti con Di Pietro, Silvio Berlusconi riferì di aver
proposto al magistrato la direzione dei servizi segreti. Anni dopo, nella
campagna elettorale del 2008, Berlusconi ha negato di aver offerto un Ministero
a Di Pietro. Nel 1996 chiamato da Romano Prodi accetta di divenire ministro nel
suo Governo sostenuto dalla coalizione dell'Ulivo, appena insediatosi dopo la
vittoria nelle elezioni politiche di aprile. L'incarico affidatogli è il
Ministero dei Lavori pubblici, ma decide di presentare le sue dimissioni dopo
sei mesi, il giorno dopo in cui gli viene notificata da Brescia una nuova
indagine nei suoi confronti (avviso di garanzia). Prodi respinge le dimissioni,
ma Di Pietro non vuole tornare sui suoi passi. Verrà poi prosciolto dai 27 capi
di accusa in tutti e dieci i processi perché il fatto non sussiste. Il 20 giugno
1997 il senatore del PDS Pino Arlacchi è nominato vicesegretario generale delle
Nazioni Unite. Nelle settimane successive Massimo D'Alema d'intesa con Romano
Prodi offrono a Di Pietro la possibilità di sostituire Arlacchi candidandosi per
l'Ulivo nel collegio senatoriale del Mugello, in Toscana. Di Pietro accetta
inaugurando così la sua attività politica. Il 9 novembre 1997 si tengono dunque
le elezioni suppletive che Di Pietro vince contro Giuliano Ferrara per la
coalizione di Silvio Berlusconi, Sandro Curzi per il PRC, e Franco Checcacci per
la Lega Nord, con il 67,8% dei voti. Diventa così senatore e, come indipendente,
aderisce al gruppo misto. Il neosenatore però lavora subito per la creazione di
un gruppo parlamentare proprio, ma nel febbraio 1998 è costretto a rinunciarci
preferendo lavorare alla creazione di un proprio movimento politico. Nasce così,
il 21 marzo seguente a Sansepolcro, Italia dei Valori. A fondare il movimento ci
sono anche Elio Veltri, la cui moglie è l'amica di famiglia Silvana Mura (oggi
parlamentare e capogruppo IDV) che vede l'adesione anche di altri parlamentari,
e insieme a loro forma un sottogruppo. Dopo la caduta del Governo Prodi I
dell'ottobre del 1998, si verificano dei cambiamenti nell'assetto dei partiti
alleati. Di Pietro è un sostenitore di Romano Prodi, lo considera come unico
punto di riferimento, aderisce al progetto dei Democratici, che intende portare
avanti l'idea unitaria formale dei partiti che sono a fondamento dell'Ulivo.
Così nel febbraio 1999 viene deciso lo scioglimento del giovane movimento, per
farlo confluire, insieme ad altre formazioni politiche, in quello di Prodi. Di
Pietro viene scelto per svolgere l'importante ruolo di responsabile
organizzativo. I Democratici debuttano alle elezioni europee dello stesso anno,
ottenendo il 7,7% dei voti e sette seggi, e Di Pietro viene eletto eurodeputato
con funzioni di Presidente di Delegazione del Parlamento europeo dapprima per le
relazioni con il Sud America, poi per l'Asia centrale ed infine per il
Sudafrica. In seguito a ripetuti dissidi con la linea portata avanti da Arturo
Parisi, leader del partito, con il culmine nello strappo avvenuto quando Di
Pietro sceglie di non votare la fiducia al nuovo governo Amato, il 27 aprile
2000 si separa dai Democratici. Rifonda quindi Italia dei Valori come partito
autonomo nel settembre dello stesso anno, sempre con l'obiettivo di portare
avanti le proprie battaglie politiche, mettendo sempre in primo piano temi come
la valorizzazione e l'affermazione della legalità e la necessità di trasparenza
amministrativa e a livello politico. Pur d'accordo nel contrastare la coalizione
guidata da Silvio Berlusconi, per le elezioni politiche del 2001 Di Pietro non
riesce a trovare un accordo e si presenta quindi da solo alla competizione
elettorale. Tuttavia non risulterà eletto, non riuscendo a spuntarla nel
collegio uninominale in Molise e non superando, con la sua lista al
proporzionale, la soglia del 4%, seppur di poco (3,9%). Alla vigilia delle
elezioni europee del 2004, Di Pietro aderisce all'appello di Prodi di
presentarsi sotto un unico simbolo nel nome dell'Ulivo. Ma non tutti sono
d'accordo con l'ingresso di Di Pietro (il fronte dell'opposizione è guidato dai
socialisti dello SDI). E così nasce una nuova intesa elettorale con Achille
Occhetto: insieme presentano la Lista Società Civile, Di Pietro-Occhetto,
Italia dei Valori. Nel suo simbolo, la lista inserisce la dicitura "Per il
Nuovo Ulivo", con un piccolo ramoscello d'ulivo, per sottolineare la chiara
intenzione di partecipare alla rinascita e al rafforzamento della coalizione.
Prodi, in un primo momento, plaude all'idea, ma poi Di Pietro e Occhetto (a
campagna elettorale già avviata) sono costretti ad eliminare quel frammento del
loro simbolo perché - dicono dalla coalizione - si potrebbe generare confusione
fra gli elettori che potrebbero confonderlo con il "vero" Ulivo. La lista,
comunque, corre regolarmente alle elezioni, ma il progetto è un fallimento:
raccoglie soltanto il 2,1%. Occhetto abbandona immediatamente l'alleanza,
cedendo il seggio di parlamentare europeo in favore del giornalista Giulietto
Chiesa (come aveva anticipato prima delle elezioni) e conservando quindi il suo
seggio al Senato. Di Pietro viene rieletto al Parlamento europeo nella
circoscrizione sud, dopo aver ricevuto in tutta Italia quasi 200 000 preferenze.
Iscritto al gruppo parlamentare dell'Alleanza dei Democratici e Liberali per
l'Europa; membro della Conferenza dei presidenti di delegazione; della
Commissione giuridica; della Commissione per le libertà civili, la giustizia e
gli affari interni; della Delegazione per le relazioni con il Sudafrica.
Intanto, nasce la nuova coalizione di centrosinistra, chiamata L'Unione,
che si apre ai contributi di Italia dei Valori e di Rifondazione Comunista. Il
nuovo schieramento debutta alle elezioni regionali dell'aprile 2005: IdV ne è
parte integrante in tutte le 14 regioni chiamate al voto, ma il partito conferma
il suo trend negativo, raggranellando soltanto l'1,8% dei voti. Prodi, in vista
delle elezioni politiche del 2006, lancia l'idea delle consultazioni primarie
per la scelta del candidato premier. Il progetto va in porto, le primarie si
organizzano e Di Pietro presenta subito la sua candidatura. Le primarie si
svolgono il 16 ottobre 2005 con sette candidati: Di Pietro è arrivato quarto,
raccogliendo 142.143 voti (il 3,3% dei consensi), alle spalle di Romano Prodi,
che ha ricevuto l'investitura di candidato premier della coalizione, di Fausto
Bertinotti e Clemente Mastella. Le elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006
fanno registrare un avanzamento dell'Italia dei Valori (che si attesta al 2,3%
alla Camera e al 2,9% al Senato) grazie anche al buonissimo risultato conseguito
in una circoscrizione tradizionalmente ostica per Di Pietro ed il
centrosinistra, la Sicilia, in cui decisiva fu la presenza nelle liste dell'IdV
di Leoluca Orlando, da un anno segretario regionale del movimento in terra
sicula e che successivamente verrà nominato presidente del partito. Il successo
nelle consultazioni arride all'Unione ed il 17 maggio 2006 Di Pietro viene
nominato Ministro delle Infrastrutture nel secondo Governo Prodi. Lascia
l'incarico di europarlamentare per accettare quello di deputato nazionale. In
qualità di ministro delle infrastrutture, sospende la procedura di fusione tra
la società autostrade e l'omologa spagnola Abertis, eccependo il danno economico
che lo Stato avrebbe avuto dall'esecuzione di tale piano. Nel luglio del 2006
scoppia una polemica interna alla coalizione di governo, in particolare nei
confronti del Ministro della Giustizia Clemente Mastella, a causa della forte
contrarietà del partito di Di Pietro ad inserire i reati finanziari, societari e
di corruzione all'interno del provvedimento di indulto. Il provvedimento è
sostenuto, invece, in maniera trasversale da esponenti e partiti di entrambi gli
schieramenti, esclusa la Lega Nord, il Partito dei Comunisti Italiani e gran
parte di Alleanza Nazionale. Di Pietro manifesta davanti a Palazzo Madama prima
dell'approvazione del provvedimento al Senato, insieme alla Lega Nord. Tuttavia,
al contrario di tale partito, Di Pietro si è dichiarato a malincuore favorevole
all'indulto come mezzo per svuotare le carceri solo dopo un cambiamento della
riforma Castelli, come previsto dal programma dell'Ulivo. Tali richieste non
vengono accolte e Di Pietro pubblica polemicamente sul suo sito web personale i
nomi dei deputati che hanno votato a favore dell'indulto, tra i quali anche
Federica Rossi Gasparrini dell'Italia dei Valori, poi passata all'Udeur. Afferma
Di Pietro: « È sconcertante, davvero sconcertante,
vedere l'Unione rinnegare nei fatti, con questo
indulto, il programma che ha presentato ai cittadini e per cui è stata eletta.
Il cittadino conta meno di zero, non può scegliere i suoi rappresentanti (con
riferimento alla legge elettorale senza preferenze, ndr) e neppure vedere
rispettato il programma di governo. A cosa serve l'istituzione parlamentare
oggi? Quanto è lontana dagli elettori? È una domanda che noi politici dobbiamo
farci e alla quale è necessario dare presto delle risposte.» In occasione
delle elezioni politiche del 2008, Di Pietro entra in coalizione con il Partito
Democratico. Il suo partito ottiene il 4,4% alla Camera dei Deputati e il 4,3%
al Senato raddoppiando i suoi voti; l'ex magistrato sceglie di essere eletto nel
natìo Molise, dove aveva raggiunto il miglior risultato in Italia, superando in
entrambe le camere il Partito Democratico.
Nel 2013, in occasione delle elezioni politiche del 2013, decide di rinunciare a
presentarsi con il suo partito per appoggiare la lista Rivoluzione Civile,
guidata dal candidato premier ed ex magistrato Antonio Ingroia. Tuttavia i
risultati delle elezioni non consentono a questa lista di superare le rispettive
soglie di sbarramento per Camera e Senato, così Di Pietro resta fuori dal
Parlamento. Il 26 febbraio si dimette da presidente dell'Italia dei Valori e il
2 maggio Rivoluzione Civile viene disciolta all'unanimità dai suoi costituenti.
Il 28 giugno al Congresso dell'Italia dei Valori ufficializza le sue dimissioni
da presidente del partito dichiarando di rimanere però militante dello stesso.
Il nuovo leader del movimento è Ignazio Messina. Nel febbraio 2014, nel corso
del programma L'aria che tira, annuncia la sua candidatura alle Elezioni
europee di maggio non venendo poi candidato. Il 3 ottobre 2014, poco prima del
raduno nazionale di Sansepolcro, Di Pietro decide di lasciare definitivamente
l'Idv. Un voto che lo vede nettamente in minoranza (il 95% dei delegati approva
infatti la linea politica del segretario Messina) sancisce l'addio al partito
che, nel 1998, aveva fondato proprio nella località toscana. Di Pietro, in
particolare, volendo portare avanti un'opposizione dura al Governo Renzi, già
dopo le elezioni europee aveva criticato la scelta di riallacciare un rapporto
di dialogo con il Pd. Di Pietro si schiera insieme a Casini ed a tutta la Casa
delle Libertà contro la rimozione del capo della polizia De Gennaro,
responsabile della polizia in carica durante le violenze del G8, adducendo come
motivazione "non tanto il gesto ma le modalità di esecuzione", ritenendo
preferibile che non venisse prontamente allontanato, troppo veementemente, un
capo della polizia indagato per istigazione alla falsa testimonianza,
allontanamento che Di Pietro definisce "una vendetta della sinistra
massimalista". Altri membri del suo partito in tale occasione si sono augurati
che a De Gennaro venissero affidati altri prestigiosi incarichi, cosa
puntualmente accaduta, con la nomina a capo del gabinetto da parte di Amato. Di
Pietro dichiara di opporsi alla riforma sulle intercettazioni che, a suo dire,
avrebbe come obiettivo l'imbavagliamento dei giornalisti e la limitazione dei
poteri della magistratura. L'ex magistrato sostiene le ragioni di Europa 7, che
da tempo cerca di ottenere le frequenze per trasmettere, situazione per la quale
lo Stato Italiano ha subito procedura di infrazione da parte della Comunità
europea in data 19 luglio 2006 [2005/5086 C(2006) 3321]. In seguito alla
condanna in primo grado di Salvatore Cuffaro per favoreggiamento semplice, ha
scritto al Presidente del Consiglio, Romano Prodi, chiedendo la sospensione di
diritto di Cuffaro, ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55. Nel 2008, dopo le
dimissioni di Mastella da Ministro della Giustizia, ha scritto a Romano Prodi,
che aveva preso l'interim. In questa lettera, ha denunciato le nomine del
Comitato direttivo della Scuola della Magistratura di Benevento, a cui, fra gli
ultimi atti che aveva compiuto come ministro, Mastella aveva nominato persone
del suo collegio elettorale, fra cui l'avvocato difensore della moglie dello
stesso Mastella. Annuncia l'adesione di IdV all'iniziativa della rivista
MicroMega per la manifestazione nazionale dell'8 luglio 2008 in Piazza Navona,
contro le cosiddette "Leggi canaglia", denominata No Cav Day. La sua
posizione riguardo al reato di immigrazione è cambiata diverse volte. Egli è
passato dal considerarlo giusto (arrivando ad affermare che alcuni immigrati
"meriterebbero il taglio degli attributi" e a sostenere pene detentive fino a
tre anni nei confronti degli immigrati irregolari) al contrastarlo
(considerandolo la causa del sovraffollamento carcerario e dichiarando che gli
immigrati "non possono essere considerati di serie B, ma devono avere gli stessi
diritti e doveri, a cominciare da quelli elettorali, dei cittadini"). Nel marzo
2010, in seguito alla firma del Presidente della Repubblica Napolitano sul
decreto legge che avrebbe permesso la riammissione delle liste PdL nel Lazio e
in Lombardia, Di Pietro affermò che bisognava valutare se ci fossero gli estremi
per mettere sotto impeachment il Presidente della Repubblica in quanto, a suo
dire, il Presidente della Repubblica aveva violato la Costituzione contribuendo
alla stesura del testo. L'attacco suscitò la reazione sdegnata sia del governo,
sia del resto dell'opposizione. Dopo le proteste del Movimiento 15-M che il 15
ottobre 2011 sono degenerate in duri scontri a Roma, il 17 ottobre 2011 alcuni
organi di informazione hanno attribuito ad Antonio Di Pietro la volontà di
introdurre una nuova "Legge Reale" per gestire situazioni di violenza durante le
manifestazioni, mentre lo stesso Di Pietro ha subito respinto e smentito tali
affermazioni.
Indagini giudiziarie e aspetti controversi.
L'inchiesta di Brescia. Dopo questi
anni da protagonista della magistratura italiana, sono partite contro di lui
diverse indagini giudiziarie, tutte risolte in assoluzioni piene o
archiviazioni. Nel 1995 viene indagato dal sostituto procuratore di Brescia
Fabio Salamone, ipotizzando reati di concussione e abuso d'ufficio in seguito a
dichiarazioni rese dal generale Cerciello (sotto accusa in un processo sulla
corruzione della guardia di finanza) ma il giudice per le indagini preliminari
archivia il procedimento. Una seconda indagine viene aperta sempre a Brescia
sulla base di affermazioni dall'avvocato Carlo Taormina (allora difensore del
generale Cerciello), la testimonianza di Giancarlo Gorrini e dossier anonimi su
presunti traffici illeciti tra l'ex pm e una società di assicurazioni.
L'inchiesta successivamente prende una strada completamente diversa e il pm
Salamone arriva ad ipotizzare un complotto finalizzato a far dimettere Di Pietro
per mezzo di ricatti e dossier anonimi. Per fare luce sulla vicenda il pm
interroga gli ispettori ministeriali Dinacci e De Biase, i ministri Alfredo
Biondi, Cesare Previti e il presidente del consiglio Silvio Berlusconi, mentre
suo fratello Paolo viene indagato per estorsione. Secondo le ricostruzioni dei
pm tutto sarebbe iniziato dopo che fu recapitato a Silvio Berlusconi un invito a
comparire dalla procura di Milano il 21 novembre 1994: Previti avrebbe
telefonato all'ispettore ministeriale Dinacci e l'avrebbe messo in contatto con
Gorrini il quale si sarebbe presentato lo stesso giorno all'ispettorato per
presentare le sue documentazioni contro Di Pietro. Questo avveniva il 23
novembre 1994. Il 29 il ministro Alfredo Biondi ha ordinato di aprire
l'inchiesta su Di Pietro. Il 6 dicembre Di Pietro annuncia le dimissioni ed il
10 l'inchiesta viene archiviata. È allora che Salamone mette sotto controllo
diversi telefoni e dalle telefonate di Gorrini sulla vicenda emerge il nome di
Paolo Berlusconi, suo conoscente e l'incriminazione per lo stesso.
Successivamente vengono incriminati anche Cesare Previti, Sergio Cusani per
estorsione e lo stesso Silvio Berlusconi per estorsione ed attentato ai diritti
politici del cittadino. In questa inchiesta emerge l'esistenza di un dossier del
SISDE su Di Pietro chiamato "Achille". Dopo le indagini si arriva ad un processo
con imputati Previti, Paolo Berlusconi e gli ispettori ministeriali che
indagarono sul Di Pietro. Il 18 ottobre 1996, mentre è ancora in corso il
processo sul presunto complotto contro Di Pietro, la procura generale di Brescia
rimuove dall'incarico i pm Salamone e Bonfigli per una presunta "grave
inimicizia" con Di Pietro (che comunque non era imputato) che "giunge al livello
di pervicace odio privato". Il successivo ricorso in cassazione di Salamone
contro la decisione della procura viene respinto. Il 21 gennaio 1997 il
procuratore che sostiene la pubblica accusa in sostituzione di Salamone
(Raimondo Giustozzi) rinuncia ad interrogare i testimoni convocati dall'accusa e
chiede subito l'assoluzione per tutti gli imputati. Istanza che viene accolta
dal giudice.
Accusa di offesa e attacchi verso Napolitano.
Il 3 febbraio 2009 Di Pietro è stato iscritto nel registro degli
indagati dalla Procura di Roma con l'accusa di Offesa all'Onore o al Prestigio
del Presidente della Repubblica (articolo 278 del codice penale). L'atto è
conseguente alla denuncia presentata il 31 gennaio dall'Unione delle Camere
Penali Italiane, secondo la cui lettura dei fatti Di Pietro, nel corso del suo
intervento durante la manifestazione organizzata dall'Associazione Nazionale
Familiari Vittime di Mafia il 28 gennaio 2008 a Piazza Farnese, non si
sarebbe limitato a criticare il comportamento del Presidente Napolitano, ma
avrebbe attribuito un atteggiamento mafioso ai suoi silenzi. Dal canto suo, Di
Pietro ha risposto dal suo blog definendo l'iniziativa "Una mossa puramente
politica [...] da parte del professore Oreste Dominioni, che sostiene di "non
essere amico di questo o di quel governo", ma che è anche avvocato di famiglia
Berlusconi oltre che Presidente dell'Unione delle Camere Penali", invitando
anche a rivedere il video del suo intervento al fine di verificare come
l'affermazione "il silenzio è mafioso" fosse inserita nella frase "Non
siamo d'accordo sull'oblio che le istituzioni hanno nei confronti di questi
familiari delle vittime. Vediamo le vittime del terrorismo, della mafia, della
criminalità che vengono dimenticate ed abbandonate a sé stesse. Lo possiamo
dire, o no? Rispettosamente! Ma il rispetto è una cosa, il silenzio un'altra: il
silenzio uccide, il silenzio è mafioso, il silenzio è un comportamento mafioso.".
Proprio in virtù di ciò il 13 febbraio 2009 la Procura della Repubblica di Roma,
per mezzo del Procuratore Giovanni Ferrara e del PM Giancarlo Amato, ha
richiesto l'archiviazione, ritenendo che: « "Una lettura attenta del complessivo
intervento dell'onorevole Di Pietro consente di escludere che i riferimenti al
'silenzio mafioso' abbiano avuto quale destinatario il presidente della
Repubblica. [...] Dovendosi esse [le affermazioni riferite al Capo dello
Stato, NdR] invece inquadrarsi nell'esercizio di un legittimo diritto di
critica che è consentito anche nei confronti delle più alte cariche dello Stato
se espresso in forme continenti (qui senz'altro ravvisabili), nessuna offesa
all'onore ovvero al prestigio del capo dello Stato possono essere ipotizzate. Da
qui la ritenuta impossibilità di configurare la fattispecie prevista
dall'articolo 278 c.p. e la conseguente decisione di non richiedere l'apposita
autorizzazione prevista dall'art.313 primo comma c.p. nei confronti
dell'indagato"». Di Pietro è tornato ad attaccare il Presidente della Repubblica
sostenendo che la bocciatura dei referendum sulla legge elettorale avvenuta il
12 gennaio 2012 da parte della Corte Costituzionale sarebbe stata una scelta non
giuridica ma di favore per compiacere il Capo dello Stato e la sua «maggioranza
inciucista». Giorgio Napolitano ha replicato immediatamente che si tratta di
«un'insinuazione volgare e del tutto gratuita che denota solo scorrettezza
istituzionale».
Immunità parlamentare per diffamazione.
Nell'aprile 2009 il Parlamento Europeo ha confermato (654 voti
favorevoli, 11 contrari e 13 astenuti) l'immunità parlamentare a vantaggio di Di
Pietro, bloccando la causa civile per diffamazione intentatagli dal giudice
Filippo Verde a seguito di un articolo pubblicato sul sito dell'Italia dei
Valori. Nel commentare il processo pendente dinanzi al Tribunale di Milano per
la vicenda IMI-SIR/Lodo Mondadori, Di Pietro affermava che Verde era stato
accusato di corruzione per aver accettato una tangente al fine di "aggiustare"
una sentenza. In effetti, Filippo Verde non è mai stato coinvolto nella vicenda
processuale del Lodo Mondadori, mentre lo è stato nel processo IMI-SIR,
nell'ambito del quale era stato assolto da tutte le imputazioni contestategli.
L'unico italiano che si è espresso con voto contrario è stato Roberto Fiore,
europarlamentare di Forza Nuova. Ha invocato l'immunità parlamentare anche nel
procedimento civile intentato da Salvatore Cuffaro presso il Tribunale di
Palermo. In questo caso, il Tribunale non ha riconosciuto la sussistenza dei
presupposti per l'insindacabilità delle proprie affermazioni ed ha condannato
l'ex pm di mani pulite a risarcire Salvatore Cuffaro. La causa civile era stata
avviata perché Di Pietro aveva linkato sul proprio sito internet,
www.antoniodipietro.it , il video "Costanzo Show Cuffaro aggredisce Falcone" ed
aveva affermato che Cuffaro avesse screditato Falcone. Il Tribunale di Palermo,
con sentenza n. 1742/2013, ha riconosciuto che Cuffaro non aveva detto nulla
contro Giovanni Falcone ed ha considerato diffamatorie le affermazioni di
Antonio Di Pietro.
Sospensione dal Foro. L'Ordine degli
Avvocati di Bergamo, Foro presso il quale l'ex magistrato attualmente esercita
la professione di avvocato, in data 7 luglio 2009, ha inflitto ad Antonio Di
Pietro la sanzione della sospensione disciplinare per la violazione del divieto
di assumere incarichi contro ex clienti di cui all'articolo 51 del codice
deontologico della professione forense. Il riferimento è al processo, svoltosi
in Corte d'Assise a Campobasso, nel quale Di Pietro era il legale di parte
civile per l'omicidio di Giuliana D'Ascenzo, compaesana di Montenero di
Bisaccia, e nel quale imputato era Pasqualino Cianci, precedentemente assistito
proprio da Di Pietro.
A cena con SISDE e CIA. Nel 2010
vengono rese pubbliche alcune foto risalenti al 1992 che ritraggono Di Pietro a
cena in una caserma dei carabinieri con alcuni esponenti dei servizi segreti,
tra i quali Bruno Contrada che solo nove giorni dopo sarà arrestato e poi
condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione di tipo
mafioso. Alla cena erano presenti anche alcuni agenti statunitensi della CIA.
CEPU. Fondato nel 1995, il CEPU ha
inizialmente goduto dell'amicizia tra il suo fondatore Francesco Polidori e Di
Pietro, che prese parte alle prime campagne pubblicitarie e tenne seminari in
qualità di docente di Tecnica processuale. Inoltre, nel 1998 Di Pietro fondò
l'Italia dei Valori in un hotel di Sansepolcro di proprietà del gruppo di
Polidori. Successivamente, i legami tra Di Pietro e Polidori si sono indeboliti,
e quest'ultimo si è candidato nella lista "Federalismo Democratico Umbro" senza
stringere alleanze con partiti già presenti in Parlamento.
L'inchiesta di Report. Una puntata di
Report dell'ottobre 2012 dedicata al patrimonio personale di Di Pietro ha
suscitato notevoli polemiche che hanno avuto influenza anche sul partito Italia
dei Valori, contribuendo alla fuoriuscita di alcuni esponenti, tra cui Massimo
Donadi. Nella trasmissione si è affermato che Di Pietro sarebbe intestatario di
56 immobili ( compresi garage, cantine e terreni), del valore stimato intorno ai
15 milioni di euro, e che parte di essi sarebbe stato acquistato utilizzando
fondi ricavati dai rimborsi elettorali e da un lascito. Peraltro diverse accuse
presentate verso Di Pietro erano già state valutate dalla magistratura, con
sentenze a lui favorevoli. Di Pietro, tramite il suo blog, si è subito difeso
portando come prova le visure catastali. Da questi documenti emergerebbe secondo
Di Pietro che "un modesto appartamento diviso in due e da me regalato nel 2008
ai miei figli Anna e Totò, a Milano, è diventato nella campagna di calunnia 15
case"; ha aggiunto inoltre di aver "messo a disposizione di chiunque i documenti
che dimostrano come in quell’agguato travestito da inchiesta siano state fatte
passare per mie proprietà marciapiedi, svincoli, strade di accesso e persino
giardinetti pubblici". Sempre dagli incartamenti del catasto si dedurrebbe che i
due appartamenti di Bergamo costituiscono in realtà un solo appartamento,
acquistato dalla moglie Susanna Mazzoleni. Ha infine dichiarato che sporgerà
querela contro la giornalista di Report che ha condotto l'inchiesta.
Tuttavia, nonostante gli
annunci, decorso il termine di novanta giorni, Di Pietro non ha sporto querela,
ma ha annunciato una causa civile.
Parte civile al processo per compravendita di senatori.
Nel febbraio 2014 si costituisce parte civile per l'IdV al
processo sulla presunta compravendita di senatori da parte di Silvio Berlusconi.
La famiglia. Antonio Di Pietro si è
sposato nel 1973 con Isabella Ferrara, da cui lo stesso anno ha avuto il figlio
Cristiano il quale siede nel consiglio regionale del Molise con l'IDV. Dopo il
divorzio, si è sposato in seconde nozze nel 1994 con Susanna Mazzoleni, avvocato
di famiglia benestante bergamasca (padre anch’egli avvocato e nonno notaio). Con
lei ha avuto due figli: Anna e Antonio Giuseppe, detto Totò. Nel 2002 diventa
nonno di tre gemelli.
Il tumore benigno alla prostata. Il 1º
ottobre 2009 Di Pietro ha confidato al Corriere della Sera di essere stato
operato, due mesi prima, per un tumore benigno alla prostata e di essersi già
discretamente ristabilito. Di Pietro ha inoltre dichiarato, nella stessa
intervista, di sentirsi solidale nei confronti di Silvio Berlusconi, il quale
aveva subito anni prima un intervento simile.
Il "dipietrese". Alcuni aspetti del
linguaggio utilizzato da Antonio di Pietro, dapprima come magistrato, e, in
seguito, dopo l'abbandono dell'ordine giudiziario, nella sua azione politica,
sono stati oggetto dell'attenzione dei media, che hanno coniato il neologismo
"dipietrese", entrato nel gergo giornalistico e usato dallo stesso Di Pietro. Il
fenomeno ha attratto l'attenzione dei linguisti, con articoli e commenti, per le
sue caratteristiche innovative nel tradizionale modo di esprimersi della
comunicazione pubblica in Italia, riconosciutegli in gradi diversi dai vari
studiosi. Questo modo d'esprimersi è salito alla ribalta nelle aule giudiziarie,
in occasione delle udienze pubbliche di processi della stagione di Mani Pulite,
in cui Di Pietro, in qualità di pubblico ministero, sosteneva il ruolo della
pubblica accusa. In particolare, è venuto all'attenzione di un vasto pubblico a
seguito della messa in onda delle registrazioni delle udienze di quei processi.
Il dipietrese si caratterizza per un lessico e un registro linguistico
coloriti e popolari, con uno stile comunicativo spesso scevro da tecnicismi e
formalismi, condito da espressioni tipiche, esclamazioni, detti proverbiali,
neologismi funzionali, come «dazione» e «dazione ambientale», «fuggitore
di notizie» (autore delle fughe di notizie), «mosca cavallina», «zanzata»,
«benedettiddio!» o «Santa Madonna!», «che c'azzecca?»
(«cosa c'entra?»), «Non ho capito!», «Scusi, non ho capito!»
(frasi ed esclamazioni rivolte a testimoni o imputati per sottolineare la
contraddittorietà di quanto dichiarato), «O è zuppa, o è pan bagnato», e
l'affermarsi di numerose altre polirematiche e neologismi divenute patrimonio
del linguaggio comune, come "Mani pulite" e "Tangentopoli". L'eloquio tende a
uno stile nominale, pur senza eccedere, come altri, in nominalismi. Un'altra
cifra distintiva è l'ampio uso di sigle in funzione di «parole piene»: «il PG»
(Procuratore generale), «il GIP» (Giudice per le indagini preliminari), «il PM»
(pubblico ministero). Quando il linguaggio di Di Pietro si manifestò per le
prime volte, offrendosi a una vasta platea giornalistica e televisiva, in esso
fu immediatamente riconosciuto un carattere di novità, rispetto a formulazioni
linguistiche retoriche, pompose, scenografiche, tecnicistiche, stereotipate, o
paludate, di quel linguaggio settoriale che la mente normalmente associa
all'ambiente giudiziario. La novità del linguaggio si accompagnava alla novità
della condotta dibattimentale, anch'essa fuori dagli schemi per quanto riguarda
il modo di porgere le prove agli interlocutori del pubblico ministero, anche con
l'utilizzo, veramente innovativo per l'epoca, di risorse informatiche e
multimediali. Il giudizio sull'innovatività linguistica del dipietrese,
assume toni diversi nelle opinioni dei linguisti: Michele Cortelazzo, ad
esempio, senza negarne gli aspetti di novità, considera il linguaggio di Antonio
Di Pietro ancora troppo vincolato ai paludamenti del tecnicismo giudiziario. Più
severo è il giudizio di Raffaele Simone, che invece riconosce nel dipietrese
i vizi perduranti del linguaggio della comunicazione pubblica italiana,
«enigmaticità ed equivocità», accostate, nel suo caso, a una dose di
«scombinatezza».
Di Pietro e Internet. A partire dal
mese di gennaio del 2006 Di Pietro tiene un blog personale. Tra le iniziative di
spicco, oltre alla pubblicazione di riflessioni personali, alla pubblicizzazione
delle iniziative e degli incontri nazionali del partito e alla spiegazione della
linea politica che egli segue, ha riproposto la spiegazione di tutte le
decisioni prese all'interno del Consiglio dei ministri sotto forma di videoclip
ospitate su YouTube, partire col CdM del 19 gennaio 2007 (e pubblicato poi sul
blog il 22 gennaio). Il 28 febbraio seguente ha annunciato sul suo blog di aver
aperto uno spazio per l'Italia dei Valori nella comunità virtuale Second Life,
avendo acquistato un'isola su cui ha piantato la bandiera del partito. In
seguito l'area è stata allestita con nuove costruzioni e, a partire dal 26
marzo, è sede per le riunioni di IDV AGORÀ, gruppo di avatar di Second
Life che si riconosce negli ideali di Italia dei Valori. Il 12 luglio Antonio Di
Pietro tiene la prima conferenza stampa ufficiale del partito su Second Life,
davanti all'avatar di numerosi giornalisti e simpatizzanti che hanno interagito,
ponendo domande anche per verificare che non fosse una registrazione. A causa di
un articolo pubblicato sul proprio sito internet dal titolo "Vi difendiamo tutti
da Cuffaro", Antonio di Pietro è stato condannato dal Tribunale Civile di
Palermo, con sentenza n. 1742/2013, a risarcire Salvatore Cuffaro con la somma
di € 6.000,00, oltre € 4.980,00 di spese legali ed alla pubblicazione della
sentenza su "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica", per aver detto
erroneamente che lo stesso avrebbe screditato il giudice Giovanni Falcone nel
corso di una trasmissione televisiva andata in onda nel 1991.
COME SI DIVENTA MAGISTRATI: CHIEDETELO AD ANTONIO DI PIETRO.
“Ho letto i requisiti per poter diventare magistrato:li ritengo ingiusti. In
special modo quello relativo alle condanne penali riportate dai parenti. Io ho
dei parenti che sono stati in carcere ma non capisco come possa la mia vita
essere collegata alla loro. Ognuno fa della propria vita ciò che vuole. La mia
scelta di vita è totalmente differente dalla loro. Perchè punire me per fatti
commessi da altri? Si potrebbe pensare: siccome sono parenti, una volta
diventato magistrato potrei aiutarli. Allora la cosa diventa paradossale: per
chi ha parenti incensurati ma dei migliori amici mafiosi...come la mettiamo?
Secondo me è una violazione palese dell'art. 3 della Cost.. In questo modo il
sogno della mia vita, svanisce prima d'iniziare...ergo...le colpe dei padri (in
senso lato) ricadono sui figli. Spero vivamente che qualcosa cambi in questo
senso.” Maria.
Vediamo un po'!. E' proprio vero che i magistrati sono di
cristallina moralità, di immacolato lignaggio e di indiscutibile frequentazione
amicale?
Magistrati, il concorso delle polemiche.
Le nuove regole per l'accesso in magistratura prevedono un
percorso agevolato per i praticanti dell'avvocatura di Stato. Eccezione che ha
fatto infuriare chi arriva dagli studi privati o dalle altre amministrazioni
pubbliche, scrive A. M. su “L’Espresso”. Rivolta contro le nuove regole per il
concorso in magistratura. Le norme stringenti e meritocratiche decise dal
governo, dopo che lo scorso anno per 365 posti erano state presentate 20 mila
domande, prevedono un’eccezione: i praticanti dell’Avvocatura dello Stato. Il
bando per 340 posti nel 2015 stabilisce infatti che possa essere ammesso
direttamente, senza passare per la costosa Scuola di specializzazione, insieme a
chi ha fatto uno stage formativo in un ufficio giudiziario, pure chi abbia
svolto il tirocinio presso l’Avvocatura statale (a patto che abbia meno di
trent’anni, un voto di laurea superiore a 105/110 o una media di 27/30 in alcuni
esami). Esclusi in toto, invece, i praticanti degli studi privati e delle altre
amministrazioni pubbliche (come le avvocature della Banca d’Italia e quelle
dell’Inps). Le nuove disposizioni hanno scatenato una bufera tra le migliaia di
precari degli studi privati che, attraverso il portale LeggiOggi.it, stanno
preparando ricorso collettivo contro «l’inaccettabile discriminazione».
Il magistrato nipote del boss mafioso,
scrive “Art. tre”. Il matrimonio tra due rampolli di Cosa Nostra, la
nipote di Messina Denaro e il figlio di un boss mafioso, celebrate nella
Cappella Palatina a Palazzo dei Normanni, hanno suscitato indubbio scalpore. I
due ragazzi, peraltro incensurati, sono gli eredi di famiglie importanti, quei
Guttadauro e Sansone che hanno scritto la storia recente di Cosa Nostra.
Comunque nulla di illecito, gli sposi hanno sancito la loro unione in un luogo
concesso dalle istituzioni a chiunque ne faccia richiesta. Mentre è emersa
un’altra vicenda relativa al boss di Brancaccio, Giuseppe Guttadauro, un suo
nipote diretto, cugino della neo sposina, è entrato in magistratura. Certamente
si tratta di un magistrato perbene e corretto, lontano dalle cosche. Ha scelto
di svolgere la funzione di giudice lontano dalla Sicilia e certamente espleta la
sua funzione in maniera ineccepibile. Ma un’anomalia, e non da poco, esiste: è
parente stretto di un appartenente a Cosa Nostra e quando il neo laureato in
giurisprudenza presentò la domanda per accedere al concorso in magistratura, gli
organismi investigativi avrebbero dovuto segnalare la cosa al ministero della
Giustizia. Infatti l’articolo 124 dell’ordinamento giudiziario recita “Il Csm
non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non
risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il
primo grado ed in linea collaterale entro il secondo grado, hanno riportato
condanne”. Per il caso Cuffaro, Giuseppe Guttadauro, zio del magistrato, è
stato condannato a 13 anni e quattro mesi di carcere. La prassi per entrare in
magistratura è rigida, la parentela di questo giudice, sarebbero stata ostacolo
anche solo per ottenere un appalto pubblico, invece nessuno ha eccepito alcunché
sulla sua nomina.
Sulla condotta censurabile si è espresso il Consiglio di Stato.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 04
luglio 2012, n. 3929 (Pres. Trotta, Est. Forlenza)
Il fratello del pm antimafia al ricevimento del boss.
A essere immortalato mentre partecipa al
ricevimento della nipote paterna del boss Antonio Pelle, alias Gambazza, e del
nipote del boss Antonio Nirta, è Vincenzo Mollace, scrive “Il Tempo”. Nozze,
clan e parenti stretti dei pm antimafia. Ad essere immortalato mentre partecipa
al ricevimento della nipote paterna del boss Antonio Pelle, alias Gambazza, e
del nipote del boss Antonio Nirta, detto «il terribile», è Vincenzo Mollace,
fratello «scomodo» del magistrato antimafia Francesco Mollace, di recente
trasferito dalla procura di Reggio Calabria a Roma. Lo scenario è un ristorante
di Gerace, nella locride. Il dvd che ritrae il fratello del pm mentre
s’intrattiene, fra un pasto e l’altro, coi più potenti boss calabresi, è
contenuto in un’informativa dei carabinieri di Locri, nelle cui mani è finito
praticamente per caso. Siamo nel gennaio 2010 e il reparto speciale «Cacciatori»
dell’Arma è sulle tracce di un pericoloso latitante: Stefano Mammoliti.
Irrompono nella casa di un secondo latitante di San Luca convinti di scovare la
loro preda, ma non trovano nessuno. Si imbattono, però, nel dvd e nel visionarlo
restano basiti: a tavola coi mammasantissima c’è infatti Vincenzo Mollace,
docente universitario, fratello del pm antimafia e all’epoca dei fatti direttore
generale dell’Arpacal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in
Calabria. Nell’informativa gli uomini dell’Arma scrivono: «Si nota di spalle con
cappotto e cappello di colore scuro Mollace Vincenzo nella zona antistante il
buffet, vicino a un soggetto anziano con la coppola, successivamente di fianco
vicino a due soggetti di spalle e a Nirta Antonio, alias “terribile”, padre
dello sposo, mentre parlano». Intorno a loro, che bevono vino, chiacchierano e
mangiano, anche Rocco Morabito, «successore» del boss Giuseppe Morabito «u
tiradrittu», e Bruno Gioffrè, che nella «cupola calabrese» occupa il secondo
posto più importante. Fra i commensali, come riportato nell’informativa, anche
due politici locali: Tommaso Mittiga, sindaco di Bovalino di area Pd, e Domenico
Savica, suo «oppositore» in consiglio comunale. Il filmato rinvenuto dai
carabinieri fa da riscontro a molti elementi contenuti nelle carte
dell’operazione «Inganno» che un mese fa ha portato agli arresti dell’ex sindaco
di San Luca, Sebastiano Giorgi, e della «paladina antimafia» Rosy Canale,
coordinatrice del «Movimento delle donne di San Luca». Ed è nel corso di questa
operazione che gli investigatori hanno intercettato l’ex sindaco Giorgi mentre
affermava che gli incontri tra Vincenzo Mollace e i boss si sarebbero
intensificati a ridosso delle ultime elezioni regionali. Gli inquirenti si
soffermano anche sui rapporti tra Savica e Vincenzo Mollace e dello stesso
Savica con Antonio Stefano Caridi, oggi senatore del Nuovo Centrodestra.
Portici, in lista la nipote del boss imbarazzo del giudice
candidato sindaco. Nascita e tramonto in poche ore
della corsa elettorale della giovane imparentata a Luigi Vollaro, detto o'
Califfo. E il magistrato: forse una leggerezza, scrive Concita Sannino su “La
Repubblica”. Psicodramma preelettorale a Portici. Una farsa, grave, a più voci.
Basta bussare a una porta del centro storico per scoprire che la nipote ventenne
del boss di camorra Luigi Vollaro, ergastolano noto come 'o Califfo, ovvero
Jessica Provisiero, è inserita in lista con l'Udc, all'insaputa - ovvio - di
tutti. "Sì, ce la voglio fare, io sono pulita, magari comincia una bella
carriera", dice Jessica. Un'ora più tardi: il terremoto. Si fa viva la mamma
della candidata: "Perché non parlate con me?". Due ore dopo: il candidato
sindaco della stessa compagine, Nicola Marrone, per inciso giudice a Torre
Annunziata, confessa di aver appreso "la grave circostanza" solo ieri, appena
dopo la visita di "Repubblica" alla signorina gravata - senza colpa - dal
legame di sangue con il nonno ras (detenuto da 30 anni). E alla fine, dopo
febbrili contatti, è lo stesso Marrone a pretendere "il ritiro immediato" di
Jessica. Ma questo si vedrà dopo. Benvenuti nella città dove esplodono i veleni
nel centrosinistra. "La colpa è tutta dell'ex sindaco e attuale senatore Pd,
Cuomo", tuonano adesso dall'Udc. La cittadina che fino a ieri piangeva i morti e
i feriti del balcone crollato, domenica scorsa, alla processione del patrono San
Ciro, relega ormai il cordoglio ai parenti e alle parrocchie, archivia i
funerali e si rituffa nel clima preelettorale. Compresi sgambetti, imboscate e
gravi sorprese. Quella della candidatura di Jessica Provisiero - classe 1991,
ragazza incensurata, senza alcun peso se non la parentela col nonno che fu il
sanguinario Califfo di camorra - è una storia in linea con lo scollamento tra
etica e politica, perfino tra evidenza e logica. Lei, la ragazza, ha una faccia
pulita e racconta: "Non mi chiedete se mi piace destra o sinistra, non saprei,
ma ci provo". Invece lo psicodramma di Portici, di cui è stata testimone ieri
"Repubblica", racconta nell'ordine: una precipitosa fuga a minimizzare prima di
capire che cosa fosse successo e chi avesse operato, anche illudendo una
ragazza; un'alta concentrazione di veleni nel campo lasciato libero dal sindaco
uscente Pd; e una grave defaillance di (mezzo) centrosinistra, visto che a
sostenere Marrone ci sono anche Sel e Verdi. Nessuno si era accorto di chi c'era
in lista? Uno psicodramma lungo un pomeriggio. In tre tempi.
Ore 15, Jessica spera. "Con la politica va via il marchio".
I vicoli che si allungano nell'antico mercato di Portici, alle spalle del
santuario di San Ciro, evocano immagini che hanno attraversato le faide dei
tremendi anni Settanta. Guerre di scafi blu, di ricchezze, di omicidi. A Portici
imperava un boss che si faceva chiamare 'o Califfo, aveva troppi figli e molti
vizi. Luigi Vollaro è rinchiuso da tre decenni. Da anni al regime 41 bis,
carcere duro per i mafiosi, al Nord. In questi vicoli, ora più silenziosi e
sereni, vive Jessica, diplomata in Ragioneria, con le sorelle, la madre che
lavora in una ditta di pulizie e il padre che si occupa di sfilate di ragazzi e
bambini. Lei è candidata Udc, la lista sostiene il giudice Nicola Marrone.
Jessica apre il portone. "Qui siamo onesti lavoratori - comincia - mio nonno
è mio nonno ma noi siamo noi". La ragazza si lascia fotografare, ribadisce di
volersi impegnare al Comune: "Magari comincio una carriera, ci voglio provare".
Ma da quando la appassiona la politica: quale leader, quale schieramento?
Jessica indugia. Poi recupera due bigliettini elettorali: "Non saprei. Me lo
hanno proposto e ho detto sì. Leggete qui, questo signore mi ha spinta per
coinvolgere i giovani". È il candidato Felice Calise dell'Udc, ha fatto stampare
i cartoncini che ora le inondano casa con la doppia preferenza: "Vota con
Marrone sindaco: Calise e Provisiero". Jessica sorride. "Lo so, qualcuno farà
polemiche, che devo fare? Magari mi libero del marchio. Ora scusate, sto
raggiungendo mamma sul lavoro. Non ho esperienza, ma vorrei fare qualcosa per il
paese". Accanto a lei c'è la sorella maggiore, Loredana: "Guardi che i miei
genitori sono onesti lavoratori e siamo felici per mia sorella, ce la farà.
Perché non ci possiamo togliere di dosso questa schiavitù? Nostro nonno ce lo
dice quando lo andiamo a trovare: "Fate altre scelte nella vita". Ecco tutto".
Saluto cordiale. Sono fiduciose.
Ore 16.30, lo stop di una madre. "Lo ha deciso chi di dovere".
Una voce gentile ma preoccupata, al telefono. È Teresa Vollaro, la madre di
Jessica. "Scusi, che servizio volete fare? Invece di chiamare Jessica dovevate
chiamare me". Ma la candidata è adulta e sa che cosa vuole. Replica della
signora Teresa: "Ma quando mai. Cancellate tutto. Sono tanto delusa dalla
giustizia divina e umana...". Si riferisce all'ergastolo per suo padre? "Che
c'entra? Perché lo nomina? Non lo nomini". La nipote del boss in lista apre
polemiche. "Ma Jessica si ritira, basta!". Jessica sembrava molto contenta di
farlo. "No. Abbiamo parlato con chi di dovere. Meglio di no. Arrivederci".
Ore 19. L'anatema di Marrone. "Jessica si ritira, basta".
Il candidato sindaco Marrone è in bilico tra amarezza e imbarazzo. E ira.
"Certamente quello che è accaduto è grave, e provvederemo a fare ritirare la
ragazza, che non ha alcuna colpa. Ma lei e la sua famiglia sono già d'accordo a
non entrare in Comune, si ritira". Resta il dubbio: si è trattato di
un'imboscata, di una clamorosa "leggerezza" o di un'operazione fallita per
un'intervista? "Sono un pragmatico e voglio ritenere che ci sia stata una
leggerezza, nel mettere in lista una giovane che peraltro porta un cognome
diverso da quello del nonno, ben noto. Ma io non ne sapevo nulla". Non si chiede
chi abbia condotto questa operazione nell'Udc? "Invece penso a chi possa aver
usato strumentalmente questa leggerezza di altri... Penso ci sia lo zampino
dell'ex sindaco e senatore Pd Cuomo: guarda le parentele degli altri, spiffera.
Proprio lui che si dispiacque quando qualcuno parlò di parentele per lui".
Veleni. Mentre Marrone si divide tra il ruolo di aspirante sindaco e quello di
giudice. Si scopre, infatti, che Marrone è in piena campagna elettorale a una
manciata di chilometri dal suo collegio giudicante, ma non è in aspettativa.
Così come la legge (poco etica) gli consente. Era accaduto ad altri magistrati,
accadrà ancora. "Mi adeguo alla legge", spiega cortese l'aspirante sindaco.
Mentre Jessica scompare sullo sfondo.
«Ma voi del Giornale non sapete una
cosa pazzesca su Antonio Di Pietro e il giudice Corrado Carnevale, sì proprio
quello a cui gli amici di Tonino danno addosso dicendo che aggiustava i processi
per conto di Cosa nostra...». L’incipit della confidenza di Elio Belcastro,
parlamentare uscente dell’Mpa di Raffaele Lombardo, ci rimanda a quando nel
1980-81 il cosiddetto giudice «ammazzasentenze», da presidente della commissione
d’esami del concorso in magistratura, fece di tutto per promuovere l’allora vice
commissario di polizia molisano che ai test aveva fatto una figura a dir poco
penosa.
(«Avevo letto il curriculum di Antonio
Di Pietro - ha raccontato Carnevale -: era stato emigrante, si era arrabattato
molto, questo mi indusse a essere clemente. Se devo pentirmi di tutto, come
pretendono molti, mi pento anche di aver fatto promuovere Di Pietro. Nei
concorsi per magistrati non bisognerebbe tenere conto di considerazioni
pietistiche. In base all’esame però non avrebbe meritato il voto minimo che gli
abbiamo attribuito...»).
Belcastro ci fa subito capire,
scandendo bene le parole, che Tonino non era nemmeno riuscito a prenderlo quel
voto, minimo. «Tempo fa l’ex procuratore capo di Roma, Felice Filocamo, che di
quella commissione d’esami era il segretario, mi ha raccontato che quando
Carnevale si accorse che i vari componenti avevano bocciato Di Pietro, lo chiamò
e si arrabbiò molto. Filocamo fu costretto a tornare in ufficio, a strappare il
compito del futuro paladino di Mani pulite e a far sì che, non saprei dire come,
ottenesse il passaggio agli orali, seppur con il minimo dei voti». Bocciato e
ripescato? Magistrato per un falso? Possibile? Altro che recriminazioni per
l’ipergarantista Carnevale che proprio grazie ai giustizialisti alla Di Pietro
si ritroverà a lungo nei guai. Non ci resta che chiedere direttamente a lui,
all’integerrimo magistrato in pensione Felice Filocamo, che agli esami orali
proprio con Di Pietro ebbe un curioso botta e risposta. «Nel grande giorno -
scrive Filippo Facci nel suo libro su Di Pietro - gli chiesero un documento
perché si identificasse e reagì stizzito: “Ma io sono il commissario Di Pietro”.
“Si, certo, ma solo quando me lo avrà dimostrato”...».
Giudice Filocamo, scusi il disturbo.
Sappiamo che lei non ha mai parlato di questa storia degli esami di Antonio Di
Pietro per indossare la toga. Ma l’onorevole Belcastro ci ha riferito che...
«Fermatevi. Parlate con il giudice
Carnevale, è lui l’autore di tutto (risatina), di quella raccomandazione. Io ero
solo il segretario della commissione, chiedete, chiedete a Carnevale».
Corrado Carnevale si è già espresso
dicendosi pentito d’aver raccomandato Tonino a diventare un pm. L’onorevole
Belcastro, riferendo di una vostra confidenza, ci ha raccontato che non si
trattò solo di raccomandazione ma di molto di più, e di più grave, a seguito di
un esame quantomeno disastroso da parte di Di Pietro. Esame ben al di sotto
della sufficienza e a seguito del quale sarebbero stati strappati compiti e
verbali. Sarebbe stato commesso un reato...
«Che ormai sarebbe prescritto
(risata). La prego, la fermo. Diciamo che anche se sono passati tanti anni è
antipatico rivelare quelli che sono, e restano, i segreti di una camera di
consiglio. Non si fa. Non mi faccia scendere nei particolari che vi ha riferito
Belcastro, non è mio costume, non insista».
Almeno se lo ricorda quell’esame?
«E come non me lo ricordo? L’esame del
vicecommissario Di Pietro è stato... poco decoroso perché insomma... la
commissione era convinta che non dovesse essere promosso. Poi è successo quello
che è successo e...».
E?
«E... niente. In quell’occasione è
stato fortunato (risata). Seguendolo, negli anni, ho potuto notare come sia
stato sempre fortunato. Come quando prese soldi e regali da quelle persone lì, a
Milano. Si è detto che non era reato, benissimo, ma non fu una cosa molto
decorosa per lui e per la magistratura. Così come non ha fatto una bella figura
quando venne sospeso dal consiglio nazionale forense per aver tradito il mandato
difensivo di un suo assistito accusato d’omicidio, che peraltro, se non ricordo
male, era pure il suo migliore amico».
A proposito di questo «tradimento» la
Cassazione ha appena chiuso il caso confermando la «condanna» a Di Pietro.
«Ecco, appunto, per indegnità, per
scorrettezza, più di questo che gli devono dire?».
Non ce ne voglia, Filocamo. Ma
dobbiamo tornare all’esame di Di Pietro perché le cose riferite dall’onorevole
Belcastro, anche se il reato è prescritto, sono comunque di una certa rilevanza.
Belcastro parla di verbali e compiti
strappati...
«Strappare i verbali... dico...
strappare... guardi, in camera di consiglio ognuno esprime la propria opinione,
e alla fine, sommando le opinioni, ha prevalso l’opinione generale contraria
alla promozione di Di Pietro. Poi, con l’intervento di qualcuno che ha ritenuto
che quella decisione non fosse... come dire... beh, ha capito, la commissione
poi cambiò idea. Ci furono delle discussioni, la decisione venne rivista. Se
chiedete al giudice Carnevale vi può dire lui come andarono veramente le cose.
Lui era il capo, lui era il presidente. Io ero solo il segretario della
commissione e il segretario, verbalizzavo punto e basta, non avevo poteri
decisionali».
Faccia uno sforzo, presidente. Davvero
non si ricorda se ha strappato il compito di Di Pietro e se poi qualcun altro
l’ha riscritto?
«Cercate di capire... sono passati
trent’anni...».
Corrado Carnevale: "Al concorso in magistratura, Di Pietro ha
avuto due aiutini". L'ex giudice Corrado Carnevale:
"Era stato in seminario ed era di famiglia povera. Fu così che chiusi un
occhio", scrive Rachele Nenzi su “Il Giornale”. "Al concorso in magistratura
Antonio Di Pietro ha avuto due "aiutini" agli scritti e poi è stato
"stampellato" all’orale". A svelare questo dettaglio sulla carriera dell'ex toga
di Mani Pulite è il Tempo che riporta quanto detto dall’avvocato Roberto
Aloisio, legale del giudice in pensione Corrado Carnevale, al collegio della
prima sezione civile della Corte d’Appello di Roma. Come scrive il quotidiano
romano, "la vicenda giudiziaria prende le mosse da un’intervista che nel 2008
Carnevale rilasciò al condirettore del giornale online "Petrus", Bruno Volpe, in
cui confessò di essersi pentito di aver fatto promuovere Di Pietro al concorso
in magistratura. Fu un grande errore – svelò l’allora presidente della prima
sezione penale della Corte di Cassazione – Mi lasciai commuovere dal suo
curriculum. Era stato in seminario ed era di famiglia povera. Fu così che chiusi
un occhio davanti ad alcune sue lacune". Corrado Carnevale è tornato in aula per
difendersi dall'accusa di diffamazione mossa da Antonio Di Pietro. Il Tribunale
civile di Roma recentemente ha condannato l’ex presidente della Cassazione a
risarcire l’ex leader dell’Italia dei Valori di 15 mila euro, a fronte dei 200
mila chiesti da Di Pietro nell’atto di citazione. Ora i legali di Carnevale
hanno chiesto alla Corte d’Appello di sospendere l’efficacia esecutiva della
sentenza. Durante il dibattimento in tribunale, il legale di Carnevale ha
ribadito le dichiarazioni del suo assistito: "In un’intervista in cui si parlava
del fenomeno di Mani Pulite, il presidente Carnevale rispose che aveva sbagliato
a valutare Di Pietro. Ha detto la verità, ossia ciò che sapeva. Il cosiddetto
"aiutino" è stato riportato dal presidente Lipari e consiste in quello che è
noto. Le commissioni esaminatrici per il concorso da uditori giudiziari si
riuniscono preventivamente per stabilire i criteri di correzione dei compiti. Se
alle prove scritte c’è una sufficienza seria e due 5 ci sono delle commissioni
che legittimamente, nell’esercizio di un potere insindacabile, dicono: due 5 e
un 6 passa poi vedremo agli orali. Non è mai stato detto che c’è stato un
intrallazzo. Ha raggiunto la sufficienza agli scritti con questi due "aiutini".
Poi all’orale, dove ha preso 8, è riuscito a raggiungere la media del 7, limite
minimo che permette di superare il concorso. Infatti Di Pietro si è collocato
nella parte finale della graduatoria". Opposta la versione del legale di Di
Pietro: "Dagli atti documentali del processo di primo grado è emerso che l’esame
condotto da Di Pietro ha portato alla sua promozione perché era pienamente
sufficiente. Quindi non corrisponde al vero dire che prese due insufficienze e
una sufficienza agli scritti e che all’orale non andò meglio. Se non si deve
dare valore ai documenti, ma alla prassi, come sostiene la controparte, allora
bisognerebbe fidarsi esclusivamente della parola del presidente Carnevale; visto
che altre prove non sono state prodotte, né tantomeno ci sono testi pronti a
testimoniare che la prassi è questa".
Quell’aiutino a Di Pietro per diventare magistrato.
L’ex giudice Carnevale sull’esame di Tonino a pm: «Era povero, mi commossi. E
due 5 diventarono 6», scrive Valeria Di Corrado su “Il Tempo”. «Al concorso
in magistratura Antonio Di Pietro ha avuto due "aiutini" agli scritti e poi è
stato "stampellato" all’orale». Un aspetto non trascurabile del percorso che ha
portato un vicecommissario del Molise a diventare uno dei magistrati di punta
del pool di Mani Pulite, viene alla luce da una causa civile per diffamazione. È
stato l’avvocato Roberto Aloisio, legale del giudice in pensione Corrado
Carnevale, a spiegare ieri al collegio della prima sezione civile della Corte
d’Appello di Roma come andò l’esame per diventare uditore di Di Pietro. La
vicenda giudiziaria prende le mosse da un’intervista che nel 2008 Carnevale
rilasciò al condirettore del giornale online «Petrus», Bruno Volpe, in cui
confessò di essersi pentito di aver fatto promuovere Di Pietro al concorso in
magistratura. «Fu un grande errore – svelò l’allora presidente della prima
sezione penale della Corte di Cassazione – Mi lasciai commuovere dal suo
curriculum. Era stato in seminario ed era di famiglia povera. Fu così che chiusi
un occhio davanti ad alcune sue lacune». Per quelle dichiarazioni, poi riprese
da altre testate giornalistiche, Di Pietro ha querelato per diffamazione a mezzo
stampa Carnevale. Il Tribunale civile di Roma recentemente ha condannato l’ex
presidente della Cassazione a risarcire l’ex leader dell’Italia dei Valori di 15
mila euro, a fronte dei 200 mila chiesti da Di Pietro nell’atto di citazione.
Ora i legali di Carnevale hanno chiesto alla Corte d’Appello di sospendere
l’efficacia esecutiva della sentenza. «L’urgenza di un’inibitoria – ha spiegato
l’avvocato Aloisio – è dovuta al fatto che è già stato notificato l’atto di
precetto. Lunedì scorso eravamo in attesa dell’ufficiale giudiziario. Il mio
assistito non solo ritiene che giustizia non sia stata fatta, ma ritiene che 30
mila euro (se si considerano pure le spese legali e gli interessi) non siano una
bazzecola per nessuno, anche per un magistrato la cui pensione mensile
corrisponde alla metà di quella somma». Prima di celebrare l’udienza, ieri, il
presidente del collegio d’Appello Francesco Ferdinandi ha chiesto alle parti
«data la levatura delle loro personalità» se volessero raggiungere un accordo
bonario e rinunciare al contenzioso, ma il legale di Di Pietro si è opposto. A
quel punto l’avvocato Aloisio è entrato nel merito della questione: «In
un’intervista in cui si parlava del fenomeno di Mani Pulite, il presidente
Carnevale rispose che aveva sbagliato a valutare Di Pietro. Ha detto la verità,
ossia ciò che sapeva. Il cosiddetto "aiutino" è stato riportato dal presidente
Lipari e consiste in quello che è noto. Le commissioni esaminatrici per il
concorso da uditori giudiziari si riuniscono preventivamente per stabilire i
criteri di correzione dei compiti. Se alle prove scritte c’è una sufficienza
seria e due 5 ci sono delle commissioni che legittimamente, nell’esercizio di un
potere insindacabile, dicono: due 5 e un 6 passa poi vedremo agli orali. Non è
mai stato detto che c’è stato un intrallazzo. Ha raggiunto la sufficienza agli
scritti con questi due "aiutini". Poi all’orale, dove ha preso 8, è riuscito a
raggiungere la media del 7, limite minimo che permette di superare il concorso.
Infatti Di Pietro si è collocato nella parte finale della graduatoria». A
difendere l’ex pm di Mani Pulite, in udienza, c’era un avvocato dello studio
legale Scicchiatano, di cui lo stesso Di Pietro fa parte da quando ha lasciato
la carriera politica per quella forense. «Dagli atti documentali del processo di
primo grado – ha spiegato il civilista – è emerso che l’esame condotto da Di
Pietro ha portato alla sua promozione perché era pienamente sufficiente. Quindi
non corrisponde al vero dire che prese due insufficienze e una sufficienza agli
scritti e che all’orale non andò meglio. Se non si deve dare valore ai
documenti, ma alla prassi, come sostiene la controparte, allora bisognerebbe
fidarsi esclusivamente della parola del presidente Carnevale; visto che altre
prove non sono state prodotte, né tantomeno ci sono testi pronti a testimoniare
che la prassi è questa». Ora la parola passa ai giudici di secondo grado che
dovranno decidere se accogliere la richiesta di sospensiva della sentenza.
Già!! La
giustizia e le nostre vite in mano a chi?
«Antonio Di
Pietro è il primo a lasciare l'ufficio di Borrelli. È irriconoscibile. Cammina
come un ubriaco, quasi appoggiandosi ai muri». Così scrive Goffredo Buccini sul
Corriere della Sera del 24 luglio 1993, il giorno dopo il suicidio di Raul
Gardini.
«Per me fu una
sconfitta terribile - racconta oggi Antonio Di Pietro ad Aldo Cazzullo su “Il
Corriere della Sera” -. La morte di Gardini è il vero, grande rammarico che
conservo della stagione di Mani pulite. Per due ragioni. La prima: quel 23
luglio Gardini avrebbe dovuto raccontarmi tutto: a chi aveva consegnato il
miliardo di lire che aveva portato a Botteghe Oscure, sede del Pci; chi erano i
giornalisti economici corrotti, oltre a quelli già rivelati da Sama; e chi erano
i beneficiari del grosso della tangente Enimont, messo al sicuro nello Ior. La
seconda ragione: io Gardini lo potevo salvare. La sera del 22, poco prima di
mezzanotte, i carabinieri mi chiamarono a casa a Curno, per avvertirmi che
Gardini era arrivato nella sua casa di piazza Belgioioso a Milano e mi dissero:
"Dottore che facciamo, lo prendiamo?". Ma io avevo dato la mia parola agli
avvocati che lui sarebbe arrivato in Procura con le sue gambe, il mattino dopo.
E dissi di lasciar perdere. Se l'avessi fatto arrestare subito, sarebbe ancora
qui con noi».
Ma proprio
questo è il punto. Il «Moro di Venezia», il condottiero dell'Italia anni 80, il
padrone della chimica non avrebbe retto l'umiliazione del carcere. E molte cose
lasciano credere che non se la sarebbe cavata con un interrogatorio. Lei, Di
Pietro, Gardini l'avrebbe mandato a San Vittore?
«Le rispondo
con il cuore in mano: non lo so. Tutto sarebbe dipeso dalle sue parole: se mi
raccontava frottole, o se diceva la verità. Altre volte mi era successo di
arrestare un imprenditore e liberarlo in giornata, ad esempio Fabrizio
Garampelli: mi sentii male mentre lo interrogavo - un attacco di angina -, e fu
lui a portarmi in ospedale con il suo autista... Io comunque il 23 luglio 1993
ero preparato. Avevo predisposto tutto e allertato la mia squadretta, a Milano e
a Roma. Lavoravo sia con i carabinieri, sia con i poliziotti, sia con la Guardia
di Finanza, pronti a verificare quel che diceva l'interrogato. Se faceva il nome
di qualcuno, prima che il suo avvocato potesse avvertirlo io gli mandavo le
forze dell'ordine a casa. Sarebbe stata una giornata decisiva per Mani pulite.
Purtroppo non è mai cominciata».
Partiamo
dall'inizio. Il 20 luglio di vent'anni fa si suicida in carcere, con la testa in
un sacchetto di plastica, Gabriele Cagliari, presidente dell'Eni.
«L'Eni aveva
costituito con la Montedison di Gardini l'Enimont. Ma Gardini voleva comandare -
è la ricostruzione di Di Pietro -. Quando diceva "la chimica sono io", ne era
davvero convinto. E quando vide che i partiti non intendevano rinunciare alla
mangiatoia della petrolchimica pubblica, mamma del sistema tangentizio, lui si
impuntò: "Io vendo, ma il prezzo lo stabilisco io". Così Gardini chiese tremila
miliardi, e ne mise sul piatto 150 per la maxitangente. Cagliari però non era in
carcere per la nostra inchiesta, ma per l'inchiesta di De Pasquale su Eni-Sai.
Non si possono paragonare i due suicidi, perché non si possono paragonare i due
personaggi. Cagliari era un uomo che sputava nel piatto in cui aveva mangiato.
Gardini era un uomo che disprezzava e comprava, e disprezzava quel che comprava.
Il miliardo a Botteghe Oscure lo portò lui. Il suo autista Leo Porcari mi aveva
raccontato di averlo lasciato all'ingresso del quartier generale comunista, ma
non aveva saputo dirmi in quale ufficio era salito, se al secondo o al quarto
piano: me lo sarei fatto dire da Gardini. Ma era ancora più importante stabilire
chi avesse imboscato la maxitangente, probabilmente portando i soldi al sicuro
nello Ior. Avevamo ricostruito la destinazione di circa metà del bottino;
restavano da rintracciare 75 miliardi».
Chi li
aveva presi?
«Qualcuno
l'abbiamo trovato. Ad esempio Arnaldo Forlani: non era certo Severino Citaristi
a gestire simili cifre. Non è vero che il segretario dc fu condannato perché non
poteva non sapere, e lo stesso vale per Bettino Craxi, che fu condannato per i
conti in Svizzera. Ma il grosso era finito allo Ior. Allora c'era il Caf».
Craxi.
Forlani. E Giulio Andreotti.
«Il vero capo
la fa girare, ma non la tocca. Noi eravamo arrivati a Vito Ciancimino, che era
in carcere, e a Salvo Lima, che era morto. A Palermo c'era già Giancarlo
Caselli, tra le due Procure nacque una stretta collaborazione, ci vedevamo
regolarmente e per non farci beccare l'appuntamento era a casa di Borrelli.
Ingroia l'ho conosciuto là».
Torniamo a
Gardini. E al 23 luglio 1993.
«Con Francesco
Greco avevamo ottenuto l'arresto. Un gran lavoro di squadra. Io ero
l'investigatore. Piercamillo Davigo era il tecnico che dava una veste giuridica
alle malefatte che avevo scoperto: arrivavo nel suo ufficio, posavo i fascicoli
sulla scrivania, e gli dicevo in dipietrese: "Ho trovato quindici reati di
porcata. Ora tocca a te trovargli un nome". Gherardo Colombo, con la Guardia di
Finanza, si occupava dei riscontri al mio lavoro di sfondamento, rintracciava i
conti correnti, trovava il capello (sic) nell'uovo. Gli avvocati Giovanni Maria
Flick e Marco De Luca vennero a trattare il rientro di Gardini, che non era
ancora stato dichiarato latitante. Fissammo l'appuntamento per il 23, il mattino
presto». «Avevamo stabilito presidi a Ravenna, Roma, a Milano e allertato le
frontiere. E proprio da Milano, da piazza Belgioioso dove Gardini aveva casa, mi
arriva la telefonata: ci siamo, lui è lì. In teoria avrei dovuto ordinare ai
carabinieri di eseguire l'arresto. Gli avrei salvato la vita. Ma non volevo
venir meno alla parola data. Così rispondo di limitarsi a sorvegliare con
discrezione la casa. Il mattino del 23 prima delle 7 sono già a Palazzo di
Giustizia. Alle 8 e un quarto mi telefona uno degli avvocati, credo De Luca, per
avvertirmi che Gardini sta venendo da me, si sono appena sentiti. Ma poco dopo
arriva la chiamata del 113: "Gardini si è sparato in testa". Credo di essere
stato tra i primi a saperlo, prima anche dei suoi avvocati». «Mi precipito in
piazza Belgioioso, in cinque minuti sono già lì. Entro di corsa. Io ho fatto il
poliziotto, ne ho visti di cadaveri, ma quel mattino ero davvero sconvolto.
Gardini era sul letto, l'accappatoio insanguinato, il buco nella tempia».
E la
pistola?
«Sul comodino.
Ma solo perché l'aveva raccolta il maggiordomo, dopo che era caduta per terra.
Capii subito che sarebbe partito il giallo dell'omicidio, già se ne sentiva
mormorare nei conciliaboli tra giornalisti e pure tra forze dell'ordine, e lo
dissi fin dall'inizio: nessun film, è tutto fin troppo chiaro. Ovviamente in
quella casa mi guardai attorno, cercai una lettera, un dettaglio rivelatore,
qualcosa: nulla».
Scusi Di
Pietro, ma spettava a lei indagare sulla morte di Gardini?
«Per carità,
Borrelli affidò correttamente l'inchiesta al sostituto di turno, non ricordo
neppure chi fosse, ma insomma un'idea me la sono fatta...».
Quale?
«Fu un
suicidio d'istinto. Un moto d'impeto, non preordinato. Coerente con il
personaggio, che era lucido, razionale, coraggioso. Con il pelo sullo stomaco;
ma uomo vero. Si serviva di Tangentopoli, che in fondo però gli faceva schifo.
La sua morte per me fu un colpo duro e anche un coitus interruptus».
Di Pietro,
c'è di mezzo la vita di un uomo.
«Capisco, non
volevo essere inopportuno. È che l'interrogatorio di Gardini sarebbe stato una
svolta, per l'inchiesta e per la storia d'Italia. Tutte le altre volte che nei
mesi successivi sono arrivato vicino alla verità, è sempre successo qualcosa,
sono sempre riusciti a fermarmi. L'anno dopo, era il 4 ottobre, aspettavo le
carte decisive dalla Svizzera, dal giudice Crochet di Ginevra: non sono mai
arrivate. Poi mi bloccarono con i dossier, quando ero arrivato sulla soglia
dell'istituto pontificio...».
Ancora i
dossier?
«Vada a
leggersi la relazione del Copasir relativa al 1995: contro di me lavoravano in
tanti, dal capo della polizia Parisi a Craxi».
Lei in
morte di Gardini disse: «Nessuno potrà più aprire bocca, non si potrà più dire
che gli imputati si ammazzano perché li teniamo in carcere sperando che
parlino».
«Può darsi che
abbia detto davvero così. Erano giornate calde. Ma il punto lo riconfermo: non è
vero, come si diceva già allora, che arrestavamo gli inquisiti per farli
parlare. Quando arrestavamo qualcuno sapevamo già tutto, avevamo già trovato i
soldi. E avevamo la fila di imprenditori disposti a parlare».
Altri
capitani d'industria hanno avuto un trattamento diverso.
«Carlo De
Benedetti e Cesare Romiti si assunsero le loro responsabilità. Di loro si
occuparono la Procura di Roma e quella di Torino. Non ci furono favoritismi né
persecuzioni. Purtroppo, nella vicenda di Gardini non ci furono neanche
vincitori; quel giorno abbiamo perso tutti».
Dopo 20 anni
Di Pietro è senza: pudore: «Avrei potuto salvarlo». Mani Pulite riscritta per
autoassolversi. L'ex pm: "Avrei dovuto arrestarlo e lui avrebbe parlato delle
mazzette al Pci". La ferita brucia ancora. Vent'anni fa Antonio Di Pietro,
allora l'invincibile Napoleone di Mani pulite, si fermò sulla porta di Botteghe
Oscure e il filo delle tangenti rosse si spezzò con i suoi misteri, scrive
Stefano Zurlo su “Il Giornale”. Per questo, forse per trovare una spiegazione
che in realtà spiega solo in parte, l'ex pm racconta che il suicidio di Raul
Gardini, avvenuto il 23 luglio '93 a Milano, fu un colpo mortale per
quell'indagine. «La sua morte - racconta Di Pietro ad Aldo Cazzullo in un
colloquio pubblicato ieri dal Corriere della Sera - fu per me un coitus
interruptus». Il dipietrese s'imbarbarisce ancora di più al cospetto di chi non
c'è più, ma non è questo il punto. È che l'ormai ex leader dell'Italia dei
Valori si autoassolve a buon mercato e non analizza con la dovuta brutalità il
fallimento di un'inchiesta che andò a sbattere contro tanti ostacoli. Compresa
l'emarginazione del pm Tiziana Parenti, titolare di quel filone. E non
s'infranse solo sulla tragedia di piazza Belgioioso. Di Pietro, come è nel suo
stile, semplifica e fornisce un quadro in cui lui e il Pool non hanno alcuna
responsabilità, diretta o indiretta, per quel fiasco. Tutto finì invece con quei
colpi di pistola: «Quel 23 luglio Gardini avrebbe dovuto raccontarmi tutto: a
chi aveva consegnato il miliardo di lire che aveva portato a Botteghe Oscure,
sede del Pci; chi erano i giornalisti economici corrotti, oltre a quelli già
rivelati da Sama; e chi erano i beneficiari del grosso della tangente Enimont,
messo al sicuro nello Ior». E ancora, a proposito di quel miliardo su cui tanto
si è polemizzato in questi anni, specifica: «Il suo autista Leo Porcari mi aveva
raccontato di averlo lasciato all'ingresso del quartier generale comunista, ma
non aveva saputo dirmi in quale ufficio era salito, se al secondo o al quarto
piano: me lo sarei fatto dire da Gardini». Il messaggio che arriva è chiaro: lui
ha fatto tutto quel che poteva per scoprire i destinatari di quel contributo
illegale, sulla cui esistenza non c'è il minimo dubbio, ma quel 23 luglio cambiò
la storia di Mani pulite e in qualche modo quella d'Italia e diventa una data
spartiacque, come il 25 luglio 43. Vengono i brividi, ma questa ricostruzione
non può essere accettata acriticamente e dovrebbero essere rivisti gli errori, e
le incertezze dell'altrove insuperabile Pool sulla strada del vecchio Pci. Non
si può scaricare su chi non c'è più la responsabilità di non aver scoperchiato
quella Tangentopoli. Di Pietro invece se la cava così, rammaricandosi solo di
non aver fatto ammanettare il signore della chimica italiana la sera prima,
quando i carabinieri lo avvisarono che Gardini era a casa, in piazza Belgioioso.
«M avevo dato la mia parola agli avvocati che lui sarebbe arrivato in procura
con le sue gambe, il mattino dopo». Quello fatale. «E dissi di lasciar perdere.
Se l'avessi fatto arrestare subito sarebbe ancora qui con noi. Io Gardini lo
potevo salvare». La storia non si fa con i se. E quella delle tangenti rosse è
finita prima ancora di cominciare.
Pomicino:
il pm Di Pietro tentò di farmi incastrare Napolitano.
L'ex ministro Cirino Pomicino: "Inventando una confessione, cercò di spingermi a
denunciare una tangente all'attuale capo dello Stato, poi spiegò il trucco",
scrive
Paolo Bracalini su “Il Giornale”. E mentre la truccatrice gli
passa la spazzola sulla giacca, prima di entrare nello studio tv di Agorà, 'o
ministro ti sgancia la bomba: «Di Pietro mi chiese: "È vero che Giorgio
Napolitano ha ricevuto soldi da lei?". Io risposi che non era vero, ma lui
insisteva. "Guardi che c'è un testimone, un suo amico, che lo ha confessato".
"Se l'ha detto, ha detto una sciocchezza, perché non è vero" risposi io. E
infatti la confessione era finta, me lo rivelò lo stesso Di Pietro poco dopo, un
tranello per farmi dire che Napolitano aveva preso una tangente. Ma si può
gestire la giustizia con questi metodi? E badi bene che lì aveva trovato uno
come me, ma normalmente la gente ci metteva due minuti a dire quel che volevano
fargli dire". "In quegli anni le persone venivano arrestate, dicevano delle
sciocchezze, ammettevano qualsiasi cosa e il pm li faceva subito uscire e
procedeva col patteggiamento. Quando poi queste persone venivano chiamate a
testimoniare nel processo, contro il politico che avevano accusato, potevano
avvalersi della facoltà di non rispondere. E quindi restavano agli atti le
confessioni false fatte a tu per tu col pubblico ministero», aveva già
raccontato Pomicino in una lunga intervista video pubblicata sul suo blog
paolocirinopomicino.it. La stessa tesi falsa, cioè che Napolitano, allora
presidente della Camera, esponente Pds dell'ex area migliorista Pci, avesse
ricevuto dei fondi, per sé e per la sua corrente, col tramite dell'ex ministro
democristiano, Pomicino se la ritrovò davanti in un altro interrogatorio,
stavolta a Napoli. «Il pm era il dottor Quatrano (nel 2001 partecipò ad un
corteo no global e l'allora Guardasigilli Roberto Castelli promosse un'azione
disciplinare). Mi fece incontrare una persona amica, agli arresti, anche lì per
farmi dire che avevo dato a Napolitano e alla sua corrente delle risorse
finanziaria». La ragione di quel passaggio di soldi a Napolitano, mai
verificatosi ma da confermare a tutti i costi anche col tranello della finta
confessione di un amico (uno dei trucchi dell'ex poliziotto Di Pietro, "altre
volte dicevano che se parlavamo avremmo avuto un trattamento più mite"), per
Cirino Pomicino è tutta politica: «Obiettivo del disegno complessivo era far
fuori, dopo la Dc e il Psi, anche la componente amendoliana del Pci, quella più
filo-occidentale, più aperta al centrosinistra. Tenga presente che a Milano fu
arrestato Cervetti, anch'egli della componente migliorista di Giorgio
Napolitano, e fu accusata anche Barbara Pollastrini. Entrambi poi scagionati da
ogni accusa». I ricordi sono riemersi di colpo, richiamati dalle «corbellerie»
dette da Di Pietro al Corriere a proposito del suicidio di Raul Gardini,
vent'anni esatti fa (23 luglio 1993). «Sono allibito che il Corriere della Sera
dia spazio alle ricostruzioni false raccontate da Di Pietro. Ho anche mandato un
sms a De Bortoli, ma quel che gli ho scritto sono cose private. Di Pietro dice
che Gardini si uccise con un moto d'impeto, e che lui avrebbe potuto salvarlo
arrestandolo il giorno prima. Io credo che Gardini si sia ucciso per il motivo
opposto», forse perché era chiaro che di lì a poche ore sarebbe stato arrestato.
Anche Luigi Bisignani, l'«Uomo che sussurra ai potenti» (bestseller
Chiarelettere con Paolo Madron), braccio destro di Gardini alla Ferruzzi,
conferma questa lettura: «Raul Gardini si suicidò perché la procura aveva
promesso che la sua confessione serviva per non andare in carcere, ma invece
scoprì che l'avrebbero arrestato». Processo Enimont, la «madre di tutte le
tangenti», l'epicentro del terremoto Tangentopoli. «La storia di quella
cosiddetta maxitangente, che poi invece, come diceva Craxi, era una maxiballa, è
ancora tutta da scrivere. - Pomicino lo spiega meglio - Alla politica andarono
15 o 20 miliardi, ma c'erano 500 miliardi in fondi neri. Dove sono finiti? A chi
sono andati? E chi ha coperto queste persone in questi anni? In parte l'ho
ricostruito, con documenti che ho, sui fondi Eni finiti a personaggi all'interno
dell'Eni. Ma di questo non si parla mai, e invece si pubblicano false
ricostruzioni della morte tragica di Gardini».
TIZIANA PARENTI.
Tiziana Parenti. Da Wikipedia,
l'enciclopedia libera. Tiziana Parenti detta Titti (Pisa, 16 aprile 1950)
è un avvocato, politica ed ex magistrato italiana.
Pisa 16 aprile 1950. Avvocato. Ex magistrato
(era nel pool Mani pulite, versante tangenti rosse: fece arrestare il comunista
Primo Greganti). Ex parlamentare (eletta con
Forza Italia nel 1994 e 1996). «Candidarsi era
giusto, lo rifarei. Nel 94 stava per andare al potere una classe dirigente
vendicativa. Avevo già dato un’occhiata all’organigramma, in Procura: Occhetto
presidente del Consiglio, Violante ministro dell’Interno... Un disastro». Ruppe
con Berlusconi ai tempi della Bicamerale: «Ero
stata mandata là e mi era chiaro che Berlusconi
la usava per trattare sulle sue cose. Credeva ai suoi consiglieri, ma io glielo
dicevo: “Guarda che non è qui che risolverai i tuoi processi”. Sono passata al
gruppo misto e poi, nel 2001, non mi sono ricandidata. Non avrei saputo con chi
farlo» (a Maria Latella). Presidente della
commissione Antimafia dal 1994 al 96. Nel 2004
aderì alla Margherita di Rutelli. Assolta nel marzo 2007 a Genova
nello stesso processo in cui un colonnello dei carabinieri fu condannato per
aver gestito in modo spregiudicato droga
e pentiti. Detta “Titti la rossa”.
Biografia. Dopo un'iniziale adesione
giovanile al PCI di Pisa, entra in magistratura. Magistrato in servizio prima in
corte d'assise, poi alla procura di Milano, "Titti la rossa" - come veniva
soprannominata da alcuni giornalisti - fu il Pubblico Ministero dell'inchiesta
denominata dai mass-media delle tangenti rosse, ed è stata sostituto
procuratore del pool milanese dal marzo 1993 nell'inchiesta "Mani pulite". Dopo
aver lasciato la magistratura ha intrapreso la professione di avvocato. Fecero
scalpore le sue dimissioni dal pool e dalla magistratura e la successiva
adesione a Forza Italia, nelle cui liste fu eletta alla Camera nel marzo 1994
nel collegio maggioritario di Mantova. Fu presidente della Commissione
antimafia, nel corso della XII Legislatura. Rieletta nel 1996 alla Camera nel
collegio maggioritario di Grosseto, aderì al gruppo di Forza Italia.
Successivamente, nel 1998, fu tra i primi aderenti al nuovo partito dell'UDR di
Francesco Cossiga. Aderì quindi ai SDI. Accusata nel 1995 di concorso in falso
in atto pubblico in un'inchiesta contro alcuni ufficiali dell'Arma dei
Carabinieri, viene assolta definitivamente nel 2009. Nel 2004 aderisce a La
Margherita ed esercita l'avvocatura. Nel 2012 rientra nel Partito Socialista
Italiano.
EXPO’, paura per la nuova tangentopoli,
scrive Roberto Capocelli su “L’Avanti On line”. Il Presidente del Consiglio
Renzi promette ancora una volta di “metterci la faccia”, mentre il commissario,
Giuseppe Sala, per l’Expo sembra voler buttare acqua sul fuoco. Secondo Sala,
incaricato di vigilare sula regolarità dei lavori dell’Expo, «il principale
problema che ha causato ritardi è stato il maltempo». Sala, ascoltato in
Commissione Antimafia, sciorina una serie di dati che sembrano essere orientati
a promuovere l’Expo mentre, nel merito di ciò su cui è chiamato a rispondere, si
limita a dire di aver dato troppa fiducia ad Angelo Paris, il direttore
pianificazione e acquisti, «non sospettando che potesse tenere certi tipi di
comportamenti». I comportamenti a cui fa riferimento sono di turbativa d’asta e
corruzione ed hanno portato già all’arresto di numerose persone facendo parlare
di una “tangentopoli due”. L’unica responsabilità di cui si fa carico il
commissario è quella di non aver insistito abbastanza con il comune di Milano al
fine di organizzare «una gara per il general contractor a cui affidare il
cantiere». Titti Parenti, ex magistrato del pool di “Mani Pulite”, esponente
socialista che ha vissuto in prima linea gli avvenimenti iniziati il 17 febbraio
del ’92 con l’arresto di Mario Chiesa, amministratore del Pio Albergo Trivulzio,
ha una lettura diversa di quanto accade oggi a Milano che restituisce all’Avanti!
con la profondità della prospettiva storica.
«Onorevole Parenti, in relazione alle indagini dell’Expo si parla
di una nuova Tangentopoli. Cosa pensa? Quali indicherebbe come differenze e
quali come similitudini con i fatti di più di vent’anni fa?
«Più che delle differenze, io credo che
ci si trovi di fronte a un’altra cosa. Mi spiego: certamente gli atti di
corruzione sono uguali nelle modalità, non c’è dubbio. Ma, l’elemento davvero
differente riguarda il ruolo della politica. Oggi la politica è più debole di
quello che era vent’anni fa. Prima c’era una stabilità di punti di riferimento,
cioè dei partiti e dei leader. Oggi, i punti di riferimento sono provvisori,
mancano i grandi leader e i partiti si sgretolano. Sono caduti quei puntelli e
non c’è più niente di tutto questo. Anche i personaggi che si avvicendano sulla
scena, a parte casi clamorosi, sono personaggi un po’ provvisori. Non vedo
grandi strateghi, grandi leader che hanno una storia. Tutto questo incide anche
sulle modalità di corruzione».
Come?
«Proprio la provvisorietà che
caratterizza questi leader li rende ancora più facili a pericolose
condiscendenze verso pratiche poco trasparenti. Lo fanno per rimanere a galla,
perché non hanno una forza propria. Per questo hanno bisogno di ricorrere a
lobby, a giri di clientele. Certamente c’è un rinnovarsi di situazioni già
viste, ma con soggetti senza un grosso “peso specifico”».
Eppure tra gli arrestati figura il nome di Primo Greganti, il
“compagno G”. Una contraddizione rispetto al quadro che lei dipinge. No?
«No. Anzi. Proprio i tre nomi storici
(Greganti, Frigerio e Grillo ndr) della politica venuti fuori che ci fanno
capire la situazione. Sono loro a rappresentare una continuità paradossalmente
proprio perché, nel contesto attuale, sono gli unici che hanno una storia
consolidata e, di conseguenza, possono offrire affidabilità e capacità. Perché
in queste situazioni non ci sono improvvisazioni».
Ma, come mai una persona come Greganti, continuava ad essere, a
prescindere dall’accertamento delle sue responsabilità, un referente in fatto di
opere come l’Expo?
«Non so come si possano essere create
queste connessioni con personaggi “datati”. Sicuramente all’epoca di
Tangentopoli si sarebbe dovuto adoperare indagini più approfondite per scoprire
le tante radici che quelle persone avevano messo e questo ci aiuterebbe a capire
quanto accade oggi. Invece, all’epoca, ci si concentrò sui leader dei partiti e
non sui gregari senza considerare che spesso i leader neanche controllano
gregari, gli danno carta bianca perché gli fanno comodo».
Che impressione le fa vedere il continuo riproporsi di dinamiche
di corruzione?
«Tangentopoli è stata una mera
illusione e la burocrazia è rimasta intatta. Si volle far credere che si era
concluso il problema. Ma, il problema è profondo e affonda le radici nella
società italiana che rende quasi sempre impossibile arrivare con i meriti
propri, e questo vale per gli individui come per le imprese. Se qualcuno cerca
di essere onesto, ma davanti si trova una schiera di disonesti che cercano di
fregarlo ha poche alternative: se ne va o si accontenta di cose residuali.
Oppure si adegua. È una lotta impari, sleale».
Dunque, mi sta dicendo che la corruzione è un fenomeno che
attraversa trasversalmente la società italiana?
«Come ora emerge chiaramente, si tratta
proprio di un fenomeno trasversale. Anche prima era trasversale solo che per
ragioni complesse emergeva meno. Ma, oggi come ieri, sono tutti d’accordo: è una
questione di logica, non è possibile che ce ne sia uno o due che fanno affari
sporchi e gli altri stanno a guardare perché, se così fosse, il sistema non
vivrebbe a lungo. Tutti sanno come vengono assegnati molti appalti e tutti
devono essere coinvolti sennò finirebbe “la pacchia”. Il nostro è un Paese fatto
per le “larghe intese” in tutto: il maggioritario non ci stava bene perche
alcuni prendevano e altri no. Ora siamo ritornati con larghe intese ad avere una
società espansa, anche nella corruzione».
Riguarda la politica come l’imprenditoria?
«Certo. Dobbiamo considerare che non
abbiamo, in Italia, grandi imprese capaci di stare sul mercato, fatta eccezione
per una parte del nostro export di qualità. Il resto sono imprese familiari, o
piccole, o comunque imprese che non hanno una struttura adeguata. Da questo
consegue che gli appalti si fanno con gli eccessi di ribasso che non permettono
nessun margine di guadagno ad imprese serie. Sono competizioni volte al peggio
invece che al meglio. È inevitabile, dunque, che si ricorra a raccomandazioni,
mazzette, a referenze che, con il tempo, possono cambiare, ma si tratta pur
sempre di operare in un sistema di relazione occulta. Manca la trasparenza e
tutti lo sanno».
Cosa determina questo sottobosco?
«C’è una complicità tra società, potere
politico e imprenditoriale che rende la nostra economia debole. L’Italia non è
debole per la crisi, che certo peggiora le cose, ma è strutturalmente debole.
Poi, quando qualcuno scopre l’acqua calda, arrivano le commissioni di inchiesta
e le “task force”, che sono ulteriormente dispendiose e non risolvono il
problema e che, oltretutto, sono a loro volta nominate non si sa in base a quali
criteri. Ma il punto è che le persone non sono messe in grado di competere
nell’ambito di un’attività professionale, nel lavoro. Per competere davvero e
far emergere i migliori c’è bisogno di trasparenza».
Ci sono rischi concreti ce possa saltare l’Expo?
«Rispetto all’organizzazione dell’Expo
mi pare che ci siano ritardi anche piuttosto gravi. Certamente non si può
pensare di fare grandi opere in tempi biblici come è prassi da noi. Ci sono
pratiche burocratiche che implicano corruzione e raccomandazioni che rallentano
tutto e, già nella tempistica si può vedere che le cose non vanno. L’opera
sicuramente è a rischio ed è a rischio la nostra credibilità, l’immagine del
Paese nel mondo. Perché l’Expo rappresenta soprattutto una porta d’ingresso per
persone interessate a investire che significa lavoro. Qui si parla di riforma
del lavoro e di contratti, ma i contratti ci saranno quando c’è lavoro. Mi
sembra che si parla di formalità prima di avere la sostanza. Quello che sta
accadendo a Milano si sa all’estero».
Un danno considerevole per l’economia che, si dice, va
rilanciata…
«Nessun investitore ha piacere a
trovarsi in condizioni di grave rischio, e i fenomeni di corruzione e malcostume
rappresentano uno svantaggio considerevole che viene valutato. E questo certo
deprime ancora di più l’economia del Paese. La politica e il mondo
imprenditoriale devono capire che così non si può andare avanti. Quello che
vediamo non rappresenta un caso isolato, ormai il ‘re è nudo’. Ognuno si deve
rendere conto che bisogna qualificarsi, attrezzarsi e ci si deve confrontare su
problematiche necessità. Gli anni passano ma nessuno dice mai la verità, prima
di tutto a se stesso e poi agli altri perché, da noi, se non sei nel compromesso
sei escluso. È terribile vivere in una società così».
Titti Parenti: "La corruzione è organica all'Italia".
L'ex magistrato parla della Tangentopoli infinita. "Sono cambiate le ragioni:
allora non si rubava per arricchirsi". Titti la rossa, che nel '94 fu eletta per
Forza Italia, ricorda: "Lasciai la magistratura quando Mani pulite prese una
deriva politica". E ancora: "Corrotto e corruttore non sono diversi. Tutti
coinvolti, anche i rossi". Francesco Ghidetti su “Il Quotidiano Nazionale”.
Incontriamo Tiziana Parenti nella sua casa di Trastevere. Carte, appunti,
ritagli di giornali e libri si accumulano nelle stanze. «Titti la rossa» adesso
fa l’avvocato. Si occupa di questioni toste. ’Ndrangheta, per capirsi. Ma
nessuno può dimenticare il suo ruolo di primissimo piano nel pool di Mani
Pulite. Lei era il magistrato che si occupava di «tangenti rosse». Lei, che dopo
una militanza nel Pci pisano, ha poi fatto politica in Forza Italia e nello Sdi.
Avvocato Parenti, Tangentopoli è storia o cronaca?
«Cronaca. Siamo ancora lì. Non ci si vuole rendere conto che la corruzione è
organica al sistema-Italia. Vent’anni fa come oggi».
Un quadro non incoraggiante...
«Lo so. Non a caso uso la parola sistema perché indicativa di un modo di essere
tipico della nostra società».
Però, nella tanto vituperata Prima Repubblica non si rubava...
«Sì, l’ho già sentita. Non si rubava per arricchirsi, ma per la lotta politica.
Ora, io non devo scrivere saggi di storia comparata. Né giustificare certe
pratiche di ladrocinio dei beni pubblici. Però, volendo parlare di contesto
posso dire che prima le ragioni della corruzione erano diverse. L’Italia aveva
avuto a che fare con i mostri del Novecento: fascismo, nazismo, comunismo.
Occorreva accompagnarla lungo l’accidentato viale della democrazia per garantire
sistema, lavoro, assistenza sanitaria».
All’inizio di Mani Pulite vi rendeste conto che l’Italia avrebbe
subito un clamoroso trauma?
«A parte il fatto che bisogna vedere se davvero c’è stato questo cambiamento e
se sia stato davvero così clamoroso. A parte il fatto che io arrivai dopo e per
occuparmi di tangenti ‘rosse’. Detto ciò, tutto nasce dal Psi milanese e da
Mario Chiesa in particolare. Una storia già scritta, mi sono sempre chiesta?
Forse. Anche perché ci fu un allargamento che colpì altre forze politiche».
Alcuni dicono: non i «rossi».
«Per quel tipo di indagini c’era un’oggettiva difficoltà. Diciamo che con
partiti come Psi, Dc, Psdi, Pri era più facile. Avevano sistemi più rozzi.
Invece, si dipinse il Pci come fuori dal sistema. E quindi impermeabile alla
corruzione. Un falso. I comunisti agivano su un doppio binario: prendevano soldi
dal blocco sovietico e, dagli anni Ottanta, cominciarono a comportarsi come gli
altri».
Contesto internazionale: cade il Muro, i cosacchi non arriveranno
più, il ceto politico italiano può anche morire: vero? falso?
«Vero. In parte. Attenzione, però. Non è che nel 1989 cade il Muro e poco dopo
la Prima Repubblica. Il processo era cominciato per lo meno quindici anni prima.
Col Papa. Coi socialisti che aiutavano i patrioti polacchi».
Politici cattivi, imprenditori vittime.
«Figuriamoci. Corrotto e corruttore non sono figure diversamente cattive. Spesso
le seconde sono le peggiori e ci guadagnano di più. Occhio: il populismo è il
vero nemico della politica».
Lei poi entrò in politica.
«Sì. Però tentennai molto. Prima con Forza Italia, poi con i socialisti dello
Sdi. Francamente, il punto era un altro. Volevo impegnarmi, certo. Ma,
soprattutto, lasciare la magistratura. Furono anni per me di profondo disagio.
Le indagini avevano preso una direzione politica che mi lasciò assai
perplessa...».
Tiziana Parenti: «Quei fondi dall’Est su cui non si indagò»,
scrive Angelo Picariello su “L’Avvenire”. Tiziana Parenti, ovvero Titti la
Rossa, quella delle tangenti al Pci mai provate, oggi fa l’avvocato a Roma con
studio a Trastevere. Venti anni dopo Tangentopoli va col ricordo a quella
primavera del ’94, a una fase che segnò la fine di Manipulite. «Berlusconi aveva
vinto le elezioni. Stava formando il governo e io ero appena stata eletta
deputata con Forza Italia. Correva voce che volesse Antonio Di Pietro a capo
della Polizia. Io andai a dirgli che era un errore».
Ma non lo voleva ministro dell’Interno?
«Fra noi correva quest’altra voce e ne
parlai con Berlusconi. Che non smentì, anzi si arrabbiò. L’uomo, un po’ come i
comunisti, non ama esser contraddetto».
Invece lei...
«Gli dissi che non era un bel segnale.
Lui evidentemente pensava invece che fosse importante in termini di immagine. Mi
rispose seccato: «Guardi che non ho nemmeno un’inchiesta». «Ma ore ne
arriveranno a decine, vedrà», gli risposi. E fui facile profeta».
Vuol dire che fino alla discesa in campo non c’era ancora traccia
di scontro fra Procura milanese e Berlusconi?
«Ricordo i giornalisti di Fininvest che
venivano a prendere le veline e come si arrabbiavano quando non gliele davano.
Ma le telecamere fisse davanti alla Procura dalle reti di Berlusconi le
ricordano tutti. Non era una vera direttiva, ma c’era il chiaro orientamento a
risparmiare, da un lato le aziende di Berlusconi e dall’altro l’ex Pci. Perché
potevano essere utili una copertura mediatica e politica».
Ma sul Pci risparmiato accusano lei. Perché la scelsero?
«Ho un sospetto: siccome nel mio
profilo avevo dovuto dichiarare la mia passata iscrizione al Pci per tre anni,
per come sono andate poi le cose potrebbero aver pensato a me - che avevo
chiesto di essere collocata alla Dda - perché avevo il curriculum giusto per
archiviare».
Ma che cosa le ha impedito di andare a fondo sulle tangenti
all’ex Pci? Quella rogatoria mai arrivata sui 600 milioni versati da Panzavolta
sul conto “Gabbietta” di Primo Greganti alla Banca di Lugano?
«Che fossero fondi per il Pci è chiaro,
già la sola contestualità con i versamenti di tangenti agli altri partiti lo
dimostra. Ma era solo un filone, c’era da indagare sulle coop rosse, e
soprattutto sui fondi arrivati attraverso la Germania dell’Est».
Di questo non si è saputo niente.
«C’era uno scatolone alto così, pieno
zeppo di attestazioni bancarie, ma andavano tradotte dal tedesco. Lei pensa sia
facile farsi raccontare la provenienza dalle banche della Germania dell’Est?»
Poi si è dimessa da pm...
«E mi risulta che non ci abbia pensato
più nessuno».
Ma perché lasciò?
«D’Ambrosio mi disse che l’inchiesta
sul Pci era un «vagone staccato». Credo, in realtà, che non si volesse andare a
fondo».
Ma Greganti nega e ha dimostrato che quei soldi gli servirono a
comprare un appartamento.
«E lei ci crede?»
Su Berlusconi comunque hanno recuperato con gli interessi...
«Da leader politico è diventato un
bersaglio, ma credo abbia inciso anche quell’offerta fatta da lui a Di Pietro
che, sebbene non andò in porto, indispettì parte della Procura, nel frattempo
spaccatasi proprio sulla scelta politica del loro ex collega. Il risultato è che
i due filoni risparmiati dalle prime inchieste di Manipulite hanno
caratterizzato questo ventennio inconcludente».
Berlusconi e i comunisti...
«Si sono fatti la guerra ma erano
d’accordo a non fare le riforme, tanto che ora sono stati commissariati dai
tecnici. E la corruzione impazza più di prima».
Ha mai visto ai suoi tempi 13 milioni spariti ad opera di un
tesoriere?
«No, assolutamente. E infatti oggi è
peggio. Da avvocato ora mi occupo di un caso che va avanti da sei anni, una
compravendita di esami a Roma 3 e alla Sapienza. La corruzione impazza, neanche
più con coperture ideologiche. Ovunque ci sia un potere da gestire e un do ut
des da utilizzare».
Tiziana Parenti (ex Pm di Mani
Pulite): Di Pietro riferiva dell’inchiesta all’America,
scrive Giampiero Marrazzo su “L’Avanti On Line”. Una volta per tutte è stato
detto: Antonio Di Pietro, soprannominato da qualcuno “Tonino l’Americano” aveva
rapporti con gli amici d’Oltreoceano ben prima che l’inchiesta di Mani Pulite
cominciasse ad entrare nel vivo. E non soltanto. Ai referenti diplomatici
americani a Milano, l’ex pm, oggi leader dell’Idv, avrebbe anche rivelato in
anticipo rispetto all’inizio degli arresti, il coinvolgimento di Craxi e della
Dc. Andando avanti con ordine: ieri il quotidiano “La Stampa” pubblicava
un’intervista postuma all’ex ambasciatore Usa in Italia, Reginald Bartholomew,
il quale, ricordando il periodo iniziale del suo incarico, dichiarava: “Indagini
giudiziarie, arresti di politici «presero subito il sopravvento sul resto del
lavoro, perché la classe politica si stava sgretolando ponendo rischi per la
stabilità del Mediterraneo», ed è in questa cornice che Bartholomew si accorge
che qualcosa nel Consolato a Milano «non quadrava». Se fino a quel momento il
predecessore Peter Secchia aveva consentito al Consolato di Milano di gestire un
legame diretto con il pool di Mani Pulite «d’ora in avanti tutto ciò con me
cessò», riportando le decisioni in Via Veneto”. Come se non bastasse oggi
arriva la conferma sempre sul quotidiano torinese, con l’intervista all’ex
Console americano a Milano Peter Semler, il quale seraficamente ricorda: «Parlai
con Di Pietro, lo incontrai nel suo ufficio, mi disse su cosa stava lavorando
prima che l’inchiesta sulla corruzione divenisse cosa pubblica. Mi disse che vi
sarebbero stati degli arresti. Ci vedemmo alla fine del 1991, credo in novembre,
mi preannunciò l’arresto di Mario Chiesa e mi disse che le indagini avrebbero
raggiunto Bettino Craxi e la DC». Con la medesima tranquillità, quasi fosse cosa
buona e giusta, Semler rivela nell’intervista a “La Stampa”, «Di Pietro mi
piacque molto, poi fece il viaggio negli Stati Uniti organizzato dal
Dipartimento di Stato (…). Gli fecero vedere molta gente, a Washington, a New
York (…). Ero spesso in contatto con lui, ci vedevamo (…). Con me era sempre
aperto, ogni volta che chiedevo di vederlo lui accettava, veniva anche al
Consolato (…)». Sempre oggi sullo stesso giornale, Di Pietro risponde: «Non
potevo anticipargli il coinvolgimento dei vertici di Dc e del Psi, perché, in
quel novembre, già indagavo su Mario Chiesa ma non avevo idea di dove saremmo
andati a parare. Semler confonde conversazioni avute in tempi e con persone
diverse». A questo punto qualche domanda bisogna pur porsela: come mai Di Pietro
riferiva all’allora console americano a Milano la nascita dell’inchiesta Mani
Pulite? Soprattutto, quale importanza aveva, mediaticamente e politicamente
parlando l’allora pubblico ministero, ben prima del famoso arresto del gestore
dell’albergo Pio Trivulzio di Milano, Mario Chiesa, tanto da essere convocato
dai più alti vertici diplomatici statunitensi? Abbiamo voluto porre questi ed
altri quesiti a chi allora faceva parte proprio del pool di Mani Pulite,
l’allora pubblico ministero Tiziana Parenti, già deputato di Forza Italia, che,
in esclusiva all’Avanti! torna a parlare dei legami e delle sensazioni che
aleggiavano nel palazzo di Giustizia di Milano.
Onorevole Parenti, allora, le nuove dichiarazioni sembrano darle
ragione: quando lei disse che l’input dell’inchiesta non era soltanto italiano
ma aveva radici americane, i suoi allora colleghi del pool, ad iniziare da Di
Pietro la querelarono?
«Questa di Semler è una confessione a
tutti gli effetti. Sono cose che tutti sapevano, ma che in pochi hanno voluto
dire. Ma sono contenta che finalmente anche diplomatici americani l’abbiano
rivelato. Perché se noi guardiamo la storia, è vero che esisteva la corruzione
nei partiti, ma per quale motivo iniziarono quelle indagini e soprattutto perché
in quel momento?»
Ce lo dica lei…
«Dopo la caduta del muro di Berlino si
erano formate in Europa determinate problematiche politiche: l’Italia non faceva
passi in avanti, era proprio come adesso, chiusa in guerre intestine, e gli
americani avevano paura e intendevano condurla da qualche parte. Perché loro
volevano continuare a navigare indisturbati nel Mediterraneo e la figura di
Craxi per loro era troppo ingombrante. Basta osservare i precedenti eventi
internazionali che vedevano coinvolti i rispettivi paesi: Italia e America».
Ma sappiamo che il legame del nostro Paese con gli Stati Uniti è
ben lontano…
«E’ inutile nasconderci dietro un dito,
l’Italia nasce sulla corruzione e sul protettorato americano, e questo è durato
per 50anni. Poi qualcosa cambiò. Ma se non ci fosse stata una volontà specifica,
visto che i nostri problemi erano ben precedenti alla data di inizio
dell’inchiesta di Mani Pulite, forse quelle inchieste non si sarebbero mai
fatte, o forse non sarebbero partite da Milano, regno del Psi di Craxi, e perché
non da Roma o da Torino. Così come mi domando per quale motivo un console
americano dovesse incontrare uno come Di Pietro che prima dell’arresto di Mario
Chiesa era un emerito sconosciuto, non aveva condotto nessun inchiesta di
rilievo. E non le nascondo che lo stesso arresto “in flagranza” di Chiesa mi
sembrò orchestrato ad arte».
E il mondo della finanza?
«Va detto che anche gli imprenditori
hanno avuto una grande parte nella spallata nei confronti della Prima
Repubblica, visto che si dovevano ridisegnare proprio gli assetti
politico-economici del Paese».
L’ex console Semler dichiara nell’intervista a “La Stampa” di
essere stato amico di molti giudici milanesi di allora. Lei lo conobbe?
«Francamente non ho mai conosciuto
questo signore. E anche questa mi sembra una cosa strana. Se è vero quello che
dice su Di Pietro, non sapevo si potesse andare a rivelare indagini che avessero
il segreto d’ufficio».
Quindi pensa che ci fu e che fu determinante il ruolo
dell’America durante quel periodo del nostro Paese e negli anni immediatamente
successivi?
«Assolutamente. Per noi era un periodo
drammatico quel del ’92 e del ’93: c’erano state le uccisioni di Falcone e
Borsellino, le bombe. L’impellenza ormai era di sciogliere le Camere, la
situazione era scappata di mano e già allora me ne rendevo conto. Tanto che come
cittadino, prima ancora che come giudice, tutto questo mi allarmava».
E Di Pietro come s’inserisce in questo contesto?
«Non so come si sia inserito, fatto sta
che queste ultime dichiarazioni dimostrano dei suoi legami con gli Stati Uniti.
Anche se non capisco dove l’ex console voglia andare a parare, ma sembra quasi
voglia lanciare un messaggio. A chi e perché sarebbe curioso saperlo».
Insomma che direzione avrebbe dovuto prendere l’Italia secondo
gli Usa?
«Questo non so dirglielo. Posso dirle
però che io ho visto con i miei occhi dei fogli con su scritto quello che
sarebbe dovuto essere l’organigramma delle massime cariche del nostro Stato,
girava per il Tribunale di Milano. Ricordo ancora l’occasione: ero scesa al bar
del Palazzo di Giustizia per la pausa pranzo e qualcuno me lo mostrò. Io
pensai: ma siete sicuri che le cose andranno in questo modo! La mia impressione
era che avessero pianificato tutto troppo presto. Comunque, se c’è del vero
basterebbe analizzare i documenti che ci sono rimasti, a cominciare
dall’archivio di Di Pietro, proprio quello di cui si parla nell’intervista di
oggi».
Andreotti diceva: «Visto che non ho fantasia, possiedo un grande
archivio, e ogni volta che parlo di questo archivio chi deve tacere, come
d’incanto, inizia a tacere». Strano che anche Di Pietro tenga un archivio, non
crede?
«Diciamo che di certo mi sembra strano
che qualcuno abbia un archivio in casa».
Insomma come se ne esce da queste vere, presunte, parziali verità
postume?
«Se non riscriviamo con serietà la vera
storia di questo Paese, invece di aspettare che tutti se la portino nella
tomba, è naturale che non avremo più una memoria, che la politica non andrà
avanti e che questo tipo di reati ci saranno ancora».
Lei queste cose le ha già dette ed è stata querelata dagli altri
componenti del pool. Com’è finita?
«Sono stata assolta dal tribunale di
Brescia. Poi dalla Camera, in quanto onorevole, non è stata data
l’autorizzazione a procedere nei miei confronti. Successivamente è
stato sollevato il conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale, che a
sua volta ha dichiarato l’improcedibilità verso di me. E per inciso, non ho mai
accettato per le mie dichiarazioni alcuna transazione finanziaria con Di Pietro
o altri del pool».
La Parenti sicura: «È nei servizi segreti»,
scrive Mariateresa Conti su “Il Giornale”. «La provenienza di Antonio Di Pietro
è in una struttura parallela ai servizi segreti. Di Pietro su questo non ha mai
fatto chiarezza...». Le parole sono attualissime. E chi parla, l'ex pm di Mani
pulite, ex deputato ed ex presidente della Commissione anfimafia, Tiziana
Parenti, è una voce più che autorevole. Solo che la dichiarazione riportata non
è affatto attuale. Anzi, ha ben tredici anni. Tredici anni durante i quali
quelle denunce, di Titti la Rossa ma non solo, sugli oscuri legami tra Tonino e
i servizi segreti sono rimaste lettera morta. E tali, forse, sarebbero rimaste
sino ad ora, se il leader Idv, tentando di giocare d'anticipo, non avesse
gridato al complotto sul suo blog. Ma c'erano, c'erano eccome le denunce, su
quei rapporti, alquanto anomali per un magistrato, con i servizi. Già 13 anni
fa, appunto. È il settembre del 1996. A dare la stura, l'allora presidente del
Cnel Giuseppe De Rita, che dalle colonne del Tempo lancia l'allarme che provoca
un putiferio: «Da Tangentopoli e dalla vicenda mafiosa stiamo uscendo con un
apparato di potere costituito dall’intreccio tra pubblici ministeri, polizia
giudiziaria e forse servizi segreti incontrollabile e incontrollato che ci deve
preoccupare». Un allarme grave, subito raccolto dall'onorevole Parenti, che cita
espressamente Di Pietro in un'intervista al Tg delle 20 di Telemontecarlo. La
Parenti conferma la contiguità dell'ex pm - nel frattempo ministro di Prodi - ai
servizi segreti: «La sua provenienza - dichiara - come risulta a Brescia, è in
una struttura parallela ai servizi segreti. Su questo Di Pietro non ha mai fatto
chiarezza». I tempi televisivi sono tiranni. All'agenzia di stampa Ansa, invece,
Titti dice un po' di più. Afferma di essere pienamente d'accordo con De Rita e
spiega che la «connessione» tra pm, polizia e servizi segreti deriverebbe da
«una politica scientifica» del Pci, che «sin dalla fine degli anni '60» avrebbe
«allevato una certa magistratura e politicizzato la polizia». È una bagarre. I
giornali ne parlano per giorni. La sinistra insorge, Di Pietro minaccia querele
e poi denuncia. Ma qualche anno dopo, a febbraio del 2000, il tribunale di
Bergamo gli dà torto e sentenzia: non luogo a procedere. Tre mesi dopo l'analisi
della Parenti si fa ancora più dettagliata. Dalle colonne di Repubblica, sentita
da una giornalista di punta del quotidiano di Scalfari, l'attuale direttora
dell'Unità Concita De Gregorio, Titti la Rossa «spara - parola di Concita -
colpi di cannone». Contro tutti: Scalfaro, il Pds, Borrelli. E Di Pietro.
«Quello che dico - afferma - è tutto documentato in carte riservate in possesso
della procura di Milano. Basterebbe indagare partendo da una domanda semplice:
perché è cominciata Tangentopoli? Cos'è successo nella procura di Milano dal '90
al '92?». La Parenti è un fiume in piena: «È successo - continua - qualcosa a
cui le indagini del Gico sono arrivate molto vicino, ed è per questo che le
vogliono fermare. È successo che prima di Mario Chiesa c'erano altri, e in
particolare un imprenditore che aveva, non so a che titolo, colloqui stretti con
Di Pietro e che lo teneva in contatto con certi ambienti, per così dire,
ambigui, in Italia e Oltreoceano». Ambienti ambigui? Oltreoceano? L'onorevole
Parenti racconta un viaggio negli Usa, contatti con la Cia. Dice che Di Pietro,
attraverso l'imprenditore suo amico della quale la Parenti non fa il nome, entra
in contatto «con ambienti del dipartimento di giustizia Usa». E che nei mesi che
intercorrono tra l'arresto di Mario Chiesa (febbraio '92) e l'entrata nel vivo
di Mani pulite «va in America. La Cia - aggiunge - voleva far fuori il Psi e
certa parte della Dc, perché non più affidabili. Caduto il muro di Berlino,
crollato il comunismo, bisognava fare piazza pulita della vecchia classe
politica e il Pds poteva essere un interlocutore affidabile. Allora Di Pietro
va, e ottiene la legittimazione. La sua rete di rapporti, in Italia, è pronta».
Anche questa volta è un putiferio. Di Pietro querela l'ex collega pm e la
giornalista. La Camera fa scudo, sostiene che quelle dichiarazioni sono protette
dall'immunità. E gli atti finiscono alla Consulta. La Parenti torna sul tema
anche in altre occasioni, in dibattiti pubblici. Ma la sua voce resta
inascoltata. Inascoltata. Ma perfettamente attuale oggi. A tredici anni di
distanza.
LE MITICHE TANGENTI ROSSE.
Le mitiche tangenti rosse, scrive
Filippo Facci su “Il Post”. Eccoci al famigerato Pci-Pds «salvato» dalla
magistratura. In un guscio di noce, la presente tesi è che il partito fu in
minima parte salvato e in massima parte si salvò e basta. Ma va spiegato bene
perché. Vediamo anzitutto come andarono le cose. Il 1° marzo 1993, in teoria,
anche il Pds nazionale era entrato seriamente in Tangentopoli: si era fatto vivo
tal Primo Greganti, un ex funzionario comunista di Torino sospettato d’aver
raccolto una tangente di 621 milioni per il Pds e di averla nascosta in un conto
svizzero chiamato Gabbietta. Sarà la prima di una serie di contestazioni
inutili: Greganti si chiuderà in un silenzio eroico e inusuale dicendo in
pratica di aver preso i soldi per sé e non per il partito, ossia il contrario di
quanto sosteneva il politico medio. L’ex segretario amministrativo del Pds,
Marcello Stefanini, sarà inquisito lo stesso: ma la sua morte prematura
coinciderà con quella di molti filoni sui finanziamenti al Pds, come non era
accaduto per il Psi con la morte del segretario amministrativo Vincenzo Balzamo.
Dirà Greganti: «Quando ho incontrato Di Pietro, e ho scoperto che aveva mandato
i poliziotti ad arrestarmi a casa prima dell’alba, non ho avuto più dubbi. Mi
voleva catturare nel sonno. Solo che io non c’ero. Avevo dormito fuori. Dove
abito io c’era mezzo metro di neve. E i poliziotti sono rimasti pure
impantanati. Io e Di Pietro avevamo un appuntamento, era da quindici giorni che
gli chiedevo di ricevermi. Finalmente ci accordiamo per le 11 al Palazzo di
Giustizia e lui che fa? Mi manda i poliziotti alle quattro del mattino a casa
per arrestarmi. Hai capito che metodi?» Il Pool di Milano intanto si era
allargato: nella primavera del 1993 era arrivato il trentaduenne Paolo Ielo e Di
Pietro avrebbe gradito anche l’inserimento del pm Gemma Gualdi, sua amica da
molti anni, ma Borrelli le preferì infine un’altra collega, Tiziana Parenti,
subito destinata al filone delle cosiddette «tangenti rosse». Le incomprensioni
e i problemi caratteriali ebbero la meglio praticamente da subito, sia per il
temperamento particolarmente orgoglioso di lei sia perché Di Pietro, come diceva
Ielo, «vuole fare il prete, il sacrestano e anche il chierichetto». Ha
raccontato il pidiessino Giovanni Pellegrino: «All’inizio D’Alema era convinto
che Violante, con la sua influenza nella magistratura, potesse proteggerci
sufficientemente dall’azione dei giudici. Poi Tiziana Parenti cominciò a
prendere di mira le fonti finanziarie del Pci-Pds e del sistema di imprese che
ruotavano intorno al partito, arrestando Renato Pollini, che del Pci era stato
l’ultimo tesoriere. In tal modo la situazione si fece pesante anche per il Pds».
Nella primissima fase di Mani pulite il Pds non venne per nulla risparmiato. Le
indagini rasero al suolo la federazione milanese (consiglieri, assessori,
segretari) e i pidiessini non mancarono di lamentarsi: anche se, al solito, tra
mille distinguo. «Dopo i primi arresti» ha raccontato Gianfranco Maris, legale
del segretario cittadino del Pds Roberto Cappellini, «il mio cliente mi disse
che aveva preso anche lui dei soldi. Chiesi a Di Pietro di sentirlo, ma
rifiutò». Racconterà Cappellini: «Me lo ricordo, Di Pietro, subito dopo
l’arresto. Era scatenato, urlava: “Parla, perché se no non esci più”». Il filone
rosso parve decollare quando il manager Lorenzo Panzavolta raccontò che a
Tangentopoli già scoppiata aveva versato altri 621 milioni al Pds sempre a mezzo
Greganti: di lì in poi le chiamate in correità cominciarono a piovere da tutte
le parti, e parlarono gli imprenditori Bruno Binasco, Giuseppe Squillaci, Paolo
Pizzarotti oltre al solito Maurizio Prada e all’ex tesoriere milanese Luigi
Mijno Carnevale. Quest’ultimo, a pagina tre del suo verbale d’interrogatorio,
chiamò in causa molto chiaramente «Occhetto e D’Alema, naturalmente d’accordo
con la segretaria amministrativa diretta dall’onorevole Stefanini». Arrestarono
anche Marco Fredda, il responsabile immobiliare del Pds. Ma le voci su avvisi di
garanzia per Occhetto e D’Alema rimasero tali. Il dissidio definitivo sarà del
24 agosto, quando Tiziana Parenti decise di inviare un’informazione di garanzia
al segretario amministrativo del Pds Marcello Stefanini senza neppure avvertire
i colleghi: le iscrizioni, sino ad allora, le aveva sempre vergate personalmente
Di Pietro. Marcello Stefanini era un senatore, e questo significava avere un
solo mese di tempo per motivare la richiesta di autorizzazione a procedere: il
Pool temeva che la collega non avesse abbastanza elementi per poterla ottenere.
E mentre i vertici della Quercia denunciavano una «strategia della tensione»,
ecco che il procuratore aggiunto Gerardo D’Ambrosio, che di solito non muoveva
un dito, condusse una sua personale indagine non per incolpare bensì per
scagionare Primo Greganti: si era collegato con l’anagrafe tributaria e aveva
concluso che neanche una lira era giunta al Pds. Il 29 ottobre 1991, nel giorno
in cui Greganti prelevava una consistente somma a Lugano – spiegò – lo stesso
firmava anche il rogito per comprare una casa, ecco dunque a prova che quei
soldi non erano finiti a Botteghe Oscure. Il caso era chiuso, anzi no: il gip
Ghitti avrebbe voluto vederci chiaro e dapprima negò l’archiviazione. Non
credeva – senza malizia: nessuno ci aveva mai creduto – alla storia del Greganti
millantatore. Ma perse la battaglia. Tra pubbliche litigate e qualche
chiacchierata di troppo coi giornalisti, in autunno l’inchiesta verrà
ufficialmente tolta a Tiziana Parenti in quanto «non allineata con la procura»
dirà Gerardo D’Ambrosio prima di aggiungere: «Questo non è il processo al Pds,
ma a Greganti e Stefanini». D’Ambrosio è lo stesso personaggio che nel maggio
precedente aveva dichiarato all’«Unità»: «Mani pulite è finita … nel senso che
ciò che doveva emergere nel filone politico-affaristico è venuto fuori». Sul
settimanale «L’Europeo» era stato ancora più chiaro: «Lo scenario è nitido, Dc e
Psi si finanziavano attraverso meccanismi illeciti … c’è stata la fase dello
stragismo … poi è venuta l’epoca della corruzione». D’Ambrosio, anni dopo, una
volta lasciata la magistratura, si candiderà come senatore nel Pds, frattanto
divenuto Ds. Se Primo Greganti rappresentava una domanda, ogni risposta giunse
comunque tardiva e seppellita da formidabili solidarietà ambientali. Greganti
divenne un vero personaggio in un mondo dove un barbuto presidente di una coop,
già di suo, appariva mediaticamente meno intrigante di un cassiere socialista in
crociera a Bora Bora, dome Silvano Larini. Ma diversi, più che gli uomini, erano
i metodi: lo era un sistema di finanziamento illecito più difficile da
individuare, lo erano elargizioni dall’Urss e commesse dall’Est che in buona
parte rientravano nei reati amnistiabili; ma diversa, in quel 1993, fu
soprattutto la gestione di Mani pulite da parte di una magistratura che
sceglieva gli obiettivi a seconda delle possibilità del momento. Quando il Pool
si mosse, insomma, la stampa già pensava ad altro. Le carte che dimostravano
come il Pds si finanziò in maniera illecita diventavano migliaia in tutto lo
Stivale, e da altrettante sentenze si evinceva tuttavia che nel Pci-Pds, più che
per altri partiti, la raccolta di fondi risultava periferizzata, parcellizzata e
soprattutto spersonalizzata. I nomi dei percettori finali non comparivano quasi
mai. Il Pds poteva contare sul mitico sistema cooperativo, ma casi moralmente
riprovevoli come quelli emersi in Campania (commistioni coop-camorra
nell’aggiudicazione degli appalti) non fecero notizia più di tanto, mentre non
si poteva negare che una scelta oculata di uomini di fiducia, cui intestare
interi patrimoni immobiliari, fu premiata da comportamenti processuali poco
solleticabili dal carcere. Il magistrato Francesco Misiani la mise così: «So
perfettamente che se avessi insistito, forse, prima o poi, sarei riuscito a
dimostrare in un’aula di tribunale che il Pci non era estraneo al circuito di
finanziamento illecito … non lo feci, consapevole anche del fatto che la
resistenza anche a lunghi periodi di detenzione, dimostrata dagli indagati,
forniva anche un ineccepibile dato formale in grado di chiudere le inchieste».
Questo mentre Italo Ghitti, il gip di Mani pulite, in un’intervista rilasciata
nel 2002 al «Corriere della Sera», ammetteva che il Pds aveva un apparato di
finanziamento illecito non meno vorace: «La storia di Mani pulite non ha
esaurito e non esaurisce la storia: qualcuno si sarà anche potuto salvare da
accuse di corruzione, ma magari ha dovuto lasciare la sede di partito, vendere
il giornale, chiudere l’azienda … il tempo ha evidenziato come, al di là dei
fatti penalmente rilevanti, vi fossero realtà che adottavano praticamente lo
stesso metodo dei partiti più coinvolti». Difficile non ripensare al
ridimensionamento della macchina organizzativa pidiessina, notoriamente la più
dispendiosa della Prima e della Seconda Repubblica. Durante la Prima resse in
qualche modo la leggenda dei finanziamenti ottenuti dalla vendita delle
salamelle al Festival dell’Unità, nella Seconda invece si passerà alle scalate
bancarie. Ha raccontato il democristiano ed ex presidente del Consiglio Arnaldo
Forlani: «Quando queste fonti si sono prosciugate hanno chiuso e poi riciclato
l’Unità, hanno venduto la sede delle Botteghe Oscure, molte di quelle
provinciali e di sezione, e infine hanno licenziato centinaia di dipendenti.
Avevamo calcolato che spendevano più di tutti gli altri partiti messi insieme.
L’autofinanziamento copriva sì e no un terzo dei costi. C’è una documentazione
con alcuni dati: cinquemila funzionari tra federazioni provinciali e organismi
collaterali, centinaia di dattilografe e autisti, un migliaio tra giornalisti e
tipografi, oltre quattrocento addetti solo alla sede centrale». Il filone legato
all’energia indica chiaramente che la spartizione a livello nazionale era fra
tutti i partiti. Il manager Lorenzo Panzavolta parlò di tre tangenti di 1
miliardo e 242 milioni ciascuna a Dc, Psi e Pci: l’1,6 per cento sulle commesse
assegnate al gruppo Ferruzzi. Spiegò che un tempo il Pci si limitava a
pretendere che una quota degli appalti fosse assegnata alle cooperative rosse,
ma dal 1986 il Consorzio cooperative costruzioni di Bologna puntò ad allargare
il proprio mercato: sicché il pidiessino Giambattista Zorzoli entrò nel
consiglio d’amministrazione dell’Enel e Panzavolta versò 1 miliardo e 246
milioni sui conti svizzeri di Greganti. Quest’ultimo sarà condannato a 3 anni e
Zorzoli a 4 anni e 3 mesi per corruzione e finanziamento illecito al partito:
«Le somme» recita la sentenza «non sono state incassate da Greganti per
prestazioni personali bensì vanno collegate a un’intermediazione fiduciaria
posta in essere da quest’ultimo a vantaggio del Pci». Per gli appalti legati
alla costruzione di impianti di desolforizzazione, in particolare, occorreva una
nuova legge e serviva che il Pci assicurasse almeno il numero legale in
Parlamento. Raccontò ancora Panzavolta: «Dissi a Greganti: se lei può dire ai
suoi parlamentari … Allora Greganti si adoperò e difatti la legge venne poi
approvata, perché il numero c’era. Il Partito comunista votò contro questa
disposizione, però era sufficiente la loro presenza per farla passare. E
Greganti venne da me e disse: “Vede che io conto, vede che riesco a ottenere
queste cose”». I giudici della VII sezione del Tribunale di Milano, nel luglio
1996, spiegarono che «a livello di federazione milanese, l’intero partito, e non
solo alcune sue componenti interne, venne coinvolto direttamente nel sistema
degli appalti per la Metropolitana Milanese … Da circa il 1987 l’allora Pci fu
inserito nel novero dei partiti politici che partecipavano alla spartizione
delle tangenti provenienti dalle imprese». L’accordo era a tal punto consolidato
che il segretario amministrativo della Dc, Maurizio Prada, fungeva spesso da
cassiere unico e smistava il denaro ai segretari amministrativi degli altri
partiti, nessuno escluso: «Risulta dunque pacifico che il Pci-Pds, dal 1987 sino
al febbraio 1992» spiega ancora la sentenza «ricevette, quale percentuale del
18,75 per cento sul totale delle tangenti, una somma non inferiore ai tre
miliardi». Raccolti dal collettore Sergio Eolo Soave prima e dal sostituto Luigi
Mijno Carnevale poi, nella divisione delle tangenti si passerà alla regola dei
tre terzi: due terzi alla corrente occhettiana e un terzo alla corrente
migliorista. Si rimanda alle note in fondo a questo post per le non poche
sentenze, condanne ed emblematiche assoluzioni del Pci-Pds-Ds nei filoni Alta
Velocità (1) e Fiat-Pds (2) e tangenti «Le gru» di Grugliasco (3) e inchiesta
veneta sulle cooperative (4) e inchiesta torinese su Eumit Intereurotrade (5) Si
tratta di situazioni definite che continuano a restare misconosciute rispetto a
situazioni non definite ma di più forte carica simbolica: a distanza di anni,
per esempio, si discute ancora del miliardo di lire che Raul Gardini pagò al Pci
per l’affare Enimont, versamento assodato per il quale il socialista Sergio
Cusani fu anche condannato in primo grado. È anche vero che i retroscena di quel
miliardo vennero trasmessi per televisione al processo Cusani, questo in un
periodo in cui un coinvolgimento del Pci-Pds in Mani pulite l’avrebbe
probabilmente trascinato nello stesso baratro in cui giacevano altri partiti
storici. La storia è sempre quella: nel 1994 l’ex uomo di fiducia di Gardini,
Leo Porcari, confermò ad Antonio Di Pietro di aver accompagnato il suo
principale in via delle Botteghe Oscure perché incontrasse Massimo D’Alema e
Achille Occhetto. Nella sentenza del 28 aprile 1994 si apprende di almeno tre
incontri di Raul Gardini coi succitati. La testimonianza di Porcari convergeva
con quella di Carlo Sama: l’ex amministratore di Montedison, infatti, aveva
riferito a Di Pietro di un colloquio avuto con Sergio Cusani dove quest’ultimo
raccontava che Raul Gardini «gli aveva detto di aver passato 1 miliardo tondo al
Partito comunista, ad Achille Occhetto in persona, per ottenere un appoggio per
la defiscalizzazione degli oneri gravanti su Enimont». Non bastasse, Pino
Berlini, uomo Ferruzzi a Losanna, aveva confermato la movimentazione del
miliardo, mentre Sergio Cusani, sempre secondo Carlo Sama, avrebbe usato un
aereo privato della Montedison per portare il miliardo da Milano a Ravenna e poi
da Ravenna a Roma. L’audizione di Occhetto e D’Alema fu tuttavia negata dal
tribunale, che pure, nella sentenza, scrisse: «Gardini si è recato di persona
nella sede del Pci portando con sé 1 miliardo di lire. Il destinatario non era
quindi semplicemente una persona, ma quella forza di opposizione che aveva la
possibilità di risolvere il grosso problema che assillava Enimont [un decreto di
sgravio fiscale ] e il fatto così accertato è stato dunque esattamente
qualificato come illecito finanziamento di un partito politico». Nel processo
d’appello, Cusani fu condannato a 6 anni – due in meno del primo grado –, ma
l’episodio venne stralciato. Riportare tutti i processati e i condannati delle
inchieste sulle coop rosse, ancora e infine, è impresa impossibile: basti che
hanno proceduto le Procure di Milano, Brescia, Torino, Venezia, Bologna, Reggio
Emilia, Modena, Ravenna, Ferrara, Firenze, Grosseto, Arezzo, Roma, Frosinone,
Napoli, Lecce, Palermo, Catania e Caltanissetta. Per non parlare dell’indagine
veneziana di Carlo Nordio che con centinaia di imputati ha assorbito i
procedimenti di Milano, Torino e Roma. Moltissime le condanne, nessuna o quasi
di peso politico. Qualche incomprensione diplomatica, a margine dell’inchiesta
di Nordio, a metà degli anni Novanta, rischiò di alimentare i dubbi di chi
sosteneva e sostiene che il Pool di Milano abbia trascurato la sinistra. Ha
raccontato Carlo Nordio: «La Procura di Milano mi mandò una serie di verbali
anche molto importanti dai quali emergeva … tutta una serie di finanziamenti
fatti al Pci-Pds. Ricordo che furono inviati i verbali di un tale Carnevale.
Dopo accadde un fatto anomalo. … arrivò a Venezia un plico anonimo con la
fotocopia di un verbale di questo Carnevale, dove si faceva il nome dell’on.
D’Alema, e questo verbale [da Milano] non mi era stato mandato. Allora chiesi
alla Procura di Milano: “Questo verbale esiste?”. In un primo tempo mi dissero
che non lo sapevano, … che loro avevano mandato tutto quello che avevano… Allora
fecero delle ricerche e lo trovarono … Io ritenni il fatto singolare». Non meno
singolare un altro episodio sempre raccontato da Nordio. La Procura di Milano,
nel 1993, aveva già interrogato il futuro teste chiave dell’inchiesta veneziana,
Agostino Borello, amministratore di una cooperativa piemontese che aveva
raccontato una serie di finanziamenti occulti a margine dei quali, in forma di
ringraziamento, si registrava la regolare presenza alle riunioni di D’Alema e di
Craxi. Nordio, perciò, nella primavera del 1995, tornò a Milano per ascoltare
questo Borello: «Lo interrogai presso la sede della Guardia di Finanza. …
Vedendo che esisteva una direttiva della Procura di Milano della fine del 1993
che demandava alla Guardia di Finanza l’onere di riscontrare le dichiarazioni di
Borello, chiesi agli ufficiali … : “Cosa avete risposto a questa direttiva? …
L’avete riscontrato o meno?”, e mi fu detto che non avevano ancora risposto. Al
che io dissi: “Avete una direttiva della Procura di Milano di fine 1993 e un
anno e mezzo dopo non c’è risposta?”». Mi fu detto: “C’è stato tanto da fare”».
1) Il costruttore Bruno Binasco (Itinera, autostrade) raccontò di 400 milioni
dati a Greganti per il Pds e in particolare citò una riunione del 1989 convocata
dal senatore Lucio Libertini in via delle Botteghe Oscure. C’erano i massimi
costruttori italiani. Si era alla vigilia del varo di grandi opere, tra le quali
nuovi tratti autostradali e appunto l’Alta Velocità ferroviaria: e il Pds aveva
aderito senza riserve, è nero su bianco. Il costruttore Marcellino Gavio
confermerà che Greganti incassò denaro per tener buono il partito, e il compagno
G. peraltro non negò di averlo ricevuto come funzionario del Pci: ma addusse a
giustificazione una complicata operazione immobiliare poi smontata dai giudici.
Gavio motiverà l’elargizione «in previsione del fatto che in quel momento
venivano stanziati i finanziamenti per le opere pubbliche che il partito era
impegnato a sostenere». Greganti e Binasco sono stati condannati per
finanziamento illecito al Pds (rispettivamente a 5 mesi e a 1 anno e 2 mesi) e
dalla sentenza si apprende che «era la volontà non del Greganti, ma del Pds, e
che tale richiesta egli faceva espressamente in nome e per conto del tesoriere
nazionale Stefanini». Circa la posizione di Massimo D’Alema, il cassiere
socialista Bartolomeo De Toma raccontò: «Balzamo mi riferì di una riunione
sull’Alta Velocità dove si discuteva di una ripartizione dei lavori tra le varie
imprese che poi avrebbero erogato finanziamenti illeciti. In quell’occasione
Balzamo mi disse che, pur essendo Stefanini il segretario amministrativo, tutte
le questioni riguardanti il finanziamento erano coordinate dall’allora
vicesegretario Massimo D’Alema». Marcello Stefanini e Vincenzo Balzamo non
poterono confermare né smentire, essendo morti.
2) Sempre a proposito della posizione di Massimo D’Alema, l’europarlamentare
diessino Cesare De Piccoli, capo dei dalemiani a Venezia, nel 1993 fu
beneficiario di mazzette Fiat. Il manager Ugo Montevecchi infatti aveva
confessato al Pool di Milano: «Mi fu fatto presente che bisognava dare una mano
al Pci e significativamente alla corrente veneta di D’Alema». E partirono 200
milioni elargiti al Pds nel maggio e nel giugno 1992 (in piena Mani pulite) poi
versati su conti svizzeri. I reati andarono in prescrizione nel febbraio 2000.
Due mesi dopo Cesare De Piccoli divenne sottosegretario all’Industria nel
secondo governo Amato e in seguito passò all’ufficio economico del partito. Per
altra indagine, poi, fu appurato che Massimo D’Alema nel 1985 incassò circa 20
milioni illeciti da Francesco Cavallari, re delle cliniche baresi e definito
«facente parte di un’associazione di tipo mafioso» dalla Procura antimafia di
Bari. Il reato, peraltro non negato da D’Alema, è caduto in prescrizione perché
confessato solo nel 1994, un anno dopo la scadenza dei termini.
3) A proposito di Piero Fassino e dell’indagine sull’immenso centro commerciale
«Le gru» di Grugliasco, in provincia di Torino, non fu trovato alcun riscontro
circa il particolareggiato ma solitario racconto fornito alla procura da Antonio
Crivelli, ex capogruppo del Pci: «La linea del partito era che il centro andava
costruito a ogni costo: la nostra sensazione era che la decisione fosse stata
già presa in altra sede, e cioè in sede di segreterie di partiti a livello
provinciale e nazionale … Avevo saputo che Fassino si era recato a Parigi sotto
la Tour Eiffel per ritirare una borsa con del denaro, in relazione alla vicenda
delle Gru». Furono appurate tangenti a due sindaci comunisti, ma nessuno
confermerà mai il racconto di Crivelli, e tantomeno lo farà Fassino, sentito
come testimone per la sua curiosa funzione di garante politico per la
costruzione di un centro commerciale.
4) L’immensa inchiesta veneziana condotta da Carlo Nordio, che pure archiviò le
posizioni di Occhetto, D’Alema e Craxi, accertò centinaia di responsabilità e
più in generale la falsità dei bilanci, l’occultamento regolare di beni, il
legame finanziario col Pci-Pds nonché «la partecipazione della segreteria
nazionale alla gestione economica delle risorse e in particolare dei
finanziamenti pervenuti in modo anomalo e clandestino», e soprattutto la
condiscendenza di svariati «signor G» oltreché la disponibilità del partito di
un immenso patrimonio immobiliare gestito da prestanome e derivante da
contributi clandestini. Nell’archiviare l’indagato Massimo D’Alema, la Procura
di Reggio Emilia ha dovuto prendere atto che il presidente di una cooperativa
rossa che aveva fatto versamenti illeciti al Pci, Nino Tagliavini, «dichiara di
aver preso parte, nel febbraio 1992, con molti altri presidenti di cooperative,
a una riunione nel corso della quale il D’Alema avrebbe ricordato agli
intervenuti gli oneri economici che il partito doveva sopportare, dicendo loro
che lo Stefanini li avrebbe chiamati. Sarebbe stato così che, sollecitato a un
incontro, Tagliavini avrebbe versato 370 milioni». Una delle migliori
descrizioni di come funzionasse il rapporto tra partito e cooperative resta
quella di Giovanni Donigaglia, presidente della Coopcostruttori di Argenta
(Ferrara) e ovviamente comunista di ferro. Durante Tangentopoli, inquisito a
Verona, Milano e Napoli, collezionò un numero impressionante di arresti e la
racconterà così: «Nelle commesse pubbliche era riservata una quota di appalto
alle cooperative vicine al Pci, che ha sempre richiesto e voluto che una parte
degli appalti fosse riservata alle imprese ideologicamente vicine alle sue
posizioni … Ogni volta che c’è un appalto pubblico in cui si deve formare un
raggruppamento di imprese e in cui deve essere previsto l’inserimento di una
cooperativa, io mi rivolgo al Consorzio cooperative di costruzione per avere
ordini, poi è il Consorzio che decide come distribuire ogni appalto tra le
cooperative. Periodicamente venivamo informati dai funzionari circa le richieste
economiche del partito». Fra questi funzionari c’erano Primo Greganti, Renato
Pollini e Marcello Stefanini. Ecco come il denaro arrivava a destinazione:
«Pubblicità sui giornali del Pci-Pds, contributi alle Feste dell’Unità, spese
per manutenzione di sedi, assunzione di operai e personale su richiesta di
esponenti del partito, contribuzioni a manifestazioni e convegni».
5) La Procura di Torino indagò sulla Eumit (Euro Union Metal Italiana Torino)
Intereurotrade e cioè su una società che promuoveva import-export di acciai con
i paesi comunisti. Un classico del Pci vecchia maniera: la società era stata
fondata nel 1974 dal Partito comunista e da una banca della Germania Est, la
Deutsche Handelsbank, ovviamente sotto l’occhio attento del servizio segreto
Stasi. Poi il fascicolo confluì a Milano e in mille altri rivoli: con ciò
divenendo un dedalo di cui si è sempre scritto e capito poco, complice la
spaventosa difficoltà di raccogliere documentazioni oltrecortina; senza contare
che una banca austriaca, in particolare, non ha mai risposto alle rogatorie
chieste dalla Procura di Milano, e questo senza che il Pool scatenasse il
finimondo. Non si tratta di cifre da poco, ma di qualcosa come 16 miliardi di
lire che sono passati dalla Eumit al Pci tra il 1983 e il 1989, estero su
estero: i reati prospettati furono frode fiscale, bancarotta fraudolenta e
finanziamento illecito al partito; gli indagati furono Achille Occhetto, Renato
Pollini e Marcello Stefanini. Un prestanome del caso, certo Brenno Ramazzotti,
ex funzionario del Pci, faceva la parte del Greganti di turno. Ma è ancora e
direttamente il Greganti autentico, sorta di prezzemolo del finanziamento
illecito pidiessino, a spuntare nel tardo 1993: sul suo celebre conto svizzero
Gabbietta nel 1990 era transitato infatti 1 miliardo di lire (frutto della
vendita della quota di Eumit appartenente al Pci, quell’anno ceduta interamente
alla Deutsche Handelsbank), che poi aveva fatto un giro contorto ed era andato a
ripianare i conti della Ecolibri, una casa editrice amministrata da Paola
Occhetto, sorella di Achille. In pratica: «Realmente vi furono illecite
erogazioni da Eumit al Pci, il cui segretario era allora l’on. Achille Occhetto,
e i segretari responsabili [tesorieri] erano allora sia Stefanini sia Pollini.
Tanto è attestato dalla logica, dal riscontro documentale, dalle univoche
risultanze della rogatoria in ambito della Ddr». La Eumit era una società
autentica che faceva profitti autentici, beninteso, ma sino al 1989, ossia sino
al crollo della cortina di ferro, rappresentava una sorta di passaggio obbligato
per tutte le imprese italiane che volevano fare affari con l’Est: bisognava
passare di lì e pagare una commessa, una tangen te, un pizzo che poi finiva al
partito. Tutto questo è appurato nelle sentenze, al pari della sussistenza di un
finanziamento illecito che tuttavia «cessò prima della fine del 1989, data in
cui la funzione di illecito strumento di erogazione della ricchezza di Eumit
venne meno; senza contare la citata amnistia che vi fu nello stesso anno. Nella
sentenza di archiviazione dell’estate del 2000, dunque, non si ravvisano i reati
di falso in bilancio e bancarotta, ma per tutto il resto (corruzione,
finanziamento illecito, reati fiscali) intervennero la prescrizione e
l’amnistia.
TANGENTOPOLI E TIFO DA STADIO, 20 ANNI DOPO.
Tangentopoli, dopo 20 anni Milano si divide come allo stadio.
Tangentopoli vent'anni dopo. Milano è più che mai
divisa nel ricordarla. Di Pietro dice di aver fatto il suo «dovere» durante un
mega evento al Teatro Elfo Puccini, ma Tiziana Parenti, all'epoca nel pool, lo
smentisce. «Quando mi affidarono il plico su Greganti era sotto il suo tavolo e
nessuno lo aveva mai aperto». In mezzo pure Stefania Craxi che attacca il
convegno di Di Pietro: «Non dovevano farlo», scrive Alessandro Da Rold su
“L’Inkiesta”. C’è una parte della storia di Tangentopoli che passa quasi
inosservata a vent’anni di distanza dall’arresto di Mario Chiesa al Pio Albergo
Trivulzio. E che contribuisce a creare ombre e veleni sull'evento che ha sepolto
la prima repubblica italiana. È quella dei 43 suicidi tra politici, imprenditori
o dirigenti di azienda che tra 1992 e il 1994 furono raggiunti da un avviso di
garanzia o citati sui quotidiani come presunti «mariuoli». Ma è soprattutto
quella del filone che portava alle tangenti rosse del Partito Comunista, di cui
il pool di Mani Pulite decise di affidare le chiavi a Tiziana Parenti. «Proprio
a me, che avevo la tessera del Pci da tanti anni...», ammette l'ex magistrato
durante una semideserta conferenza stampa a Milano all’Hotel dei Cavalieri,
insieme con l’ex avvocato di Craxi Michele Saponara, Tiziana Maiolo e il
giornalista Paolo Liguori. In questa giornata di celebrazione e festa per
il leader dell’Italia dei Valori Antonio Di Piero al teatro Elfo Puccini insieme
con il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, tutto esaurito, Titti la rossa mette
il dito nella piaga di quegli anni creando una specie di confronto a distanza
con gli ex colleghi del pool. Li smentisce sulle ricostruzioni date in questi
giorni («C’era la copertura politica da parte del Pci»). E ribalta il ricordo
che in questi giorni viene messo nero su bianco su diversi settimanali o
quotidiani. «Il problema di Tangentopoli fu soprattutto la mancanza di
credibilità che avevano i magistrati. Io lo dissi a D’Ambrosio: non ci serve
l’aiuto dei giornali, i magistrati devono svolgere il loro lavoro e basta».
Proprio D’Ambrosio ieri ha rilasciato un’intervista al Messaggero dove ha
sostenuto invece che le accuse di politicizzazione del pool arrivarono «perchè
noi non guardavamo in faccia nessunno». Stesso discorso fatto anche da Di Pietro
che durante le celebrazioni all’Elfo ha detto di aver fatto «il suo dovere».
Discorso che invece stride con quello dei protagonisti dell’Hotel dei
Cavalieri, che hanno puntato il dito proprio sulla strategia «chirurgica dei pm
che cancellarono solo una parte della politica italiana, sperando di portare la
sinistra al governo. Cosa che non successe grazie all’avvento di Berlusconi».
Del resto, la Parenti racconta nel dettaglio di quando arrivò al palazzo di
Giustizia di Milano. «Mi chiamò Minale perchè avevamo lavorato assieme in Corte
d’Assise. Non capii il perchè di questa richiesta in un primo momento, anche
perchè non mi sembrava di avere un curriculum da inquirente. Mi affidarono il
caso di Primo Greganti e delle tangenti rosse. Il plico lo trovai sotto la
scrivania di Di Pietro. Credo che nessuno l’avesse mai letto». Passa il tempo,
la Parenti indaga, ma un certo punto iniziano a incalzarla sulla scarcerazione
del compagno G. «Mi chiesero di togliergli la custodia cautelare. Anzi, mi
dissero pure che sarei stata ricompensata...Allora capii il perchè di quella
chiamata nel pool: avevo un passato comunista e potevo dare una mano alla
causa». Titti la rossa se lo domanda più volte durante la conferenza stampa. «Io
quelle indagini le ho portate avanti. Chiesi anche una rogatoria alla Germania
dell’Est perchè molti soldi arrivavano da lì. Le carte ci sono ancora, ma le
hanno abbandonate». Le inchieste sulla Milano Serravalle che hanno travolto il
Partito Democratico di Milano con l’ex presidente della provincia di Milano
Filippo Penati la scorsa estate non l’hanno smossa più di tanto. «La tangente di
Greganti arrivava da Marcellino Gavio...Sono storie che si conoscono da anni, ma
su cui i quotidiani e una parte della magistratura non hanno mai voluto
approfondire. Poi, nel momento del bisogno saltano fuori». È proprio il
sodalizio tra stampa e magistratura quello che provocato il maggior disgusto
nell’ex pm di Mani Pulite. «Ricordo i corridoi del palazzo Giustizia invasi dai
giornalisti. C’erano bottigliette per terra, cartacce, un caos incredibile, che
a volte noi che ci occupavamo anche di altro facevamo fatica a muoverci.
Sembrava di stare allo stadio. Era qualcosa di tremendo per una persona come me
che voleva solo fare il magistrato e credeva nella magistratura». Secondo la
Maiolo, che ha appena pubblicato un libro per Rubbettino, «giornalisti e pm si
mettevano d’accordo per chi arrestare. Era tutto organizzato». Titti la rossa
non ce l’ha con i quotidiani. «In questi giorni ho visto sull’Espresso una foto
del pool con Ilda Boccassini. All’epoca lei non c’era neppure, se la storia non
viene raccontata com’è, l’Italia non capirà mai dai suoi errori». Milano, del
resto, non è mai stata così divisa come in questi giorni di ricordo dell'arresto
di Mario Chiesa al Pio Albergo Trivulzio. Mentre Di Pietro all'Elfo Puccini
ricordava la «metastasi» della politica italiana mentre allora si parlava di
tumore, Stefania Craxi dall'altro lato della città ricordava invece il discorso
del padre Bettino in parlamento. «Craxi, nel discorso del 3 luglio 1992, chiese
la responsabilità politica a tutti i partiti di dare una morte politica alla
prima Repubblica, di porre un rimedio a quella degenerazione, a quel problema di
moralizzazione della vita pubblica che si era creato seguì un vile silenzio.
Venticinquemila avvisi di garanzia hanno prodotto 4mila processi e qualche
centinaio di condanna». E poi, rispetto all'evento al Puccini dice: «Non doveva
essere fatto».
Vent’anni e sentirli, scrive Filippo
Facci su “Il Post”. Tutto parte e riporta lì, sempre a Mani Pulite, genesi di
una seconda Repubblica mai nata e già vecchia: è il nostro Prima e Dopo Cristo,
è l’incubatrice di un presente politico eternamente incerto tra ieri e domani.
Agli spauracchi genere «non è cambiato niente» si è progressivamente sostituita
una consapevolezza terrificante: è cambiato tutto, nel senso che la politica di
allora oggi appare superiore anche perché diversi erano i curriculum, le
professionalità, le investiture dal basso: roba che oggi ha ceduto il passo alla
nomina di uno bravo ogni venti amici e parenti e servi. Avevi i voti o non li
avevi: non c’erano carfagne e non c’era merito di guerra che potesse bastare.
Nostalgia? Per niente. Nulla giustifica come il finanziamento illegale della
politica, un tempo fisiologico e necessario, fosse degenerato a Milano come nel
resto del Paese. Nella capitale morale ogni appalto doveva sovvenzionare la
politica in quote prestabilite (tot alla Dc, tot al Psi, tot al Pci eccetera,
secondo il consenso acquisito) e le imprese a loro volta potevano prestabilire i
vincitori delle gare in barba al libero mercato, formando così un «cartello» che
escludeva altra concorrenza e falsava i costi. Maggioranze e opposizioni
conducevano un gioco delle parti che dietro le quinte diveniva complicità e
spartizione degli affari: a Milano accadeva che per determinati appalti ci fosse
un cassiere unico che poi ridistribuiva agli altri partiti, Pci compreso. Il
sistema era talmente oliato da rendere praticamente impossibile comprendere chi,
tra imprese e partiti, avesse il coltello dalla parte del manico. Gli
imprenditori si definiranno come ricattati dai politici, i politici come
assediati da imprenditori ansiosi di offrire: in concreto «era un sistema», come
disse Bettino Craxi, o quantomeno una «dazione ambientale», come la descrisse Di
Pietro: ispirato, in realtà, da un altro magistrato che si chiamava Antonio
Lombardi. Era un sistema malato di elefantiasi e degenerato negli effetti
pratici ed economici: più costose e durature erano le opere e più grande era la
torta da spartire, il mercato era sfalsato e così pure la selezione delle
offerte migliori e più convenienti. Tutto questo, naturalmente, in linea di
massima: fioccavano le eccezioni e le isole felici, mentre le degenerazioni e un
senso del limite si tenevano la mano in un Paese che in qualche modo tirava
avanti. Grazie al debito pubblico? I numeri, ormai, hanno smentito anche questo.
Dal 1946 al 1992, la Prima Repubblica ha accumulato un debito pubblico pari a
circa 6-700 miliardi di euro: il restante – ossia i 1300 miliardi di euro che
hanno portato il debito pubblico italiano alle cifre odierne – lo ha fatto la
Seconda Repubblica dei vari governi Berlusconi, Amato, Ciampi, D’Alema e Prodi;
la Prima Repubblica accumulava una media giornaliera di 47,5 milioni di euro di
debito al giorno, la Seconda è arrivata a oltre 200 milioni di euro al giorno,
quasi quintuplicando la cifra. Oscar Giannino, un collega quantomeno rigoroso,
ha raffrontato i governi di centrodestra e centrosinistra sulla base dei
dati della Banca d’Italia: il record di debito
pubblico sono stati i 330 milioni al giorno del primo governo Berlusconi, che
nell’ultimo governo è sceso a 207 milioni. Perfetto, ma perché Mani
pulite nacque proprio allora? Qui in genere si scontrano versioni improbabili e
micro – la favoletta del magistrato onesto che smaschera i corrotti – e altre
non meno improbabili e complottarde e legate a scenari internazionali. Tra
Montenero di Bisaccia e Washington, non manca chi sostenga che l’inchiesta
avrebbe potuto nascere in ogni momento dal Dopoguerra in poi, anche se è vero
che alla fine degli anni Novanta certe disinvolture avevano superato ogni limite
e così pure la tolleranza di una popolazione in progressiva crisi economica. Noi
voliamo basso. È inutile ricostruire e contestualizzare tutti gli scenari che
indubbiamente, più che dare origine all’inchiesta, da un certo punto poi non ne
impedirono la nascita come in passato sarebbe probabilmente accaduto, anzi, come
probabilmente avvenne. Si possono tuttavia menzionare pochi accadimenti chiave
che prepararono il terreno.
Uno, nell’aprile 1990, fu l’amnistia che contemplava vari reati compiuti sino al
24 ottobre 1989, e tra questi il finanziamento illecito ai partiti. La
demarcazione si rivelerà essenziale per giustificare l’impunità di alcune parti
politiche e soprattutto per depenalizzare ogni finanziamento illecito versato al
Pci dall’Unione Sovietica. Dall’ottobre 1989 al marzo 1992 non passarono che una
trentina di mesi: l’intero sconvolgimento del sistema politico italiano è stato
realizzato in quel periodo.
Dirompente, nel tardo 1989, fu poi l’entrata in vigore del nuovo Codice di
procedura penale Vassalli-Pisapia. Esso si proponeva, nelle intenzioni, pari
dignità giuridica tra accusa e difesa, custodia cautelare come extrema ratio ,
segretezza delle indagini, pubblicità del processo e, soprattutto, prova che
doveva formarsi rigorosamente in aula. Il totale stravolgimento delle velleità
del nuovo Codice, con la complicità della classe politica e il palese dolo della
magistratura, sarà una chiave di volta della prima e fondamentale parte di Mani
pulite. Molti magistrati nei primi anni Novanta lanciavano grida d’allarme
contro un nuovo Codice che paventavano come troppo garantista.
Il procuratore generale della Cassazione Vittorio Sgroi, all’inaugurazione
dell’anno giudiziario 1992, definì le nuove norme addirittura «ipergarantiste» e
lo stesso facevano i cronisti. Il professor Giandomenico Pisapia, presidente
della commissione per la riforma del codice di procedura penale, intervistato
dallo scrivente nel 1992, la mise così: «È il processo che è pubblico, non le
indagini. Il nuovo Codice vieta la divulgazione di atti che sono in gran parte
segreti: il segreto delle indagini c’è e serve a tutelare sia le indagini sia
l’indagato che naturalmente teme che la divulgazione di notizie anticipate possa
pregiudicare la sua immagine, immagine che una volta guastata non può essere
ripristinata nemmeno in caso di assoluzione». L’allora vicepresidente del Csm
Giovanni Galloni, sempre nel 1992, aggiunse: «La stampa deve intervenire solo a
conclusione delle indagini, e l’avviso di garanzia deve essere protetto da
segreto istruttorio ». Sembra fantascienza.
- Il referendum sulla preferenza unica proposto da Mario Segni simboleggiò poi
come anche Bettino Craxi, che invitò bonariamente gli elettori a disertare le
urne, non avesse polso di quanto andava montando. Alle urne si recò il 65 per
cento degli italiani e il referendum passò con il 95,6 per cento di sì. Il voto
celava null’altro che una forte insofferenza contro i partiti.
- Altre date rilevanti, a Mani pulite iniziata, saranno il 5 ottobre 1992 e il
successivo 29 ottobre, quando la lira cioè scese al minimo storico e fu
ratificato anche in Italia il Trattato di Maastricht sull’unione monetaria.
Qualsiasi peculiarità italiana, di lì in poi, avrebbe dovuto allinearsi a
parametri ormai imprescindibili: anche da questo, il 10 luglio 1992, nascerà una
manovra finanziaria da 30.000 miliardi di lire con cui il governo di Giuliano
Amato tenterà un primo risanamento del disavanzo pubblico. Nello stesso periodo
verrà avviata la privatizzazione di Iri, Eni, Enel e Ina: una strada obbligata e
però gravida di conseguenze sociali e occupazionali che contribuiranno a
riscaldare il clima. L’Italia, all’inizio del 1992, era un castello di carte che
aspettava solo un refolo di vento. Crisi varie, inflazione, la Fiat che
annunciava prepensionamenti, carabinieri ammazzati dalla camorra, urla contro i
politici durante i funerali, l’antipolitica che strepitava dai televisori: senza
contare che il capo dello Stato, Francesco Cossiga, il 2 febbraio avrebbe
sciolto le Camere. E Milano, da sempre laboratorio anticipatore di ogni brezza o
tempesta destinata a spirare nel paese, era una polveriera rimasta incustodita.
E Di Pietro? Di Pietro era un magistrato di non buonissima fama. Non aveva
rapporti neanche coi giornalisti, o non erano buoni: lo sfotticchiavano per la
pronuncia o addirittura fingevano un refuso e scrivevano «Antonio Di Dietro». I
giovani cronisti lo chiamavano «il troglodita». Che avesse in mente tutto
fuorché Mani pulite l’ha raccontato in più occasioni Elio Veltri, che l’incontrò
nei primi giorni di febbraio: il magistrato gli disse che presto avrebbe
abbandonato i reati contro la pubblica amministrazione e si sarebbe dedicato
alle estorsioni; aveva archiviato il caso di un’intera famiglia di Parma
scomparsa nel nulla e «Chi l’ha visto?» ci aveva montato una puntata intera. A
lui era piaciuto, la tv lo faceva già impazzire. Ammetterà anche Francesco
Saverio Borrelli: «Non immaginavo che dall’arresto di Chiesa potesse nascere
quello che è nato, ma credo che non l’immaginasse nessuno. Non l’immaginava
certamente Di Pietro».
È vero, Mani Pulite nacque per caso, ma il caso non esiste. E comunque non se ne
accorse nessuno, dapprima: quasi tutto andava bene a quasi tutti. All’ascesa
socialista si era via via accompagnato un discutibile sottopotere socialista:
Milano era da bere, ma lo slogan era soprattutto di chi non poteva sedere a
tavola. Il Titanic romano già affondava lentissimo mente Milano era una
Bismarck. Tutto era diverso e inimmaginabile. La cerimonia d’insediamento di
Giulio Catelani, venturo procuratore generale dai toni «rivoluzionari», fu
benedetta dalla presenza di Giulio Andreotti. Persino la nomina di Francesco
Saverio Borrelli a capo della procura ebbe il placet della Dc e del Psi. E non
era crollato il mondo, nel maggio 1990, quando la richiesta di autorizzazione a
procedere nei confronti del senatore socialista Antonio Natali – tesoriere
maximo – era stata respinta. La Metropolitana Milanese era a tutti gli effetti
una società per azioni privata, si disse, dunque poteva finanziare i partiti.
Tutti. Eppure, neanche due anni dopo, il ragionamento sarà rovesciato e si andrà
di ramazza. Allora invece nessuno fiatò, neanche le opposizioni. Non si
procedette neppure per violazione del finanziamento illecito. La verità è che la
nave andava, e Antonio Di Pietro era a bordo.
Molti hanno scritto che già in quel periodo il magistrato indagasse per Mani
pulite, anzi, che indagava praticamente da sempre, come un infiltrato che
conducesse una sorta di indagini preliminari lunghe quarantadue anni. Così, a
cena da qualche personaggio imbarazzante, mica cenava: raccoglieva materiale
probatorio. Con altri fingeva amicizia: poi sbirciava nel loro portafoglio –
questo scrivono – e annotava il nome delle banche in cui avevano i conti. Tutto
molto improbabile, anzi. Di Pietro continuava a essere quel personaggio
straordinariamente ambiguo che è ed è sempre stato, da amico di tutti e di
nessuno. A Palazzo di Giustizia non aveva una fama meravigliosa: certi suoi
trascorsi l’avevano accompagnato sin lì. «Tu gli giri sempre intorno, ai
politici, ma non li prendi mai» gli diceva per esempio Elio Veltri, che lo
conobbe in quel periodo e che scrisse: «Confesso che qualche volta ho dei dubbi,
perché nelle inchieste non arriva mai ai politici. I loro furti sono così
evidenti e la loro certezza di impunità così sfacciata, che si fatica a pensare
che non si possa incastrarli».
Le perplessità, condivise da molti cronisti giudiziari, erano legate perlopiù
alla rumorosissima inchiesta sull’Atm (Azienda Trasporti milanesi) di cui
presidente era il democristiano Maurizio Prada e vicepresidente il socialista
Sergio Radaelli: si era profilato dunque il rischio che Di Pietro incontrasse di
giorno gli amici che già frequentava la sera. Prada e Radaelli, infatti,
facevano parte di un giro di frequentazioni ad ampio raggio (il sindaco, l’ex
questore, il capo dei vigili, industrialotti vari) che il magistrato aveva anche
invitato a casa sua. Tra gli amici non mancavano industriali come Giancarlo
Gorrini o il costruttore Antonio D’Adamo: che fecero, insieme, più di duecento
milioni di «prestito» beneficiato da Di Pietro. Lo spaventoso elenco di favori
che il magistrato ebbe dallo stesso potere che poi avrebbe abbattuto (prestiti,
affitti a equo canone, domicili, auto per sè e per la moglie, incarichi e
consulenze per moglie e amici, impieghi per il figlio, vestiario, telefoni, la
celebre Mercedes scontata) non rappresentano solo comportamenti «di indubbia
rilevanza disciplinare», come avrebbe sancito la magistratura: rappresentò,
allora, la ragione principale per cui, tra i ben informati, a Milano nessuno
pensava che Di Pietro avrebbe fatto il botto. Anche al famoso Mario Chiesa, cioè
alla miccia iniziale, Di Pietro arrivò quasi distrattamente. Nel giugno 1990 «Il
Giorno» aveva pubblicato un articolo nel quale un impresario funebre raccontava
che per lavorare al Pio Albergo Trivulzio bisognava pagare: la querela di Mario
Chiesa era stata affidata a Di Pietro, che aveva archiviato, sì, ma aveva anche
preso nota e in parallelo aveva aperto un fascicolo e disposto intercettazioni.
Ma l’arresto di Chiesa fu comunque un caso. Luca Magni, un imprenditore del ramo
pulizie, non si rivolse a Di Pietro perché strozzato dalle tangenti e dal
bisogno: lo fece perché vessato dall’arroganza di Chiesa. Il lavoro non gli
mancava, ma per gli appalti della Baggina, «Chiesa cominciò a chiamarmi
insistentemente. Mia sorella non stava bene, era stata ricoverata, per cui non
avevo tempo da dedicargli. La risposta fu che la salute di mia sorella era affar
mio, non dell’ingegner Chiesa». Magni – che ha raccontato queste cose, vent’anni
dopo, nel libro «Alla fine della fiera» di Federico Ferrero – allora si rivolse
a un’associazione di commercianti che gli diede un numero dei Carabinieri. Il
capitano raccolse la denuncia e la presentò al magistrato di turno: che era Di
Pietro, ma poteva anche essere un altro.
Chiesa aveva chiesto a Magni di versare il 10 per cento su un appalto. Allora
l’impresario andò nell’ufficio dell’ingegnere con settanta banconote segnate da
centomila: flagranza di reato, concussione, galera. Le modalità di
quell’arresto, riviste oggi, fanno comprendere quanto fosse diverso come
l’atteggiamento della magistratura a proposito della custodia cautelare: in Mani
pulite una sola chiamata in correità basterà per incarcerare chicchessia, ma,
prima di essa, Di Pietro non si fece bastare la confessione di Luca Magni e
neppure le intercettazioni telefoniche: predispose banconote segnate, un
microfono e persino una telecamera che peraltro non funzionò.
L’arresto di Chiesa destò scalpore, certo, ma il neonato Tg5, per capirci, non
pronunciò la parola «socialista» neanche una volta. Sembrava tutto sotto
controllo: l’avvocato di Chiesa, Nerio Diodà, chiese subito il patteggiamento.
«Faremo la direttissima» annunciò Borrelli, inconsapevole di quanto aveva tra le
mani. O, forse, sin troppo consapevole. Dirà Di Pietro: «Io dimenticai di
depositare gli atti nei tempi prescritti per la direttissima… Borrelli aveva
dato indicazione di depositarli… erano in vista le elezioni del ’92, la tensione
montava, il fatto risultava chiaro, era opportuno rinviare Chiesa a giudizio per
direttissima e chiudere così il caso e le crescenti polemiche. A quel punto, io
non ho la forza di dire al dottor Borrelli che non lo faccio perché voglio
arrivare a un obiettivo preciso; e allora “mi sbaglio”».
Così la faccenda s’insinuò nella campagna elettorale per le elezioni politiche.
E Craxi, il 3 marzo, disse: «Mi ritrovo un mariuolo che getta un’ombra sul
Partito». Mariuolo che intanto marciva in galera mentre vari imprenditori
pellegrinati in Procura – per paura o perché tirati in ballo da un collega
«infiltrato», Fabrizio Garambelli – cominciarono a parlare e straparlare pur di
scampare la galera. Chiesa decise di parlare il 23 marzo: era politicamente
finito, non aveva più un lavoro né una moglie, suo figlio non gli scriveva da un
mese e la sua nuova compagna era incinta da sette. Parlò per questo. Ammise i
versamenti ai vari big del Garofano e non solo a loro. Il 30 marzo i cronisti si
appostarono con l’orecchio vicino alla stanza di Di Pietro, la 254, e annotarono
un urlo di Chiesa: «M’avete rotto i coglioni con quel nome». Il nome di Bobo
Craxi. Suo padre era candidato alla presidenza del Consiglio e vantava ancora un
alto gradimento.
Il 2 aprile concessero gli arresti domiciliari a Chiesa. Si delineava uno
scenario probatorio da paura, e il gip Italo Ghitti disse chiaro e tondo: «Il
nostro obiettivo è colpire un sistema, non le singole persone». Cominciò una
nuova fase giurisprudenziale. Ogni reato ipotizzato, di lì in poi, sarebbe stato
inquadrato nell’affiliazione a un sistema, e dimostrare che l’indagato ne avesse
fatto parte sarebbe bastato a giustificare il protrarsi delle carcerazioni. Chi
parlava e denunciava altri, invece, poteva essere liberato perché ritenuto ormai
inaffidabile agli occhi del sistema: come i pentiti con la mafia. Ogni proposta
di sistematizzare la confessione sarebbe stata avallata dal Pool. E ogni
tentativo di limitare le carcerazioni sarebbe stato chiamato colpo di spugna.
L’antipolitica montò soprattutto in tv. Su Raitre c’era Gad Lerner col suo
«Profondo Nord», poi diventato «Milano, Italia». Su Italia Uno c’era Gianfranco
Funari col suo «Mezzogiorno italiano». Michele Santoro, col suo «Samarcanda»,
aveva fatto grandissimi ascolti con una puntata dedicata alla crisi dei partiti;
poi, dopo che il 12 marzo a Mondello avevano ucciso il democristiano Salvo Lima,
si era rivolto direttamente alla piazza televsiva: «Siete contenti che l’hanno
ammazzato?». Scoppiò un putiferio. Gli fui intimato di rinunciare alla piazza
nelle settimane pre-elettorali, ma rifiutò, sicché gli chiusero la trasmissione
per quindici giorni. Da immaginarsi che cosa ne venne fuori.
In ogni caso il voto del 5 aprile 1992 segnò il crollo storico della Dc e
perdite minime per il Psi, ma il pentapartito ne uscì comunque malconcio. La
Lega superò i tre milioni di voti (9 per cento) e cantarono vittoria anche neo
movimenti come la Rete. La stampa aprì un fuoco di fila contro la maggioranza e
ci fu anche una telerissa in diretta fra il direttore del Tg1 Bruno Vespa e il
segretario repubblicano Giorgio La Malfa: «Lei, Vespa, è stato sconfitto come
l’onorevole Forlani, e se ne deve andare!», «E lei ha lottizzato la Rai come
hanno fatto gli altri partiti, se non peggio».
Cominciava un burrascoso interregno giudiziario. Ebbe inizio un periodo
incredibile: chiamate in correità a mezzo stampa, il Tg3 come se l’Armata rossa
fosse alle porte di Trieste, telefonate concitate, avvocati coi clienti in lista
d’attesa. La Prima Repubblica era finita, ma neppure questo avevano ancora
capito.
Una sola notte di prigione, il 21 aprile 1992, trasformò otto imprenditori in
terribili accusatori: ammisero centocinquanta miliardi pagati a vari politici e
cominciò la delazione ambientale. Ammetterà Di Pietro: «Per l’imprenditore la
convenienza è soprattutto imprenditoriale. Qual è il suo primo problema quando
viene coinvolto? I giornali, la televisione, l’arresto, la confessione, tutto
questo produrrà effetti a catena disastrosi per la mia impresa. Le banche mi
ritireranno i fidi, i committenti non mi daranno più gli appalti, i lavoratori
mi contesteranno, sarò costretto a chiudere».
Il 23 aprile ecco un altro caposaldo: il fascicolo virtuale. Tutti i fatti di
Tangentopoli sarebbero stati compresi in un solo procedimento con un solo gip,
il finto mite Italo Ghitti. Al resto provvedevano altre tecniche. «L’avviso di
garanzia è stato un bel passo indietro, perché noi pm abbiamo potuto agire
indisturbati e in silenzio più di prima… La legge dice che il pm dovrebbe
cercare anche gli elementi favorevoli all’indagato. Ma figuriamoci!». Dopo
l’iscrizione di Tizio nel registro degli indagati, secondo il Nuovo Codice,
un’inchiesta non doveva durare più di sei mesi: il Pool aggirare la normativa
col modello 44, cui si ricorreva quando l’indagato era ignoto: i sei mesi non
decorrevano. È il registro in cui inserirono Bettino Craxi. Altro stratagemma:
archiviare direttamente a modello 45 (cui si ricorre quando si ritiene che non
esista notizia di reato, come nel caso di denunce di pazzi con manie di
persecuzione) oppure, sempre per indagare a tempo scaduto, comunicare al
Procuratore generale l’intenzione di rinviare a giudizio.
Il 27 aprile con Di Pietro apparve un nuovo pm: Gherardo Colombo, uno gentile,
jeans stinti, Lacoste, scarpe da vela consumate, il vizio delle sigarette e
delle dita nel naso. Di Pietro aveva richiesto che gli fosse associato
Piercamillo Davigo, ma Borrelli all’inizio preferì Colombo anche per controllare
meglio Di Pietro, che aveva la fama che aveva. Davigo sarebbe arrivato poi.
La stampa invece era già arrivata, anzi, la ressa si era fatta insopportabile e
certi entusiasmi cominciarono a creare problemi. Il 27 aprile 1992 i carabinieri
non poterono arrestare il socialista Matteo Carriera perché sotto casa sua c’era
il Gabibbo. Quei parvenu della Fininvest esordivano coi loro telegiornali e
dapprima vennero sospettati di intelligenza col nemico, ma gli steccati caddero
subito, anzi, il problema divenne che di notizie ne davano sin troppe e
rischiavano di bruciare tutti gli altri. Ogni tanto Paolo Brosio del Tg4
diffondeva il panico nei servizi della notte («Il gip ha appena firmato
ventinove ordini di cattura») e ogni volta i cronisti della carta stampata
venivano richiamati per verificare e ribattere. Una volta, in diretta, Brosio
disse che avevano arrestato l’industriale Carlo Gavazzi – in realtà morto – e
non suo figlio Riccardo. Un’altra volta intervistò l’ex sindaco Carlo Tognoli e
lo chiamò per cinque volte Pillitteri.
L’informazione si strinse nel collo di bottiglia di pochi cronisti, quei quattro
o cinque che avevano consolidato rapporti personali coi magistrati, ma poi si
allargò a tutti gli altri. Nacque, per un delimitato ma decisivo periodo, una
specie di Pool dei giornalisti: una redazione giudiziaria unificata con
distribuzione equanime delle notizie e dei celebri verbali, spesso tradotti dal
burocratese e semplificati in linguaggio corrente. Due gli obbiettivi: gestire
la mole impressionante delle notizie e in secondo luogo proteggersi da eventuali
censure distribuendo le notizie a tutti gli altri. Di fatto le informazioni si
strinsero nel collo di bottiglia di pochi cronisti, e l’informazione si fece
uniformata da giornale a giornale. L’entusiasmo e la giovane età, in qualche
caso, giustificarono episodi al limite del fanatismo: per esempio la produzione
della maglietta «anch’io seguo Mani pulite», o ancora il primo avviso di
garanzia a Craxi appeso in sala stampa (dopo aver brindato a champagne, come
accadde anche per l’arresto di Salvatore Ligresti) e più in generale una
dedizione che portò alcuni ragazzi a sentirsi parte dell’inchiesta anziché
strumento della medesima: «C’è un gruppo di cronisti che si comporta in maniera
alterata, abbandonando il privato» disse il decano dell’Ansa. Le notizie
uscivano da più direzioni, non soltanto dai magistrati: ma difficilmente
uscivano se loro non volevano. Dirà Italo Ghitti, il gip storico di Mani pulite:
«Ci fu un momento in cui ebbi la certezza che determinate notizie uscivano dagli
uffici dei pm». Ci furono casi in cui le notizie furono depositate nelle edicole
prima che nelle mani degli avvocati, o altri casi, particolari, come raccontato
dal cassiere democristiano Severino Citaristi: «Consegnai gli elenchi anche a Di
Pietro. Conoscendo le poco corrette abitudini di Milano, gli raccomandai di fare
in modo che l’elenco non fosse reso pubblico. Me lo assicurò. Infatti, due
giorni dopo, quotidiani e settimanali pubblicarono integralmente i tre elenchi.
Scrisse l’allora cronista del manifesto: «I giornalisti hanno avuto i loro
padrone: la magistratura. Molti giornali si sono messi sull’attenti, si sono
scordati pezzi del Codice penale, pezzi importanti delle garanzie che la legge
prevede per gli imputati. E’ stato rispettato più il Codice Di Pietro che non il
nuovo Codice penale. C’è stata una specie di identificazione totale con
l’ufficio del pm, tanto che alcuni periodici (L’Espresso e Panorama, nda) sono
diventati i portavoce della Procura e i depositari dei verbali d’interrogatorio.
I giornali si sono così abituati a singolari trattative sulla carcerazione
preventiva o sulla consegna degli imputati, come se fosse una cosa normale».
Il ruolo della stampa era fisiologico all’inchiesta: questa la vera novità.
Travestita da libera circolazione delle notizie, la pubblicazione di certi
verbali piuttosto che altri si traduceva in un irresistibile effetto richiamo
per decine di indagati che si ritrovavano nero su bianco sui giornali. Senza
contare che un solo avviso di garanzia, o mezza notizia ben filtrata, erano in
grado di squadernare ogni trattativa politica.
Di Pietro, tra i cronisti, era oggettivamente adorato. L’uomo che anni prima
avevano chiamato «Di Dietro», nel loro gergo, divenne «Zanzone», «Dio»,
«Diozanza», «Padrepio», «l’Onnipotente» e da un certo punto in poi «la Madonna».
Un esempio dei rapporti che Di Pietro intratteneva coi giornalisti è ricavabile
da un interrogatorio di Giancarlo Gorrini reso nel 1997 a Brescia: «Io e Di
Pietro ci trovammo a uscire dal suo ufficio. Nel suo corridoio vi erano numerosi
giornalisti e operatori delle varie tv che immediatamente accesero i faretti. Di
Pietro, alzando e muovendo le braccia, disse di stare fermi in quanto la persona
che era con lui non era un indagato bensì un suo amico». Gorrini in realtà era
già inquisito per bancarotta fraudolenta e condannato per appropriazione
indebita: ma a Di Pietro, coi giornalisti, bastava alzare un braccio.
La manovalanza dei cronisti doveva interfacciarsi coi desk delle rispettive
redazioni, e circolavano leggende secondo le quali i direttori dei principali
quotidiani si telefonavano per concordare spazi e titoli comuni. Piero
Sansonetti, condirettore de l’Unità nel 1992-1993, ha raccontato che c’era del
vero: «Nel biennio 1992-1993 la società politica era allo sbando e nacque
un’alleanza di ferro tra quattro giornali: il Corriere, la Stampa, l’Unità e
Repubblica. Il direttore de l’Unità era Veltroni, alla Stampa c’era Mauro, il
caporedattore di Repubblica era Antonio Polito. Tra i quattro giornali si
stabilì un vero e proprio patto di consultazione che li rendeva fortissimi: ci
si sentiva due o tre volte al giorno, si concordavano le campagne, le notizie, i
titoli. Il punto di riferimento di tutti era Paolo Mieli». Antonio Polito
confermerà: «I partiti pesavano pochissimo, il governo era altrettanto debole,
perse in pochi mesi una decina di ministri che si dimettevano subito, appena
ricevuto l’avviso di garanzia, anche per via delle nostre campagne di stampa.
Abbiamo interpretato e indirizzato l’opinione pubblica».
L’unico giornale non propriamente sdraiato sulle procure era Il Giorno diretto
da Paolo Liguori, dove scrivevano firme come Andrea Marcenaro, Carla Mosca e
Napoleone Colajanni. Suo antagonista naturale era L’Indipendente, dove ai
brindisi all’avviso di garanzia si accompagnavano talvolta veri e propri
ammiccamenti alla violenza di piazza.
Ma c’era una seconda ragione per cui i cronisti chiamarono Di Pietro «la
Madonna»: fu per via delle decine di avvocati che presero a pellegrinare in
Procura in omaggio al citato effetto richiamo dei giornali. Partì da qui,
sommessamente, una polemica volta a indicare anche una sostanziale abdicazione
del ruolo dell’avvocato alla base del crescente successo di Mani pulite. Per
tutta l’inchiesta, infatti, ruolo essenziale fu quello dei cosiddetti «avvocati
accompagnatori», legali che spesso si limitavano ad assistere i loro clienti nel
percorso che li portava fino alla stanza di Antonio Di Pietro: poi null’altro
che un’ossequente confessione. Un cronista del Mattino, a proposito
dell’appoggio dato ai clienti nel parlare e liberarsi, li ribattezzò «addetti al
vomito». Scrisse invece un cronista del Manifesto: «Gli avvocati raramente
rappresentano un contraddittorio coi magistrati, una fonte d’informazione
alternativa… Il processo in pratica si celebra prima di andare in aula… Il ruolo
dei legali il più delle volte si limita ad assistere inerti agli interrogatori o
alle trattative per evitare ai loro clienti la galera».
In pratica i cosiddetti i principi del foro, con poche eccezioni, durante Mani
pulite non batterono chiodo. Non era sfuggito che avvocati poco noti, ma graditi
ad Antonio Di Pietro, erano i difensori di tutti i principali accusatori di
Tangentopoli: cambiare avvocato si traduceva in un cambio di atteggiamento e in
una potenziale svolta processuale, ergo si usciva dal carcere o neppure ci si
entrava. Il semi-sconosciuto Giuseppe Lucibello, compagno di bisboccia di
Tonino, assunse difese clamorose come quella del banchiere Pierfrancesco Pacini
Battaglia. Anche il democristiano Roberto Mongini, che di legali ne cambiò
addirittura tre, cambiò e cominciò a parlare. Uno come Salvatore Ligresti rimase
in carcere per cinque mesi sinché cambiò avvocati e fu subito liberato previo
cambio di atteggiamento. Autentica guerra di nervi fu poi quella combattuta da
Michele Saponara, presidente dell’Ordine degli Avvocati: il socialista Loris
Zaffra, da lui difeso, rimase a San Vittore per sei mesi sinché non dette
incarico a un altro e fu l’apriti sesamo. Eppure, fiutata l’aria, Zaffra era
giunto a far verbalizzare: «Non intendo avvalermi di un altro avvocato ». «La
Procura», accusò Saponara, «fece sapere alla famiglia di Zaffra che se voleva
tornare libero doveva cambiare avvocato». A tal proposito, ascoltato dagli
ispettori ministeriali nel 1995, Saponara produrrà una testimonianza secondo il
quale un pm del Pool aveva urlato a Zaffra: «Se non cambia legale, si dimentichi
di uscire». Ma le accuse non trovarono conferma. Col tempo, e col progredire
dell’inchiesta, architrave di Mani pulite diverrà invece lo studio del professor
Federico Stella, eminenza grigia, difensore dell’Eni e futuro ghostwriter di
Antonio Di Pietro. Il professor Stella difese l’imprenditore Fabrizio
Garampelli, che con le sue confessioni spedì in galera praticamente chiunque
tranne se stesso; difese uno sterminato numero di dirigenti dell’Eni «buono» ed
elaborerà ben due proposte di legge per uscire da Tangentopoli, entrambe
appoggiate dal Pool: una a ottobre 1992, elaborata in seno all’Assolombarda, di
cui pure era difensore, e un’altra praticamente identica nel settembre 1994,
presentata in pompa magna alla Statale di Milano. A dispetto di queste
semplificazioni, comunque, in Mani pulite trovarono spazio anche avvocati con
posizioni più varie e sfumate. Quando L’Espresso nella primavera 1993 pubblicò
una specie di hit parade degli avvocati di Tangentopoli (titolata «Primo Bovio,
ultimo Chiusano») il presunto vincitore, Corso Bovio, scrisse così al
settimanale: «La qualità di un avvocato non si misura dalla durata della
carcerazione… Credo che la sua funzione sia quella di far rispettare la
dialettica del processo. Mi autoassolvo, ma non sento di assolvere il mio ruolo…
Perry Mason non è famoso perché pilota le confessioni o patteggia le pene. Oggi
sono vincenti l’inquisizione, il pentitismo, lo Stato di Polizia con le sue
manette e le sue galere».
Intanto il pool proseguiva con una tripartizione precisa: Di Pietro interrogava,
Colombo spulciava le carte e Davigo vergava le richieste di autorizzazione a
procedere. Italo Ghitti invece autorizava gli arresti «privilegiando la rapidità
al cesello», come dirà Colombo. Dirà invece Di Pietro, appena più grezzo: «Io
andavo dai colleghi e segnalavo un’operazione che mi puzzava. “Vedi che cosa è
successo qui?” Questo secondo me è un reato di porcata… Cari Davigo e Colombo,
cavoli vostri, entro domattina trovate una soluzione che dal punto di vista
giuridico non faccia una piega perché non voglio rischiare una sconfitta dal
tribunale della Libertà”». Traduzione: io lo metto dentro, il come e il perché
trovatelo voi. Ha raccontato Primo Greganti, storico inquisito comunista:
«Avevano emesso un mandato d’arresto illegittimo. Ma, dopo aver ammesso
l’errore, Di Pietro mi disse: “Adesso vado da Davigo, e vedrai che lui un motivo
per tenerti dentro lo trova”. Fatto sta che tornai in cella per altri ventisei
giorni». A Di Pietro era permesso tutto, anche perché si avviava a divenire un
eroe nazionale: partecipò alla festa della Polizia e l’applaudirono per due
minuti. Il suo status era cambiato in un niente: gli avevano riverniciato la
stanza, aveva quattro scrivanie, tre computer e due poltroncine girevoli in
similpelle. Gli giungevano migliaia di lettere da tutt’Italia, soprattutto
immaginette sacre e santini di Padre Pio, e la sera le portava a casa per
leggerle al figlio. Il Corriere della Sera, nella sola settimana dal 7 al 15
maggio, sfoderò questi titoli: «Il pm contadino, quasi un eroe», «La domenica
tranquilla dell’eroe», «Il fascino discreto dell’uomo onesto». Il dipietrismo
nacque ufficialmente in maggio. La prima scritta era stata individuata nel
parcheggio dello stadio di San Siro: «Di Pietro, sei meglio di Pelè». Poi un
«Grazie Di Pietro» in via Manin e poi lo striscione «Di Pietro sindaco» ancora a
San Siro. E così via. «La rabbia degli onesti corre sui muri» titolò l’Unità del
10 maggio. A metà del mese ecco la prima fiaccolata pro Di Pietro con cabaret
finale a cura di Lella Costa, David Riondino, Paolo Rossi più una giovanissima
Sabina Guzzanti. Il 30 maggio, su Italia Uno, Gianfranco Funari nel suo
programma «Mezzogiorno italiano» fece partire uno spot quotidiano con immagine
di Di Pietro che camminava e una voce di sottofondo che lo incitava: «Vai
avanti… vai avanti…».
Anche la strage di Capaci registrò il tentativo di sfruttare la morte di Falcone
per portare acqua a Mani pulite. Il magistrato morì un sabato, e lunedì 25
maggio «la Repubblica» uscì in edizione straordinaria col titolo «L’ultima
telefonata con Di Pietro». La morte del magistrato siciliano ebbe il potere di
accelerare l’elezione del presidente della Repubblica dopo un interminabile
gioco di fumate nere, veti e contro-veti. Il 25 maggio elessero Oscar Luigi
Scalfaro, sponsorizzato da Marco Pannella e Bettino Craxi, che non se ne
pentiranno mai abbastanza. Dopo le tormentate elezioni di Giorgio Napolitano e
Giovanni Spadolini alla Camera e al Senato, anche la corsa per palazzo Chigi
s’avviava a conclusione: «Craxi», sussurravano tutti. Ma la sera del 3 giugno la
notizia era un’altra: «C’è anche il nome di Craxi nell’inchiesta sulle tangenti»
disse il Tg1. Di Pietro precisò: «Allo stato il mio ufficio non ha rilevato
nulla di penalmente rilevante che possa riguardare la famiglia Craxi». Allo
stato, Craxi non sarebbe stato presidente del Consiglio, punto. La sua parabola
si fece discendente anche se il 3 luglio pronunciò un discorso alla Camera
destinato a passare alla Storia, parole che per buona parte riverserà in un
altro discorso che pronuncerà il successivo 29 aprile 1993, giorno precedente
all’assedio dell’Hotel Raphael. Craxi chiese al Parlamento di assumersi le
proprie responsabilità per trovare una soluzione politica alla crisi della Prima
Repubblica. Lo fece quando mancavano quasi sei mesi a un suo coinvolgimento
effettivo in Mani pulite, e quando l’eventualità che potesse essere inquisito
pareva semplicemente impensabile. Racconterà il segretario amministrativo della
Dc Severino Citaristi: «Dissi a Forlani che era il momento di prendere
posizione, ma invano». Secondo Giovanni Pellegrino, Pds, allora presidente della
giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato, «Quando Craxi fece quel
discorso c’era ancora qualche margine per fare almeno delle riforme che
consentissero di uscire dal pantano, ma non se ne fece niente perché Occhetto
aveva altri programmi: pensava che il Pds sarebbe uscito indenne e che gli altri
partiti sarebbero stati cancellati dalla geografia politica».
Agosto fu il mese dei tre corsivi sull’«Avanti!» vergati da Bettino Craxi. Il
segretario socialista il 23 la mise giù dura: «Col tempo potrebbe persino
risultare che il dottor Di Pietro è tutt’altro che l’eroe di cui si sente
parlare, e che non è proprio oro tutto quello che riluce». Senza farla tanto
lunga: il poker di Craxi non era un bluff, tutte le carte – Mercedes svendute,
frequentazioni, prestiti eccetera – verranno calate negli anni successivi e
saranno decisive per le dimissioni di Di Pietro dalla magistratura. Ma allora
non c’era neanche il tavolo per giocare. Di fatto, per qualche tempo, fioccarono
le scarcerazioni: «Come mai», notò anche il Corriere della Sera, «Di Pietro
rinuncia alla sua proverbiale risolutezza? Perché una linea tanto morbida?» Se
lo chiese anche Gherardo Colombo: «È successo che tornando dalle ferie estive
dissentisse su iniziative di Piercamillo e mie in tema di custodia cautelare…
Ciò si verificava contestualmente al fatto che la stampa avesse avuto da ridire
su alcuni aspetti dell’indagine». Ma forse, a contribuire a una certa cautela,
il 3 settembre era stato anche il terribile suicidio del deputato socialista
Sergio Moroni. La sua toccante lettera spedita al Presidente della Camera, letta
al Tg2 e pubblicata da tutti i giornali, denunciava un clima da caccia alle
streghe e risvegliò qualche orgoglio parlamentare. Ma erano colpi di coda. Il 19
settembre il cassiere socialista Vincenzo Balzamo passò da Palazzo di Giustizia
e fu preso d’assalto dai cronisti: e nessuno di loro ricorda quel giorno con
particolare orgoglio. Ma la sindrome era tale che L’Avanti!, poco tempo dopo,
titolò «Querci: ho dato 400 milioni a Balzamo» quando nessun altro giornale fece
altrettanto, anche perché Balzamo intanto era sul letto di morte. Il 2 novembre
fu stroncato da un infarto e l’Indipendente titolò in prima pagina «Balzamo,
infarto da mazzetta». Quello stesso giorno altri giornali titolavano invece «Di
Pietro in autostrada soccorre una ferita» e resta il fatto che tutte le accuse
contro il segretario amministrativo del Psi, di lì poi, sarebbero state deviate
su Craxi.
La verità è che il Pool di Milano era assortito fantasticamente e fu
insuperabile nel fare ciò che volle fare. Di Pietro. Davigo. Colombo. Borrelli.
Poi Ielo e Greco. Un po’ meno D’Ambrosio, che in realtà non faceva un tubo se
non dichiarazioni disastrose. Resta che per abbattere una Repubblica – che non
è, in genere, un compito del potere togato – il Pool e tutta la magistratura
stravolsero o sovra-interpretarono il Codice di procedura penale varato nel
1989: lo neutralizzarono e poi ridestarono come un frankenstein
inquisitorio/accusatorio. A un Di Pietro usato come ariete (le manette come
regola) si affiancò infatti una contro-legislazione operata dall’alto: alcune
sentenze della Corte costituzionale (su tutte la 255/92) e una legge suicida (il
Decreto Scotti-Martelli) ristabilirono lo strapotere delle indagini preliminari;
ai pm era sufficiente estrarre verbali d’interrogatorio e riversarli in processi
che non contavano più nulla, ridotti a vidimazioni notarili delle carte in mano
all’accusa. La loro totale discrezionalità dipendeva perlopiù dalla loro buona o
cattiva disposizione, dalle trattative ossia che l’indagato fosse disposto ad
accettare pur di uscire dal procedimento o dalla galera preventiva: colpevole o
innocente che si ritenesse.
Le condanne di Mani pulite (si parla di Milano) nacquero in maggioranza da
patteggiamenti e riti abbreviati: 847 su 1254, esiti che erano stati ottenuti
quando il carcere preventivo era la regola e quando nelle indagini tutto si
esauriva, complice la stampa e le sue storture. Tutti quei nuovi riti erano
divenuti le scorciatoie pagate a caro prezzo da chi aveva voluto uscire dal
tritacarne giudiziario, dal Rito ambrosiano: ma tutto erano fuorché normalità,
soprattutto per chi non era disposto a starci. Forse non è un caso che tra i
1320 indagati che il Pool spedì ad altre procure competenti il numero dei
proscioglimenti fu altissimo. Tutta gente non colpevole ma che non figura, però,
nella casistica ufficiale di Mani Pulite, come se Milano avesse teso a
sbarazzarsi delle posizioni scomode e indisponibili alla confessione
liberatoria. Si dovrà aspettare anni perché una riforma elementare ristabilisca
un principio chiave che Mani pulite aveva fatto a pezzi: l’articolo 513, quello
in base al quale solo nel processo una testimonianza può diventare una prova,
non nel parlatorio di un carcere o in una caserma di polizia. Esattamente come
accade nei film americani, dove tutto ciò che non avviene durante il processo,
semplicemente, non esiste.
In una sentenza bresciana che trattava delle omissioni di Mani pulite – sentenza
favorevole a Di Pietro – il giudice fu costretta a scrivere che «le mancanze di
approfondimenti rilevate appaiono del tutto in lines con i già evocati frenetici
ritmi di lavoro che connotarono la prima fase di Mani Pulite». Chiamato a
testimoniare, il pm Francesco Greco la mise così: «Difficilmente in Mani pulite
i filoni investigativi venivano approfonditi oltre un certo livello, perché non
c’era il tempo per farlo. Scoperto un episodio si andava a quello dopo». Il Pool
era composto da gente cazzuta e competente, ma Mani pulite per certi aspetti fu
un’indagine superficiale in cui la velocità primeggiò sulla qualità e
sull’accuratezza. I magistrati sceglievano gli obiettivi a seconda delle
possibilità del momento, e fu Francesco Saverio Borrelli a parlare di
«Blitzkrieg»: «Era la guerra lampo tipica degli eserciti germanici, una
penetrazione impetuosa su una fascia molto ristretta di territorio, lasciando ai
margini le sacche laterali». Il Pool agiva allo stesso modo: «Tendeva ad
arrivare rapidamente ad assicurarsi risultati certi, lasciando ai margini una
quantità di vicende da esplorare in un secondo momento». Il punto è che i
risultati giunsero perciò in un secondo momento (quando giunsero) oppure dal
1994 in poi, quando la stampa e il Paese già pensavano ad altro. Le carte che
dimostrano come il Pds si finanziò in maniera illecita, per fare l’esempio più
clamoroso, diventarono migliaia in tutto lo Stivale: ma non se ne accorse
nessuno, perché nella fase più calda ed efficace – quando tutto era possibile,
forzature comprese – il Pool si era concentrato sul Psi e sulla Dc. Il Pci-Pds
si salvò anche per questo.
Il Pool di Milano fece delle scelte. Forse non poteva evitarle, ma le fece, e
questo contribuì a scrivere una storia perlomeno parziale. Per descrivere i
singoli casi (segretari di partito abbattuti o neppure sfiorati, imprenditori
salvati e altri suicidati, Eni buono ed Eni cattivo eccetera) non basterebbe un
libro, ma il vizio d’origine è riscontrabile sin dai primi mesi dell’inchiesta,
quando si propinò la favoletta degli imprenditori concussi e dei cattivi
concussori, cioè i politici. Il 28 novembre 1992, a botta calda, il famoso Mario
Chiesa fu condannato a sei anni e sei mesi e sei miliardi da restituire: il 160
per cento dei soldi ricevuti; mentre Fabrizio Garampelli, il concusso, difeso da
legali graditi all’accusa, dovette rimborsare solo il 15 per cento senza che
frattanto avesse mai smesso di lavorare: la sua azienda vinceva gli appalti del
Pio Albergo Trivulzio da vent’anni – con ogni presidente – e continuò a farlo.
Altri imprenditori se la cavarono con meno di due anni e la condizionale. Dirà
lo stesso Mario Chiesa: ««Tangentopoli non nasce solo per la prepotenza dei
politici. Di imprenditori estorti non c’è nemmeno l’ombra… corruttori pronti a
prendere calci nel culo, a subire ogni vessazione, sempre pronti a presentarti
ventisette donne pur di non uscire dalla loro nicchia ed evitare di misurarsi
col libero mercato… Una logica da gironi danteschi: nel primo c’erano le imprese
garantite per i lavori a cavallo del miliardo, nel secondo quelle per opere sui
tre miliardi… sino alla Cupola, sei o sette imprese che si riuniscono e
pianificano investimenti e leggi ad hoc per dividersi gli appalti secondo una
logica mafiosa».
Confermerà, molti anni dopo, Piercamillo Davigo: «Le imprese si sono sempre
giustificate dicendo che erano state costrette a farlo, che erano concusse, ma
quello che si è appurato nei processi o nei patteggiamenti, con le innumerevoli
condanne, mi fa propendere per l’altra ipotesi, quella di una prevalente
corruzione. Anche perché, molte volte, al versamento delle tangenti si
accompagnavano sistematiche pratiche di alterazione delle gare attraverso gli
accordi tra le imprese stesse. Insomma, molti imprenditori costituivano una
categoria di soggetti abituati a vivere di ‘protezione’, al riparo della
concorrenza, con un mercato privilegiato in cui gli appalti venivano suddivisi e
spartiti al loro interno; in questa situazione il costo delle tangenti era
rappresentato, a ben vedere, da cifre tutto sommato modiche rispetto ai benefici
che se ne ottenevano».
Mani pulite è anche questo, anzi, fu soprattutto questo, un’inchiesta
giudiziaria che ebbe conseguenze politiche alla cui ombra potè accadere ogni
cosa. E per forza: il Paese, agli albori del 1993, era un groviglio di manette,
di malcontento e di retorica. Retate ad Ancona, Vercelli, Bergamo, Monza, in
tutte le città d’Italia. Una manifestazione contro la manovra economica degenerò
in scontri con 60 feriti. Gli scioperi fiorirono dappertutto e vennero
contestati i sindacati. La Lega invitò a non acquistare i Bot, fallì un
attentato contro la sede della Confindustria, scesero in piazza i commercianti
contro l’annunciata minimum tax. Al segretario della Cisl, Sergio D’Antoni,
tirarono un bullone in testa. Arrestarono l’intera giunta regionale dell’Abruzzo
e l’intera giunta comunale di Vercelli. Ma è impossibile, ora, spiegare lo
scenario in cui scivolavano le inchieste di quel periodo, ed è ancor oggi
impossibile trovare un filo comune tra accadimenti che mozzavano il respiro: la
bomba che il 14 maggio 1993 scoppiò al quartiere Parioli di Roma, l’autobomba
che il 27 luglio scoppiò a Milano in via Palestro, le altre due l’indomani
scoppiarono a Roma in piazza San Giovanni in Laterano e a San Giorgio al
Velabro. L’opinione pubblica e i mass media si ritrovarono in un conformismo che
si pensava smarrito. Durante il funerale delle vittime di via Palestro si
distinsero frasi come queste: «Metteteli tutti a pane e acqua: la forca, ci
vuole la forca!»; «Giuràtelo che li metterete tutti alla forca!»; Di Pietro,
fatti ridare i soldi che hanno rubato, devi sequestrare tutto, hai capito?».
Dopo quel paio di suicidi eccellenti che avevano calamitato l’attenzione sui
metodi della magistratura (Gabriele Cagliari e Raul Gardini) si ripartì
tranquillamente in quarta. Un sondaggio, elaborato dopo i suicidi, spiegava che
il 60 per cento degli italiani riteneva che la carcerazione andasse bene così.
Ormai la magistratura prendeva i contorni di un grande gendarme con potere
d’interdizione permanente su uomini e cose. Un faro accecante sul vuoto della
politica. Il mondo giornalistico intanto esplodeva in entusiasmi conformisti di
cui solo noi siamo capaci, come l’era Monti in parte dimostra. Il settimanale
«L’Europeo» regalava gli adesivi circolari «Forza Di Pietro», «Panorama»
esaltava l’Italia «dei tanti Di Pietro che sono fedeli alle mogli, una nuova
specie di uomo». Chiara Beria di Argentine scriveva sull’Espresso sempre su Di
Pietro: «Un implacabile nemico delle mazzette, un giudice mastino che interrompe
i lunghi, estenuanti interrogatori offrendo Ferrero Rocher». Maria Laura Rodotà
scriveva su Panorama: «Il nuovo eroe italiano, il nuovo modello, a grande
richiesta… Di Pietro, eroe tranquillo, un role model, un modello di
comportamento italiano». Laura Maragnani scriveva su Donna: «Di Pietro fa
sognare anche le donne. Piace. Strapiace. C’è chi lo definisce un sex symbol, un
eroe per gli anni Novanta… Dicono di lui che sia duro, testardo, di metodi
spicci. E che sia onesto, onestissimo. Basta questo a farlo adorare alle donne?
O è merito anche del suo anti-look, del calzino corto che si ribella alla
tirannia dell’apparire?». Ah, saperlo.
Nel suo consueto editoriale sul Fatto quotidiano dal titolo “Vent’anni e non
sentirli”, Marco Travaglio traccia un parallelo. Il 13 luglio del 1994 e oggi,
cosa hanno in comune queste date?
Vent’anni e non sentirli
(Marco Travaglio). Da Il Fatto Quotidiano del 13/07/2014. Il Consiglio dei
ministri del 13 luglio è più breve del solito. Il premier e i ministri han
fretta di correre a vedersi la semifinale dei Mondiali di calcio. Ma,
profittando della distrazione generale, cacciano anzitempo il Cda Rai per
sostituirlo con un vertice di stretta osservanza governativa, e varano in
quattro e quattr’otto due leggi vergogna da urlo: un condono fiscale per gli
evasori, pudicamente ribattezzato “concordato”; e un decreto che salva dalla
galera i colletti bianchi (niente più custodia cautelare in carcere, al massimo
domiciliari, per concussione, corruzione, peculato, abuso d’ufficio,
finanziamento illecito ai partiti, bancarotta fraudolenta, falso in bilancio,
frode fiscale, associazione per delinquere, truffa allo Stato). Intanto le tv
pubbliche e private bombardano gli italiani con spot che annunciano i
mirabolanti (e inesistenti) risultati già ottenuti in pochissimo tempo dal nuovo
governo, con slide dominate dalla scritta “Fatto!”, e con sondaggi che
annunciano l’irresistibile ascesa del premier e del suo partito, ben oltre il
recente successo elettorale. A questo punto è bene precisare l’anno in cui
avveniva tutto ciò: il 1994. E anche il nome del presidente del Consiglio:
Silvio Berlusconi. Oggi la storia si ripete, ma con qualche piccola variante. Ci
sono sempre i Mondiali, anche se vent’anni fa l’Italia di Sacchi andò in finale
e la perse malamente ai rigori contro il Brasile, mentre quest’anno è subito
rincasata. C’è sempre un premier “nuovo”, mediatico, chiacchierone, molto
populista e popolare, anche se non guida la destra ma il centrosinistra. Al
posto degli spot “Fatto!”, ci sono le slide di Renzi e le sue conferenze stampa
con effetti speciali, ma la sostanza non cambia: si danno per fatte leggi mai
viste, o solo annunciate, o ancora da approvare, o già approvate ma prive delle
norme attuative. E soprattutto si annuncia la “grande riforma” della
Costituzione che rafforza a dismisura il premier a scapito dei poteri di
controllo, Parlamento in primis: se però B. – piduista doc – si vantava del
proprio autoritarismo, Renzi – piduista a sua insaputa – lo nega a dispetto
dell’evidenza. E il condono agli evasori? Tranquilli, sta arrivando: solo che
oggi, anziché camuffarlo da “concordato”, lo chiamano “voluntary disclosure”, in
inglese, così pochi capiscono che ripulisce i fondi neri dei grandi frodatori
depenalizzando i reati commessi per arraffarli. E il decreto Biondi? Abbiamo
anche quello. Si chiama decreto Orlando del 26 giugno: “Non può applicarsi la
misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito
del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a 3 anni”. Il che
equivale a immunizzare dalla galera tutti i galantuomini sorpresi a tentare
stupri, rapinare, rubare, borseggiare, spacciare, molestare o stalkerare
ragazze, pestare moglie e figli. Ma anche corrotti, corruttori, politici
finanziati illegalmente, frodatori fiscali eccetera, che con comodi
patteggiamenti o riti abbreviati superano raramente i 3 anni di condanna. Non
tutto però è uguale al ’94. Da allora, se Dio vuole, molte cose sono cambiate e
tanto tempo non è trascorso invano. Vent’anni fa, a bloccare il decreto Biondi,
provvidero i pm di Mani Pulite, abbandonando polemicamente le inchieste su
Tangentopoli; e i giornali, da La Voce di Montanelli a Repubblica di Scalfari al
Corriere di Mieli a La Stampa di Mauro, che informarono i cittadini sugli
effetti del “Salvaladri” innescando un meccanismo virtuoso a catena. Migliaia di
persone scrissero e telefonarono ai giornali e ai partiti, Montanelli lanciò la
raccolta di firme del “popolo dei fax”, movimenti e partiti di opposizione
chiamarono la gente nelle piazze, Lega e An si spaventarono e costrinsero B. a
ritirare il decreto (“io non lo volevo, è stato Biondi…”). Ecco, oggi le porcate
sono identiche. Mancano solo un’informazione che le chiami col loro nome,
un’opposizione che le contrasti (a parte i 5Stelle e i resti di Sel) e
un’opinione pubblica che protesti. Per il resto tutto bene.
LA CASTA. CON L'IMMUNITA' PARLAMENTARE SI DIFENDE.
Casta, così l'immunità parlamentare è diventata lo scudo contro arresti e
processi. Dal 1994 Montecitorio e Palazzo Madama hanno respinto il 90 per cento
delle richieste di carcerazione o di domiciliari avanzate dai giudici. E negato
spesso l’uso di intercettazioni e tabulati, sempre per un presunto fumus
persecutionis nelle indagini. Una “protezione” che con il nuovo Senato sarà
estesa a sindaci e consiglieri regionali, scrive Paolo Fantauzzi su
“L’Espresso”. Immunità anche per i “nuovi” senatori. Dopo critiche, proteste,
smentite e pressioni varie, alla fine lo scudo giudiziario sarà esteso anche ai
sindaci e ai consiglieri regionali che approderanno a Palazzo Madama. E come
avviene per i deputati, servirà un’autorizzazione per arrestarli, intercettarli
ed effettuare perquisizioni nei loro riguardi. Eppure, se vorrà evitare che
finisca col lancio di monetine come durante Tangentopoli, il governo farebbe
bene ad approfittare della riforma costituzionale per congegnare un sistema che
eviti gli abusi degli ultimi due decenni. Senza contare il caso Galan , in
merito al quale Montecitorio non si è ancora espresso, su 31 richieste di
arresto avanzate dai giudici nell’arco di questo ventennio - ha ricostruito
l’Espresso - 28 sono state respinte. Nove volte su dieci, in pratica, Camera e
Senato hanno ritenuto viziate da fumus persecutionis le istanze della
magistratura di mandare in carcere o ai domiciliari un parlamentare. Un dato che
mostra come la riforma dell’articolo 68 della Costituzione varata nel 1993
sull’onda di Mani pulite non sia servita a granché. Così se nella Prima
Repubblica, senza il via libera della Camera di appartenenza, un onorevole non
poteva essere inquisito e nemmeno arrestato dopo una condanna definitiva, dal
’94 in poi l’immunità ha continuato a rappresentare un formidabile scudo dalle
vicende giudiziarie. Peraltro con una significativa recrudescenza negli ultimi
anni, visto che oltre un terzo delle richieste di arresto sono state inoltrate
nella scorsa legislatura (2008-2013).
Dati riferiti agli anni 1994-2014.
Il berlusconiano Alfonso Papa e i democratici Luigi Lusi e Francantonio Genovese
, arrestati negli ultimi tre anni, sono gli unici a essere finiti dietro le
sbarre. Ma fino al 2011 ogni richiesta è stata puntualmente respinta. Spesso
grazie anche al voto segreto. Come nel caso del deputato Pdl Nicola Cosentino,
accusato di concorso esterno in associazione camorristica: secondo l’istruttoria
svolta dai deputati della Giunta delle autorizzazioni di Montecitorio,
l’onorevole andava spedito in carcere come chiedeva il gip di Napoli. Ma nel
segreto dell’urna, nel 2009 l’Aula lo ha graziato , impedendo anche l’utilizzo
di alcune sue intercettazioni telefoniche. Idem nel 2011 per Alberto Tedesco
(Pd) e nel 2012 per il senatore Sergio De Gregorio (Pdl), accusato di truffa e
false fatturazioni nell’inchiesta sui fondi pubblici all’editoria e per il quale
erano stati chiesti i domiciliari. In altri casi, invece, il Parlamento si è
trasformato in una sorta di Corte di Cassazione. E anziché limitarsi ad appurare
un eventuale intento persecutorio dei pm (come previsto dalla legge), si è
spinto a dare giudizi di merito sulle inchieste. Nel 1997, ad esempio, il
deputato Carmelo Carrara (Ccd-Cdu), relatore della richiesta d’arresto di Cesare
Previti - salvato dal carcere nell’inchiesta Imi-Sir, in cui l’avvocato fu poi
condannato per corruzione in atti giudiziari - ravvisava «un’esasperazione
accusatoria del gip di Milano». Due anni dopo anche il relatore Filippo Berselli
(An) motivò il suo “no” alla richiesta di carcerazione nei confronti di Marcello
Dell’Utri per la «evidente sproporzione tra la misura cautelare adottata e i
reati contestati», ovvero tentata estorsione e calunnia. Quando il gip di Bari
nel 2006 chiese i domiciliari per Raffaele Fitto nell’ambito di un’inchiesta
sulla sanità, la Giunta della Camera stabilì all’unanimità che il pericolo di
reiterazione del reato “non appare motivato”. E quindi l’ex governatore pugliese
- poi condannato a 4 anni in primo grado - doveva restare libero. La richiesta
di carcerazione nei confronti del deputato Udc Remo Di Giandomenico, anche lui
accusato di corruzione nel 2006, era invece “connotata da fumus persecutionis,
specie in rapporto all’attualità delle esigenze cautelari”. E siccome
l’onorevole in una sua memoria difensiva alla Giunta aveva “offerto concreti
elementi di contestazione nei confronti delle accuse”, “si affievolisce la
esigenza custodiale”. Tradotto: niente arresto. Il fumo della persecuzione
Montecitorio l’aveva ravvisato anche nel 1998, nelle due diverse richieste di
carcerazione dell’ex sindaco di Taranto Giancarlo Cito (poi condannato sia per
l’una che l’altra vicenda): entrambe furono infatti respinte. Si dirà: se
l’inchiesta è debole, è comprensibile una levata di scudi. Eppure nemmeno
un’indagine riconosciuta come fondata dagli stessi onorevoli ha portato a un
esito diverso. Quando nel 2006 il gip di Roma chiese il carcere per il deputato
Giorgio Simeoni (Forza Italia) per il pericolo d'inquinamento delle prove in
un’inchiesta sulla sanità, la maggioranza dei suoi colleghi in Giunta
osservarono che “il pericolo mancherebbe perché il quadro indiziario è tutto
sommato abbastanza solido”. Risultato: l’autorizzazione a procedere non fu
concessa nemmeno in questo caso. Il diniego agli arresti non è l’unico aspetto
significativo. Grosso modo una volta su due (in totale 26 su 58), il Parlamento
ha negato anche l’uso di uno strumento fondamentale d’indagine come le
intercettazioni. Ma le Camere non hanno solo impedito l’utilizzo delle
conversazioni captate indirettamente. In qualche caso hanno negato perfino la
semplice acquisizione dei tabulati, che consentono di ricostruire le chiamate
ricevute ed effettuate, per “tutelare la sfera di riservatezza del
parlamentare”. Pure l’insindacabilità, vero cuore dell’immunità, si è prestata a
qualche interpretazione di manica assai larga. Si tratta dello “scudo” nei
confronti delle opinioni espresse dagli eletti, una prerogativa fondamentale per
assicurare la loro indipendenza e autonomia senza il timore di essere trascinati
in tribunale. Su oltre 700 casi, il 92 per cento delle volte Montecitorio e
Palazzo Madama hanno ritenuto che i giudizi di deputati e senatori sfociati in
una causa per diffamazione erano stati espressi nell’esercizio delle funzioni
parlamentari, come prevede la legge. Pertanto gli onorevoli non erano
processabili. Un “ombrello” sotto il quale - solo per citare alcuni degli
episodi più celebri - sono finite le critiche di Francesco Storace a Giorgio
Napolitano (dalla «disdicevole storia personale», la «evidente faziosità
istituzionale» e «indegno di una carica usurpata a maggioranza»), le accuse di
Maurizio Gasparri a John Woodcock («un bizzarro pm, che spara a vanvera accuse
ridicole») oppure le intemerate di Vittorio Sgarbi contro i pm del pool di
Milano («vanno processati ed arrestati: sono un’associazione a delinquere con
libertà di uccidere che mira al sovvertimento dell'ordine democratico»). Proprio
Sgarbi, peraltro, in questi anni si è dimostrato una sorta di record-man: oltre
150 delibere di insindacabilità (un quinto del totale) hanno riguardato proprio
lui. Un dilagare generalizzato contestato dalla Corte costituzionale, che in
questi 20 anni - a seguito di conflitti di attribuzione sollevati dai giudici -
ha annullato 84 concessioni di immunità: per la Consulta si trattava di
affermazioni che nulla avevano a vedere con l’attività parlamentare. E quindi
deputati e senatori andavano processati come normali cittadini.
Onorevole inquisito? Non c'è fretta. La melina delle Camere che
rallenta i giudici. Due anni di attesa per le
intercettazioni di Verdini. Quasi uno per quelle dell'Ncd Azzollini. Sei mesi
(finora) per l'autorizzazione nei confronti dell'ex ministro Matteoli e tempi
ancora vaghi per le offese di Calderoli alla Kyenge. Quando è indagato un suo
componente, il Parlamento se la prende comoda, scrive Paolo Fantauzzi su
“L’Espresso”. Paragonare un ministro di origini congolesi a un orango è
un'opinione insindacabile espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari?
Comunque la pensiate, sappiate ci vuole molto tempo prima di stabilirlo. Pure
se, dopo un'istruttoria durata settimane e settimane, per decidere ci vorrebbe
assai poco. E per autorizzare la magistratura a procedere nei confronti di un ex
ministro accusato di aver intascato mezzo milione di euro? Possono volerci anche
sei mesi. Troppo? Sciocchezze, perché come niente si può arrivare anche a un
anno o due di attesa. Parafrasando Bogart, sono i tempi dell'immunità
parlamentare, bellezza. Un istituto pensato per proteggere deputati e senatori
dal rischio di intenti persecutori della magistratura, trasformatosi col tempo
in un tribunale preventivo preoccupato più che altro di salvarli dai processi.
Ma a regalare anzitempo generose assoluzioni non c'è solo questo scudo
giudiziario, che ha trasformato l'immunità in impunità e portato a respingere
nella Seconda repubblica il 90 per cento delle richieste di arresto avanzate dai
giudici . Prima ancora di arrivare a un verdetto, qualunque sia, si assiste
infatti puntualmente a una sorta di "melina" calcistica che dilata a dismisura i
tempi. Il caso di Denis Verdini è emblematico: il Parlamento ci ha messo due
anni prima di concedere l'uso delle sue intercettazioni nell'inchiesta sulla P4,
in cui è accusato di corruzione. Era maggio 2012 quando il gup Cinzia Parasporo
ha trasmesso alla Camera la richiesta di usare una trentina di telefonate
captate indirettamente tra l'allora deputato, che in quanto tale non poteva
essere intercettato, e la "cricca" delle Grandi opere (Angelo Balducci, Fabio De
Santis e Riccardo Fusi). La Giunta delle autorizzazioni di Montecitorio aveva
anche espresso parere positivo e nel giro di un mese era tutto pronto. Bastava
solo trovare uno spazio nel calendario dei lavori d'Aula. Invece, nonostante ci
fossero mesi e mesi a disposizione, niente da fare. Risultato: la legislatura è
finita, Verdini è stato eletto senatore e ad aprile 2013 il gup ha dovuto di
nuovo trasmettere gli atti, stavolta a Palazzo Madama. Dove, come al gioco
dell'oca, si è ripartiti da zero. E prima del via libera è trascorso un altro
anno. Grosso modo lo stesso lasso di tempo necessario a rispondere "no" al gip
di Trani che chiedeva di usare una decina di intercettazioni indirette del
senatore Ncd Antonio Azzollini, inquisito per la presunta truffa
dell'ampliamento del porto di Molfetta . Una vicenda che mostra la mera ragion
politica che si cela a volte dietro alcune scelte: per salvare il potente
parlamentare alfaniano e in questo modo la stabilità del governo, con una
decisione senza precedenti il Pd - come ha rivelato l'Espresso - ha addirittura
convocato una riunione d'emergenza. E dire che in Giunta si era già visto di
tutto: 11 sedute in 7 mesi, due richieste di integrazioni istruttorie chieste al
giudice e altrettante audizioni del senatore, perfino una disputa sulle date in
cui erano iniziati gli ascolti. Alla fine, dopo dieci mesi di passione, il
Senato ha negato l’autorizzazione: era chiaro che mettendo sotto controllo i
telefoni degli altri indagati i pm avrebbero intercettato anche il parlamentare,
ha motivato nella sua relazione il senatore Pd Claudio Moscardelli. Ma se quelli
di Verdini e Azzollini sono i più eclatanti, i casi sono numerosissimi. Sono
passati sei mesi, ad esempio, da quando è arrivata in Senato la richiesta di
autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Ambiente Altero
Matteoli, che secondo i pm dell’inchiesta sul Mose avrebbe ricevuto tangenti per
550 mila euro fra il 2001 e il 2012. Sarebbe bastata qualche ora per votare,
visto che la relazione istruttoria sulla vicenda è pronta dal 10 febbraio. Solo
che per settimane nessuno si è preoccupato di farla mettere all'ordine del
giorno dell’Aula. Che si è occupata di tutt’altro, fra decreti in scadenza da
convertire, emergenze, mozioni varie e perfino la richiesta di dimissioni di
fuoriusciti del Movimento cinque stelle. Adesso, dopo qualche pressing
informale, il presidente Piero Grasso ha finalmente fissato la data: il 2
aprile. Intanto, nel corso di un'audizione sugli appalti, si è assistito al
paradosso di un presidente di commissione accusato di corruzione (Matteoli)
seduto accanto al presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone. Ancora tempi
lunghi si prevedono invece per gli epiteti di Roberto Calderoli rivolti nel
luglio 2013 all’allora ministro dell’Integrazione: «Ogni tanto, smanettando con
internet, apro il sito del governo e quando vedo venire fuori la Kyenge io resto
secco. Io sono anche un amante degli animali per l’amore del cielo. Ho avuto le
tigri, gli orsi, le scimmie e tutto il resto. Però quando vedo uscire delle
sembianze di un orango, io resto ancora sconvolto». Diffamazione aggravata da
finalità di discriminazione razziale, secondo i pm bergamaschi Maria Cristina
Rota e Gianluigi Dettori. Ma non per la Giunta di Palazzo Madama, che col voto
determinante di alcuni senatori Pd si è espressa per lo stop al processo. Adesso
resta da vedere se, dopo le polemiche, l'Aula ( e soprattutto il Pd ) confermerà
o ribalterà il parere espresso. Intanto le cose vanno per le lunghe: la
relazione, affidata al forzista Lucio Malan, è pronta dal 25 febbraio ma la
questione non ha ancora trovato posto nel calendario dei lavori.. «Calderoli -
vi si legge - ha utilizzato, all'interno di un articolato intervento
sull'immigrazione fortemente critico, un'espressione forte, ma fatta
esclusivamente come battuta ad effetto, visto che il contesto, oltre che
politico, era anche ludico e cioè quello di una festa estiva organizzata».
Insomma, uno scherzo. Quindi niente processo. Non sono state poste all'ordine
del giorno nemmeno le 13 telefonate e 68 sms dell’ex senatore Pd Antonio Papania
che secondo la Procura di Trapani proverebbero la corruzione per un atto
contrario ai doveri di ufficio: tra il 2010 e il 2012 l’allora parlamentare
avrebbe ricevuto “in più occasioni utilità consistite nell’assunzione di
numerose persone a lui gradite e da lui segnalate”. Ma la vicenda è oggetto di
un ping pong che si trascina da mesi. Le carte sono arrivate a Palazzo Madama a
giugno ma se ne è iniziato a discutere solo a ottobre. A dicembre il caso è
approdato in Aula ma per una questione formale il fascicolo è stato rimandato in
Giunta. Sono trascorsi altri tre mesi e da qualche settimana è tutto pronto per
il voto dell’Assemblea. Ma tutto è ancora fermo. Va riconosciuto che quando si
tratta di arrestare un parlamentare le Camere riescono a essere più celeri: per
acconsentire a mandare dietro le sbarre i deputati Giancarlo Galan (Forza
Italia) e Francantonio Genovese (Pd), come chiesto dai giudici, ci sono voluti
“solo” due mesi. In ogni caso moltissimo se si considerano le motivazioni che
richiedono la carcerazione: pericolo di fuga, inquinamento delle prove e
reiterazione del reato. Insomma, se i rischi sono tali, a ben vedere neppure
otto settimane sono così poche. Tanto più che, a giudicare dalle date, nemmeno
in queste circostanza di estrema urgenza il Parlamento pare essere stato
particolarmente solerte nella rispondere alla magistratura. La relazione che
concedeva l'arresto di Galan per corruzione, ad esempio, è rimasta ferma una
dozzina di giorni prima di arrivare in Aula: dal 10 al 22 luglio 2014. Nel caso
di Genovese - accusato di peculato, truffa aggravata, riciclaggio, emissione di
fatture false e associazione a delinquere - le carte sono arrivate da Messina il
18 marzo 2014 ma la Giunta delle autorizzazioni di Montecitorio ha iniziato
l’esame solo il 26 e la seconda seduta si è tenuta il 10 aprile, dopo altre due
settimane. Poi, siccome c'è stata Pasqua di mezzo, altre due settimane di stop.
Casi eccezionali? Non proprio. Nella scorsa legislatura, quando fu raggiunto il
record di 11 richieste di arresto nei confronti di parlamentari, i tempi sono
stati grosso modo gli stessi. Nel 2008 ci vollero tre mesi e mezzo prima di
votare (contro) la richiesta di domiciliari per il pidiellino Nicola Di
Girolamo. E oltre due mesi prima di respingere l'arresto dell'imprenditore
Antonio Angelucci, di Vincenzo Nespoli, del consigliere del ministro Tremonti,
Marco Milanese, e consentire quello di Alfonso Papa (tutti del Pdl). Due mesi
per arrestare Alberto Tedesco (Pd) e un mese e mezzo per mandare ai domiciliari
Sergio De Gregorio (Pdl) e in carcere Luigi Lusi (Pd). Unica eccezione, quella
del deputato Pd Salvatore Margiotta: nel 2008 la Camera impiegò appena due
giorni per respingere la richiesta di arresti domiciliari, avanzata dal pm Henry
John Woodcock nell'ambito dell'inchiesta per la realizzazione del Centro oli
della Total in Basilicata. Per quelle accuse (turbativa d’asta e corruzione) lo
scorso dicembre il parlamentare dem, adesso senatore, è stato condannato in
Appello a un anno e sei mesi.
Finanziamenti ai partiti, nessuno controlla.
Entro il 15 febbraio 2015 dovrebbe essere ultimata la verifica sulle fonti di
finanziamento pubbliche e private. Ma i magistrati designati per occuparsi della
commissione trasparenza si sono dimessi. E non è facile trovare chi voglia
sostituirli, scrive Mariagrazia Gerina il 19 dicembre 2014 su “L’Espresso”. C’è
una montagna di carte ancora da controllare per verificare dove sono andati a
finire i finanziamenti pubblici ai partiti e anche da dove vengono quelli
privati: ricevute, fatture, elenchi dei donatori, con nomi e cognomi di tutti
quelli che hanno dato più di 5mila euro. La legge prevede che entrate e uscite
di ciascun partito siano passate al setaccio entro il prossimo 15 febbraio da
cinque alti magistrati nominati dai presidenti di Camera e Senato. Ma nelle
stanze di via del Seminario assegnate alla Commissione per la trasparenza dei
rendiconti dei partiti da quasi due mesi non c’è nessuno. Sul sito del
parlamento campeggiano ancora i nomi dei cinque commissari che il 28 ottobre si
sono dimessi. «Prima o poi se ne accorgeranno che ce ne siamo andati», bisbiglia
sarcastico uno di loro. Trovare chi voglia sostituirli non è facile. Finora,
solo il presidente della Corte dei Conti ha indicato i tre nomi che spetta a lui
designare, quelli di Consiglio di Stato e Cassazione mancano ancora all’appello.
Tanto che i presidenti di Camera e Senato stanno pensando di accontentarsi di
tre soli commissari pur di far ripartire i controlli. Compito ingrato lavorare
per una Commissione che deve funzionare “a costo zero”. «È nata con il piombo ai
piedi», sentenzia Bruno Bove, che l’ha presieduta dal 2012, quando è stata
istituita, fino a due mesi fa: «Abbiamo fatto il nostro lavoro finché è stato
possibile». Si sono arresi davanti alla montagna di rendiconti relativi al 2013.
A partire da quest’anno, la legge prevede che la Commissione verifichi non solo
la correttezza ma anche la «conformità delle spese effettivamente sostenute e
delle entrate percepite alla documentazione prodotta». Sono migliaia di pagine
da spulciare. E, a seguire, ci sono le sanzioni da applicare agli inadempienti.
I commissari lo avevano scritto nella lettera riservata, consegnata a Pietro
Grasso e a Laura Boldrini, prima dell’estate: è impossibile procedere con appena
due segretarie a disposizione e senza essere dispensati dagli incarichi ordinari
presso le rispettive magistrature. La risposta sperata non è arrivata. E sono
seguite le dimissioni. «L’auspicio è che siano servite a dare una scossa»,
osserva Bove. Chissà. Il parlamento per correre ai ripari sta preparando una
“leggina” che consenta ai prossimi commissari di essere almeno collocati “fuori
ruolo” per la durata del mandato. Nel frattempo, però, con il nuovo sistema di
finanziamento dei partiti voluto da Matteo Renzi, il lavoro è raddoppiato. Oltre
alla ripartizione dei fondi pubblici, che saranno ridotti ma non aboliti prima
del 2017, la Commissione dovrà verificare le nuove entrate previste: il 2 per
mille, i contributi diretti dei privati e gli sgravi fiscali a cui la legge del
febbraio scorso dà accesso. Una forma di finanziamento pubblico indiretto. Forse
ancora meno trasparente. Un consiglio più che ai successori, ancora non
nominati, il presidente uscente lo dà al legislatore: «C’è da mettere ordine nel
groviglio delle norme». Fin qui il parlamento, a quanto pare, non ci è riuscito.
"1992": LA STORIA SCRITTA DAI VINCITORI.
Ai funerali di Pietrino Vanacore,
intorno alla sua bara, assorta nel silenzio con la rabbia ed il dolore, c’era la
gente che gli voleva bene. Una donna ha avuto il coraggio di dare voce alla sua
comunità: «applaudite, hanno ottenuto quello che volevano!!!» La frase era
rivolta a coloro, che, per deformazione professionale e culturale, non hanno una
coscienza. Intanto, intorno alle sue spoglie gli sciacalli hanno continuato ad
alimentare sospetti. La sua morte non è bastata a zittire una malagiustizia che
non è riuscita a trovare un colpevole, ma lo ha scelto come vittima sacrificale.
A zittire una informazione corrotta che lo indicava come l’orco, pur senza
condanna. Non poteva dirsi vittima di un errore giudiziario, come altri 5
milioni di italiani in 50 anni. Per venti anni è stato perseguitato da innocente
acclamato. Voleva l’ultima parola per dire basta. Non l’hanno nemmeno lasciata.
Pure da morto hanno continuano ad infangare il suo onore. Accuse che nessuna
norma giuridica e morale può sostenere. Accanimento che nessuna società civile
può accettare. La sua morte è un omicidio di Stato e di Stampa. Non si può, per
venti anni, non essere capaci di trovare un colpevole e continuare a
perseguitare un innocente acclamato. Non si può, per venti anni, continuare ad
alimentare sospetti, giusto per sbattere un mostro in prima pagina.
Ferdinando Imposimato, il “giudice coraggio” delle grandi inchieste
contro il terrorismo e la delinquenza organizzata, ha provato sulla propria
pelle l’amarissima esperienza di star sul banco degli imputati. Egli conclude,
come un ritornello inquietante: “E’ più difficile talvolta difendersi da
innocenti che da colpevoli”. Parola di magistrato.
Manette facili e ideologia. Che processi tragicomici.
Oltre quarant'anni fa, le commedie all'italiana avevano colto le
degenerazioni del sistema giudiziario. Quasi nulla è cambiato, scrive
Claudio Siniscalchi su “Il
Giornale”. L'editoria cinematografica italiana è
stata dissanguata prima dagli ideologi di sinistra, poi dal dominio della
scrittura oscura di semiologi e psicoanalisti, o presunti tali. Ormai trattasi
di un corpo tenuto in vita da una macchina artificiale. Ci vorrebbe, per
rianimarlo, un miracolo. O, almeno, un po' di sangue fresco. Buona linfa scorre
all'interno di una linea di ricerca sul cinema italiano avviata dall'editore
calabrese Rubbettino, guidata dal giovane universitario Christian Uva,
all'insegna di una complementarità: cinema e storia. L'ultimo tassello è In nome
della legge. La giustizia nel cinema italiano, a cura di Guido Vitiello. Il
volume, raccolta di molti saggi, suscita alcune considerazioni. Dagli anni
Trenta del secolo passato ad oggi, cioè dal fascismo alla democrazia, la
commedia è stata il genere principe del cinema italiano. Nel Ventennio la
macchina da presa s'è tenuta alla larga dai tribunali. Nel dopoguerra invece ci
si è buttata per cogliere il tratto comico della giustizia. L'immenso Vittorio
De Sica con la toga da avvocato (versione aggiornata dell'azzeccagarbugli
manzoniano), folti capelli candidi, gesti da mattatore, eloquio da senatore (del
Regno non della Repubblica), ridicolizzato dalla perdita della memoria. Totò e
Peppino, grandissimi falsi testimoni. L'Albertone nazionale alla sbarra imputato
di essersi bagnato nella marana senza vestiti. Il giudice Adolfo Celi che non
ammette repliche alla sua autorità e competenza equestre. Insomma, in aula si
ride. Pensate ora all'americano Codice d'onore (1992) di Rob Reiner. Il giovane
Tom Cruise in doppiopetto blu con bottoni d'oro, avvocato della marina,
assistito da Demi Moore, impegnato ad incastrare davanti alla corte marziale un
mastino gallonato del corpo dei marine, Jack Nicholson. Non è uno scontro
generazionale, di temperamenti, ma di visioni del mondo. Persino di attori. Il
processo qui è anche spettacolo. Un grandioso spettacolo. Serissimo. Certo
l'impianto giuridico americano rispetto a quello italiano agevola la
drammatizzazione cinematografica. Per questo il cinema hollywoodiano ha un
genere specifico dedicato ai tribunali, il courtroom drama o legal film. La
commedia all'italiana, però, non è stata soltanto un contenitore di risate. Ha
saputo anche cogliere e indicare questioni cruciali. Ad esempio la denuncia
dell'arbitrarietà della carcerazione preventiva. L'odissea giudiziaria (e
carceraria) che tocca ad Alberto Sordi in Detenuto in attesa di giudizio (1971)
di Nanni Loy è un capolavoro dal sorriso amaro. Lo stritolamento dello
sfortunato e innocente geometra mette a nudo l'arretratezza del sistema
giudiziario e carcerario italiano. Siamo all'inizio degli anni Settanta, e
sembra la storia di oggi. E come dimenticare l'istantanea sull'ideologizzazione
progressista della magistratura scattata da Dino Risi nel suo In nome del popolo
italiano (1971)? Il giudice Ugo Tognazzi non riesce a contenere l'odio di classe
nei confronti dell'imprenditore di successo Vittorio Gassman. Quest'ultimo
incarna il male del capitalismo italiano del boom economico: corrotto e
corruttore. Quindi va eliminato, anche bruciando le prove della sua innocenza.
La condanna non deve essere giudiziaria ma ideologica e morale. Infatti il
procuratore, che mostra con disinvoltura una copia dell'Unità, non ce l'ha solo
con i ricchi. Vorrebbe chiudere in cella anche capelloni, maoisti, anarchici,
obiettori di coscienza, giovani scansafatiche. Da un figlio dei fiori redarguito
si becca un insulto e l'accusa di essere fascista. Del resto nello stesso
periodo la magistratura viene raffigurata come il braccio armato del potere
(spesso occulto, antidemocratico, fascistoide), sia nel genere popolare
«poliziottesco», sia nel filone di «ricerca impegnata», da Indagine su un
cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970) e Todo Modo (1976) di Elio Petri a
Cadaveri eccellenti (1976) di Francesco Rosi. Il cinema italiano si suicida tra
la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta. Nelle macerie dell'ultimo
trentennio si salva poco o niente. L'inchiesta Mani pulite poteva diventare un
serbatoio infinito di sceneggiature ma la poltrona della sala cinematografica è
stata sostituita dal divano di casa. La magistratura saliva al cielo grazie al
piccolo schermo. La grande popolarità di Antonio Di Pietro, il più teatrale dei
magistrati, comincia con la televisione. E con la televisione si chiude. Non
regge all'urto della cannonata sparatagli da Milena Gabanelli. Col tubo catodico
era schizzato tra le stelle. Col plasma è tornato sulla terra.
Napolitano: 1992-2011 Re Giorgio tra due guerre.
C'è il Napolitano che ai tempi di Mani Pulite criticava il
protagonismo della magistratura milanese e il Napolitano di oggi, preoccupato
per i frequenti attacchi al potere giudiziario. Che cosa è cambiato? Si chiede
Giovanni Fasanella su “Panorama”. Chissà se è proprio come raccontano le
cronache. Se è vero che Silvio Berlusconi, venerdì 11 febbraio alle 17, è salito
al Quirinale per chiedere il conforto di Giorgio Napolitano contro la procura
milanese. E che il presidente della Repubblica glielo ha negato, invitandolo
invece a presentarsi davanti ai giudici, l’unica sede in cui difendersi dalle
accuse. Chissà. Prima di varcare la soglia di quel palazzo, accompagnato dal suo
sottosegretario Gianni Letta, forse il premier ricordava il Napolitano
presidente della Camera, l’uomo che nel 1992-93, nel pieno della rivoluzione
giudiziaria passata alla storia col nome di «mani pulite», mentre gli avvisi di
garanzia fioccavano a centinaia, aveva sfidato il pool milanese, costringendolo
almeno in un’occasione addirittura a scusarsi con il Parlamento. Se erano
davvero questi i fotogrammi che passavano velocemente nella sua memoria e il
gelo che un’ora dopo ha suggellato la fine dell’incontro, come raccontano le
cronache, il Cavaliere deve avere lasciato il Quirinale con immagini molto
diverse. A lui il Napolitano di oggi dev’essere sembrato solo uno sbiadito
ricordo di quello di ieri. «Egregio Signor presidente, ho deciso di
indirizzare a Lei alcune brevi considerazioni prima di lasciare il mio seggio in
Parlamento compiendo l’atto conclusivo di porre fine alla mia vita…»: era il
3 settembre 1992 e mai Napolitano era apparso in pubblico emozionato fin quasi
alle lacrime, come in quel giorno. L’aula di Montecitorio lo ascoltava nel più
assoluto silenzio mentre leggeva la lettera che gli aveva scritto il deputato
socialista Sergio Moroni. «Vengo coinvolto nel cosiddetto scandalo
“tangenti”, accomunato nella definizione di “ladro” oggi così diffusa. Non lo
accetto, nella serena coscienza di non avere mai personalmente approfittato di
una lira. Ma quando la parola è flebile non resta che il gesto». Quelle
furono le ultime parole scritte da Moroni prima di uccidersi sparandosi in bocca
con un fucile, nella cantina della sua abitazione. E il destinatario, il
presidente della Camera, non ebbe neppure la forza di commentarle come avrebbe
voluto. Lo ammise lui stesso nel libro che pubblicò dalla Rizzoli due anni dopo,
Dove va la Repubblica. 1992-94, una transizione incompiuta. «Avrei
forse dovuto, quel giorno, dire di più. Ho poi sentito il rammarico di non
essere stato più esplicito: di non avere espresso più apertamente la mia
inquietudine per una situazione che tendeva a bloccarsi nella contrapposizione
tra la tendenza a rimettere solo all’azione della magistratura, acriticamente e
anche strumentalmente acclamata da una parte delle forze politiche, l’imperiosa
necessità di una bonifica politica e morale, e il tentativo di opporvi
resistenza, in vario modo, in seno al Parlamento». Il presidente della
Camera nell’era di «mani pulite» era convinto che fosse stato oltrepassato un
limite. Che l’azione della magistratura tendesse a volte a colpire nel mucchio,
alterando in modo pericoloso l’equilibrio fra i poteri. All’inizio del 1993, era
ormai sotto inchiesta gran parte del Parlamento, le richieste di autorizzazione
a procedere nei confronti di deputati e senatori avrebbero ben presto raggiunto
la cifra impressionante di 619. Il governo presieduto dal socialista Giuliano
Amato, entrato in carica appena sei mesi prima, nel giugno del 1992, stava per
crollare. I suoi ministri, raggiunti da avvisi di garanzia, cadevano uno dopo
l’altro, come birilli su un tavolo da biliardo. E proprio mentre nell’aula di
Montecitorio si discuteva una mozione di sfiducia presentata dal segretario del
Pds Achille Occhetto, il 2 febbraio 1993 accadde un episodio che scatenò l’ira
di Napolitano. Inviato da Gherardo Colombo, uno dei pubblici ministeri del pool
milanese, un ufficiale della Guardia di finanza si era presentato alla Camera
pretendendo i bilanci del Partito socialista. Il presidente dell’assemblea prese
subito la parola per denunciare l’accaduto. Poi telefonò al capo della procura
di Milano, Francesco Saverio Borrelli, costringendolo a scusarsi. E convocò
Colombo nel suo studio per chiedergli spiegazioni. Non pago, consegnò alla
stampa un comunicato di rara durezza: «Si è chiesta in modo irrituale agli
uffici della Camera copia di atti per altro già pubblicati per obbligo di legge
sulla Gazzetta ufficiale. La segreteria generale della Camera ha
contestato la irritualità e incomprensibilità di tale passo». Il suicidio di
Moroni e l’«assalto» giudiziario al Parlamento lasciarono a lungo il segno. Al
punto che Napolitano, ormai presidente della Repubblica, ha dedicato a quella
drammatica fase della storia italiana alcune delle pagine più toccanti della sua
autobiografia, ripubblicata dalla Laterza nel 2008, due anni dopo la sua ascesa
al Quirinale. Rievocando quegli anni, parla addirittura di «clima di “pogrom”
nei confronti della classe politica». E ne denuncia le responsabilità senza
perifrasi: «Una gran parte del mondo dell’informazione; e una parte dello
stesso mondo politico, dell’opposizione vecchia e nuova». Parla del ruolo
della stampa. Stigmatizza cultura e atteggiamenti forcaioli, allora, del Msi
(poi Alleanza nazionale) e della Lega. Ricorda le «forche caudine»
organizzate dai deputati missini all’ingresso di Montecitorio e il cappio
agitato e invocato dai leghisti dentro l’aula. Non risparmia critiche neppure al
suo partito, il Pds, «che certamente contava di trarre beneficio, sul piano
politico ed elettorale, da quella bufera che investiva soprattutto i partiti di
governo». Impietoso il quadro complessivo che Napolitano ricostruisce: «L’adesione
acritica a qualsiasi posizione e azione venisse dalla magistratura inquirente,
l’amplificazione e generalizzazione delle risultanze di qualsiasi indagine,
l’intimidazione nelle stesse aule parlamentari facevano parte di quello che fu
chiamato giustizialismo e costituì non solo un fattore di stravolgimento degli
equilibri istituzionali, ma anche un ostacolo al corretto svolgimento della
funzione propria del Parlamento rispetto a esigenze reali di moralizzazione e di
rinnovamento». Insomma, scrive, «ne scaturì la prassi abnorme delle
dimissioni obbligate di ogni membro del governo che fosse raggiunto da
un’”informazione di garanzia”, strumento previsto dal codice a tutela del
diritto di difesa del cittadino e divenuto l’equivalente di un pubblico sospetto
di colpevolezza (anche per mancanza di riservatezza e per lo scandalismo della
stampa)». Chissà se anche il presidente della Repubblica ripensava a quegli
anni, mentre aspettava Silvio Berlusconi, il pomeriggio di venerdì 11 febbraio.
Chissà se ha rivisto mentalmente i fotogrammi di quel trauma, mentre dettava il
comunicato diffuso prima dell’incontro, quasi a volere stabilire preventivamente
una distanza dalla delicata posizione del Cavaliere: «Nella Costituzione e
nella legge possono trovarsi i riferimenti di principio e i canali normativi e
procedurali per far valere insieme le ragioni della legalità nel loro necessario
rigore e le garanzie del giusto processo. Fuori di questo quadro, ci sono solo
le tentazioni di conflitti istituzionali e di strappi mediatici che non possono
condurre, per nessuno, a conclusione di verità e giustizia». Parole pesanti.
Che alle orecchie del premier devono essere suonate peggio che una presa di
distanze: la negazione di un passato garantista e un avallo esplicito alla
procura milanese. Quel che è certo è che il Giorgio Napolitano presidente della
Repubblica è ancora più angosciato di quanto non lo fosse il Napolitano
presidente della Camera, almeno così si fa sapere dal Colle: oltre tre lustri
sono trascorsi da quel trauma, ma è come se il tempo non fosse mai passato, con
un sistema ancora bloccato da un odio politico che diventa sempre più cieco e da
tensioni istituzionali che diventano sempre più laceranti.
1992, i trucchi del pool e gli errori di Craxi.
Un docufilm in onda su History Channel ricostruisce con testimonianze inedite i
metodi della squadra di Di Pietro. E ripropone le sottovalutazioni del leader
socialista, come nella politica di oggi, scrive Gianluca Di Feo su “L’Espresso”.
Ormai su Mani Pulite si sta ritirando fuori di tutto, intrecciando fiction e
cronaca, in un quadro forse un po' confuso che ha un solo punto fermo: oggi come
allora, la maggioranza degli italiani non è più disposta a tollerare la
corruzione. C'è un documentario che forse può aiutare a trovare qualche punto
fermo, grazie ad alcune testimonianze e documenti d'epoca: “1992 attacco al
potere”, che andrà in onda questa sera (14 aprile 2015) e il 21 aprile alle
23 su History Channel. Si apre con Luca Magni, l'imprenditore che consegnò la
bustarella a Mario Chiesa che ha fatto crollare un intero sistema politico.
Ricostruisce i fatti minuto per minuto. Dice che i magistrati «era come se
avessero la macchina ma non sapessero farla partire, io sono stato la chiave che
ha fatto partire tutto». Negli occhi di Magni non c'è più il senso di sfida che
mostrava ventitre anni fa: non ha l'aria dell'eroe, sembra un uomo distrutto,
piange. Il pregio del filmato è proprio quello di offrire prospettive diverse,
molto personali. Ci sono i racconti di tutti gli uomini chiave della prima fase
di Tangentopoli, i protagonisti rimasti nell'ombra che ricordano metodi e
trucchi investigativi: il capitano dei carabinieri Roberto Zuliani e i due
poliziotti Giancarlo Spadoni e Rocco Stragapede, veri factotum di Antonio Di
Pietro. L'avanzata dell'indagine verso il cuore del potere viene narrata con
ritmo e chiarezza. Forse per questo tra le righe emerge il dilemma più
importante di quella stagione, ossia il ruolo che ha avuto nella vita italiana
Bettino Craxi. Viene riproposto un documento unico: l'intervista televisiva in
cui il leader socialista dà del “mariuolo” a Chiesa. «Mi preoccupo di creare le
condizioni perché il paese abbia un governo in grado di affrontare le condizioni
difficili che abbiamo davanti e mi ritrovo un mariuolo che getta un'ombra su
tutta l'immagine di un partito che a Milano in cinquant'anni non ha avuto un
amministratore condannato per reati gravi contro la pubblica amministrazione». È
un momento decisivo, che incrina il silenzio di Mario Chiesa: dopo tre mesi
tutti gli amministratori socialisti milanesi e lombardi saranno sotto accusa.
Quelle parole sono state un errore tattico, che ha determinato una sconfitta
strategica. E nascevano dall'incapacità di Craxi nel fare i conti con la
situazione. Lo conferma Paolo Pillitteri, suo cognato ed ex sindaco di Milano:
«Conoscevo Di Pietro, aveva i classici modi del contadino furbo, io ero molto
preoccupato ed avevo ragione. Glielo dicevamo a Bettino. Lui non ascoltava: “Non
dovete preoccuparvi, è una cosa locale, si ferma lì”. Noi invece abbiamo capito
subito che l'inchiesta vuole espandersi: l'arresto di Chiesa era stato un colpo
di gong, lui lo sottovalutò». Il primo maggio 1992 sono proprio gli avvisi di
garanzia a Pillitteri e a Carlo Tognoli a rendere manifesta la portata
dell'istruttoria. Con qualcosa altro che l'uomo forte del Psi non riesce a
valutare: il meccanismo mediatico che si è innestato intorno ai magistrati di
Milano, sulla spinta soprattutto delle reti Mediaset, cementando il consenso
popolare verso i magistrati. «Un circo mediatico-giudiziario che non
conoscevano», ammette Pillitteri «e creava il mito di Di Pietro. Il pool diventa
un Olimpo che getta saette». Mentre invece le parole di Craxi non incutono più
timore. Quando si rende conto della minaccia e cerca di giocare il suo poker,
nei confronti di Di Pietro e degli altri partiti, non capisce che il tavolo è
cambiato. I messaggi trasversali contro il magistrato, anche quelli che si
riveleranno fondati, cadono nel nulla. Come accade all'avvertimento lanciato in
Parlamento il 3 luglio, con un discorso che viene riproposto in “1992 attacco al
potere”: «I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o
piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali e associative, e con
essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono
all’uso di risorse aggiuntive in forma irregolare od illegale.
Se gran parte di
questa materia deve essere considerata materia puramente criminale allora gran
parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno in
quest’aula, responsabile politico di organizzazioni importanti che possa alzarsi
e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo: presto o tardi
i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro». C'è una seconda parte
dell'intervento di Craxi che – depurata dagli attacchi del momento – sembra
mantenere un'attualità politica: l'appello al cambiamento delle regole prima che
gli illeciti distruggano la credibilità di tutti i partiti. «Un finanziamento
irregolare ed illegale al sistema politico, per quanto reazioni e giudizi
negativi possa comportare e per quante degenerazioni possa aver generato non è e
non può essere considerato ed utilizzato da nessuno come un esplosivo per far
saltare un sistema, per delegittimare una classe politica, per creare un clima
nel quale di certo non possono nascere né le correzioni che si impongono né
un’opera di risanamento efficace ma solo la disgregazione e l’avventura. A
questa situazione va ora posto un rimedio, anzi più di un rimedio. È
innanzitutto necessaria una nuova legge che regoli il finanziamento dei partiti
e che faccia tesoro dell’esperienza estremamente negativa di quella che l’ha
preceduta». Oggi le sovvenzioni pubbliche sono state abrogate e per questo il
problema della natura dei contributi privati alla vita politica è diventato
ancora più forte. Le indagini continuano negli ultimi mesi a evidenziare come in
questo settore non ci siano né controlli efficaci, né trasparenza. Questo – come
“l'Espresso” denuncia da mesi - riguarda soprattutto il canale lecito ma opaco
delle fondazioni, usate da esponenti di tutti i partiti per raccogliere soldi.
Nonostante accuse e sospetti siano crescenti, i segnali di riforma restano
deboli. Il Parlamento non sembra deciso a prendere iniziative concrete per
cambiare i meccanismi del finanziamento, con il rischio di sottovalutare la
rapidità del cambiamento. E ripetere gli errori del 1992.
Realtà e non fiction nel 1992 di History. Mani Pulite raccontata
da imprenditori e forze dell'ordine, scrive “L’Ansa”.
Non è il 1992 raccontato su Sky dall'acclamata serie con Stefano Accorsi, Miriam
Leone, Guido Caprino e Antonio Gerardi ma alla fine tra i titoli di coda non
apparirà l'avvertimento che "le storie narrate sono frutto della fantasia degli
autori" e "che qualsiasi collegamento con persone vissute e viventi è puramente
causale". La storia dell'anno che sconvolse il nostro Paese, che "dal sassolino
Mario Chiesa si trasformò in una frana inarrestabile", è raccontata senza filtro
e senza risparmiare sui particolari in "1992 - Attacco al potere", in onda
martedì 14 e 21 aprile alle 23.00 su History (canale 407 di Sky). E niente è
casuale, "rielaborato" e "romanzato". Sarà per questo che vedere, dopo venti
anni, l'imprenditore Luca Magni dalla cui denuncia partì "Mani Pulite"
raccontare, con il groppo alla gola e le lacrime agli occhi come se non fosse
passata che una manciata di minuti, la storia di quel giorno che sconvolse la
sua vita e quella dell'Italia intera vale forse più di una fiction. E sentire
dalla voce di Roberto Zuliani, capitano dei Carabinieri e nome in codice
"Giaguaro", tutti i particolari dell'irruzione nello studio di Mario Chiesa e
del suo arresto (anche il fatto che la storia delle mazzette gettate nel water è
una balla) tiene incollati allo schermo. Il valore aggiunto delle due puntate di
History infatti è proprio questo: i protagonisti non sono solo Chiesa, Antonio
Di Pietro e Bettino Craxi ma tutti le persone meno conosciute che stavano al
loro fianco e che svolsero un ruolo fondamentale in quei giorni, dai poliziotti
e dai carabinieri che eseguirono le perquisizioni e gli arresti agli
imprenditori che finirono al centro delle inchieste, dai giornalisti ai
fotografi. La vicenda è raccontata con ritmo incessante tra interviste
esclusive, materiale di repertorio inedito, ricostruzioni dei luoghi, delle
indagini e degli interrogatori. Ecco allora il Di Pietro che, come racconta
Filippo Facci all'epoca giornalista de L'Avanti, "faceva Di Pietro e cioè lo
sbirro, quello che aveva sempre fatto". Ecco il collaboratore Rocco Stragapede,
"la scatola nera" di Di Pietro, con cui il magistrato vive quasi in simbiosi e
si capisce al volo tanto da condurre assieme interrogatori "da far paura". E lo
spettatore, tenuto per mano da coloro vissero in prima linea quei giorni ma al
Tg non comparvero mai, non vede solo il Di Pietro conosciuto ma può sbirciare
nella sua sala degli interrogatori, dove lui siede sulla sedia al rovescio e
appoggia sulla scrivania montagne di fascicoli gonfi come a dire "Caro indagato,
noi di lei sappiamo tutto!". Se qualcuno aprisse quei fascicoli, ci troverebbe
solo giornali vecchi ma il bluff regge alla grande. Oppure può scoprire che
quando era pensieroso o preoccupato il magistrato di tirava giù i calzettoni e
si grattava i polpacci per ore. O come racconta Giancarlo Spadoni, investigatore
della Procura di Milano che era il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene ed
riuscito a inculcare alla sua squadra "un metodo di lavoro, legato
all'organizzazione e all'informatica, che non aveva uguali in Italia".
"1992", l'anno che cambiò l'Italia. Sky
mette in onda la fiction su Tangentopoli di Giuseppe Gagliardi, ideata da
Stefano Accorsi. In scena la sconfitta dei vecchi partiti e la strategia dell’ex
Cavaliere. Mentre la sinistra si rivela solo una comparsa, scrive Marco Damilano
su “L’Espresso”. C’è, nelle prime scene di “1992”, l’immagine delle banconote
che galleggiano nella tazza del cesso, i pezzi da centomila lire con Caravaggio
che tornano su dallo scarico, come un rigurgito nella coscienza collettiva. I
soldi, in quei primi anni Novanta, erano ancora qualcosa di fisico. Si
toccavano, si annusavano, si buttavano via. Dalla finestra, per esempio: una
sera d’estate gli abitanti del quartiere romano Flaminio avevano visto planare
come aeroplanini di carta banconote per tredici milioni di lire, una mazzetta
gettata dalla moglie di un notabile dc. E nel water: la tangente da 37 milioni
che il pomeriggio del 17 febbraio 1992 l’ingegner Mario Chiesa, il socialista
presidente del milanese Pio Albergo Trivulzio, cerca di far sparire mentre i
carabinieri bussano alla porta. Era un lunedì, l’inizio di una settimana di
routine per il burocrate della tangente, invece crollò un sistema durato
decenni. E quel colpo di sciacquone equivale allo sparo di Sarajevo che portò
all’estinzione gli Imperi invincibili della Prima Repubblica, i democristiani, i
socialisti. La fine della belle époque dei partiti. E l’annuncio del Nuovo.
Prodotta da Wildside e diretta da Giuseppe Gagliardi (Tatanka) da una idea di
Stefano Accorsi, debutta il 24 marzo in prima TV su Sky Atlantic HD e in
contemporanea su Sky Cinema 1 HD la fiction 1992, diretta da Giuseppe Gagliardi,
da un'idea di Stefano Accorsi e sceneggiata da Alessandro Fabbri, Ludovica
Rampoldi e Stefano Sardo. Sullo schermo, personaggi immaginari insieme ai
protagonisti della cronaca politica. Arrivano in tv (dal 24 marzo 2015 su Sky
Atlantic Hd) le dieci puntate della fiction sull’anno che cambiò l’Italia, il
1992 di Tangentopoli. La calata nel Parlamento romano dei barbari della Lega, il
pool Mani Pulite di Antonio Di Pietro, la fine di Bettino Craxi, le stragi di
mafia. E l’embrione dell’avventura politica di Silvio Berlusconi. Un anno
ricostruito dal regista Giuseppe Gagliardi nei dettagli: cravatte, pettinature,
trasmissioni (“Non è la Rai”), i pesantissimi cellulari. Volti famosi e storie
sconosciute: la scelta narrativa degli sceneggiatori Alessandro Fabbri, Ludovica
Rampoldi, Stefano Sardo è affiancare personaggi di fantasia a quelli reali (il
pm Di Pietro, Francesco Saverio Borrelli, Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo,
Marcello Dell’Utri, Umberto Bossi). «Abbiamo seguito la lezione di James
Ellroy», spiega Lorenzo Mieli, il produttore della fiction con Wildside.
«Mescolare la finzione con la realtà, i fatti della cronaca con le trame e i
ricatti invisibili al cittadino e allo spettatore». “1992” è il nostro Italian
Tabloid, in una Milano notturna, cupa, livida, una Gotham City in cui i vecchi
potenti si aggirano da padroni e invece sono già morti, e i buoni non esistono.
L’ideatore della serie è Stefano Accorsi, classe 1971, segnato come tutti i suoi
coetanei da quei dodici mesi spartiacque: «Volevo capire cosa è successo
quell’anno. E raccontare quella parte d’Italia che ha vinto, nel segno
dell’ambiguità. In questa storia non ci sono personaggi giusti». L’attore sta
girando l’Italia in teatro con il “Decamerone” di Boccaccio in cui interpreta
Panfilo, sempre attuale: «Giorno non passa che novello scandalo scalza lo
precedente... E li cittadini onesti smarriscon così fede e orgoglio di civica
appartenenza e vien loro meno, speranza e fiducioso attendimento nel domani». In
“1992” è Leonardo Notte, pubblicitario di successo, arrogante, spregiudicato,
ansioso di consumare il presente per far dimenticare un passato che continua a
tormentarlo. «Gli anni Ottanta sono finiti!», avverte durante una convention al
cospetto di Dell’Utri. «E la crisi è un’opportunità». Per questo sarà incaricato
dal presidente di Publitalia di studiare cosa si muove nel profondo della
società. Chi rappresenterà il Nuovo quando i vecchi politici saranno spazzati
via. Chi farà la scalata. A rileggere i testimoni più lucidi di allora si
avverte il senso della Fine in arrivo. «La classe politica italiana sembra
assoggettarsi a due spinte esattamente opposte, l’istinto di conservazione e
un’oscura volontà di auto-annientamento», aveva scritto Edmondo Berselli sul
“Mulino” nell’autunno 1991. Nella campagna elettorale del 1992, l’ultima dei
partiti della Prima Repubblica, il Psi aveva girato un docufilm sul suo
segretario Bettino Craxi, candidato a tornare a Palazzo Chigi. Ma i primi piani
avevano rivelato un uomo stanco, lontano dal Capo che aveva interpretato la
modernità per un decennio. «Va a finire che ci fa una migliore figura chi ha
avuto l’accortezza di farsi riprendere da lontano, come Berlusconi, seduto di
sbieco al pianoforte, bello come Julio Iglesias», commentò profetico Emanuele
Pirella sull’“Espresso”. «All’elettore vien più voglia di votare Berlusconi che
quell’affaticata comparsa di Craxi». In “1992” il passaggio dal vecchio
al nuovo è confuso e feroce, come ogni trapasso. Scandito dagli homines novi
, i vincenti di “1992”. I magistrati, i leghisti. Berlusconi. «Ognuno è
rappresentato da un personaggio, un avatar che incarna la loro ossessione, la
spinge all’estremo», spiega Mieli. Pietro Bosco, interpretato da Guido Caprino,
è un reduce della guerra nel Golfo che si ritrova eletto per caso deputato della
Lega, catapultato sul palcoscenico di Roma ladrona, tra gli intrighi, le
trappole, le seduzioni della Capitale. Gli fa schifo la politica, entra
sbandierando il “tutti a casa”, la sua irriducibile diversità rispetto agli
uomini del potere in blu ministeriale, e invece ci cade dentro, fino in fondo.
Luca Pastore (Domenico Diele) è un agente di polizia giudiziaria che lavora con
Antonio Di Pietro, mosso da una sete di giustizia, anzi, di vendetta verso un
industriale che gli ha distrutto la vita. Veronica Castello (Miriam Leone) vuole
lavorare in tv, a “Domenica In”, a qualsiasi costo. L’ansia di cambiamento, di
fare piazza pulita. La sete di giustizia che si trasforma in desiderio di
vendetta, di purificazione. La brama di una vita in “prime time”. Questioni
private che intrecciano le pulsioni profonde della società italiana degli anni
Novanta, disposta ad auto-assolversi, dimenticare e a ricominciare.
«L’elettorato non è moderato, è smodato, arrapato», grida Leo Notte, in questo
stato nascente, di disperata vitalità, in cui tutto cambia e tutto è necessario
prendere, cavalcare, afferrare, come l’Occasione di cui parla Machiavelli nel
“Principe”, «senza quella occasione la virtù dell’animo loro si saria spenta».
«Per lui il movimento è una condizione essenziale per sopravvivere. Era un
estremista, si è trasformato in un pubblicitario senza smettere di essere contro
il sistema, lo status quo», lo descrive Accorsi. «Il suo credo è lo stesso che
canta Manuel Agnelli degli Afterhours: “Io maledico il modo in cui sono fatto/
Il mio modo di morire sano e salvo dove m’attacco”. Riesce sempre a farla
franca, a morire sano e salvo». Come vorrebbero fare molti italiani nel 1992,
pronti a buttarsi nella nuova avventura. La sinistra compare in una sola scena,
è un pallido candidato alla Camera del Pds di Achille Occhetto, impaurito come
la sua giacchetta marrone. Ma non c’è sinistra e non c’è alternativa,
nell’Italia del 1992 e forse anche in questa. La corruzione c’è ancora, da
Milano a Palermo. E se degli uomini nuovi di allora è già nota la parabola, le
speranze bruciate, la rivoluzione giudiziaria immeschinita nei partitini
personali degli ex pm, la Lega bossiana divorata dalle mollezze romane,
Berlusconi che appare come un’ombra di luce già spenta, lo spettatore è colto
dall’inquietudine di immaginare, in un’altra fase di cambiamento, che fine
faranno gli uomini nuovi di oggi che gridano al tutti a casa e alla rottamazione
del passato, la loro scalata al potere, famelica di illusioni. Nell’inizio è già
visibile la fine. Qualcosa di familiare.
Padri, figli, corrotti e magistrati. La fiction (non manichea)
sul ’92, scrive Mattia Feltri su “La Stampa”. John
Wayne non c’è. Nessun giustiziere solitario, nessun supereroe spuntato dal
retrobottega della nostra coscienza a riscattare gli umili e offesi. Non
aspettatevi inquadrature di metaforici calci di fucile segnati di tacche a ogni
potente abbattuto, intanto che la vecchietta o il ragazzino o il padre di
famiglia risollevano la testa dalla polvere. Non è la biografia agiografica o
problematica di un Tonino Di Pietro né quella collettiva di un pool che vediamo
oggi, venti anni dopo, nelle foto di gruppo mentre avanza con lo sguardo che
punta lontano, involontario e caricaturale nuovo Quarto stato di Pellizza da
Volpedo, la serie di cui la prima puntata va in onda su SkyAtlantic, non è -
nella sintesi che migliore non ci riesce - la storia di Mani pulite ma la storia
di Tangentopoli, e cioè non è la storia del drappello di pm bensì la storia di
come eravamo, noi abitanti della città delle mazzette. Una bella sorpresa: due
decenni e tre anni dopo quel 17 febbraio - giorno dell’arresto di Mario Chiesa e
inizio della fine della Prima repubblica - qualcuno è stato capace di ricacciare
il secchio in quei complicati mesi senza attingere a retorica settaria. Non ci
sono i buoni contro i cattivi. Non è il bene contro il male. I politici rubavano
e furono presi con le mani nel sacco, e non erano né mostri né perseguitati. I
magistrati indagavano con le timorose prudenze del contesto, espresse dal
procuratore capo Francesco Saverio Borrelli che trattiene Di Pietro: «Per
puntare in alto ci vogliono le spalle coperte». È un Di Pietro a cui luccicano
gli occhi alla vista di cinque lettere stampate sul giornale - «Craxi» - perché
è lì che vuole arrivare, introduzione a una giustizia redentrice che prima trova
i colpevoli e poi le notizie di reato. E però non è questo il punto. Davvero non
contano né Di Pietro né Borrelli né Craxi né Chiesa, conta molto di più tutto
ciò che lì dentro c’è di fiction. I personaggi storici sono colonne del tempio
dentro cui si muovono i personaggi di fantasia, i veri protagonisti, il
ragazzone rientrato dalla guerra del Golfo senza un’idea di sé e del suo futuro
che salva un capoccia leghista dall’aggressione di due albanesi, sarà candidato
al Parlamento, salirà sul palco a urlare salivante che è ora di finirla adesso
basta, «adesso tocca a noi», e tanto basta al nuovo entusiasmo: e lui poi va a
liquidare il padre: «Presto avrò una casa quattro volte questa». C’è il
collaboratore della procura determinato a incastrare l’imprenditore corrotto per
una questione personale, pur di raccattare le prove violerà domicili, ingannerà
ragazzine, minaccerà a mano armata e troverà la giornalista cui girare (di
nascosto) le informazioni buone per gli scoop e per la fama degli inquirenti.
C’è il giovane berlusconiano (Stefano Accorsi, ideatore della serie)
collaboratore di Marcello Dell’Utri che per vendere la pubblicità a un
inserzionista indeciso gli spiega che «la gente là fuori è orribile», si tratta
soltanto di assecondarla: non diseducarla o traviarla, assecondarla. C’è tutto
il nostro mondo, la ragazza che per la carriera in tv si concede a chi la
piglia, i padri boriosi che non capiscono i figli, i figli tossici che mandano
al diavolo i padri, la gente maleducata e velenosa, i grandi attici delle grandi
baldorie, i miserabili appartamenti di miserabili rancori, c’è persino
l’insegnante delle medie che salverà il mondo liberando i piedi dalla
costrizione delle scarpe. Ricordate che niente è definitivo, i peggiori
diventeranno i migliori, i pessimi risultati saranno prodotto delle buone
intenzioni: è il festival molto credibile, compreso qualche inevitabile eccesso
parodistico, dell’ambiguità morale che fa parte della nostra vita e della buona
scrittura che la racconta.
Di Pietro: “Questa è fiction, Mani pulite invece è storia”.
“1992” vista con l’ex pm: non dice come provarono a fermarci, scrive Paolo
Colonnello su “La Stampa”. Già alla prima inquadratura, si preoccupa: «Oh, ma
non è che quello lì con le chiappe all’aria sono io?». Lo «Zanza», anzi, lo
«Zanzone» come Antonio Di Pietro veniva chiamato dagli allora giovani cronisti
di Mani Pulite a significare la scaltrezza e la furbizia contadina, si accomoda
sul divano. Chiede un caffè, ride di gusto: «Ah, no, meno male, non sono io…
Eccomi, eccomi! C’è perfino il gilet bordeaux che usavo allora». Panoramica
sulla Milano da bere: i rampanti di Publitalia, l’attricetta che si fa
raccomandare, le ragazzine di Boncompagni, i ristoranti e la rucola: «Era così
ma non per tutti: c’era chi se la godeva, chi faceva affari, chi faceva
carriera…Io indagavo, ricordi?». E come dimenticarselo: 1992, un anno infernale.
Prima puntata di un ventennio che sembra non aver mai fine. «Se si confronta
un’informativa del ‘93 che feci insieme a Davigo sulla corruzione con quella che
hanno fatto su Incalza adesso, ritrovi molti degli stessi nomi». Un po’ più
stanco, più affaticato, l’avvocato Di Pietro 23 anni dopo ammette di non avere
più grandi aspirazioni: «Sindaco di Milano? Ma con quale partito? E poi…». E
poi? «Prima che finisca la serie in tivù, lo dico subito: se c’è un errore che
non rifarei, è quello di mettermi in politica. Mannaggia... Ho 65 anni e devo
dire che un po’ li sento». Di Pietro è ansioso di vedere la fiction. Non mangia,
non beve, un asceta. Passa la prima scena di sesso e si sfila gli occhiali:
«Prendo atto, però non mi pare necessaria…». Però il sesso è sempre stato un
orpello fondamentale del potere. «Vero. Ma, se interessa, vorrei dire che
durante la nostra inchiesta non abbiamo mai utilizzato il gossip per scoprire le
tangenti». Certo è strano per un’inchiesta che nacque anche grazie alla causa
di separazione tra l’ex presidente della Baggina, Mario Chiesa, e la sua ex
moglie, Laura Sala. «Si, ma non ci fu bisogno di intercettazioni. Chiedemmo di
poter vedere gli atti della separazione, poi lei ci parlò dei conti in Svizzera,
“Levissima” e “Fiuggi”. Quando dissi a Chiesa che l’acqua minerale era finita,
lui capì al volo e crollò. Fu l’inizio della fine». Alla scena dell’arresto di
Mario Chiesa, lo «Zanza» chiede di mettere in pausa: «Non è vero che andò in
bagno per buttare altri soldi. Quella storia la raccontò dopo una settimana e si
riferiva a un’altra mazzetta di un altro imprenditore…». Osserva divertito
l’ufficio del suo pool investigativo: «Seee… magari avessimo avuto tutto quello
spazio!». È colpito dal rampante di Publitalia interpretato da Stefano Accorsi,
chiamato da Marcello Dell’Utri a fondare Forza Italia: «Bisogna dire che
Dell’Utri che racconta la storia della Repubblica delle Banane è convincente.
Grazie a Berlusconi stiamo comprando banane ancora adesso. La differenza è che
mo’ ci stanno tanti berluschini». E i «dipietrini»? «Anche quelli sono stati un
problema. Mani Pulite iniziò ad affondare per la nascita dei tanti dipietrini
d’Italia che senza avere una visione d’insieme del “sistema”, indagavano
chiedendoci gli atti per competenza». Davvero Craxi all’inizio era un tabù? «Ma
quando mai. Per noi Craxi all’inizio non era un problema. Cioè, sapevo, avendo
visto come si era comportato in precedenza, che si sarebbe potuti arrivare a
lui, ma davvero nell’inchiesta il suo nome non esisteva. Il “Cinghialone”, come
lo chiamavate voi, era ancora lontano dalle carte…». Alla fine, rimane deluso:
«Qui mi sembra che Mani Pulite sia solo uno sfondo, una scusa per raccontare
altro». Emozioni? «Nessuna, io ho vissuto una realtà che mi ha riempito
abbastanza. Mi basterebbe che qualcuno un giorno scrivesse come hanno cercato di
delegittimarmi in tutti i modi… Non c’azzeccava niente. Speriamo nella storia,
questa è solo fiction».
«Ma quali escort? Non andò così» Segni contesta la fiction
«1992». La ricostruzione tv sugli anni di Tangentopoli
e le critiche di uno dei protagonisti di allora, scrive Renato Bendetto su Il
Corriere della Sera”. Nell’ultimo episodio di 1992 , la serie tv di Sky sugli
anni di Tangentopoli, Mario Segni appare scandalizzato. È rappresentato al
tavolo di un ristorante: discute di politica e di possibili intese con alcuni
uomini di Publitalia (la discesa in campo di Berlusconi in prima persona è di là
da venire). Arrivano Olga, Irina e Katarina, tre prostitute ingaggiate per
«siglare l’intesa». Segni si alza e se ne va indignato. A differenza del
personaggio della serie, Mario Segni, quello vero, martedì sera non si è alzato,
è rimasto davanti alla tv a guardare la puntata. Ma era scandalizzato: «Sono
indignato. Hanno mistificato la realtà». Segni è stato tra i protagonisti
(quando da deputato lasciò la Dc dopo il successo del referendum per il
maggioritario) della stagione politica raccontata da 1992 . Nulla di strano che
il suo nome compaia nella serie di Sky, che mescola personaggi reali e di
fantasia e racconta una storia di fiction nel contesto(reale) di Mani pulite:
Dell’Utri lo vuole sondare come possibile leader di una «casa dei moderati»; a
trattare c’è Leonardo Notte (Stefano Accorsi), protagonista della fiction, uomo
marketing del Biscione incaricato del dossier politico. Notte e Segni sono
insieme al ristorante: il deputato ex dc è indeciso sul dolce («vorrei una
mousse, anzi no, una crostata. Aspetti... abbia pazienza. Ho cambiato idea... mi
porti il menu»). Notte taglia corto: «Il dolce lo offre la casa». Arrivano le
prostitute e l’intesa fallisce. Notte dirà a Dell’Utri: «Ci ha messo mezz’ora
solo per scegliere il dolce, Segni non va da nessuna parte». «Possibile che si
debba ridurre tutto a una volgare pochade?», si chiede Segni, quello vero, dopo
aver visto la puntata. «I rapporti tra movimento referendario e la nascita di
Forza Italia sono parte di una storia più complessa, che ha inizio con l’offerta
di alleanza di Berlusconi e si conclude con il mio rifiuto. Una storia politica,
non fatta di prostitute. I contatti furono diretti», specifica. E di quella
scena smentisce tutto. A cominciare dall’anno: non fu il 1992. «Il primo
contatto con Berlusconi fu a casa di Gianni Letta, nell’ottobre del 1993: al
tavolo c’erano Berlusconi e Confalonieri». E nessuna prostituta russa. In
effetti quella di Sky è una fiction: «Anche se ispirate a fatti realmente
accaduti le storie narrate sono frutto della fantasia degli autori», è
chiaramente espresso all’inizio di ogni puntata di 1992 . Per Segni, «va bene
mescolare realtà e finzione, ma quando nomi e cognomi sono quelli... Non puoi
raccontare falsità e attribuirle a una persona specifica».
La serie tv su Tangentopoli. E Di Pietro pontifica in tv.
Grazie a una fiction l'Italia prova a fare i conti con il proprio turbolento
passato, con una classe politica spazzata via da un'inchiesta della
magistratura, scrive Orlando Sacchelli su “Il Giornale”. Parte "1992", la serie
tv di Sky dedicata a Tangentopoli e all'inchiesta che spazzò via un'intera
classe politica. Fiction e realtà, sapientemente mescolati, suddivisi su dieci
episodi. Un'operazione culturale oltre che "cinematografica". Perché non è solo
una delle tante serie tv. Parla di un periodo su cui il nostro Paese ancora non
ha fatto pienamente i conti. Ci sono stati i processi e le sentenze. E i
cambiamenti politici che da esso sono derivati. Ma ci sono ancora tante
omissioni. Il compito di mettere mano alla vicenda e inquadrarla nel modo
migliore possibile tocca agli storici. Non può essere altrimenti. La tv fa
spettacolo, anche se può offrire spunti di riflessione interessanti. E non
bisogna dimenticare che, essendo prodotta da noi italiani (e venduta
all'estero), la serie fornisce una chiave di lettura del nostro Paese a chi ci
vedrà (e giudicherà) oltreconfine. La tesi che da una parte i politici fossero
tutti ladri, e dall'altra, invece, ci fossero solo brave persone, che mai e poi
mai si erano macchiate del reato di finanziamento illecito ai partiti, a
distanza di ventitre anni si può considerare superata. E non solo perché Bettino
Craxi lo disse in parlamento (e poi in tribunale a Milano). I bilanci dei
partiti depositati in parlamento erano tutti (o quasi) farlocchi e chi doveva
controllare non lo faceva. Così erano anche i soldi dall'estero e quello delle
imprese che finanziavano la politica. Si è andati avanti così per oltre
quarantacinque anni. Poi due amnistie hanno cancellato tutti i reati (fino al
1989) e da allora in poi si sono creati i presupposti (penali) per lo scoppio
dello scandalo, esploso, com'è noto, il 17 febbraio 1992, con l'arresto di Mario
Chiesa. Uno dei protagonisti dell'epoca, Antonio Di Pietro, impazza su giornali
e tv. "Del film ho preso atto, quando ho saputo che lo stavano facendo -
racconta Di Pietro a Sky Tg24 Pomeriggio -. La realtà l’avevo già vissuta e mi
darete atto che già la realtà era davvero un film. Chi in quegli anni ha visto
evolversi giorno dopo giorno l’inchiesta di Mani pulite ha visto un drammatico
film di una storia italiana. Che poi, voglio dire, è come se stessimo sfogliando
i giornali di questi giorni", dice l’ex pubblico ministero. "Prima
dell’inchiesta Mani pulite - prosegue - a Milano ci furono molte inchieste
contro la pubblica amministrazione. Quel sistema, all’interno della procura di
Milano, lo avevamo ben individuato. Il problema delicato era sul piano
processuale: la corruzione è un reato a concorso necessario, bisognava scoprire
sia l’atto d’ufficio fatto per fare piacere a qualcuno, sia i soldi o l’utilità
corrisposti: nel reato di corruzione si era puniti in due. L’inchiesta di Mani
pulite ha permesso di scoprire casi in cui gli imprenditori non erano
corruttori, ma subivano una tangente che non volevano subire. È stata una chiave
di lettura che ci ha permesso di aprire quella scatola, ma come era fatta la
scatola lo sapevamo già allora e purtroppo lo sappiamo ancora oggi". Per il
lancio della serie Sky ha dato voce a diversi protagonisti dell'epoca:
soprattutto politici e giornalisti. Oggi, accanto a Di Pietro, ha avuto spazio e
voce anche Claudio Martelli, ex ministro del Psi e braccio destro, per anni, di
Craxi. A lui il compito (arduo) di dare voce agli "sconfitti". "È stato fatto un
lavoro monumentale di documentazione - dice Stefano Accorsi, ideatore e
interprete di 1992 - ma il lavoro più prezioso è stato quello fatto dagli
sceneggiatori per tenere fuori tutto quello che si è detto di Mani pulite nei 20
anni successivi e tutelare nel racconto la realtà dell’epoca, con lo stupore di
fronte alla prima grande inchiesta sui vertici politici ed imprenditoriali e la
speranza di cambiamento. L’idea di questa serie - prosegue - è nata nel 2011,
pensando al fatto che erano passati quasi vent’anni da quegli avvenimenti senza
che nessuno li avesse raccontati in tv". Tangentopoli è ormai lontana nel tempo.
Ventitre anni sono tanti e i protagonisti, salvo rare eccezioni, sono spariti
dalla scena. Qualcuno prova a riaffacciarsi (vedi Di Pietro). Altri, come l'ex
pm Gherardo Colombo, scrivono libri (Lettera a un figlio su Mani pulite)
tentando di spiegare ai giovani cosa accadde in quel periodo. La stessa
operazione la fa la tv con la serie di Accorsi. Vedremo con quali risultati.
Sesso, soldi e potere ma quante lacune in 1992, la serie tv su
Mani pulite. La fiction "1992" parla dell'inchiesta
Mani pulite e delle vicende che portarono alla fine della Prima Repubblica. Poca
politica e si vede subito che nel "mirino" c'è Berlusconi, scrive Orlando
Sacchelli su "Il Giornale". Si parte subito in quarta, con lo spettacolare
arresto di Mario Chiesa. Del resto non poteva essere altrimenti. Tangentopoli è
iniziata da lì, dal Pio Albergo Trivulzio, noto ai milanesi come la "Baggina",
l'istituto di ricovero per anziani a cui capo c'era l'esponente socialista.
Chiesa intasca una mazzetta, gli inquirenti ascoltano tutto grazie a una
microspia e irrompono nel suo ufficio. A nulla servono le scuse di Chiesa e del
suo avvocato. Le banconote sono siglate, una ad una, e fotocopiate. Non si
scappa. La tangente, pagata dall'imprenditore Luca Magni (sette milioni di lire,
la prima di due rate, per un appalto complessivo di 140 milioni), dà il via
all'inchiesta passata alla storia come "Mani pulite". Nasce Tangentopoli e, nel
giro di pochi mesi, un'intera classe politica crollerà sotto i colpi della
magistratura. La serie tv di Sky "1992" inizia così, con Antonio Di Pietro
subito protagonista. Al centro della storia ci sono sei persone comuni, la cui
vita si intreccia con il terremoto politico, civile e sociale innescato dalla
maxi inchiesta. I personaggi di fantasia si muovono in parallelo a quelli reali.
Questo per permettere agli autori un certo margine di libertà nello sviluppo
della storia, che corre lungo i binari della realtà. Nelle prime due puntate
trasmesse da Sky vengono subito ben tratteggiati i protagonisti: Leonardo Notte
(Stefano Accorsi), rampante pubblicitario esperto di marketing, che lavora per
Publitalia; il poliziotto Luca Pastore (Domenico Diele), che entra a far parte
del pool di Mani pulite proprio quando inizia l'inchiesta; Bibi Mainaghi (Tea
Falco), figlia viziata di un imprenditore milanese colluso con la politica;
Veronica Castello (Miriam Leone), bella showgirl disposta a ogni compromesso pur
di sfondare in tv; Pietro Bosco, ex militare rientrato dall'Iraq, che inizia
un'avventura politica militando nella nascente Lega Nord. Accanto a loro ci sono
i protagonisti reali, a partire da Antonio Di Pietro (interpretato da Antonio
Gerardi), Piercamillo Davigo (Natalino Balasso), Francesco Saverio Borrelli
(Giuseppe Cederna), Gherardo Colombo (Pietro Ragusa). Tra i personaggi veri c'è
anche Marcello Dell'Utri (Fabrizio Contri), che fin dall'inizio apprezza le doti
di Notte. Il racconto ha ritmo e gli attori sono bravi. Belle le musiche, tutte
rigorosamente di quel periodo ("Non amarmi", di Aleandro Baldi e Francesca
Alotta, "Everybody hurts" dei Rem), interessanti gli spezzoni dei tg dell'epoca.
Ma a chi non ha vissuto quel periodo o letto qualcosa, questa serie fornirà
qualche informazione utile per capire cosa è stata davvero Tangentopoli? Secondo
noi no. Del resto non c'era d'aspettarsi troppo: si tratta di fiction non di un
documentario e tantomeno di un approfondimento storico. In "1992" si capisce che
si vuole andare a parare in una certa direzione. Il messaggio viene messo in
bocca a Dell'Utri, che parlando con il rampante Notte (Accorsi) senza mezzi
termini gli indica il suo obiettivo, con un mix tra spregiudicata filosofia
politica e marketing: "Bisogna salvare la Repubblica delle banane". E il
riferimento non è tanto all'impresa (Publitalia) quanto alla politica, la nuova
formazione che dà lì a pochi mesi vedrà la luce. Per il resto c'è molta
superficialità e una grande banalizzazione. Siamo solo alle prime due puntate ed
è probabile che, grazie ai personaggi di fantasia, la serie vivrà un crescendo
di emozioni e colpi di scena. C'è da sperarlo. Perché se dovessimo limitare il
giudizio alla prima parte della storia, la delusione sarebbe grande. E non
perché sappiamo già come va a finire. La politica vera si vede solo sullo
sfondo: nei manifesti elettorali, nei comizi di Umberto Bossi e poco altro.
Tutto qua? Chi ha visto House of cards sa come si può trattare
l'argomento in una serie tv. Fiction, sì, ma con molta più sostanza. Tutta
un'altra cosa rispetto a 1992. Forse il problema, per la serie ideata da
Accorsi, è che si dovevano fare i conti con la realtà. E si è preferito
limitarsi ai cliché.
Continua "1992 La serie": poco scandalo Tangentopoli e tanto
anti-berlusconismo. Tutto ruotava intorno alla figura
di Silvio Berlusconi come personaggio più desiderato dagli italiani? Troppo
difficile da credere. O troppo facile, scrive Carola Parisi su “Il Giornale”.
Giù la maschera. 1992 La Serie non parla di Tangentopoli. E dispiace,
perché le premesse per un buon prodotto c’erano tutte. Ma la seduzione e la
tentazione di trasformare il racconto di quello che fu uno dei momenti più
imbarazzanti e confusi di questo Paese, in una velata critica a Silvio
Berlusconi, a Fininvest e alla ancora non nata Forza Italia, era troppo forte.
Si può capire che un certo salotto non abbia voglia di accedere a nuove chiavi
di lettura. Che siano anche solo quelle della storia. Stupisce che sia quello
stesso salotto che ama pavoneggiarsi al grido di: "Io la televisione non la
guardo, preferisco un buon libro". "Qui mi sembra che Mani Pulite sia solo uno
sfondo, una scusa per raccontare altro". Sono proprio le parole di Antonio Di
Pietro, protagonista, in qualità di magistrato, e anima dello scandalo di
Tangentopoli, a descrivere una ricostruzione filmica poco corrispondente alla
realtà. Facile, facilissimo, farsi coccolare dalle braccia sicure
dell’anti-berlusconismo. Ma è stata davvero Publitalia, con la sua fitta
schiera di manager spietati, assassini, ex comunisti da banda armata e amanti
dei ménage à trois nelle vasche idromassaggio, il centro della vita dell’Italia
nel 1992? Tutto ruotava intorno alla figura di Silvio Berlusconi come
personaggio più desiderato dagli italiani? Troppo difficile da credere. O troppo
facile. Ed è Stefano Accorsi nei panni di Notte a portarsi sulle spalle tanta
responsabilità. Lui è l’emblema di una politica vuota, partorita a tavolino tra
slogan e marketing. Priva di contenuti. E questo sarebbe uno spaccato dello
scandalo Tangentopoli? Sul finale della quarta puntata, Miriam Leone che
interpreta Veronica, ambiziosa amante di Michele Mainaghi, imprenditore che
decide di togliersi la vita dopo essere stato coinvolto nell’inchiesta Mani
Pulite (ed anche nella triste vicenda della vendita di sangue infetto), disposta
a tutto per ottenere un programma in tv, dopo una telefonata di raccomandazione
a Berlusconi, bussa alla porta del Cavaliere. Ultima spiaggia per fare carriera
in tv. Il rimando è chiaro e davvero poco velato, ma, oltre a strappare qualche
facile ghigno, è uno scivolone banale per chi vorrebbe raccontare l’Italia che
si delineò dopo l’arresto di Mario Chiesa. Eppure, la produzione è stata
elogiata nel resto d’Europa. All’indomani del debutto al Festival di Berlino, ad
esempio, il Frankfurter Allgemeine Zeitung ha applaudito 1992: "Raramente
un paese ha il coraggio di guardarsi allo specchio come in questo caso". Sì, gli
specchi di legno.
1992, un alieno chiamato Silvio Berlusconi:
la serie mostra con coraggio la carica rivoluzionaria del Cavaliere, scrive di
Francesco Borgonovo su “Libero Quotidiano”. C’è un’antipatia sottile e diffusa
nei confronti di Stefano Accorsi. La frase «da un’idea di Stefano Accorsi»,
utilizzata da Sky per la promozione della serie 1992, è diventata un hashtag su
Twitter, ovviamente per sfottere. Certo, ormai ci sono i libri di storia,
Accorsi mica si è inventato l’epoca di Tangentopoli. Però non basta un cretino
qualsiasi per ideare un prodotto come quello che sta andando in onda sulla pay
tv. Lo dimostra il fatto che, tanto da destra quanto da sinistra, sono arrivate
parecchie critiche. Ed è facile immaginare che tante altre ne arriveranno a
breve, quando la figura di Silvio Berlusconi diventerà sempre più presente nella
serie. Si può discutere fin che si vuole sull’accuratezza e sull’attendibilità
storica di 1992, ma ci sono qualità che emergono oltre ogni ragionevole dubbio.
Tanto per cominciare, è scritta benissimo. Leonardo Notte, il pubblicitario
interpretato dallo stesso Accorsi, è un personaggio denso, sfaccettato. Il
cognome e il fatto che vesta spesso di nero dovrebbero caratterizzarlo come una
figura negativa, ma la faccenda è più complessa. Notte ha dei tratti demoniaci,
è un Grande Seduttore, nonché un uomo che ha adattato i propri ideali all’epoca
in cui vive. Dall’Autonomia Operaia bolognese è passato a Publitalia. Un
percorso che hanno fatto in parecchi - sotto forme diverse, se vogliamo - in
questo Paese. A Notte interessano i soldi, le donne, in parte anche il potere.
Ma tutti i personaggi della serie sono così. La bellezza di 1992 sta nel fatto
che non ci sono dietrologie o letture politicamente orientate. Emergono gli
uomini e le loro brame. Ciascun protagonista è mosso da ambizioni personali. Di
Pietro viene ripetutamente accusato di puntare soltanto a Bettino Craxi, di
esserne ossessionato, di volerlo inchiodare con ogni mezzo, a costo di abusare
della carcerazione preventiva (cosa che gli viene rinfacciata e che lui non
smentisce). I personaggi fittizi che si agitano nel Palazzo di Giustizia di
Milano sono spinti chi dal desiderio di vendetta, chi dalla necessità di
racimolare soldi. In qualche modo, sono tutti «cattivi». Leonardo Notte, oltre
all’egoismo, manifesta anche un enorme talento. Nel suo mestiere è una specie di
genio, un Dottor House (o un Don Draper di Mad Men). Soprattutto, capisce per
primo quali sono le potenzialità «politiche» del Cavaliere. Una delle scene più
belle è quella in cui il politico democristiano e quello socialista - entrambi
contattati da Marcello Dell’Utri perché lo aiutino a capire in che direzione va
la corrente a Roma e dintorni - si trovano a tavola con Mariotto Segni. Vogliono
chiedergli se ha intenzione di diventare il nuovo leader dei «moderati». Verso
la fine della cena, ecco comparire Notte. Si siede a tavola e gli basta un
dettaglio per capire che Segni non ha futuro: Mariotto non riesce a decidere se
ordinare una mousse o un altro dolce, continua a cambiare idea. Uno così, non
può andare da nessuna parte. Notte, con l’ausilio di tre escort russe, lo fa
indispettire e manda a monte l’incontro. Questo perché ha capito la portata
rivoluzionaria di Berlusconi. Dopo una convention (introdotta da Massimo Boldi,
quello vero) esce sul balcone a fumare una sigaretta e guarda il cielo assieme a
una collega. Parlano di Ufo. «Stasera c’è stato un avvistamento», dice. Si
riferisce al Cavaliere, che ha tenuto un discorso. Proprio perché si tratta di
una serie tv e non di un saggio storico, a emergere dal racconto di 1992 sono
gli uomini. Quella che si tenta, semmai, è un’analisi antropologica. A un certo
punto si riporta una frase di Formentini secondo cui gli uomini di Berlusconi
sarebbero un esercito di plastica. Ed ecco che la camera scorre inquadrando la
coda alla mensa di Publitalia: una sfilata di acconciature diverse ma simili.
Appare un tipo umano unico, con minime variazioni. Ecco il lato negativo
dell’antropologia berlusconiana. Ma c’è anche quello positivo: la carica
sovversiva del «sogno», la spinta del cambiamento in un Paese soffocato,
annichilito. Berlusconi è presentato appunto come un alieno che può portare un
vento fresco in un Palazzo pieno di dinosauri. Questa ricerca di qualcosa di
diverso, di uno scossone, pervade tutte le puntate della serie, con i suoi lati
oscuri e le sue lame di luce. A molti non piacerà, perché dopo tutto il
Cavaliere rappresenta ancora l’incarnazione del Male. Ma l’affresco dell’Italia
è vivido, affascinante. 1992 è un prodotto ambizioso, a tratti letterario. Sarà
anche un’idea di Accorsi, ma è una buona idea. Talmente buona che, come spesso
capita alle opere di valore, parla del passato e sembra mettere in scena il
presente. Con quel pizzico di speranze in più che, ventitrè anni fa, almeno
c’erano.
1992, Mediaset contro Sky: "Quella fiction ci danneggia".
Mediaset contro Sky. Oggetto del contendere: la fiction della tv di Murdoch su
Mani Pulite. S'intitola "1992" e ricostruisce la storia di Tangentopoli,
ma la storia così com'è stata messa in scena non è piaciuta affatto ai vertici
del Biscione. Paolo Liguori, volto storico di Mediaset, su Il Giornale
sottolinea come la fiction abbia falsificato le origini del concorrente.
"Un'operazione di propaganda che non bada a spese a uso dei soliti nemici di
Berlusconi". Sotto accusa la grande divisione tra buoni e cattivi: "Si qua Di
Pietro e Mani Puliti, di là i corrotti, i partiti, Dell'Utri e Publitalia. Falso
enorme perfino nei particolari: la Lega non è nata dopo l'arresto di Mario
Chiesa e le televisioni Fininvest, come tutti ricordano, furono in prima linea
davanti al Tribunale di Milano". Non piace, quindi, questa ricostruzione
considerata troppo "di parte", un'ennesima occasione per attaccare l'acerrimo
nemico Silvio.
Scrive Filippo Facci su “Libero Quotidiano”: il Di Pietro da
fiction non la racconta giusta. Elencare “quello che
manca” in un film o in una fiction è facile e comodo, ci si possono riempire i
libri: non è un caso che gli autori della serie «1992» (Sky,
cominciata martedì scorso) si siano paraculati premettendo che «ogni riferimento
a fatti accaduti» eccetera eccetera. Messa così, però, è facile e comodo anche
per gli autori: perché i riferimenti a fatti accaduti ci sono eccome, con nomi e
cognomi, e il prodotto è stato venduto all’estero con pretese storicizzanti.
Alcuni personaggi di pura fantasia quindi vanno benissimo (poi possono piacere o
meno) e altri personaggi sospesi tra fantasia e cronaca già sono discutibili: va
bene anche questo, e infatti sono gli episodi pretesa aderenza con la realtà a
lasciare un po’ così. Si può trasvolare sul dettaglio che lo svincolo
autostradale Bologna-Borgo Panigale non c’era (non così) e che pure non esisteva
un determinato modello di frigorifero. Si può ritenere imprescindibile che il
grattacielo del Pirellone nella fiction appaia già ristrutturato (post incidente
aereo del 2002) e che gli spot pubblicitari con la prima campagna ministeriale
sull’Aids (quella con le sagome contornate di viola) risalga in realtà all’anno
prima, al 1991, come pure la versione del programma «Avanzi» in cui si vedono
Serena Dandini e Corrado Guzzanti. Fa niente anche per un divano di design che
non era ancora stato disegnato, e pace anche se ormai non c’è scena milanese -
ambientata in un bar - che non abbia per location la solita Belle Aurore di via
Castelmorrone, sempre quella, due palle: oltretutto lo spacciano come bar vicino
al tribunale anche se dista più di sei chilometri. E, oltretutto, nella fiction
si vede un ufficiale di polizia giudiziaria che paga e se ne va senza scontrino.
1) Però, egregi autori, verso la fine della seconda puntata compare un mandato
d’arresto che sembra disegnato al computer da un bambino: non sono fatti così, a
esser precisi non erano neanche più d’arresto: erano i famigerati ordini di
custodia cautelare. Nota: quegli interrogatori di gruppo coi tavolini uno
affianco all’altro, seriali e con Di Pietro direttore d’orchestra, beh, non
esistono e sono ridicoli.
2) Al di là di possibili inesattezze già evidenziate da Mario Chiesa circa il
proprio arresto («non esiste nessun verbale che attesti la leggenda della
tangente gettata nel water», ha detto) qui non si vuole segnalare
un’imprecisione: tuttavia le modalità di quell’arresto, riviste oggi, fanno
comunque comprendere quanto fosse diverso l’atteggiamento della magistratura a
proposito della custodia cautelare. In Mani pulite, una sola chiamata in
correità basterà per incarcerare chicchessia, ma prima di essa Antonio Di Pietro
non si fece bastare la confessione di Luca Magni e neppure le intercettazioni
telefoniche: predispose banconote segnate (in realtà solo una ogni dieci) e poi
microfono e persino una telecamera che non funzionò. Solo allora arrestò Chiesa.
3) Nella fiction si vede un Di Pietro che garantisce riservatezza alla moglie di
Mario Chiesa qualora l’avesse aiutato a individuare i conti in Svizzera dell’ex
marito. A parte che fu lei a rivelarne l’esistenza agli inquirenti, Di Pietro in
realtà la fece attendere per ore e ore in corridoio: e questo proprio per farla
vedere ai giornalisti perché scrivessero di lei, cosicché l’ex marito
intendesse.
4) A un certo punto un improbabile Di Pietro dice che il processo per
direttissima a Mario Chiesa «ho deciso di non farlo». Non andò proprio così, Di
Pietro infatti mica poteva decidere diversamente da qualcosa che il suo
procuratore capo aveva già annunciato. L’ha raccontato Di Pietro stesso: «Mani
pulite s’è fatta perché io - sì, io e solo io -, diciamo per sbaglio,
“dimenticai” di depositare gli atti nei tempi prescritti per la
direttissima...Borrelli aveva dato pubblicamente l’indicazione di depositare gli
atti...erano in vista le elezioni del ’92, la tensione montava... A quel punto,
io non ho la forza di dire al dottor Borrelli che non lo faccio perché voglio
arrivare a un obiettivo preciso; e allora “mi sbaglio”». Borrelli a suo modo ha
confermato: «Non immaginavo che dall’arresto di Chiesa potesse nascere quello
che è nato, ma credo che non l’immaginasse nessuno. Non l’immaginava certamente
Di Pietro».
5) Non c’è cronaca e sentenza ma soprattutto logica che porti a sostenere che
Marcello Dell’Utri abbia pensato d’inventarsi un soggetto politico sin
dall’inizio del 1992. Non quando arrestarono Chiesa (l’arresto fu a lungo
snobbato) e neanche dopo le elezioni del 5 aprile 1992, che segnò certo un
crollo storico della Dc ma perdite minime per il Psi, grande sponsor di
Berlusconi. Le cui tv, va ricordato, sin da principio diedero manforte
all’inchiesta. È vero che la Lega superò i 3 milioni di voti (quasi il 9 per
cento) anche se fanno vedere che un tizio viene candidato quando le liste erano
senz’altro già chiuse.
6) Qualche pignoleria. A un certo punto inquadrano il programma «Non è la Rai»
trasmesso su Italiauno, ma al tempo andava in onda su Canale 5: passerà a
Italiauno solo dal gennaio 1993. Il termine «cinghialone» riferito a Craxi, o
cinghiale, non fu di Di Pietro, ma dei cronisti; comparve per la prima volta su
l’Indipendente. In un baracchino vicino al Castello Sforzesco si vedono in
vedita delle bottigliette di Gatorade che non esistevano. Sciocchezzuola finale:
nella fiction si dice che la scuola steineriana «è una delle più care di
Milano». Non è vero per niente. Siccome il riferimento è chiaramente ai figli di
Berlusconi, andrebbe aggiunto che la sezione scolastica del caso era a Lambrate,
e nasceva da una scissione dalla storica scuola steineriana di via Clericetti;
era così malmessa che Veronica Berlusconi mandò personalmente degli imbianchini
a mettere in ordine le aule.
Bene, ora siamo pronti per le puntate successive.
Tangentopoli:la storia scritta dai vincitori
scrive Tiziana Maiolo su “Il Garantista”. Il 1992 mi evoca subito il numero 41,
i quarantuno morti suicidi di Tangentopoli, che non hanno potuto scrivere la
Storia per ovvie ragioni, ma anche perché la Storia la scrivono i vincitori, e
loro erano i vinti. La storia dei Vinti è rimossa con fastidio, dopo che uno dei
Pubblici Ministeri di Milano, Gerardo D’Ambrosio, aveva sentenziato, non senza
un certo cinismo: «Evidentemente c’è ancora qualcuno che ha il senso
dell’onore». Non un dubbio sul fatto che il circo mediatico-giudiziario del
disonore che era stato cucito addosso a colpevoli e innocenti sia stato il vero
assassino, che ha colpito con violenza la reputazione e la vita di persone che
non avevano nessuna possibilità di difendersi, incarcerati, disorientati e
sbeffeggiati. Ma dalla parte dei trionfatori, che in occasione della fiction di
Sky invadono ogni angolo del pianeta della comunicazione, la storia è stata
raccontata come il puro trionfo del Bene sul Male, un gruppo di
magistrati-guerrieri senza macchia in lotta contro una classe politica corrotta
che ammorbava l’intera società. Sulla scialuppa degli onesti erano saliti ben
presto imprenditori in lacrime, giornalisti-coccodè, uomini politici con le
tasche traboccanti di rubli, avvocati-accompagnatori alleati del Pubblici
Ministeri. Ma la storia di Tangentopoli potrebbe anche essere raccontata come
vera Storia Politica, come vicenda che segnò il trionfo massimo di una giustizia
di parte, che ebbe come protagonisti magistrati politicizzati e un eroe
tutt’altro che “senza macchia”. Che vide complici con le toghe innanzi tutto
quegli imprenditori che avevano ben lucrato sul finanziamento illegale ai
partiti, a tutti i partiti, e che mai se ne erano lamentati, finché l’arresto di
otto di loro fece rendere conveniente agli altri immaginare di esser stati
sfruttati. Sono gli stessi che, proprietari di giornali, decisero la campagna
del Grande Sputtanamento degli uomini politici, quelli sconvenienti, i non
allineati. Quelli che si salvarono dal carcere ripudiando se stessi e la propria
storia e accoltellando quelli che erano stati i loro benefattori. La vacca non
dava più latte. Non c’era più pane e loro scelsero le brioches. Il girotondo
intorno ai protagonisti principali, magistrati e imprenditori, era fatto di
avvocati di grandi e piccoli studi, che salivano festosi, ma in ginocchio, le
scale fino al quarto piano del Palazzo di giustizia tenendo per mano i proprio
assistiti pronti all’autodafè, mentre il Di Pietro di turno li riceveva in
ciabatte, rideva e agitava manette. Quelli bravi, quelli amici, riuscivano a
salvare l’assistito dal carcere e ne venivano ricompensati. In vario modo e da
diverse parti. Avevano dimenticato il codice a casa, molti di questi avvocati,
badavano al sodo e basta. C’erano poi i giornalisti-coccodè, i cronisti
giudiziari che ogni mattina fiutavano la preda, giovani entusiasti che
indossavano con orgoglio la maglietta che inneggiava all’eroe di Mani Pulite,
lavoravano in pool e non tornavano mai in redazione a mani vuote, con il
carniere pieno di verbali d’interrogatorio ( non erano ancora di moda le
intercettazioni ), sicuri che avrebbe apprezzato il direttore, ma soprattutto
l’editore, lo stesso che tremava se il campanello di casa suonava troppo presto
il mattino. I fiaccolanti forse erano i più innocenti, cittadini che facevano il
girotondo intorno al Palazzo, nella speranza-illusione che qualcosa cambiasse.
Ma non c’erano solo loro, c’era un po’ di tutto, in quelle manifestazioni,
compresi i cinici di nuovi movimenti politici che volevano solo sostituirsi agli
altri, e anche quelli che erano sulla scialuppa di salvataggio, comunisti e
democristiani di sinistra che si erano finanziati come gli altri, ma che si
erano opportunamente alleati ai magistrati. Una folla di indifferenti, mentre
ogni giorno saltavano le regole dello Stato di diritto, mentre veniva calpestata
la Costituzione, mentre si violavano le competenze territoriali, la libertà
personale e i diritti della difesa. Mentre si usava il carcere come tortura per
far parlare la gente. Mentre si uccideva. Tanto la Storia la scrivono i
vincitori, anche alle spalle dei quarantuno che non ci sono più.
Caro Pietro, servirebbero altri cent’anni…,
scrive Piero Sansonetti il 30 marzo 2015 su “Il Garantista”. «Ti
romperemo le ossa». Giorgio Amendola sibilò questa frase nell’orecchio di
Pietro Ingrao, passandogli vicino nella sala dove si celebrava l’XI congresso
del Pci, nel 1966. E non era un modo di dire. Nei mesi successivi Pietro Ingrao
e tutti gli ingraiani furono emarginati, esclusi dalla vita politica del gruppo
dirigente del Pci, del quale erano stati l’anima. «Ti romperemo le ossa»
è una frase agghiacciante, specie se pronunciata da un grande intellettuale,
comunista e borghese. Che fosse una frase metaforica non cambia molto, e dice
invece molto su cosa fosse esattamente il Pci post-togliattiano, impasto di
stalinismo profondo, di conservatorismo, di burocrazia, eppure sempre sulla
breccia nella battaglia riformista. Oggi in Italia la sinistra non esiste più.
Nel senso letterale della parola. Resta in piedi solo questo tentativo di
Maurizio Landini, che però più che altro è un tentativo estremo di difesa, di
resistenza. Di difesa dal renzismo. Il renzismo nasce nelle aree del
centrosinistra ma si è strutturato come il più serio, robusto e insidioso
tentativo di restaurazione classica, conservatrice e di destra. Il partito di
Renzi è il partito di massa più di destra che abbia mai operato dalla caduta del
fascismo ad oggi. Cos’è che ha spinto così a destra Renzi? L’assenza della
sinistra. Renzi non è un leader ideologico, è un amministratore della politica,
e non certo un creatore. Si è trovato a operare in un quadro nel quale la caduta
e la scomparsa della sinistra ha creato un’onda, o quasi uno tsunami, che spinge
tutto a destra, e lui ha seguito quest’onda, ha fatto surf. Quando è morta, in
Italia, la sinistra? Non saprei dire la data di morte. Posso dire qual è secondo
me la data nella quale iniziò l’agonia. È proprio il 1966, XI congresso del Pci.
E non solo. Il ’66 è l’anno successivo alla chiusura del Concilio ed è l’anno
che da alla luce le prime avvisaglie del ’68. È un anno di grande fermento a
sinistra. E l’XI congresso è il congresso nel quale il Pci decide come
proseguire il suo cammino dopo la scomparsa di Togliatti. Fa i conti con la
necessità di entrare nella modernità. Ma ha paura ad entrare nella modernità. Si
confrontano e si danno battaglia due ipotesi riformiste molto distanti l’una
dall’altra. La prima è quella di Amendola e del segretario Longo, i quali
pensano che il Pci debba restare dentro l’idea stalinista di sempre, e cioè la
convinzione che il fine della politica sia sempre e comunque e esclusivamente la
presa del potere. La via per il potere, in quel momento, era l’avvicinamento al
centrosinistra che, sebbene avesse subìto il colpo del ’64 (minacciato golpe
militare e alt alle riforme più ardite) restava un solco sul quale camminare, e
poteva essere condizionato da sinistra, e poteva, nei tempi medi, includere il
Pci nel governo. La seconda ipotesi era quella di Ingrao, che pensava che si
dovesse mettere in discussione il modello liberista, come si configurava allora,
e che questo fosse possibile sfruttando la forza innovativa e ribelle che veniva
dalle nuove generazioni e dal mondo cattolico, spaccando lo schieramento
politico dell’establishment e offrendo al paese una modernità nella
discontinuità. Ingrao immaginava il ’68, che ancora non era venuto, lo
prevedeva, cercava già di indicargli un sentiero politico. E per fare questo
poneva un’altra grande questione: la fine del centralismo democratico,
l’apertura della discussione libera, della ricerca, del dissenso dentro la
partito. Ingrao non era affatto un liberale. Qualche anno fa, l’ultima volta che
l’ho intervistato, non sono riuscito a fargli spendere qualche parola buona per
la “libertà borghese”, non lo interessava. Ingrao però ha sempre capito
che la libertà, un certo grado di libertà, è essenziale per aprire le porte al
pensiero e alla ricerca. E al dubbio. E Ingrao pensa che il pensiero, e la
ricerca, e il dubbio, siano l’essenziale della politica. Per questo, Ingrao,
l’uomo che più si identificava con la storia e la vita del Pci, secondo me, non
ha mai avuto niente a che fare con il Pci. E’ la verità: niente a che fare con
il Pci. Ingrao fu sconfitto all’XI congresso e messo fuori dai giochi politici.
Il Pci restò il partito di Amendola, anche se poi fu chiamato Berlinguer a
governarlo. La libertà di pensiero e di dubbio fu bandita. E lo stalinismo
restò, temperato dalla burocrazia. La burocrazia diventò la chiave di tutto.
Cos’è la burocrazia, in politica? Un meccanismo che attenua, leva via gli
spigoli, addolcisce, e garantisce stabilità e strada dritta. È nemica degli
eccessi, è utile per cancellare gli orrori maggiori dello stalinismo, ma
soprattutto è nemica del pensiero, dell’anticonformismo. Il Pci è stato il
partito regno della burocrazia. Cosa poteva farci, Pietro Ingrao, nel Pci?
Domani compie cent’anni. Un secolo di battaglie politiche grandiose. Con questo
cruccio: spesso ha avuto ragione, molte volte ha avuto paura, sempre ha perso. E
con un grande cruccio per noi: se avesse vinto all’XI, e se in Italia fosse nata
una sinistra anti-liberista e libertaria, che avesse tenuto sulla corda le
classi dirigenti, non avesse accettato la subalternità al pensiero dominante, la
storia d’Italia sarebbe stata diversa? In Italia quella sinistra, che è l’unica
che può vivere nella modernità, non è mai nata. Ci portiamo ancora appresso la
sconfitta dell’XI.
DA QUALE PULPITO VIEN LA PREDICA. CORRUZIONE NEL CUORE DELLO
STATO E DELLA SOCIETA' CIVILE.
Corruzione nel cuore dello Stato. Solo
alla Difesa 130 dipendenti sotto accusa. Al Mef c'è chi si porta via pure i
timbri. Nel giro di due anni hanno subito provvedimenti disciplinari per reati
penali anche 800 dipendenti della Guardia di Finanza. Neppure la Presidenza del
Consiglio e il Consiglio di Stato sono immuni. Ecco la radiografia degli
illeciti nelle istituzioni che non avete mai letto. E l'Anac corre ai ripari:
dipendenti onesti, segnalate a noi, scrive Thomas Mackinson su “Il Fatto
Quotidiano”. Al Tesoro c’è chi si porta via pure i timbri. Se parlare di 60
miliardi l’anno quasi non impressiona più, si possono però citare i 130
dipendenti della Difesa per i quali nel giro di due anni l’amministrazione ha
avviato procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti. Certo potevano
essere anche di più, visto che l’amministrazione conta 31.589 dipendenti tra
militari e civili. Fatto sta che tra il 2013 e il 2014 per 109 di loro è
scattata la sospensione cautelare dal servizio con privazione della
retribuzione, cinque sono stati licenziati in tronco. A cercare bene si scopre
che neppure la Presidenza del Consiglio, coi suoi 3.382 dipendenti, è immune
agli illeciti: negli ultimi due anni Palazzo Chigi ha dovuto vedersela con un
dirigente accusato di peculato e sei procedimenti disciplinari legati a vicende
penali, una delle quali per rivelazione di segreto d’ufficio. Nel frattempo al
Ministero dell’Economia e Finanze si sono registrati 15 casi su 11.507
dipendenti, compreso quello che s’è portato a casa i timbri dell’ufficio, e vai
a sapere per farne cosa.
La mappa anche le guardie fanno i ladri. Pillole da una casistica che disegna
una inedita “mappa della corruzione” nelle amministrazioni che sono il cuore
dello Stato. La si ottiene analizzando una per una le “relazioni annuali
sull’attività anticorruzione” che i funzionari responsabili della prevenzione
delle amministrazioni pubbliche devono predisporre entro il 31 dicembre di ogni
anno, così come previsto dalla legge Severino (n.190/2012), le norme in fatto
pubblicità e trasparenza (decreto n. 33/2013) e le successive “disposizioni
sulla condotta per i pubblici dipendenti” (n. 62/2013). Prescrizioni cui ha
contribuito in maniera importante l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac),
fornendo le linee guida del Piano nazionale anticorruzione, elaborando schemi
operativi e modelli organizzativi e operativi per le amministrazioni e
predisposto formulari destinati alla raccolta, gestione e diffusione dei dati
nei piani triennali delle singole PA. Un articolato sistema di prevenzione e
contrasto che – visti i numeri – sembra ancora insufficiente a contenere un
fenomeno che si consuma prevalentemente nelle amministrazioni statali. Il
bubbone, infatti, è tutto lì, come certificano le 341 sentenze pronunciate negli
ultimi 10 anni dalla Corte dei Conti per casi di corruzione e concussione: il
62% ha riguardato i dipendenti dello Stato, a pari merito col 12% quelli dei
comuni, sanità, enti previdenziali e assistenziali. Residuali, al momento, i
reati che riguardano province, regioni e università. Dunque il problema è nel
cuore dello Stato. E la tendenza non sembra cambiare, anzi. Dai documenti
aggiornati a dicembre si apprende anzi di amministrazioni che hanno visto
raddoppiare gli episodi di illecito penale nel giro di un anno. Al Ministero per
i Beni culturali ad esempio erano stati 12 nel 2013, nel 2014 sono stati 24.
Altri rapporti fanno intravedere la penetrazione verticale dell’inquinamento
corruttivo. Non fa gli argine, ad esempio, il Consiglio di Stato. Siamo in casa
di giudici, non ci si aspetterebbe che ladri e corrotti avessero dimora. Invece
su 869 dipendenti sono stati avviati 15 provvedimenti disciplinari per fatti
penalmente rilevanti, due sono terminati con il licenziamento. E che cosa
succede, allora, a casa delle guardie? La Finanza reprime gli illeciti. Ma molto
lavoro arriva direttamente dai suoi uffici, e su dimensioni di scala
impressionanti. La Gdf conta 433 dirigenti, 2.477 ufficiali, 56mila tra
ispettori, appuntati e finanzieri. Negli ultimi due anni le Fiamme Gialle hanno
avviato ben 783 procedimenti disciplinari per fatti penali a carico dei propri
dipendenti: 17 riguardano ufficiali, 766 personale non dirigente o direttivo.
Con quali effetti e sanzioni? Una degradazione generale: 658 sanzioni
disciplinari di corpo, 40 sospensioni disciplinari, 66 perdite di grado. Nota di
colore: nel cortocircuito tra guardie e ladri spunta anche il finanziere
“colluso con estranei per frodare la Finanza”. La via italiana
all’anticorruzione, visti questi, sembra ancora in salita. La difficoltà è
palese, avvertita e denunciata sia dall’interno degli uffici pubblici e sia
all’esterno, come in più occasioni ha segnalato la stessa Anac. I responsabili
della trasparenza lo dicono chiaramente: a due anni dalla legge che è il perno
delle politiche di contrasto al fenomeno, le amministrazioni non hanno poteri
effettivi, non ricevono risorse adeguate, devono muoversi in un quadro normativo
sempre più complesso e farraginoso che affastella leggi su leggi. Solo gli
obblighi di pubblicazione hanno raggiunto quota 270. “Un monitoraggio efficace è
difficilmente attuabile”, ammette Luigi Ferrara, da sei mesi responsabile
anticorruzione del Mef, “anche in considerazione del fatto che l’Amministrazione
non ha poteri d’indagine e che i terzi potenzialmente interessati sono molto
numerosi”. E abbiamo visto quanto.
Una macchina senza benzina. Che non va avanti. Il dito è puntato
sull’insufficienza di strumenti e risorse per debellare la natura pervasiva e
sistemica della corruzione. Si è fatto un gran parlare dei fondi per
l’authority, spesso centellinati in nome del risparmio. Per nulla di quelle che
servono alle amministrazioni per utilizzare gli strumenti via via codificati dal
legislatore per fare opera di prevenzione dall’interno. L’impressione, ammette
un funzionario, è che si vuol fare la guerra a parole, a costo zero. E questo
atteggiamento vanifica gli sforzi. Un esempio? Il personale individuato dalle
amministrazioni per vigilare sui settori a maggior rischio si sarebbe dovuto
formare “senza ulteriori oneri per lo Stato, nella Scuola superiore della
pubblica amministrazione”. Questo dice la legge 190. Ma quasi mai succede.
“Alcune misure e raccomandazioni, per lo più riferite alla Scuola Superiore
dell’economia e delle finanze, sono state superate a seguito della soppressione
della Scuola medesima”, fa notare con sottile ironia il responsabile
anticorruzione del Mef, Luigi Ferrara. L’Anac gli dà ragione, sottolineando come
il legislatore avesse assegnato alla formazione un ruolo essenziale, ma a
distanza di un anno era ancora “la tessera mancante del mosaico”. Tanto che le
attività progettate dalla Scuola nazionale dell’amministrazione “non si può dire
siano andate a regime”. A volte le carenze riguardano cose banali: “Mancano gli
applicativi informatici ad hoc per il supporto dell’attività di monitoraggio e
di attuazione delle misure anticorruzione”, mette a verbale il capo dipartimento
per la programmazione e la gestione delle risorse umane del Miur, Sabrina Bono.
Del resto, spiega, il nuovo complesso di norme che ha investito le
amministrazioni si scontra con la mancanza di personale dedicato. Per far
seguito agli impegni previsti dalla normativa anticorruzione la funzionaria si è
avvalsa di un dirigente e di due funzionari che “hanno svolto tali funzioni
congiuntamente ai compiti assegnati in ragione dell’ufficio d’appartenenza”. Uno
modo delicato per dire che non c’è personale da dedicare alla missione, a fronte
di un aumento esponenziale degli adempimenti. In questo quadro, l’invito a
ciascuna amministrazione a disegnare una propria politica di prevenzione rischia
di cadere nel vuoto.
L’authority chiama in causa la politica. Sono criticità ben note all’Anac che
negli anni ha lanciato più volte l’allarme sul rischio che le iniziative assunte
si traducano in un mero adempimento formale degli obblighi, senza effetti reali
sul malcostume nella cosa pubblica. Già nel primo anno di applicazione della
190/2012 l’Autorità chiamava in causa la politica e inviava al Parlamento una
durissima relazione: “Appare particolarmente problematica – si legge – la
constatazione che il livello politico non abbia mostrato particolare
determinazione e impegno”. La rampogna era diretta al legislatore che
affastellava leggi su leggi per spegnere l’incendio della corruzione salvo
dimenticarsi di aprire i rubinetti. Ma era rivolta anche ai vertici delle
amministrazioni pubbliche che all’invito a render conto delle proprie attività,
segnatamente in fatto di trasparenza, rispondevano alzando un muro di gomma.
Dopo un anno, per dire, solo l’8% dei ministeri si era premurata di indicare un
responsabile interno. Molte non trasmettevano i dati, altre non davano seguito
agli obblighi in materia di pubblicazione. Con la beffa finale, segnalata
direttamente da Cantone pochi mesi dopo, per cui – a fronte del quadro sopra
descritto – “la quasi totalità dei dirigenti pubblici ha conseguito una
valutazione non inferiore al 90% del livello massimo atteso”.
Quelle denunce mai fatte. Ecco l’ultima speranza. Il dato fa poi il paio con la
scarsa propensione dei dipendenti degli “uffici” a denunciare “fatti penalmente
rilevanti per i quali siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto
di lavoro”. Doveva essere la mina che fa saltare il sistema dall’interno, il
famoso whisteblowing di matrice anglosassone, tanto enfatizzato dai mezzi di
informazione all’indomani dell’approvazione della legge Severino. E quanti
“sussurrano”? Pochi, quasi nessuno. Le “Relazioni” dei responsabili
anticorruzione confermano che le segnalazioni si contano sulle dita di una mano
e che quasi mai arrivano da dentro gli uffici, nonostante la promessa protezione
contro rappresaglie e discriminazioni. Se ci sono, quasi sempre arrivano da
fuori. Esempi. La Difesa, con 30mila dipendenti, registra un solo caso che abbia
comportato una misura di tutela del segnalante. Il Ministero dell’Istruzione ha
4.223 dipendenti in servizio. Il responsabile anticorruzione nel suo rapporto
conferma che la procedura è attivata via mail. Quanti l’hanno usata in due anni?
Nessuno. Segno che il timore e l’omertà tengono ancora banco negli “uffici”. E
forse per questo lo scorso 9 gennaio l’Anac ha diramato una nota per segnalare
la propria competenza a ricevere segnalazioni.
Consiglieri, commessi e segretari. Ecco il Parlamento dei
parenti. La burocrazia più ricca di intrecci familiari
d’Italia? È quella delle Camere. Legami L’ex tesoriere della Margherita Lusi
aveva il fratello in Senato e il cognato alla Camera, scrive Sergio Rizzo “Il
Corriere della Sera”. Chi guarda con apprensione alla fusione fra le
amministrazioni di Camera e Senato, per possibili traumi o crisi di rigetto, si
può tranquillizzare. Il ruolo unico è già stato realizzato, con reciproca
soddisfazione, per via familiare. La recente nomina all’impegnativo incarico di
segretario generale di Montecitorio di Lucia Pagano, figlia dell’ex consigliere
della Camera Rodolfo Pagano e moglie del nuovo capo dell’informatica di Palazzo
Madama, Mauro Fioroni, ne è la certificazione più limpida. In Italia non esiste
burocrazia con intrecci parentali e dinastici così diffusi e profondi come in
quella del Parlamento. A tutti i livelli: da quelli più bassi ai più elevati. E
altri casi, oltre a quello di Lucia Pagano, rendono bene l’idea. Il suo vice
Aurelio Speziale, per esempio, è sposato con Gloria Abagnale, consigliere del
Senato. Giovanni Gifuni, consigliere della Camera, è figlio dell’ex potentissimo
segretario generale di Palazzo Madama Gaetano Gifuni. Mentre l’ex vicesegretario
generale della Camera Carlo Goracci è il papà di Alessandro Goracci, alto
funzionario del Senato. E se il padre di Ugo Zampetti, fino a qualche giorno fa
capo indiscusso della burocrazia di Montecitorio, era il responsabile della
biblioteca di Palazzo Madama, quello dell’attuale segretario generale del Senato
Elisabetta Serafin era solo un commesso. Commesso come anche il papà di Daniela
D’Ottavio, consigliera d’Aula. A dimostrazione del fatto che l’ascensore
sociale, fermo ormai ovunque, qui non è mai andato in manutenzione. «vietato»
Anche se qualche volta s’inceppa. Figlio di un ex consigliere della Camera,
Fabrizio Castaldi ne sarebbe diventato a 43 anni uno dei segretari generali più
giovani di sempre se la sua candidatura non fosse naufragata in extremis. Come
quella di Giacomo Lasorella, incidentalmente fratello della giornalista Rai
Carmen Lasorella. E quella del possibile terzo incomodo Costantino Rizzuto
Csaky, consorte di Maria Teresa Stella, consigliera della Camera al servizio
biblioteca. Parentela, quest’ultima, che ci riporta a un illustre caso del
passato. Fece scalpore, cinquant’anni orsono, il matrimonio fra Antonio
Michela-Zucco, nipote dell’omonimo inventore della rivoluzionaria macchina di
stenotipia, e Magda Sammartino. Erano entrambi stenografi del Senato e la cosa
venne considerata causa di incompatibilità. Per rimuoverla fu deciso il
trasferimento della moglie alla Camera. Dove Magda Sammartino fu protagonista di
una splendida carriera arrivando, prima donna nella storia, all’incarico di
vicesegretario generale. Ma erano altri tempi. i Oggi la presenza di coniugi
nelle stanze dei bottoni della stessa amministrazione non scandalizza più
davvero nessuno. Marito e moglie sono il capo servizio controllo parlamentare
Carlo Lomaglio e la direttrice dell’ufficio pubblicazioni della Camera Consuelo
Amato: figlia del magistrato ed ex capo dell’amministrazione penitenziaria
Nicolò Amato. Marito e moglie sono Stefano Cicconetti, dirigente di Montecitorio
ora in pensione, e la sua collega ancora in servizio Maria Teresa Calabrò:
figlia del potentissimo ex presidente del Tar Lazio e dell’Agcom Corrado
Calabrò. Marito e moglie sono Alessandro Palanza, ex vicesegretario generale
della Camera e la funzionaria Martina Mazzariol. Attualmente vicepresidente
della Fondazione Italiadecide di Luciano Violante, Palanza ha guidato a lungo
un’amministrazione nella quale aveva un ruolo di rilievo anche sua sorella Maria
Rita. Marito e moglie sono Pietro Calandra, alto dirigente del Senato poi finito
all’autorità di vigilanza dei lavori pubblici su indicazione del Pd e la
funzionaria di Palazzo Madama Stefania Boscaini. Ma si potrebbe andare avanti
chissà quanto, notando come il gioco degli intrecci e delle parentele non sia
limitato ai soli burocrati. Dice tutto quello intorno alla funzionaria della
Camera Giuliana Coppi. Figlia del principe del Foro Franco Coppi, legale di
Silvio Berlusconi, è sposata a sua volta con un altro avvocato. Non uno dei
tanti. Il suo nome è Pierantonio Zanettin, senatore di Forza Italia eletto al
consiglio superiore della magistratura in quota al partito di Berlusconi. Si
potrebbe anche ricordare come il vicesegretario della Camera Guido Letta sia il
nipote di Gianni Letta e cugino di Enrico Letta. Oppure che il funzionario del
Senato Luigi Ciaurro sia figlio dell’ex ministro liberale Gianfranco Ciaurro,
scomparso ormai quindici anni fa. O che Valentina Loiero, figlia dell’ex
governatore della Calabria Agazio Loiero, e Giulia Laganà, figlia dell’ex
parlamentare del Pd Tana De Zulueta, facciano parte dello staff della presidente
Laura Boldrini. La cui segreteria, peraltro, era stata per otto mesi guidata da
Marco Cerase, genero di Alberto Asor Rosa, prima che venisse trasferito ad altro
incarico per far posto all’astro emergente Castaldi. Come dimenticare poi che
l’ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi, ex senatore, aveva il fratello
direttore del servizio del Senato, mentre suo cognato Francesco Petricone è
funzionario della Camera? E che Cristiano Ceresani, un altro funzionario della
Camera già vicecapo legislativo di Gaetano Quagliariello e oggi addirittura capo
con il ministro Maria Elena Boschi, è il marito di Simona De Mita, quindi genero
dell’ex presidente del Consiglio e attuale sindaco di Nusco Ciriaco De Mita?
Più di 5 milioni di italiani con la tangente o la
raccomandazione, scrive Paolo Comi su “Il Garantista”.
C’è una ricerca del Censis, che è stata presentata a Roma, molto interessante su
svariati argomenti (la ricerca è sul rapporto tra mondo produttivo e pubblica
amministrazione) e che ci fornisce in particolare un dato sul quale sarà giusto
riflettere. Questo: quattro milioni e mezzo di italiani ammettono di avere fatto
ricorso a una raccomandazione per ottenere una maggior velocità (e un buon
esito) alle pratiche disperse nei meandri dell’amministrazione pubblica. E
addirittura 800 mila ammettono di avere fatto un regalino a dirigenti e
funzionari per avere in cambio un atto dovuto. Regalino, a occhio, è qualcosa di
simile alla tangente. Le cifre poi vanno lette bene. Se quattro milioni e mezzo
ammettono, è probabile che altri quattro milioni e mezzo non ammettono. E così
per gli 800 mila. Le cifre vere potrebbero essere 9 milioni di raccomandazioni e
un milione e seicentomila piccole tangenti. Se consideriamo che non tutta la
popolazione attiva (e cioè circa 40 milioni di persone) ha avuto bisogno di
velocizzare pratiche nella pubblica amministrazione (diciamo circa la metà)
otteniamo questo rapporto: su 20 milioni di persone che hanno avuto problemi con
la pubblica amministrazione, 9 milioni hanno fatto ricorso a una
raccomandazione, perché conoscevano qualcuno, un milione e seicentomila ha
pagato una tangente, altri 9 milioni e quattrocentomila se ne sono stati buoni
buoni in fila ad aspettare. E’ abbastanza divertente intrecciare questi dati coi
dati su coloro che chiedono più rigore, più pene, severità e ferocia contro la
corruzione. Corrotti, corruttori e ”punitori” di corruttori e corrotti, spesso,
sono la stessa persona. La ricerca del Censis ci consegna una realtà nitida e
incontrovertibile: almeno la metà degli italiani fa uso di forme soft di
corruzione. E le forme, probabilmente, sono soft perché non esistono le
possibilità che siano hard. Perché questi nove milioni non hanno né potere né
soldi. Naturalmente di fronte a questo dato si può dire: colpa dei politici che
danno il cattivo esempio. Beh, questa è una stupidaggine. Non c’è un problema di
cattivo esempio, perché anzi, da almeno vent’anni, i politici e i giornalisti e
tutti i rappresentanti delle classi dirigenti, delle professioni, dei mestieri e
della Chiesa, non fanno altro che indicare la corruzione come il peggiore dei
mali che ammorba la nostra società. Il problema è che spesso, gli stessi,
ricorrono in qualche modo alla corruzione e non si sentono per questo
incoerenti. Qualche caso un po’ clamoroso di ipocrisia è saltato fuori
recentemente dalla cronaca, fior di imprenditori antimafia e anticorruzione
presi con le mani nel sacco. La gran parte dei casi però non emerge. Potete star
sicuri, ad esempio, che una buona parte degli opinionisti, dei giornalisti e dei
politici che tutti i giorni si impancano e vi fanno la lezione di moralità,
qualche mancetta l’hanno lasciata, qualche pagamentino in nero lo hanno
accettato, qualche rimborso spese di troppo… L’altro giorno, in una intervista
divertentissima, il vecchio Pippo Baudo raccontava, sorridendo, di quando il
principe dei moralizzatori, Beppe Grillo, si faceva pagare dalla Rai il rimborso
spese per il soggiorno a Roma, se lo metteva in tasca, e poi andava a mangiare e
a dormire a casa di Pippo. Il vecchio Baudo se la rideva, e ha anche raccontato
di quel giorno che Beppe gli ha detto: «Magari, per sdebitarmi, lascio una
mancia alla Nena». La Nena era la donna di servizio di Baudo, e Baudo subito ha
detto a Beppe che gli pareva un’ottima cosa, e gli ha chiesto quanto pensava di
lasciarle. Grillo, vecchio genovese, ha risposto: «Che dici, cinquemila?». «Non
sarà troppo?, gli ha ribattuto, ironico, Pippo Baudo. E allora Grillo ha
sentenziato: «No, meno di 5000 no, allora è meglio niente». E non gli ha
lasciato niente… Così il rimborso se l’è preso tutto intero. Non sarà colpa
dell’esempio, ma comunque è colpa dei politici. La raccomandazione e la tangente
sono un frutto del modo nel quale è organizzata la vita pubblica. E i politici
di questo sono responsabili. La mancata trasparenza (nella pubblica
amministrazione come negli appalti) è la causa vera della corruzione. Perché la
rende possibile e perché la rende indispensabile. Però di tutto questo frega
poco a tutti. Prendiamo la questione degli appalti. E’ chiaro come l’acqua che
il sistema complicatissimo vigente (in Italia ci sono oltre 30 mila stazioni
appaltanti, e non si sa a chi rispondano, e non si sa chi decide, e ognuna
adopera criteri tutti suoi per valutare, e non sia sa chi e come può controllare
ed eventualmente indagare) consegna poteri discrezionali enormi a un certo
numero di persone e -spesso – ad alcuni politici. Che naturalmente esercitano
questo potere. Alcuni, meritoriamente, in modo onesto – ma perché sono
disperatamente onesti loro, incorruttibili – alcuni in modo meno onesto, o
comunque traendone qualche utilità. Moltissime volte l’appalto viene assegnato
senza gara. Altre volte col sistema del ribasso dei prezzi, che è un sistema
assurdo perché consegna un potere immenso a chi decide e presuppone un rapporto
forte e sregolatissimo tra impresa e stazione appaltante. Dovrebbe essere
abbastanza chiaro che, in seguito a una perizia seria, si può stabilire che
costruire in quel luogo una scuola con certe caratteristiche e di una certa
grandezza costa una cifra tot. Diciamo 10 milioni. L’appalto non può essere dato
a chi chiede meno. Se uno mi offre di fare quella scuola a 5 milioni, mi sta
fregando. O pensa di fare la scuola con la carta pesta, o pensa di farla piano
piano e che tra due anni chiederà una revisione prezzi e otterrà 15 milioni ( e
poi magari la farà lo stesso di carta pesta…). L’appalto deve essere concesso a
una cifra fissa all’azienda che da le maggiori garanzie. E da un numero
ridottissimo e quindi controllabile di stazioni appaltanti. Se fosse così
sarebbe molto difficile corrompere qualcuno. E la stessa cosa per le pratiche
della pubblica amministrazione. Vanno semplificate, spesso abolite,
deburocratizzate e risolte in tempi certi. Ottenere qualcosa del genere sarebbe
una riforma seria. Una riforma dello Stato molto, molto più utile e profonda
dell’abolizione del Senato e roba simile. Perché nessuno le chiede queste leggi?
Perchè la politica e l’intellettualità italiana sono nelle mani di un cerchio
magico (che si è costruito, trasversale, attorno al triumvirato Anm-Travaglio-
Salvini) il quale se ne frega delle riforme e chiede solo pene severe. Per loro
non contano le leggi, le idee, contano gli anni di carcere e basta. Adesso hanno
stabilito che la pena massima per la corruzione sale da otto o dieci anni. E
sono felici, e brindano, e sentono le manette tintinnare allegre. Riforma
forcaiola e inutile. Il problema non è di tenere un povero cristo in prigione
per due anni di più, il problema è di rendergli impossibile la corruzione. Ma
questa idea non piace a nessuno. Non piace a Salvini, non piace a Travaglio, non
piace all’Anm, non piace, probabilmente, neanche a Renzi, e nemmeno ai 4 o 9 o
10 milioni di italiani delle raccomandazioni e dei regalini. A loro piace solo
sapere che impiccheranno Lupi con una corda d’oro.
Repubblica
inetta, nazione corrotta, scrive Massimo Cacciari su “L’Espresso”. Nonostante
gli angeli vendicatori di Tangentopoli la corruzione dilaga ancora in Italia. E
la spiegazione si trova in Machiavelli: è l’incapacità di governare a produrre
malaffare e conflitti d’interessi. Corruzione, corrotti, corruttori. Non si
parla d’altro. Ma come? Non avevamo stretto un patto col destino dopo
Tangentopoli? Che mai più saremmo incorsi in simili peccati? Non erano discesi
dal Sinai eserciti di Di Pietro, con il loro seguito di angeli vendicatori? E
ancora non vi è chi tema le loro pene? Neppure i nipotini di Berlinguer e i
giovani scout? Nulla dunque può spezzare l’aurea catena che dalle origini della
patria va ai Mastellas e da lì ai Boccias, e abbraccia in sé destri e sinistri,
senes, viri et iuvenes? Ah, se invece di moraleggiare pedantemente, leggessimo i
padri! «Uno tristo cittadino non può male operare in una repubblica che non sia
corrotta» (Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, Libro III,
cap.8). Niccolò vedeva dall’Albergaccio meglio che noi ora da Montecitorio.
Tristi cittadini sempre ci saranno. Ma in una repubblica che non sia, essa,
corrotta, poco potranno nuocere e facilmente essere “esiliati”. Gli “ordini”
contano, le leggi, che non sono fatte dai giudici. Le leggi non cambiano la
natura umana, ma la possono governare. È la repubblica corrotta che
continuamente produce i corrotti. E quando una repubblica è corrotta? Quando è
inetta. Quando risulta impotente a dare un ordine alla molteplicità di interessi
che la compongono, quando non sa governare i conflitti, che sono la ragione
della sua stessa vita, ma li patisce e li insegue. Se è inetta a mutare in
relazione all’“occasione”, se è inetta a comprendere quali dei suoi ordini siano
da superare e quali nuovi da introdurre, allora è corrotta, cioè si corrompe e
alla fine si dissolverà. Corruzione è anzitutto impotenza. E impotenza è
incapacità di “deliberare”. Una repubblica strutturata in modo tale da rendere
impervio il processo delle decisioni, da rendere impossibile comprendere con
esattezza le responsabilità dei suoi diversi organi, una repubblica dove si è
costretti ogni volta alla “dannosissima via di mezzo” (sempre Niccolò docet),
alla continua “mescolanza” di ordini antichi e nuovi, per sopravvivere - è una
repubblica corrotta e cioè inetta, inetta e cioè corrotta. Ma quando questa
infelice repubblica darà il peggio di sé? Con megagalattiche ruberie da
Tangentopoli? Purtroppo no. Piuttosto (“banale” è il male), allorchè diviene
quasi naturale confondere il privato col pubblico, concepire il proprio ruolo
pubblico anche in funzione del proprio interesse privato. Magari senza violare
norma alcuna - appunto perché una repubblica corrotta in questo massimamente si
manifesta: nel non disporre di norme efficaci contro i “conflitti di interesse”,
di qualsiasi tipo essi siano. Una repubblica è corrotta quando chi la governa
può credere gli sia lecito perseguire impunemente il «bene particulare» nello
svolgimento del proprio ufficio. Che questo “bene” significhi mazzette, o essere
“umani” con amici e clienti, “essere regalati” di qualche appartamento,
manipolare posti nelle Asl o farsi le vacanze coi soldi del finanziamento
pubblico ai partiti, cambia dal punto di vista penale, ma nulla nella sostanza:
tutte prove della corruzione della repubblica. Poiché soltanto “il bene comune è
quello che fa grandi le città” (Discorsi, Libro II, cap.2). Il politico di
vocazione può riuscire nel difficile compito di tenerlo distinto sempre dal suo
privato. Il politico di mestiere, mai. Quello che si è messo alla prova nei
conflitti della repubblica senza corrompersi, può farcela. Il nominato, il
cooptato, che abbia cento anni o venti, mai. Ma abbiamo forse toccato il fondo.
E questo deve darci speranza. Per vedere tutta la virtù di Mosè, diceva Niccolò,
era necessaria tutta la miseria di Israele.
ALL’INIZIO FU
TANGENTOPOLI. L’ultimo bilancio dell’inchiesta mani pulite, condotta dal pool di
magistrati della procura di Milano, risale al febbraio del 1999. Anche perché da
allora la stessa inchiesta mani pulite può dirsi morta, mentre Tangentopoli
continua ad imperare. A sette anni dall’avvio delle indagini sulla corruzione
politica e finanziaria che va sotto il nome di Tangentopoli, cominciate il 17
febbraio 1992 con l’arresto di Mario Chiesa, il solo pool di Milano aveva
indagato 3.200 persone, aveva chiesto 2.575 rinvii a giudizio e aveva ottenuto
577 condanne, di cui 153 con sentenza passata in giudicato. Le statistiche ci
dicono ancora che fino alla fine 1997 la guardia di finanza aveva accertato
reati fiscali legati a Tangentopoli per un importo di 3.609 miliardi. Sono cifre
che bastano da sole a dare un’idea della diffusione in Italia del sistema della
corruzione che ha riguardato arricchimenti personali, ma anche e soprattutto
maniere illecite di finanziamento dei partiti mediante il sistema delle
tangenti, le cosiddette bustarelle, pagate da imprenditori ad esponenti
politici. Quello che le statistiche non possono però raccontarci riguarda i
criteri in base ai quali, non solo il pool di Milano, ha portato avanti queste
inchieste. Anche perché, pur essendo – per ammissione degli stessi magistrati
inquirenti - la corruzione estesa a tutti i partiti, nessuno escluso,
decapitando di fatto solo una parte della classe politica e permettendo ad
un’altra di salire al potere, l’inchiesta giudiziaria mani pulite ha avuto un
notevole impatto sugli assetti istituzionali del Paese.
Mose, ultimo
capitolo della tangentopoli della Seconda Repubblica. Da Bertolaso a Galan,
passando per Penati, scrive Pietro Salvatori su “L’Huffingtonpost” All’inizio fu
Tangentopoli. Una purga benefica per il sistema, dicevano. Qualcosa non deve
essere andato per il verso giusto se vent’anni dopo un pubblico ministero come
Carlo Nordio presenzia ad una conferenza stampa snocciolando parole come queste:
“Avendo trattato Tangentopoli 20 anni fa posso dire che gran parte della
corruzione scoperta oggi è simile e molti dei protagonisti sono gli stessi. Ma
questo è un sistema molto più sofisticato". Punto. Si riparte da Expo, Mose, la
cricca del G8, gli scandali milanesi, il “colpo di culo” del terremoto
abruzzese. Se è vero, come sosteneva Honoré de Balzac, che “la corruzione è
l’arma della mediocrità”, la grande aspirazione della classe politica emersa nel
post-Tangentopoli sarebbe dovuta essere quella di elevare la schiera dei
mediocri spazzati via dalle procure in un giardino di ottimati dai saldi
principi e dalla retta condotta. Non sembra essere andata così. Perché nel pieno
di una crisi economica di portata storica il ricorso alle Grandi opere
salvifiche è stata spesso la bandiera sotto la quale combattere per creare
occupazione, sviluppo e rivitalizzare una filiera produttiva in debito
d’ossigeno. Ma è indubbio che quella dei “big deal all’amatriciana” è sovente
stata un’etichetta latrice di operazioni opache, appalti pilotati, se non di
corruttele. Gli ultimi sono gli episodi che hanno visto trentacinque arresti
nell’ambito della realizzazione del Mose, il gigantesco sistema di paratoie
mobili che dovrebbe isolare Venezia dai rovesci delle maree. Trentacinque paia
di manette sono scattate ai polsi di altrettanti indagati. Tra questi figurano
l’azzurro Renato Chisso, assessore regionale ai Trasporti, il democratico
Giampietro Marchese, collega di Chisso in Regione, ma soprattutto Giorgio
Orsoni, sindaco Pd della città lagunare. I provvedimenti di custodia cautelare
sarebbero stati trentasei, se non che il berlusconiano Giancarlo Galan siede tra
i banchi della Camera, e per lui bisognerà attendere l’autorizzazione a
procedere da parte di Montecitorio. Quello delle fila di Forza Italia è uno
sfarinamento che va avanti da tempo. Per tacer del leader, le inchieste che
coinvolgono i fedelissimi dell’ex Cavaliere occupano da mesi le pagine della
cronaca giudiziaria: da Denis Verdini (sotto botta per la gestione del Credito
cooperativo fiorentino) a Marcello Dell’Utri (condannato per concorso esterno in
associazione mafiosa), passando per Claudio Scajola, arrestato per aver favorito
la latitanza dell’ex collega onorevole Amedeo Matacena. La vecchia guardia, si
dirà. Vero, ma solo in parte. Perché, a molte delle figure riemerse da un’epoca
che fu, si affiancano volti nuovi di una classe dirigente maturata dopo il 1994.
Prendiamo Orsoni. Fino alla metà degli anni zero ha guidato la società
ingegneristica dell’aeroporto di Venezia ed è stato consigliere di
amministrazione alla Biennale. La sua frequentazione con gli ambienti della
politica è tutto sommato residuale (tecnico al ministero dei Lavori pubblici dal
’96 al ’98, un’esperienza da assessore del capoluogo lagunare terminata nel
2005) fino al 2010. È quando la svolta fusionista veltroniana si è consumata da
tempo che viene individuato come volto nuovo, profilo da grand commis tecnico,
da presentare sul palcoscenico nazionale, lanciato nel 2010 verso la
polverizzazione dell’avversario di centrodestra, Renato Brunetta, e da innalzare
a guida Democratica di uno dei patrimoni storici dell’umanità. Sorte condivisa
da Giampietro Marchese, che, forte di una prima elezione in consiglio regionale
nel 2005, non ha ancora festeggiato il primo decennio con una targhetta di un
certo rilievo sulla porta dell’ufficio. Orsoni avrebbe ricevuto soldi per
finanziare la propria campagna elettorale, in cambio di “agevolazioni” ai suoi
co-imputati una volta eletto. Proprio da questo punto di vista, sono stati i
magistrati che indagano sull’altro grande scandalo delle ultime settimane,
quello che riguarda l’Expo 2015, a mettere in luce un paradigma delle inchieste
che hanno terremotato la politica del post-Tangentopoli. Mentre vent’anni fa ci
si sporcava le mani avendo come scopo principale quello di apportare benefici al
proprio partito, oggi a muoversi sono cupole ramificate che sì coltivano
rapporti con la politica o che ne fanno parte, ma che si mettono in moto per
tornaconto personale. Così se alla metà degli anni ’90 si poteva dare a Primo
Greganti il beneficio del dubbio che i soldi in nero fossero transitati per un
suo conto avendo come destinazione finale il sol dell’avvenire, oggi l’accusa è
quella che si sia mosso per intascarsi una bustarella degli appalti che tentava
di pilotare. Così come i suoi sodali tripartisan nella cricca che sguazzava
nelle ricche commesse dell’esposizione universale: l’ex democristiano
Gianstefano Frigerio, e l’ex senatore berlusconiano Luigi Grillo. Anche qui un
miscuglio di protagonisti datati di un’epoca che sembrava archiviata si unisce
senza soluzione di continuità a rampanti arrivisti dell’ultima ora, come il
responsabile dell’ufficio contratti Angelo Paris, che ha ammesso di aver
commesso alcuni dei presunti illeciti contestatigli “per la promessa di una
futura carriera”. La primogenitura della lunga serie di mani sporcatesi nel
tentativo di drenare parte del fiume di denaro diretto verso le grandi opere è
dell’uomo nuovo per eccellenza dell’epoca d’oro di Silvio Berlusconi, quel Guido
Bertolaso che ha guidato le sorti di mezza Italia da capo della Protezione
civile e sottosegretario della presidenza del Consiglio. Una carriera
folgorante, rimasta invischiata in un “sistema gelatinoso” che lo ha visto
coinvolto insieme ad Anemone e Balducci, accusati di aver distratto soldi
dall’organizzazione del G8 della Maddalena, dai cantieri messi in piedi per i
150 anni d’Italia e dall’allestimento dei mondiali di nuoto. Vecchi sistemi,
uomini e fini nuovi. Il trait d’union delle due epoche è quel Filippo Penati che
non ha conosciuto il carcere forse solamente perché la prescrizione è
intervenuta a estinguerne i reati. Anche il “sistema Sesto” era imperniato su
opere pubbliche. Da un lato due aree industriali (le cosidette Falck e Marelli)
per la cui riqualificazione, secondo gli inquirenti, girarono una serie di
mazzette. Dall’altra l’acquisto (dal gruppo Gavio) della Provincia di parte
delle quote della Milano-Serravalle, con un danno per le casse erariali stimato
in 119 milioni di euro. Penati ha un cursus honorum nel corpaccione dei partiti
della Prima repubblica simile a quello di Greganti. Ma i fatti contestatigli
risalgono a quando, da semplice assessore di Sesto San Giovanni, arrivò a
toccare con mano il potere vero, come presidente della Provincia meneghina, un
incarico che lo fece incamminare verso la grande sfida (persa) per la guida del
Pirellone contro Roberto Formigoni. Da semplice quadro di partito negli anni nei
quali l’Italia veniva sconvolta dalle inchieste del pool di Milano, è nella
Seconda Repubblica che l’ex sindaco di Sesto San Giovanni si proiettò sul
panorama nazionale. Prima da presidente provinciale, nel 2004, poi da membro del
coordinamento del Pd veltroniano, infine da capo della segreteria politica di
Pier Luigi Bersani una volta che questi vinse le primarie per la segreteria del
2009. Insomma, per le mele marce della politica dalla metà degli anni ’90 a
oggi, le grandi opere sono spesso “una botta di culo”. Così Ermanno Lisi,
assessore della giunta di centrosinistra de L’Aquila, definiva il terremoto che
provocò 309 vittime nel capoluogo abruzzese. In barba alle bare e alle migliaia
di sfollati, Lisi vedeva nelle montagne di soldi che sarebbero arrivati per la
ricostruzione una grande opportunità di business. Dello stesso parere
sembrerebbero altri tre amministratori aquilani: il vicesindaco Roberto Riga,
indagato per una presunta mazzetta da 30mila euro, un ex consigliere comunale
con delega, Pierluigi Tancredi del Pdl, accusato di corruzione, e un altro ex
assessore, Vladimiro Placidi. Solo punte dell’iceberg in un sistema che ha
portato l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici a trasmettere negli
ultimi anni alle procure e alla Corte dei Conti più di settanta indagini e quasi
mille denunce per false dichiarazioni nelle gare di appalto. Tante, troppe, per
la voracità di quella classe politico-imprenditoriale che si doveva affrancare
dalla mediocritas dei propri padri. E che, al contrario, a dar retta a Nordio,
insieme ai suoi predecessori rischia di trasmettere sugli schermi degli italiani
il brutto film di una nuova Tangentopoli.
Tangenti Mose,
Massimo Carlotto: «Il Nord è più criminale del Sud». Tangentopoli in Veneto. Lo
scrittore Carlotto: «All'estero ci studiano come laboratorio della nuova
malavita economica». Intervista di Gabriele Lippi su “Lettera 43”. Chi ha letto
i suoi libri, probabilmente, nella mattinata di mercoledì 4 giugno 2014 è
rimasto meno stupito di altri. Di intrecci tra criminalità e politica in Veneto,
Massimo Carlotto ne aveva parlato anni prima che lo scandalo Mose scoppiasse
coinvolgendo il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, l'assessore regionale alla
Infrastrutture Renato Chisso e l'ex governatore, ora deputato di Forza Italia,
Giancarlo Galan. «NORD PIÙ CRIMINALE DEL SUD». Nessuna sorpresa dunque per
Carlotto, che a Lettera43.it spiega come questo sistema fosse «evidente da
tempo», e racconta come, ormai, «il Nord è ben più criminale del Sud» e viene
studiato nelle università straniere «come il laboratorio della nuova criminalità
economica». Una situazione riemersa con prepotenza dalle acque torbide dei
canali veneziani. Massimo Carlotto, scrittore nato a Padova.
DOMANDA.
Politica, malaffare, criminalità. Quello scoppiato a Venezia sembra un romanzo
di Carlotto.
RISPOSTA. Devo
dire che questo l'avevo raccontato in Alla fine di un giorno noioso.
D. Sapeva già
tutto?
R. In Veneto
si aspettava da tempo questa azione della magistratura, il sistema era evidente,
era stato messo a nudo dai comitati sul territorio.
D. Come si
sapeva?
R. Le denunce
sono state fatte nel corso degli anni in un silenzio assordante e nella
protervia con cui i politici coinvolti rispondevano alle domande dei comitati.
La battaglia è stata gestita da una minoranza forte e agguerrita del Veneto.
Ora, finalmente, il territorio può tirare un sospiro di sollievo.
D. Corruzione
e politica. Cosa sta succedendo al Veneto?
R. Nulla di
nuovo. Questo è un sistema che ha governato la Regione per moltissimi anni. Ci
sarà un motivo per cui nelle università straniere il Nord Est italiano è
studiato come il laboratorio della nuova criminalità economica. Si è creata una
connessione tra la criminalità e tre ambienti fondamentali della società:
imprenditoria, politica e finanza.
D. E da questa
unione cosa è nato?
R. Un sistema
che ha permesso nel passato grandi accumulazioni di capitale che poi si sono
riversate in tutti questi agganci nel mondo dei grandi appalti. Ma si tratta di
una situazione definita ormai da tempo.
D. Quello del
Nord Est virtuoso e motore dell'economia italiana è un falso mito, dunque?
R. Il mito è
dovuto anche al fatto che ci sono stati moltissimi imprenditori onesti che hanno
creato un sistema economico vincente. Poi si sono infilati anche quelli che
hanno accumulato grandi ricchezze evadendo sistematicamente le tasse, con il
lavoro nero, con lo smaltimento illegale dei rifiuti industriali.
D. La
superiorità morale del Nord vantata dalla Lega non esiste?
R. Lo dico da
moltissimo tempo che il Nord è ben più criminale del Sud, perché i veri affari
avvengono qui. Bisogna dire la verità anche sui tempi in cui le mafie si sono
insediate in Settentrione. La 'ndrangheta è arrivata a Torino nel 1964. È
l'Italia nel suo complesso che ha un sistema criminale di cui bisogna liberarsi
al più presto.
D. L'inchiesta
sul Mose andava avanti da anni, ma si aspettava uno scandalo di tali
proporzioni?
R. Mi
sorprende solo il coinvolgimento del sindaco di Venezia. Gli altri nomi
circolavano da tempo nell'ambito delle indagini e tra coloro che si occupavano
di queste cose.
D. Il sindaco
di Venezia, un assessore regionale, l'ex presidente della Regione. Uno scandalo
bipartisan. La politica veneta è tutta da rottamare?
R. Esiste
anche una parte della politica onesta, anche in senso bipartisan. C'è però un
sistema che ha governato il Veneto per tantissimi anni e che ora deve essere
debellato completamente. Ma poteva essere fatto prima.
D. In che
senso?
R. Si sta
facendo ora un'opera di pulizia che prima della magistratura toccava alla
politica. Agli elettori. Il sistema politico era evidente, ma si è preferito
mantenerlo perché era fortemente ancorato a quello economico.
D. Come si
spiega il ritorno forte della magistratura sugli appalti?
R. Credo che
siano cambiati anche gli equilibri politici, in particolare per quanto riguarda
il Veneto. Pensare che il lavoro dei magistrati non sia influenzato da queste
cose significa non essere ancorati alla realtà. D'altra parte gli appalti sono
diventati un'occasione di riciclaggio del denaro sporco per la criminalità
organizzata.
D. Come mai
proprio gli appalti?
R. Quando la
criminalità ricicla su attività normali non c'è guadagno, c'è una perdita che la
guardia di finanza calcola intorno al 30%. Investendo in attività pubbliche,
invece, la criminalità riesce anche a guadagnare sui soldi che investe, oltre a
riciclarli.
D. Per Galan
c'è una richiesta d'arresto. Pensa che il parlamento darà l'ok?
R. Questo non
lo so ed è difficile dirlo. Quello che secondo me è politicamente importante è
la dimensione complessiva dell'inchiesta per cui il sistema nel suo complesso è
stato messo a nudo.
D. Sembra
anche qualcosa che va oltre Tangentopoli. Tra gli indagati ci sono magistrati,
ex generali della guardia di finanza. La criminalità si insinua ovunque.
R. Questo è il
dato della mutazione antropologica di questa società. La dimensione dell'agire
criminale è di una illegalità diffusa che ha contagiato nel suo complesso la
società.
D. Cioè?
R. Non c'è
aspetto che non sia toccato o influenzato da queste forme illegali. Niente di
cui stupirsi in un Paese in cui la corruzione aumenta del 100% ogni anno.
D. Se fosse un
libro di Carlotto come andrebbe a finire?
R. Arriverebbe
qualcuno che mette tutto a tacere, come successo con Tangentopoli. Si sono
accordati sul 10% di tangente e tutto è continuato nella normalità, fino allo
scandalo successivo. In questo Paese gli scandali sono serviti spesso a sanare
le contraddizioni. Questo è un po' diverso, ma non bisogna abbassare la guardia
per il futuro.
D. Insomma, il
lieto fine c'è solo per i cattivi della storia.
R.
Esattamente.
Basta sdegno e
chiacchiere. Trentuno anni e costi quadriplicati. Quando diremo basta alle
mazzette? Per il Mose ci sono voluti nove volte i tempi del colossale ponte di
Donghai, scrive Gian Antonio Stella su “Il Corriere della Sera”. «Votatelo,
pesatelo, se sbaglia impiccatelo», diceva un antico adagio veneziano. Certo, se
anche le accuse contro Giorgio Orsoni, Giancarlo Galan e gli altri politici e
affaristi coinvolti nell’inchiesta trovassero conferma nei processi e nelle
sentenze, nessuno pretende corda e sapone. Il quadro di corruzione disegnato dai
giudici, però, è così vasto da imporre finalmente una guerra vera, non a
chiacchiere, contro la mazzetta. L’«affare» del Mose è esemplare. Perché c’è
dentro tutto. C’è dentro lo spaccio dell’«emergenza», dei lavori da fare a tutti
i costi in tempi così drammaticamente rapidi da non consentire percorsi lineari
nei progetti, nella scelta degli esecutori, nelle gare d’appalto, nelle
commesse. Risultato: di fretta in fretta sono passati 31 anni, nove volte di più
di quelli bastati alla Cina per fare il ponte di Donghai, che coi suoi 32
chilometri a 8 corsie sul mare collega Shanghai alle isole Yangshan. C’è dentro
l’idea della scorciatoia per aggirare (non cambiare: aggirare) le regole troppo
complicate con la creazione d’un concessionario unico, il Consorzio Venezia
Nuova che, dopo tre decenni passati senza lo straccio di una concorrenza e dopo
essere stato così pesantemente coinvolto negli scandali coi suoi massimi
dirigenti, giura oggi d’essere estraneo alle brutte cose e pretende di
presentarsi come una verginella al primo appuntamento. C’è dentro quel rapporto
insano tra la cattiva politica e il cattivo business così stretto da chiudere
ogni spazio ai controlli veri sui costi, sui materiali, sugli uomini, sui tempi.
Basti ricordare l’impegno preso dall’allora vicepresidente del consiglio Gianni
De Michelis il 4 novembre 1988, quando dopo anni di tormentoni fu presentato il
prototipo del Mose: «La scadenza? Resta quella del 1995. Certo, potrebbe esserci
un piccolo slittamento...». Sono passati quasi vent’anni, da quella scadenza: ci
saranno anche stati degli intoppi, ma cosa succederebbe, in Germania o in
Olanda, se lo Stato si sentisse preso per i fondelli sui tempi in modo così
sfacciato? E cosa direbbero i leghisti da tre lustri al governo del Veneto se un
cantiere interminabile come quello del Mose fosse ancora aperto dopo tanti anni
a Reggio Calabria o a Napoli? C’è dentro il disprezzo per i pareri discordanti e
più ancora, alla faccia del chiacchiericcio federalista, per le opinioni del
Comune, tagliato fuori da decisioni prese altrove: «Sinistra e destra, sul Mose,
erano d’accordo, e io sono rimasto inascoltato», ha accusato più volte, negli
anni, Massimo Cacciari. Ieri l’ha ripetuto: «Le procedure erano tali che da
sindaco io non potevo toccare palla». Una linea verticistica che la Serenissima
non avrebbe accettato mai. Al punto di pretendere, se c’erano di mezzo opere
idrauliche, che oltre a quello degli ingegneri si sentisse il parere di «otto
pescadori» e cioè «due da S. Nicolò, uno da Sant’Agnese, uno da Muran, due da
Buran e due da Chiozza». E poi c’è dentro, in questa brutta storia, il continuo
rincaro delle spese, la peste bubbonica delle nostre opere pubbliche: doveva
costare un miliardo e trecento milioni di euro attuali, il Mose. E di anno in
anno, di perizia in perizia, di furbizia in furbizia, ha sfondato i cinque
miliardi e non è detto che ne basteranno sei. C’è dentro la blandizia verso i
possibili «amici» e insieme l’insofferenza arrogante verso ogni critica, come
nel caso della stupefacente querela per «accanimento mediatico» (avevano dato
battaglia sui giornali) contro Vincenzo Di Tella, Paolo Vielmo e Giovanni
Sebastiani, tre ingegneri rei di avere criticato il costosissimo progetto delle
paratie mobili, la gallina dalle uova d’oro del consorzio. C’è dentro la
ripartizione di incredibili privilegi, come ad esempio, per citare le Fiamme
Gialle, «il compenso di un milione di euro riconosciuto nel 2009» all’allora
presidente Giovanni Mazzacurati «a titolo di “una tantum”, nonché i periodici
rimborsi spese privi di giustificazione contabile», per non dire delle case
affittate in California, delle consulenze distribuite ad amici e parenti o della
liquidazione finale di 7 milioni di euro incassata dopo l’arresto: l’equivalente
di trentuno anni di stipendio del presidente della Repubblica. Una buonuscita
stratosferica, per un uomo finito in manette. E tutti soldi pubblici. Sia
chiaro. Tutti soldi privatamente gestiti come in una combriccola di società
private ma tirati fuori dalle tasche degli italiani. Per amore di Venezia. Per
salvare Venezia dall’acqua alta dovuta non solo ai capricci della Natura e del
Fato ma anche a interventi come la cosiddetta «sussidenza», cioè lo
sprofondamento del suolo dovuta al pompaggio dell’acqua dolce nel sottosuolo o
la creazione del canale dei petroli, un canyon lungo 14 chilometri, largo 200
metri e profondo fino a 17, scavato nel ventre di una laguna delicata la cui
profondità media era di 110 centimetri. E torniamo al rispetto per l’acqua, la
terra, le barene della Serenissima Repubblica. «Tre condition de homeni ruinano
la Laguna: li Signori, li Inzegneri e li Particulari», cioè i proprietari,
scriveva nel ‘500 il Magistrato alle acque Cristoforo Sabbadino. Scordava gli
affaristi dell’appalto facile. Quelli della spartizione fra sodali. Che non
guardano alla destra o alla sinistra ma al business. O, per dirla alla veneta,
ai «schei». Montagne di «schei». Certo è che quest’ultima ondata di arresti
colpisce i cittadini italiani, proprio mentre mostravano di voler credere in un
riscatto e in una nuova speranza, come una frustata in faccia. E dimostra che,
nella scia dei moniti di papa Francesco che batte e ribatte contro il «pane
sporco» del «dio tangente», è indispensabile una svolta vera. Nei fatti. L’Expo
2015, i restauri a Pompei, il G8 alla Maddalena e poi all’Aquila, i primi
interventi e poi la ricostruzione in Abruzzo, i Mondiali di nuoto, il Mose...
Non c’è Grande Evento, da anni, che non sia infettato dalla corruzione. E dopo
ogni arresto, lagne su lagne. E tutti a chiedersi come sia possibile, come mai
non cambi mai niente, perché proprio qui e bla bla bla... Poi, passata la
tempesta di sabbia, appena si posa la polvere, le leggi che parevano
ur-gen-tis-si-me vengono rinviate dal lunedì al martedì, poi alla settimana
dopo, poi al mese seguente, poi all’autunno e da lì all’estate successiva...
Eppure è tutto chiaro: per vent’anni, come denunciano don Luigi Ciotti,
Piercamillo Davigo e tanti altri, ogni sforzo della cattiva politica (troppo
comodo dare tutta la colpa ai berlusconiani) è stato dedicato a smontare le
leggi che c’erano e a buttare bastoni tra le ruote dei giudici. Pochi numeri:
nel decennio dopo la stagione di Mani Pulite, 1996-2006, secondo l’Alto
Commissariato, le condanne per corruzione precipitarono dell’83,9%, quelle per
concussione del 90,4%, quelle per abuso d’ufficio del 96,5%. Come mai? Perché
l’Italia è più pulita? Magari! L’abbiamo scritto ma vale la pena di ripeterlo:
dice il rapporto 2013 dell’Institut de criminologie et de droit pénal curato
dall’Universita di Losanna, che nelle nostre carceri solo 156 detenuti, lo 0,4%
del totale, sono lì per reati economici e fiscali, tra cui la corruzione e la
concussione. Una percentuale ridicola. Dieci volte più bassa rispetto alla media
europea del 4,1%. È una coincidenza se la Germania, il Paese di traino del
Continente, ha le galere più affollate di «colletti bianchi»? Ed è solo una
coincidenza se noi, che arranchiamo faticosamente in coda, ne abbiamo 55 volte
di meno?
Dopo i «100
motivi per amare l’Italia». Ecco (almeno) 10 motivi di vergogna. L’amore per il
nostro Paese non cambia ma vicende come quella di Venezia (Mose), o di Genova
(Carige) e Milano (Expo), impongono una riflessione, scrive Beppe Severgnini su
“Il Corriere della Sera”. Abbiamo appena pubblicato su Corriere.it «100 buoni
motivi per amare l’Italia». Sono stati tradotti in inglese, spagnolo e francese.
Vicende come quella di Venezia (Mose), Genova (Carige), Milano (Expo) - tanto
per restare alla cronaca di questi giorni, e restare lontani dalle paludi romane
e dai buchi neri del sud - non ci fanno cambiare idea. Ma onestà impone di
aggiungere, ai 100 motivi d’orgoglio, almeno 10 motivi di vergogna:
intraducibili. Ecco perché, purtroppo, in queste ore l’Italia ci imbarazza.
1. Perché
tutti sono innocenti finché non è provata la colpevolezza. Ma insomma.
2. Perché gli
oppositori drammatizzano e i governanti minimizzano. Salvo scambiarsi i ruoli al
prossimo giro.
3. Perché la
fame è fisiologica, ma l’ingordigia è patologica: dove finiscono tutti quei
soldi? Cosa se ne fanno? Quanti auto tedesche e appartamenti svizzeri deve
comprare, un uomo, prima di essere sazio?
4. Perché le
grandi opere, da decenni, sono occasioni di grandi saccheggi. Ma ce ne
accorgiamo sempre dopo.
5. Perché la
nostra indignazione è tribale: il peccato è grave quando lo commettono i nostri
avversari. Altrimenti, parliamone.
6. Perché i
collettori di frustrazioni sono lì che aspettano. E non tutti sono inoffensivi
come Grillo & C.
7. Perché
viene il dubbio che non ci meritiamo Venezia, sprechiamo Milano, svergogniamo
Genova, umiliamo Siena, roviniamo Roma. E al Sud, ormai, abbiamo rinunciato.
8. Perché
«Delitto e castigo», in Italia, è solo il titolo di un romanzo russo che hanno
letto in pochi. C’è sempre un’amnesia, un’amnistia o una prescrizione per
tirarsi fuori dai guai.
9. Perché le
pene italiane sono drammatiche, lontane e incerte. Quando dovrebbero essere
proporzionate, rapide e certe.
10. Perché
abbiamo la memoria di un pesce rosso (quattro secondi). Dimentichiamo tutto
subito. E qualcuno, questo, se lo ricorda bene.
Corruzione, la
Grande Ipocrisia. L'analisi. Da Tangentopoli in poi, e per un infinito ventennio
di malaffare, non solo si è fatto assai poco. Ma quel poco che si è fatto lo si
è fatto male, scrive Massimo Giannini su “La Repubblica”. Cos'altro deve
succedere, per convincere la politica a muovere un passo concreto, tangibile e
inequivocabile, contro la corruzione che torna a minare le basi della convivenza
civile e della concorrenza economica? Quante altre retate devono accadere, per
spingere il governo e il Parlamento a ripristinare con un atto definitivo,
responsabile ed efficace, il principio di legalità di cui in questi anni di
fango hanno fatto strame tutti, ministri e sottosegretari, amministratori
centrali e cacicchi locali? Domande tutt'altro che oziose (o capziose), di
fronte all'acqua lurida che tracima dal Mose, dove proprio la politica si è
definitivamente messa "a libro paga", esigendo quello che i magistrati chiamano
"lo stipendio di corruzione". Da Tangentopoli e Mani Pulite in poi, e per un
infinito ventennio di malaffare pubblico e privato, non solo si è fatto assai
poco. Ma quel poco che si è fatto lo si è fatto assai male. Grandi proclami,
piccoli compromessi. Leggi-feticcio, da dare in pasto al popolo bue. E poi
appalti in deroga a volontà, per lucrare fondi neri. Non solo in epoca
berlusconiana, che sappiamo straordinariamente nefasta sul piano etico. Anche in
tempi più recenti, che speravamo finalmente proficui sul piano della
ricostruzione morale e della legislazione penale. Così non è stato. Così non è
ancora. E al presidente del Consiglio Renzi, che meritoriamente dichiara di
voler "cambiare verso" all'Italia anche dal punto di vista della giustizia e che
opportunamente si accinge a dare più poteri al commissario anti-corruzione
Cantone, non è inutile ricordare quanto è accaduto e quanto sta ancora
accadendo. Al di là degli annunci, che pure servono a scuotere la coscienza di
un Paese disabituato al meglio e assuefatto al peggio, ma che da soli non
bastano a consolidare nell'opinione pubblica la percezione di un vero
cambiamento. Da troppo tempo - interrotti solo dai blitz dei pm sulle infinite
cricche tricolori, dal terremoto dell'Aquila al G8 della Maddalena, dai mondiali
di nuoto al sacco di Carige, dall'Expo milanese al Mose veneziano - abbiamo
ascoltato alti lai e asciugato lacrime di coccodrillo. Ma nulla è cambiato, nei
codici e nelle norme di contrasto. C'è come l'accidiosa consapevolezza che la
corruzione, con i suoi 60 e passa miliardi di "fatturato" l'anno, rappresenti
una parte essenziale e forse irrinunciabile del Pil nazionale. Così
l'establishment, politico ed economico, celebra a ogni nuovo arresto la Grande
Ipocrisia. Interviste sdegnate, riunioni d'emergenza. Poi più nulla. O leggi
fatte male, a volte col legittimo sospetto che le si vogliano esattamente così,
per convenienza bipartisan. Non parliamo, stavolta, dei misfatti compiuti da
Berlusconi premier. Sono tristemente noti. Diamo dunque per acquisite le 12
leggi ad personam azzardate dall'ex Cavaliere sulla giustizia. La colossale
occasione, miseramente mancata, è stata la legge Severino, approvata dal governo
Monti nel novembre 2012. Insieme a qualcosa di buono (le nuove norme sulla
decadenza e l'incandidabilità, che costano allo stesso Berlusconi condannato il
seggio al Senato) la legge "spacchetta" inopinatamente il reato di concussione,
riducendo i reati (e dunque i tempi di prescrizione) per l'ipotesi meno grave
(ma infinitamente più frequente) dell'"induzione". L'anomalia viene segnalata
dai magistrati, rilevata dal "Sole 24 Ore" e da "Repubblica", che ne chiede
conto al ministro Guardasigilli consegnandole 250 mila firme raccolte a favore
di una "seria legge contro la corruzione". Ma non c'è niente da fare. La legge
passa così com'è, con la benedizione trasversalissima delle appena nate Larghe
Intese: "tecnici" montiani, Pd e Pdl votano compatti, alla Camera: 480
favorevoli, solo 19 contrari, il Parlamento approva. Di lì nascono tutti i guai
successivi. Berlusconi userà i benefici derivanti dal caos normativo innescato
dalla legge Severino nel processo Ruby. La stessa cosa farà Filippo Panati nel
processo Falck. Un caos che nel frattempo viene autorevolmente certificato. A
febbraio di quest'anno tocca alla Ue, nel suo rapporto sulla corruzione,
evidenziare la lunga "serie di problemi irrisolti" lasciati dalla legge Severino
(prescrizione, falso in bilancio, autoriciclaggio, voto di scambio) e
stigmatizzare "gli effetti della frammentazione del reato di concussione". Il 15
marzo tocca invece alla Corte di Cassazione denunciare per sentenza i danni
causati da quella legge all'esercizio della giurisdizione, e chiedere a governo
e Parlamento di porvi rimedio al più presto. La richiesta cade nel vuoto. Mentre
cominciano a scoppiare i nuovi scandali, governo e Parlamento non solo non
raccolgono l'invito. Ma si muovono lanciando al Paese segnali contraddittori, su
tutti i fronti che riguardano lo Stato di diritto. Due esempi, ma clamorosi
perché passati sotto silenzio. Il 28 gennaio 2014 il governo Letta approva il
decreto legge numero 4, "disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro
dei capitali detenuti all'estero". È la cosiddetta "voluntary disclosure", in
voga in altri Paesi dell'Unione. Ma da noi viene allentata oltre misura. Al
Senato il testo originario viene modificato, le imposte dovute sui capitali
rientrati vengono dimezzate e i reati di frode "con altri artifici", oltre alla
omessa o infedele dichiarazione, vengono depenalizzati. Di fatto, quasi un colpo
di spugna, che alla fine non passa solo perché la Camera il 19 marzo decide di
stralciare queste norme e di farle confluire in un ddl che sarà presentato in
futuro. Per uno scampato pericolo, un disastro compiuto. Il 17 maggio è entrata
in vigore la legge numero 67, che introduce la possibilità di chiedere
l'affidamento in prova ai servizi sociali nei procedimenti per delitti
economico-finanziari con pene fino a 4 anni di detenzione. In questi casi, su
richiesta del soggetto incriminato, si sospende il processo e si avvia un
percorso di servizio e risarcimento, di durata massima 2 anni, al termine del
quale il reato si estingue. Nella lista dei delitti per i quali si può ottenere
il beneficio ci sono l'omessa dichiarazione dei redditi, la truffa, il falso in
bilancio e persino il furto. Questo sì, a tutti gli effetti, ha le fattezze di
un "colpo di spugna", studiato proprio per i reati dei "colletti bianchi". Il
Parlamento approva unanime la legge, il 2 aprile scorso, nell'indifferenza dei
più. Mentre riesplodono le nuove e vecchie Tangentopoli, che vedono il potere
politico alternativamente vittima e a volte carnefice di quello economico, il
Parlamento invia dunque questi strani segnali di fumo al Paese. Delinquere non è
poi così compromettente. Alla fine si può scendere a patti. Di fronte a tanto
cinismo consociativo, la Grande Speranza si chiama Matteo Renzi. Solo lui può
spazzare via la Grande Ipocrisia chiamata lotta alla corruzione. Ma le prime
mosse del premier non sono confortanti. Nel discorso sulla fiducia alle Camere,
il 22 febbraio, il nuovo presidente del Consiglio non dice una parola sul tema
della legalità e delle strategie di contrasto al malaffare. Un silenzio che
assorda, e che spinge Roberto Saviano a scrivere una lettera aperta al premier,
su "Repubblica" del 28 febbraio. Renzi raccoglie la sollecitazione, e il giorno
dopo annuncia dal salotto di Fabio Fazio, a "Che tempo che fa", la nomina di
Raffaele Cantone alla guida dell'Autorità anti-corruzione, nata un anno prima e
mai formata. È un primo indizio, che sembra rassicurante. Ma le mosse
successive, purtroppo, non sembrano trasformarlo nella prova che tutti
aspettiamo. La vicenda del Documento di Economia e Finanza, non aiuta a capire
qual è la vera strategia del governo. Il Consiglio dei ministri, riunito a
Palazzo Chigi, approva il Def l'8 aprile. Renzi ne illustra le linee guida, con
le solite slide. Il giorno dopo, sul suo sito, il ministero dell'Economia
pubblica il testo integrale. A pagina 27 del Piano Nazionale delle Riforme,
compare un ricco capitolo dedicato alla giustizia: "Asset reale per lo sviluppo
del Paese", è il titolo. Pier Carlo Padoan, dai tempi dell'Ocse, ha bastonato
duramente l'Italia, proprio per i ritardi sulla corruzione. Per questo, nel Def,
il ministro scrive parole chiarissime, non solo sulla giustizia civile e
amministrativa, ma proprio sulla lotta alla corruzione: occorre "rivedere la
disciplina del processo penale, con particolare riferimento all'istituto della
prescrizione, ferma restando l'esigenza di assicurare la certezza e
ragionevolezza dei tempi". Più avanti: "Introduzione dei reati di
autoriciclaggio e autoimpiego, anche rafforzando il 41 bis". E infine: "È
necessario affrontare in modo incisivo il rapporto tra gruppi di interesse e
istituzioni e disciplinare i conflitti di interesse e rafforzare la normativa
penale del falso in bilancio". Finalmente una dichiarazione programmatica
impegnativa. Il segno che "cambiare si può". Ma sei giorni dopo, quando il Def
arriva alle Camere per l'avvio dell'iter parlamentare, il testo è
sorprendentemente cambiato. Il capitolo Giustizia rimane, alle pagine 29 e 30, e
poi a pagina 63, nel capitolo II.10 intitolato "Una giustizia più efficiente".
Si parla di tutto, dalla riforma della giustizia civile al sovraffollamento
carcerario, dalle leggi già varate sul voto di scambio a quelle contenute nella
Severino. Si propone la "mediazione obbligatoria" e la "depenalizzazione dei
reati minori", la "difesa dei soggetti più deboli" e la "tutela dei minori". Ma
per quanto li si cerchi, i paragrafi sulle modifiche al processo penale, dalla
prescrizione all'autoriciclaggio, dall'autoimpiego al falso in bilancio, non ci
sono più. Chi e perché le ha cancellate? Una spiegazione possibile, anche se
parziale, la forniscono gli atti parlamentari. Il 16 aprile, durante il
dibattito in Commissione Giustizia della Camera, i deputati Cinquestelle almeno
per una volta fanno bene il loro mestiere. Alfonso Bonafede "ritiene che sia
estremamente grave che nella formulazione presentata alle Camere del Def in data
9 aprile 2014 venga fatto espressamente riferimento all'esigenza di affrontare
definitivamente entro giugno 2014 il problema dei tempi di prescrizione e che
ieri, martedì 15 aprile, dopo che nella serata di lunedì 14 aprile il presidente
del Consiglio si sia incontrato con Silvio Berlusconi, sia pervenuta alle Camere
una "errata corrige" da parte della presidenza del Consiglio, nella quale è
stato cancellato ogni riferimento alla questione della prescrizione". La
risposta di Donatella Ferranti, presidente della Commissione, arriva di lì a
poco: "Le correzioni apportate con l'errata corrige - replica l'esponente del Pd
- erano state in realtà segnalate dagli uffici del Ministero della Giustizia
alla Presidenza del Consiglio la scorsa settimana". Dunque, non sarebbe stato il
premier a "depotenziare" il testo, e meno che mai l'avrebbe fatto dopo
l'incontro di due ore, a Palazzo Chigi, con l'ex Cavaliere. Possiamo credere
alla ricostruzione della Ferranti. Ma l'anomalia resta. E se a "sbianchettare" i
paragrafi sul programmato giro di vite per la prescrizione, l'autoriciclaggio e
il falso in bilancio è stato il ministro Orlando, e non Renzi, che differenza
fa? Di nuovo: che segnale si vuol mandare al Paese? Siamo all'oggi. La
gigantesca metastasi delle mazzette, che si propaga da Milano a Venezia nel
corpo malato dell'"operosa Padania", obbliga il governo a fare qualcosa, subito.
Orlando ha preso tempo sui vari provvedimenti già all'esame del Parlamento da
più di un anno (dal testo della Commissione Fiorella sulla prescrizione alle
diverse proposte sul falso in bilancio). Ha rinviato tutto a un più organico
disegno di legge anti-corruzione, originariamente previsto entro l'estate e ora
forse anticipato alla prossima settimana. Ma nel frattempo deve battere un
colpo, almeno sulla promessa attribuzione dei pieni poteri a Cantone e magari
anche sull'autoriciclaggio. Se ci riuscirà, al Consiglio dei ministri di domani,
sarà tanto di guadagnato. Ma di fronte alla nuova Questione Morale, che torna a
devastare drammaticamente il Paese e a sporcarne irrimediabilmente l'immagine,
non basta più la narrazione riformista. Serve l'azione riformatrice. Chiara e
severa, senza concessioni e senza ambiguità. Anche così si difende la memoria di
Enrico Berlinguer dagli iconoclasti pentastellati.
Democratici
divisi anche sulle mazzette. Fassino: "Orsoni uomo onesto". Ma i renziani non
vogliono scandali. Moretti: "Nuova classe dirigente per mettere fine alla
corruzione", scrive Fabrizio Boschi su “Il Giornale”. È sempre così. Quando
succedono queste cose è tutto un fuggi fuggi. Quello non c'entra, quell'altro è
innocente, ci auguriamo che la magistratura faccia chiarezza al più presto, bla
bla bla. A una settimana dai sorrisoni a trentadue denti mostrati al Nazareno,
dopo la schiacciante vittoria di Renzi alle Europee, da ieri mattina il Pd si è
improvvisamente ammutolito. Anzi no, di chiacchiere se ne sono sentite sin
troppe, ma del fiume di parole sgorgate dalle bocche dei dirigentoni e
esponentoni del partito, qualcuna non solo era dissonante, ma in certi casi
contrastante. Nordisti contro sudisti. Veneti contro il resto del mondo.
Soprattutto la nuova contro la vecchia guardia. Ex comunisti contro neo
demo-renziani. C'è da capirli ahiloro. Il loro cristallino sindaco di Venezia,
di specchiata moralità e ineccepibile levatura, è finito in manette. E si levò
nell'aria un unico attestato di stima: «Chiunque conosca Orsoni non può dubitare
della sua correttezza e della sua onestà». Parola di Piero Fassino, sindaco di
Torino. Virginio Merola gli fa eco da Bologna. Ma loro appartengono al vecchio,
due che Renzi, se fosse il rottamatore, avrebbe già rottamato (per motivi
anagrafici). Uno ad uno hanno fatto capolino i nuovi, o quelli rivestiti di
nuovo, come la ex bersaniana, poi ultrà renziana, Alessandra Moretti, che da ex
vicesindaco di Vicenza scarica tutte le colpe sui vecchi compagni con una frase
che i politici di razza definirebbero «concreta»: «È arrivato il tempo che una
nuova generazione di politici si prenda la responsabilità di scommettere sul
futuro». Parole sacrosante. L'altra conterranea, Laura Puppato, ex sindaco di
Montebelluna in provincia di Treviso, salita a forza sullo stipato carro
renziano, dà la colpa di tutto questo marciume a quei vecchi bacucchi del suo
partito, in via di rottamazione: «Dall'inchiesta sul Mose viene fuori la parte
peggiore della politica del passato», mentre «noi con Renzi stiamo voltando
pagina da tutto questo». E pure il sottosegretario alla presidenza del
Consiglio, Sandro Gozi, si smarca dalla puzza che fuoriesce dalla laguna,
tirando fuori un evergreen: «Siamo il governo del cambiamento». Quel discolo di
Pippo Civati non ci casca e pretende «una maggiore selezione della classe
dirigente». Il filosofo ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari aveva la
soluzione in tasca ma, guarda caso, nessuno l'ha ascoltato: «Da sindaco, durante
i governi Prodi e Berlusconi ebbi modo di ripetere che le procedure assunte non
permettevano alcun controllo da parte degli enti locali e che il Mose si poteva
fare a condizioni più vantaggiose. L'ho ripetuto milioni di volte».
L'eurodeputato rieletto David Sassoli s'improvvisa spazzino e si augura che si
faccia «pulizia rapidamente» con un pizzico di retorica: «Voglio una Repubblica
fondata sul lavoro non sulle mazzette». Sarà il prossimo ad essere rottamato.
Quella verità
inconfessabile: "Niente affari senza tangenti". Dall’interrogatorio
dell’imprenditore Maltauro emerge la fotografia di un Paese in via di
decomposizione. "Ho quasi settant’anni, mettiamo fine a questo sistema",
scrivono Luca Fazzo Enrico Lagattolla su “Il Giornale”. È come nel '92, è come
Mani Pulite. No, «è peggio». È l'Italia delle tangenti vista con gli occhi di
chi, le tangenti, le paga. Enrico Maltauro è un imprenditore. Un mese fa finisce
in carcere perché - sostengono i pm di Milano - ha versato stecche per avere i
lavori di Expo. «Tutto vero», conferma Maltauro davanti al giudice. «Ammetto»,
dice l'imprenditore all'inizio dell'interrogatorio di garanzia. Ma a Maltauro
non basta, e chiede al gip Fabio Antezza di poter fare «una premessa». È la
fotografia di un Paese in via di decomposizione. Così eccola, la metastasi della
corruzione. «Questa vicenda - mette a verbale l'imprenditore - è collegata alla
vicenda del '92. Perché io lo chiamo, lo definisco stato di necessità da parte
di un professionista che svolge e gestisce la mia attività, di avere la
necessità della sua presenza sul mercato delle opere pubbliche e dei lavori
banditi dallo Stato (...). Una persona che fa il mio mestiere ha l'assoluta
necessità di avere un contatto, un'interlocuzione, un rapporto con la... diciamo
con le stazioni appaltanti». È una consapevolezza antica. «Parlo dalla metà
degli anni '80». «Mi sono perfettamente reso conto - insiste Maltauro - che
esiste una totale e assoluta invadenza e una totale e assoluta dominanza
della... chiamiamola politica, con le sue varie diramazioni. Con il
sottogoverno, con la politica, con le espressioni amministrative periferiche,
rispetto alla gestione di questo mercato. Per cui in qualche modo, in modo
assoluto e in modo assolutamente forte, in modo assolutamente in certi casi
patologico, viene a essere necessitato un collegamento e un contatto di questo
genere». L'imprenditore vicentino scava nel passato. «Io avevo avuto
un'esperienza molto negativa negli anni '90 (ha patteggiato una pena a un anno
per le tangenti sugli appalti di Malpensa 2000, ndr), dopodiché decisi
sostanzialmente non dico di cambiare mestiere, ma di ritirarmi in un altro tipo
di attività». Maltauro racconta di aver lavorato in Libia, e dopo qualche anno
di essere tornato in Italia. «Nell'ambito di questa mia rientrata nel sistema
italiano, mi sono assolutamente reso conto che la situazione che avevo lasciato
tanti anni prima non solo non era cambiata, ma forse sotto un certo aspetto era
anche peggiorata». E in che modo l'Italia di oggi è peggio di quella di
vent'anni fa? «Il sistema dei partiti - spiega ancora Maltauro - che fino agli
anni '90, '92, '93 comunque sia aveva un suo ordinamento, una sua gerarchia,
aveva una sua logica, bella, brutta, sbagliata, giusta, questo è un altro
ragionamento, però c'era una sorta di gerarchia, di ordine, di riferimento, di
definizione. Negli ultimi anni qui la situazione si era sfarinata, prendendo
delle caratteristiche assolutamente personalizzate. Gruppi di potere, gruppi di
influenza, gruppi di lobby, gruppi di gestione di attività/nomine/conseguenze
delle nomine». Quindi, che fare? «O lavoriamo all'estero, cosa che peraltro
abbiamo fatto, oppure vendiamo l'attività, cosa che io ho pensato moltissime
volte». Maltauro racconta di aver provato a cercare dei partner stranieri,
vendendo quote della propria società. «Abbiamo fatto un preliminare con
un'importante azienda austriaca (...). Era un'operazione di grande qualità e di
grande livello, anche perché è una delle grandi società europee, per cui era una
cosa che mi rendeva molto contento». Ma «non riuscimmo a concludere
quell'operazione». Motivo? «Il consiglio di amministrazione della multinazionale
austriaca prese paura, molto semplicemente detto, della situazione italiana. E
vennero a dirci: Guardate, tutto a posto dal punto di vista dei numeri, però noi
non ce la sentiamo di approfondire». E così, sfumati i capitali stranieri,
Maltauro ritiene di non avere avuto altre alternative. «Siamo una società che ha
mille e ottocento dipendenti a libro paga (...), è un'azienda che ha quasi
cent'anni». E per «trovare delle soluzioni dal punto di vista anche
dell'acquisizione del lavoro (...), ho avuto la necessità, diciamo così, di
aumentare o impostare un mio livello di comunicazione con la... chiamiamola
politica, con la para-politica, con le lobby della politica, chiamiamole come
vogliamo. E rispetto a questo, a questo che io definisco stato di necessità, si
incardina il procedimento che mi vede in questo momento protagonista. Io non
contesto minimamente i fatti. (...) Ho quasi settant'anni e questo momento mi
mette nella volontà e nell'assoluta decisione di porre una censura definitiva
con questo tipo di situazione».
Siamo un
popolo di corrotti? Credo che in questi giorni, di fronte all’ennesimo episodio
di malaffare, un interrogativo del genere si sia riproposto con una forza fin
qui inedita. Ma una risposta negativa, pur ineccepibile, non soddisfa più,
scrive Giovanni Belardelli su “Il Corriere della Sera”. Se si abbattessero le
ville che hanno distrutto le nostre coste, tanti italiani sentirebbero che lo
Stato non li ha abbandonati Testo: C’è qualcosa, nel modo d’essere e di agire
degli italiani, che ci rende più inclini di altri popoli a infrangere regole e
norme, o quanto meno ci spinge a tollerare con disinvoltura che altri lo
facciano? Credo che in questi giorni, di fronte all’ennesimo episodio di
corruzione seriale, un interrogativo del genere si sia riproposto con una forza
fin qui inedita. Per dirla in modo brutalmente sintetico, siamo un popolo di
corrotti? Il fatto è che una risposta negativa, pur ineccepibile (a intascare od
offrire tangenti non sono «tutti», ma sempre persone con un nome e un cognome),
non soddisfa più. Non allontana la sensazione che certi fenomeni di corruzione,
se effettivamente sono presenti in tutte le democrazie sviluppate, in Italia
appaiono non solo più diffusi ma anche radicati nella cultura del Paese, quasi
fossero parte dell’identità della nazione, ne caratterizzassero l’anima
profonda. E neppure funziona più, di fronte a una sequenza di scandali che pare
ininterrotta, la consolatoria spiegazione che attribuisce il malaffare diffuso a
un certo numero di politici e imprenditori disonesti, aiutati da qualche
pubblico funzionario senza scrupoli. Non perché queste responsabilità non ci
siano davvero tutte, come mostrano le cronache di questi giorni. Ma perché da
tempo quelle stesse cronache danno regolarmente notizia di piccole e grandi
ruberie, truffe, imbrogli (dai falsi permessi per disabili all’alterazione delle
autocertificazioni sul reddito) che coinvolgono una platea di cittadini non
proprio ristretta e segnalano la sostanziale accettazione di fenomeni di
illegalità di massa. Insomma, al mito della società civile onesta, che si
contrappone alle varie cricche politico-affaristiche, non crede ormai più
nessuno. Del resto, l’idea che il nostro Paese abbia qualche serio problema nel
rapporto con la legge circola da secoli. Era proprio questo che tra Sette e
Ottocento (l’epoca del Grand Tour, che aveva l’Italia tra le sue mete obbligate)
sostenevano tanti osservatori stranieri: convinti che ogni popolo avesse un suo
«carattere nazionale», vedevano negli italiani una grande vitalità e creatività,
bilanciate però da una scarsa o nulla inclinazione a rispettare le leggi, a
guardare oltre il proprio interesse individuale concepito nell’accezione più
egoistica del termine. In anni più vicini a noi, le scienze sociali non hanno
fatto altro, in fondo, che dare una veste scientifica a quella diagnosi,
evocando il «familismo amorale» o la scarsa «cultura civica» degli italiani. Si
è trattato di spiegazioni suggestive, anche se mai interamente convincenti. In
ogni caso, il deficit di etica pubblica e privata di cui soffre il Paese sembra
innegabile. Ma questo riconoscimento dovrebbe portare a qualcosa di più efficace
del solito auspicio di trasformazioni culturali profonde, che vedranno semmai i
nostri nipoti. Dovrebbe indurre a dare un qualche riconoscimento a quella parte
del Paese che tutto sommato le leggi le rispetta, ma che non si sente
adeguatamente valorizzata dalle istituzioni. In attesa, infatti, di una
rivoluzione culturale, se verrà e quando verrà, che cambi la mentalità
collettiva, i pubblici poteri dovrebbero puntare il loro sguardo, ad esempio, su
quegli italiani che abusi edilizi non ne hanno fatti, ma vedono chi invece ne ha
compiuti godere in assoluta tranquillità i frutti del proprio comportamento.
Sono pur sempre le istituzioni, come sostenne ai suoi tempi Jean-Jacques
Rousseau, a formare «il genio, il carattere, i gusti e i costumi di un popolo».
E allora, se - invece di promuovere tanti corsi, giornate, navi della legalità,
invece di obbligare ogni università ad avere il suo bel «piano triennale
anticorruzione» - si abbattessero un po’ delle ville e villette che hanno
distrutto chilometri delle nostre coste, tanti italiani certo insorgerebbero. Ma
tanti altri, è probabile, sentirebbero che lo Stato non li ha abbandonati, che
punta su di loro per uscire prima o poi dalla palude fatta di una illegalità e
una corruzione accettate, più o meno fatalisticamente, come normali.
La mazzetta
incurabile, scrive Marcello Veneziani su “Il Giornale”. Non riesco più a
indignarmi per la corruzione. Troppo seriale, scontata, inestirpabile,
trasversale per suscitare ancora rabbia. Il sistema col tempo è peggiorato: si
prendono mazzette senza realizzare le opere e poi ieri portava almeno benefici a
cascata, oggi resta ai diretti interessati. È stupida la reazione «mandiamoli
tutti a casa»; e poi chi subentra, in base a quale sortilegio sarà più
affidabile? Sono forse cambiati i criteri di selezione, sono mutate le
motivazioni, ci sono differenze «etniche», culturali o religiose che possano
farci dire che i nuovi sono diversi? Chi ci dice che i miracolati di Grillo ma
anche quelli di Renzi, diventati di colpo classe di potere, siano più affidabili
rispetto ai loro predecessori? Vi ricordate cosa fecero i craxiani rispetto ai
vecchi marpioni dc & soci? E la soluzione non è nemmeno dare poteri enormi ai
giudici o invocare nuove leggi, normative più toste. Non serve e s'è visto. Per
arginare la corruzione restano tre vie non ancora intraprese: rendere più
semplice il sistema e le sue norme, sfoltendo i passaggi e i poteri di veto,
perché più controlli ci sono e più potenziali corrotti ci saranno; selezionare
la classe dirigente sulla base di curriculum, competenza, capacità e non in base
a criteri cosmetici, demagogici o di affiliazione ai clan e ai capi; scegliere i
politici in base alla motivazione che li muove, se sono spinti da molle civili e
ideali o no, perché se quel che conta siamo io, i miei e la nostra vita, la
corruzione è dietro l'angolo. E si ripeterà in eterno.
Certi sindaci d’Italia tra mazzette, furtarelli e le accuse di spaccio di
marijuana. I guai penali e amministravi di (alcuni) amministratori pubblici. I
casi degli ultimi sessanta giorni, scrive Alessandro Fulloni il 2 aprile 2015 su
“Il Corriere della Sera”.
1. Condanne, arresti e dimissioni. C’è
quello (caso classico) che intasca mazzette, l’altro (caso inedito) che si
appropria dei risparmi che gli avevano affidato due anziane sorelle decedute.
Poi c’è il primo cittadino che potrebbe essere sottoposto (e sarebbe un record)
per due volte nel giro di venti mesi alle applicazioni della legge Severino
sulla corruzione. C’è anche l’amministratore «sceriffo» - noto alle cronache per
aver fatto arrestare tre ladri - che si fa beccare per spaccio. Storie di
(alcuni) sindaci italiani: quelli che alla guida di comuni grandi e piccoli
(circa 8 mila) talvolta amministrano con eccessiva disinvoltura la cosa
pubblica. Ecco, per stare agli ultimi sessanta giorni, le vicende più singolari.
Tra condanne, arresti e le attese di pareri della Consulta sull’applicazione
della Severino. Il caso più noto di questi giorni è quello del sindaco di Ischia
Giuseppe Ferrandino, arrestato lunedì nell’ambito dell’inchiesta della Procura
di Napoli sulle opere di metanizzazione sull’isola e detenuto nel carcere di
Poggioreale. Martedì si è dimesso dando mandato al suo legale di consegnare al
segretario generale del Comune di Ischia una lettera nella quale comunica la sua
decisione, presa «al solo fine di potersi difendere libero da vincoli e ruoli
istituzionali». Nella lettera Ferrandino scrive di avere «la serenità di chi è
straconvinto della propria innocenza e di chi ritiene di avere sempre operato
nell’esclusivo interesse della cittadinanza e di chi crede fermamente nella
giustizia italiana».
2. Il sindaco che si appropria dei risparmi delle sorelle morte.
Si sarebbe appropriato di una somma di denaro di circa
36 mila euro, i risparmi di una coppia di anziane sorelle che poi sono morte.
Per questo motivo è stato arrestato dai carabinieri, con l’accusa di peculato,
il sindaco di Santa Maria Salina (nel Messinese), Massimo Lo Schiavo. Le due
sorelle, malate e bisognose di assistenza, erano proprietarie di una casa e di
vari beni. Nel giugno del 2013 furono trasferite in una casa di riposo di Leni,
sull’isola di Salina, per essere curate. La loro abitazione fu sigillata e le
anziane chiesero all’amministrazione di custodire i loro risparmi: 36 mila euro,
212 dollari australiani e 180 dollari americani. Il sindaco ha preso il denaro e
lo ha sigillato in due buste alla presenza dei vigili urbani. Dopo la morte di
una delle donne ed è stato nominato un amministratore di sostegno dell’altra
anziana. Poco tempo dopo è deceduta anche la sorella e l’amministratore ha
chiesto di avere la somma di denaro e le chiavi dell’abitazione. A questo punto
il sindaco avrebbe accampato alcune scuse dicendo che la somma era solo di 25
mila euro e di non sapere dove fossero le buste perché le avrebbe perse durante
un trasloco. Ha poi consegnato seimila euro all’amministratore, chiedendogli di
aspettare il versamento delle somme restanti. Nel corso delle indagini i
carabinieri hanno però trovato a casa del sindaco le buste, che erano state in
precedenza sigillate, vuote. Nel corso della perquisizione nell’abitazione del
sindaco sono stati trovati anche 12 mila euro, in parte anche in valuta
straniera. Sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza del denaro.
3. La mazzetta al sindaco dei record.
Una mazzetta di 100 mila euro in cambio di un appalto di otto milioni per
realizzare alloggi popolari. È la contestazione della Procura di Bari nei
confronti di Sergio Povia, sindaco di centrosinistra di Gioia del Colle,
arrestato il 6 febbraio dalla Finanza. Arresti poi revocati dal gip. Ma il primo
cittadino (più volte alla guida della cittadina pugliese a partire dal 1993: un
record) a seguito della bufera giudiziaria, si è dimesso. Con lui erano finiti
in carcere anche l’ex vicesindaco e l’imprenditore che aveva allungato la
mazzetta. I reati contestati sono corruzione e turbativa d’asta. Secondo il pm
Eugenia Pontassuglia, le persone arrestate (sia politici che dipendenti comunali
e liberi professionisti) in cambio della tangente avrebbero fatto in modo che
l’imprenditore si aggiudicasse la gara per numerosi alloggi. Gli indagati
avrebbero tenuto una «molteplicità di condotte collusive sia nella fase
concernente la pubblicazione del bando di gara, predisposto dai funzionari
comunali seguendo le direttive indicate da Posa e contenute in elaborati tecnici
redatti da professionisti di sua fiducia, sia la fase successiva».
4. «Fumo» e bilancino in casa dell’assessore «sceriffo».
Droga e un bilancino di precisione all’interno della cassaforte di casa. Con
l’accusa detenzione ai fini di spaccio è stato arrestato, giovedì 26 marzo,
l’assessore alla sicurezza di Pieve Fissiraga (Lodi) , il leghista Antonio
Iannone (soprannominato l’assessore «sceriffo»). I carabinieri che hanno
perquisito la sua abitazione, gli hanno intimato di aprire la cassaforte:
all’interno c’erano 250 grammi di hashish, uno di marijuana e un bilancino. Il
tribunale di Lodi ha convalidato il fermo concedendogli gli arresti domiciliari.
Iannone si era fatto la fama di «assessore sceriffo». Nell’autunno scorso, ad
esempio, aveva bloccato quasi da solo e fatto arrestare tre romeni sorpresi a
rubare rifiuti nella piazzola ecologica del paese.
5. Condanna in Appello per l’ex sindaco di Buccinasco.
L’11 febbraio l’ex sindaco di Buccinasco (nel Milanese),
Loris Cereda, arrestato nel marzo 2011 per un giro di tangenti legate ad appalti
per la nettezza urbana e per il cambio di destinazione d’uso di alcune aree
della cittadina, è stato condannato a 3 anni e 6 mesi (e 20.000 euro di
provvisionale al Comune) per corruzione dalla seconda Corte d’Appello di Milano.
L’accusa imputava a Cereda (che in primo grado aveva avuto 4 anni e 3 mesi) una
tangente di 7mila euro per garantire l’approvazione di una convenzione tra il
Comune e una società per la concessione d’uso di un’area verde «da destinare a
parcheggio». Inoltre l’allora sindaco avrebbe accettato 25mila euro e la messa a
disposizione di due Ferrari e una Bentley per garantire l’approvazione di una
delibera di «rinnovo del contratto per i servizi di igiene urbana» con
«contestuale subappalto».
6. Il Caso Ostia e il «minisindaco» dimissionario.
A Ostia, municipio del comune di Roma, il minisindaco (Pd) Andrea Tassone è
dimissionario. Un gesto annunciato il 18 marzo dallo stesso Tassone in chiave di
allarme antimafia: troppo forti le pressioni della criminalità organizzata, «non
ho gli strumenti per andare avanti. Non ho mai chiesto un carrarmato per
combattere le mie battaglie ma almeno una piccola mazzafionda l’avrei
desiderata». Una vicenda però in chiaroscuro, che mette in imbarazzo il Pd: tra
le condizioni per continuare, Tassone (citato nelle carte di Mafia Capitale dal
faccendiere Salvatore Buzzi che lo definisce «nostro») ha posto l’allontanamento
del comandante dei vigili di Ostia Roberto Stefano. Ma Stefano ha condotto
l’inchiesta sui chioschi del lungomare di Ostia, dove «ballano» 300 mila euro
per le opere a scomputo, un’indagine per la quale risultano indagati (con
elezione di domicilio) lo stesso Tassone e anche l’assessore ai Lavori pubblici
Antonio Caliendo (anche se lui nega). Morale: dimissioni (almeno sinora)
definitive. Consiglio municipale a un passo dallo scioglimento. E nuove elezioni
praticamente certe.
7. Il sindaco che diventa senatore «grazie» a legge Severino.
Fosse un calciatore, Domenico Auricchio, detto «Mimì», fedelissimo di
Berlusconi, sarebbe un numero 7, genere Franco Causio. Claudio Sala o Bruno
Conti, capace di saltare l’avversario con un dribbling secco. Auricchio invece è
un sindaco-senatore, e il dribbling lo ha fatto infilandosi in uno di quei
«varchi» non previsti dal la legge Severino. Grazie alla quale è arrivato a
palazzo Madama, per usare le parole del presidente dell’Autorità Anticorruzione
Raffaele Cantone «dopo una condanna di primo grado» per la quale da sindaco -
due anni fa - è stato «sospeso per effetto della Severino». «Epperò può entrare
in Parlamento perché era il primo dei non eletti». Ma ora c’è un nuovo caso.
Terminata la sospensione di 18 mesi, Auricchio è tornato sindaco in piena
regola. Nuova tegola il 18 marzo: quando è stato condannato per abuso d’ufficio.
I giudici del tribunale di Nola lo hanno giudicato colpevole dell’installazione
di un chiosco abusivo in pieno Parco Nazionale del Vesuvio: una concessione
avvenuta, secondo l’accusa, senza passare dall’ufficio tecnico. Ora il
sindaco-senatore rischia una nuova applicazione della Severino. La seconda in 20
mesi. E sarebbe record.
8. De Luca, attesa per il parere della Consulta.
Vincenzo De Luca, 65 anni, è stato per quattro volte sindaco di Salerno, due
volte deputato e sottosegretario ai Trasporti nel governo Letta. Una trafila dal
Pci al Pd. Ora per il centrosinistra è il candidato (vincente alle primarie)
alle prossime regionali in Campania. Il 21 gennaio è stato condannato ad un anno
di reclusione per abuso d’ufficio per la nomina di un ex collaboratore come
project manager del termovalorizzatore. Il giorno dopo il prefetto di Salerno ha
disposto la sua sospensione in base alla legge Severino che prevede tra le altre
misure, la sospensione e decadenza degli amministratori locali in condizione di
incandidabilità (appunto come De Luca, condannato per un reato contro la
pubblica amministrazione). L’ex sindaco di Salerno attende ora una decisione
della Corte costituzionale. Che presto, anche se il ruolo non è ancora stato
assegnato a un relatore, dovrà vagliare la costituzionalità della legge
anticorruzione varata dal governo Monti. Se venisse eletto governatore della
Campania in assenza di una decisione della Corte, De Luca verrebbe
immediatamente sospeso su richiesta della presidenza del Consiglio. Però, un
minuto dopo De Luca farebbe ricorso al Tar. Poi si vedrà.
Mafia: neri, rossi e boss. Chi comanda a Roma.
La ragnatela criminale di Carminati aveva unito politici di
destra e sinistra. Il volto nuovo del potere criminale in un saggio-inchiesta di
Lirio Abbate e Marco Lillo che svela intrecci con vip, calciatori,
professionisti e imprenditori, scrivono Lirio Abbate e Marco Lillo su
“L’Espresso”. È l'inchiesta più clamorosa dell'ultima stagione, l'incredibile
ragnatela di potere creata intorno al Campidoglio da Massimo Carminati. Adesso
quella rete di malaffare viete setacciata da un saggio scritto da Lirio Abbate
de "l'Espresso" e da Marco Lillo de "il Fatto". "I Re di Roma" (Chiarelettere,
256 pagine): prende il titolo dall'inchiesta giornalistica del nostro
settimanale che nel 2012 svelò la spartizione criminale della metropoli
capitolina, prima ancora che le indagini ne ricostruissero l'organizzazione.
Ecco in anteprima il capitolo finale, sulla matrice politica di questo scandalo:
a comandare era il terrorista mai pentito che dava ordini a uomini di destra e
sinistra. In libreria per Chiarelettere il nuovo libro inchiesta di Lirio Abbate
e Marco Lillo: ''I Re di Roma. Destra e sinistra agli ordini di mafia
capitale''. Una storia incredibile, che è poi diventata l'inchiesta di Pignatone
e che propone al lettore una mappa inquietante e dettagliata di ''un sistema
criminale senza precedenti, che ha dominato Roma con la complicità di politica e
istituzioni. Un sistema che pesa sui cittadini con disservizi visibili ogni
giorno''. E dunque "Mafia Capitale" è di destra o è di sinistra? Massimo
Carminati è il capo dell’organizzazione ed è un ex Nar, non certo un ex Br.
Poche storie: «mafia Capitale» è di destra. Gaber risponderebbe: eh no, sembra
facile. Il Nero è socio dipendente di una coop rossa, la 29 giugno, dunque lo
vedi che «mafia Capitale» è di sinistra? L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno,
è indagato per associazione mafiosa con Buzzi e Carminati, dunque «mafia
Capitale» torna a destra. Sì, ma Giuliano Poletti, da capo della Legacoop,
andava a cena con uno dei capi di «mafia Capitale», Salvatore Buzzi, e dunque è
di sinistra. Sì, ma a quella cena c’era pure il manager dell’Ama legato ad
Alemanno, Franco Panzironi, dunque è di destra. E Ignazio Marino si faceva
finanziare la campagna elettorale dalla coop rossa 29 giugno, quella che poi
lucrava sugli immigrati, lo vedi che è di sinistra? Peccato che la coop 29
giugno finanziava la fondazione di Gianni Alemanno, mica quella di Renzi, quindi
è di destra. Dimentichi che il Rosso finanziava anche le cene elettorali
dell’attuale premier, quindi è di sinistra. Sì ma Buzzi faceva il tifo per il
centrodestra alle elezioni comunali del 2013 e poi, per cambiare il bilancio del
Comune a favore della sua cooperativa, sono intervenuti Massimo Carminati e il
segretario del sindaco Alemanno, mica Che Guevara. Quindi è di destra. Il
bilancio del Comune con le correzioni a favore della coop amica di Carminati,
però, poi lo approvavano anche i consiglieri del Pd, quindi «mafia Capitale» è
di sinistra. Alla fine forse è più corretto prendere atto che «mafia Capitale» è
sia di destra che di sinistra, ma tradisce insieme i valori della destra e
quelli della sinistra. Chi fa saltare le regole della concorrenza e del libero
mercato, chi usufruisce di sconti e condoni per continuare a violare la legge,
come hanno fatto Buzzi e Carminati, è la negazione dei valori della destra
economica e sociale. All’opposto, chi usa persino il disagio degli immigrati,
dei nomadi e dei senzatetto per gonfiare il proprio portafoglio compie il
peggiore tradimento possibile ai valori della sinistra. Ma cos’è la destra,
cos’è la sinistra? Se «mafia Capitale» fosse solo di destra o solo di sinistra,
sarebbe più facile da combattere. Invece, gli affari rossi e quelli neri si
mescolano e diventano verdi: il colore dei soldi. Carminati è socio della coop
di Buzzi che con una mano scrive discorsi di ringraziamento al ministro Poletti
e al premier Renzi e con l’altra sostiene e finanzia le elezioni di Gianni
Alemanno. L’ex collaboratore di Veltroni, Luca Odevaine, è lo sponsor delle
cooperative care al Vaticano e a Giulio Andreotti. Dov’è la destra e dov’è la
sinistra? Sono in parlamento e governano insieme da molti anni, prima con Mario
Monti, poi con Enrico Letta e ora con Matteo Renzi. Non è un caso se
l’opposizione si è rivelata inefficace sia nell’era Veltroni che nell’era
Alemanno. Solo il lavoro del Ros dei carabinieri e dei magistrati della Procura
di Roma ha scoperchiato il verminaio che oggi, a prescindere dalle possibili
condanne, è già sotto gli occhi di tutti. In tutte le indagini maggiori del
2014, dall’Expo al Mose fino a «mafia Capitale», sono emerse tre costanti: la
presenza di finanziamenti non trasparenti alle fondazioni dei politici di destra
e di sinistra; la nomina di manager incapaci e asserviti al potere politico a
capo delle municipalizzate, delle società miste e dei consorzi pubblici che
gestiscono le grandi opere; l’alleanza tra coop rosse e coop bianche per entrare
negli appalti maggiori. Se il governo Renzi avesse voluto, avrebbe potuto
approvare un decreto per intervenire su questi problemi composto di tre
articoli: tutti i finanziamenti a una fondazione nella quale figuri un politico
in qualsiasi veste, non solo quelli ai partiti, devono essere resi pubblici su
internet; i manager delle municipalizzate, delle società miste e dei consorzi
che devono gestire soldi pubblici sono scelti con concorso nazionale per titoli,
primo dei quali la fedina penale intonsa; le cooperative che sono sorprese a
truccare le gare o a corrompere pubblici ufficiali perdono ogni beneficio di
legge dal punto di vista fiscale. In pochi giorni l’ampia maggioranza
destra-sinistra che ha dominato la scena della politica italiana negli ultimi
anni avrebbe potuto risolvere i tre problemi posti dall’indagine su «mafia
Capitale». Non ci sarebbero stati più i finanziamenti «segreti» della coop rossa
a Gianni Alemanno né le nomine di soggetti condannati per ricettazione come
Riccardo Mancini a capo dell’Eur Spa. Le cooperative rosse sarebbero state più
accorte ad assumere un tipo come Massimo Carminati. Invece il governo Renzi ha
preferito proporre l’ennesimo pacchetto di grida manzoniane che aumentano le
pene minime senza sfiorare i veri nodi delle fondazioni, delle municipalizzate e
del sistema cooperativo. Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra? All’indomani
della scoperta di «mafia Capitale», l’animo dei politici è confuso, molto
confuso. E non solo a livello locale. Il presidente del Consiglio Renzi difende
il suo ministro Poletti, fotografato quando era responsabile delle coop, insieme
a Buzzi, e dice: «È un galantuomo». E annuncia il commissariamento del Pd romano
con Matteo Orfini. Il premier è «sconvolto, perché vedere una persona seria come
il procuratore di Roma parlare di mafia mi colpisce molto. Vale per tutti il
principio di presunzione di innocenza e il governo ha scelto Raffaele Cantone
per l’anticorruzione. Certe vicende fanno rabbia, serve una riflessione
profonda». E ancora: «Certo, l’epicentro è l’amministrazione di Alemanno, ma
alcuni nel Pd romano non possono tirare un sospiro di sollievo». E così il
presidente di Dem annuncia che il partito a Roma è «da rifondare e ricostruire
su basi nuove». Ci sono un assessore e il presidente del consiglio comunale
indagati e dimissionari e altri esponenti sotto inchiesta. E il sindaco Ignazio
Marino parla di «pressioni» sulla sua amministrazione e assicura che «ha
sbarrato le porte a chiunque volesse influenzarla in qualsiasi modo». E
dell’ormai ex assessore alla Casa, Daniele Ozzimo, indagato e dimessosi, che nel
rimpasto di giunta era in predicato per assumere le deleghe al sociale, dice:
«L’ho conosciuto per la sua forza nell’imporre la legalità». Il ciclone
giudiziario soffia anche su quello che è stato il partito di Silvio Berlusconi a
Roma, il Pdl. A cominciare da Gianni Alemanno, ex sindaco, indagato per
associazione mafiosa, che appena ricevuto l’avviso di garanzia si autosospende
dagli incarichi in Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale e afferma su “Libero” e
“la Repubblica”: «Un anno e mezzo fa, dopo il primo articolo de “l’Espresso” sui
“quattro re di Roma”, tra cui Carminati, che io non ho mai conosciuto, anzi
pensavo fosse morto oppure in pensione, sono cominciate le allusioni. Allora
chiesi ai miei collaboratori: ma voi avete contatti, ci parlate? Fu un coro di
no». La scena che descrive l’ex sindaco potrebbe essere quella di una commedia.
Ma la storia è seria per poterci ridere sopra. E Alemanno ribadisce la propria
innocenza: «Due cose non rifarei. La prima: trascurare la composizione della
squadra. Ho sbagliato i collaboratori. Ma è capitato pure a Veltroni con
Odevaine, che era il suo vicecapo di gabinetto e che io ho allontanato appena
arrivato in Campidoglio. La seconda: non aver agito in totale discontinuità con
il passato». «Salvatore Buzzi – aggiunge Alemanno – il patron della cooperativa
29 giugno, io l’ho trovato ed è cresciuto sotto le amministrazioni di sinistra.
Non volevo fare la figura del sindaco di destra che caccia tutti quelli di
sinistra». Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra? Fra intercettazioni e sviluppi
investigativi, nell’inchiesta finiscono nomi di politici, non solo quelli
indagati ma anche altri che, pur non essendo stati colpiti da provvedimenti
giudiziari, vengono trascinati in questa storia dai protagonisti dell’indagine.
Nelle lunghe conversazioni spunta anche il nome di un altro politico di destra,
l’ex ministro Ignazio La Russa. Di lui parlano Pozzessere e Carminati: «Ignazio
doveva mette’ a pareggia’ all’interno... i conti di Ligresti... Ignazio
faceva... fa il capo bene lui... me lo ricordo, da ragazzini era così, eh, io
quando andavo a Milano... la federazione del Mis erano solo loro, lui, Romano,
er padre... vanno ai congressi e gli rompono sempre il cazzo al padre, gli
dicono che era mafioso perché era amico di Ligresti ... è Ligresti che viene da
me, no io che vado da lui». E c’è anche Gianni Letta, l’ex sottosegretario alla
presidenza del Consiglio. Buzzi punta alla gestione del Cara di Castelnuovo e
ottiene un incontro con Letta per tentare di sensibilizzare il prefetto di Roma.
Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra?
LA SINISTRA: IERI DIVERSI. OGGI CATTIVI E DANNOSI...OSSIA UGUALI.
Ieri diversi, oggi cattivi dannosi e pericolosi,
scrive Bruno Manfellotto su “L’Espresso”. Duecento tesserati in due ore. Falso
un iscritto su cinque. Il rapporto sul Pd romano fa impressione. Ma sarebbe bene
farne altri simili in tutto il paese. Cattivo. Dannoso. Pericoloso. No, non è un
virus. Si parla di Pd, la Ditta, l’ex Pci della diversità berlingueriana.
Secondo la lettura choc di Fabrizio Barca. E non è una battuta scappata in tv,
ma il punto d’arrivo di un’analisi minuziosa svolta su 110 circoli romani del
Pd, durata finora sei mesi, ricca di documentazione e di testimonianze dei
militanti (è tutto sul blog di Barca assieme al resoconto del suo precedente
“Viaggio in Italia”, personale inchiesta alla scoperta del partito condotta nel
2013 provincia per provincia). Dunque, un lavoro serio. Confesso che non mi era
mai capitato di leggere parole così dure, precise e taglienti sulla realtà
interna di un partito, scritte per di più da qualcuno che in quel partito milita
convintamente. Che siano poi firmate da Barca, uomo colto, scrupoloso, rigoroso
servitore dello Stato, è una garanzia in più di fedeltà e qualità. E però,
nonostante questo, il rapporto non ha avuto finora l’eco che merita. Forse
perché riguarda solo il Pd romano; o perché nei giorni in cui è stato diffuso un
primo documento (il lavoro continua), giornali e tv erano presi dalla strage di
Tunisi e dal pasticciaccio Lupi-Incalza. Ma nemmeno nei giorni successivi il
dibattito è decollato, anzi tutto è ricominciato stancamente come prima, con le
minacce di scissione a sinistra, le battutine sferzanti di questo contro quello
e la sempiterna ricerca di un anti-leader, stavolta individuato nell’ottimo
Giuliano Pisapia che non ha fatto a tempo ad annunciare di non volersi
ripresentare a sindaco di Milano per essere candidato a sua volta a capo di una
cosa che non c’è. Certo, Roma è stata colpita da Mafia Capitale, l’inchiesta che
ha investito anche frange di Pd, spinto Matteo Renzi a commissariare il partito
e a sua volta il commissario Matteo Orfini a incaricare Barca dell’indagine. Ma
quando si legge di assenza di trasparenza, di deformazioni clientelari, di
scorribande dei capibastone, di - testuale - carne da cannone da tesseramento
(si citano casi di “duecento tessere in due ore”, e si scopre che un tesserato
su cinque è falso), sale il timore che la malattia non si fermi all’ombra del
Cupolone. Del resto, quando il Pd ha chiamato a raccolta i suoi elettori, penso
alle primarie, ne sono capitate di tutti i colori, e non solo nel 2012 (una per
tutte, i cinesi in fila a Napoli). E alzi la mano chi non ha pensato subito a
infiltrati, brogli, tessere false. Renzi ha provato a evitare in Campania lo
scontro Vincenzo De Luca-Andrea Cozzolino, ma invano: si è dovuto beccare De
Luca con tutto il seguito di legge Severino e dintorni. Non era andata meglio in
Emilia dove i due candidati Stefano Bonaccini, caro al premier, e Matteo
Richetti sono finiti in una delle mille inchieste della magistratura. In Liguria
è finita con Sergio Cofferati che denuncia brogli. E l’altro giorno, mentre
Massimo D’Alema scaldava animi scissionisti, Renzi cercava di scongiurare la
candidatura a sindaco di Enna di Vladimiro Crisafulli, ieri giudicato
“impresentabile” alle politiche e oggi sponsorizzato dal Pd locale. Intanto ad
Agrigento le primarie del centrosinistra vedevano in testa Riccardo Gallo
Afflitto, vicesegretario regionale di Forza Italia, promotore di una lista
civica. Molte cose non tornano. E non c’è da meravigliarsi se alle ultime
regionali il Pd ha dimezzato i voti nella sua Emilia e a Livorno, storica
roccaforte rossa, ha conservato sì un sontuoso 52 per cento, ma è stato punito
alle contemporanee comunali nelle quali gli elettori hanno preferito il grillino
Nogarin. Intendiamoci, nel suo viaggio Barca ha incontrato anche un robusto Pd
né cattivo né dannoso né pericoloso, anzi, ma che spesso fatica a imporsi
sull’altro. Là dove ce la fa, ecco i “luoghi ideali”, simili a quelli dove in
questi mesi sono stati avviati significativi progetti pilota. Mi permetto di
suggerirne un altro: che almeno un circolo in ogni città chieda a Renzi di
estendere il metodo Barca in tutta Italia così che l’indagine sullo stato del Pd
conquisti il primo posto nel programma del partito. Sì, forse ne vedremo delle
belle. Ma lo sforzo di trasparenza e di pulizia aiuterebbe a riprendere quella
fiducia in se stessi che in tanti è andata dispersa.
A D’Alema bonifici per 87 mila euro. Vino e fondazione, i
versamenti all’ex premier. I pm potrebbero sentirlo
Nelle intercettazioni i timori dei dirigenti della coop Cpl: siamo ascoltati,
scrivono Fulvio Bufi e Fiorenza Sarzanini su “Il Corriere della Sera”. Erano
forniture annuali quelle che la «Cpl Concordia» ordinò all’azienda «La
Madeleine» di Massimo D’Alema. Spumante e vino rosso per 22.500 euro.
Complessivamente i versamenti ammontano dunque a 87mila euro in tre anni. Soldi
che i vertici della cooperativa sostenevano di aver elargito «perché è molto più
utile investire negli “Italianieuropei”». E di questo si parlerà domani nel
corso degli interrogatori di garanzia di Francesco Simone, che curava le
pubbliche relazioni dell’azienda, e del presidente Roberto Casari, entrambi
arrestati per dall’associazione per delinquere, corruzione, turbata libertà
degli incanti, riciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti. E
chiarimenti sulla natura di questi rapporti potrebbero essere chiesti allo
stesso D’Alema: i magistrati stanno valutando la sua convocazione dopo aver
ascoltato la versione degli indagati. Non sarà l’unico. L’inchiesta che ha
portato in carcere il sindaco di Ischia Giuseppe Ferrandino per le tangenti che
avrebbe preso per affidare la metanizzazione dell’isola alla «Cpl» si allargano
ai rapporti della cooperativa con le altre Fondazioni create dai politici. E
inseguono i soldi all’estero: a San Marino, dove Simone dice di poter muovere
fondi, ma soprattutto in Tunisia. È lo stesso manager, in passato fedelissimo di
Bettino Craxi, a vantarsi con il presidente del consiglio di amministrazione
Maurizio Rinaldi, della propria capacità di muoversi nel Paese africano: «Se tu
vuoi vieni una volta con me in Tunisia che è una cosa più sicura, ti apri il tuo
conto oppure fai un’altra società che costa duecento euro... Tunisia, offshore,
dove tu sei socio unico e garante, nella mia stessa banca, così è più veloce
l’operazione». Lui faceva la spola continuamente e quando si trattava di
nascondere i soldi da far rientrare in Italia li nascondeva nei posti più
strani, compreso il passeggino del figlio. Nelle conversazioni intercettate nel
marzo del 2014 Simone parla con una dipendente di «Italianieuropei» per
l’acquisto di 500 libri di D’Alema da presentare a Ischia. Specifica di essere
«disposto a pagare cifra piena se i soldi vanno alla Fondazione», altrimenti
chiede uno sconto del 10 per cento. La donna lo rassicura che il pagamento sarà
diretto e così si accordano per la fornitura dei volumi «ma anche del vino,
uniamo l’utile al dilettevole».
In realtà quelle bottiglie non sono le uniche acquistate. Secondo una nota dei
carabinieri del Noe, delegati alle indagini, «nel 2013 sono state comprate 1.000
bottiglie di spumante per 14.600 euro e nel 2014 altre 1.000 bottiglie di vino
rosso per 7.900 euro». Uniti a tre bonifici da 20.000 euro l’uno elargiti alla
Fondazione e alle centinaia volume «Non solo euro» fanno 87.300 euro. Quando
decidono quali Fondazioni devono finanziare i vertici di «Cpl» sono molto
espliciti, come spiega il responsabile commerciale in un colloquio del maggio
scorso. Verrini : «Il mio problema però è questo, queste persone poi quando è
ora, le mani nella merda ce le mettono o no?». Simone : «...dobbiamo pagarlo
perché ci porta questo e chiudiamo questo, no venti ma anche duecento...». Non
si sa a chi si riferiscano, gli atti sono coperti da omissis «per ragioni
investigative». Certo è che un filone dell’indagine, come scrive il giudice, si
concentra sui versamenti «al mondo politico-istituzionale, ovvero a quelle
fondazioni o associazioni che in qualche modo sono espressione di tale mondo». E
infatti sottolinea come «il tenore e il contenuto della conversazione appaiono
fondamentali anche per la valutazione delle esigenze cautelari, e in particolare
della pericolosità sociale dei protagonisti della vicenda, rappresentando lo
“specchio” della strategia aziendale di tale cooperativa, con particolare
riferimento ai rapporti e alle relazioni “patologiche” esistenti tra gli uomini
espressione di tale cooperativa da una parte ed esponenti politici (e più in
generale della pubblica amministrazione) dall’altra, rapporti sovente
“schermati” attraverso triangolazioni con fondazioni varie e di varia natura».
Accertamenti che riguardano anche i rapporti diretti con chi si sarebbe mostrato
disponibile ad agevolarli, come il sottosegretario Simona Vicari, vera
promotrice dello sblocco di 140 milioni di euro nella legge di stabilità come
loro avevano sollecitato e sul conto della quale sono tuttora in corso nuove
verifiche. Dalle intercettazioni raccolte dagli investigatori si capisce che
alla Cpl c’era la consapevolezza di essere al centro di una indagine. «Siamo
ascoltati», dice Simone a Verrini. In un’altra conversazione Simone fa
riferimento al generale della Guardia di Finanza Michele Adinolfi (già coinvolto
in altre inchieste) e parla della necessità di ricercare microspie negli uffici
della cooperativa: «Ho parlato con un assistente di Adinolfi... Serve fare una
bonifica, Nicò! Quando mi autorizzi chiamo il generale, ce la facciamo fare,
però ovviamente ci farà un prezzo di riguardo. Però facciamola».
A SINISTRA: DA ACCUSATORI AD ACCUSATI LE COSE CAMBIANO.
D’Alema e il caso Ischia: «Così la magistratura si delegittima da
sola. Il Csm e l’Anm devono intervenire». L’ex
premier: «Non ritengo legittimo l’uso di intercettazioni come quello nei miei
confronti. Abolito il finanziamento pubblico ai partiti, ora si criminalizza
quello privato», scrive Giovanni Bianconi su “Il Corriere della Sera”. Il giorno
dopo, Massimo D’Alema è ancora «indignato e offeso».
Davvero non ha trovato una ragione a giustificazione dei
magistrati che hanno inserito il suo nome nell’ordine d’arresto per le presunte
tangenti a Ischia?
«E quale potrei trovare? Si parla di un’ipotesi di reato, tutta da dimostrare,
in cui io non c’entro. Non c’era alcuna necessità di utilizzare intercettazioni
fra terze persone, senza valore probatorio, dove si parla di me de relato.
Allora mi viene il sospetto che ci sia un motivo, per così dire,
extra-processuale».
Sarebbe a dire?
«Dubito che la notizia dell’arresto del sindaco di Ischia e qualche suo presunto
complice sarebbe finita sulle prime pagine dei giornali, se nell’ordinanza non
fossero stati citati D’Alema, Tremonti, Lotti o qualche altro personaggio di
richiamo. Ma se questa fosse la logica che ha ispirato i magistrati, ci sarebbe
da preoccuparsi. Non per me, ma per il funzionamento della giustizia. Anche
perché negli ultimi tempi si sono susseguite diverse assoluzioni che hanno
sconfessato le indagini, soprattutto nei confronti di amministratori locali
addirittura arrestati. Se le inchieste avessero l’obiettivo di una più efficace
ricerca delle prove, anziché di qualche forma di pubblicità, credo sarebbe più
utile alla giustizia e alla moralità pubblica».
Che fa, delegittima anche lei la magistratura solo perché
stavolta è stato toccato dal «pubblico ludibrio» delle intercettazioni?
«Io non delegittimo nessuno. Sono stato a lungo indagato e sempre prosciolto,
anche quando avevo responsabilità di governo. Un pm ha dovuto risarcirmi per i
tempi troppo lunghi di accertamento della verità, a spese dei contribuenti, come
credo che per altre ragioni sia capitato pure al pm di Napoli titolare di questa
indagine. Credo però che l’organo di autogoverno della magistratura, il Csm, ma
anche l’Associazione magistrati, dovrebbero esercitare una maggiore vigilanza
affinché certe misure non siano superate e la magistratura non si delegittimi da
sola. Non ritengo legittimo un uso delle intercettazioni come quello che è stato
fatto nei miei confronti».
Ha riforme da suggerire?
«No, dico che serve maggiore autocontrollo tenendo presente che i magistrati
devono accertare fatti e reati, senza attribuirsi funzioni politiche o
pubblicistiche di altro genere. Proprio per mantenere integro il rispetto che si
deve alla funzione giudiziaria e che io conservo: sono un garantista, ma anche
un legalitario».
Nelle intercettazioni gli indagati dicono che lei era disponibile
a «mettere le mani nella merda» per loro, e che già gli «aveva dato delle cose»;
parole che per pm e giudice non sono affatto irrilevanti. Non è questo suo
presunto ruolo che dovrebbe indignarla e offenderla?
«Io ho solo aderito agli inviti a partecipare a iniziative pubbliche. Non ho
fatto niente per queste persone, che sono state interrogate: immagino che se i
magistrati avessero ritenuto di dovermi contestare dei reati lo avrebbero fatto.
D’altra parte, se hai motivo di ritenere che ci sia stato un illecito, me lo
contesti e io mi difendo. Insomma, compito del magistrato è provare a verificare
il contenuto di quelle parole, che possono essere millanterie, frasi in libertà
o qualunque altra cosa, prima di darle in pasto al pubblico».
Lei che rapporti aveva con le persone arrestate?
«Il sindaco di Ischia Ferrandino l’ho conosciuto nel 2014, quindi quando il
presunto reato era, eventualmente, già stato consumato. Con i responsabili della
Cpl, Roberto Casari e Francesco Simone, avevo rapporti più risalenti nel tempo,
ma non ho mai fatto alcunché di illecito, né me l’hanno chiesto. Del resto se in
due anni di intercettazioni non c’è la mia voce qualcosa vorrà dire...».
Dunque non sa perché dicessero quelle frasi?
«Io no. Mi auguro che i magistrati lo chiedano a loro».
E l’acquisto dei suoi libri e dei suoi vini?
«L’acquisto dei libri, legato a una presentazione in concomitanza con
un’iniziativa elettorale a favore di Ferrandino candidato alle elezioni europee
del 2014, rientra nei finanziamenti che noi raccogliamo per la fondazione
Italianieuropei , un’associazione culturale che pubblica una rivista prestigiosa
e svolge molte iniziative importanti. Tutto alla luce de sole, così come le
donazioni, regolarmente messe a bilancio. Quando abbiamo cominciato, sedici anni
fa, abbiamo ricevuto sostegno da Pirelli, dalla Fiat, da De Benedetti e molte
altre imprese. Quanto al vino, mi scusi ma mi viene da sorridere: se i pm
vogliono acquisire agli atti una buona guida enologica scopriranno che i nostri
spumanti sono segnalati tra i migliori, ed è notorio che in occasione delle
festività le aziende ne acquistano in quantità per regalarli. Li abbiamo venduti
e fatturati, concedendo la possibilità di pagare quattro mesi dopo: siamo noi
che abbiamo fatto il favore alla cooperativa, non viceversa».
L’acquirente dice che fu lei a chiedere di comprare...
«Nel particolare non mi ricordo. Ma in generale consiglio a tutti di comprare il
nostro vino. Spero non sia un reato grave... Ho sentito anche dire che siccome
io sono una persona nota c’è chi compra per simpatia e dunque questa sarebbe
concorrenza sleale, ma vale anche il contrario: c’è chi non compra per
antipatia, come è ovvio e lecito che sia. Dov’è il reato?».
Reati a parte, ci sono questioni di opportunità politica che
emergono dalle indagini e hanno un loro peso. Come è capitato all’ex ministro
Lupi.
«Premessa la mia totale solidarietà nei suoi confronti, credo che ci sia un po’
di differenza tra l’avere la responsabilità di un ministero e contemporaneamente
rapporti con chi ottiene appalti e commesse, lavorando proprio con quel
ministero, e chi, senza incarichi istituzionali, continua a fare politica da
privato cittadino».
E raccoglie fondi per la sua fondazione, come faceva quando era
parlamentare...
«Prima è stato abolito il finanziamento pubblico dei partiti, ora si
criminalizza il finanziamento privato della politica. E dopo che resterà? Lo
chiedo in generale, perché Italianieuropei non ha mai beneficiato di
finanziamenti pubblici, ma ha sempre vissuto con il sostegno di semplici
cittadini e imprenditori. Sono favorevole a regole di maggiore trasparenza nel
finanziamento delle fondazioni, magari accompagnate con qualche serio incentivo
fiscale. Ma episodi come quello di cui stiamo parlando spaventano le persone e
le allontanano anche da legittime attività di sostegno. Per questo io sono
preoccupato: non per l’azienda di famiglia, ché anzi, gli ordini dei vini stanno
aumentando in segno di solidarietà, bensì per il futuro di Italianieuropei».
E per il futuro del Pd? I fatti emersi negli ultimi tempi non
sono sintomo di una «questione morale» nel partito e nella sua classe dirigente?
«Il Pd è un partito di governo a tutti i livelli. E questo, naturalmente, lo
espone a rischi di compromissione e inquinamento, che non debbono essere
sottovalutati. È evidente che ci vuole maggiore vigilanza».
La vera storia del vino di D'Alema. Presto interrogato dai
giudici, scrive di Giacomo Amadori su “Libero
Quotidiano”. In questa storia è tutto rosso o per lo meno rosé: le Coop,
le presunte tangenti e pure il vino. Infatti nell’inchiesta della procura di
Napoli che indaga sui fondi neri e le presunte mazzetta pagate dalla Cpl
Concordia, spunta il nome dell’azienda vitivinicola della famiglia di Massimo
D’Alema, La Madeleine, adagiata sulle colline umbre tra Otricoli e Narni
(Terni). Nei giorni scorsi l’ex premier è stato avvistato nello stand dei
produttori umbri del Vinitaly, intento a vendere personalmente le sue etichette.
Ma dalle nuove carte giudiziarie apprendiamo che per piazzare i suoi “rossi”
Baffino preferisce andare sul sicuro e rivolgersi ai vecchi compagni. Uno degli
arrestati di ieri, il barese Francesco Simone, responsabile delle relazioni
istituzionali del gruppo Cpl Concordia, il 6 novembre aveva dichiarato agli
inquirenti: «Confermo che la Cpl ha acquistato 2.000 bottiglie di vino prodotte
dall’azienda della moglie di D’Alema, tuttavia posso rapprsentarvi che fu
Massimo D’Alema in persona, in occasione di un incontro casuale tra me, lui, il
suo autista e il presidente Casari a proporre l’acquisto dei suoi vini». Il
giudice Amelia Primavera nell’ordinanza chiosa con una certa perfidia: «Visto il
prezzo pagato dalla Cpl Concordia per ciascuna delle 2.000 bottiglie di vino
acquistate (non si tratta di un prodotto da somministrare in una mensa
aziendale) si tratta evidentemente di un’altra delle "eccezioni" cui faceva
riferimento lo stesso Simone per parlare dell’acquisto dei libri». Ma quanto
valgono 2 mila bottiglie di nettare rosso dalemiano? L’ordinanza non lo svela.
La moglie di Massimo D’Alema, Linda Giuva, procuratore speciale dell’azienda, si
limita a farci sapere che i prodotti sono stati inviati in tre momenti diversi
(novembre 2013, aprile 2014 e ottobre 2014) e che «gli acquisti sono stati fatti
in occasione delle festività». Tre le etichette vendute: il prodotto base, in
vendita a 9,50 euro, il Cabernet Franc "Sfide"; lo spumante Nerosé (17,50 euro)
e il pinot nero Narnot, (29 euro, 70 il magnum). Tutte ideazioni dell’enologo
dei vip Riccardo Cottarella. «I pagamenti sono avvenuti tramite bonifico
bancario che hanno seguito le fatture di circa mediamente 130 giorni (…) i
prezzi sono stati quelli di listino». La signora sottolinea che la Cpl il regalo
non lo ha fatto a loro, ma ai propri clienti, visto che i vini della Madeleine
piacciono e «un’etichetta è esaurita da più di tre mesi». Forse per questo la
coop si è anche preoccupata di organizzare la presentazione dell’ambrosia di
casa D’Alema nell’isola di Ischia. Il solito Simone ne discute al telefono con
la segretaria della Fondazione Italianieuropei dello stesso D’Alema: «Io ho poi
parlato con (…) la Linda (…) perché siccome noi come Cpl abbiamo preso anche
alla signora del vino (…) volevamo fare un’iniziativa di presentazione del vino
suo loro a Ischia con tutti i ristoratori e gli albergatori una cosa bella…
l’utile al dilettevole: presenteremo il libro (di D’Alema ndr) e…». Il vino.
Simone ha le idee chiare: «Volevo organizzare un fine settimana a Ischia per
presentare il libro e poi a latere senza ovviamente nessuna evidenza pubblica
mentre il libro sarebbe una manifestazione pubblica». Quindi in piena campagna
elettorale per le Europee del 2014 "il compagno D’Alema" come lo chiamano un po’
ironicamente gli indagati, promuove la sua ultima impresa editoriale e la
moglie, a rimorchio, le bottiglie. La coppia nel luglio scorso ha avuto l’onore
di ricevere praticamente sotto casa, a Gallipoli, (storico buen retiro
dalemiano) il premio Barocco, «condotto con sobrietà da Alba Parietti» si legge
sul sito della Madeleine. Nella motivazione si ricorda «che la nuova avventura
imprenditoriale rappresenta una delle tante "Sfide" che Linda Giuva ha portato
avanti nella sua vita, ricordando così il nome di uno dei prodotti della
Madeleine». La Parietti che premia l’amica Linda è la metafora perfetta di una
"sfida" solo immaginaria, la vendita del proprio vino nel circuito delle coop
rosse più riconoscenti e disponibili. Nella Madeleine non mancano altri incroci
curiosi. Per esempio il socio dei figli di D’Alema è l’imprenditore barese
Francesco Nettis, conosciuto attraverso Roberto De Santis, sodale da quasi 40
anni di Baffino e già armatore della sua barca a vela. De Santis è stato
recentemente perquisito nell’inchiesta sulle Grandi opere di Firenze e con
Nettis ha usufruito di una vacanza in barca a Saint Tropez con belle fanciulle
al seguito a spese di Giampaolo Tarantini, il presunto procacciatore di escort
per Silvio Berlusconi. L’esclusiva crociera doveva servire a «ricompensarlo (De
Santis ndr) delle conoscenze (D’Alema compreso ndr) che mi aveva fatto fare» ha
detto Tarantini a verbale. E gli intrecci non sono finiti. Nel 2009 Francesco
D’Alema, erede non ancora diciannovenne dell’ex premier, ha acquistato il 40 per
cento dell’azienda agricola da un prestanome dell’avvocato Sergio Melpignano,
fiscalista noto alle cronache anche per alcune traversie giudiziarie oltre che
proprietario di un esclusivo resort molto amato dal fu Lìder Maximo. Per dieci
mesi questo professionista è stato il socio "occulto" del cadetto di casa
D’Alema. Poi l’ex segretario dei Ds ha acquistato l’intero pacchetto. Non prima
di aver indicato a Melpignano, il nome del "compagno" Adolfo Orsini, ex
dipendente di Asl e sindaco di Città di Castello (Perugia), per l’incarico di
«rappresentante delegato della società agricola» nell’acquisto dei «diritti di
reimpianto» di viti presso diversi agricoltori locali. Orsini nel 2010 diventa
così l’amministratore unico dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e
l’innovazione in agricoltura ed è probabilmente anche grazie alla sua esperienza
che la Madeleine ottiene 57mila euro di finanziamenti regionali. Orsini è stato
socio anche nella Soluzioni di business (Sdb) di Vincenzo Morichini, pure lui
umbro, ex socio di D’Alema nella barca a vela Ikarus e suo fundraiser per la
fondazione Italianieuropei. Quando nel 2011 Morichini viene coinvolto in una
vicenda di appalti e mazzette, legati all’Enac, l’ente dell’aviazione civile, il
nome di Orsini finisce in un pizzino con un elenco di presunti contributi
sospetti a politici, ma la sua posizione viene subito chiarita. Il 27 settembre
2013, con un decreto del ministero delle Politiche agricole, è nominato
consigliere dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare
(Ismea), poltrona su cui è stato riconfermato l’estate scorsa. Ecco la morale
della favola: per le sue “Sfide” D’Alema preferisce affidarsi a un rodato
circuito di amici e compagni. Che, miracolosamente, ottengono incarichi ed
appalti. Per poi brindare, magari, con un Nerosé della real casa.
"Non sono come Lupi". D'Alema passa nel torto pure quando ha
ragione. Nel difendersi dalle insinuazioni cade nella
solita superiorità morale della sinistra. E così la vigliaccata su di lui
finisce in secondo piano, scrive Renato Farina su “Il Giornale”. È stato
sputtanato a sangue, anzi a vino, merda e libri, con un cocktail di
intercettazioni micidiali fornito dalla ditta Woodcock. Nessuna indagine su di
lui, ma citazioni perfette per annegarlo a testa in giù nel cabernet della sua
cantina. Una vigliaccata, non si fa. A nessuno. E lo abbiamo scritto. Come
reagisce, Massimo D'Alema? È inutile, è più forte di lui: crede di essere il
primo e unico essere superiore vittima di questo trattamento di immersione nella
fossa dei coccodrilli. Siccome però vede che c'è un altro tizio arrivato lì poco
fa tra le fauci degli alligatori, precipitato anche lui con al collo le
intercettazioni senza essere indagato, che fa D'Alema? Come un Conte Ugolino lo
morde sulla nuca. In prima pagina, Il Mattino di Napoli titola: «Io, offeso e
indignato non sono come Lupi». È un messaggio destinato al popolo comunista, ma
se possibile diretto anche a Zeus che poteva tirargli fulmini, inviargli come a
Prometeo un'aquila a squarciargli il petto e a divorargli il fegato: però solo a
lui. Cos'è questa confusione? Cosa ci fa lì, anche Maurizio Lupi? No, questo per
D'Alema è insopportabile. Persino quando ha ragione, Massimo D'Alema riesce ad
aver torto, a manifestarsi per quella creatura umana sì, ma diversa, tipicamente
figlia dell'educazione comunista, per cui lui, gettato a terra da mosse schifose
dell'avversario, riesce a rivoltarsi e per prima cosa sputazza sui compagni di
sventura. È superiore moralmente anche nelle intercettazioni. Guai ad
accomunarlo alla genia degli esseri che non sono stati introdotti da piccoli
alla visione estatica di Palmiro Togliatti. Nello specifico. Dove sta la
differenza con Lupi? Abbiamo provato a scavare. In effetti. La storia dei vini
firmati D'Alema acquistati dalla cooperativa Concordia, nel numero di duemila
bottiglie, sono cose normali, normalissime. Ad esempio. A Predappio si produce
il vino del Duce, un sangiovese ovviamente nero, e i nostalgici lo acquistano
non per le recensioni del Veronelli e del Gambero Rosso, ma poiché credono di
rinvenirvi sentori residui di olio di ricino e di palmizi imperiali per la
gloria dell'idea fascista. Immaginiamo accada la stessa cosa con le etichette di
casa D'Alema: sono un segno di appartenenza, le Coop rosse si specchiano in quei
riflessi e così i loro clienti, se mai avessero un dubbio, capiscono chi è il
loro santo in Paradiso, e nella vigna. Ovvio. In fondo, anche se con finali
diversi, sono entrambi, Benito e Massimo, ex primi ministri. Siamo assolutamente
certi che per decidere la commessa (i prezzi per i privati, comprensivi di Iva,
partono dalle 9,50 euro del Cabernet Franc Sfide alle 17,50 del Nerosè) abbiano
nominato una commissione di enologi che hanno assaggiato alla cieca trenta
diverse bottiglie di rosso, scegliendo il migliore. O no? Così per i cinquecento
libri prodotti coi grappoli ubertosi cresciuti nella testa del medesimo D'Alema,
Non solo euro. Anche lì ordinati si suppone previa consultazione di una severa e
imparziale giuria della Fondazione Gramsci. O no? Ciascuno ha le sue idee. Ma
perché caro D'Alema ci tieni così tanto a stabilire le distanze da Lupi,
implicitamente dandogli del disonesto? Sostieni di essere un «pensionato»,
mentre Lupi era un ministro, dunque è diverso, molto diverso. Le intercettazioni
fanno presente tuttavia che in realtà D'Alema vi è rappresentato come un
pensionato piuttosto vispo e in carriera. Siamo costretti alla citazione da
D'Alema, se no come si fa il paragone? «Bisogna investire negli Italianieuropei
dove D'Alema sta per diventare commissario europeo... D'Alema mette le mani
nella merda come ha già fatto con noi e ci ha dato delle cose». Insomma:
comprano per imbonirsi uno molto bravo a interessarsi delle cose, e che presto
diventerà super-ministro. E com'è nato l'acquisto della partita di vini
dalemiani? Stralcio di verbale d'interrogatorio dell'acquirente: «Posso
rappresentarvi che fu D'Alema in persona in occasione di un incontro casuale, a
proporre l'acquisto dei suoi vini». Si noti poi il particolare fornito dal
compratore per conto della Coop Concordia: i vini sono dell'«azienda della
moglie di D'Alema». Secondo noi ha ragione D'Alema. Non è come Lupi. Lupi è
meglio.
Giuliano Ferrara a Massimo D'Alema: scrivi un libro.
Un consiglio, quasi un'esortazione quella che Giuliano Ferrara fa
a Massimo D'Alema su Il Foglio, scrive “Libero Quotidiano”. Un consiglio
elargito sotto forma di una lettera che comincia così: "Gentile D'Alema che lei
si senta "indignato e offeso". Una cooperativa amica può comprare derrate di
suoi libri ed ettolitri del suo vino senza che il venditore debba sentirsi
infamato da un reato penale, magari per accostamento a pratiche corruttive del
sindaco di Ischia (da provare) o addirittura al clan dei Casalesi specie se
l'accostamento sia ricavato da intercettazioni in cui se ne dicono delle
brutte". Ferrara spiega come anche lui sia "schifato" dall'uso che ne viene
fatto dalle intercettazioni. E evidenzia come Il Foglio si sia sempre "indignato
e offeso" "di fronte a questa manomissione del diritto e della verità storia e
dell'autonomia della politica". Fatta questa premessa, l'ex direttore dà un
consiglio all'ex premier: scrivere un libro. Un libro-verità "che metta
definitivamente le cose a posto". Sarebbe un caso editoriale. E poi la battuta
finale: "Ne acquisteremmo tre, quattrocento copie, e poi faremmo un brindisi con
il suo buon vino di Umbria".
Arrestato il vino di D'Alema. Milioni, mazzette e bottiglie: manette nel Pd e
nella super coop, scrive Salvatore Tramontano su Il Giornale”. Dopo Lupi,
D'Alema. I malpensanti diranno che chi attraversa la strada di Renzi si ritrova
con la faccia nel fango. È la teoria del gatto nero, che si specchia con quella
governativa dei gufi. La realtà è meno scaramantica e forse anche un po' più
preoccupante. Lupi e D'Alema non sono indagati, ma la condanna delle
intercettazioni vale più di una sentenza. Sono le frasi a effetto che fanno la
differenza, i simboli. A Maurizio Lupi sono stati fatali la mezza
raccomandazione a favore del figlio e l'orologio superlusso, per D'Alema il vino
comprato dalla Coop coinvolta nello scandalo e il dialogo «rubato» tra due
esponenti della stessa cooperativa. Ecco cosa si sono detti: «Ci sono politici
che mettono le mani nella merda e quelli che non lo fanno. D'Alema mette le mani
nella merda come ha già fatto con noi. Ci ha dato delle cose». Quello che un
tempo era l'uomo forte del Pd urla tutta la sua rabbia contro questo gioco di
ventilatori. Si chiede come sia possibile che queste intercettazioni del tutto
irrilevanti ai fini dell'inchiesta finiscano su stampa e tv. Perché? Con quale
obiettivo? Secondo quale legge ed etica? Benvenuto a giustiziopoli. D'Alema ha
fatto conoscenza con il metodo Woodcock, il pm acchiappavip, che da Fabrizio
Corona a Vittorio Emanuele, da vallettopoli alla famiglia Mastella si è
specializzato nel tanto rumore per nulla. Solo che le risposte alle sue domande
sono tutte a sinistra. Le procure da almeno vent'anni i processi li fanno prima.
Le intercettazioni da strumento utile per le indagini sono ormai una gogna
politica. Ed è certo che le carte non escano da sole dagli uffici giudiziari per
accomodarsi nelle pagine dei giornali. C'è qualcuno che le passa e spesso
sceglie i tempi dell'uscita. L'indignazione di D'Alema è arrivata con decenni di
ritardo. Non era lui quello della scossa sulla testa di Berlusconi? Ma peggio di
D'Alema stanno le Coop rosse. Non c'è inchiesta che negli ultimi tempi non le
veda protagoniste. È la caduta buzziana di Mafia capitale, è l'affare delle
grandi opere, e questa volta a Ischia finisce nella polvere la Cpl Concordia, re
del metano e una delle cooperative più antiche d'Italia. Sembra la fine di un
sogno, di un'utopia. C'era una volta la coop sei tu, il sogno padano della terza
via tra capitalismo e comunismo. La coop riconosciuta e protetta dalla
Costituzione. C'è da chiedersi invece come la ragnatela delle Coop rosse sia
diventata una fabbrica di appalti sospetti, in una zona grigia di politica e
affari. Una cooperazione a delinquere.
D'Alema minaccia il giornalista: "Mi dica il nome, la denuncio".
Il giornalista di Virus gli chiede del vino
acquistato dalla coop finita nell'inchiesta per mazzette. D'Alema sbotta: "La
querelo". Nicola Porro: "Si adoperi piuttosto per cambiare le leggi", scrive
Sergio Rame Mer, 01/04/2015, su “Il Giornale”. "Gli acquisti (del vino, ndr)
sono avvenuti nel corso di due anni non in una convention del Pd, sono stati
regolarmente fatturati e sono avvenuti in prossimità delle festività,
evidentemente per fare regali come fanno molte imprese". Massimo D'Alema perde
le staffe e sbotta. Non riesce proprio a sopportare la domanda di un giornalista
di Virus che gli chiede delle bottiglie di vino acquistate dalla CPL
Concordia, la cooperativa rossa finita nell'inchiesta per mazzette a Ischia. "Io
la querelo - tuona l'ex premier davanti a tutti - non sarebbe il primo oggi".
Poi minaccia: "Mi dia il suo nome, le arriverà una denuncia". All'Università di
Bari, dove partecipa al convegno Sprofondo Sud sull’ultimo numero della
rivista Italianieuropei, D'Alema si scontra duramente con Filippo Barone,
giornalista della trasmissione Virus che domani sera torna su Rai 2 con
Nicola Porro. Barone interroga l'ex premier proprio sull'opportunità di
mischiare una convention del Pd alla vendita di vini. "Come risulta chiaramente
dalle fatture - replica, secco, l'ex Ds - quegli acquisti sono avvenuti nel
corso di due anni, in prossimità di festività, evidentemente per fare regali,
come fanno molte imprese e sono stati fatturati ad un trattamento di favore, con
pagamenti a quattro mesi e non in una convention del Pd". Come ricostruisce lo
stesso D'Alema, si è trattato di "acquisti avvenuti nel corso di due anni,
regolarmente fatturati e non certo nel corso di una convention del Pd, non
c’entra nulla". Poi, rivolgendosi al giornalista di Virus che gli ha
posto la domanda, aggiunge: "E siccome sto denunciando diversi giornali,
denuncerò anche lei, lei dice cose sciocche". In una intervista al Corriere
della Sera, poi, D'Alema invita il Csm e l’Associazione nazionale magistrati
a "esercitare una maggiore vigilanza affinché certe misure non siano superate e
la magistratura non si delegittimi da sola". "Non ritengo legittimo - conclude -
un uso delle intercettazioni come quello che è stato fatto nei miei confronti".
Ogni volta che l'abuso delle intercettazioni va a colpire un democrat, si apre
un caso nazionale. Quando tocca a un esponente del centrodestra, allora tutto
passa sotto silenzio. "Si risparmi le querele - scrive Nicola Porro su Facebook
- si adoperi piuttosto per cambiare le leggi". Il caso D'Alema sarà tra i temi
della puntata di Virus di domani. "Sono convinto, per quello che conta,
che queste intercettazioni sono una schifezza - continua Porro - per di più il
metodo Woodcock che ben conosco, si basa su intercettazioni a strascico". Il
conduttore di Virus è d’accordo con D'Alema sul fatto che se non lo
avessero tirato in ballo, tutta l’inchiesta avrebbe avuto minore rilevanza
mediatica. "Detto questo - chiosa - mi chiedo per quale dannato motivo quando si
è parlato delle intercettazioni e delle leggi che le volevano regolamentare il
nostro Leader maximo non si è adoperato per farle passare anzi in un caso le ha
esplicitamente affossate. E mi chiedo per quale motivo la sinistra fino a quando
non è toccata direttamente fischietta facendo finta che non ci sia un problema
con la giustizia spettacolo". Poi Porro incalza: "Ci spieghino, cosa dobbiamo
fare allora? le intercettazioni del Cav, dei suoi amici, di oscuri consiglieri
regionali, di faccendieri vari; favolette come la culona della Merkel o regali
di Rolex possono finire in tv, diventare miti e quelle che riguardano Dalema no?
Domani - conclude Porro - Virus ha intenzione di parlare anche di queste
cose e delle inchieste di Woodcock il cui stile di intercettazione e di
inchieste viene improvvisamente scoperto dalla sinistra. Ben arrivata e si
risparmi le querele. Si adoperi piuttosto per cambiare le leggi".
D’Alema: «Tutelare non indagati». Denuncerò chi dice il falso».
In mattinata sfuriata contro un giornalista sulla questione dei vini alle coop.
In serata replica dell’Anm: «Pensare ai reati». Gratteri: punire pubblicazione
arbitraria, scrive “Il Corriere della Sera”. «Che noi abbiamo venduto dei vini
alla cooperativa Cpl è vero, però non ho capito perché questo debba essere
contenuto in un atto giudiziario dal momento che non è un reato». Massimo
D’Alema non usa mezzi termini riguardo alla vicenda che lo vede coinvolto,
intercettato nell’ambito di un’indagine per presunte tangenti a Ischia. «Non
sono indagato per nessun reato - ha detto con fermezza da Bari, dove si trovava
per un convegno della Fondazione che presiede Italiani Europei. Allora - ha
continuato - perché si devono rendere pubbliche in un atto giudiziario cose
private di persone, tra l’altro in questo caso si tratta di mia moglie, che non
sono indagate, che non hanno compiuto alcun reato. E che vengono semplicemente
gettate in pasto così all’opinione pubblica per poter essere diffamate. Occorre
- ha concluso - una tutela delle persone che non sono indagate». Concetti che
aveva già ribadito in un’intervista al Corriere,sostenendo che, così facendo,
«la magistratura si delegittima da sola». E in serata arriva la reazione
dell’Anm: «Fermare l’attenzione sui fatti gravi di corruzione che stanno
emergendo, non sulle polemiche»: è l’invito alla stampa dell’Anm. .La
riservatezza «va tutelata», ma «non si mettano in discussione le intercettazioni
come strumento di indagine». A proposito del diritto di difesa e riservatezza
delle comunicazioni, nel frattempo, una nuova fattispecie di reato di
«pubblicazione arbitraria di intercettazioni» viene proposta dalla commissione
Gratteri. Il nuovo reato si accompagnerebbe, tra l’altro, alla previsione
dell’«inedito divieto» all’autorità giudiziaria a inserire il testo integrale
delle intercettazioni. Quest’ultima disposizione - è scritto nella proposta -
«mira a una tutela rafforzata del diritto di privacy, eliminando il fenomeno
negativo della divulgazione, proprio tramite gli atti dell’autorità giudiziaria,
del contenuto di informazioni che esulano l’accertamento processuale. Si vuole
così porre uno deciso e serio sbarramento alla possibilità che la lesione alla
sfera riservata degli intercettati possa trovare la sua origine nell’ attività
di impiego procedimentale o processuale dei risultati delle intercettazioni».
Intanto, a margine del convegno, è scoppiata una lite tra D’Alema e un
giornalista del programma tv Virus. «Lei ha detto -si è infuriato l’ex premier -
che ho venduto il vino durante una convention del Pd, come si chiama lei, scusi?
Devo trasmettere al mio avvocato questa informazione. La prego di mandare questa
registrazione, avrà una denuncia». Un’intemerata che si è svolta sotto gli occhi
delle telecamere: «Quegli acquisti sono avvenuti nel corso di due anni non in
una convention del Pd. Lei dice delle cose sciocche perché quegli acquisti, come
risulta chiaramente dalle fatture sono avvenuti nel corso di due anni, sono
stati regolarmente fatturati, sono avvenuti in prossimità delle festività
evidentemente per fare molti regali come fanno molte imprese e sono stati
fatturati con trattamento di favore, diciamo, perché con fatture a 4 mesi», ha
spiegato, ribadendo: le bottiglie «non sono state vendute nel corso di una
convention del Pd, quindi la pregherei, siccome sto denunciando, oggi, diversi
giornali, denuncio anche lei, con l’occasione». «Ben arrivata» alla sinistra
sulla questione intercettazioni e «si risparmi le querele. Si adoperi piuttosto
per cambiare le leggi», scriveva qualche ora dopo sulla sua pagina Facebook
Nicola Porro, conduttore di Virus, criticando l’uscita dell’esponente Pd. «Mi
dispiace di essermi arrabbiato con un collega - si è giustificato poco dopo
D’Alema - ma metterei in guardia i giornalisti dal dichiarare o scrivere simili
e palesi sciocchezze». E che all’ex premier la faccenda non sia andata giù lo
rivela la nota dei suoi legali, che dicono di aver «ricevuto mandato di tutelare
la sua onorabilità in sede sia civile che penale da ricostruzioni evidentemente
errate e strumentali che compaiono oggi su alcuni organi di stampa». Sono sempre
gli avvocati a ricostruire: «L’on. D’Alema - sottolineano - non ha personalmente
ricevuto alcunché dalla cooperativa CPL Concordia, né direttamente né
indirettamente. La CPL Concordia ha acquistato copie del libro `Non solo euro´
in occasione di una manifestazione politica in vista delle consultazioni
elettorali europee del 2014 e, nell’arco di un biennio, circa 2.000 bottiglie di
vino dell’azienda agricola della famiglia del Presidente D’Alema, regolarmente
fatturate e pagate con bonifici a quattro mesi di distanza dalla fornitura.
Infine la CPL Concordia ha effettuato, in tre diverse annualità, finanziamenti
del tutto leciti alla Fondazione Italiani Europei, che notoriamente non è una
fondazione personale dell’on. D’Alema ma un istituto che egli presiede e dirige,
politicamente e culturalmente, a titolo del tutto volontario, senza beneficiare
né direttamente né indirettamente dei contributi che la stessa riceve per la sua
attività». Il caso D’Alema riporta così alla ribalta il tema delle
intercettazioni, che spesso coinvolgono anche non indagati all’interno di
inchieste delicate (vedi recentemente il caso Lupi, costretto a dimettersi da
ministro).«Un intervento del legislatore sarebbe opportuno, non limitando
l’intervento della magistratura e non mettendo il bavaglio alla stampa, ma
tutelando l’onorabilità e la riservatezza delle persone non indagate», dice il
vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, a
margine di un convegno su «Economia e legalità» a Roma. «Il presidente D’Alema
pone un tema serio, quello della riservatezza e dell’onorabilità delle persone
non indagate - ha commentato Legnini - Il Csm però non è munito di poteri
d’intervento d’ufficio, può intervenire se investito dal pg o dal ministro». Il
tema della fuga di notizie, quindi, «meriterebbe un intervento legislativo
appropriato».
Massimo D'Alema: "Una legge per tutelare chi non è indagato",
scrive “Libero Quotidiano”. "Non sono indagato per nessun reato, perché rendere
pubbliche in un atto giudiziario cose private di persone come mia moglie?".
Massimo D’Alema non ci sta a vedere il suo nome negli atti dell'inchiesta sulle
tangenti a Ischia e, dal foyer del teatro Petruzzelli di Bari, invoca una legge
che avrebbe evitato anche le dimissioni dell'ex ministro Lupi che si è fatto da
parte dopo essere stato coinvolto, pur non essendo indagato, nello scandalo
"Grandi Opere". Una legge ad hoc - "Serve un intervento legislativo per tutelare
l'onorabilità delle persone non indagate, per proteggerle da campagne
diffamatorie come questa che mi vede protagonista, me e la mia famiglia", ha
tuonato l'ex presidente del Copasir ribadendo la sua difesa: "E' falso che ho
ricevuto bonifici per 87mila euro, per questo a partire da oggi abbiamo
cominciato a muovere la carta bollata e a intraprendere azioni legali contro
quanti hanno avviato questa campagna scandalistica priva di qualsiasi
fondamento". Diffamazione - "Ho già avuto modo di esprimere tutta la mia
indignazione - ha proseguito D'Alema - per la divulgazione di notizie che
riguardano persone a me vicine che non sono indagate, messe in collegamento con
un'indagine con cui non hanno nessuna attinenza. Questo episodio conferma quanto
affermato oggi dal vicepresidente del Csm, ossia che occorrono delle norme per
tutelare i non indagati. Perché rendere pubbliche in un atto giudiziario cose
private di persone come mia moglie?". Quanto alla Fondazione di cui è
presidente, ha precisato: "Definirmi beneficiario dei contributi raccolti dalla
Fondazione ItalianiEuropei di cui risulto essere presidente protempore a titolo
gratuito è un'affermazione falsa che ha solo carattere diffamatorio".
Massimo D'Alema, parla la moglie Linda Giuva: "Il vigneto? Lo
abbiamo acquistato per i nostri figli", scrive “Libero
Quotidiano”. Travolto dal suo vino, Massimo D'Alema perde le staffe. Un uomo nel
mirino, Baffino. E ora, in suo "soccorso", scende in campo niente meno che la
moglie, la riservatissima Linda Giuva, che da sette anni gestisce il vigneto di
famiglia, intestato ai figli Giulia e Francesco. Rompe il silenzio, la signora,
e lo fa in un'intervista concessa a Repubblica dove parla dei 15 ettari
di terreno dei quali 6,5 sono impegnati dal vigneto. "Vorrei fare il mio lavoro
- si sfoga -, la produttrice di vino, onesta e laboriosa, senza dover essere
inseguita da insulti e basse insinuazioni". Ma non è tutta pubblicità? Sì, lo è,
la signora D'Alema conferma: "Abbiamo avuto in queste ore un'impennata di ordini
inimmaginabile". La signora racconta che il vigneto, quando fu acquistato, era
un allevamento di bovini. Poi spiega perché lo comprarono: per la prole, "con lo
sguardo rivolto al futuro dei figli". I vini dei D'Alema, insomma, come una
"garanzia" per il futuro dei loro pargoli. Parla il macellaio - Nell'articolo,
in cui la signora Linda Giuva si sbottona ben poco, Repubblica si spende
poi nell'elogio di D'Alema, citando voci che da Narni, in provincia di Terni,
assicurano come "Massimo qui ha portato un po' di benessere". Nell'articolo si
dà la parola anche a Fabrizio Nunzi, il macellaio del Paese, che presenta le
bottiglie e spiega che un tempo votava per Silvio Berlusconi, ma ora con D'Alema
si dà del tu. "Lui mi chiama e io gli preparo il filetto, la coppa di testa o il
capocollo, di cui è ghiottissimo". E' forse arrogante, Baffino? Il Macellaio
ovviamente rassicura tutti: "Lo pensavo anche io prima di conoscerlo, invece è
un uomo senza spocchia. Doveva vederlo ad agosto alla sagra, il Vinotricolando,
sembrava uno di noi: era lì con il suo banchetto, fermava le persone".
L'inchiesta? "Non ci credo - taglia corto il macellaio -. Il suo vino davvero è
buono, lo vogliono in tanti, e dopo questo polverone ancora di più".
Caro Massimo, benvenuto tra i perseguitati,
scrive Tiziana Maiolo su "Il Garantista". Negli Stati
Uniti il magistrato si tiene le intercettazioni ben strette nel proprio
cassetto”. Così il giornalista Federico Rampini nella trasmissione Piazza
pulita, ricorda, dal Paese in cui vive e lavora, l’anomalia italiana paragonata
a un sistema, come quello americano, dove in uno spazio dieci volte più grande,
il numero complessivo delle intercettazioni è pari alla metà di quelle italiano.
E del resto, non occorre andare lontano per avere l’esempio di un magistrato che
di recente è stato capace di “tenere ben strette nel proprio cassetto” le
intercettazioni che lui stesso aveva disposto. Parliamo del Procuratore aggiungo
di Venezia Carlo Nordio, che è riuscito a condurre un’inchiesta colossale come
quella sul Mose senza che neppure una riga fosse sfuggita dalle maglie del
segreto investigativo, intercettazioni comprese. Il che significa che è
possibile evitare lo “sputtanamento”, soprattutto di persone non indagate,
purché il magistrato, che è il custode naturale della riservatezza delle
indagini, lo voglia. E quindi, a contrario, ogni volta che la notizia scappa,
significa che il magistrato, prima di tutto ( e con lui le forze dell’ordine che
dipendono dal Pm ) lo ha voluto. Intercettazioni depositate in edicola, si dice,
con ammiccamento complice, tra giornalisti. E’ capitato, buon ultimo, a un
esponente del Pd, Massimo D’Alema, non uno qualunque, ma che ha il torto di non
essere sull’inginocchiatoio davanti a San Matteo. Sadicamente, e con un po’ di
malizia, avremmo preferito che la vittima dell’ennesimo circo
mediatico-giudiziario fosse un amico del premier Renzi, secondo il detto del
“chi la fa l’aspetti”. Perché questo problema delle intercettazioni in edicola
in genere viene preso a cuore solo da chi lo subisce e dai propri amici. Inoltre
gli argomenti usati per lo “sputtanamento”, soprattutto del personaggio
politico, sono sempre quelli più adatti a suscitare invidia sociale, dal posto
di lavoro per il figlio o l’orologio di valore simbolico come il Rolex ( se così
non fosse non esisterebbero i falsi ), come nel caso di Maurizio Lupi, o le
bottiglie di vino pregiato come nel caso di Massimo D’Alema. Lo “sputtanamento”
è costruito ad hoc per istigare i cittadini all’odio e all’invidia. Il
personaggio individuato serve da cappello su inchieste che spesso non
conquisterebbero le prime pagine (con conseguente tam tam televisivo e sui
social ) senza “il nome” del politico da rosolare. E qui si apre un problema di
politica giudiziaria molto serio. Da un po’ di tempo i magistrati delle indagini
preliminari hanno introdotto il costume di allegare all’ordinanza di custodia
cautelare il testo delle intercettazioni. Il documento complessivo è “a
disposizione delle parti”, il che non vuol dire che siano atti pubblici. Ma
ormai è come se lo fossero, perché magistrati e forze dell’ordine li
distribuiscono a piene mani ai giornalisti dietro l’alibi che i responsabili di
queste propalazioni potrebbero anche essere gli avvocati. Ma quale difensore
avrebbe interesse a rendere pubbliche intere pagine che danneggiano il loro
assistito? La risposta è ovvia. Inoltre, in mezzo alle intercettazioni, ne viene
allegata abilmente qualcuna che riguarda un uomo politico famoso, che non è
indagato, che spesso non è neppure intercettato (come nel caso di D’Alema ), ma
di cui parlano altri. Che cosa si imputa, con titoloni e strilli, al
non-indagato che diviene immediatamente un imputato al Tribunale del popolo? Il
“comportamento”. Il re dei cattivi comportamenti resta sempre Silvio Berlusconi,
e giù moralismi a palate. Ma insomma, anche Lupi e D’Alema: era opportuno
che…..e giù moraleggiando. A nessuno ( o quasi ) viene in mente di considerare
che il magistrato dovrebbe limitarsi, se proprio deve, ad allegare all’ordinanza
solo le intercettazioni relative alla commissione di reati, e non ai
comportamenti, soprattutto se di persone estranee. E comunque che dovrebbe
tenerle ben strette nel proprio cassetto, come Nordio e tutti i magistrati Usa
insegnano. Purtroppo queste questioni non riguardano più solo il mondo della
politica, come insegna tutto quanto il processo a Massimo Bossetti, che è già
diventato il processo della pubblica moralità, di cui sono diventate vittime,
oltre all’imputato, tutte le donne della sua famiglia, nella cui vita affettiva
e sessuale si fruga con rara morbosità, in modo che tutti noi “spettatori”
possiamo sentirci più virtuosi. Il problema delle intercettazioni (una volta
erano i verbali d’interrogatorio ) in edicola non ha soluzione, purtroppo.
Perché ogni volta che il Parlamento o un Governo cercano di metterci mano,
partono sempre con il cercare di erogare sanzioni all’utilizzatore finale, il
giornalista, arrivando persino a tentare di punirlo con il carcere. Si sa già
come va poi a finire, con i sindacati, gli articoli ventuno, le senonoraquando,
tutti a protestare con il bavaglio sulla bocca e la cosa finisce in niente. Del
resto una parte ( ma solo una parte ) di ragione i giornalisti l’hanno, perché
il cane cui viene dato l’osso, come fa a non rosicchiarlo? L’unica punizione che
veramente meriterebbero certi giornalisti è di essere intercettati, non solo al
telefono, anche in camera da letto o sulla Comasina, che è una strada
abitualmente popolata da prostitute. Per il resto, l’unico che dovrebbe essere
sanzionato ( ma da chi? Dai suoi colleghi?) è il naturale custode della notizia,
colui che l’ha prodotta e che dovrebbe tenerla “ben stretta nel proprio
cassetto”. Ecco perché il problema non ha soluzione, ecco perché è inutile
lamentarsi, caro compagno D’Alema. Benvenuto tra noi.
Arrangiatevi, scrive Filippo Facci su
“Libero Quotidiano”. Riassunto. Nel 2005 ci fu una convergenza tra Berlusconi e
i Ds per una legge sulle intercettazioni, ma nel 2006 i Ds bocciarono la
proposta (Castelli) perché c'era la campagna elettorale. Dopo la diffusione
delle intercettazioni su Antonveneta, poi, i Ds ricambiarono idea e nel 2007 ci
fu la legge proposta da Clemente Mastella: fu votata da Ds, Margherita, Verdi e
Rifondazione comunista, ma poi - tra polemiche arroventate - si arenò al Senato.
Nel 2008, durante la campagna elettorale, Walter Veltroni promise di riesumare
la proposta, ma poi ricambiò idea e, in giugno, si accodò alla posizione di Di
Pietro e dell'Associazione nazionale magistrati, anche se nel programma Pd
restava scritto che pubblicare intercettazioni durante le indagini andava
espressamente proibito. Nel 2010 il governo Berlusconi cercò di blindare
finalmente una legge, ma fioccarono manifestazioni (anche un'assemblea di
direttori di giornale) e il provvedimento si sfarinò, con Massimo D'Alema che
definì la norma "ostruzionistica per le indagini". Nel 2013 i "saggi" nominati
da Napolitano dissero che l'uso delle intercettazioni andava ridotto, ma il Pd,
in Commissione giustizia, rispose che "il tema non è una priorità". Ora D'Alema
non è indagato come non lo era Maurizio Lupi, tuttavia "io non do gli appalti"
specifica il Migliore. Il quale è stato sputtanato dalle intercettazioni come
Maurizio Lupi, tuttavia "D'Alema non è ministro" specifica l'altro Migliore, il
piddino Gennaro. Insomma, D'Alema: vedi titolo.
SPUTTANATI E SPUTTANANDI.
Pd, scandali e risse: la deriva che Matteo Renzi non riesce a
fermare. Travolto dalle inchieste. Infiltrato da
affaristi e mafiosi. Con gli iscritti in fuga. Il partito democratico è in
crisi. E il segretario e premier non sembra poterla controllare, scrive Marco
Damilano su “L’Espresso”. Divisioni. Iscritti in fuga. Infiltrazioni di ogni
tipo, comprese quelle della criminalità mafiosa. «Un partito buttato», travolto
da indagini giudiziarie e da minacce di scissione. È il Pd che si avvia alle
elezioni regionali di fine maggio raccontato nell'inchiesta dell'“Espresso” di
questa settimana. Un viaggio da Nord a Sud in quello che l'ex ministro Fabrizio
Barca nel suo rapporto sul Pd romano definisce «un partito non solo cattivo ma
pericoloso e dannoso», in cui «traspaiono deformazioni clientelari e una
presenza massiccia di “carne da cannone da tesseramento”» e che «subisce inane
le scorribande dei capibastone». Con il più importante dei suoi leader storici,
Massimo D'Alema, in guerra con la magistratura e con la stampa dopo
intercettazioni e notizie senza rilevanza penale che accostano la sua fondazione
ai dirigenti della cooperativa Cpl Concordia arrestati da pm napoletani. A Roma
e a Ostia il Pd è chiamato a liberarsi dai condizionamenti della mafia. In
Calabria non è stata ancora completata la formazione della giunta di Mario
Oliverio, eletta quattro mesi fa. In Campania c’è il caso di Vincenzo De Luca e
l'arresto a Eboli di funzionari accusati di sfruttare donne immigrate:
certificati falsi di residenza in cambio di voti alle primarie comunali per il
Pd. In Sicilia c’è il candidato vincente alle primarie del Pd Silvio Alessi che
in realtà è di Forza Italia. Nelle Marche, al contrario, il presidente uscente
del Pd Gian Mario Spacca guiderà una lista civica di centrodestra con gli uomini
di Berlusconi. In tutte queste situazioni c’è un solo protagonista, il Pd di
sempre, con i vecchi uomini e i vecchi metodi, e un grande assente, il nuovo
corso di Renzi. Decisionista da capo del governo, da segretario del Pd Renzi si
rivela immobilista. Nei territori finisce in minoranza o è costretto ad
affidarsi ai professionisti del trasformismo. E dietro di lui c’è il deserto.
«vedo una contraddizione profonda tra il Pd di Roma e il territorio e tra Renzi
e il renzismo. C’è una grande distanza tra il segretario-premier e la sua classe
dirigente», dice Antonio Bassolino. E sulla scissione, avverte il grande vecchio
Alfredo Reichlin, «vedo in Renzi una preoccupazione. Lui sa che non si fa un
partito del 40 per cento che vuole rappresentare il Paese nel profondo senza un
rapporto con l’elettorato di sinistra e le sue rappresentanze». Ma anche per
questo il Pd renziano rischia di apparire un'occasione perduta. Un partito
buttato.
Ma che razza di partito è diventato il Pd?
Scosso dagli scandali, da nord a sud. Succube dei vecchi
apparati. In calo drammatico di iscritti. Diviso fino al rischio di scissione.
Si avvicinano le elezioni regionali e il Pd è del tutto fuori controllo. E Renzi
sembra incapace di agire, continua Marco Damilano. Vecchia pietra/per
costruzioni nuove/vecchio legname/per nuovi fuochi...». Il senatore del Pd Mario
Tronti quasi sussurra i versi di Thomas Stearns Eliot per festeggiare i cento
anni di Pietro Ingrao, l’ultimo comunista, il sopravvissuto del secolo delle
ideologie. Nell’auletta dei gruppi parlamentari applaudono le prime file, il
capo dello Stato in carica (Sergio Mattarella) e il presidente emerito (Giorgio
Napolitano), Pier Luigi Bersani e Achille Occhetto, Anna Finocchiaro e Luciano
Violante, Emanuele Macaluso e Aldo Tortorella, antichi più che anziani. Vecchie
pietre, vecchio legname. Le nuove costruzioni, il Pd di Matteo Renzi, non si
vedono in sala. Non c’è un ministro a testimoniare la presenza del nuovo corso,
neppure un vice-segretario. «Il governo? E chi è?». Massimo D’Alema, seduto a
due posti di distanza dall’ex rivale Occhetto, sfodera l’acidità dei momenti
peggiori. Il giorno prima il suo nome è rimbalzato nell’inchiesta giudiziaria
che ha portato ll’arresto del sindaco Pd di Ischia Giosi Ferrandino ,
candidato alle europee. Notizie non rilevanti ai fini penali sull’acquisto di
bottiglie di vino di produzione dalemiana e di cinquecento copie del suo libro,
più finanziamenti di 60mila euro (registrati) della cooperativa Cpl Concordia
alla fondazione Italianieuropei, corredate da intercettazioni («D’Alema è uno
che mette le mani nella m...»), ma che bastano a far infuriare l’ex premier.
Galeotto fu il libro: “Non solo euro”, il testo in questione, fu presentato a
Roma da Renzi il 18 marzo 2014, quel giorno Matteo assicurò che per la futura
Commissione europea il governo avrebbe scelto «le persone più forti che
abbiamo». D’Alema si era riconosciuto nell’identikit, invece Renzi designò
Federica Mogherini. È anche da quella promessa che parte la guerra che oggi
dilania il Pd. Il fantasma di una mini-scissione che agita il partito del 41 per
cento alle elezioni europee, con la minoranza interna che minaccia di non votare
la legge elettorale Italicum quando a fine mese approderà alla Camera. Un atto
che segnerebbe una rottura irreparabile. «Operazione 27 aprile», la chiama Pippo
Civati. Ma la vera guerra contro il passato che preoccupa Renzi non è quella
contro i leader della minoranza (Pier Luigi Bersani, Gianni Cuperlo, Stefano
Fassina, Rosy Bindi, Pippo Civati), divisi tra loro. È la difficoltà a far
cambiare verso al Pd, dopo quasi un anno e mezzo di segreteria. Divisioni.
Iscritti in fuga. Infiltrazioni di ogni tipo, comprese quelle della criminalità
mafiosa. «Un partito non solo cattivo ma pericoloso e dannoso», ha scritto l’ex
ministro Fabrizio Barca nel suo rapporto sul Pd romano, in cui «traspaiono
deformazioni clientelari e una presenza massiccia di “carne da cannone da
tesseramento”» e che «subisce inane le scorribande dei capibastone». A Roma il
centrosinistra governa dal 1993, salvo la parentesi di Gianni Alemanno dal 2008
al 2013, l’inchiesta Mafia Capitale sta sfiorando le amministrazioni del Pd e i
suoi uomini-chiave. L’ultimo indagato, il cinquantenne Maurizio Venafro, era il
capo di gabinetto di Nicola Zingaretti alla presidenza della regione Lazio. Nato
e cresciuto nella Fgci di Goffredo Bettini e nelle sezioni di borgata del Pci,
nessuno ha mai messo in discussione la sua correttezza ma è il modello Roma
fatto persona, per più di venti anni nelle stanze del potere romano: capo staff
di Francesco Rutelli in Campidoglio, affiancandolo nella candidatura a premier
nel 2001, capo del dipartimento comunicazione con Enrico Gasbarra alla Provincia
di Roma, capo delle relazioni esterne della giunta Marrazzo e infine braccio
destro di Zingaretti. Negli stessi giorni è stato sciolto il municipio di Ostia,
governato dal Pd, per collusioni con la mafia. Roma è l’unica situazione locale
in cui Renzi si è mosso con rapidità, nominando commissario il presidente del
partito Matteo Orfini. Che non è un estraneo alle beghe correntizie, è stato in
cordata per anni con il deputato Umberto Marroni (uno dei commensali, tra
l’altro, nella cena in cui il futuro ministro Giuliano Poletti sedeva a tavola
con Gianni Alemanno e con il socio del boss Massimo Carminati Salvatore Buzzi).
Nel partito li chiamavano i Dalemerrimi o i Dalebani, per sottolineare la
fedeltà al loro capo di allora, D’Alema. In minoranza a Roma, dove dominavano
Bettini, Zingaretti, i veltroniani. Oggi Orfini sta con Renzi, ha impugnato la
bandiera del rinnovamento: azzeramento delle commissioni in Campidoglio,
inchiesta sui circoli, invito ai consiglieri comunali ad andare in Procura a
denunciare le situazioni sospette. In altre situazioni, invece, il Pd nazionale
stenta a intervenire. In Calabria non è stata ancora completata la formazione
della giunta di Mario Oliverio, eletta il 23 novembre, quattro mesi fa. E non si
può neppure dare la colpa all’inesperienza, dato che il nuovo presidente è
entrato per la prima volta nel consiglio regionale calabrese nel 1985, quando
Renzi aveva dieci anni. In Campania c’è il volo del calabrone Vincenzo De Luca
su cui pesa una condanna in primo grado per abuso di ufficio e che per la legge
Severino potrebbe essere costretto a sospendersi dalla sua funzione in caso di
elezione. Ma ha vinto le primarie e si presenta come l’uomo di Renzi in regione.
Intanto a Eboli un funzionario del Comune e un imprenditore sono stati arrestati
con l’accusa di sfruttare donne immigrate: certificati falsi di residenza in
cambio di voti alle primarie comunali per il Pd. In Sicilia c’è lo scambio delle
identità. Nella pirandelliana Agrigento il candidato vincente alle primarie del
Pd Silvio Alessi in realtà è di Forza Italia, sponsorizzato dal presidente del
Pd isolano Marco Zambuto (ex cuffariano, ex alfaniano, oggi faraoniano, nel
senso di Davide Faraone, il sottosegretario all’Istruzione capo dei renziani in
Sicilia) che è andato in visita ad Arcore da Silvio Berlusconi. Nelle Marche,
dopo dieci anni di governo, il presidente uscente del Pd Gian Mario Spacca si è
buttato dalla parte opposta e guiderà una lista civica di centrodestra aperta a
Forza Italia. In tutte queste situazioni c’è un solo protagonista, il Pd di
sempre, con i vecchi uomini e i vecchi metodi, e un grande assente, il nuovo
corso di Renzi. Il leader egemone a Roma, che strapazza e umilia gli avversari,
nei territori finisce in minoranza o è costretto ad affidarsi ai professionisti
del trasformismo. E dietro il leader c’è il deserto. I renziani, per ora, non
esprimono una classe dirigente, un’organizzazione, una cultura politica.
Faticano a darsi un nome. Una settimana fa i renziani della Lombardia si sono
riuniti per la prima volta tutti insieme con il segretario regionale Alessandro
Alfieri e con il numero due del Pd nazionale Lorenzo Guerini. E hanno deciso di
chiamarsi “maggioranza del Pd”, così, senza altri aggettivi. Qualunque altra
definizione, tipo quella dei catto-renziani vagheggiata dagli amici di Graziano
Delrio, avrebbe fatto infuriare il premier. Di riforma del Pd si stanno
occupando due ex avversari del leader, Orfini e il bolognese Andrea De Maria,
incaricato di preparare un evento a Cortona. Sul tesseramento è stato chiamato a
lavorare il deputato di Arezzo Marco Donati, renziano della prima ora. Compito
delicato. Nel 2014 a Bologna, la città rossa per eccellenza, nell’anno del boom
elettorale renziano, si sono persi per strada un quarto degli iscritti. I
circoli chiudono: erano tre a Sasso Marconi, ne è rimasto uno e il nuovo
segretario cittadino è stato votato da cinquanta irriducibili (su 400 iscritti).
Altrove è il contrario, c’è il tesseramento gonfiato di anime morte. L’ex
deputato di Sel Gennaro Migliore, ora renziano, spedito da Orfini a monitorare
il municipio romano di Tor Bella Monaca, non si separa mai da una cartellina
rossa che contiene i primi risultati dell’indagine: almeno un quarto delle
tessere è di provenienza incerta, sospetta. «Ho votato per Renzi alle primarie e
lui è un politico di razza», osserva un padre nobile del Pd come Antonio
Bassolino, «ma vedo una contraddizione profonda tra il Pd di Roma e il
territorio e tra Renzi e il renzismo. C’è una grande distanza tra il
segretario-premier e la sua classe dirigente, una questione che continua a
restare irrisolta e che è sempre più urgente. È una difficoltà quasi tecnica:
con l’attività di governo che assorbe ogni energia dove può trovare Renzi il
tempo di affrontare le tante questioni locali?». Le elezioni regionali sono
ormai vicine. Un nuovo test per il Pd renziano dopo le trionfali europee del
2014 e le regioni conquistate negli ultimi mesi (l’Emilia confermata nonostante
inchieste e astensioni e Sardegna, Piemonte, Abruzzo e Calabria strappate al
centro-destra). Se sulla legge elettorale dovesse arrivare lo strappo della
minoranza le conseguenze sul voto sarebbero imprevedibili. Ma ancora più
imprevedibile è che il premier decisionista sul rinnovamento del partito si
riveli immobile. Abbandonando il Pd al vecchio legname. Senza costruzioni nuove.
La Ditta del Pd si rottama da sola.
Ischia, Roma, le cooperative. Nuovi scandali che coinvolgono soprattutto uomini
ex Pci. Ma con un partito così Renzi non può rinnovare il Paese, scrive Luigi
Vicinanza su “L’Espresso”. C'è dell'umorismo involontario nel titolo dell’ultimo
libro di Massimo D’Alema, “Non solo euro”, cinquecento copie del quale sono
state acquistate dalla cooperativa rossa Cpl Concordia, quella che trafficava
con il sindaco d’Ischia. E già, non solo euro. Ma anche vino. Duemila bottiglie
di rosso. Dalemiano, rigorosamente. Acquistate sempre dalla stessa coop. Saperi
& sapori: la via rivoluzionaria per la conservazione del potere. Nulla di
illegale, è stato ripetuto. Ed è bene ribadirlo. Come nel caso del Rolex
regalato al figlio dell’ex ministro Maurizio Lupi. Così si usa a Roma e
dintorni. D’altra parte è tutto ancora da verificare il fondamento
dell’inchiesta condotta da un pm napoletano famoso non certo per i risultati
processuali. Intanto però le carte giudiziarie, prima di un reato, ci parlano di
una diffusa spregiudicatezza nei comportamenti. Non è roba da codice penale, ma
da codici di stile. Ecco dunque sempre dalla Cpl Concordia un versamento di
60mila euro alla fondazione che fa capo a D’Alema, Italianieuropei. Con tre
distinti bonifici negli anni. Dunque verosimilmente fatturati. Ma rimasti finora
riservati. Difficile credere a una donazione disinteressata. L’associazione
dalemiana, interpellata da “l’Espresso” tre mesi fa in occasione di una
preveggente copertina, “Le casseforti dei politici”, disse di preferire la
segretezza dei conti alla trasparenza sui nomi dei donatori. Perché quel tipo di
finanziamento non ha regole. Ognuno fa come gli pare. Leader nazionali e capetti
di periferia si sono intestati la loro fondazione. Di destra come di sinistra.
Promuovono convegni, riviste e vino quando serve. Senza vergogna. Una onorevole
tradizione politica, tramandata dal Pci di Berlinguer, si spappola
definitivamente in affarucci di bottega o in tangenti d’oro. Con le cooperative
rosse sempre più spesso al centro di inconfessabili patti scellerati. Peggio del
peggior capitalismo. Corruttori delle regole di mercato in nome di una
solidarietà sociale perduta e umiliata. Appare dunque come una beffa della
storia l’accusa rivolta a Matteo Renzi dalle agitate minoranze interne del Pd:
non sei di sinistra. Riducendo l’essere di sinistra a un’etichetta, a una
rendita di posizione, senza valori e contenuti. La “ditta” di bersaniana memoria
si è disintegrata per colpa dei suoi troppi difetti, prima ancora che per la
rottamazione renziana. Da Ischia a Venezia, lungo tutto lo stivale, è un
festival di pasticci. Tale da mettere a rischio la stessa sopravvivenza del
Partito democratico, con tutta l’arroganza della “vecchia guardia”. È il tema
della nostra inchiesta di copertina di questa settimana. Al premier-segretario
questo partito sta stretto più di quanto dica Massimo D’Alema che ancora pochi
giorni fa evocava manovre di scissione. Fuori da Palazzo Chigi e dalla stanze
del Nazareno è evidente l’assenza di controllo. Il rinnovamento non si intravede
oltre il perimetro degli studi tv. Non è necessario spingersi nel profondo Sud,
basta restare a Roma. Il rapporto stilato da Fabrizio Barca, dirigente rigoroso,
studioso di valore, racconta di un’organizzazione inquinata, dannosa (vedi
“l’Espresso” n. 13): un iscritto su cinque è fasullo; la compromissione con i
clan di Mafia Capitale inquietante. Il contenitore è corrotto. C’è ancora del
contenuto da salvare? Con buona pace di quegli onesti e generosi militanti
resistenti a ogni choc. Per lo stesso Matteo Renzi è difficile liberarsi di
notabili e capifazione quando questi controllano ingenti pacchetti di voti.
Giosi Ferrandino, il sindaco di Ischia arrestato, alle europee del maggio scorso
ha rastrellato in tutto il Sud oltre 80mila preferenze. Sì, quelle stesse
preferenze che, secondo convenienza, vengono sbandierate come strumento di
democrazia e partecipazione per la selezione dei gruppi dirigenti. E i risultati
si vedono. Negativi. La narrazione renziana è lontana dalla realtà. Non basta
rottamare. Quel che resta del Pd va rifondato. È in gioco la stessa credibilità
del segretario e del suo progetto politico. Se non rinnova in casa, come può
rinnovare l’Italia?
Finché incassate soldi di nascosto,
scrive Alessandro Gilioli su L'Espresso". «Restano misteriosi e non accessibili
molti dei flussi finanziari che rappresentano forme diverse di finanziamento del
sistema della politica nel nostro paese». E poi: «Avere dati dettagliati sui
finanziamenti che i partiti hanno ottenuto dai privati sarebbe stato
interessante. Sfortunatamente, questi dati sono risultati non recuperabili». E
ancora: «Il nostro lavoro è stato reso difficoltoso dalla difficoltà di accesso
ai dati e dalla bassa qualità degli stessi (…). L’esigenza della trasparenza e
della massima fruibilità dei dati rappresenta ancora un obiettivo da
raggiungere». Queste parole testuali appaiono nel report ufficiale sui costi
della politica rilasciato dall'ex commissario alla spending review, Carlo
Cottarelli, finalmente reso pubblico: e ora si capisce anche meglio perché
Cottarelli non è più lì. Non sarà un eroe dei due mondi, ma ha detto
l'indicibile: e cioè che i partiti prendono soldi in mille modi che noi non
sappiamo, che quando uno (nominato dal governo!) cerca di scoprirlo gli mettono
i bastoni tra le ruote e che infine la trasparenza sui finanziamenti veri
alla politica, in questo Paese, è lontanissima. È curioso come la cannonata ad
alzo zero di Cottarelli sia apparsa on line proprio mentre D'Alema abbaiava e
querelava in giro perché sui giornali era uscita l'intercettazione che
riguardava lui e la sua fondazione. Nell'intercettazione, lo ricordo, il regista
degli affari sporchi della cooperativa Cpl Francesco Simone dice: «Bisogna
investire negli Italianieuropei dove D’Alema sta per diventare commissario
europeo... D’Alema mette le mani nella merda come ha già fatto con noi e ci ha
dato delle cose». Lo stesso Simone parla poi con un’impiegata della Fondazione
«dell’acquisto da parte di “Cpl” di alcune centinaia di copie dell’ultimo libro
del politico nonché di alcune migliaia di bottiglie del vino prodotto da
un’azienda agricola riconducibile allo stesso D’Alema». Nella perquisizione alla
Cpl sono stati infine trovati «tre dispositivi di bonifici effettuati da “Cpl”
in favore della Fondazione Italianieuropei ciascuno per l’importo di 20 mila
euro nonché un ulteriore dispositivo di bonifico per l’importo di 4.800 euro per
l’acquisto di 500 libri di D’Alema dal titolo “Non solo euro”». Come noto,
D'Alema si è incazzato come un puma perché sono usciti quei verbali: «È
incredibile diffondere intercettazioni che nulla hanno a che vedere con
l’indagine, la giustizia non può avere come fine quello di sputtanare le
persone, ma deve avere come fine la ricerca dei responsabili dei reati». Poi ha
pure perso un po' la calma. Le fondazioni dei politici in Italia sono
prevalentemente macchine per finanziare i politici stessi e soprattutto non
rivelano a nessuno i nomi dei loro finanziatori: «Ottengono i quattrini che sono
il vero motore delle campagne elettorali. Possono intascare centinaia di
migliaia di euro senza darne conto e sono fuori da ogni possibilità di
controllo», come ha detto il presidente dell'Autorità Anticorruzione, Raffaele
Cantone. In particolare, quando nel dicembre scorso "l'Espresso" ha chiesto a
ItalianiEuropei chi la finanziava, ha ottenuto un secco diniego con la seguente
spiegazione: «Preferiamo la privacy alla trasparenza. I nostri bilanci sono
depositati alla prefettura, non ci sono i nomi e i cognomi ma trovate entrate e
uscite». Quindi quei verbali che tanto hanno fatto infuriare D'Alema sono stati
sostanzialmente un (pur minuscolo) squarcio di verità sui finanziatori segreti
della sua Fondazione. E allora, il problema in questo Paese è un verbale
processuale depositato che restituisce ai cittadini una piccolissima porzione di
un loro diritto sacrosanto - sapere chi finanzia privatamente la politica
- o è il fatto che la politica si faccia finanziare in modo torbido e segreto?
Ecco: con permesso, finché i partiti e i politici incassano i soldi di nascosto
dai cittadini, tramite le loro fondazioni, credo che qualsiasi loro lamentela
sulla pubblicazione dei verbali "sputtananti" abbia davvero scarsa credibilità,
scarsa autorevolezza, ma soprattutto scarsissima ragion d'essere.
"D'Alema attacca i cronisti ma ce l'ha con Woodcock".
Il suo braccio destro a Palazzo Chigi: "Coi giornali ha un rapporto morboso. Per
lui bisogna 'lasciarli in edicola'. Anche sua madre non li sopporta. Ma da
premier rimise tutte le querele", scrive Andrea Cuomo su "Il Giornale". «Massimo
è un antico professore di liceo. Uno di quelli che quando ti interroga va a
fondo, non si accontenta di risposte abborracciate. Per questo non sopporta la
superficialità del giornalismo attuale». Fabrizio Rondolino ride quando gli
chiediamo del D'Alema che minaccia di querele i giornalisti, lui che ne è stato
responsabile della comunicazione, lui che ne è stato amico (spesso) e nemico
(talvolta), lui che l'altro ieri si è preso anche la briga di ordinargli, per
solidarietà, due casse di vino Madeleine («una di NarnOt e una di Sfide»).
Rondolino, va bene che noi giornalisti siamo spesso degli
adorabili cialtroni. Ma lui non se la prende troppo?
«Ma lui sbaglia, perché se il sistema informativo è questo, la battuta di
agenzia che dà il titolo, bisogna essere furbi e cavalcarlo. O ignorarlo, come
fa Renzi, che non considera i giornali, per lui sono già morti, lo bastonano e
fa finta di nulla, lui punta su tv e social network».
Proprio un bel quadretto...
«Lo aveva detto lo stesso D'Alema a Prima Comunicazion e negli anni Novanta: i
giornali bisogna lasciarli in edicola».
Ecco, la profezia si avvera.
«Sì, ma per altri motivi».
Torniamo a D'Alema. Si ricorda qualche episodio?
«Sì, ma non d'ira, semmai di sarcasmo. Ricordo una giornalista che gli si
avvicinò col microfono sguainato: Segretario, posso farle una domanda? E lui,
gelido: L'ha già fatta. E si allontanò lasciando la collega con un palmo di
naso».
Si racconta anche di una fatwah nei confronti di Augusto
Minzolini quando era notista politico della Stampa.
«Io già non lavoravo più con D'Alema. Peraltro a me il Minzo sta simpatico. Ma
quella volta avrà scritto qualcosa di antipatico o di terribilmente vero».
Un rapporto insanabile tra Baffino e l'informazione.
«Sì, ma nato da un amore tradito. D'Alema, da vecchio comunista, ha sempre avuto
un rapporto morboso con la carta stampata. Antonio Gramsci fondò prima i
giornali e poi il Pci. E non era Marx che diceva che il giornale è la preghiera
mattutina dell'uomo moderno? No, mi sa che era Hegel».
Sì, Hegel.
«Che poi anche la mamma di D'Alema ce l'aveva con i giornalisti. La incontrai
solo una volta e mi trattò come una persona poco affidabile».
Magari aveva ragione la signora. Ma scatti di ira mai?
«Non ricordo urla o porte sbattute. Non voglio fare psicoanalisi da bar, ma
questo è uno dei suoi problemi. Lui è un vecchio illuminista, pensa davvero che
la ragione sovrasti tutto. Da qui l'estremo autocontrollo, che si manifesta in
quella postura sempre contratta. La mente controlla le passioni. Punto».
Una persona fredda.
«Ma no, poi non è affatto freddo. È timido, legato alla famiglia, ama la moglie.
Ma questa sfera affettiva è sepolta dentro la corazza dell'illuminista».
Sa perdonare?
«Mettiamola così. Una delle cose che mi ha insegnato è che la battaglia politica
non è mai personale. Lui le ha prese e le ha date non dico con fair play ma con
l'atteggiamento del giocatore di scacchi che se perde non cerca scuse e pensa
alla rivincita. Infatti quando diventò presidente del Consiglio, nel 1998,
rimise tutte le querele, primo e unico a farlo. Da leader di una parte politica
era diventato il presidente di tutti gli italiani e pensò a un gesto
distensivo».
Ne rimise una anche a me.
«Che poi, lui, ora, mica ce l'ha con i giornalisti ma con la magistratura. Se la
prende con la stampa perché non può prendersela con Woodcock che lo ha gettato
in una vicenda in cui non è nemmeno indagato».
Con lei si è mai arrabbiato?
«Quando fallì la scalata alla poltrona di commissario europeo, per Europa
scrissi un pezzo affettuoso in cui sostenevo che era la fine della sua carriera
politica. Qualcuno glielo fece notare e lui: Non mi occupo di giornali
clandestini».
Alla faccia dell'affetto. E in che rapporti siete ora?
«Ma dài, buoni; gli voglio bene, gli compro anche il vino».
Chieda lo sconto. Col caldo i rossi non si vendono più.
«Allora lo pretendo».
Michele Santoro attacca i dalemiani: "Siete dei miserabili".
Il conduttore attacca anche "Baffino" e i suoi vini acquistati dalle Coop,
scrive Mario Valenza su "Il Giornale". Dopo le intercettazioni e le polemniche
sul caso Ischia piovute addosso a Massimo D'Alema, Michele Santoro attacca
"Baffino" nel suo monologo iniziale a Servizio Pubblico. In apertura di puntata,
Santoro si è rivolto direttamente all'ex presidente del Consiglio sfottendolo
sui tanti ruoli che ha ricoperto finora, da politico a presidente della
fondazione Italianierupei fino al vignaiolo. "C'è chi ha parlato malissimo dei
suoi vini, come l'ex sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, candidato Pd alla
presidenza 'Ha detto che il tuo vino è una schifezza, lo ha fatto per far
piacere a Renzi e per i titoli sui giornali - ha detto Santoro - così come fanno
i miserabili ex amici di D'Alema che non perdono occasione per sputargli in
faccia. Oppure - aggiunge il conduttore - come i soci della Coop Concordia che
apprezzano il fatto che D'Alema è uno capace di mettere 'le mani nella m...'".
Michele Santoro attacca Massimo D'Alema: "Grazie a te il prossimo
leader maximo sarà Matteo Salvini", scrive “Libero
Quotidiano”. Non vedeva l'ora Michele Santoro di togliersi altri sassi delle
scarpe contro Massimo D'Alema. E tutto il caos sulle intercettazioni che
riguardano il Baffino a proposito dell'inchiesta sulle tangenti al comune di
Ischia è stata l'occasione ghiotta per il tribuno di La7. In apertura a
Servizio Pubblico si è rivolto direttamente all'ex presidente del
Consiglio sfottendolo sui tanti ruoli che ha ricoperto finora, da politico a
presidente della fondazione Italianierupei fino al vignaiolo. C'è chi ha parlato
malissimo dei suoi vini, come l'ex sindaco di Salerno Vincenzo De Luca,
candidato Pd alla presidenza della Campania: "Ha detto che il tuo vino è una
schifezza, lo ha fatto per far piacere a Renzi e per i titoli sui giornali - ha
detto Santoro - così come fanno i miserabili ex amici di D'Alema che non perdono
occasione per sputargli in faccia. Oppure - aggiunge il conduttore - come i soci
della Coop Concordia che apprezzano il fatto che D'Alema è uno capace di mettere
'le mani nella m...'". Secondo Santoro il grande vincitore rimane ancora una
volta Matteo Renzi e quasi si intravede una nuova sfavillante ossessione dopo
Berlusconi. "D'Alema non sarà condannato perché non ha fatto niente di illecito
- dice Santoro - lo saranno però quelli che hanno creduto in lui, condannati a
tifare Renzi per evitare il trionfo della Destra". E poi c'è un altro merito di
Baffino, cioè quello di aver fatto scappare gli elettori delle periferie, i
lavoratori: "Che continueranno a non credere più nel socialismo e voteranno
Matteo Salvini. Uno - aggiunge Santoro - che sa solo ripetere 'a casa, a casa'
oppure 'Santoro a casa'. Uno così originale - ha concluso un infiacchito Santoro
- corre il rischio di diventare il leader maximo, altro che D'Alema".
Istituzioni, coop e imprese: chi finanzia Italianieuropei.
Italianieuropei può contare su un fatturato di 1,2 milioni di euro. Nonostante i
fondi stiano calando, la fondazione si sostenta attraverso finanziamenti diretti
e inserzioni pubblicitarie di garndi imprese: ecco chi sostiene economicamente
la fondazione di Baffino, scrive Sergio Rame su Il Giornale. "... È molto più
utile investire negli Italiani Europei dove D'Alema sta per diventare
commissario europeo, capito... D'Alema mette le mani nella merda come ha già
fatto con noi ci ha dato delle cose...". È il brano di un dialogo intercettato
tra Francesco Simone e Nicola Verrini, due degli arrestati nell'ambito
dell'inchiesta sulle opere di metanizzazione che hanno interessato i comuni
dell'isola di Ischia. È la prima conversazione, riportata nell'ordinanza di
custodia, nella quale si fa riferimento a Massimo D'Alema. Ed è il gip Amelia
Primavera a sottolineare come per "comprendere fino in fondo e per delineare in
maniera completa il sistema affaristico organizzato e gestito dalla Cpl
Concordia, appare rilevante soffermarsi sui rapporti intrattenuti tra i vertici
della cooperativa e l'esponente politico che è stato per anni il leader dello
schieramento politico di riferimento per la stessa Cpl Concordia, che è tra le
più antiche cosiddette cooperative rosse". Rapporti che passano anche attraverso
la fondazione dell'ex premier: Italianieuropei. Che peso ha economicamente e
politicamente la fondazione di D'Alema? Difficile a dirlo con esattezza. Come
riporta la Stampa, Italianieuropei può contare su un fatto di 1,2 milioni
di euro. La maggior parte di questo bottino viene portato a casa dalla
pubblicità che, nonostante la crisi dell'editoria e gli appena mille abbonati
alla rivista di riferimento della fondazione, tiene botta. Come aveva spiegato
il segretario Andrea Peruzy, agli inserzionisti vengono proposti pacchetti da
30mila euro. Tra questi troviamo Mps, Enel, Eni, Unicredit, Rai e Aeroporti di
Roma. Tanto per citarne alcuni. La lista è lunga. La struttura, però, costa.
Nell'ultimo triennio, per esempio, la Solaris, la srl che pubblica i libri e le
riviste della fondazione, ha chiuso in negativo: meno 115mila euro nel 2011,
meno 214mila euro nel 2012 e meno 154mila euro nel 2013. Ogni volta il buco è
stato ripianato dalla fondazione. Negli ultimi giorni sono crescite le pressioni
su D'Alema per capire da dove arrivano i soldi che "gonfiano" le casse di
Italianieuropei. "D'Alema faccia i nomi di tutti i suoi donatori - tuona il
piddì Fabrizio Barca - così si potrebbe tramutare una cosa sgradevolissima in
una grande sfida". Di questi nomi si sa poco è niente. Come ricostruisce la
Stampa, i primi finanziatori furono poco più di una ventina. Misero insieme
un miliardo di lire: 103mila euro dalla Lega delle Coop guidata da Ivano
Barberini, 100mila euro dalla Cooperativa estense, 50mila euro dall'Associazione
nazionale delle cooperative e dalla Lega coop di Modena, 25mila euro dalla Lega
coop di Imola. E ancora: la Romed di Carlo De Benedetti, la Fiat e la Pirelli.
Cifre che variavano dai 25 agli 80mila euro. Non mancavano certo imprenditori
come Guidalberto Guidi, gli Angelucci, Francesco Micheli, Vittorio Merloni,
Alfio Marchini, Claudio Cavazza e Giuseppe Clementi. Italianieuropei non è una
fondazione ad appannaggio di D'Alema. Nel comitato di indirizzo siedono infatti
politici come Gianni Cuperlo, Anna Finocchiaro, Ignazio Marino e Franco Marini.
Negli ultimi anni i finanziamenti si sono ridotti. Ma, stando a quanto riportato
dalla Stampa, ancora nel 2012 veniva finanziata da Finmeccanica e Poste
con cifre oltre i 25mila euro. Tra gli inserzionisti della rivista, invece,
troviamo ancora Piaggio, Fs, British american tocacco e, appunto, Finmeccanica.
"Stiamo valutando le modalità con cui rendere noti i nomi dei nostri sostenitori
- ha spiegato nei giorni scorsi la portavoce Daniela Reggiani - naturalmente nel
rispetto della normativa e della loro privacy".
La Coop finanziava anche Renzi, Bersani e Meloni,
scrive “Libero Quotidiano”. Non solo Massimo D’Alema. Emergono sempre nuovi
particolari dalle carte dell'inchiesta di Napoli sui finanziamenti della
cooperativa Cpl Concordia. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano avrebbe
finanziato una cena elettorale di Matteo Renzi, ha versato 17.000 euro al Pd di
Roma e ha dato contributi elettorali un po’ a tutti: a Ugo Sposetti ed Eugenio
Patané del Pd, al comitato "Per Ignazio Marino sindaco di Roma", alla lista
civica Zingaretti e al Pd marchigiano. Ma le elargizioni erano bipartisan perché
dalle carte dell’inchiesta spunta il nome dell’esponente di Fratelli d' Italia
Antonio Paravia e al comitato "Io sto con Giorgia Meloni". Il Fatto riporta
l’interrogatorio del direttore generale affari esteri Cpl Fabrizio Tondelli che
diece: "Io non darei soldi a nessun politico e infatti anche quando si è parlato
di partecipare alla cena di Renzi io ero in disaccordo, non trovavo alcuna
utilità. Tuttavia il cda per motivi commerciali e di opportunità ha poi
stabilito diversamente e quindi ha erogato il contributo". L’elargizione era
sempre dichiarata. E quello che colpisce è proprio la trasversalità di queste
donazioni: nel novembre 2014, la cooperativa registra 5.000 euro in uscita per i
democratici. Matteo Renzi ha organizzato due cene di raccolta fondi, il 6 a
Milano e la replica il 7 a Roma. Ma la cooperativa ha finanziato le campagne
elettorali anche in precedenza, quando c’erano ancora di Ds. Nel 2011 il
candidato sindaco di Bologna Virgilio Merola ha ricevuto un assegno di 20.000
euro. “ Lo stesso periodo spediva 10.000 ciascuno ai dem di Pesaro, di Ferrara,
il doppio a Urbino, un obolo (2.000) a Foggia e Frosinone.”, scrive ancora il
Fatto. E poi soldi al comitato di Bersani. Tra il 2013 e il 2014 sono emerse
altre donazioni: 10.000 per il senatore Ugo Sposetti (Pd); 5.000 per il deputato
Alfredo D' Attorre; 10.000 per la lista civica Zingaretti e altri 10.000 per il
comitato Zingaretti; 6.000 per una cena elettorale di coppia Zingaretti-Marino;
2.000 per il comitato "io sto con Giorgia Meloni" e 3.000 per Antonio Paravia di
Fratelli d' Italia; 2.500 per Ignazio Marino sindaco di Roma e 5.000 per Antonio
Decaro sindaco di Bari; 2.000 per il mandato a Strasburgo di Cecile Kyenge e
4.000 per l' ex ministro Flavio Zanonato; 1.000 per Antonella Forattini in
Lombardia e 10.000 per Eugenio Patané, consigliere regionale poi indagato a Roma
nell' ambito di Mafia Capitale; 17.000 per il Partito democratico della
provincia di Roma. Non solo politici, Ma anche solidarietà: centinaia di euro,
sono state versate per le associazioni locali, per un progetto a Chernobyl, per
i genitori con figli disabili, per un omaggio alla fondazione di Umberto
Veronesi. Un investimento maggiore per la beatificazione di Giovanni Paolo II
vale uno sforzo in più, 25.000 euro.
Tangenti, ecco come la Coop rossa riusciva a cancellare le multe
e ottenere onorificenze, scrive “Libero Quotidiano”.
L'interrogatorio per Francesco Simone, definito dai magistrati "l'uomo-chiave"
dell'inchiesta sulle tangenti a Ischia, è fissato per oggi. Nel frattempo
emergono nuovi elementi sulla cooperativa Cpl di Modena che dimostrano come il
responsabile delle relazioni istituzionali del gruppo abbia tessuto una rete con
molteplici fili annodati con la Fondazione Italianieuropei di Massimo
D'Alema, ma anche con la fondazione Big Bang che ha sostenuto Matteo
Renzi. Una rete che riusciva ad ottenere qualsiasi cosa chiedesse, persino delle
onorificenze per il presidente della CPL, Roberto Casari.
Le onorificenze - Casari, infatti, nel
2011 era stato nominato cavaliere del lavoro, ma non bastava. Simone, rivela il
Messaggero, si da da fare per averne una anche da Palazzo Chigi. Lo
dimostra una telefonata tra lui e un funzionario della prefettura di Modena,
Daniele Lambertucci, a cui ha delegato la partita. "Io ho scritto e ho parlato
con il capo della segreteria di Poletti che però è stato incasinato tra Germania
Parigi con Renzi quindi non mi ha ancora risposto", dice Simone a Lambertucci.
"Nel frattempo ho incrociato la responsabile dell' ufficio onoreficenze di
Palazzo Chigi e mi diceva di proporlo come Grande Ufficiale o Commendatore". Il
funzionario conferma e Simone incalza: "Eh come si può fare in questo caso deve
arrivare dalla Prefettura su segnalazione di qualche cittadino...". Lambertucci
gli spiega che "sempre su segnalazione deve arrivare". Alle preoccupazioni di
Simone, il funzionario replica: «"Sta andando tutto velocemente a noi fa fede il
nostro riferimento la teniamo monitorata noi sotto controllo già è partita a
velocità supersonica".
Le multe - La solerzia di Lambertucci
per accontentare Francesco Simone è documentata anche da altre intercettazioni.
Come quelle per far annullare delle multe di Roberto Casari in cambio di
biglietti per la partita del Modena, o per accelerare l'attribuzione di un
certificato antimafia che potrebbe servire alla Coop per ottenere un appalto in
Sicilia. "Te l'ho girata due minuti fa", dice il funzionario a Simone in base
agli atti pubblicati dal Messagero, "l'ho messa a posto, la situazione con il
verbale lì è definitiva per sempre... Dì al presidente di pensare al Modena che
ci servono tre punti alla Spezia". Poco dopo, a Lambertucci arrivano i biglietti
per la partita del Modena e le magliette dei calciatori. E lo stesso fa per
l'inserimento della Cpl Concordia nella white list antimafia: "L' inserimento
nella white list era stata un po' rallentata visto alcune vicissitudini passate,
senza parlarne abbondantemente a telefono...".
Berlusconi intercettato: vogliono arrestarmi su ordine
Napolitano. Nelle carte dell’inchiesta spunta anche il
nome dell’ex Cavaliere, scrive “Il Corriere della Sera”. Anche il nome dell’ex
premier Silvio Berlusconi spunta tra le migliaia di intercettazioni
dell’inchiesta sulle tangenti a Ischia. Sono le 11.31 dell’11 maggio dello
scorso anno. È Silvio Berlusconi, tramite la sua segreteria - annotano i
carabinieri del Noe - a chiamare Amedeo Laboccetta, ex parlamentare del Pdl. È
lui ad essere intercettato, perché gli inquirenti intendono chiarire soprattutto
la natura dei suoi contatti con Francesco Simone, il responsabile delle
relazioni istituzionali della cooperativa CPL, arrestato nei giorni scorsi. Con
Laboccetta il Cavaliere «parla, tra l’altro, della situazione di crisi sociale.
Berlusconi dice inoltre - scrivono ancora i carabinieri - che i giudici, anche
su ordine del Capo dello Stato, aspettano soltanto un suo passo falso per avere
la scusa ed arrestarlo». Nell’atto giudiziario in questione, che è una richiesta
di proroga delle intercettazioni nei confronti di Labocetta datato 5 giugno
2014, non c’è la trascrizione testuale della telefonata ma solo il sunto della
conversazione. Stessa cosa in molti altri atti in cui lo stesso il passaggio
viene riportato, sempre in forma sintetica. Gli investigatori si occupano di
Laboccetta in quanto ritenuto una delle persone della «rete relazione» di
tom-tom Simone, il consulente della Cpl che «arrivava dovunque».
In particolare, al di là del lavoro svolto per conto della cooperativa rossa,
Simone aveva stretto rapporti con Alessandro Clementi, della Wave Investment
partners di Roma, una società che si occupa di gestione e recupero del credito
al quale segnalava aziende che vantavano dei crediti, anche con la pubblica
amministrazione, disposte a cederli alla Wave. E Laboccetta era stato da poco
nominato presidente della società campana Gori che vantava qualcosa come 170
milioni di crediti nei confronti sia dei privati che della Pa. «Laboccetta -
scrivono i carabinieri, dando conto dell’esito di una intercettazione - dice che
sarebbe opportuno fare una manifestazione d’interesse perché una gara avrebbe
tempi più lunghi, ma Simone si raccomanda di non spargere la voce sulla
questione che stanno trattando, trovando d’accordo il suo interlocutore». In un
successivo colloquio intercettato tra Simone e Clementi «si parla del nuovo
Decreto che è stato emanato e che stabilisce che solo le banche possono
acquistare e scegliere i crediti relativi alla pubblica amministrazione». In
questo contesto Clementi «fa presente che `quella roba lì´ vista con Laboccetta
non può farla con il decreto legge in questione. In conclusione Simone dice però
a Clementi di andare avanti con Laboccetta e company rassicurandolo che
probabilmente il decreto decadra’». È in questo scenario che i carabinieri del
Noe annotano i «contatti frequenti» di Laboccetta «sia con l’ex presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi che con l’ex deputato Marco Milanese», in passato
consigliere dell’ex ministro Giulio Tremonti e coinvolto in diverse inchieste.
Viene citata in particolare la telefonata dell’11 maggio, nella quale Berlusconi
e e Laboccetta «commentano la situazione di crisi che c’è in
giro...disoccupazione giovanile e problema immigrati e l’Europa che non prende
posizioni». Segue la considerazione di Berlusconi sui giudici che «aspettano
solo un suo passo falso» per arrestarlo. La conversazione chiude con la proposta
di Labocetta di far incontrare al Cavaliere, di lì a poco, «l’amico Marco»,
riferendosi a Milanese. Berlusconi acconsente, ma poi di fatto l’incontro salta.
Alcuni giorni prima, emerge sempre dagli atti dell’inchiesta, Laboccetta era
stato a cena con Milanese e la compagna di questi, la quale aveva incontrato
Berlusconi a Palazzo Grazioli quello stesso pomeriggio. «È stata una cena molto,
molto interessante», riferisce alle 23.58 Laboccetta a Berlusconi, aggiungendo
che martedì avrà «..un promemoria analitico, preciso e puntuale che è veramente
interessantissimo».
CON LO SPUTTANAMENTO C'E' LA GALERA...ANCHE I MAGISTRATI.
Sputtanati e sputtanandi. Sarebbe
comodo per Panorama cavalcare lo "scandalo" D'Alema. Ma lo scandalo vero, in
questa faccenda, è l'uso delle intercettazioni, scrive Giorgio Mulè su Panorama.
L’ultima fatica della Procura di Napoli ci consegna l’ennesimo caso di
sputtanamento politico e mediatico a uso e consumo dei libidinosi delle
intercettazioni. Il metodo è sempre lo stesso, il protagonista pure. Quanto al
metodo è quello, solito, d’inserire in un provvedimento giudiziario brandelli di
conversazioni assolutamente irrilevanti sul piano penale, ma esplosive su quello
politico e giornalistico. Il protagonista, poi, è ancora una volta il sostituto
procuratore Henry John Woodcock, cioè il pm che passerà alla storia come
protagonista mai punito dei più allucinanti flop giudiziari della Repubblica. In
questa giostra impazzita e barbara che sono le intercettazioni, stavolta è
salito Massimo D’Alema, ovviamente da non indagato come si usa in questa giungla
che vorrebbero contrabbandarci per giustizia. Sarebbe stato molto comodo per
Panorama cavalcare lo "scandalo". Perché questo giornale e questo direttore
hanno più volte incrociato le lame con l’ex presidente del Consiglio, duramente
attaccato per i rapporti che storicamente hanno legato e legano il partito
democratico al mondo delle cooperative rosse. Rapporti stretti e consolidati,
che i dirigenti del Pd di oggi e di ieri hanno goffamente negato nonostante
l’evidenza dei fatti. La coerenza rispetto a una linea che ha sempre indicato
come stella polare il rispetto dei diritti e delle garanzie di tutti i cittadini
unita allo schifo che proviamo ogni volta che le inchieste si trasformano in una
micidiale macchina del fango (vogliamo parlare del processo Ruby e di Silvio
Berlusconi, assolto dopo cinque anni di gogna?) ci impongono di stare dalla
parte di D’Alema. Ci fa quindi specie che il presidente del Consiglio e
segretario del Pd, Matteo Renzi, non abbia sentito l’obbligo di pronunciare
nell’immediatezza dei fatti, con un tweet o davanti alla direzione del suo
partito, parole chiare e nette contro questa barbarie. Sarebbero state parole
coraggiose pronunciate da un vero leader. Ma, come sappiamo, coerenza e coraggio
sono doti che Renzi contempla unicamente quando ha un tornaconto personale (vedi
il caso Lupi). Peggio per lui. Perché è scritto nelle stelle, diciamo così, che
sarà solo una questione di tempo: prima o poi anche lui finirà sui giornali,
magari da non indagato, come nuovo socio del grande club degli sputtanati a
causa di conversazioni telefoniche intercettate. La puzza si sente già in
lontananza perché, come ci informa il Fatto quotidiano, esisterebbe almeno
un’intercettazione irrilevante ascoltata dai pm di Napoli nell’ambito
dell’inchiesta in cui è stato tirato in ballo D’Alema; una conversazione tra
Renzi e un generale della Guardia di finanza, un ufficiale abbondantemente
sputtanato quattro anni fa dal solito Woodcock e poi regolarmente archiviato. Al
pavido Renzi, che non trova le parole per schierarsi contro la barbarie
consumata ai danni di D’Alema, suggeriamo allora di darsi una mossa. Conviene
anche lui - eccome - sbrigarsi a varare un provvedimento che limiti questa
ignominia. Non pensi agli italiani rovinati e sputtanati senza motivo, pensi a
se stesso che oggi è nelle vesti dello "sputtanando" prossimo venturo. Statene
certi, stavolta la legge la farà.
Toh, ora i compagni scoprono il fetore delle intercettazioni.
Le parole rubate al telefono hanno fatto comodo finché i derubati erano
avversari da esporre alla berlina, da emarginare e, infine, escludere
dall'arena, scrive Vittorio Feltri su “Il Giornale”. Fin dagli anni Cinquanta la
sinistra si dà tante arie e suole dividere l'umanità in buoni e cattivi,
mettendosi dalla parte dei primi che essa definisce non a caso progressisti.
Già. Talmente progressisti da arrivare ultimi in ogni circostanza. Lo abbiamo
constatato anche stavolta a proposito delle intercettazioni, da decenni al
centro di polemiche, oggetto di numerose proposte di legge dibattute
all'infinito eppure rimaste lettera morta poiché prive del nullaosta indovinate
di chi? Degli ex o postcomunisti, decida il lettore come chiamarli; tanto,
comunisti erano e la loro mentalità settaria è ancora intatta dai tempi che
furono. Il problema è semplice. Ai politici col birignao e sedicenti colti in
quanto militanti o simpatizzanti di sinistra, le parole rubate al telefono
(contenenti millanterie e forzature di ogni genere sul cui significato
occorrerebbe detrarre la tara) hanno fatto comodo finché i derubati erano
avversari da esporre alla berlina, da emarginare e, infine, escludere
dall'arena. Un gioco facile facile. Le Procure inserivano negli atti processuali
le registrazioni di colloqui malandrini, compresi quelli penalmente irrilevanti
ma giornalisticamente interessanti, piccanti, e a divulgarle provvedeva solerte
la stampa, suscitando la curiosità morbosa dell'opinione pubblica. Gli
sventurati, vittime delle incursioni nella loro vita privata, venivano infilzati
con soddisfazione da chi se ne avvantaggiava. Questo tipo di falli erano e sono
impuniti: manca una legge apposita che li sanzioni. Clemente Mastella, quando
era guardasigilli, predispose una normativa per arginare il traffico delle
intercettazioni (poco giudiziarie e molto gossippare), però la maggioranza
progressista che all'epoca reggeva il governo lo mandò al diavolo, creando i
presupposti per eliminarlo dalla scena. È chiaro a chiunque che le
intercettazioni violano il segreto delle conversazioni private, ma poiché di
solito riguardano la gente comune (della quale non importa nulla a nessuno nel
Palazzo) oppure «nemici» di partito da sputtanare, ogni iniziativa tesa a
disciplinare la materia è stata sistematicamente bocciata. Per lustri il
personale politico di destra e centrodestra ne ha fatto le spese, mentre quello
di sinistra ne ha tratto dei benefici sotto il profilo elettorale, essendo
scontato che dai faldoni dei tribunali non uscisse nemmeno un sospiro delle loro
telefonate innocenti o no. Una pacchia per i progressisti durata fin troppo.
Infatti la musica sta cambiando. Qualche spiffero velenoso comincia ad ammorbare
le sacre stanze degli «intelligenti per antonomasia», i quali, sfiorati dal
fetore delle intercettazioni, sono sul punto di cambiare idea; anzi, l'hanno
cambiata, tanto è vero che si stanno attrezzando per impedire la fuga di notizie
frutto di «furti» negli uffici dei magistrati. Come? Sbattendo in galera i
giornalisti «ricettatori» del materiale scottante. Se la stampa aiuta la
sinistra, i progressisti predicano in favore del diritto alla libertà della
medesima; se, invece, essa si concede un attacco antigauche, allora meditano
d'ingabbiare i ficcanaso delle redazioni. Sinché erano i berlusconiani a essere
massacrati dai quotidiani con paginate e paginate di chiacchierate intime, non
c'era anima bella che suggerisse di porre fine alle gratuite diffamazioni. Al
contrario, adesso i progressisti, colpiti dalle indiscrezioni, invocano la
Costituzione affinché agli scribi sia tolta la licenza di ferire con la penna
riportando il contenuto di nastri registrati su ordine delle Procure. Questa è
la storia delle intercettazioni che attendono ancora - per poco, suppongo - una
regolamentazione: non per vietarne l'impiego a scopo investigativo (ci
mancherebbe), bensì perché si pubblichino soltanto quelle relative
all'accertamento di reati. Ci si domanda come sia possibile procedere in questo
senso. Visto che siamo tanto cretini da non recuperare in proprio una soluzione
che salvi la capra (la dignità delle persone) e i cavoli (giudiziari), sarebbe
opportuno dare un'occhiata alle legislazioni di altri Paesi e copiare la
migliore. Non è un'operazione complicata, basta alzare i glutei dalla sedia
ministeriale e recarsi, per esempio, negli Stati Uniti a verificare come
agiscano le autorità americane. Chi avrà l'energia per affrontare la trasferta
scoprirà che negli Usa non sfugge una parola dei discorsi intercettati. Motivo?
I magistrati statunitensi non mollano ai giornalisti neppure uno spiffero. Sarà
perché ignorano l'esistenza di Pulcinella, per loro il segreto è una cosa seria.
Intercettazioni. Piano Gratteri: galera giornalisti che
pubblicano le irrilevanti, scrive Redazione Blitz. Il
ministro della Giustizia Andrea Orlando, nell’ambito della riforma della
Giustizia da affrontare con un complicato iter legislativo (due deleghe al
Governo), ha bloccato la proposta della commissione istituita a Palazzo Chigi e
guidata dal procuratore antimafia Nicola Gratteri in tema di intercettazioni.
Nel testo, ne descrive i contenuti Francesco Grignetti de La Stampa, era
previsto anche il carcere per i giornalisti che pubblicano quelle irrilevanti.
Gratteri ha ipotizzato un nuovo reato: la pubblicazione arbitraria di
intercettazioni. Si sanzionerebbe chi pubblica le intercettazioni “acquisite
agli atti di un procedimento penale” ma “irrilevanti ai fini della prova”. Per i
trasgressori, praticamente si applicherebbe solo ai giornalisti, prevista una
sanzione da 2mila a 10mila euro o la detenzione da 2 a 6 anni. Ha spiegato
Orlando: “La Commissione Gratteri ha fornito un importante contributo.
Chiaramente non tutti i punti diventeranno testo di legge”.
Vi sono molte cose condivisibili nella lenzuolata pubblicata dal “Fatto
Quotidiano” dedicata alle riforme presentate dalla commissione guidata dal
procuratore Nicola Gratteri, mancato ministro della Giustizia per veto di un
malfidato Napolitano, scrive Dagospia. Per esempio, è razionale interrompere la
prescrizione con la formulazione dell’imputazione e farla cessare dopo la
sentenza di primo grado. Ed è giusto sancire che le prove restino valide anche
se cambia il giudice del dibattimento, come è comprensibile lo sforzo di
aumentare il ricorso al rito abbreviato e al patteggiamento. Un po’ meno
prudente, e garantista, l’ansia di ridurre i ricorsi “inammissibili” e l’idea di
punire il voto di scambio mafioso anche senza le intimidazioni. Ma sono vicende
sulle quali è lecito e utile discutere. Fa invece letteralmente accapponare la
pelle la parte che riguarda le intercettazioni. Gratteri vuole istituire un
nuovo reato ad hoc (ne abbiamo troppo pochi…) che si chiama “Pubblicazione
arbitraria delle intercettazioni”, dove nell’aggettivo “arbitrario” c’è già
tutta la pericolosità di un reato, appunto, “arbitrario”. Il reato consiste in
un divieto ai magistrati di utilizzare il testo integrale delle intercettazioni
negli atti, “a meno che la riproduzione testuale dell’intera comunicazione
intercettata non sia rilevante ai fini della prova”. E poi nel divieto ai
cronisti di “divulgare i dati”. Per ora, come si vede, la formulazione del reato
è piuttosto vaga ma non meno pericolosa. In compenso ecco le pene: reclusione da
due a sei anni e la multa da 2.000 a 10.000 euro. Fermiamoci un attimo e
respiriamo: sei anni di carcere per la pubblicazione “arbitraria” di
un’intercettazione? Ma non vi sembra un’enormità? Dagospia di intercettazioni ne
pubblica pochine, ma il “Fatto” letteralmente ci campa. Solo perché la proposta
arriva da un magistrato amico facciamo finta di nulla? Se anziché Gratteri a
proporre il carcere fosse stato Carlo Nordio, vicino a Forza Italia, e se al
governo ci fosse Silvio Berlusconi non starebbero tutti gridando al bavaglio
liberticida?
Intercettazioni: e se anche rischiassi la galera?
G. Antonio Stella: "pubblicherei", scrive Ugo Dinello su
“Articolo 21”. "Una cosa indecente che va chiamata con il suo nome: censura".
L'uomo dall'ironia garbata per antonomasia, Gian Antonio Stella, il giornalista
del "Corriere della Sera" che riesce a mettere alla berlina i potenti senza mai
farli urlare al complotto, dopo aver letto cosa prevede il disegno di legge
Alfano, lascia il fioretto e afferra la clava. Quel disegno che mente anche nel
nome (parla di "tutela della privacy" quando invece mira a impedire alla stampa
di seguire qualsiasi "attività d'indagine" cioè qualsiasi tipo di notizia,
soprattutto quelle sgradite ai potenti) gli fa perdere, solo per un istante, il
consueto aplomb. Non l'ironia. E soprattutto non la voglia di opporvisi.
"Una cosa indecente. Se fanno una legge in cui si stabilisce che il
magistrato, o il brigadiere, o il cancelliere o l'avvocato che passa le notizie
ai giornalisti - se non lo può fare, perchè mica è detto che l'avvocato non lo
possa fare - e ammesso che vengano incastrati con prove ritenute
"inoppugnabili", perfino per l'avvocato Ghedini, perfino per l'avvocato Longo, o
per l'avvocato Previti, o per l'avvocato Sammanco (tutti legali di Berlusconi
ndr), se fosse incastrato persino per queste persone e decidessero di dargli 10
anni di galera, facciano. Perché se c'è una legge che stabilisce che non si
possono diffondere le notizie per tutelare il segreto istruttorio è giusto che
ci sia una punizione. Ma che vengano puniti dei giornalisti perché pubblicano
delle notizie che riescono a procurarsi, beh, questo è indecente. E se questo
disegno passasse è l'anticamera della censura. Bisogna chiamare le cose con il
loro nome e allora lo chiamino "disegno di legge sulla censura". E a quel
punto anche chi come me è sempre stato molto, ma molto, ma molto riottoso a fare
paragoni fra Silvio Berlusconi e il duce - e secondo me sono paragoni per ora
improponibili - beh, se passasse questa legge l'unico precedente che avrebbe
nella storia sarebbe proprio la censura fascista".
Brutale. E a te? Cioè, se dopo questa legge capitasse di avere
per le mani...
"Pubblicherei.."
... una notizia che..
"...pubblicherei..."
... ti fa andare in galera se...
"... pubblicherei..."
E se il tuo editore ti dicesse: "Caro Gian Antonio, scusa ma io
di pagare un milione di euro di multa per raccontare la verità agli italiani non
ho proprio l'intenzione". Perché sarà questa una delle armi della censura.
Multare gli editori "disobbedienti". Che fai?
"Beh, in quel caso si aprirà un contenzioso tra me e il mio editore. Sarebbe la
prima volta".
Perchè quello degli editori è un bel capitolo...
"Su questo bisogna essere molto chiari. La storia di questi anni ci ha
dimostrato che i giornali e le tivù del gruppo Berlusconi sono stati molto,
mooolto generosi di intercettazioni fornite ai loro lettori. Diciamo la verità:
quando ha potuto usare le intercettazioni tutto il gruppo che ruota intorno al
presidente del Consiglio Berlusconi altroché se le ha usate. Caspita se le ha
usate. Vogliamo ricordarci le campagne di stampa su Fassino intercettato sulla
banca?".
E pure intercettazioni abusive....
"Appunto, vogliamo ricordarci tutti gli altri casi? Ma ce ne sono stati decine.
Tanto è vero che quando sono venute fuori le prime voci sul giro di vite in
questo settore, persino Vittorio Feltri fece dei pezzi durissimi contro
quest'ipotesi. Difatti io sono sicuro che Vittorio Feltri, se uomo d'onore come
credo sia, tornerà su questo tema opponendosi a questo disegno di legge. Perché
è un tema che lui ha già affrontato duramente e lo ha detto in modo molto
chiaro. Ricordo una polemica tra lui e la dirigente di Mediaset passata alla Rai
e intercettata, Deborah Bergamini, fu una polemica durissima. Io condivido
totalmente quello che ha scritto Vittorio Feltri quella volta. Quindi condivido
totalmente ciò che pensava il direttore scelto da Silvio Berlusconi per il
giornale di suo fratello".
Ricominci a divertirti...
"Sì, perché è molto divertente vivere in un Paese in cui il garantismo vale solo
per Berlusconi e non per i ragazzi di Emergency e le "intercettazioni infami"
sono solo quelle che riguardano lui e non quelle che riguardano gli avversari.
E' davvero molto divertente questo paese. C'è un'idea dell'uguaglianza dei
cittadini che è assai bizzarra".
Caso Escort, l’ira di Sgarbi sulle intercettazioni: “Magistrati
criminali, vadano in galera”, scrive “Il Fatto
Quotidiano”. Furia incontenibile di Vittorio Sgarbi ai microfoni de La Zanzara
(Radio24) sulle intercettazioni delle conversazioni tra Berlusconi e Tarantini:
“Sono intercettazioni abusive. Questa magistratura criminale usa i soldi nostri
per occuparsi dei cazzi degli altri. Si usa troppa tolleranza nei confronti di
gente infame che usa la giustizia per scopi politici e di affermazione. Vadano a
fare in culo questi magistrati che si occupano di pettegolezzi e di stronzate
coi soldi nostri”. Con il suo noto linguaggio sopra le righe, il critico d’arte
aggiunge: “Berlusconi è un comico da cinepanettone, quello che dice nelle
telefonate è una cosa da conte Mascetti, da gagà di Dapporto. E’ puro varietà. E
noi paghiamo le tasse per questa gentaglia, che continua a inondare i giornali
di schifezze. Soldi dello Stato per queste puttanate. Ma intercettino il buco
del culo questi incapaci di Bari che non sanno che cazzo fare se non
pettegolezzi. Hanno rotto i coglioni”. E continua: “Mattarella li mandi in
galera, dica a questa gente che non deve diffondere merda inutile. Dica:
‘Archiviate tutto’ per carità di patria, non se ne può più. D’altra parte, tutto
il mondo è pieno di ricchi che pagano le donne. Si pensi a Kennedy o a Clinton,
che si è fatto fare pompini da tutti gli Usa, o a Fidel Castro, che ha avuto
35mila donne. E poi quanti soldi Berlusconi dà a sua moglie? Lei viene mantenuta
perché non lavora”. Su Tarantini Sgarbi afferma: “L’ho conosciuto assieme alla
moglie e a Checco Zalone in un posto bellissimo in Puglia, vicino a Monopoli.
Tarantini è come Lavitola e Corona, cioè gente che non ha fatto niente in vita
sua. Processi su questa roba, quando l’Italia è in miseria, l’economia non
funziona, si buttano soldi in stronzate, cadono i monumenti. Vadano in galera
questi magistrati” di Gisella Ruccia.
Intercettazioni telefoniche: cosa dice la legge,
scrive Zeus News. Cosa sono realmente le intercettazioni telefoniche, che cosa
permettono di scoprire, come vengono eseguite e perché finiscono sui giornali.
Ormai è diventata un'abitudine consolidata: succeda quel che succeda là fuori,
ogni due mesi in Parlamento si deve discutere di intercettazioni telefoniche. Ma
cosa sono realmente le intercettazioni telefoniche? Che cosa permettono
di scoprire? Come vengono eseguite? E come mai finiscono sui giornali?
La legge.
A differenza di quello che avviene in molti altri paesi, in Italia le forze
dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Postale, etc.)
godono di pochissimo potere discrezionale e, salvo rari casi, non possono
avviare o gestire un indagine di propria iniziativa. Le indagini di polizia
vengono avviate e coordinate dalla Procura della Repubblica, nella figura del
Procuratore Generale o di un Sostituto Procuratore. In entrambi i casi si tratta
di un Magistrato Inquirente, non di un poliziotto. Il
Procuratore, a sua volta, non ha assolutamente nessun potere discrezionale
riguardo alle indagini: nel momento in cui viene a conoscenza di un reato è
tenuto, per legge, ad avviare un'indagine. Diversamente finisce in galera per
omissione di atti d'ufficio. Questa è la famosa "obbligatorietà
dell'azione penale". Durante l'indagine il Procuratore
agisce sotto il controllo del Giudice per le Indagini Preliminari e al termine
dell'indagine presenta le sue tesi al Giudice per l'Udienza Preliminare, che
decide se rinviare l'imputato a giudizio o se archiviare il caso. Se la tesi del
Procuratore viene considerata abbastanza solida, il caso viene passato al
Pubblico Ministero che rappresenterà l'accusa (lo Stato) in tribunale.
Salvo rari casi, tutti i processi penali (quelli in cui si rischia la galera) si
celebrano davanti ad un collegio giudicante formato da un giudice titolare e da
due giudici "a latere". Per i casi di omicidio e cose simili si celebrano
addirittura davanti alla famosa "corte d'assise" formata da due giudici "togati"
(due magistrati di professione) e da sei "giudici popolari" (semplici cittadini
scelti a caso nelle liste elettorali). In Italia, una sentenza diventa
"esecutiva", e quindi si può finalmente mettere in galera il malfattore, solo al
termine del terzo e ultimo grado di giudizio (la Corte di Cassazione). Se questo
vi sembra un sistema bizantino e iper-garantista, siete in buona compagnia.
Praticamente tutti gli studiosi di diritto ritengono che il sistema giudiziario
italiano sia tra i primi al mondo per livello di garantismo e per complessità,
soprattutto per quanto riguarda la parte penale. All'interno di questo schema,
le intercettazioni entrano in gioco solo quando esiste un fondato sospetto che
una persona possa utilizzare il telefono, la posta elettronica o altri mezzi di
comunicazione per portare a termine il suo piano criminoso. In altri termini, in
Italia non si possono fare intercettazioni "a caso". Non si possono nemmeno fare
"monitoraggi" generici nella speranza di "beccare" qualcuno mentre organizza una
rapina. Si può procedere a una intercettazione solo quando esistono delle
fondate ragioni per pensare che l'Indagato usi il telefono per il proprio
"business" criminale e solo quando il reato ipotizzato è di una certa gravità.
Per avviare una intercettazione è necessario l'ordine del Giudice per le
Indagini Preliminari, che solitamente agisce su richiesta del Procuratore della
Repubblica o di un suo Sostituto. L'intercettazione iniziale può avvenire solo
sullo specifico numero telefonico per cui è stata richiesta e non può durare più
di 15 giorni. Se durante questo periodo vengono raccolte delle "notizie di
reato" o degli "indizi di reato" di un certo valore, allora l'intercettazione
può essere protratta per altri 15 giorni (e poi altri 15, ad infinitum) ed
allargata ad altre utenze telefoniche, diversamente viene terminata. Il
materiale raccolto durante le intercettazioni è coperto da segreto istruttorio
fino al momento in cui viene depositato presso la Cancelleria del Tribunale
insieme al resto delle prove a carico e insieme alla richiesta di rinvio a
giudizio. A quel punto diventa pubblico. Sia gli avvocati della Difesa che
qualunque privato cittadino (o giornalista) possono richiederne una copia.
Il fatto che tutto il materiale raccolto dall'Accusa
sia di pubblico dominio è la conseguenza di un principio di Diritto
universalmente riconosciuto e che serve a proteggere l'Imputato. Se così non
fosse, si potrebbero celebrare processi farsa "a porte chiuse" alla maniera di
Stalin. In questo modo, invece, l'Imputato può sapere di cosa viene accusato e
può difendersi pubblicamente. Questa situazione è molto diversa da
quanto avviene in molti altri paesi. Ad esempio, negli Stati Uniti (e in quasi
tutti i paesi di lingua inglese) la Polizia può avviare un'indagine di sua
iniziativa e può mettere in atto una intercettazione telefonica senza nessun
mandato di un Giudice. Può tranquillamente fare intercettazioni "a caso" e può
svolgere "monitoraggi" di vario tipo. Addirittura, in alcuni casi, possono
eseguire delle intercettazioni telefoniche anche moltissimi altri "enti" che non
hanno nulla a che fare con la Polizia. Ecco come Antonio Ingroia spiega nel suo
libro la situazione che esiste in USA e UK: "Ebbene, negli Stati Uniti, le
intercettazioni sono consentite non solo per i reati più gravi, di competenza
dell'FBI, ma anche per i reati previsti dai singoli stati, per cui le
intercettazioni possono essere disposte dal procuratore federale, dal
procuratore di ciascuno stato, dalle polizie locali e persino dalle polizie
municipali (che corrispondono ai nostri vigili urbani!). Per non parlare dei
corpi antiterrorismo e persino dalle autorità di controllo della Borsa!"."In
Gran Bretagna, poi, il potere di ordinare delle intercettazioni, senza che sia
necessaria l'autorizzazione di un Giudice, è riconosciuto ai Servizi Segreti, a
tutte le articolazioni della Polizia e a una selva di enti pubblici che vanno
dagli istituti finanziari, ai direttori degli istituti di pena, fino addirittura
ad uffici postali e pompieri!"
Quello che si vede in telefilm come NCIS o CSI è effettivamente la pratica
quotidiana in molti paesi di lingua inglese ma, in qualunque paese europeo,
porterebbe i poliziotti dritto in galera per abuso di potere. Tutti gli
osservatori sono concordi nel ritenere l'Europa un "faro nella notte" per quello
che riguarda la protezione del cittadino dalle intercettazioni e l'Italia viene
da sempre considerato il paese più garantista d'Europa da questo punto di vista.
Questo avviene già da molto, molto prima che si iniziasse a parlare di riforma
della legge sulle intercettazioni. Un'ultima parola sulle intercettazioni dei
parlamentari. In Italia è vietato porre sotto intercettazione il telefono di un
parlamentare (e quindi anche quello di un Ministro o di un altro esponente del
Governo e delle Istituzioni, come il Presidente della Repubblica). Nemmeno un
Giudice può ordinare una intercettazione di questo tipo. Ma, allora, com'è
possibile che appaiano sui giornali le intercettazioni del Presidente del
Consiglio, dei suoi Ministri e di altri Parlamentari? Questo avviene perché
questi parlamentari si intrattengono in conversazioni compromettenti con loschi
figuri che non godono della loro stessa prerogativa. Quando questi malviventi
vengono rinviati a giudizio, i materiali raccolti a loro carico devono essere
resi pubblici per permettere loro di difendersi pubblicamente. Il Giudice non
potrebbe fare diversamente nemmeno se lo volesse. Si
noti che solo in Italia è vietato intercettare i parlamentari. In tutto il resto
d'Europa, ed in gran parte del mondo (USA, Canada, Australia, Giappone, persino
in Russia, etc.), un parlamentare è un semplice cittadino agli occhi della
Magistratura e quindi non gode di nessuna protezione in più rispetto al normale
"Signor Rossi". La famosa "immunità parlamentare",
inoltre, salva il parlamentare solo dalle conseguenze delle azioni che compie
nello svolgimento delle sue funzioni, non dalle conseguenze delle sue azioni
criminali. Si noti anche che il contenuto delle intercettazioni
telefoniche (che siano rilevanti o meno ai fini dell'indagine, che riguardino
privati cittadini o parlamentari) viene considerato di pubblico dominio in
praticamente tutti i paesi del mondo alla sola condizione che le intercettazioni
siano state depositate come atti in un processo.
REATO IMPUNITO: LA FUGA DI NOTIZIE.
Non solo “sti signori” sono impuniti per motivi di colleganza e di casta, ma,
addirittura è impedito parlarne. Su “Panorama” e su “Il Giornale” la
testimonianza di una giornalista. “Non sono ancora le 9 quando in casa di
Anna Maria Greco, la cronista de "Il Giornale"
«colpevole» di aver scritto un articolo intitolato La doppia morale della
Boccassini, suonano alla porta. Tranne la figlia che si sta preparando per
uscire, gli altri dormono tutti. Ad alzarsi è il marito. L’uomo non fa in tempo
ad aprire, che in un attimo quelli hanno già imboccato la strada per la camera
da letto. Manco si trattasse di dover scovare un pericoloso latitante
pluricondannato, i carabinieri si presentano in cinque. Devono subito
localizzare la giornalista e notificarle l’ordine di perquisizione disposto dal
procuratore aggiunto Pierfilippo Laviani nell’ambito
dell’indagine a carico del membro laico del Consiglio Superiore della
Magistratura Matteo Brigandì, accusato di abuso d’ufficio per
aver passato, proprio a lei, un fascicolo riservato. Anna Maria
non è indagata di nulla. Ha solo scritto un articolo riguardante un procedimento
disciplinare a carico di Ilda Boccassini risalente al 1982
quando, la principale accusatrice di Silvio Berlusconi per il caso Ruby, fu
costretta a difendersi davanti al Csm dopo essere stata beccata in atteggiamenti
amorosi con un giornalista di "Lotta continua". Anna Maria non è
indagata, eppure le rivoltano la casa: setacciano stanza per stanza, smontano
cassetto per cassetto, controllano foglio per foglio. Alla fine della
perquisizione le porteranno via il suo pc personale, le agende, i documenti,
ogni singolo foglio con la sigla “Csm”, come se non fosse normale trovarne nella
casa di una cronista che da vent’anni si occupa di giudiziaria. «La cosa più
grave – racconta Anna Maria a "Panorama.it" mentre è ancora in attesa
di firmare il verbale della perquisizione assistita dal suo avvocato – è che si
sono portati via pure il pc di mio figlio, al quale io non ho mai nemmeno avuto
accesso. Speriamo che almeno quello ce lo restituiscano in fretta». Eh già,
perché magari è proprio nel computer del figlio 24enne che Anna Maria avrebbe
potuto nascondere il fascicolo incriminato, a meno che non l’abbia occultato
nella redazione romana del Giornale perquisita anch’essa in mattinata.
«Io quel fascicolo l’ho visto, ma non ce l’ho. E comunque non sapevo che si
trattasse di carte segrete dal momento che riguardano un procedimento risalente
all’’82 conclusosi, come ho anche scritto nel mio articolo, con un’assoluzione
per la Boccassini. Dov’è il segreto?» . La Greco, che in tutta la sua carriera
non ha mai subito una perquisizione domiciliare, non nasconde rabbia e sorpresa.
Da una parte è ancora scossa per quanto accaduto poche ore prima in casa sua,
dall’altra si sente delusa e amareggiata perché a “denunciarla” su un giornale è
stata proprio una che fa il suo stesso mestiere. Anna Maria non fa nomi, ma è
semplice capire a chi alluda. Il giorno dopo la pubblicazione del suo articolo,
infatti, su "Repubblica" Liana Milella svela la presunta fonte dello
scoop del Giornale sulla Boccassini, ossia lo stesso Brigandì oggi accusato
d’abuso d’ufficio. «Qui siamo davanti a un fatto clamoroso: una giornalista che,
invece di tutelare un principio cardine del nostro lavoro come la copertura
delle fonti, arriva a fare una cosa del genere. Dovrebbe vergognarsi». Nessun
attestato di solidarietà, dunque, da chi per mesi si è battuto contro il
bavaglio alla libera informazione? «Macché solidarietà! Da altri sì, non certo
dai colleghi di Repubblica». A parte scovare il fascicolo che le avrebbe passato
Brigandì, secondo la Greco, dietro la doppia perquisizione ordinata oggi in casa
sua e al Giornale, c’è una chiara intenzione intimidatoria nei confronti di chi
esercita questa professione. «Da oggi il mio lavoro diventerà ancora più
difficile di quello che è normalmente, – spiega la cronista - occuparsi di
giustizia, e in particolare della condotta dei magistrati, è sempre più
rischioso. Anche quando hai in mano fatti e documenti certi che comprovano delle
responsabilità a loro carico, devi muoverti in punta di piedi». Secondo la
Greco, invece di essere una casa di vetro, trasparente agli occhi dei cittadini,
la giustizia è sempre più una casa di piombo, «se nemmeno dopo 30 anni dalla
chiusura di un procedimento a suo carico, la gente ha diritto di sapere cosa ha
fatto un magistrato, che democrazia è? Perché non si dovrebbe parlare oggi di un
fatto che può essere d’interesse per l’opinione pubblica dal momento che quel
magistrato si sta occupando di un’indagine che riguarda la privacy di una
persona? Perché – si chiede ancora Anna Maria mentre aspetta solo che la lascino
andare a casa e riprendere il suo lavoro – i cittadini non dovrebbero sapere
certe cose?».” «I carabinieri - ha spiegato la giornalista - mi hanno detto che
dovevano procedere a una perquisizione personale e, di fronte a una donna
carabiniere, ho dovuto spogliarmi integralmente. Non si tratta quindi
semplicemente di una consegna degli abiti, come sostenuto dalla procura, ma di
una procedura molto imbarazzante. Confermo altresì, come scritto nel mio
articolo, di non essere stata toccata. Mi chiedo - ha concluso - se sia normale
che una giornalista venga costretta a rimanere nuda di fronte a un'esponente
delle forze dell'ordine senza nemmeno essere indagata. Lascio il giudizio ai
lettori».
Fughe di notizie. Fughe inarrestabili. Fughe senza colpevole. È così che va la
giustizia italiana da quando la giustizia fa notizia. Dal primo ciak di Mani
pulite. Certo, allora gli arresti si susseguivano sul nastro della procura, al
quarto piano, e qualche volta il Gabibbo arrivava sotto casa prima dei
carabinieri e prima delle manette. Oggi gli spifferi portano sui giornali
frammenti di verbali in tempo reale, notizie che servono a far discutere, ma non
aggiungono un grammo all’inchiesta, intercettazioni che poi, a bocce ferme,
riservano sorprendenti riletture. La contabilità degli incendi mediatici, quella
non la tiene più nessuno. Figurarsi. Già nell’ormai lontanissimo 1995, un’epoca
fa, gli avvocati del Cavaliere, contestavano 130 fughe non ortodosse. Numeri che
oggi, se aggiornati, verrebbero polverizzati. Numeri che, naturalmente, nessuno
dentro i palazzi di giustizia ha mai preso sul serio. Perché le Procure spesso
considerano la fuga un episodio deplorevole, ma non un reato, così come invece
è, specie se commesso da un loro collega. E perché le poche indagini aperte sono
davvero, per dirla con il linguaggio della magistratura, atti dovuti. Atti
dovuti e nulla più. Atti senza futuro. Gli avvocati del Cavaliere, ma non solo
loro, hanno depositato nel tempo diverse denunce, a Milano, e anche a Brescia,
competente per i reati compiuti dalla magistratura di rito ambrosiano. In un
caso e nell’altro i risultati sono stati nulli.
Ed è inutile contestare, tanto il potere in Italia è nelle mani della
magistratura, non nelle mani del popolo. Ed infatti, a seguito della
perquisizione del 1 febbraio 2011 presso l’abitazione di Anna Maria Greco e
presso la redazione de "Il Giornale" disposta dalla procura di Roma attinente
alla pubblicazione di documenti interni al Csm riguardanti il procuratore
aggiunto di Milano Ilda Boccassini, la Federazione nazionale della stampa aveva
commentato in una nota: “Oggettivamente, non se ne può più. Nello scontro
politica-magistratura non possono essere chiamati a pagare i giornalisti se
danno notizie, ancorché su di esse e sulla loro valenza in termini di interesse
pubblico, ciascuno possa avere opinioni diverse. La perquisizione di oggi a
carico della collega de 'Il Giornale' Anna Maria Greco appare, allo stato,
assolutamente incomprensibile, oltreché, nei fatti, pesantemente invasiva". "Le
notizie 'riservate', non escono mai con le proprie gambe. - aggiungeva la nota
FNSI - Ma se si volesse prendere a prestito una espressione del moderno
linguaggio politico-giudiziario, si potrebbe dire che si va a cercare presunte
colpe, neanche meglio precisate, nell''utilizzatore finale'. Cosi non si può
andare avanti. Ai giornalisti è chiesto, tanto più in questa fase di scontro
politico e istituzionale dai toni esasperati, di alzare l’asticella della
responsabilità, per non fare la fine dei vasi di coccio. Ma occorre misura e
rispetto, da parte di tutti". Critica sulla vicenda, per altri profili, anche
l'Unione Camere Penali. "Si possono esprimere ampie riserve, non solo estetiche,
in merito allo 'scoop', strumentale e bacchettone, del 'Giornale' sulla
dottoressa Ilda Boccassini, che segna l'ennesimo episodio di imbarbarimento
dello scontro in atto, cosi come si possono anche avanzare fondati interrogativi
- afferma una nota della Giunta UCPI - sulla necessita di custodire come il
terzo segreto di Fatima gli atti dei procedimenti disciplinari dei magistrati
risalenti a trenta anni fa, ma non ci si può esimere dal registrare anche
l'inusitato spiegamento di mezzi processuali con cui, ancora una volta, la
magistratura reagisce quando viene coinvolto un collega". "Mentre tante Procure
leggono sonnacchiose sui quotidiani gli atti dei propri processi, di cui per
legge e vietata la pubblicazione, quando viene interessato un magistrato
scattano prontamente i sigilli alle stanze di un organo costituzionale e si
perquisiscono con altrettanta solerzia quelle di un giornale, anch'esso
avamposto del diritto di manifestazione e diffusione del pensiero, difeso dalla
Costituzione", commentano i penalisti. "Se ce ne fosse stato ancora bisogno,
abbiamo avuto la riprova", conclude la nota UCPI, "di quanto sia discrezionale
non solo l'esercizio dell'azione penale, ma anche le sue stesse modalità, con
buona pace del principio di eguaglianza che tutti invocano".
LE COOP ED
IL SISTEMA SCOPPIATO.
Un sistema sCOOPpiato: i vantaggi fiscali non hanno più senso,
scrive Maurizio Belpietro su “Libero Quotidiano”. Alcune note a margine della
vicenda che ha visto il sindaco Pd di Ischia finire in galera. Lo accusano di
aver preso mazzette dalla cooperativa che eseguì i lavori per la metanizzazione
dell'isola. Fin qui niente di straordinario: è ciò che capita spesso - anche tra
i progressisti - quando ci sono di mezzo opere pubbliche e dunque i soldi dei
contribuenti. Siccome chi paga sono appunto gli italiani, le imprese pagano con
generosità, assecondando ogni desiderio di politici e funzionari. Siamo alla
solita corruzione. Ciò che è meno solito è il susseguirsi di inchieste che
vedono al centro le cooperative. Cambiano i nomi, cambiano i vertici, ma il
sistema è lo stesso. Le coop, ossia delle società che dovrebbero ispirarsi a
criteri etici e di solidarietà fra i lavoratori, in realtà si comportano come
qualsiasi impresa, anzi peggio di qualsiasi impresa, usando metodi spicci e
spregiudicati degni di una gang e soprattutto "oliando" a suon di tangenti la
pubblica amministrazione. Già alcune cooperative sono un'anomalia, perché pur
essendo colossi in grado di fare concorrenza a primarie ditte private godono di
una fiscalità di vantaggio, che consente loro di risparmiare su tasse e
contributi. Ma visto che oltre a comportarsi come qualsiasi azienda del settore,
si muovono anche come i più disinvolti corruttori, la cosa si fa insopportabile.
Eppure, da Mafia capitale al Mose si capisce che queste coop sono abituate a
ottenere gli appalti pubblici ad ogni costo, anche violando la legge. Ha senso
dunque favorirle abbassando solo a loro le imposte? Non si distorce il mercato
più di quanto già non lo distorcano le bustarelle? Altro che sostenere la
necessità di rivedere il sistema degli appalti, come l'altro ieri ha dichiarato
il presidente di Lega Coop Mauro Lusetti, qui bisogna rivedere il sistema delle
coop, soprattutto di quelle collaterali alla politica, che, guarda caso, sono di
sinistra.
Cooperazione a delinquere: ormai è pioggia di inchieste.
Dall'ultimo caso di Ischia fino alle tre coop coinvolte nel "sistema Incalza"
per realizzare le grandi opere. Quei soldi all'ex ministro Kyenge, Zingaretti e
Sposetti, scrive Gian Maria De Francesco su “Il Giornale”. Se si volesse
scherzare con il codice penale (ma solo per ironia, giacché la materia è
serissima), si potrebbe inventare un nuovo reato: la «cooperazione a
delinquere». Un po' per celia e un po' perché tutti gli ultimi grandi scandali
legati a fenomeni corruttivi che hanno interessato le Procure di mezza Italia
vedono quasi sempre tra gli indagati esponenti di spicco delle coop, soprattutto
di quelle «rosse». Insomma, la storica gemmazione del vecchio Pci, la terza via
del fare impresa - né capitalismo né comunismo ma socialità - non è poi così
diversa da quella tradizionale. Il viaggio a ritroso non può non partire dalla
fine. Con la coop rossa Cpl Concordia, gigante modenese della distribuzione del
gas, che avrebbe «unto» numerose ruote, in particolare quelle del sindaco di
Ischia Giosi Ferrandino e dell'ex premier Massimo D'Alema, per garantirsi
l'appalto per la metanizzazione dell'isola campana. Un contratto da 160mila euro
all'albergo del primo cittadino ischitano, tre bonifici da 20mila euro a
ItalianiEuropei (ma «nel Pd – giura il presidente Matteo Orfini – non credo ci
sia questione morale»). Poi si contano i 2mila euro all'ex ministro Cécile
Kyenge, altri 10mila nel 2013 per la Lista Civica Nicola Zingaretti, 10mila euro
nel 2013 per l'ex tesoriere dei Ds, Ugo Sposetti. Non trascurabili altri 6mila
euro al Pd Comitato Provvisorio Roma che, sempre nel 2013, aveva ottenuto un
finanziamento da 10mila euro dalla 29 Giugno di Salvatore Buzzi. Basta tornare a
due settimane fa ed è la Procura di Firenze a salire in cattedra denunciando il
«sistema Incalza», cioè il potere del super dirigente del ministero delle
Infrastrutture di indirizzare appalti e commesse. Nell'occhio del ciclone tre
Coop rosse: la Cmc di Ravenna, partecipante al consorzio Cavet che ha realizzato
la Tav Firenze-Bologna, è accusata di aver versato oltre 500mila euro a Incalza
tra il 1998 e il 2008. Le fanno compagnia la reggiana Coopsette («favori» in
cambio della nomina dell'imprenditore Perotti alla direzione di alcuni lavori) e
la Cmb di Carpi. Ancora un po' indietro e si palesa la corruzione di Mafia
Capitale. Al centro c'è sempre una cooperativa rossa, la 29 giugno di Salvatore
Buzzi: una piccola grande holding di servizi da 59 milioni di fatturato. Dalle
pulizie alla nettezza urbana, dai centri di accoglienza ai campi rom. Gestita da
un dominus in grado di far sedere al proprio tavolo il presidente della
LegaCoop, Giuliano Poletti (oggi ministro), e il sindaco di Roma Gianni
Alemanno. «I classici risolutori di problemi, che vanno a mette' 'e mani nella
merda». È il braccio destro di Buzzi, l'ex Nar Massimo Carminati, parlando
proprio delle Coop a introdurre quel vocabolo triviale che si ritroverà anche
nelle intercettazioni napoletane su D'Alema. Nell'inchiesta milanese sugli
appalti Expo, invece, si ritrova il colosso Manutencoop e anche un protagonista
della prima Tangentopoli, il «compagno G.», ossia Primo Greganti, che aveva un
contratto di consulenza con la Cmc di Ravenna. Cambiano città e temi, ma i
protagonisti sono sempre le coop che, tra un «favore» e l'altro ai politici
amici, riescono ad ottenere commesse pubbliche importanti. E anche il Mose di
Venezia non è esente dal sistema. «Il 20% dei lavori alle aziende Iri, 60% a
quelle private, 20% alle cooperative rosse», raccontò al pm Nordio un dirigente
Italstat circa trent'anni fa. L'inchiesta dell'anno scorso ha dimostrato che
l'impostazione non è cambiata molto. Le coop presenti nei consorzi che dovevano
realizzare il sistema di barriere mobili «finanziavano» la politica per
garantirsi la prosecuzione del sistema. E che dire dell'ex presidente della
Provincia di Milano Filippo Penati che impose la Ccc di Bologna per la
riqualificazione dell'area Falck di Sesto San Giovanni? E poiché le coop rosse
sono nate e cresciute all'interno della «famiglia» Pci-Pds-Ds-Pd, occorre
interrogarsi sulla natura di questo rapporto. In alcuni casi, i risvolti penali
sono spariti per prescrizione, causa ridefinizione del reato di concussione da
parte del governo Monti (con incluso salvataggio delle grandi coop). Ma c'è
anche un sostanzioso profilo politico: Cpl Concordia, 29 giugno, Cmb, Ccc,
Manutencoop e compagnia cantante sono spesso comparse nell'elenco dei
finanziatori (leciti, per carità) del partito: sia di quello tinto di rosso dei
vecchi Bersani, D'Alema e Veltroni sia quello più sbiadito di Renzi. I Comuni di
Roma, Venezia e Ischia, la Provincia di Milano, se guidati dal centrosinistra,
avevano, tra gli altri, un interlocutore privilegiato che, a sua volta,
compariva tra gli sponsor del partito. E quando si parla di grandi appalti, il
«sistema» non trascura mai o quasi mai le Coop. Forse non c'è nemmeno corruzione
o concussione, è solo familiarità.
«Il sistema criminale» della Coop rossa.
Dopo il caso Incalza & Co, la corruzione scuote di nuovo il Paese. Questa volta
a finire nel mirino degli inquirenti è la storica cooperativa modenese Cpl
Concordia. Sotto accusa l'ex presidente, vari mananger e il sindaco Pd di
Ischia, Giuseppe Ferrandino. E tra i contatti politici nelle carte spuntano i
nomi di D'Alema e Bobo Craxi, scrivono Giovanni Tizian e Nello Trocchia su
“L’Espresso” Ombre rosse sugli appalti in Campania. C'è la storica cooperativa
emiliana, la Cpl Concordia, c'è il primo cittadino dell'isola verde, ci sono
faccendieri e imprenditori e compaiono i nomi di politici di rango, come Massimo
D'Alema, che non è indagato. Il gip lo definisce un «sistema criminale». Un
altro. L'ennesimo. Dopo Incalza & Co: ecco il nuovo capitolo del romanzo
criminale italiano. I vertici della cooperativa Cpl concordia - arrestati l'ex
presidente Roberto Casari, l'ex socialista Francesco Simone (relazioni esterne),
Nicola Verrini (area commerciale) - avevano messo in piedi un 'protocollo
criminale'. Corrompevano funzionari e politici per accaparrarsi gli appalti nel
settore della realizzazione di impianti energetici, in Campania, e emettevano
false fatture per “pagare tangenti e altre utilità”. Non badavano a costi e la
corruzione non si fermava a politici e funzionari: se serviva, a libro paga,
finivano pure gli uomini del clan. Un meccanismo rodato. In provincia di
Caserta, infatti, i vertici di Cpl si erano accordati anche con esponenti della
criminalità organizzata e con i politici conniventi con gli ambienti
camorristici. Tutto è ben definito nell'intercettazione tra Simone e Verrini
quando distinguono i politici in due categorie, quelli che 'mettono le mani
nella merda' e gli altri. Loro hanno fatto sempre affidamento sui primi. C'è un
particolare inedito che l'Espresso ha scovato. L'inchiesta nasce dalle
intercettazioni disposte nei confronti di Giuseppe Incarnato: «Dal monitoraggio
degli ascolti emergevano – scrive il Gip – preziosi spunti investigativi».
Incarnato, che non risulta indagato, è protagonista già di una indagine relativa
all'indebitamento della clinica del Vaticano, l'Idi di Roma. Al telefono parla
con Francesco Simone, personaggio chiave del sistema, discutendo di alcune gare
bandite dalla regione Campania. Quella di oggi, considerando anche gli omissis,
è solo la prima tappa dell'inchiesta sul sistema della Cpl Concordia. Otto sono
finiti in carcere, Simone Arcamone, responsabile tecnico del comune di Ischia, è
finito ai domiciliari, per due è scattato l'obbligo di dimora. Tutto parte
dall'esigenza di metanizzare l'isola. La storica cooperativa modenese, in cambio
dei «favori» di Ferrandino per l'assegnazione dei lavori - avrebbe stipulato due
«fittizie convenzioni» (ciascuna da 165 mila euro) con l'Hotel Le Querce di
Ischia, di proprietà della famiglia del sindaco, ciascuna da 165 mila euro, a
fronte della «messa a disposizione» di alcune stanze durante le stagioni estive
2013 e 2014 per i dipendenti della società modenese. Il sindaco, al secondo
mandato, era diventato 'un factotum al soldo della Cpl”. E pensare che si
definiva campione di legalità, che 'andava inculcata ai giovani', e aveva
fondato anche un osservatorio coinvolgendo magistrati ed esponenti
istituzionali. Oggi è in carcere con l'accusa di corruzione. Sarebbe lui
l'articolazione politica di quello che viene definito dagli inquirenti «un vero
e proprio sistema». Altre utilità ottenute dal sindaco sarebbero state
l'assunzione del fratello, Massimo Ferrandino, come consulente della Cpl e
almeno un viaggio tutto pagato in Tunisia. Secondo l'accusa l'amministrazione
avrebbe favorito l'azienda emiliana, che a sua volta avrebbe pagato tangenti
grazie ai fondi neri costituiti in Tunisia con la società Tunita Sarl,
riconducibile a Francesco Simone, responsabile delle relazioni istituzionali del
gruppo Cpl Concordia, definito dagli inquirenti «personaggio chiave» della
vicenda. Simone è un vecchio socialista di scuola craxiana. «Nasce socialista
come segretario di Bobo Craxi che fu una delle prime persone che mi fece
conoscere, e all'inizio Simone spese questa sua conoscenza per introdurre la Cpl
in Tunisia, nazione nella quale i Craxi avevano forti entrature. Non so se Bobo
Craxi sia mai stato legato da rapporti formali (consulenze, contratti ... ) con
la Cpl» racconta ai pm un testimone. Un paragrafo dell'ordinanza è dedicato ai
rapporti della Cpl Concordia con esponenti politici, in particolare con Massimo
D'Alema che è estraneo all'indagine. Relazioni tra la storica cooperativa rossa
e "il leader dello schieramento politico di riferimento per la stessa Cpl”.
Simone parla al telefono con Nicola Verrini nel marzo 2014: “ Preferisco
investire negli ItalianiEuropei dove D'Alema sta per diventare commissario
europeo”. E più avanti: “D'Alema mette le mani nella merda come ha fià fatto con
noi ci ha dato delle cose”. Poi a proposito dei rapporti con D'Alema si
evidenzia nell'ordinanza “l'acquisto da parte della Cpl di alcune centinaia di
copie dell'ultimo libro del predetto politico nonché di alcune migliaia di
bottiglie del vino prodotto da un'azienda agricola riconducibile allo stesso
D'Alema”. Il numero delle copie è pari a 500, le bottiglie, invece, duemila.
Così come l'11 maggio la presentazione del libro di D'Alema ad Ischia viene
curata dalla Cpl Concordia e si tiene nell'albergo 'Le Querce' della famiglia
Ferrandino. Ci sono poi, nell'ultima parte del paragrafo, i finanziamenti
erogati dalla Cpl alla fondazione Italianieuropei. Vengono ritrovati nella
perquisizione nella sede di Cpl Concordia, tre bonifici da 20 mila euro (periodo
2012-2014). Non solo i libri di D'Alema, la Cpl ha acquistato anche copie del
libro dell'ex ministro Giulio Tremonti. Vengono acquisite due fatture
rispettivamente di 7440 euro e di 4464 euro. Massimo D'Alema ha chiarito subito:
«Rapporti trasparenti, non ho avuto alcun regalo e alcun beneficio personale.
L'acquisto delle bottiglie di vino è stato fatturato e pagato con bonifici».
Ferrandino è stato il primo dei non eletti alle utlime Europee. E se Andrea
Cozzolino, eurodeputato, avesse vinto le primarie contro Vincenzo De Luca e poi
le regionali avrebbe dovuto lasciare il posto proprio al sindaco di Ischia.
Ferrandino in quella campagna elettorale si è dato molto da fare. Nelle
intercettazioni, mentre parla di voti da raccogliere in Campania, fa riferimento
anche a un fedelissimo di Matteo Renzi, Luca Lotti (sottosegretario alla
presidenza del Consiglio), con il quale avrebbe dovuto parlare, senza
specificarne il motivo.
TANGENTOPOLI ED IL POTERE DELLE FONDAZIONI.
Tangentopoli di Ischia: il vero potere adesso passa per le
Fondazioni. Da mafia Capitale allo scandalo Penati,
tutte le inchieste dell'ultima stagione finiscono per sottolineare il ruolo che
le fondazioni hanno assunto nella vita politica nazionale. È lì che - in maniera
lecita o illecita - affluiscono i finanziamenti per i leader di tutti gli
schieramenti: da Massimo D'Alema a Gianni Alemanno, scrive Gianluca Di Feo su
“L’Espresso”. Mafia Capitale, lo scandalo Penati e adesso anche la tangentopoli
ischitana. Non è un caso se tutte le inchieste dell'ultima stagione finiscano
per sottolineare il ruolo che le fondazioni hanno assunto nella vita politica
nazionale. È lì che - in maniera lecita o illecita - affluiscono i finanziamenti
per i leader e persino per i gregari di tutti gli schieramenti, da Massimo
D'Alema a Gianni Alemanno. E, di fatto, oggi questi organismi hanno rimpiazzato
le vecchie correnti. «Non ci sono più i partiti. È inutile imporre la
trasparenza nei bilanci dei partiti, che ormai sono spompati e nessuno li
finanzia più. Oggi il vero potere passa per le fondazioni», ha detto il
presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone, il primo a porre la questione
in un'intervista a “l'Espresso” nello scorso dicembre. L'indagine sulle mazzette
a Ischia accende i riflettori sulla prima di queste creature, ItalianiEuropei,
nata nel 1998 per volontà dell'allora premier Massimo D'Alema. Al di fuori della
rilevanza penale, l'invito dell'uomo della coop Concordia a «investire in
ItalianiEuropei» si traduce in tre bonifici da 20 mila euro ciascuno. Soldi
motivati nelle intercettazioni dal loquace Francesco Simone, perché «D'Alema
mette le mani nella merda come ha già fatto con noi... ci ha dato delle cose».
Sessantamila euro sono poca cosa, forse, rispetto alle somme che girano nei
circuiti del malaffare. E un versamento attraverso bonifici sembra rispettare
tutte le forme della legalità. Ma quanti altri contributi ha ricevuto
ItalianiEuropei? Impossibile saperlo. «Diciamo che preferiamo la privacy alla
trasparenza», ha spiegato la portavoce di D'Alema Daniela Reggiani a Marco
Damilano e Emiliano Fittipaldi, autori tre mesi fa di un'inchiesta de
“l'Espresso” sulla questione: «I nostri bilanci sono depositati alla prefettura,
non ci sono i nomi e i cognomi ma trovate entrate e uscite. Non è giusto che
l’origine di un contributo venga svelata, se chi l’ha fatto sapeva di poter
rimanere nell’ombra. È una questione di correttezza». Correttezza verso chi
paga, non certo verso i cittadini. Questo è il cuore del problema. Fondazioni e
associazioni simili sono lo snodo della vita politica ma sfuggono a qualunque
controllo. Salvo rare eccezioni, non c'è trasparenza: non devono spiegare chi le
finanzia, né come usano le risorse. Le regole contabili sono minime, senza
nessuno di quegli obblighi a cui devono sottostare i finanziamenti ai partiti e
ai parlamentari. Eppure si tratta di organismi con sedi prestigiose e uffici nel
centro storico di Roma, che editano riviste patinate e organizzano convegni di
alto livello. Ad esempio «ItalianiEuropei», come scrisse Marco Damilano su
“l'Espresso”, ha sede in piazza Farnese, di fronte all'ambasciata francese: nel
2012 aveva un patrimonio di un milione e 600 mila euro, una rivista mensile da
appena mille abbonati e da 582 mila euro di pubblicità, a consultare il bilancio
della società editrice Solaris (tra gli inserzionisti: Eni, Enel, British
American Tobacco, Finmeccanica, Trenitalia, Monte dei Paschi). Già l'indagine
romana sulla ragnatela di Massimo Carminati aveva evidenziato il fiume di cash
che affluiva nei conti di diverse fondazioni. C'era Gianni Alemanno con la sua
“Italia Futura”, sulla quale è stata dirottata gran parte dei 285 mila euro
pagati da Salvatore Buzzi, reuccio delle cooperative romane e braccio destro
dell'ultimo re criminale della capitale. E c'era persino l'associazione
intitolata alla memoria di Alcide De Gasperi a cui vanno 30 mila euro: è
presieduta da Angelino Alfano, a cui invano “l'Espresso” ha chiesto lumi su
tutti gli sponsor. Ma non sono solo i big a usare questi circoli come bancomat.
Luca Odevaine, il funzionario che arbitrava lo smistamento dei profughi
diventato l'ultimo grande business, nelle intercettazioni sembra alterare le
attività di “Integra Azione” a suo piacimento, sfruttandone i bilanci per
mascherare i quattrini ottenuti dalla rete di Carminati. Una ricerca
dell'università La Sapienza curata dal politologo Mattia Diletti ne ha censite
ben 105: il 34 per cento sono think-tank di carattere personale, legate alla
figura di un leader o di un capo-corrente. Negli anni duemila ogni politico di
spicco ne ha creata una. E sono protagoniste sempre più frequenti delle cronache
giudiziarie. Dalle vicende di Luigi Lusi, ex tesoriere della Margherita, sono
spuntati i fondi a “Centro per il futuro sostenibile”, sigla con vocazione
ambientalista creata da Francesco Rutelli e dall’attuale assessore ai Trasporti
della Capitale Guido Improta, che secondo l'Ansa sarebbe indagato per i rincari
della Metro C, notizia da lui smentita. Invece la “Fondazione della Libertà” che
fa riferimento a Altero Matteoli, ex ministro sotto inchiesta per la
tangentopoli del Mose, è stata chiamata in causa nello scandalo Enac. La
trasparenza, quando c'è, è sempre parziale. “Open” di Matteo Renzi indica parte
degli sponsor, ma non fa luce su chi partecipa a caro prezzo alle cene
elettorali, né all'impiego delle disponibilità. «A livello di percezione questa
situazione ha raggiunto limiti di indecenza», ha dichiarato Cantone, chiedendo
una legge che stabilisca criteri rigorosi anche per questo settore. Perché ormai
il merchandising usato per finanziare la politica sembra senza confini. La
cooperativa Concordia compra duemila bottiglie di vino dalle cantine di D'Alema
e si assicura cinquecento copie del suo saggio “Non solo Euro” per 4800 euro.
Ma, in omaggio alla trasversalità imperante, ne paga quasi 12 mila per due
diverse opere letterarie di Giulio Tremonti. Un investimento in cultura che
forse può spiegare la frenesia editoriale di tanti politici.
Il trucchetto delle fondazioni per nascondere le mazzette.
I think tank legati ai politici non sono tenuti a dichiarare chi li finanzia o a
depositare un bilancio. Ormai è boom di "pensatoi": sono oltre 100 e spesso
finiscono nelle inchieste, scrive Paolo Bracalini su “Il Giornale”. L'ultima
stima ne conta più di cento, 105 per la precisione. Per tutti i gusti, da destra
a sinistra, da leader a presunti tali, nessuno si fa mancare una fondazione. Se
lievitano a vista d'occhio è perché offrono diversi vantaggi, soprattutto in
tempi di magra per il finanziamento pubblico ai partiti. Le fondazioni ricevono
fondi ministeriali, accedono al 5 per mille, hanno sgravi fiscali, a differenza
dei partiti possono ricevere donazioni da aziende pubbliche - munifici colossi
come Eni, Finmeccanica, Poste - ma il grosso delle risorse arriva da tasche
private, ed è qui il principale vantaggio dei think tank : non sono tenute a
dichiarare chi le finanzia, neppure a depositare un bilancio, tutto al riparo da
sguardi indiscreti. «Non siamo neppure obbligati a tenere una contabilità
ufficiale delle erogazioni che riceviamo» racconta il presidente di
un'importante fondazione politica, legata ad un ex ministro. Così negli ultimi
anni il flusso di denaro si è spostato dalle segreterie di partito alle segrete
stanze delle fondazioni, che puntualmente spuntano in miriadi di inchieste per
corruzione, da Mafia capitale con la «Nuova Italia» di Alemanno, fino a quella
sulla coop Cpl. Il presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone ha segnalato
ancora il problema: «È inutile imporre la trasparenza nei bilanci dei partiti,
che ormai sono spompati e nessuno li finanzia più. Oggi il vero potere passa per
le fondazioni». In questo campo Massimo D'Alema è un precursore, perché la sua
fondazione Italianieuropei , prestigiosa sede in piazza Farnese a Roma,
festeggiava già nel 2008 i dieci anni di vita. Il volume celebrativo edito per
l'occasione riporta anche un po' di cifre e di nomi. Circa 350mila euro di
donazioni, arrivati da big come la Glaxo, multinazionali del tabacco come Philip
Morris, aziende di elettrodomestici come Merloni, e poi Pirelli, Ericcson, e una
serie di coop: Coop Estense, Legacoop Imola, Lega Nazionale Coop e Mutue, Lega
Ligure delle Coop... Chi la finanzi adesso non si sa (anche se basta comprare la
rivista bimestrale e vedere chi sono gli inserzionisti di pubblicità, a botte di
decine di migliaia di euro, tutte grosse aziende con tanta voglia di buone
relazioni con la politica), perché alla richiesta la fondazione dalemiana
risponde che i nomi non si fanno, per la privacy («Dai finanziamenti si potrebbe
desumere l'orientamento politico di chi ha elargito il contributo» ha spiegato
lo stesso D'Alema). Privacy che altrove, come in Germania, dove le fondazioni
sono ampiamente finanziate dallo Stato, non esiste, perché si devono seguire
precise e severe regole di trasparenza. Anche a Bruxelles è così, e D'Alema lo
sa bene, visto che presiede un'altra fondazione, la Foundation for European
Progressive Studies (espressione del Partito socialista europeo di cui fa parte
il Pd), che nell'ultimo hanno si è presa 3 milioni di euro di fondi dalla Ue.
Dietro le carriere politiche c'è spesso l'attivismo di una fondazione. Tosi è
arrivato alla rottura con la Lega proprio per la sua fondazione «Ricostruiamo il
Paese», 57 sedi in tutta Italia, finanziatori ignoti. Enrico Letta, appena
diventato premier, ha chiuso la sua VeDrò, appena visitata dalla Guardia di
finanza, ma l'associazione politica è servita a preparare la strada di premier
di larghe intese (tutti invitati a Vedrò). Quella di Renzi, prima la Big Bang e
poi la Fondazione Open, guidate dal braccio destro Carrai, sono stati i motori
della repentina ascesa del sindaco di Firenze, concentrando finanziamenti,
sponsor, amicizie. Renzi, in piena guerra di primarie Pd (coi bersaniani che lo
accusavano di ricevere soldi persino da Usa e Israele...), ha pubblicato una
lista di finanziatori. Ma sugli sponsor di Renzi e sui partecipanti alle cene di
fund raising resta un'ampia zona di mistero. Come in tutte le altre. Sarà per
questo che piacciono tanto?
Fondazioni, così i politici ora fanno cassa.
I finanziamenti ai leader piccoli e grandi ora passano attraverso
questi enti, che possono operare senza alcun controllo. Ecco come la fine dei
fondi pubblici cambia il rapporto tra il Parlamento e le lobby, scrivono Marco
Damilano e Emiliano Fittipaldi su “L’Espresso”. Il palazzo delle fontane all'Eur
di Roma illuminato per la cena del Pd Doveva essere un anticipo di futuro. Il
partito all’americana. Il fund raising, la raccolta fondi, limpida e trasparente
come un ruscello di montagna. Venerdì 7 novembre la prima cena di
auto-finanziamento del Pd a Roma (dopo quella di Milano) era stata un
successone. Ottocento tavoli, mille euro a testa, il presidente del Consiglio
Matteo Renzi festeggiato come uno sposo. «Esperimento riuscito, da ripetere». Il
mondo nuovo della politica finanziata dai privati. Che si è rivelato invece, tre
settimane dopo, il solito mondo di mezzo. Il confine sottile e buio che separa
la vetrina del potere dalle bande criminali scoperte dall’operazione Mafia
Criminale. Alla cena con il premier c’era anche Salvatore Buzzi, presidente
della cooperativa “29 giugno”, arrestato con l’accusa di essere il cassiere
della banda romana guidata da “Er Cecato”, come ha raccontato il suo vice
Claudio Bolla: «Il tavolo alla cena di Renzi è costato 10 mila euro, ha pagato
tutto la cooperativa e, tra i nostri soci, c’è anche Massimo Carminati». Si
realizza la profezia del boss ex Nar intercettato: «Tutto è possibile, che ne
so, che un domani io posso stare a cena con Berlusconi». O con il suo giovane
successore a Palazzo Chigi, ignaro. «I nomi si vedono. Sono tutti pubblici e
registrati. Chiedete al tesoriere del partito Francesco Bonifazi», ha garantito
il premier in tv il 3 dicembre. A due settimane di distanza, però, la lista
degli invitati e dei contributi non è saltata fuori. Nell’attesa, l’inchiesta
“Mafia Capitale” e le regalie dei presunti criminali alla politica arrivano
proprio mentre i leader provano faticosamente a costruire un nuovo modello di
approvvigionamento, dopo che l’abolizione del finanziamento pubblico (che
entrerà a regime nel 2017) sta già dissanguando le casse dei partiti. Dunque,
l’antica domanda resta più attuale che mai. Chi finanzia la politica? E perché?
«Non ci sono più i partiti. È inutile imporre la trasparenza nei bilanci dei
partiti, che ormai sono spompati e nessuno li finanzia più. Oggi il vero potere
passa per le fondazioni», ha denunciato una settimana fa a “l’Espresso” il
presidente dell’Autorità anti-corruzione Raffaele Cantone. «Le fondazioni
ottengono, spesso attraverso altre mediazioni, i quattrini che sono il vero
motore delle campagne elettorali. Possono intascare centinaia di migliaia di
euro senza darne conto. Oggi sono fuori da ogni possibilità di controllo». Le
fondazioni politiche sono un punto di intersezione tra interessi pubblici e
privati, legali e inconfessabili, di lobby e di cordate che si incrociano e si
incontrano, senza nessun obbligo di trasparenza dei bilanci e dei finanziatori.
Una terra di mezzo, appunto. E sono il fantasma che si aggira tra le pagine
dell’inchiesta su “Mafia Capitale”. Spulciando tra le migliaia di documenti e
intercettazioni si scopre, infatti, che gli enti finiti nell’ordinanza (alcuni
solo di striscio) sono ben cinque. Come il magistrato Cantone, anche l’ex Nar
Carminati e il compare Buzzi avevano capito che i think-tank possono essere
scatole vuote. Da riempire di soldi e tangenti. Matteo Renzi alla cena di
finanziamento del Pd Anche se dei pensosi convegni sull’economia e delle
conferenze sul Mediterraneo ai boss fregava nulla, non è un caso che
nell’ordinanza d’arresto la parola “fondazione” venga pronunciata dagli indagati
45 volte. Sono i soggetti giuridici spuntati come funghi negli ultimi dieci
anni, enti dove la trasparenza è un accessorio e il lobbismo spinto è l’unico,
vero core business. Pronti a degenerare in una macchina per corrompere dirigenti
pubblici, ungere i facilitatori, riciclare e fare ottimi affari. Dal think-tank
all’americana al think-“tanke” all’amatriciana. “Il Tanke” era il soprannome che
“Er Cecato” dava a Franco Panzironi, in testa all’elenco degli arrestati, ex
amministratore delegato dell’Ama, la municipalizzata romana dei rifiuti, e
segretario della fondazione di Gianni Alemanno “Nuova Italia”. La onlus che il
“Tanke” usava come una sorta di bancomat. Secondo i pm, infatti, i padrini di
“Mafia Capitale” avrebbero finanziato il club di Gianni per almeno tre anni, da
gennaio 2012 allo scorso settembre, versando centinaia di migliaia di euro: al
pensatoio dell’ex sindaco di Roma, tra bonifici e bustarelle, secondo i pm
sarebbero arrivati dalle cooperative dei boss contributi per 265 mila euro. In
cambio, l’organizzazione avrebbe ottenuto appalti pubblici e utilità di ogni
tipo. «Quello è ’na cambiale, l’ho messo a 15 mila al mese», ride Buzzi al
telefono, facendo riferimento all’affitto della sede della centralissima via San
Lorenzo in Lucina, nello stesso palazzo in cui c’è la sede nazionale di Forza
Italia. Panzironi dai presunti mafiosi otteneva di tutto e di più: da orologi di
lusso alla «rasatura del prato di zone di sua proprietà». Ma il “Tanke” era
direttore operativo anche di un’altra prestigiosa associazione, la “Fondazione
per la pace e la cooperazione internazionale Alcide De Gasperi”, presieduta per
decenni da Giulio Andreotti, con ottime entrature in Vaticano e nella finanza
bianca (tra i consiglieri spicca Giovanni Bazoli accanto a Vito Bonsignore,
condannato per corruzione). Buzzi gira 30 mila euro anche a loro, e incontra
Panzironi negli eleganti uffici di Via Gregoriana. Al tempo l’ente era
presieduto dall’ex berlusconiano Franco Frattini, ma dal luglio 2013 è stato
sostituito dal numero uno del Viminale, Alfano. Anche sul sito della “De
Gasperi”, come su quello di “Nuova Italia” manco a dirlo, non c’è alcuna sezione
“trasparenza”. Abbiamo provato a contattare per giorni il segretario generale
Lorenzo Malagola per chiedere lumi sui finanziatori privati, ma non ci ha mai
richiamato. Anche Alfano non ha voluto rispondere alle nostre domande.
«Sottolineiamo però», tiene a far sapere il suo staff, «che la fondazione non è
di un politico, esiste da trent’anni, e che presidente onorario è la figlia di
De Gasperi». Andiamo avanti. Se nel paragrafo dell’ordinanza dedicata alle
«frequentazioni di Carminati» spunta Erasmo Cinque, costruttore coinvolto nelle
inchieste sul Mose e sull’Expo nonché autorevole membro del cda della
“Fondazione della liberà per il Bene comune” dell’amico ex ministro di An (oggi
in Forza Italia) Altero Matteoli, un uomo del “Cecato” aveva messo piede anche
in altre due associazioni, stavolta di tendenza democrat. Stefano Bravo, per gli
inquirenti lo “spallone” del clan, il commercialista che portava i denari
oltreconfine, è stato tra i promotori della “Human Foundation”, una creatura
dell’ex ministro Pd Giovanna Melandri. Ma era - ha scoperto “l’Espresso” - anche
presidente del collegio dei revisori della Fondazione “Integra Azione”, fondata
da Legambiente. L’ente, che ha un logo profetico in cui una mano rossa ne
stringe una nera, era presieduto da Luca Odevaine (l’ex vice-capo di gabinetto
di Walter Veltroni al soldo di Buzzi finito in galera) e da Francesco Ferrante,
ex senatore del Pd. «È un paradosso, noi di Human foundation siamo nati proprio
perché crediamo nella trasparenza assoluta di stampo anglosassone», spiega
furiosa la Melandri, che solo pochi giorni fa ha scoperto che uno dei fondatori
del suo circolo (nell’elenco spiccano anche il viceministro all’Economia Carlo
Calenda e il filosofo Sebastiano Maffettone) è considerato dai pm uno dei
complici dell’ex terrorista nero. «Noi siamo parte lesa. Se il dottor Bravo sarà
condannato ammetteremo di aver sbagliato a scegliere un collaboratore, ma con
“Mafia Capitale” non abbiamo nulla a che spartire». È un fatto che la Human sia
tra le pochissime onlus a indicare sul sito le aziende che sponsorizzano i suoi
progetti: si va da Unicredit e Telecom, passando per Banca Mediolanum a
Sorgenia, che hanno versato liberalità da un minimo di 10 mila (contributore
“bronze”) a un massimo di 50 mila euro l’anno (contributore “platinum”). «Solo
Vodafone ha messo di più per un master alla Cattolica», chiosa la Melandri, che
sostiene l’apoliticità della sua creatura. Presentata al mondo però con una
lettera di Giorgio Napolitano, l’intervento dell’allora premier Mario Monti, i
saluti dell’allora ad Enel Fulvio Conti e le conclusioni di Giuliano Amato. Il
commercialista oggi indagato lavorava anche in un’altra fondazione di sinistra,
“Integra Azione”, un ente creato nel 2010 per favorire «l’integrazione tra i
popoli». «Abbiamo fatto progetti di cui sono orgoglioso, con fondi europei,
all’ospedale Pertini di Roma, la Coca-Cola ha contribuito per un progetto a
Rosarno», interviene Ferrante, che l’anno scorso ha lanciato il nuovo partito
ambientalista “Green Italia”. «Il centro per gli immigrati di Mineo, in Sicilia?
È vero, nelle intercettazioni ne parlavano Odevaine e Buzzi, ma “Integra” non
c’entra nulla, era un affare personale di Luca». Comunque, la onlus ha
organizzato dei corsi per mediatori culturali, proprio per il centro vicino
Catania che Buzzi sognava di trasformare in un nuovo business della banda. Con
l’abolizione del finanziamento pubblico e con la ricerca di sponsor privati che
potranno contribuire al massimo per 100 mila euro, le fondazioni avranno un peso
sempre più rilevante nella politica. Come avviene in Francia, Usa, Gran
Bretagna. Ma se lì i controlli sono stringenti (in Germania, ad esempio, le
fondazioni sono una per partito, finanziate quasi interamente dallo Stato,
controllate dalla Corte dei conti e obbligate alla pubblicità e alla trasparenza
dei bilanci) il modello italiano è più simile al far west. Prendiamo la più
famosa delle fondazioni politiche, a lungo considerata la più influente di
tutte, la fondazione Italianieuropei di Massimo D’Alema, con elegante sede in
piazza Farnese a Roma, di fronte all’ambasciata francese. Se chiedi la lista dei
finanziatori rispondono a muso duro che loro, finché la legge non cambierà, non
divulgheranno un bel nulla. «Diciamo che preferiamo la privacy alla
trasparenza», ragiona Daniela Reggiani, portavoce del fondatore del pensatoio.
«I nostri bilanci sono depositati alla prefettura, non ci sono i nomi e i
cognomi ma trovate entrate e uscite. Non è giusto che l’origine di un contributo
venga svelata, se chi l’ha fatto sapeva di poter rimanere nell’ombra. È una
questione di correttezza». In linea con quanto affermato dallo stesso D’Alema
nel 2011: «Dai finanziamenti si potrebbe desumere l’orientamento di chi ha
elargito il contributo». L’ex premier lo dichiarò tre anni fa, quando la sua
fondazione finì nella bufera per il coinvolgimento di Vincenzo Morichini nello
scandalo degli appalti truccati dell’Enac (l’imprenditore amico di D’Alema era
il procacciatore di finanziamenti della fondazione, ha patteggiato un anno e sei
mesi per corruzione e frode fiscale). Tra le onlus vicine al centro-sinistra non
sempre la trasparenza è stata considerata una virtù. Nel 2012 l’allora tesoriere
della Margherita Luigi Lusi fu arrestato per appropriazione indebita dei
rimborsi elettorali del suo partito. Poco dopo un’inchiesta de “l’Espresso”
scoprì che Lusi, nel 2009, aveva girato oltre un milione di euro al “Centro per
il futuro sostenibile”, fondazione con vocazione ambientalista creata da
Francesco Rutelli e dall’attuale assessore ai Trasporti della Capitale Guido
Improta. Lusi aveva bonificato il denaro quando Rutelli aveva già fondato un
altro partito, l’Api. Lo stesso “Cfs”, poi, versò decine di migliaia di euro
alla nuova formazione politica: nessuno di questi contributi fu mai dichiarato,
né dall’Api né da Rutelli. Due vicende con gli stessi protagonisti, ma che
corrono separate. Per il furto dei rimborsi elettorali Lusi è stato l’unico
condannato. Anche la “Fondazione della Libertà” che fa riferimento a Matteoli è
stata tirata in ballo nella vicenda delle tangenti Enac. L’ex ministro delle
Infrastrutture ha sempre smentito qualsiasi coinvolgimento, ma oggi non può
certo negare di conoscere bene Erasmo Cinque, l’imprenditore a cui Carminati ha
fatto visita nel maggio del 2013. I nomi di Matteoli e di Cinque - che è nel cda
della fondazione con l’ex deputato Marcello De Angelis, ex di Terza posizione,
cinque anni di carcere alle spalle e una carriera come cantante del gruppo
musicale 270bis, riferimento all’articolo del codice penale sulle associazioni
con finalità di terrorismo - sono finiti anche nelle inchieste sul Mose e
dell’Expo. Il boom delle fondazioni è stato raggiunto nel 2012-2013, quando la
crisi dei partiti ha toccato l’apice. Secondo una recente ricerca
dell’università La Sapienza curata dal politologo Mattia Diletti sono oggi 105,
in crescita esponenziale: erano appena 33 nel 1993, anno di passaggio tra la
Prima e la Seconda Repubblica. Il 34 per cento sono think-tank di carattere
personale, legate alla figura di un leader o di un capo-corrente. Nell’ultimo
decennio, in pratica, ognuno si è fatto la sua, con nomi immaginifici (Claudio
Scajola con la “Cristoforo Colombo”) o banalotti (“Fare Futuro”, “Futuro
Sostenibile”, “Costruiamo il Futuro”). L’ultima arrivata è “Ricostruire il
Paese” del sindaco di Verona Flavio Tosi, leghista in rotta di collisione con
Matteo Salvini: tesserarsi costa dieci euro, nell’agenda degli eventi
dell’ultimo mese c’è la partecipazione di Tosi a “Un giorno da pecora” e a
“Virus”, i comitati locali si chiamano “fari” (accendiamo un faro...) ma sui
donatori non c’è illuminazione. Così come nulla si sa di preciso su “Costruiamo
il futuro”, la fondazione del ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi, oggi
gettonatissima, perché il destino degli enti e le loro fortune economiche segue
la parabola dei loro promotori. Vice-presidente è l’ingegnere valtellinese Lino
Iemi, legato alla Compagnia delle Opere, immobiliarista con il pallino dei
centri commerciali e degli shopping center, edificatore di una controversa
città-mercato in Sardegna. Chi meglio di lui, per costruire il futuro? L’unica
associazione che ha messo on line i bilanci dettagliati e l’elenco dei suoi
finanziatori è anche la più in voga del momento. La fondazione “Open”, un tempo
chiamata “Big Bang”, organizza gli incontri annuali della stazione Leopolda e fa
riferimento diretto al premier Renzi. Tra i donatori ci sono i deputati e i
senatori renziani al gran completo, compreso il tesoriere del Pd Bonifazi che ha
elargito 12 mila euro. Ma anche l’ex presidente della Fiat Paolo Fresco (25 mila
euro), l’ex presidente della cassa di risparmio di Firenze Jacopo Mazzei (10
mila), il finanziere Davide Serra (125 mila euro) di casa a Palazzo Chigi (era a
pranzo da Renzi una settimana fa). Tutto regolare. Eppure sulla trasparenza
resta ancora molto da fare. In occasione dell’ultima Leopolda Open, con una nota
ufficiale, ha fatto sapere che in due anni di vita ha raccolto due milioni in
donazioni, e che ogni kermesse costa circa 300 mila euro: il resto è stato speso
«in due elezioni primarie, il sito della Fondazione e tantissimi eventi e
incontri socio-culturali in tutta Italia», di cui però non si hanno evidenze.
Incuriosisce, inoltre, che Renzi da un lato come segretario del Pd partecipi
alle cene di auto-finanziamento per il partito e dall’altro promuova una
fondazione privata affidata ai suoi fedelissimi. Ancor più curioso che il board
sia composto da sole quattro persone: Maria Elena Boschi, Luca Lotti, Marco
Carrai e il presidente Alberto Bianchi. Rispettivamente il ministro delle
Riforme, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il più fedele
consigliere del premier e l’avvocato di Matteo, presidente di Open nominato a
primavera anche membro del cda dell’Enel. Le fondazioni, dicono gli esperti,
saranno la prossima frontiera della politica “all’americana”. In realtà le onlus
hanno preso la solita declinazione: all’italiana. Nella ricerca della Sapienza
emerge che a fare da padrone nelle sponsorizzazioni sono i più importanti enti
pubblici e le principali banche: Eni, Enel, Finmeccanica, Autostrade, Telecom,
Edison, Unicredit, Intesa-SanPaolo, Ferrovie. Le nove sorelle che fanno girare
l’economia italiana. Talmente inserite nel meccanismo che Enrico Letta, da
premier, si sentì in dovere di sciogliere la sua associazione VeDrò per non
finire stritolato in un circuito di pressioni e di lobbying. Molti ex VeDrò sono
però confluiti tra i renziani della Leopolda: i deputati Ernesto Carbone e
Lorenza Bonaccorsi, Simonetta Giordani, passata da Autostrade al governo Letta
come sottosegretaria alla Cultura e infine nominata da Renzi nel cda di
Ferrovie. Nei prossimi anni, quando il finanziamento pubblico sarà interamente
cancellato, i soldi arriveranno da lì. Imprenditori ed enti pubblici che
foraggiano fondazioni, guidate da politici che decidono gli aiuti alle aziende e
nominano i vertici delle stesse partecipate. Un bel circuito di interessi,
lasciamo perdere il conflitto, roba fuori moda. I think tank sono destinati a
evolversi: da struttura personale a disposizione del capocorrente di turno a
società di consulenza da cui attingere per personale, risorse, classe dirigente.
Un passo ulteriore verso la destrutturazione della politica. Perché dopo la
grande torta del finanziamento pubblico, in assenza di trasparenza e certezza su
chi versa soldi alle fondazioni, non finiremo in una nuova casa di cristallo,
come si auguravano in tanti, ma in un territorio ancora più oscuro. E
pericoloso.
La selva oscura delle fondazioni e quel controllo che non c’è,
scrive Sergio Rizzo su “Il Corriere della Sera”. Che una cooperativa finanzi una
fondazione politica, come sembrava essere nei progetti della Cpl Concordia
finita nell’inchiesta sulle mazzette al sindaco pd di Ischia, non è affatto uno
scandalo. Nelle democrazie occidentali è questa la forma con cui i privati
contribuiscono anche alla formazione della classe dirigente dei partiti. Ma in
piena trasparenza. Proprio quella che invece in Italia manca: alimentando il
sospetto che la funzione principale di queste fondazioni, moltiplicatesi in modo
esponenziale negli ultimi anni proprio mentre l’opinione pubblica premeva per
imporre ai partiti regole più stringenti, sia decisamente più prosaica. Ai
magistrati che indagano su Mafia capitale Franco Panzironi, ex segretario
generale della Nuova Italia di Gianni Alemanno e insieme collaboratore della
Alcide De Gasperi di Franco Frattini, ha raccontato che le fondazioni politiche
sono un comodo salvadanaio dove gli imprenditori mettono soldi in cambio
dell’accesso a un sistema di relazioni. Lungi da chi scrive il voler fare di
tutta l’erba un fascio. Ma il problema esiste, e lo sanno bene i partiti. Che
però di metterci mano seriamente non ne hanno alcuna intenzione. Nel 2012,
mentre si discuteva alla Camera il taglio dei rimborsi elettorali, un
emendamento pensato da Linda Lanzillotta e Salvatore Vassallo che mirava a
imporre le stesse regole di trasparenza previste per i partiti anche alle
fondazioni, fu impallinato da destra e da sinistra. Due anni più tardi, nella
legge sulla presunta abolizione del finanziamento pubblico, ecco spuntare
finalmente quell’obbligo. Peccato che sia inapplicabile. La norma di cui
parliamo dice che sono soggette agli obblighi di trasparenza validi per i
partiti le fondazioni i cui «organi direttivi» siano nominati «in tutto o in
parte» dai partiti medesimi. Neppure una di quelle esistenti ricade in questa
fattispecie. E siccome chi l’ha scritta non ha l’anello al naso, la norma
aggiunge che le regole di trasparenza, (per esempio la pubblicazione online di
tutti i contributi di entità superiore a 5.000 euro) si applicano anche a quelle
fondazioni che destinano più del 10 per cento dei proventi al finanziamento di
attività politiche. Si tratta soltanto di stabilire come e chi controlla che
quel limite non venga superato. Ma di questo non si fa cenno. Fatta la legge,
non si deve neppure fare la fatica di trovare l’inganno. Quante fondazioni
resterebbero in vita se le regole della trasparenza venissero correttamente
applicate e fatte rispettare, non possiamo dirlo. Ma sul fatto che sia ormai
necessario intervenire senza furbizie ci sono pochi dubbi. Lo sostiene con
fermezza anche il presidente dell’Anticorruzione Raffaele Cantone. Che per
questo si è beccato una punzecchiatura dalemiana dalla Velina rossa con l’invito
a far pubblicare tutti i contributi alle fondazioni,«anche a quelle di Firenze».
Bersaglio: Matteo Renzi. Ma forse Pasquale Laurito, autore della Velina, non
aveva consultato il sito della renziana Fondazione Open. Avrebbe trovato una
lunga lista di finanziatori. Dai 175 mila euro del patron del fondo Algebris
Davide Serra ai 50 mila dell’ex presidente Fiat Paolo Fresco e della sua
consorte Marie Edmée Jacqueline, ai 60 mila della Isvafim di Alfredo Romeo, ai
62 mila del finanziere molisano Vincenzo Manes... Va però detto che non
compaiano i nomi di chi non ha dato l’assenso alla pubblicazione. Come se la
privacy possa valere per i finanziamenti a una fondazione che fa riferimento al
premier e con un consiglio direttivo nel quale accanto al suo amico del cuore
Marco Carrai ci sono il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi, il
sottosegretario alla presidenza Luca Lotti e l’avvocato Alberto Bianchi,
nominato dal governo nel consiglio di amministrazione dell’Enel. Nessuna lista
abbiamo trovato invece nel sito della Italianieuropei presieduta da Massimo
D’Alema, di cui Claudio Gatti e Ferruccio Sansa ricordano nel loro libro «Il
sottobosco» alcuni finanziatori: gli imprenditori Alfio Marchini e Claudio
Cavazza, i gruppi Pirelli e Asea Brown Boveri, nonché le immancabili Coop,
queste ultime per 103.291 euro. Per la sinistra Italianieuropei è stata un
formidabile rompighiaccio. Da allora è stato un fiorire di fondazioni,
associazioni, centri studi, think tank. Pier Luigi Bersani e Vincenzo Visco
hanno messo su Nuova economia nuova società. Anna Finocchiaro la Fondazione
Cloe. Walter Veltroni la scuola di politica Democratica, che ha cambiato nome in
Idemlab. Impossibile poi non citare Astrid di Franco Bassanini e Glocus di Linda
Lanzillotta. Come pure le associazioni Riformismo e solidarietà dell’attuale
sottosegretario (all’Economia) Pier Paolo Baretta e Libertà Eguale del
viceministro (stesso ministero) Enrico Morando. E il network trasversale di
Enrico Letta e Angelino Alfano, Vedrò. La destra non è stata certo da meno. Ecco
allora la Free Foundation di Renato Brunetta. Poi la già citata Nuova Italia di
Alemanno, adesso orfana di quel Panzironi finito nella bufera giudiziaria
romana: al suo posto Claudio Ferrazza, avvocato dell’ex sindaco di Roma. Orfana
del medesimo soggetto pure la Alcide De Gasperi di Frattini, dove Panzironi, ha
raccontato l’ex ministro degli Esteri, era arrivato dietro consiglio di
Alessandro Falez, imprenditore della sanità con solidissimi rapporti vaticani.
Quindi la Cristoforo Colombo per le Libertà di Claudio Scajola, con un comitato
politico presieduto dall’ex ministro Mario Baccini: il quale a sua volta ha una
propria fondazione, la Foedus. Ecco poi la Fondazione della Libertà per il Bene
Comune: presidente l’ex ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli, al suo
fianco il costruttore suo braccio destro Erasmo Cinque insieme a Roberto
Serrentino e Giovan Battista Papello, entrambi già piazzati all’Anas dalla
destra. Ecco ancora Italia Protagonista di Maurizio Gasparri. E Riformismo e
Libertà di Fabrizio Cicchitto. Mentre si chiama Europa e civiltà la fondazione
di cui è presidente onorario Roberto Formigoni. Per non parlare di Magna Carta
di Gaetano Quagliariello, che ha il merito di esporre gli stemmi (ma non i
contributi) dei soci fondatori, fra cui Erg e Mediaset: mentre non troviamo più
l’elenco dei soci aderenti, dove tre anni fa figurava anche la holding pubblica
Finmeccanica. Esiste ancora il Movimento delle Libertà dell’ex parlamentare di
Forza Italia Massimo Romagnoli. Come Città Nuove, embrione di quello che poteva
essere il partito della ex presidente della Regione Lazio Renata Polverini. E
sopravvive pure Costruiamo il futuro, forse un tantino abbacchiata dopo quello
che è successo al suo presidente (autosospeso) Maurizio Lupi.
TANGENTOPOLI E LE CONSULENZE TRUCCATE.
"Mose, un miliardo bruciato in tangenti e consulenze".
L'inchiesta di Venezia. Il costruttore Baita: un euro su
cinque sprecato per le spese extra. Le risorse dissipate anche in assunzioni di
favore e studi tecnici inutili per realizzare l'opera, scrivono Giuseppe
Caporale e Corrado Zunino su “La Repubblica”. C'è un miliardo di troppo nel
prezzo del Mose, cantiere costato ad oggi 5,6 miliardi pubblici. Quel miliardo
di troppo lo ha evidenziato il più importante tra i costruttori, Piergiorgio
Baita che ha guidato la Mantovani spa fino al suo arresto, 28 febbraio 2013.
Quel miliardo non è servito a far crescere la mastodontica opera idraulica, ad
assumere i progettisti più qualificati, a pagare macchinari, bonifiche,
straordinari. È servito solo ad alimentare il Consorzio Nuova Venezia,
appaltatore unico della diga da trenta chilometri. Fin qui la magistratura ha
certificato 22,5 milioni di tangenti consegnate dal consorzio a sindaci e
presidenti di Regione, magistrati delle acque e della Corte dei conti,
consiglieri regionali, finanzieri, spioni. A questo bottino minimo (il 4 per
mille del valore dell'opera, ben al di sotto della media delle mazzette
italiane) vanno però aggiunti i costi delle "utilità" certificate: le ville
ristrutturate a carico della pubblica comunità, i soggiorni in grand hotel di
Venezia e Cortina, i voli privati, le vacanze in Toscana pagate alla famiglia di
Paolo Emilio Signorini, funzionario della Presidenza del Consiglio. E, ancora, i
contratti a progetto offerti nelle "aziende Mose" a figli e fratelli di
magistrati, le molte assunzioni precisamente inutili: la figlia di Paolo
Splendore, direttore dei servizi segreti del Triveneto, la figlia di Giovanni
Artico, importante funzionario della Regione Veneto, quindi Giancarlo Ruscitti,
ex funzionario della sanità utile per ottenere l'appalto dell'ospedale di
Padova. Il conto del malaffare s'impenna, infine, contabilizzando le consulenze
inutili, gli studi idrogeologici commissionati e neppure letti. "Tutti insieme
noi costruttori abbiamo girato al consorzio cento milioni l'anno", dice
l'ingegner Baita, maggior azionista Cnv da undici stagioni. Fanno un miliardo,
qualcosa in più, lasciando fuori i venti precedenti anni di vita del
raggruppamento Nuova Venezia. È una tangente globale pari al 20 per cento
dell'opera: i conti iniziano a tornare. Nelle 437 pagine delle richieste di
arresto della procura veneziana si trovano molte conferme a quella cifra
sprecata, un miliardo di euro, in illecite "pubbliche relazioni". Le regole
della tangente collettiva - i costruttori dovevano fare una colletta ogni volta
che veniva richiesto - le impose il capo supremo Giovanni Mazzacurati quando
prese in mano le redini del consorzio monopolista in Laguna. Nel 2002. "La mia
azienda aveva appena rilevato le quote del Consorzio appartenute a Impregilo, un
investimento da 70 milioni che ci trasformava negli azionisti più importanti",
ha messo a verbale l'amministratore della Mantovani, Piergiorgio Baita.
"L'ingegner Mazzacurati mi convocò e, in sede, mi precisò una serie di regole
non scritte che vigevano tra i soci. La più importante era questa: dovevamo
impegnarci tutti a retrocedere al consorzio, in nero, le somme concordate". Il
secondo obbligo era che "nessuna delle singole imprese, salvo ordine supremo,
poteva permettersi di pagare direttamente politici e funzionari: le tangenti
dovevano sempre passare attraverso il consorzio". Mazzacurati, che pretendeva di
essere l'unico a gestire i rapporti politici più alti - incontrò diverse volte a
Roma Silvio Berlusconi e Gianni Letta "per spiegare come stavano i lavori del
Mose e farli procedere più velocemente" - riceveva le buste di denari
personalmente dai costruttori. Altre volte mandava uno dei suoi collaboratori:
Luciano Neri o Federico Sutto. Raccoglievano e consegnavano al presidente. "Era
Mazzacurati a decidere il fabbisogno di fondi extracontabili, a scegliere chi
doveva anticipare le somme nei momenti di crisi. Era lui, durante le campagne
elettorali, a dettare gli importi del finanziamento ai partiti. Noi della
Mantovani e quelli di Fincosit sostenevamo rappresentanti del Pdl, Condotte e
Coveco il Pd. Solo la mia azienda ha retrocesso al consorzio sei milioni di
euro". Retrocesso, si dice così. Significa " restituire in nero" parte del
denaro pubblico ricevuto per trasformarlo in tangente. Già, nel tempo il
collezionista di "rientri" aveva perfezionato il" sistema di retrocessione",
come illustra il prospetto recuperato dalla finanza nel novembre 2011. Le
quattro aziende più importanti - la Mantovani, la Coedmar, la Fincosit e la
cooperativa Coveco - si facevano carico di "ritornare" al loro consorzio il
50-6-0 per cento degli importi indicati nelle "prestazioni di servizio", studi
idrogeologici e consulenze tecniche. La stessa aliquota (50-60 per cento
dell'appalto) le aziende dovevano riconsegnarla sulla voce "anticipazione di
riserve" (fondi messi da parte in attesa di richieste urgenti). Infine, le
quattro grandi aziende grandi e le due minori dovevano garantire il 5-6 per
cento dei ricavi derivanti dai "lavori in sasso": la gettata di massi fatta per
alzare dighe alle quattro bocche del Mose. "Il sospetto che qualcuno di noi
costruttori cercasse di barare al gioco della colletta c'era ", confessa Baita.
Spiegano i magistrati: "Accettato l'importo richiesto, le imprese stipulavano
con il consorzio contratti fittizi per prestazioni sovradimensionate
nell'importo. I contratti venivano tutti predisposti dal ragionier Neri". Un
esempio? "La coop Coveco riceveva una fattura dalla sua azienda San Martino di
2-00 mila euro e faceva la fattura di200 mila euro al Consorzio Venezia Nuova.
Dopo un mese Pio Savioli con la sua macchinetta andava a prendere 1-00 mila euro
in contanti dalla San Martino e li portava in Piazzale Roma all'amico Neri ".
Che li girava a Mazzacurati, che li distribuiva a Orsoni e Galan. Alla fine di
ogni esercizio le singole imprese dovevano taroccare i loro bilanci annuali per
spiegare gli esborsi extra Mose. E predisporre relazioni con l'elenco delle
riunioni e degli incontri formali. "Attività mai svolte", dicono i magistrati,
"che saranno coperte da Valentina Croff, rappresentante legale del Consorzio ".
Per telefono, intercettati, si sentono dirigenti di società quantificare il
falso: "Per merce sollevabile con i moto pontoni posso mettere trenta
tonnellate?... No, è rischioso, metti solo dieci".
Lupi, le consulenze d'oro del suo ministero.
Sul sito delle Infrastrutture, 48 pagine e 478 file raccontano
dei contratti (e dei rinnovi di anno in anno) degli “esperti” scelti fuori dai
ranghi della Pubblica Amministrazione di cui si è avvalso il dicastero. Dai 136
mila euro per Incalza ai 60 mila netti per Girlanda. Con buona pace della
spending review, scrive Sonia Oranges su “L’Espresso”. Quarantotto pagine per
poco meno di 480 file che, sul sito del ministero della Infrastrutture ,
raccontano della valanga di consulenze e collaborazioni, spesso ottimamente
pagate, di cui si è avvalso in questi anni il dicastero guidato da Maurizio
Lupi. Di certo lo era quella di Ercole Incalza, il superdirigente arrestato
lunedì scorso per un presunto giro di tangenti sulle grandi opere. Incalza lo
scorso anno, ha ricevuto 136mila euro dal ministero per guidare la struttura
tecnica di missione: un cococo d’oro, che fa sbiadire la pensione da 60 mila
euro annui, pure percepita dal dirigente ora in manette. D’altra parte, la
struttura di missione brilla per quantità e consistenza delle consulenze
assegnate: circa una Ercole Incalza ventina quelle da 75mila euro annui,
destinate a professionisti (soprattutto avvocati e ingegneri) che spesso portano
avanti carriere parallele: quelle svolte privatamente, e quelle costruite negli
anni all’interno della pubblica amministrazione, con redditi da quadro, senza
aver mai vinto alcun concorso. Carriere parallele in cui i confini tra pubblico
e privato sono pericolosamente sfumati, almeno a leggere i dettagli dei
curriculum. Sergio Mastrangelo è al ministero dal 2011 come esperto, pur essendo
presidente di consorzi privati impegnati nella ricostruzione in Abruzzo. Alfredo
Cammarano, fino al 2009 è stato dipendente dell’Economia e funzionario apicale
del Cipe, poi consulente per il gruppo che doveva costruire una pezzo di
autostrada tra l’aeroporto di Grazzanise e la Domitiana, infine consulente delle
Infrastrutture. La lista di nomi è lunga. C’è il brindisino Donato Caiulo che da
dirigente del porto pugliese finì pure lui in un’inchiesta sul rigassificatore.
C’è un manager dell’information technology come Domenico De Rinaldis che
contemporaneamente lavora anche con il ministero dello Sviluppo economico, e c’è
l’avvocato Massimo Ricchi, pedeegree forense maturato nello studio di Giuseppe
Consolo, che si è già sperimentato al Cipe e al ministero della Giustizia. Ma
anche negli altri settori del ministero, gli appannaggi dei collaboratori non
lasciano a desiderare. Di certo non si lamenta Nicola Bonaduce, consigliere per
gli affari regionali di Lupi, già suo capo segreteria alla Camera e con un
passato milanese a dirigere le relazioni istituzionali della Compagnia delle
Opere: porta a casa un compenso da 90mila euro l’anno, che arrotonda con i
28mila euro provenienti dall’incarico di consigliere di indirizzo dell’Istituto
nazionale di Ricovero e Cura degli Anziani. Che nulla hanno a che fare con
ponti, strade e porti, ma poco importa nella logica dei giri di poltrone del
palazzo. Rocco Girlanda La stessa logica che spiega la permanenza al ministero
delle Infrastrutture di Rocco Girlanda, pure lui indagato nell’ultimo scandalo
delle opere pubbliche. Nel dicastero era sottosegretario forzista durante il
governo Letta, e quando gli azzurri abbandonarono il governo, preferì lasciare
gli azzurri ed entrare in Ncd, conservando la poltrona. E se il cambio della
guardia a Palazzo Chigi gli è costato il sottogoverno, alle Infrastrutture è
rimasto lo stesso. Come consulente “esperto per l'approfondimento delle
problematiche inerenti l'autotrasporto ed il trasporto merci e concernenti il
miglioramento dell'efficienza del trasporto pubblico locale, nonché per i
rapporti con il Cipe”, per un corrispettivo di 60mila euro annui. Netti.
Tangenti grandi opere, Giulio Burchi:
"La spartizione delle direzioni lavoro, una delle vergogne di questo paese",
scrive Claudia Fusani su L'Huffington Post. Passerà alla storia per quel grido
“Ercole, Ercolino (Incalza, ndr), che decide tutto lui, al 100%i” condiviso con
l’amico imprenditore al telefono.. Oppure per l’altra: “Non faccio altro che
fare l’ufficio di collocamento”. O magari per quella straordinaria ammissione:
“I soldi che ho guadagnato a stare in questo Paese di merda deregolarizzato…”.
Ogni inchiesta regala uno o più personaggi, una o più frasi destinati ad entrare
nella cronaca. E quindi nella storia. Pennellate gergali che hanno il potere di
spiegare più di mille pagine di atti giudiziari. Nei faldoni di “Sistema”,
l’inchiesta della procura e del Ros di Firenze sulla “Cricca delle Grandi Opere”
(o della Struttura tecnica di missione) si ritaglia un ruolo molto particolare
Giulio Burchi, imprenditore modenese di 65 anni (li ha compiuti proprio in
questi giorni) che forse è azzardato chiamare “compagno” ma certo vanta una
buona amicizia con un compagno storico come Ugo Sposetti. Il “compagno” Burchi,
dunque. Dal punto di vista giudiziario ha un ruolo abbastanza defilato tra gli
oltre cinquanta indagati. E’ indagato per false fatturazioni (200 mila euro) e
traffico di influenze (346 bis cp), uno dei nuovi reati contro la corruzione
introdotti dalla famosissima legge Severino. Burchi avrebbe cioè utilizzato le
proprie conoscenze per ottenere la direzione dei lavori di un tratto (20 km)
della Salerno-Reggio Calabria. Eppure, nonostante la marginalità, è quasi un
Virgilio che accompagna gli investigatori nella selva oscura della Struttura di
missione. Colui che, essendoci dentro da anni, ne rivela nelle intercettazioni
presunti meccanismi e segreti. Con una caratteristica: il compagno Burchi odia e
ama il sistema. Scrivono i pm fiorentini Turco, Mione e Monferini: “Benchè in
numerose conversazioni intercettate Burchi non perda occasione per stigmatizzare
il rapporto illecito tra Ercole Incalza e Stefano Perotti, è un soggetto
perfettamente inserito nel sistema illecito”. Quando si ha notizia dei primi
arresti per Expo tra cui quello di Antonio Acerbo, il sub commissario di Expo,
Burchi ammette: “Anch’io ho fatto compromessi ma i soldi che ho guadagnato a
stare in questo paese di merda deregolarizzato non li avrei mai potuti
guadagnare in Inghilterra o in America”. Una gola profonda. A sua insaputa. Il
“compagno” Burchi, ad esempio, è il primo ad indicare agli investigatori il buco
nero dell’inchiesta, dove nasce il malaffare nella cricca della Struttura di
missione. Il 5 giugno 2014, commentando le notizie sull'indagine della Procura
di Venezia sul Mose, afferma: “Ci sono due elementi che sono assolutamente non
procrastinabili, togliere dalla Legge Obiettivo il fatto che il general
contractor possa nominarsi il direttore dei lavori”. E’ quello che i pm
chiameranno “il grimaldello del collaudato sodalizio criminale: “Una direzione
dei lavori siffatta, dove il controllore è per contratto anche il controllato, è
lo strumento che fa transitare su società e soggetti privati enormi somme di
denaro (per compensi non inferiori all’1% dell’importo dei lavori appaltati, ma
in molti casi fino addirittura al 3%), prive di sostanziale giustificazione ed
inquadrabili nel prezzo di una dazione corruttiva”. Detto in modo ancora più
chiaro, “utilità illecite in favore del sodalizio medesimo costituite dal
conferimento dell’incarico professionale di direzione lavori e spesso da una
miriade di assunzioni o consulenze collaterali alla gestione dell’appalto, del
tutto fittizi, in favore di amici degli amici del pubblico ufficiale o di suoi
prestanome o accoliti”. Così, in un’intercettazione del 21 ottobre 2014, Burchi
dice: “La spartizione fantastica di queste direzioni lavori commissionate dai
general contractor è una delle vergogne grandi di questo Paese perché affidando
alle stesse imprese la direzione dei lavori hai depotenziato la funzione di
controllo dello Stato. Una cosa che se tu la spieghi ad un inglese non ci riesci
... Un mio amico inglese mi ha detto che non era possibile, che mi sbagliavo”.
Ecco perché i pm definiscono “ricordo quasi patetico le mazzette” rispetto alla
“moderna prassi corruttiva” dove i “professionisti nominati direttori dei lavori
(nell’inchiesta Sistema è il caso dell’ingegnere Perotti, ndr) e gli stessi
funzionari (l’ingegnere e dirigente generale del ministero Ercole Incalza e suoi
sodali, ndr) fanno parte di un’unica compagine criminale che condivide
strategie, azioni e proventi illeciti”. Giulio Burchi è un supermanager dai
molti incarichi: presidente del consiglio di amministrazione di Italferr spa dal
2004 al 2007, siede in diversi cda (la Autocamionabile della Cisa spa;
autostrade lombarde; società di progetto autostrada diretta Brescia Milano;
serenissima A4) anche di partecipate miste ed è referente della Siteco s.r.l.
(servizi di engineering e di consulenza tecnica), e della “Siteco Informatica
s.r.l.”. È stato anche socio dell’invidiatissimo “Perottino”(Stefano Perotti,
arrestato con Incalza, Cavallo e Pacella) che definisce “il loro uomo su tutto”,
quello che ha preso “diciassette direzioni lavori sempre con lo stesso sistema”
ma che è vissuto nell’ambiente come “una spina nell’occhio” perché “Incalza
glielo ha fatto digerire in molte situazioni in cui ne avrebbero fatto anche a
meno”. Nelle numerose intercettazioni i pm rintracciano il filo rosso di una
prassi volta “inequivocabilmente a procurarsi false fatture per abbattere gli
utili”. Questo per testimoniare l’originalità e l’affidabilità della gola
profonda. Che infatti rivela vari aspetti del sistema. Quello dei figli, ad
esempio: il figlio di Acerbo che si scambia incarichi e consulenze con il padre
ex numero 2 di Expo; il figlio di Lupi, di alcuni amici del giovane ingegnere e
di altri figli di dirigenti del ministero che beneficiano di posti di lavoro.
Burchi è una fonte preziosa anche nel raccontare un altro effetto collaterale
dell’inchiesta Sistema: la ricerca di posti di lavoro. “Non faccio altro che
fare l’ufficio di collocamento” dice al telefono con l’amico Ugo Sposetti (il
senatore Pd che a sua volta in questi giorni ha paragonato “alla Caritas” il suo
interessamento “per persone che hanno bisogno”). Burchi si attiva spesso per
trovare posti e incarichi in favore di persone indicate da Sposetti o dal
viceministro alle Infrastrutture Riccardo Nencini il quale “scrivono i pm,
s’interfaccia con il Burchi tramite l'ex parlamentare Mauro Del Bue”. Il 3
aprile 2014 il supermanager chiede a Del Bue di procurargli un appuntamento con
Nencini. Subito dopo Del Bue chiede a Burchi: “Tu potresti dargli qualche
contributo di questo tipo anche a Nencini, ci sono delle nomine da fare in giro,
ci interessa sistemare due o tre persone in qualche ente”. Altre intercettazioni
spiegano che in effetti Burchi ha chiesto a più soggetti, tra cui il
viceministro, un intervento per una nomina in Terna. Il 17 maggio 2014 sempre
Burchi dice al telefono: “Sistemare uno in un collegio, mi può essere utile,
Riccardo Nencini è vice ministro”. Magari sono solo millanterie ma è
significativo di come ragionano gli uomini della cricca. Che in certi momenti
sembrano non poterne più dello strapotere di Perotti. Il 5 aprile Burchi è al
telefono con un altro manager, Giovanni Gaspari. Parlano dell’appalto e delle
direzione lavori dell’autostrada in Libia. Perotti vuole e otterrà anche quella.
Gaspari auspica qualche intervento di “pulizia”, probabilmente dal governo:
“Speriamo che vada avanti, un po’ di pulizia la dovrebbe fare, però non sta
pulendo quello che gli altri stanno facendo lì alle Infrastrutture... Lupi & C
stanno facendo”.
La Procura di Milano: «Giulio Tremonti corrotto». Ecco le accuse.
Richiesta dei pm al Senato: l'ex ministro va processato per corruzione. Nel
mirino una tangente da 2,5 milioni su un affare miliardario di Finmeccanica,
mascherata da parcella del suo studio professionale. Le ammissioni del suo ex
braccio destro, Marco Milanese, e degli altri faccendieri arrestati, scrive
Paolo Biondani su “L’Espresso”. Un grande ministro. Il suo studio professionale
privato. E una parcella da due milioni e mezzo di euro. C'è questo triangolo
d'oro alla base dell'inchiesta che ha spinto la Procura di Milano a chiedere al
Senato l'autorizzazione a procedere contro Giulio Tremonti. L'ex ministro
dell'Economia ora rischia di finire sotto processo per corruzione. In Italia
l'unico precedente di questa speciale procedura risale agli anni neri dello
scandalo Lockheed. Come qualsiasi altro indagato, Tremonti va considerato
innocente e lo rimarrà fino a un'eventuale condanna definitiva. Ma rispetto ai
normali cittadini ha un'arma in più: grazie a una legge costituzionale del 1989,
i suoi colleghi parlamentari hanno il potere di bloccare con un veto politico il
processo contro il senatore Tremonti. L'indagine riguarda un affare del gruppo
Finmeccanica che si è rivelato disastroso per le casse dello Stato. Ma ha
garantito una ricca parcella allo studio fiscale fondato dal professor Tremonti.
Nel 2008 l'azienda statale, allora guidata da Pierfrancesco Guarguaglini,
acquista il gruppo statunitense Drs, che è un grande fornitore di tecnologie
militari, per un prezzo astronomico: 5 miliardi e 200 milioni di dollari, che
all'epoca corrispondono a 3,4 miliardi di euro. Oggi il valore del gruppo
americano si è quasi dimezzato: lo Stato italiano ci ha rimesso più di due
miliardi di dollari. Tra i consulenti fiscali di quell'operazione spicca lo
studio Virtax, di cui è socio fondatore Tremonti, che quando diventa ministro lo
affida al suo fidato collega Enrico Vitali. Finmeccanica è una grande società
controllata dal governo, che ha il potere di nominare gli amministratori.
Inoltre il ministero dell'Economia deve sborsare 250 milioni di euro per
l'aumento di capitale necessario a garantire gli imponenti prestiti bancari
spesi per comprare Drs. Nel 2008, dunque, sembra a tutti impensabile varare
un'operazione così costosa senza l'appoggio di Tremonti. Che infatti vede il
numero uno di Finmeccanica ancor prima delle elezioni, quando è già sicura la
vittoria di Berlusconi: nel suo interrogatorio, però, Tremonti «non ha memoria»
di quel primo incontro con Guarguaglini. La richiesta di autorizzazione a
procedere cita numerosi testimoni, già sentiti da diverse procure (Roma, Napoli
e Milano) nelle indagini su Finmeccanica: tutti confermano che Tremonti
all'inizio è contrario a quell'operazione miliardaria dell'azienda statale. Il
problema è che l'ostilità del ministro smette di manifestarsi proprio quando lo
studio Virtax ottiene quella consulenza da due milioni e 615 mila euro. La data
del contratto di assistenza fiscale con Finmeccanica è veramente imbarazzante: 8
maggio 2008, lo stesso giorno in cui Tremonti diventa ministro del quarto
governo Berlusconi. L'indagine, come impone l'apposita legge sui reati commessi
dai ministri nell'esercizio dei loro poteri, è stata condotta da tre magistrati
estratti a sorte. Riuniti nel cosiddetto «tribunale dei ministri», hanno avuto
solo solo 90 giorni di tempo per chiudere l'intera inchiesta. Tremonti intanto
ha potuto esaminare tutti gli atti d'accusa, presentare prove a discolpa e farsi
interrogare. Ma non ha convinto nessuno dei tre giudici istruttori. Il primo
pilastro dell'accusa è il rovesciamento della posizione di Tremonti, che sembra
avvenire in perfetta coincidenza con la consulenza fiscale milionaria incassata
dal suo studio. Lo testimonia perfino il suo ex braccio destro, Marco Milanese,
l'ex parlamentare di Forza Italia già protagonista del caso dei soldi in nero
per affittare una casa di lusso per il ministro a Roma: l'indagine romana che ha
spinto Tremonti a patteggiare la sua prima condanna per finanziamenti illeciti.
Riascoltato dal tribunale dei ministri, Milanese spiega di aver assistito
personalmente all'incontro tra il ministro e Guarguaglini. E conferma che
all'inizio «Tremonti si lamentava che queste società, tra cui Finmeccanica,
andassero a investire all'estero e non in Italia». L'ex braccio destro, già
inquisito per le tangenti del Mose di Venezia, non vorrebbe dire di più. Ma
quando il tribunale dei ministri gli contesta le dichiarazioni che lui stesso
aveva già reso in precedenza ai pm, l'ex onorevole Milanese conferma di aver
saputo, dall'interno di Finmeccanica, «che l'affare era stato concluso e che al
riguardo della contrarietà con Tremonti avevano trovato una strada... attraverso
il coinvolgimento dello studio Vitali». Nello stesso interrogatorio Milanese
rivela che il ministro Tremonti, per le comunicazioni più riservate, «non usava
il suo telefono, ma prendeva il mio o quello della capo-segreteria». Anche
Lorenzo Borgogni, ex responsabile delle relazioni esterne di Finmeccanica,
dichiara di aver «accompagnato Guarguaglini allo studio a Roma di Tremonti, che
gli domandò come mai non investiva in Italia ma negli Stati Uniti». In quel
momento Tremonti non era ancora ministro e secondo Borgogni il suo parere «era
molto condizionato dalla Lega», preoccupata per la sorte della fabbrica Agusta
che ha sede a Varese, la città di Bossi e Maroni. Sul collegamento tra la
parcella e il successivo via libera, invece, Borgogni all'inizio sostiene di non
ricordare bene: «Può darsi che abbia detto che sicuramente con un coinvolgimento
dello studio, anche il ministero.... la posizione di Tremonti sarebbe stata più
in difficoltà». Ma quando gli viene contestato un altro verbale, lo stesso
Borgogni finisce per confermare che il movente dell'incarico «era certamente
quello di inserire lo studio di Vitali, che poi voleva dire anche Tremonti,
nell'orbita delle società che lavoravano per Finmeccanica, e soprattutto in
un'acquisizione di questo genere». L'accusa più esplicita arriva da Lorenzo
Cola, il faccendiere romano di estrema destra che ai tempi di Guarguaglini era
incredibilmente diventato il rappresentante di Finmeccanica nella trattativa
miliardaria con gli americani. Cola riassume così la posizione iniziale del
ministro: «Gurauaglini mi informò che Tremonti gli disse: “Voi andate a
investire questi grandi capitali all'estero, quando noi in questo momento
avremmo altre emergenze, tipo Alitalia”». Lo stesso Cola aggiunge che in seguito
Guarguaglini (che invece nega tutto) gli rivelò che «per avere il consenso di
Tremonti e poter fare l'operazione, era stato necessario dare questa consulenza
allo studio professionale». Di consulenze per quell'affare, in effetti, Cola se
ne intende: lui stesso ha intascato più di 16 milioni di dollari, che
Finmeccanica (azienda statale quotata in borsa) gli ha versato su un conto
intestato a una società offshore. L'ex titolare dell'Economia è stato attaccato
più volte, durante tutto il ventennio berlusconiano, per i presunti conflitti
d'interessi tra l'attività pubblica e quella privata, ma ha sempre replicato di
non aver mai mescolato il suo ruolo di ministro delle tasse con quello di
consulente fiscale delle aziende. Ogni volta che è tornato al potere con
Berlusconi, in effetti, Tremonti ha lasciato ai suoi partner tutte le attività
dello studio, restandone socio esterno, per ridiventarne titolare solo quando
non era più ministro. E così nel 2006, nei due anni di governo Prodi, nella sede
centrale di via Crocefisso a Milano è tornata la sigla «studio Tremonti», ma nel
2008, quando è ridiventato ministro, il suo nome è scomparso dall'elenco dei
professionisti associati. Anche la consulenza a favore di Finmeccanica, quindi,
è stata gestita dal suo socio principale, Enrico Vitali, che aveva fondato lo
studio negli anni '80 insieme a Tremonti. Ma i magistrati milanesi ora si sono
convinti che quella parcella, benché intestata ad altri, sia stata il prezzo
sborsato da Finmeccanica per “comprare” il consenso del ministro. Una tangente
ben mascherata con una fattura in apparenza regolare. Il tribunale dei ministri
è arrivato a concludere che quella consulenza era fittizia, cioè serviva solo a
dare una giustificazione cartacea al passaggio di soldi, anche grazie ad altre
deposizioni. Alessandro Pansa, allora direttore generale di Finmeccanica, anche
lui ora coinvolto suo malgrado nell'indagine per corruzione, ha dichiarato che
fu Guarguaglini a imporgli la scelta dei consulenti fiscali. Ai quali Pansa
impose uno sconto: quattro milioni in tutto, anziché i cinque richiesti. A
chiudere il cerchio delle testimonianze sono gli altri consulenti di
Finmeccanica: i tributaristi italiani della società Ernst & Young. Che
confermano di aver dovuto accettare, con imbarazzo, la richiesta di Vitali di
incassare la fetta più grande della parcella, cioè due milioni e mezzo. Anche se
il lavoro effettivo di consulenza a Finmeccanica l'aveva fatto proprio e
soltanto Ernst & Young. Un manager di questa società dichiara testualmente che
Vitali e i suoi colleghi «erano puri spettatori», nel senso che «l'intero
lavoro» era a carico di Ernst & Young, e quasi si scusa della sua testimonianza,
precisando: «Non volevo essere offensivo nei confronti di nessuno, era proprio
una constatazione di quello che è veramente accaduto». A questo punto i giudici
del tribunale del ministri passano in rassegna tutti i documenti che dovrebbero
dimostrare l'effettivo contenuto della consulenza fornita dallo studio fiscale
di cui Tremonti è fondatore e comproprietario. Il controllo è possibile perché
la Procura di Roma, con il pm Paolo Ielo, ha sequestrato già nel 2010 l'intero
dossier Drs nella sede di Finmeccanica. Mentre l'indagato Vitali ha potuto
presentare al tribunale tutti gli atti del suo studio. Quindi i giudici milanesi
passano in rassegna tutte le carte, una dopo l'altra, ma non trovano neppure un
atto dello studio Virtax che possa rappresentare una qualsiasi forma di
esecuzione della consulenza contrattata con Finmeccanica. E tantomeno
giustificare una parcella da due milioni e mezzo. Ci sono soltanto email,
resoconti di riunioni orali e informazioni generiche sulle leggi fiscali
americane, scaricabili anche da Internet. Tutti gli atti più importanti sono
stati compilati da Ernst & Young: lo studio Virtax, osservano sconsolati i
giudici, si è limitato «ad apporre il proprio logo successivamente alla
redazione del documento».
Giulio Tremonti: "Mai chiesto nulla a Finmeccanica".
La replica dell'ex ministro alla notizia delle indagini avviate
dalla procura di MIlano nei sui confronti per presunti reati ministeriali,
scrive R.I. su “L’Espresso”. «Non ho mai chiesto o sollecitato nulla ed in
nessun modo da Finmeccanica. Anche per questo, come sempre, ho assoluta fiducia
nella giustizia». Così l'ex ministro Giulio Tremonti ha replicato alla notizia
delle indagini avviate dalla procura di Milano. «Ben prima di entrare nel
governo, insediatosi venerdì 8 maggio 2008 - spiega Tremonti in una nota - mi
sono cancellato dall'ordine degli avvocati e sono uscito dallo studio in base ad
atto notarile e perizia contabile. Ci sono rientrato solo nel 2012, un anno dopo
la fine del governo, come prescrive la legge. Nel durante ho interrotto tutti i
rapporti con lo studio». «L'operazione DRS-Finmeccanica - prosegue - ha
interessato e coinvolto la politica industriale e militare di due Stati. Come
risulta dai documenti SEC e Consob, l'operazione è iniziata nell'ottobre 2007 ed
è stata conclusa lunedì 12 maggio 2008. Anche seguendo il calendario, si può
dunque verificare che, per la sua dinamica irreversibile e per la sua natura
internazionale, l'operazione non era da parte mia né influenzabile, né
modificabile, né strumentalizzabile. In questi termini, non ho mai chiesto o
sollecitato nulla ed in nessun modo da Finmeccanica».
Quanti affari col metodo Tremonti. Tre
milioni al “suo” studio per sbloccare un’operazione di Finmeccanica: l’ex
ministro indagato per corruzione. Ma per i pm anche altri casi sono sospetti. A
partire dal Mose, scrive Paolo Biondani su “L’Espresso”. Giulio Tremonti Un
grande ministro. Il suo studio privato. E una ricca parcella. C’è un triangolo
d’oro alla base dell’inchiesta che ha convinto la Procura di Milano a iscrivere
nel registro degli indagati il nome di Giulio Tremonti, per la prima volta
accusato di corruzione. L’indagine riguarda un affare di Stato: una colossale
acquisizione decisa nel 2008 dall’allora vertice del gruppo Finmeccanica, che si
è poi rivelata disastrosa per le casse pubbliche. Ma che in compenso ha
garantito una parcella invidiabile allo studio tributario fondato dal professor
Tremonti. Ricostruendo quell’operazione, i magistrati hanno acceso un faro su un
presunto schema corruttivo: il sospetto è che possa aver funzionato anche in
altri casi clamorosi. Dall’intrigo fiscale Bell-Telecom ai
finanziamenti-scandalo per il Mose di Venezia. Un quadro che ha portato i pm ad
approfondire anche altre indagini collegate, per verificare un’ipotesi d’accusa
più ampia: una sorta di “sistema Tremonti”. Per ora la Procura di Milano ha
fatto partire solo la prima procedura di messa in stato d’accusa davanti al
tribunale dei ministri, che riguarda una presunta triangolazione tra l’allora
ministro dell’Economia, lo studio professionale da lui fondato e il gruppo
Finmeccanica. Nel maggio 2008 quel colosso statale, allora guidato da
Pierfrancesco Guarguaglini, acquista la holding statunitense Drs, che è un
grande fornitore di tecnologie militari, per un prezzo senza precedenti: 5
miliardi e 200 milioni di dollari. Tra i consulenti di quell’acquisizione
compare lo studio Vitali, Romagnoli, Picardi & associati, che ha come socio
fondatore proprio Tremonti. Finmeccanica versa a quello studio una parcella
netta di due milioni e 400 mila euro, quasi tre con l’Iva. L’azienda statale è
controllata dal governo, che nomina i dirigenti, per cui è impensabile varare
un’operazione così costosa senza il via libera del ministero dell’Economia.
Durante le trattative, secondo la ricostruzione dei magistrati, Tremonti si
dichiara contrario. Ma all’improvviso diventa favorevole, proprio alla vigilia
dell’accordo. E ora si scopre che, pochissimi giorni prima di questo
“ribaltone”, il socio più importante dello studio da lui fondato aveva siglato
quella ricca consulenza con Finmeccanica. Per un affare indubbiamente sbagliato:
oggi il valore del gruppo americano si è quasi dimezzato. A conti fatti, lo
Stato italiano ci ha perso più di due miliardi di dollari. L’accusa di
corruzione è stata formalizzata dai pm Roberto Pellicano e Giovanni Polizzi dopo
un vertice con il procuratore capo Edmondo Bruti Liberati, che ha esaminato gli
atti e autorizzato l’iscrizione. Gli indizi finora raccolti hanno convinto i
magistrati, in sostanza, che quella parcella milionaria fosse la vera
spiegazione del cambio di linea del ministro Tremonti. L’ex titolare
dell’Economia era stato attaccato più volte, nel ventennio berlusconiano, per
gli ipotetici conflitti d’interessi legati al suo studio, ma ha sempre replicato
di non aver mai mescolato il suo ruolo di ministro con la sua professione
privata. Ogni volta che è tornato al governo, infatti, Tremonti ha sempre
rivendicato di aver lasciato ai suoi partner tutte le consulenze dello studio,
restandone socio dall’esterno, per ridiventarne titolare solo dopo aver perso la
carica. E così nel 2006, durante il governo Prodi, nella sede di via Crocefisso
a Milano era ricomparsa la sigla «studio Tremonti», ma nel 2008 il suo nome è
sparito dalla lista dei professionisti. La consulenza per Finmeccanica sarebbe
stata gestita, in particolare, dal suo socio più fidato, Enrico Vitali, che
fondò lo studio insieme a lui negli anni Ottanta. Ma ora i magistrati avanzano
l’ipotesi che quella parcella intestata al collega nascondesse il prezzo pagato
da Finmeccanica per “comprare” il sì del ministro. Tra gli atti d’accusa ora
inviati al tribunale dei ministri, compaiono anche gli interrogatori di Marco
Milanese, che è stato il braccio destro di Tremonti per un decennio. Arrestato
per corruzione per l’inchiesta sul Mose di Venezia, Milanese ha confermato che
Tremonti era contrario all’affare Drs, ma cambiò idea in circostanze poco
chiare. Il sospetto di una consulenza fittizia, secondo l’accusa, troverebbe
riscontro anche nei tempi strettissimi: Finmeccanica avrebbe affidato l’incarico
allo studio dei soci di Tremonti appena cinque giorni prima di siglare
l’acquisizione. Le anomalie dell’affare e i dubbi sulla consulenza-lampo
verrebbero indirettamente riscontrati anche da altri testimoni d’accusa, come
Alessandro Pansa, il manager che sostituì Guarguaglini, e gli altri consulenti
di Finmeccanica, soprattutto i tributaristi italiani della Ernst & Young. Ora
Tremonti potrà difendersi davanti al cosiddetto tribunale dei ministri, composto
da tre giudici estratti a sorte. La procedura è regolata da una legge
costituzionale del 1989, che è molto singolare: di fronte a un possibile reato
commesso da un ministro, le procure hanno il divieto di trovare prove. «Omessa
ogni indagine», come impone quella legge, possono soltanto avvisare l’indagato.
È la stessa procedura finora applicata soltanto all’ex ministro Altero Matteoli,
accusato di corruzione nell’inchiesta sulle bonifiche-scandalo della Laguna di
Venezia. L’inchiesta su Tremonti è nata dalle istruttorie delle Procure di
Napoli e Roma sul gruppo Finmeccanica, che avevano svelato il ruolo di Lorenzo
Cola, un faccendiere che nell’era di Guarguaglini era diventato un’eminenza
grigia. Intercettandolo, si è scoperto che proprio lui gestì la trattativa
miliardaria su Drs, fissandone il prezzo senza alcuna verifica indipendente (in
gergo, “due diligence”). Per la sua mediazione non ufficiale, pure Cola sarebbe
riuscito a farsi pagare da Finmeccanica una consulenza da favola: 16 milioni e
mezzo di dollari, che l’azienda statale gli avrebbe versato addirittura su un
conto offshore, nascosto al fisco. Nell’aprile scorso, quando “Il Fatto
Quotidiano” pubblicò le prime indiscrezioni sull’affare Drs, Tremonti si
dichiarò all’oscuro di tutto: «Non so nulla». Ma a questo punto i magistrati
stanno valutando se sia necessario trasmettere al tribunale ministeriale anche
il fascicolo sulla tangente da mezzo milione che gli industriali del Mose di
Venezia hanno ormai confessato di aver versato a Marco Milanese. Quella
mazzetta, nella primavera 2010, ebbe il sicuro effetto di sbloccare centinaia di
milioni di fondi pubblici in precedenza fermati dal ministro. E l’ordine di
pagare Milanese, secondo il manager pentito Piergiorgio Baita, sarebbe venuto
dal grande capo del Consorzio, Giovanni Mazzacurati, «dopo un incontro con
Tremonti a Roma». Finora l’ex ministro aveva avuto pochissimi guai giudiziari:
l’anno scorso ha dovuto patteggiare un’accusa di finanziamento illecito, a Roma,
per l’affitto in nero della lussuosa residenza che gli aveva procurato proprio
Milanese. Gli stessi pm lombardi del caso Finmeccanica però stanno tenendo
aperta anche l’inchiesta sulla Bell, la cassaforte lussemburghese della scalata
a Telecom, che era difesa dallo studio Tremonti. I suoi soci italiani furono
costretti a pagare le prime tasse in Italia solo nel 2007, dopo il ritorno al
governo di Prodi e Visco, versando al fisco ben 156 milioni di euro. Un altro
incrocio pericoloso tra Tremonti, il ministero e lo studio tributario su cui ora
i magistrati vogliono accendere nuove luci.
LE MANI SPORCHE DI MANI PULITE. GIUSEPPE ORSI.
"In cella senza prove e poi assolto. Ora sono volontario per i poveri". L'ex
numero uno di Finmeccanica, le inchieste sulle tangenti indiane e quella sui
soldi alla Lega finite in un nulla di fatto: "Con me hanno distrutto la
reputazione dell'Italia", scrive Stefano Zurlo su “Il Giornale”. La pietra
tombale sulle voci maligne e i sussurri l'ha messa infine il gip di Busto
Arsizio: «L'ipotesi di un finanziamento illecito alla Lega non ha trovato alcun
riscontro investigativo». Peccato che ci siano voluti quattro anni, le
dimissioni da amministratore delegato e presidente di Finmeccanica, in pratica
la più grande industria italiana, un danno d'immagine per il sistema Italia
incalcolabile, decine di titoli di giornale che ricamavano su tutto il
ricamabile. Non si è arrivati nemmeno al dibattimento. «Appunto. La stessa
Procura, dopo anni e anni di indagini, ha chiesto e ottenuto l'archiviazione
perché su questa storia dei 10 milioni che avrei girato alla Lega, tirandoli
fuori come una costola da un'altrettanto inesistente tangente indiana, non c'era
nulla di nulla». Giuseppe Orsi è seduto al tavolo in un' anonima palazzina della
periferia milanese. Sotto c'è «Ruben», il ristorante per i nuovi poveri voluto
dall'ex patron dell'Inter Ernesto Pellegrini. La cena costa 1 euro. Orsi in
pratica è l'amministratore delegato di un ambizioso progetto che mira a dare
pane ma anche occupazione ai tanti in difficoltà. Lui, però preferisce un'altra
qualifica: «Sono il primo volontario. Sa, ho ancora sulle spalle una condanna a
2 anni per false fatture. Confido che cada in appello. Intanto, per correttezza,
non voglio, pur potendolo fare, ricoprire alcun incarico societario. Però».
Giuseppe Orsi, classe 1945, allarga le braccia: «Vede, non è mio costume
alimentare polemiche, ma qualche considerazione vorrei farla». «Sono stato
assolto per la famigerata mazzetta al numero uno dell'aviazione indiana e ora
hanno riconosciuto la mia estraneità a qualunque attività illegale sul versante
Lega. Dicevano persino che l'Indian connection avrebbe rappresentato per la Lega
quel che Monte dei Paschi aveva scoperchiato per il Pd. Sono stato 83 giorni in
cella a Busto Arsizio senza prove. C'erano solo le calunnie di un ex dirigente,
Lorenzo Borgogni, che ho querelato. È stato lui a raccogliere le malevolenze di
alcune persone interne all'azienda, a soffiare sul fuoco costruendo l'accusa».
Una contestazione doppia.
«Sì, io avrei allungato un obolo alla Lega. E avrei creato una provvista in nero
sul fronte indiano dove avrei corrotto il maresciallo Sashi Tyagi, capo di stato
maggiore dell'Indian Air Force».
Ma perché Borgogni l'avrebbe messa in mezzo?
«Quando nel 2011 sono arrivato sul ponte di comando di Finmeccanica, con
qualcosa come 70mila dipendenti, io ho iniziato una profonda riforma della
società. Avevo in mente il modello della public company anglosassone. Rapporti
col potere politico ridotti all'indispensabile, chiusura di alcune delle troppe
sedi romane non operative, avanti con la meritocrazia e via i dirigenti abituati
solo a tessere trame nel palazzo».
Gliel'hanno giurata?
«Qualcuno non si è arreso al cambiamento. Il problema è quel che è successo
dopo».
A cosa allude?
«L'indagine è partita da Napoli, da Woodcock, poi è stata trasferita a Busto.
Bene, dopo mesi e mesi di inchieste, una bella mattina di febbraio del 2013
vengo arrestato. Scusi, ma perché prima non mi hanno almeno interrogato? Tu puoi
considerare che il numero uno di Finmeccanica sia un corruttore internazionale,
ma dovresti porti il problema del danno al Paese. Invece, mi hanno messo in
cella con una sfilza di accuse terrificanti, dalla corruzione internazionale al
riciclaggio, che poi sono cadute. E il governo non ha mosso un dito».
Monti?
«Solo silenzio. Altrove, vedi la Gran Bretagna, il Paese fa quadrato intorno
alle sue industrie strategicamente rilevanti. Da noi un colosso come
Finmeccanica, con aziende importantissime come Agusta Westland e Alenia, è stato
letteralmente abbandonato al suo destino. Nessuno ha provato a circoscrivere
l'incendio».
Quale incendio?
«L'ipotesi era che Agusta, da cui io provenivo e di cui ero stato amministratore
delegato, avesse versato nel 2005 una tangente al maresciallo Tyagi per piazzare
12 elicotteri AW 101. Un contratto da 700 milioni che ora naturalmente è
sospeso. Gli inglesi mettono il segreto di Stato e chiudono la partita. Da noi
tutte le illazioni sono lecite. Ma così si distrugge l'Italia e la sua
reputazione».
Non c'era la tangente?
«Non è mai stata quantificata nemmeno la fantomatica cifra, anche se si
sosteneva che avrei versato fino a 51 milioni di euro. Al dibattimento abbiamo
dimostrato che il processo decisionale indiano era precedente e che Tyagi aveva
solo ratificato una scelta fatta da altri, con un passaggio tecnico molto
importante: l'abbassamento della quota di volo degli elicotteri richiesti
dall'India, portandola, diciamo così, ad un'altezza adatta ai nostri AW 101. Del
resto Guido Haschke, il presunto mediatore di questa storia, ha negato di aver
compiuto alcuna attività corruttiva. Certo, Haschke era storicamente in società
con tre fratelli a loro volta cugini di questo signore. Capisco la suggestione,
ma questo può essere un indizio. E invece siamo persino andati in India a dare
improbabili lezioni di moralità».
Tipo?
«Messaggi di questo tenore: “Attenzione cari amici indiani. Voi avete un capo di
stato maggiore corrotto. Le prove forse ci sono o forse no, ma intanto ve lo
diciamo”. Secondo lei come l'hanno presa? I giornali hanno cominciato a scrivere
che li accusavamo di essere un Paese di ladri. E a puntare il dito contro un
tizio che lì è un semidio. Gli stessi giornali sostenevano che noi andiamo a
sparare contro i loro marinai».
Ah, i marò.
«Mi sono sempre chiesto se ci sia un nesso fra le due vicende».
Il caso Tyagi può aver complicato la già contorta vicenda?
«Un collegamento diretto secondo me non c'è. E però il clima è quello: l'India
si è sentita sotto pressione su due fronti, con una perfetta sovrapposizione
temporale».
Ora è finita.
«No, ci sarà l'appello, c'è ancora quella macchia delle false fatture. E poi,
non creda: il disastro, in termini economici, contrattuali, di immagine, è
incalcolabile. Vada lei a spiegare al Pentagono o all'amministratore delegato
della Boeing che la tangente non c'era, che Finmeccanica si è comportata bene,
che il suo amministratore delegato non è un bandito. Se entri in una black list,
se sei stato depennato, non è facile rientrare nel gioco. E quando ero in cella,
qualcuno si chiedeva: “Possibile che Orsi non esca nemmeno con la cauzione?”».
La cauzione?
«Sì, non è che negli Usa conoscano a memoria come funziona il nostro sistema.
Pochi sanno che da noi questo istituto non c'è».
Oggi?
«Ruben è un'esperienza importante. Diamo da mangiare alle famiglie bisognose.
Senza avvilire la dignità di chi viene qua. Per questo quell'euro è importante.
E presto passeremo alla fase due: il lavoro. A Milano non mancano tanto il cibo
e i sussidi quanto l'opportunità di un lavoro che restituisca dignità. Manca il
lavoro e manca ancora di più la cultura del lavoro. È ora di affrontare questa
emergenza».
LE MANI SPORCHE DI MANI PULITE. BETTINO CRAXI.
Bettino Craxi Da Wikipedia,
l'enciclopedia libera. Benedetto Craxi, detto Bettino (Milano, 24
febbraio 1934 – Hammamet, 19 gennaio 2000), è stato un politico italiano. Craxi
fu Presidente del Consiglio dei Ministri dal 4 agosto 1983 al 17 aprile 1987.
Coinvolto in seguito nelle inchieste condotte dai giudici di Milano che presero
il nome di Tangentopoli, subì due condanne definitive per corruzione e
finanziamento illecito al Partito Socialista Italiano, e morì mentre erano in
corso altri quattro processi contro di lui. Egli respinse fino all'ultimo giorno
della sua vita l'accusa di corruzione, mentre ammise di aver accettato
finanziamenti illeciti, prassi diffusa, per permettere la dispendiosa attività
politica del PSI, meno potente finanziariamente dei due grandi concorrenti, la
DC e il PCI. Il governo e il partito di Craxi vennero sostenuti anche da Silvio
Berlusconi, suo amico personale, avendo altresì una forte sintonia con dei
leader della sinistra europea del calibro di Felipe González e Mário Soares, con
cui vi fu una grande vicinanza rispetto all'allargamento dell'Ue ed al ruolo del
"socialismo mediterraneo". È uno degli uomini politici più rilevanti della
cosiddetta Prima Repubblica, ma anche uno dei più controversi a causa delle
dette indagini di Mani Pulite, che ne condussero all'incriminazione e ad una
duplice condanna definitiva in sede penale. Craxi non scontò mai la pena perché
lasciò il Paese, rifugiandosi in Tunisia, mentre erano ancora in svolgimento i
procedimenti giudiziari nei suoi confronti; pertanto, da latitante, «morì in
solitudine, lontano dall'Italia».
Biografia. Primogenito dell'avvocato
Vittorio Craxi (1906 – 1992), antifascista e perseguitato politico, la cui
famiglia paterna era originaria di San Fratello (comune della provincia di
Messina sui Nebrodi), e di Maria Ferrari, una casalinga di Sant'Angelo Lodigiano
(un comune della provincia di Lodi in Lombardia), Benedetto nasce a Milano il 24
febbraio 1934. Durante la seconda guerra mondiale, la famiglia decide di
affidarlo al collegio cattolico "De Amicis" a Cantù, sia per il carattere
turbolento, sia per allontanarlo dai pericoli che correva a causa dell'attività
antifascista del padre che, dopo la liberazione, assumerà la carica di
viceprefetto a Milano e poi quella di prefetto a Como. Terminata la guerra,
Bettino Craxi frequentò il Liceo ginnasio statale Giosuè Carducci a Milano e
iniziò ad avvicinarsi giovanissimo alla politica; nel 1953 a 19 anni entrò nella
federazione milanese del Partito Socialista, diventandone funzionario e 4 anni
dopo, a 23 anni, fu eletto nel comitato centrale del PSI. Nel frattempo
frequentò la facoltà di giurisprudenza, diventando vicepresidente dell'Unuri, il
parlamentino degli studenti. Intanto proseguiva la sua ascesa all'interno del
PSI: nel 1965 divenne membro della direzione nazionale. Dopo un'esperienza di
amministratore come consigliere comunale a Sant'Angelo Lodigiano e assessore
nella sua Milano, iniziata nel 1960, nel 1968 veniva eletto per la prima volta
in Parlamento. Poco dopo il fallimento dell'unificazione socialista (cioè la
riunificazione coi socialdemocratici avvenuta nel 1969), nel 1970 diventò
vicesegretario nazionale, su nomina di Giacomo Mancini. All'interno del partito
fu un convinto sostenitore di Pietro Nenni e del centro-sinistra "organico" che
in quegli anni governava l'Italia. Nel 1972 con l'elezione di Francesco De
Martino a segretario nazionale del PSI, durante il congresso di Genova, Craxi
viene confermato insieme a Giovanni Mosca nel ruolo di vicesegretario, ricevendo
l'incarico di curare i rapporti internazionali del partito. Da rappresentante
del PSI presso l'Internazionale Socialista stringe legami con alcuni dei
protagonisti della politica estera del tempo, da Willy Brandt a Felipe González,
da François Mitterrand a Mario Soares, da Michel Rocard ad Andreas Papandreou. A
partire da quella funzione di responsabile del PSI per gli esteri, e per tutto
il seguito della sua carriera politica, finanziò alcuni partiti socialisti messi
al bando dalle dittature dei rispettivi Paesi, tra cui il Partito Socialista
Operaio Spagnolo, il Partito Socialista Cileno di Salvador Allende, di cui Craxi
era amico personale, e il Partito Socialista Greco. In omaggio all'apporto dato
ai socialisti cileni, Craxi è stato insignito del Premio Allende alla
memoria, al Festival del cinema latino-americano di Trieste del 2009. Nel 1976,
un articolo sull'Avanti! del segretario socialista Francesco De Martino causò la
caduta del governo Moro, provocando le successive elezioni anticipate che si
conclusero con una crescita impressionante del PCI di Enrico Berlinguer, mentre
la Democrazia Cristiana riuscì a rimanere il partito di maggioranza relativa
solo per pochi voti. Per il PSI invece, quelle elezioni furono una pesante
sconfitta: i voti scesero sotto la soglia psicologica del 10%. Secondo Craxi,
poco dopo la sua elezione a segretario, la popolarità del partito, secondo un
sondaggio da lui commissionato, era scesa ai minimi storici del 6% (solo da Mani
pulite in poi il PSI scenderà più in basso). De Martino, che puntava ad una
nuova alleanza con i comunisti, fu costretto alle dimissioni e si aprì
all'interno del partito una grave crisi. Alla ricerca di una nuova identità che
rilanciasse il partito, il 16 luglio il comitato centrale si riunì in via
straordinaria presso l'Hotel Midas di Roma ed elesse Bettino Craxi, da pochi
giorni capogruppo alla Camera, nuovo segretario. La scelta di Craxi fu frutto di
una mediazione fra le varie correnti socialiste che si presentavano fortemente
frammentate e quindi incapaci di far emergere un segretario, appoggiato da una
solida maggioranza. Emerse così la volontà di eleggere un "segretario di
transizione" che guidasse il partito fuori dalla crisi. Il primo a proporre il
nome di Craxi fu Giacomo Mancini, che riuscì a far convergere sul suo nome anche
i voti delle correnti guidate da Claudio Signorile ed Enrico Manca. Si opposero
alla sua elezione soltanto i cosiddetti "demartiniani", ostili a colui che era
considerato il "pupillo di Nenni", i quali però al momento delle votazioni
preferirono astenersi. Craxi mostrò immediatamente le sue doti politiche,
palesando di essere tutt'altro che un semplice "segretario di transizione".
Nominò suoi collaboratori personalità nuove, alcune molto giovani, tanto da dare
inizio a quella che sarà chiamata la "rivoluzione dei quarantenni". Si mosse con
determinazione ed energia, puntando al rilancio del partito, che "partendo dalla
sua grande tradizione, ritrovasse il suo orgoglio e il coraggio di intraprendere
nuove strade, di dare inizio a quello che il segretario chiamò "il nuovo corso".
Volendo tracciare nuovi sentieri, Craxi si oppose al compromesso storico e
delineò per il futuro una linea dell'alternanza fra la DC e il suo partito. Già
nei primi anni di segreteria ci fu una rivalutazione del pensiero socialista
libertario rispetto al marxismo, una riscoperta di Proudhon rispetto a Marx.
Basta leggere un saggio scritto da Craxi stesso su L'Espresso e
intitolato «Il Vangelo socialista», dove si ha una profonda critica del
leninismo: «La profonda diversità dei «socialismi» apparve con maggiore
chiarezza quando i bolscevichi si impossessarono del potere in Russia. Si
contrapposero e si scontrarono due concezioni opposte. Infatti c'era chi
aspirava a riunificare il corpo sociale attraverso l'azione dominante dello
Stato e c'era chi auspicava il potenziamento e lo sviluppo del pluralismo
sociale e delle libertà individuali [...] La meta finale è la società senza
Stato, ma per giungervi occorre statizzare ogni cosa. Questo è, in sintesi, il
grande paradosso del leninismo. Ma come è mai possibile estrarre la libertà
totale dal potere totale? Invece [...] Si è reso onnipotente lo Stato [...] Il
socialismo non coincide con lo stalinismo [...] è il superamento storico del
pluralismo liberale, non già il suo annientamento.» Durante il sequestro
Moro fu l'unico leader politico insieme ad Amintore Fanfani e Marco Pannella a
dichiararsi disponibile ad una trattativa, attirandosi addosso parecchie
critiche. In quello stesso anno, il 1978, si svolse a Torino il XLI congresso in
cui Craxi riuscì a farsi rieleggere segretario grazie al consolidamento del pur
innaturale "asse" con la sinistra lombardiana, rappresentata da Claudio
Signorile, malgrado la sua corrente dell'"Autonomia Socialista" fosse giunta a
questo punto in aperto contrasto con quella demartiniana, rappresentata da
Enrico Manca. Craxi si presentò agli Italiani in una maniera totalmente nuova:
da un lato prese esplicitamente le distanze dal leninismo rifacendosi a forme di
socialismo non autoritario, e dall'altro si mostrò attento ai movimenti della
società civile e alle battaglie per i diritti civili, sostenute dai radicali,
curava la propria immagine attraverso i mass media e mostrava di non disdegnare
la politica-spettacolo. Avviò una campagna per la "governabilità del governo",
assumendo toni sempre più decisionisti, con quella che nei giornali sarà
chiamata la "grinta" di Craxi; vi fu anche chi la presentò come l'unica forma di
alternativa fino a quando vi sarebbe stata una "democrazia bloccata" dalla
presenza del più grande partito comunista dell'Occidente. L'azione di
Craxi viene aspramente criticata dalla sinistra interna, ma trascina il partito
all'ottimo risultato raggiunto alle elezioni del 1983. In seguito a ciò, Craxi –
che nel 1979 aveva dovuto rinunciare ad un precedente incarico, conferitogli dal
presidente Pertini – chiede e ottiene la presidenza del Consiglio. È il primo
socialista che ci riesce. Il primo governo Craxi è sostenuto dal Pentapartito,
un'alleanza fra Dc, Psi, Psdi, Pri e Pli. Quest'alleanza nasceva non da accordi
pre-elettorali o da una comune identità di vedute, ma dall'opportunità,
fortemente sfruttata da Craxi, offerta dal capovolgimento delle alleanze tra le
correnti della Democrazia cristiana (la cui gestione interna s'era assestata
sulla linea del Preambolo di Donat Cattin, che aveva sostenuto la necessità di
"tenere i comunisti fuori dal governo"): è l'unica maggioranza, in pratica,
capace di potersi formare, senza coinvolgere in nessun modo il Pci. Nonostante
ciò, il suo governo fu uno dei più lunghi nella storia della Repubblica e riuscì
a lasciare una traccia profonda nella politica italiana. Il 5 agosto 1983,
appena un giorno dopo aver formato il suo primo governo, Craxi istituisce il
Consiglio di Gabinetto, dando seguito ad un impegno assunto con i partiti del
Pentapartito nel corso delle consultazioni: «Si tratta - disse allora Craxi - di
un Consiglio nel quale saranno rappresentate tutte le forze politiche; un
Consiglio politico, che dovrà consentire consultazioni più rapide su tutte le
questioni che saranno poi sottoposte al vaglio del Consiglio dei ministri, su
tutte le questioni di indirizzo importanti. Si tratta di un organismo autorevole
in cui saranno rappresentati anche i ministeri politici ed economici più
importanti». La prima riunione si svolge il 26 agosto e vi prendono parte, oltre
naturalmente a Craxi, Arnaldo Forlani, vicepresidente del Consiglio e Giulio
Andreotti, ministro degli Esteri, Giovanni Goria, ministro del Tesoro, Oscar
Luigi Scalfaro, ministro dell'Interno in rappresentanza della Dc, Giovanni
Spadolini, segretario del Pri e ministro della Difesa, Renato Altissimo ministro
dell'Industria del Pli, Gianni De Michelis, Psi e ministro del Lavoro e il
ministro del Bilancio del Psdi Pietro Longo. Fanno parte del Consiglio quindi i
rappresentanti di tutti e cinque i partiti dell'alleanza di governo. Il
Consiglio in seguito assunse un ruolo centrale e agì come sede di concertazione
delle principali decisioni politiche nel successivo triennio, contribuendo alla
fama di "governo forte" che assunse quell'Esecutivo. Presenziava alle riunioni
il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giuliano Amato (PSI). Furono
diversi i provvedimenti varati dal governo Craxi, fra i più importanti: il nuovo
concordato con la Santa Sede, detto Accordi di Villa Madama perché firmato nel
1984 a Villa Madama con il cardinale Agostino Casaroli Segretario di Stato
vaticano; il cattolicesimo abbandonava la nozione di "religione di Stato" e
veniva abolita la "congrua". Veniva istituito il contributo dell'8 per mille per
i finanziamenti alla Chiesa cattolica e alle altre religioni e l'insegnamento
facoltativo della religione cattolica nelle scuole. Il taglio di tre punti della
Scala mobile, a seguito del cosiddetto "decreto di San Valentino", ottenuto con
la concertazione della CISL e della UIL, ma contestato dal Pci e dalla CGIL.
Quest'ultima abbandonò le trattative e diede vita a massicce manifestazioni di
massa, con la collaborazione del Pci, che nel frattempo scatenò in Parlamento un
ostruzionismo durissimo. Il decreto passò con la fiducia e in seguito venne
avviata una raccolta di firme che portò ad un referendum abrogativo. Al
referendum, che si tenne nella primavera del 1985, Craxi partecipò attivamente
alla campagna elettorale a sostegno della sua riforma, riuscendo ad ottenere, a
sorpresa, la sconfitta degli abrogazionisti. Una politica economica di cui
rivendicò i successi, l'inflazione, dal 1983 al 1987, scese dal 12,30% al 5,20%,
e lo sviluppo dell'economia italiana vide sia una crescita dei salari (in
quattro anni, di quasi due punti al di sopra dell'inflazione) diventando il
quinto paese industriale avanzato del mondo. D'altro lato però, in quegli stessi
anni il debito pubblico passò da 234 a 522 miliardi di euro (dati valuta 2006) e
il rapporto fra debito pubblico e PIL passò dal 70% al 90%. Ciò ha fatto dire
che la sua gestione del bilancio - sul punto non correttiva degli squilibri
accumulatisi nei conti pubblici già nel decennio precedente - ha contribuito a
provocare allo Stato l'enorme debito pubblico, decisamente superiore alla media
europea; c'è chi invece distingue tra i suoi due governi nella IX legislatura ed
i governi a partecipazione del suo partito che gli succedettero nella X
legislatura. La battaglia agli evasori fiscali nel commercio al minuto, che
produsse l'obbligo del registratore di cassa e dello scontrino fiscale grazie ad
una battaglia condotta dal ministro delle finanze Bruno Visentini. Il condono
edilizio Nicolazzi del 1985: esso era inserito in una legge urbanistica, che non
fu mai realmente applicata, che aveva l'ambizione di voltare pagina rispetto al
passato ed introduceva un sistema di regole penali e una diretta attribuzione di
responsabilità alle amministrazioni comunali per la repressione degli abusi. Il
"decreto Berlusconi", varato dopo la decisione dei pretori di Torino, Roma e
Pescara di oscurare i canali televisivi della Fininvest di proprietà di Silvio
Berlusconi, allora un semplice imprenditore con cui Craxi aveva una forte
amicizia (fece da testimone al suo secondo matrimonio). Il decreto stabilì la
legalità delle trasmissioni delle televisioni dei grandi network privati, ma
suscitò aspre critiche da parte delle piccole emittenti private e di
costituzionalisti, e fu approvato dal Parlamento solo tramite il voto di
fiducia. Tra i progetti non realizzati di Craxi vi fu invece la mancata riforma
delle istituzioni. Come ricordò anni dopo il presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, "il discorso sulle riforme istituzionali che aveva rappresentato,
già prima dell'assunzione della Presidenza del Consiglio, l'elemento forse più
innovativo della riflessione e della strategia politica dell'on. Craxi (...) non
si tradusse in risultati effettivi di avvio di una revisione della Costituzione
repubblicana. La consapevolezza della necessità di una revisione apparve
condivisa (...) ma (...) non seguì alcuna iniziativa concreta, di sufficiente
respiro, in sede parlamentare. Si preparò piuttosto il terreno per provvedimenti
che avrebbero visto la luce più tardi, come la legge ordinatrice della
Presidenza del Consiglio e, su un diverso piano, significative misure di riforma
dei regolamenti parlamentari". Rimase quindi "un inutile abbaiare alla luna" -
come lo definì Craxi stesso con amarezza - il progetto di una "grande riforma"
costituzionale in senso presidenzialista, che desse maggiore efficienza in senso
decisionista ai poteri pubblici italiani; non si raggiunse mai in Parlamento la
maggioranza necessaria anche solo per affacciare l'ipotesi di approvazione di un
testo, sul quale peraltro vi erano forti oscillazioni nello stesso entourage
craxiano (vi era chi optava per il presidenzialismo all'americana e chi per
quello alla francese). Eppure, nel 1992, un'autorità in tema di scienza politica
come Norberto Bobbio osservò che, rispetto alle riforme costituzionali, "non si
poteva negare che Craxi fosse stato un precursore". Altro insuccesso fu la sua
proposta – sulla scorta di analoghe operazioni effettivamente realizzate negli
anni settanta in Grecia e, negli anni cinquanta nella Germania Ovest di Konrad
Adenauer – della "lira pesante", un progetto per la parità uno a mille della
valuta: si disse con la possibile coniazione di una moneta con l'effigie di
Garibaldi, ma l'operazione non ebbe alcun seguito. Con i potentati economici del
Nord il rapporto fu sempre alquanto dialettico: al congresso della CGIL del 1986
accusò gli industriali di voler "lucrare senza pagare", ricevendo dalla platea
sindacale un caloroso applauso e dando così l'impressione di un'efficacia
redistributiva maggiore di quella che – dopo la marcia dei quarantamila, che
aveva visto spuntarsi le armi del sindacalismo confederale – era promessa dal
massimalismo di sinistra facente capo al PCI. Di contro la Confindustria
evidenziò polemicamente che da un lato si chiedeva agli industriali un
contributo al benessere della collettività, ma a ciò non corrispondeva una buona
condotta della politica nella gestione del denaro pubblico. Infatti, dagli anni
settanta la spesa pubblica decollò e il sistema partitico non fece nulla per
porvi un freno. Assai più criticati, perché rientranti in una nozione di
ingerenza dello Stato nell'economia, furono gli interventi del governo Craxi per
la fine del mandato di Enrico Cuccia come presidente di Mediobanca (elusa dal
consiglio di amministrazione con la sua nomina a presidente onorario) e
l'opposizione alla vendita del complesso alimentare dell'IRI – la SME –
negoziata direttamente dal suo presidente Romano Prodi e smentita da una
direttiva del Governo. Nella politica estera, il governo Craxi e il personale
intervento del Presidente del Consiglio "si caratterizzarono per scelte
coraggiose volte a sollecitare e portare avanti il processo d'integrazione
europea, come apparve evidente nel semestre di presidenza italiana (1985) del
Consiglio Europeo". Si tratta di un indirizzo che proseguì anche nei successivi
governi a partecipazione socialista e che portò al deciso avallo del trattato di
Maastricht nel 1992. Craxi continuò anche la politica atlantista dei suoi
predecessori, ai quali aveva dato l'appoggio del suo partito per l'installazione
in Sicilia degli "euro-missili" posizionati contro l'URSS; secondo Zbigniew
Brzezinski, l'ex segretario di Stato di Carter, ”senza i missili Pershing e
Cruise in Europa la guerra fredda non sarebbe stata vinta; senza la decisione di
installarli in Italia, quei missili in Europa non ci sarebbero stati; senza il
PSI di Craxi la decisione dell'Italia non sarebbe stata presa. Il Partito
Socialista italiano è stato dunque un protagonista piccolo, ma assolutamente
determinante, in un momento decisivo”. Nel contempo, però, Craxi mantenne una
linea di attenzione ad alcune cause terzomondiste, come già lasciava prevedere -
prima del suo arrivo alla guida del Governo - il sostegno dato all'Argentina
nella Guerra delle Falkland, senza però interferire in alcun modo nel conflitto.
Stipulò accordi con i governi della Jugoslavia e della Turchia; sostenne anche
il dittatore della Somalia Muhammad Siad Barre, già segretario del Partito
Socialista Rivoluzionario Somalo. Fornì un appoggio convinto alla causa
palestinese e intrecciò relazioni diplomatiche con l'OLP e con il suo leader
Yasser Arafat, di cui divenne amico personale, sostenendone le iniziative.
Obiettivo dichiarato era quello di fare dell'Italia una potenza regionale
nell'area del Mar Mediterraneo e del Vicino Oriente. In quest'ambito, tre
episodi sono considerati quelli più significativi, e tutti e tre coinvolsero gli
Stati rivieraschi di fronte alle coste italiane: Egitto, Libia e Tunisia. La
cosiddetta "Crisi di Sigonella" rappresentò l'episodio più noto a livello
internazionale della politica estera craxiana. Il complesso caso diplomatico
avvenne appunto nella base NATO di Sigonella, in Sicilia, nell'ottobre 1985, e
rischiò di sfociare in uno scontro armato tra VAM (Vigilanza Aeronautica
Militare) e Carabinieri da una parte e gli uomini della Delta Force (reparto
speciale delle forze armate statunitensi) dall'altra, all'indomani di una
rottura politica - poi ricomposta - tra Craxi e il presidente degli Stati Uniti
Ronald Reagan, circa la sorte dei sequestratori della nave da crociera italiana
Achille Lauro, che avevano ucciso un passeggero disabile, statunitense ed ebreo.
Craxi riteneva che i terroristi andassero processati sotto la giurisdizione
italiana, e così avvenne, anche se il loro capo riuscì a sfuggire alla cattura e
si rifugiò in Iraq.
All'epoca del bombardamento statunitense contro Tripoli, avvenuto il 14 aprile
1986, il ruolo di Craxi fu reputato eccessivamente prudente e fu per questo
criticato dalla stampa nazionale per non aver reagito alla rappresaglia libica
(il lancio di missili su Lampedusa, avvenuto il giorno successivo al raid
statunitense). Oltre venti anni dopo è emersa una diversa descrizione dei fatti
secondo cui Craxi avvertì preventivamente Gheddafi dell'imminente attacco
statunitense su Tripoli, consentendogli in tal modo di salvarsi. Si tratta di
una ricostruzione conforme con le note posizioni del governo italiano, che
considerava la ritorsione statunitense, scaturita dalla politica di appoggio al
terrorismo della Libia, come un atto improprio, che non doveva coinvolgere come
base di partenza dell'attacco il suolo italiano. Tale versione è coerente anche
con alcune ricostruzioni dei missili su Lampedusa, segnatamente quella secondo
cui i missili sarebbero stati un espediente per coprire "l'amico italiano" agli
occhi degli statunitensi: lo dimostrerebbe la scarsa capacità offensiva di
penetrazione dei missili, che per altro sarebbero caduti in mare senza cagionare
alcun danno. Tale tesi, nel contempo, però, non spiega come facesse Craxi a
conoscere l'attacco due giorni prima, visto che esso fu condotto da navi della
VI flotta alla fonda nel golfo della Sirte e che ostentatamente all'epoca si
disse che il governo italiano - così come tutti gli altri governi della NATO con
l'eccezione di quello Regno Unito - non era stato coinvolto nella sua
preparazione. Sul punto, però, è giunta recentemente una testimonianza diretta
del consigliere diplomatico di Craxi a palazzo Chigi, l'ambasciatore Antonio
Badini, secondo cui Reagan inviò Vernon Walters ad informare il governo italiano
dell'imminente attacco a Gheddafi e Craxi, non essendo riuscito a convincere gli
statunitensi a desistere, decise di salvare la vita al leader libico per evitare
un'esplosione di instabilità in un Paese islamico di fronte all'Italia. Nel
novembre 1987 la senescenza fisica e mentale del "padre della patria" tunisino,
Habib Bourguiba, indusse la diplomazia francese a cercare di "teleguidare" un
proprio candidato alla successione: ma ventiquattr'ore prima della loro mossa,
la successione di Bourghiba avvenne con un colpo di Stato incruento di Zine
El-Abidine Ben Ali, che prese il potere mantenendolo per oltre 23 anni (fino al
gennaio 2011), al quale immediatamente Craxi offrì il necessario sostegno
internazionale. Dieci anni dopo, le memorie dell'ammiraglio Fulvio Martini,
allora capo del Sismi, rivelarono che non solo si era avuto il prematuro (e
concordato) riconoscimento internazionale italiano del nuovo governo tunisino,
ma addirittura la scelta del nuovo Presidente "bruciando sul tempo" il candidato
di Parigi. Una nuova crisi esplose nel 1986. Il segretario della Democrazia
Cristiana, Ciriaco De Mita, ottenne che il secondo incarico conferito dal nuovo
Capo dello Stato Francesco Cossiga a Craxi fosse vincolato ad un informale
"patto della staffetta", che avrebbe visto un democristiano alternarsi alla
guida del governo dopo un anno, per condurre al termine la legislatura. Dopo
aver taciuto per mesi intorno a questo patto, avallandone implicitamente
l'esistenza, Craxi sconfessò l'accordo in un'intervista a Giovanni Minoli nella
trasmissione Mixer del 17 febbraio del 1987. La sfida così pubblicamente
lanciata ricompattò la DC e fu raccolta da De Mita, che fece nuovamente cadere
il governo e, con un governo Fanfani, portò il Paese alle urne; con un gesto di
sfida, Craxi dichiarò che non gli interessava guidare il governo durante il
periodo elettorale, perché "non stiamo in America latina, dove è il prefetto che
decide l'esito delle elezioni in una provincia". L'esito elettorale – che non
portò molto avanti l'"onda lunga" del consenso del PSI, da lui ripetutamente
vaticinata – si incaricò di smentire quest'assunto. La fine del governo Craxi
portò ad attestazioni di stima e di rammarico per la sua caduta da parte di
diversi giornali stranieri, come Le Monde, Wall Street Journal,
Financial Times. Dal 1987 in poi, la DC non fu più disponibile a dare la
fiducia a Craxi, preferendo sostenere come presidente del Consiglio prima
Giovanni Goria e poi Ciriaco De Mita. Fu solo uno degli episodi degli scontri
fra De Mita e Craxi, spiegabile forse nel fatto che il leader democristiano era
anche il punto di riferimento della sinistra Dc, quella cioè più vicina al Pci.
Anche alla luce di questo orientamento, Craxi resse il gioco a Forlani ed
Andreotti nella progressiva sottrazione a De Mita della segreteria DC e poi
della Presidenza del Consiglio. Rimase agli atti, di quella stagione di
decisionismo senza Craxi presidente, l'approvazione della modifica dei
Regolamenti parlamentari che abolì il voto segreto nell'approvazione delle leggi
di spesa; invano richiesta da Craxi per anni da Presidente del Consiglio, fu
conseguita grazie alla sua politique d'abord, di attacco al governo De
Mita. In questi anni Craxi ottenne importanti ruoli alle Nazioni Unite: fu
rappresentante del segretario generale dell'ONU Peréz de Cuéllar per i problemi
dell'indebitamento dei Paesi in via di sviluppo (1989); successivamente svolse
l'incarico di consigliere speciale per i problemi dello sviluppo e del
consolidamento della pace e della sicurezza (rinnovatogli nel marzo 1992 da
Boutros Ghali). Il ritorno al governo della Democrazia cristiana fu accompagnato
da un'accentuata conflittualità, all'interno dell'alleanza col PSI: Craxi
inaugurò una tecnica di "movimentismo" (corredata di frequenti minacce di crisi
di governo, che rientravano dopo aver ottenuto dal partner di governo le
concessioni richieste), che fu definita "rendita di posizione". Conseguenze
furono importanti battaglie condotte - al di fuori del vincolo di maggioranza -
a fianco di alleati occasionali: quella sulla responsabilità civile dei giudici
a fianco di Pannella, quella sulla chiusura delle centrali nucleari a fianco dei
Verdi, ambedue coronate dal successo referendario; quella sull'ora di religione
e quella sulla penalizzazione del consumo di droghe a fianco dell'ala
conservatrice dello schieramento politico. Ma la sensazione che se ne trasse fu
di un'estrema disinvoltura tattica, lontana dalla rimozione delle cause del
dissesto del Paese e finalizzata solo ad acquisire vantaggi elettorali. La
traduzione di questi vantaggi in cariche pubbliche - secondo un metodo di
spartizione assai accurato e, quel che è peggio, generalizzato a tutti i livelli
della vita politica, sia nazionale che locale, con capovolgimenti di alleanze
locali in base ad esigenze nazionali - era foriera, invece, di
un'estremizzazione dei vizi partitici già intrinseci al sistema politico
italiano. Uno degli assunti più reiterati della retorica craxiana - la facile
polemica sull'assemblearismo ed il consociazionismo, che aveva "favorito nel
nostro paese rendite di posizione (...) di coloro che hanno amministrato senza
doverne dare troppo conto all'opposizione, che assai spesso è pervenuta ad
accordi con la maggioranza", ritardando o impedendo la modernizzazione del Paese
- veniva quindi controbilanciato da un fenomeno gravido di conseguenze proprio
sul piano dell'efficienza del sistema: "la formazione della volontà politica non
avviene più attraverso un processo pubblicistico e collegiale, quanto piuttosto
attraverso un processo privatistico e contrattuale". Persino un momento di
trasparenza della vita politica come l'abolizione del voto segreto
nell'approvazione delle leggi di spesa - per il quale Craxi insistette fino ad
ottenere, nel novembre 1988, l'apposita revisione dei regolamenti parlamentari -
fu guardato con sospetto, dall'opinione pubblica: sin da allora ci si chiese se
"l'estensione del voto palese andrà nel senso di rafforzare l'elemento
pubblicistico e collegiale, oppure se la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica saranno chiamati semplicemente a ratificare accordi raggiunti
nell'ambito delle coalizioni governative". A partire dalla vittoria elettorale
del 1983, con la crescita di consenso per il PSI, si estinse all'interno del
partito socialista l'opposizione a Craxi, tanto che nei successivi congressi, fu
sempre rieletto con voti plebiscitari; l'unica corrente ufficialmente non
craxiana rimase quella di Michele Achilli, con meno del 2% degli iscritti. A
porsi contro Craxi rimasero alcuni esponenti, anche prestigiosi, che condussero
solitarie battaglie. Uno su tutti Giacomo Mancini, che esclamò in un congresso
"Questo non è più il partito socialista italiano; è il partito craxista
italiano". Anche fra i sostenitori di Craxi vi era coscienza della grande
autorità che aveva il segretario nel partito, senza precedenti nella storia del
socialismo italiano. All'inizio degli anni ottanta, Craxi – che già nel 1979
aveva avviato una revisione ideologica, inneggiando al socialismo umanitario di
Proudhon in luogo di quello scientifico di Marx – proseguì ed incoraggiò una
revisione anche estetica del partito. Ad esempio, vennero cancellati dal
programma politico alcuni termini che potevano ricondurre al marxismo; venne
eliminato il termine autonomismo che venne sostituito con la parola riformismo,
giudicata più inerente dalla corrente moderata e riformista. Venne inoltre
abolito il termine "Comitato Centrale" (perché esso riconduceva immediatamente
ai partiti comunisti), sostituito dal più neutro "Assemblea Nazionale", nella
quale entrarono a far parte oltre ai politici anche uomini dello spettacolo,
della moda, dello sport e della cultura. Alcuni eccessi di spettacolarizzazione
(celebri le scenografie congressuali ideate dall'architetto Filippo Panseca)
furono criticati dai suoi stessi compagni di partito: Rino Formica coniò, per
l'Assemblea Nazionale del 1991, l'eloquente immagine di una "corte di nani e
ballerine". Si rinunciò al tradizionale anticlericalismo socialista (con
l'approvazione del Concordato) e fu infine ridotta e poi eliminata (dal 1985) la
falce e martello dal simbolo storico del PSI, sostituendola col garofano rosso,
che da allora divenne emblema del partito. Soprattutto dopo il 1989, (quando
cadde il muro di Berlino), ritenendo ormai prossima la crisi del PCI, nelle
intenzioni di Craxi entrò anche il lancio di un progetto annessionistico a
sinistra, con la parola d'ordine dell'"unità socialista", scritta che fu
aggiunta al simbolo del partito. Il rapporto assai travagliato con il PCI risale
agli anni della guerra fredda, quando citando Guy Mollet Craxi aveva sostenuto
che "I comunisti non sono a sinistra, sono a est": ma furono "i comunisti della
seconda generazione, quella dopo Togliatti e Longo" quelli che "non apprezzano
la sua posizione e gliela fanno pagare cara, avvalendosi anche dell'implacabile
collaborazione del direttore di Repubblica, che pure nei lontani anni sessanta
era stato fraternamente appoggiato da Craxi, con Lino Jannuzzi, nella campagna
elettorale". L'impulso ad una trasformazione del grande partito della sinistra
italiana in senso occidentale era impresso da Craxi con una metodica scevra
dalle sudditanze politiche dei suoi predecessori, giovandosi della posizione di
potere acquisita con i lunghi anni di governo con la DC, tanto che essa è
descritta da Claudio Petruccioli come una disperante sindrome da "riserva
indiana" in cui il PSI costringeva in un ghetto politico il PCI ponendosi
"all'imboccatura della valle" della politica di governo ed esigendo un pedaggio
democratico che non gli venne mai concesso. Quando però il PCI guidato da
Achille Occhetto si stava per trasformare nel PDS, per costituire un'unica forza
politica ispirata al riformismo socialdemocratico, la sua strategia non seppe
adeguarsi altro che con la volontà di unificare PSI, PSDI e il nuovo partito, in
una logica visibilmente annessionistica che fu particolarmente criticata dai
riformisti del PCI (cosiddetta corrente "migliorista"), i quali videro nel
mancato tentativo di arruolare Gianfranco Borghini nel PSI un'aggressione da
rintuzzare con decisione (alla fine fu solo suo fratello, Giampiero Borghini, a
passare dall'altra parte). Craxi fu anche favorevole all'entrata del neonato
Partito Democratico della Sinistra nell'Internazionale Socialista (di cui lo
stesso leader socialista fu vicepresidente fino al 1994, quando fu sostituito
proprio dal segretario della "Quercia" Achille Occhetto). Il progetto di alcune
limitatissime liste comuni, sperimentato nelle elezioni amministrative del 1992
(dove non riscosse molto successo), naufragò definitivamente in seguito alle
inchieste di Tangentopoli.
Nel 1989, Craxi torna alla carica contro la maggioranza della Democrazia
cristiana espressione della sinistra interna: è deciso a ritornare a Palazzo
Chigi, ma per farlo deve scalzare De Mita dalla guida del governo e del partito.
Forma perciò con i democristiani Giulio Andreotti e Arnaldo Forlani un'alleanza
di ferro: il C.A.F. (dalle iniziali dei cognomi dei tre protagonisti), che fu
definita la "vera regina d'Italia". Nel LXII congresso del PSI, Craxi, dopo
essere stato rieletto segretario con una maggioranza schiacciante, fa approvare
una mozione che - anche per le modalità con cui viene illustrata dal fidatissimo
vicesegretario Claudio Martelli, allora considerato il suo delfino in pectore -
suona come esplicita sfiducia al governo De Mita. De Mita rassegna le dimissioni
da Presidente del Consiglio, dopo che aveva perso già la segreteria
democristiana che era andata nelle mani di Arnaldo Forlani, alleato di
Andreotti. Quest'ultimo assume la guida di due governi che reggono fino al 1992.
Sono anni "di assoluto immobilismo": il governo sembra incapace di prendere
decisioni concrete; nel Paese si diffonde un forte malcontento, accentuato dai
sospetti emersi con lo scandalo Gladio. Craxi confida apertamente in un
logoramento democristiano e spera nella possibilità di portare il partito
socialista al centro della scena politica, assumendo quel ruolo-guida, che fino
a quel momento apparteneva alla Dc. Si mostra fiducioso di sé, anche quando il
referendum sulla preferenza unica, promosso da Mario Segni – al quale Craxi si
era opposto invitando gli italiani ad "andarsene al mare" – raccoglie invece un
larghissimo consenso. Il progetto di Craxi, coltivato a lungo, non si sarebbe
però mai realizzato: secondo Giuliano Amato, dopo il crollo del muro di Berlino
si finì per contare "più sulla definitiva disfatta dell'ex Pci che non sulla
prospettiva di assumere noi la guida della sinistra. Sbagliammo: invece di
attendere che il cadavere del Pds passasse sul fiume, avremmo dovuto invocare
noi le ragioni della convergenza". Nella stessa circostanza Amato affermò che
"forse ebbe un peso anche la sua malattia, molto seria, alla quale teneva testa
solo grazie alla sua fibra veramente robusta, perché nei fatti non si curava,
era sregolatissimo. Mi venne detto da medici esperti che l'incedere del diabete
determina anche incertezze nuove nel carattere delle persone che ne soffrono.
Può essere dunque che il suo ritrarsi da una decisione rischiosa fosse anche la
conseguenza di un cattivo stato di salute"; in effetti, all'agosto 1990 risale
il primo ricovero di Craxi al San Raffaele di Milano per le complicazioni
derivate dal diabete mellito che l'avrebbe portato alla morte dieci anni dopo.
Un'altra chiave di lettura è invece quella secondo cui "per un cattivo governo
il momento più pericoloso è sempre quello in cui comincia a riformarsi", secondo
la "legge" enunciata da Alexis de Tocqueville e di cui in quegli stessi anni
sperimentarono la fondatezza altre "democrazie bloccate" come il Giappone
monopolizzato dal partito liberaldemocratico. La recessione economica, la crisi
politica della Prima Repubblica, l'aumento del già abnorme debito pubblico e
l'affermazione delle liste regionali (in particolare la Lega Lombarda) causarono
il crollo del sistema politico di cui egli fu grande protagonista; inoltre, le
inchieste giudiziarie avviate nei suoi confronti causarono la sua caduta,
stavolta definitiva. L'epicentro del potere socialista e craxiano era Milano,
centro nevralgico della finanza e degli affari, con il cui ambiente il PSI finì
per identificarsi. Nel dicembre del 1986 si avvicenda alla guida del comune
Paolo Pillitteri, cognato di Craxi, sostituendo Carlo Tognoli, con una giunta
pentapartito. Il 17 febbraio 1992, l'ingegnere Mario Chiesa, esponente del PSI,
già assessore del comune di Milano con l'ambizione alla poltrona di sindaco,
viene arrestato in flagrante per aver intascato una tangente da una ditta di
pulizie. Craxi al TG3 del 3 marzo, a un mese dalle elezioni politiche,
commenterà sostenendo che «una delle vittime di questa storia sono proprio io...
Mi trovo davanti a un mariuolo che getta un'ombra su tutta l'immagine di un
partito che a Milano, in 50 anni, non ha mai avuto un amministratore condannato
per reati gravi contro la pubblica amministrazione». Il 23 marzo Chiesa inizia a
confessare svelando ai pubblici ministeri dell'inchiesta Mani Pulite il
complesso sistema di tangenti che coinvolgono i dirigenti milanesi del PSI.
Craxi, fiducioso che il crollo della DC sia imminente, organizza una massiccia
campagna elettorale, puntando alla presidenza del Consiglio. Il 6 aprile
l'intero Quadripartito del governo Andreotti VII esce dalle urne con un
clamoroso 48,8%. Il PSI, dal canto suo, passa dal 14,3 al 13,5%, ma a Milano c'è
già un crollo di oltre 5 punti (dal 18,6 al 13,2%). «Un piccolo calo» commenta
Craxi «rispetto alla crisi dei partiti di governo». In virtù di questo, Craxi
chiede la guida del nuovo governo, per poter portare «l'Italia fuori dal caos».
Ma il nuovo Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro rifiuta di
concedere incarichi ai politici vicini agli inquisiti. Craxi è costretto a farsi
da parte; al suo posto viene nominato il socialista Giuliano Amato. Dal maggio
1992 Mani Pulite era però ormai una questione nazionale, tanto da
spingere Craxi il 3 luglio 1992 alla Camera, durante il discorso di fiducia al
governo Amato I, a chiamare in correità tutto il Parlamento dichiarando
«spergiuro» chi avesse negato di aver fatto ricorso al finanziamento illecito
dei partiti. Il giuramento cui sfidò tutto il Parlamento non fu raccolto da
nessuno, ma fu per anni sentito come un silenzio ipocrita. Secondo Gerardo
D'Ambrosio il discorso craxiano fu «onesto», mentre il silenzio altrui era
dovuto al fatto che «in quel periodo gli altri partiti speravano di farla
franca, anziché affrontare il problema lasciarono Craxi solo». Per Piero
Ostellino il discorso conteneva anche un appello "all’etica della
responsabilità", un appello che "non è stato colto, per opportunismo e per
viltà, ieri; non è colto, per conformismo e per incultura, oggi". Secondo Piero
Fassino, in quell'occasione «non c’è dubbio che ci fu un silenzio assolutamente
reticente e ambiguo da parte di tutta la classe politica davanti al discorso che
Craxi fece alla Camera e nel quale disse con parole crude che il problema del
finanziamento illegale non riguardava soltanto il PSI ma l’intero sistema
politico». In un corsivo sull'Avanti! – firmato con il consueto pseudonimo
"Ghino di Tacco" – attaccò gli inquirenti e Di Pietro: "non è tutto oro, quello
che luccica". Questo attacco, cui fece seguito il giudizio riferito da Rino
Formica circa il "poker d'assi" che Craxi aveva mostrato in una direzione del
suo partito sul conto di Di Pietro, non riuscì ad emanciparsi dall'impressione
che Craxi difendesse se stesso non con i fatti, ma con vaghe teorie
"complottistiche", volte a chiamare a raccolta sostenitori politici che non
vennero mai allo scoperto. L'impotenza politica di Craxi si accentuò quando la
situazione processuale precipitò a causa della sua chiamata in correità da parte
della magistratura milanese, fino a quel momento solo adombrata: il 15 dicembre
1992 Craxi ricevette il primo degli avvisi di garanzia della Procura di Milano.
Il sentimento anticraxiano esplose nel Paese: "fu un autentico contagio di
massa, un meccanismo accusatorio" nel quale "non passava giorno senza che Craxi
incontrasse per strada giovinastri che gli gridavano «Ladro!» mostrandogli i
polsi incrociati. Nacque una specie di ritualità” nella pubblica riprovazione,
tanto che un giorno "il sosia televisivo Pier Luigi Zerbinati si nascose in
un'auto per paura di essere scambiato per Craxi". Il 23 marzo 1993 gli avvisi di
garanzia - tutti per episodi circostanziati di corruzione e finanziamento
illecito di partito - erano diventati 11, ma già l'11 febbraio 1993 Craxi si era
visto costretto a dimettersi dalla segreteria del PSI. Anche gli altri due
componenti del cosiddetto CAF, Forlani e Andreotti, verranno raggiunti in quel
periodo da informazioni di garanzia, l'uno nell'ambito del processo per tangenti
negli appalti Eni-Snam-Autostrade e l'altro addirittura per supposta collusione
con la mafia. Sia Forlani che Andreotti, peraltro, verranno completamente
assolti e scagionati da ogni accusa. Il nuovo governo ebbe vita tormentata fin
dagli inizi. Poco dopo l'avviso a Craxi una "pioggia di avvisi di garanzia"
cadde sulle teste dei principali leader politici nazionali. Il PSI venne
travolto dalle inchieste; la sua dirigenza fu letteralmente decimata e perse la
guida del governo dopo la mancata firma del presidente Scalfaro al decreto Conso
che mirava ad una "soluzione politica" depenalizzando il finanziamento illecito
ai partiti. Craxi stesso ricevette una ventina d'avvisi di garanzia e dopo aver
accusato la Procura di Milano di muoversi dietro "un preciso disegno politico",
si presentò alla Camera il 29 aprile del 1993 e in un famoso discorso tuonò:
"Basta con l'ipocrisia!"; tutti i partiti –secondo Craxi– si servivano delle
tangenti per autofinanziarsi, anche quelli "che qui dentro fanno i moralisti".
La sua linea di difesa fu incentrata sulla tesi secondo cui i finanziamenti
illeciti sarebbero stati necessari alla vita politica dei partiti e delle loro
organizzazioni per il mantenimento delle strutture e per la realizzazione delle
varie iniziative; il suo partito non si sarebbe discostato da questo generale
comportamento e, quindi, più che dichiarare sé stesso innocente, Craxi giungeva
a sostenere che egli era colpevole né più né meno di tutti gli altri. In altre
parole, egli si dichiarò colpevole, anche davanti ai giudici, solo di
finanziamento illecito al PSI, ma negò sempre ogni accusa di corruzione per
arricchimento personale. Il 29 aprile 1993, la Camera dei deputati negò
l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti provocando l'ira dell'opinione
pubblica e facendo gridare allo scandalo numerosi quotidiani. Nella stessa aula,
seguirono momenti di tensione, con i deputati della Lega e dell'MSI che
gridavano "ladri" ai colleghi che avevano votato a favore di Craxi, secondo una
tecnica di utilizzo politico definita "la mossa del cavallo". Alcuni ministri
del governo Ciampi si dimisero in segno di protesta. Il 30 aprile in tutt'Italia
si svolsero manifestazioni di dissenso: a Roma circa 200 giovani dell'istituto
Einstein sostarono in piazza Colonna scandendo slogan contro governo e
Parlamento; un altro centinaio protestarono davanti alla sede del PSI in via del
Corso; un terzo gruppo, proveniente dal liceo Mamiani, percorse in corteo il
centro storico soffermandosi anch'esso davanti alla sede del PSI venendo però
disperso dalle forze dell'ordine. Ci furono anche una manifestazione del
Movimento Sociale Italiano nella galleria Colonna - seguita da un incontro
stampa del segretario Gianfranco Fini per sottolineare l'impossibilità di tenere
in vita questo parlamento - e un'altra dimostrazione, tenuta in serata per
iniziativa del PDS, la cui riunione di segreteria era stata per l'occasione
sospesa. Diverse migliaia di persone si radunarono in piazza Navona per
ascoltare i discorsi del segretario del PDS Occhetto, di Francesco Rutelli e di
Giuseppe Ayala: tutti loro avevano incitato i presenti a protestare contro il
voto parlamentare a favore dell'ex Presidente del Consiglio. Un piccolo corteo,
organizzato dalla Lega Nord, sfilò infine da piazza Colonna al Pantheon. In
coincidenza con la fine del comizio tenutosi a Piazza Navona, una folla invase
Largo Febo e attese Craxi all'uscita dell'hotel Raphael, l'albergo che da anni
era la sua dimora romana. Quando Craxi uscì dall'albergo, i manifestanti lo
bersagliarono con lanci di oggetti, insulti e soprattutto monetine e cantilene
irridenti. Con l'aiuto della polizia, Craxi riuscì a salire sull'auto e poi
lasciò l'hotel. Quest'episodio, ritrasmesso centinaia di volte dai telegiornali,
viene preso come simbolo della fine politica di Craxi. Egli stesso definì quanto
aveva subito "una forma di rogo" in un'intervista a Giuliano Ferrara trasmessa
su Canale 5.
Nel corso del 1993 ed a seguito della sua testimonianza al processo Cusani
emersero sempre più prove contro Craxi: con la fine della legislatura e
l'abolizione dell'autorizzazione a procedere, si fece sempre più vicina la
prospettiva di un suo arresto. Il 15 aprile 1994, con l'inizio della nuova
legislatura in cui non era stato ricandidato, cessò il mandato parlamentare
elettivo che aveva ricoperto per un quarto di secolo e, di conseguenza, venne
meno l'immunità dall'arresto. Il 12 maggio 1994 gli venne ritirato il passaporto
per pericolo di fuga, ma era già troppo tardi perché Craxi, si seppe solo il 18,
era già in Tunisia ad Hammamet, protetto dall'amico Ben Alì; già il 4 maggio era
stato avvistato a Parigi, dato che inizialmente era intenzionato a chiedere
asilo politico alla Francia. Il 21 luglio 1995 Craxi sarà dichiarato
ufficialmente latitante. Ci fu anche chi disse già dal 1993, cosa subito
smentita, che Craxi volesse candidarsi al parlamento europeo nelle file del
Partito Socialista francese. La fuga all'estero del leader socialista fu
percepita dall'opinione pubblica come un tentativo di sottrarsi all'esecuzione
delle condanne penali inflittegli. Dalla latitanza in Tunisia, con fax e lettere
aperte, Craxi continuò a commentare le vicende della politica italiana,
perseverando nelle accuse rivolte al PDS e ai giudici di Mani Pulite, e
nell'affermazione di aver ricevuto finanziamenti illeciti, ma non a fini di
corruzione. Si soffermò anche su alcuni suoi ex sodali, come Giuliano Amato, da
lui dipinto come il becchino, in alcuni dei quadri, della cui pittura si dilettò
nella parte finale della sua vita. Dall'estero, assistette alla fine del PSI,
con la divisione dei suoi maggiori esponenti, confluiti in parte nel Polo delle
Libertà, in parte nell'Ulivo, in genere non approvandone spesso le scelte
politiche. Craxi, secondo quanto dichiarato dai figli, nutriva inoltre la
convinzione che i giudici di Mani Pulite fossero stati manipolati da parte di ex
comunisti e spinti anche da settori del governo degli Stati Uniti, che volevano
un "cambio di regime politico" dopo la crisi di Sigonella, poiché, anche se non
antiamericano, Craxi era considerato troppo "indipendente", e approfittarono del
finanziamento illecito ai partiti. Craxi ipotizzò anche un intervento della CIA,
volto a guidare l'azione del pool di Milano. Affetto da cardiopatia, gotta e da
molti anni malato di diabete, colpito poi da un tumore a un rene, Craxi morì il
19 gennaio del 2000 per un arresto cardiaco. L'allora presidente del Consiglio e
leader dei Democratici di Sinistra Massimo D'Alema propose le esequie di Stato,
ma la sua proposta non fu accettata né dai detrattori né dalla famiglia stessa
di Craxi, che accusò l'allora governo di avere impedito al leader socialista di
rientrare in Italia per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico presso
l'ospedale San Raffaele di Milano (operazione effettuata invece a
Tunisi). I funerali di Craxi ebbero luogo alla cattedrale di Tunisi e videro una
larga partecipazione della popolazione autoctona. Ex militanti del PSI e altri
italiani giunsero in Tunisia per rendere l'ultimo saluto al loro leader. Le
precedenti vicende dell'epoca Mani Pulite, ancora vicine, non erano dimenticate
dalla folla di socialisti giunta fuori la cattedrale della città tunisina e la
delegazione del governo D'Alema, formata da Lamberto Dini e Marco Minniti, venne
bersagliata da insulti e da un lancio di monete che voleva rappresentare la
simbolica restituzione di quanto ricevuto con l'episodio all'Hotel Raphael. La
sua tomba, nel piccolo cimitero cristiano di Hammamet, è orientata in direzione
dell'Italia.
Il termine "craxismo" e "craxiano" vennero usati per definire, in senso prima
dispregiativo, poi storico-politico, la stagione politica di Craxi, ma non
furono mai usati dal leader socialista. Egli stesso definiva la sua azione come
ispirata al socialismo riformista classico e autonomista, ma ebbe gli elogi, per
il patriottismo che si richiamava a Giuseppe Garibaldi, di parti politiche
opposte alla sua: il giornalista e storico di destra Giano Accame definì quello
di Craxi un "socialismo tricolore", ossia un socialismo nazionale, ma di stampo
democratico e di sinistra. Nella storiografia più recente è stato evidenziato
"il nesso che Craxi riuscì a stabilire tra la modernizzazione in atto nella
società italiana e la necessità di operare una modernizzazione sia nei partiti
sia nelle istituzioni. Questa modernizzazione egli la interpretò, sembra
giustamente, nel senso di un rafforzamento della leadership sia all'interno dei
partiti sia nell'apparato decisionale con una stabilizzazione ed un
consolidamento del ruolo del capo del governo. Al primo aspetto si legò lo
sforzo di plasmare la struttura socialista in senso «leggero» e progressivamente
deideologizzato: un partito agile adatto ad una «guerra per bande», come lo
avrebbe definito nel 1987 Gaetano Arfé. Al secondo appartenne una prassi di
governo che accentuò molto il ruolo personale e certi elementi di decisionismo
appartenuti alla personalità del leader socialista". Il lato negativo del
craxismo è che indubbiamente, più di quanto già facevano i partiti concorrenti,
accentuò la necessità di procurare risorse al partito per procurare consensi
tramite convegni, manifestazioni, ecc. in cui tutte le spese erano a carico del
partito; ma ancor più grave fu la deliberata politica di espansione del deficit
pubblico per aumentare il benessere immediato dei cittadini, senza tagliare
nessuno spreco, lasciando così il conto da pagare alle generazioni future. Sul
mutamento introdotto da Craxi nella politica e nella società italiana, vi è chi
ha sottolineato come, al di là delle estremizzazioni mediatiche, il craxismo
abbia "lanciato" una generazione di giovani di cui, ancora a vent'anni di
distanza e dagli opposti fronti degli schieramenti parlamentari, le istituzioni
e la gestione della cosa pubblica ancora si avvalgono. Ma il quesito
storiografico è se questa spinta modernizzatrice abbia avuto anche un valore in
sé, oltre all'emersione di una nuova generazione di politici e di
amministratori. Secondo alcuni gli anni di Craxi “sono il frutto di quell'idea
di moderno in cui l'individualismo senza princìpi si sostituisce alle
solidarietà tradizionali in crisi”, di cui quel governo seppe solo accelerare la
“destrutturazione” senza sostituirvi nuovi valori. Secondo altri, invece, “Craxi
interpreta le domande di dinamicità di una società che cambia e chiede alla
politica di stare al passo”, a differenza di chi vedeva “nei cambiamenti
un'insidia, anziché un'opportunità”; la teoria - elaborata da Craxi insieme con
Claudio Martelli - dei «meriti e bisogni», "che fu contrapposta
all'egualitarismo delle culture politiche allora vigenti, ha fatto da apripista
a quella meritocrazia della quale - almeno a parole - oggi nessuno riesce a
prescindere". Gennaro Acquaviva, in particolare, gli riconosce «la dote, che fu
particolarmente sua, di saper prendere decisioni politiche serie e rischiose con
freddezza e al momento giusto, costruendosi contemporaneamente condizioni e
forza sufficienti a fargli convogliare sulla decisione un consenso ampio e
solido, in grado di portarlo alla realizzazione della decisione stessa». Certo è
che dagli anni ottanta parole d'ordine come "governabilità" e "decisionismo" -
dopo la deriva degli anni settanta, in cui ogni forma di autorità era osteggiata
come potenziale fonte di autoritarismo - sono state successivamente invocate da
destra e da sinistra per proporre un approccio modernistico all'organizzazione
del sistema-Paese. Vi è stato però chi ha sottovalutato l'apporto ideale di tale
approccio, rilevando che esso andava incontro ad una pulsione già presente nella
politica italiana negli anni cinquanta ed all'epoca soddisfatta
dall'interventismo in economia del primo Fanfani e dalle ricette solidaristiche
e stataliste dei morotei; Craxi avrebbe soltanto "aggiornato" le soluzioni
offerte dalla politica degli anni ottanta, sposando un moderato liberismo
economico più in voga nell'epoca di Reagan e Thatcher. Da ciò la spiegazione
della competizione senza quartiere che si scatenò tra PSI craxiano e sinistra DC
per oltre un decennio, vista come deleteria dalla parte più tradizionalista del
Paese che vi leggeva il pericolo di un riformismo foriero di un tracollo delle
strutture-partito su cui si fondava la democrazia italiana del dopoguerra. Come
arma di tattica politica, volta a spezzare il connubio tra democristiani di
sinistra e partito comunista che negli anni settanta aveva compresso lo spazio
di manovra del PSI, abbandonò la delimitazione dei rapporti politici all'"arco
costituzionale": ricevette Almirante nelle consultazioni di governo e consentì
all'elezione di un deputato del partito di destra ad un organo parlamentare di
garanzia. Vi è stato chi, vent'anni dopo, ha ritenuto di leggere da tutto ciò
un'apertura politica alla destra, anticipando lo "sdoganamento" di Fini da parte
di Berlusconi nel "discorso di Casalecchio" del 1993. Eppure, una testimonianza
circa il ruolo consulenziale che avrebbe svolto Craxi nel 1993 nei confronti
dell'ingresso in politica di Silvio Berlusconi, esclude che nel suo disegno
fosse coinvolta la destra post-fascista. Quali che fossero destinati ad essere i
suoi orientamenti tattici dopo la rovinosa caduta degli anni novanta, la sua
formazione personale e politica restava strategicamente di sinistra: per tutti
gli anni ottanta l'attenzione per il progresso sociale e le conquiste sociali
della sinistra non fu da lui abbandonata, se è vero che, ancora vent'anni dopo,
Massimo D'Alema indicava in Craxi uno dei due soli leader (l'altro è lui stesso)
di partiti di sinistra che abbiano assunto la carica di capo del Governo nei 148
anni dall'Unità d'Italia; analoga posizione, nel tempo, hanno assunto Piero
Fassino e Nichi Vendola, secondo il quale “non si può ridurre la vita politica
di Craxi alla cifra di una vicenda giudiziaria (...) penso che Craxi abbia
interpretato un’idea della modernizzazione dell’Italia che in qualche maniera
era dentro il tempo in cui cominciava ad aprirsi la stagione della
globalizzazione liberista (...) secondo la tradizione dell’umanesimo socialista
(...) Da questo punto di vista ci sono, nella vicenda di Craxi, semi buoni che
devono ancora germogliare".
Le sentenze di condanna. Craxi è stato
condannato con sentenza passata in giudicato a:
5 anni e 6 mesi per corruzione nel processo ENI-SAI il 12 novembre 1996;
4 anni e 6 mesi per finanziamento illecito per le mazzette della metropolitana
milanese il 20 aprile 1999.
Per tutti gli altri processi in cui era imputato (alcuni dei quali in secondo o
in terzo grado di giudizio), è stata pronunciata sentenza di estinzione del
reato a causa del decesso dell'imputato. Fino a quel momento Craxi era stato
condannato a:
4 anni e una multa di 20 miliardi di lire in primo grado per il caso All Iberian
il 13 luglio 1998, pena poi prescritta in appello il 26 ottobre 1999.
5 anni e 5 mesi in primo grado per tangenti ENEL il 22 gennaio 1999;
5 anni e 9 mesi in appello per il conto protezione, sentenza poi annullata dalla
Cassazione con rinvio il 15 giugno 1999;
3 anni in appello bis per il caso Enimont il 1º ottobre 1999;
Craxi fu anche rinviato a giudizio il 25 marzo 1998 per i fondi neri Montedison
e il 30 novembre 1998 per i fondi neri Eni.
Le prove sulla base delle quali furono emesse le prime sentenze di condanna
della vicenda giudiziaria di Craxi, secondo alcuni autori, si incaricheranno di
smentire due dei suoi principali assunti difensivi. Il primo era quello secondo
cui i reati erano stati compiuti solo per eludere le forme di pubblicità
obbligatoria del finanziamento dei partiti, e non in contraccambio di atti
amministrativi: in un caso (sentenza ENI-SAI) la sua condanna definitiva fu per
corruzione, e non solo per finanziamento illecito di partito (ciò spiega
l'insistenza dei suoi eredi nell'attaccare la procedura di quella sentenza
dinanzi alla Corte di Strasburgo). L'altro assunto era quello secondo cui i
proventi dei reati contestatigli era destinato al partito e non a fini
personali; varie sentenze - non passate in giudicato solo per il decesso
dell'imputato - sostennero in motivazione che Craxi aveva utilizzato parte dei
proventi delle tangenti (circa 50 miliardi di lire) per scopi personali
(Finanziamento del canale televisivo GBR di proprietà di Anja Pieroni, acquisto
di immobili, affitto di una casa in Costa Azzurra per il figlio); durante le
indagini (dopo un fallito tentativo di far rientrare tali proventi in Italia,
bloccato dal nuovo segretario del Psi Ottaviano Del Turco) Craxi li versò sul
conto di un prestanome, Maurizio Raggio. La lettura di un uso privato dei fondi,
ancora assai ricorrente, fu sostenuta da Vittorio Feltri all'epoca dei fatti, ma
è stata dallo stesso abbandonata più di recente (lo stesso Feltri ammise anche
di aver attaccato Craxi in maniera eccessiva) venendo così sostanzialmente a
coincidere con quanto sempre sostenuto dai familiari circa l'esistenza di conti
segreti ascrivibili al solo PSI. Distinguendo tra movente e comportamenti, uno
dei giudici del pool anticorruzione di Milano, Gerardo D'Ambrosio, sostenne in
proposito: «La molla di Craxi non era l'arricchimento personale, ma la
politica».
Le sentenze di assoluzione. Craxi venne
invece assolto:
nel processo per le tangenti Intermetro, dal tribunale di Roma nel 1999.
nel processo alle irregolarità degli appalti per la costruzione della
metropolitana di Lima, in Perù; l'estraneità dell'ormai defunto Craxi venne
riconosciuta, sempre a Roma, nella sentenza che assolse tutti i co-imputati nel
2002.
I ricorsi a Strasburgo contro le sentenze di condanna.
Il 5 dicembre 2002 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di
Strasburgo (dopo aver bocciato il ricorso in prima istanza) ha emesso una
sentenza d'appello - in riferimento al processo preso in esame, quelli ENI-Sai -
che condanna la giustizia italiana per la violazione dell'articolo 6 ("equo
processo"), paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera D ("diritto di interrogare o fare
interrogare i testimoni") della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, in
ragione dell'impossibilità di «contestare le dichiarazioni che hanno costituito
la base legale della condanna», condanna formulata «esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni pronunciate prima del processo da coimputati (Cusani, Molino
e Ligresti) che si sono astenuti dal testimoniare e di una persona poi morta
(Cagliari)». Tuttavia, la Corte ha rilevato anche che i giudici, obbligati ad
acquisire le dichiarazioni di questi testimoni dal codice di procedura penale,
si sono comportati in conformità al diritto italiano. Per quanto riguarda gli
altri ricorsi valutati (diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni
necessarie alla difesa) la corte non ha rilevato violazioni. Per la violazione
riscontrata la corte non ha comminato nessuna pena, in quanto ha stabilito che
«la sola constatazione della violazione comporta di per sé un'equa soddisfazione
sufficiente, sia per il danno morale che materiale». La Corte ha emesso una
seconda sentenza il 17 luglio 2003, questa volta riguardante la violazione
dell'articolo 8 della Convenzione ("diritto al rispetto della vita privata"). La
Corte ha rilevato infatti che «lo Stato italiano non ha assicurato la custodia
dei verbali delle conversazioni telefoniche né condotto in seguito una indagine
effettiva sulla maniera in cui queste comunicazioni private sono state rese
pubbliche sulla stampa» e che «le autorità italiane non hanno rispettato le
procedure legali prima della lettura dei verbali delle conversazioni telefoniche
intercettate». Come equa soddisfazione per il danno morale, la Corte ha elargito
un risarcimento di 2000 € per ogni erede di Bettino Craxi.
Eredità politica. La forte personalità
di Bettino Craxi incise in tal modo sulla strutturazione stessa del PSI da
determinarne, dopo la sua uscita di scena e anche a causa delle inchieste di
Tangentopoli, il rapido e repentino disfacimento. Dei tre immediati eredi del
PSI, i Socialisti Italiani (eredi legali del simbolo e del nome), la Federazione
Laburista e il Partito Socialista Riformista, sarà quest'ultimo, nonostante la
breve vita, ad ospitare la maggioranza dei membri della corrente craxiana
rimasti in politica. In seguito molti esponenti socialisti già a lui fedeli
hanno aderito a Forza Italia, il partito dell'amico Silvio Berlusconi; tra
questi si ricordano: la figlia Stefania (poi fondatrice di un partito autonomo
denominato Riformisti Italiani), Fabrizio Cicchitto, Giulio Tremonti, Maurizio
Sacconi, Renato Brunetta e Franco Frattini. Altri sono rimasti a sinistra
aderendo prima ai Socialisti Italiani e successivamente al partito dei
Socialisti Democratici Italiani (guidato da Enrico Boselli); tra questi si
ricordano Ugo Intini e Ottaviano Del Turco (in seguito aderente al PD), o
confluendo nei DS: la Federazione Laburista di Valdo Spini e i Riformatori per
l'Europa di Giorgio Benvenuto. Anche la corrente di maggioranza della CGIL (oggi
vicina al Partito Democratico) è stata guidata da un ex-craxiano, Guglielmo
Epifani, che fu anche segretario confederale; Guglielmo Epifani è stato poi
nominato segretario del PD nel 2013 dall'Assemblea Nazionale, ponendo quindi un
esponente del gruppo craxiano degli anni Ottanta alla guida del partito che
comprende una parte degli ex comunisti, tra cui molti che furono accesi rivali e
forti critici di Craxi stesso; socialista era anche il giurista del diritto del
lavoro Marco Biagi, poi assassinato dalle Nuove Brigate Rosse. Altro partito
erede della politica craxiana è il Nuovo PSI (nato dalla fusione del Partito
Socialista - Socialdemocrazia e della Lega Socialista), che vede nelle sue file
uno dei più importanti esponenti socialisti degli anni ottanta, Gianni De
Michelis, già ministro degli esteri; tuttavia, De Michelis e Bobo Craxi, figlio
secondogenito di Bettino, a seguito di un infuocato congresso celebratosi verso
la fine del 2005 si sono contesi con reciproche contestazioni la guida del
partito, con strascichi anche giudiziari. L'oggetto del contendere furono le
alleanze politiche: Bobo Craxi intendeva far entrare il Nuovo PSI, che finora ha
appoggiato i governi berlusconiani, nell'Unione di centrosinistra, mentre De
Michelis, pur concordando nel ridiscutere il rapporto con Berlusconi, si era
dichiarato contrario a questa alleanza; anche Stefania Craxi, in
contrapposizione con Bobo, si è fermamente opposta ad un passaggio dei
socialisti craxiani nella coalizione prodiana. Tuttavia Bobo Craxi ha fondato
una sua lista in appoggio della coalizione dell'Ulivo, denominata I Socialisti
(oggi un piccolo partito denominati Socialisti Uniti e guidato da Saverio
Zavettieri). L'anno successivo, però, anche De Michelis ha abbandonato il
centro-destra, per avvicinarsi, seppur brevemente e criticamente, al
centro-sinistra, per tornare poi a collaborare col ministro berlusconiano Renato
Brunetta. Claudio Martelli ha invece aderito prima allo SDI, poi al Nuovo PSI,
prima di ritornare alla sua precedente attività giornalistica. Nel 2007 molti
craxiani hanno aderito alla Costituente Socialista di Enrico Boselli, volta a
ricostituire il PSI, che ha sancito la rinascita del Partito Socialista, seppur
in forma ridotta, rispetto quello dell'epoca craxiana. Sia Boselli che il
successore come segretario, Riccardo Nencini, hanno rivendicato al PSI moderno
l'eredità politica migliore di Craxi, cosa fatta anche, nell'area laica, dal
leader radicale Marco Pannella. A parte queste contese strettamente partitiche,
l'eredità politica di Craxi è oggi contesa da parte del centrosinistra, sia da
numerosi esponenti del Partito Democratico (alcuni dei quali provenienti dal PSI
craxiano), sia dal rinato Partito Socialista Italiano ma anche dal Popolo della
Libertà (centro-destra), alleato con il Nuovo PSI. Nel bene e nel male, si
tratta di comunque di una figura che ha segnato indiscutibilmente la politica e
la storia italiane del dopoguerra. Nel libro Segreti e Misfatti (2005),
scritto dal suo fotografo personale e amico fidato fino agli ultimi giorni
tunisini Umberto Cicconi, si scoprono molti retroscena curiosi ma anche di
grande interesse politico, storico ed umano. Sempre lo stesso anno, la
pubblicazione del libro di Bruno Vespa, L'Amore e il Potere, contenente
anche gossip su Craxi e le sue presunte amanti, ha provocato la reazione del
figlio Bobo, che ha definito il carattere del libro "particolarmente odioso".
La Fondazione Craxi. La Fondazione
Craxi è una fondazione nata il 18 maggio 2000 allo scopo di tutelare la
personalità, l'immagine, il patrimonio culturale e politico di Bettino Craxi
attraverso la raccolta di tutti i documenti storici che riguardino la sua storia
politica. Principale animatrice è la figlia Stefania Craxi, già deputato del
gruppo Misto e oggi presidente del movimento politico Riformisti Italiani. La
sede principale è a Roma, mentre un'altra importante sede si trova ad Hammamet,
in Tunisia, luogo dove è sepolto Bettino Craxi. Tra le attività della fondazione
vi è la costituzione e valorizzazione dell'"Archivio Storico Craxi", costituito
riunendo documenti conservati in diversi luoghi (Milano, Roma, Hammamet),
costituiti essenzialmente da corrispondenza, memorie, discorsi, articoli,
interviste, atti processuali. L'obiettivo generale è quello di "riabilitare" la
figura dello statista italiano coinvolto nei processi di Mani Pulite e di
riqualificarne l'importanza storica nonostante le svariate condanne penali
riportate. La fondazione figura anche come organizzatrice di convegni e mostre
inerenti alla vita e all'attività politica di Bettino Craxi, cui affianca anche
un'attività editoriale.
Riconoscimenti. A seguito del
ricorrente tentativo di conseguire un atto ufficiale che esprima una
condivisione pubblica dell'operato del personaggio, si apre periodicamente il
dibattito sull'opportunità o meno di intitolare in Italia una strada al leader
socialista. Ad una disamina condotta nel dicembre 2009, risultano i toponimi
"piazza Bettino Craxi" nei comuni di Grosseto e Lissone e "via Bettino Craxi" in
quelli di Valmontone, Lecce, Botrugno, Marano Marchesato, Alà dei Sardi e
Scalea. Nella città di Aulla (provincia di Massa e Carrara) nel 2003 per
iniziativa dell'allora sindaco Lucio Barani era stata eretta anche una statua di
Craxi (di marmo bianco, con la scritta: "A Bettino Craxi, statista, esule e
martire"), oltre ad intitolargli una piazza. La frase sulla tomba di Craxi ("La
mia libertà equivale alla mia vita"), a lui stesso attribuita, è scolpita anche
nel monumento alle vittime di Tangentopoli, situato sempre ad Aulla. La
statua (proprietà del Nuovo PSI, che la commissionò, secondo quanto dichiarato
da Barani) fu messa in vendita dall'amministrazione successiva. Lo scultore
Maurizio Cattelan ha scolpito un altro monumento marmoreo a Bettino Craxi. Il
monumento è stato scolpito dall'artista veneto ispirandosi ad un modello non
utilizzato dagli scultori della cave di Carrara, per la realizzazione della
statua posizionata ad Aulla, ma includendo rimasugli di un'opera degli anni
Trenta, modificata per l'occasione. Intenzione di Cattelan era posizionarlo a
Carrara al posto della statua di Giuseppe Mazzini, per dimostrare la
"vulnerabilità della storia", ma successivamente, in seguito a proteste, è stato
messo in un vicino cimitero. L'opera raffigura una sorta di piccolo tempio greco
in bassorilievo, con due angeli piegati, mentre due putti sollevano un tondo con
un ritratto di profilo del leader socialista. Il governo tunisino ha provveduto,
il 19 gennaio 2007, in occasione del settimo anniversario della sua morte, a
intitolargli una via. Il 15 gennaio 2007 in un comune laziale di 2.500 anime,
Sant'Angelo Romano, a 20 chilometri da Roma, l'amministrazione di centrodestra
guidata dal sindaco Angelo Gabrielli, ex socialista, ha inaugurato una piazza
all'ex leader socialista. Per quanto riguarda le grandi città, violente
polemiche hanno frenato la decisione toponomastica: sette anni dopo la sua morte
aveva preso avvio il progetto di intitolare una strada di Roma a Bettino Craxi.
La decisione è stata presa la prima volta dal sindaco della Capitale Walter
Veltroni, in accordo con la sua giunta di centro-sinistra, e poi ribadita dal
nuovo sindaco Alemanno. Nel 2009 identica proposta è stata avanzata dal sindaco
di Milano Letizia Moratti, portando ad una manifestazione di protesta, svoltasi
il 9 gennaio 2010 in piazza Cordusio, durante la quale Beppe Grillo e Antonio di
Pietro hanno arringato gli oltre cento partecipanti.
Soprannomi. Per alcuni anni fu
soprannominato il "Cinghialone" dai suoi detrattori, dopo esser stato così
definito in un articolo di Vittorio Feltri sul quotidiano L'Indipendente;
più raffinatamente, Indro Montanelli, sul Giornale, nel giorno delle sue
dimissioni da segretario del PSI, lo definì un "imano", volendo intendere forse
la parola imam, dandogli quindi il senso di un dignitario/satrapo
orientale. Matt Frei afferma che nella Roma politica il suo epiteto sarebbe
stato il "Maestro", in quanto padrone delle mille tattiche utili alla strategia
politica che lo aveva posto al centro della vita nazionale per oltre un
decennio. Nella polemica su Tangentopoli, era comune in quel periodo storico
sentire definito Craxi come "ladrone", detentore di un tesoro alla Ali Baba.
Rispetto a questo tipo di definizioni - la cui ampia diffusione nell'opinione
pubblica sfugge oramai ad un giudizio solo processuale, essendo la forma di
percezione pubblica di un giudizio storico - più eleganti appaiono i richiami
storici ricercati da autori di più auliche similitudini. Ad esempio, Francesco
De Gregori lo definì Nerone in una sua canzone, per poi comunque affermare,
alcuni anni dopo, la superiorità di Craxi rispetto ai politici che vennero dopo
di lui. Craxi usò lo pseudonimo Ghino Di Tacco, epiteto datogli da Eugenio
Scalfari, per firmare articoli anonimi sul giornale Avanti!. A volte il
nome fu storpiato dagli avversari in Ghigno Di Tacco, in riferimento
presunto all'espressione facciale di Craxi, Giorgio Forattini, che allora
lavorava per la Repubblica, il giornale diretto da Scalfari, storpiò a
sua volta questo soprannome in Benito di Tacco, perché era solito
rappresentare Craxi in camicia nera e stivali, per via dei suoi modi "da Duce".
L'ultimo discorso di Craxi alla Camera.
Discorso alla Camera dei Deputati del 29 Aprile 1993 - Di Bettino
Craxi. "Circa dieci mesi or sono prendendo la parola di fronte alla Camera dissi
con franchezza ciò che un ex Presidente della Repubblica definì poi come
l'apertura di quella "grande confessione" verso la quale avrebbe dovuto e
dovrebbe aprirsi, con tutta la sincerità necessaria, tutto o gran parte almeno
del mondo politico. I giudici che mi accusano l'hanno considerata invece come
una "confessione extragiudiziale" elevandola subito e senz'altro a prova di
primo grado contro di me. Quella per la verità era ed è rimasta la sola prova di
quell'accusa. Sempre che una dichiarazione una analisi ed una riflessione fatte
di fronte al Parlamento possano essere considerate alla stregua di una prova
penale. Ricordo che, ancor prima di allora, commentando a caldo le prime
esplosioni scandalistiche milanesi che aprivano il libro dagli inesauribili
capitoli apertosi poi un po' dovunque, mi ero permesso semplicemente di dire:
"Su quanto sta accadendo la classe politica ha di che riflettere". Questa
affermazione fu allora maltrattata come espressione di un atteggiamento
intimidatorio, provocatorio, financo ricattatorio. In realtà non era difficile
avvertire già da allora tutta la dimensione del problema che si era aperto,
tutta la sua gravità e la sua complessità. Non era difficile cogliere la
inutilità e l'errore di una difesa e di una giustificazione che non fossero
improntate al linguaggio della verità. Per le responsabilità che mi competevano,
per il ruolo che, per lungo tempo, avevo esercitato, di Segretario nazionale del
Partito Socialista, io non ho negato la realtà, non ho minimizzato, non ho
sottovalutato il significato morale, politico, istituzionale della questione che
veniva clamorosamente alla luce riguardante il finanziamento irregolare ed
illegale ai partiti ed alle attività politiche ed anche il vasto intreccio
degenerativo che ad esso si collegava o poteva, anche a nostra insaputa, essersi
collegato. Come si ricorderà ne parlai proprio di fronte a voi seguendo una
traccia che stamane mi consentirete di riprendere. Osservavo nel Luglio del '92:
"C'è un problema di moralizzazione della vita pubblica che deve essere
affrontato con serietà e con rigore, senza infingimenti, ipocrisie, ingiustizie,
processi sommari e grida spagnolesche. E' tornato alla ribalta, in modo
devastante, il problema del finanziamento dei Partiti, meglio del finanziamento
del sistema politico nel suo complesso, delle sue degenerazioni, degli abusi che
si compiono in suo nome, delle illegalità che si verificano da tempo, forse da
tempo immemorabile. Bisogna innanzitutto dire la verità delle cose e non
nascondersi dietro nobili e altisonanti parole di circostanza che molto spesso e
in certi casi hanno tutto il sapore della menzogna. Si è diffusa nel paese,
nella vita delle istituzioni e della pubblica amministrazione, una rete di
corruttele grandi e piccole che segnalano uno stato di crescente degrado della
vita pubblica, uno stato di cose che suscita la più viva indignazione,
legittimando un vero e proprio allarme sociale, ponendo l'urgenza di una rete di
contrasto che riesca ad operare con rapidità e con efficacia. I casi sono della
più diversa natura, spesso confinano con il racket malavitoso, e talvolta si
presentano con caratteri particolarmente odiosi di immoralità e di asocialità.
Purtroppo anche nella vita dei Partiti molto spesso è difficile individuare,
prevenire, tagliare aree infette sia per la impossibilità oggettiva di un
controllo adeguato, sia talvolta, per l'esistenza ed il prevalere di logiche
perverse. E così all'ombra di un finanziamento irregolare ai Partiti e, ripeto,
al sistema politico, fioriscono e si intrecciano casi di corruzione e di
concussione, che come tali vanno definiti trattati provati e giudicati. E
tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire, e che tutti sanno del resto, è
che buona parte del finanziamento politico è irregolare od illegale. I Partiti
specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività
propagandistiche, promozionali e associative, e con essi molte e varie strutture
politiche e operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive
in forma irregolare od illegale. Se gran parte di questa materia deve essere
considerata materia puramente criminale allora gran parte del sistema sarebbe un
sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno in quest'aula, responsabile
politico di organizzazioni importanti che possa alzarsi e pronunciare un
giuramento in senso contrario a quanto affermo: presto o tardi i fatti si
incaricherebbero di dichiararlo spergiuro". E del resto, andando alla ricerca
dei fatti, si è dimostrato e si dimostrerà che tante sorprese non sono in realtà
mai state tali. Per esempio, nella materia tanto scottante dei finanziamenti
dall'estero sarebbe solo il caso di ripetere l'arcinoto "tutti sapevano e
nessuno parlava". Ed osservavo ancora: "Un finanziamento irregolare ed illegale
al sistema politico, per quante reazioni e giudizi negativi possa comportare e
per quante degenerazioni possa aver generato non e' e non può essere considerato
ed utilizzato da nessuno come un esplosivo per far saltare un sistema, per
delegittimare una classe politica, per creare un clima nel quale di certo non
possono nascere nè le correzioni che si impongono nè un'opera di risanamento
efficace ma solo la disgregazione e l'avventura. A questa situazione va ora
posto un rimedio, anzi più di un rimedio". Mi spiace che tutto questo sia stato,
allora, sottovalutato. Tante verità negate o sottaciute sono venute una dopo
l'altra a galla e tante ne verranno, ne possono e ne dovranno venire ancora. E
mentre molti si considerano tuttora al riparo dietro una regola di reticenza e
di menzogna, non si è posto mano a nessun rimedio ragionevole e costruttivo.
Questo deve valere anche per i Partiti che se debbono continuare ad esistere
come elementi attivi della democrazia italiana ed europea sia pure in un diverso
ruolo ed in diverse configurazioni, debbono essere posti di fronte a nuove
regole impegnative ed utili a rinnovare e a far rifiorire la loro essenza
associativa e democratica. Si è invece fatto strada con la forza di una valanga
un processo di criminalizzazione dei partiti e della classe politica. Un
processo spesso generalizzato ed indiscriminato che ha investito in particolare
la classe politica ed i partiti di governo anche se, per la parte che ha
cominciato ad emergere, non ha risparmiato altri come era e come sarà prima o
poi inevitabile. Era del tutto evidente che scavando e risalendo negli anni e
persino nei decenni nella sfera delle forme di finanziamento illegale
dell'attività politica, delle sue articolazioni, delle organizzazioni e
competizioni elettorali, ogni giorno si sarebbe incontrato un episodio, un caso,
uno scandalo. E così è stato. E così sarà. La lista delle indagini, delle
investigazioni e poi delle controinvestigazioni, dei pentiti, dei pentiti a
scoppio ritardato e dei contropentiti, delle rivelazioni vere o false, mirate o
sapientemente mutilate, e dei rei-confessi per amore o per forza è destinata a
farsi interminabile. A queste si sono aggiunti fatti di corruzione personale che
sono del tutto estranei alla responsabilità dei Partiti anche se pesano
egualmente in tutta la loro gravità. Ma di tutte l'erbe s'è fatto alla fine un
fascio. Tutto si è ridotto ad una unica accusa generalizzata. Le campagne
propagandistiche hanno ruotato sovente solo attorno a slogans ed a brutali
semplificazioni. Di questo si è incaricata infatti parte almeno della stampa e
dell'informazione, andando ben al di là dei diritti e dei doveri propri
dell'informazione, deformando spesso oltre misura, esaltando le ragioni
dell'accusa e mettendo di canto quelle della difesa, travolgendo senza alcun
rispetto diritti costituzionalmente garantiti con difese divenute praticamente
impossibili, creando sovente un clima infame che ha distrutto persone, famiglie
e generato tragedie. La criminalizzazione della classe politica, giunta ormai al
suo apice, si spinge verso le accuse piu' estreme, formula accuse per i crimini
più gravi, più infamanti e più socialmente pericolosi. Un processo che quasi non
sembra riguardare più le singole persone, ma insieme ad esse tutto un tratto di
storia, marchiato nel suo insieme. Un vero e proprio processo storico e politico
ai Partiti che per lungo tempo hanno governato il Paese. Mi chiedo come e quando
tutto questo si concili con la verità, che rapporto abbia con la verità storica,
con gli avvenimenti e le fasi diverse e travagliate che abbiamo attraversato e
nelle quali molti di noi hanno avuto responsabilità politiche di governo di
primo piano. Davvero siamo stati protagonisti, testimoni o complici di un
dominio criminale? Davvero la politica e le maggioranze politiche si sono
imposte ai cittadini attraverso l'attuazione ed il sostegno di disegni
criminosi? Davvero gli anni ottanta di cui soprattutto si parla, senza
risparmiare i precedenti, sono stati gli anni bui della regressione, della
repressione, della malavita politica che scrivono e cantano in prima fila tanti
reduci dell'eversione, delle rivoluzioni mancate, delle rotture traumatiche che
sono state contrastate ed impedite? Questa non e' altro che una lettura falsa,
rovesciata mistificata della realtà e della storia. Chi ha condotto per anni una
opposizione democratica ha da far valere in ben altro modo tutte le sue ragioni.
Per parte mia, io non dimentico che negli anni Ottanta l'Italia ha rimontato la
china della regressione, della stagnazione e dell'inflazione, è uscita dalla
crisi economica e produttiva per entrare in un ciclo di espansione e di sviluppo
senza precedenti toccando le punte di sviluppo più alte tra i paesi dell'Europa
industrializzata. Si è trattato di un progresso forte, intenso, diffuso, che ha
ridotto tante disuguaglianze e che poneva le basi per ridurne tante altre che
ancora dividevano e dividono la nostra società. Sono gli anni in cui viene posto
fine al capitolo dell'eversione militare, del terrorismo e delle sue code
sanguinose. Sono anche gli anni di un nuovo prestigio internazionale, con
l'Europa comunitaria che si amplia e si consolida e con l'Italia che entra a far
parte del club economico ma anche politico delle maggiori Nazioni
industrializzate del mondo occidentale. Tutti i cicli, come è naturale passano,
entrano in contraddizione, si esauriscono, degenerano. Sono così subentrati gli
anni delle difficoltà e della crisi, che stiamo ancora attraversando. Ma gli
effetti e le conseguente di un periodo critico sarebbero stati ben diversi e ben
più onerosi se non avessimo avuto alle spalle il solido sviluppo realizzato nel
corso degli anni ottanta ed un retroterra conquistato con un balzo in avanti
poderoso. I finanziamenti illegali ai partiti ed alle attività politiche non
sono stati tuttavia una invenzione e una creazione degli anni ottanta. Hanno
radici, come si sa, ben più antiche e ben ripartite tra le forze che si
contrapponevano, in lotta tra loro, e sovente senza esclusione di colpi. Così
come nella vita della società italiana non è nata negli anni ottanta la
corruzione nella pubblica amministrazione e nella vita pubblica. La vicenda dei
finanziamenti alla politica, dei loro aspetti illegali, dei finanziamenti
provenienti attraverso le vie più disparate dell'estero, della ricerca di
risorse aggiuntive rispetto poi ad una legge sul finanziamento pubblico ipocrita
e ipocritamente accettata e generalmente non rispettata, accompagna la storia
della società politica italiana, dei suoi aspri conflitti, delle sue
contraddizioni e delle sue ombre, dal dopoguerra sino ad oggi. Non c'e' dubbio
che un troppo prolungato esercizio del potere da parte delle più o meno medesime
coalizioni di Partiti ha finito con il creare per loro un terreno più facilmente
praticabile per abusi e distorsioni che si sono verificate. Ma onestà e verità
vorrebbero che in luogo di un processo falsato, forzato, ed esasperato, condotto
prevalentemente in una direzione, si desse il via ad una ricostruzione per
quanto possibile obiettiva ed appropriata di tutto l'insieme di ciò che è
accaduto. Si tratta di una realtà che non si può dividere in due come una mela,
tra buoni e cattivi, gli uni appena sfiorati dal sospetto, gli altri
responsabili di ogni sorta di errori e nefandezze. Trovo perlomeno singolare che
sia stata liquidata con poche battute di circostanza, qualche pretesto e qualche
falsa riverenza la proposta di una inchiesta parlamentare che abbracciasse
l'arco di almeno un quindicennio della nostra storia politica. Il Parlamento
avrebbe il dovere di farlo avendo esso stesso nella sua storia una montagna di
dichiarazioni di bilanci di Partiti certamente falsi, di organi di controllo che
non hanno controllato, di revisori che non hanno rivisto. Che tutto questo
avvenisse senza l'insorgere di clamorose contestazioni e denunce e senza
clamorosi conflitti, salvo casi sporadici ed aspetti particolari, significa che
il sistema in funzione e le sue irregolarità non solo erano in principio
riconosciute, ma erano consensualmente accettate e condivise, almeno dai più. E'
d'altro canto un sistema cui hanno partecipato e concorso, in forme varie e
diverse, tutti i maggiori gruppi industriali del paese, privati e pubblici.
Gruppi e società importanti nel loro settore e nella economia nazionale e in
molti casi presenti e influenti anche sui mercati internazionali, gruppi potenti
in grado di influire e di condizionare i poteri della politica e dello Stato. Di
questi tutto si può dire salvo che siano state vittime di una prepotenza, di una
imposizione, di un sistema vessatorio ed oppressivo di cui non vedevano l'ora di
liberarsi. Si tratta di tutti i maggiori gruppi del paese, quelli che sono stati
chiamati in causa e quelli che ancora possono esservi chiamati, anch'essi
fornitori dello stato, tributari dello stato di sostegno di varia natura,
tributari di appalti pubblici, esportatori, proprietari di catene
giornalistiche, speculatori a vario titolo, se la verità, anche per loro, come
c'è da augurarsi, finirà prima o poi per farsi strada. Si tratta di condotte
illegali del mondo imprenditoriale attuate con piena consapevolezza e
responsabilità e con finalità di molteplice natura, di ordine economico
aziendale commerciale ed anche di ordine pubblico a sostegno di un sistema, dei
suoi diversi equilibri, della sua stabilità complessiva, ed anche a sostegno più
diretto di singoli membri di un personale politico con il quale mantenere
rapporti amichevoli più impegnativi. Illegalità nel mondo politico, illegalità
nel mondo imprenditoriale. Ad esse si sono venute aggiungendo illegalità nel
mondo giudiziario. Una inchiesta giudiziaria è tanto più forte, accettata,
rispettata, quanto più forte, rigoroso, lineare è il rispetto della legge
ch'essa si impone, senza prevaricazioni, arbitri, forzature ed eccessi di sorta.
Si è verificato purtroppo, e in più casi e ripetutamente tutto il contrario. Non
c'è fine che possa giustificare il ricorso a mezzi illegali, a violazioni
sistematiche, clamorose e persino esaltate della legge, dei diritti dei
cittadini, dei diritti umani. Non c'è consenso popolare, sostegno politico,
campagna di stampa che possa giustificare un qualsiasi distacco dai principi
garantiti dalla Costituzione e fissati dalla legge. Non la giustifica neppure
l'assenza, l'insensibilità o il ritardo degli organi di controllo, la debolezza
o il disorientamento delle difese, la barriera del pregiudizio negativo. Non lo
ha visto e non lo vede, del resto, solo chi non lo vuole e preferisce, per
opportunità, per superficialità o per calcolo voltare la testa dall'altra parte.
Chi non ha visto le forzature macroscopiche e strumentali nella interpretazione
delle leggi per giungere ad usare impropriamente i poteri giudiziari? Sin da
quattro secoli in Inghilterra era stato scritto nel Leviatano "Se il giudice usa
con arroganza il potere di interpretare le leggi, tutto diventa arbitrio
imprevedibile. Di fronte ad un metodo del genere ogni sicurezza viene meno". Chi
non ha visto gli arresti illegali, facili, collettivi, spettacolari e financo
capricciosi, di fronte ad una civiltà del diritto e ad una normativa di legge
che anche nel nostro paese considerava l'arresto una "extrema-ratio". Chi non ha
visto le detenzioni illegali che fanno impallidire la civiltà dell'Habeas
Corpus. Le detenzioni a scopo di confessione che sono tutto il contrario di ciò
che è riconosciuto ed accettato. Chi non ha visto le perquisizioni a scoppio
ritardato, quelle in particolare delle sedi di Partito manifestatamente inutili
ma utili, per la messinscena predisposta e per lo spettacolo denigratorio
assicurato. Sono all'ordine del giorno del resto le sistematiche violazioni del
segreto istruttorio, ormai praticamente vanificato e inesistente o esistente
solo in ragione di criteri discriminatori o criteri arbitrari dettati da
interessi ed opportunità di varia natura ivi comprese quelle politiche. C'è
forse qualcuno che non ha visto la esemplare tempistica politica di determinate
operazioni? Quando la giustizia funziona ad orologeria politica essa contiene
già in se qualcosa di aberrante. Purtroppo c'è anche materia per scrivere un
capitolo sui diritti umani, sulla loro mortificazione e sulle loro violazioni.
Affacciandosi, già mesi orsono, sulla realtà italiana, una missione
internazionale composta di alti magistrati ed esponenti del Foro di Parigi,
prudentemente, rispettosamente annotava in un suo primo rapporto :"I magistrati,
incaricati delle inchieste sulla corruzione, applicano le disposizioni di legge
relative alla detenzione preventiva in modo particolarmente estensivo. Senza
arrivare ad espressioni quali tortura o inquisizioni - pur usate da diverse
personalità, non sembra si possa dubitare del fatto che la carcerazione
preventiva sistematica di numerosi indiziati - molti dei quali presentano
evidenti qualifiche di notorietà - e che è ufficialmente motivata dalla
preoccupazione di un possibile inquinamento delle prove, ha in realtà lo scopo
di esercitare delle pressioni per ottenere confessioni di colpevolezza, o la
denuncia di complici. Ciò che numerosi magistrati hanno ammesso pubblicamente
sottolineando l'efficacia di tale metodo. Questa pratica, di carattere
chiaramente repressivo appare in contraddizione sia con il disposto art. 275 del
nuovo codice di procedura penale italiano che indica la detenzione preventiva
come una misura coercitiva di natura eccezionale, sia con i testi internazionali
esistenti in materia di tutela dei diritti dell'uomo". Nello stesso rapporto si
legge che "Gli eccessi constatati nell'applicazione del codice di procedura
penale nell'ambito delle inchieste in materia di corruzione sono ancora più
preoccupanti perchè a tutt'oggi sembrano sottratti a qualsiasi tipo di
controllo. In effetti la maggior parte dei ricorsi al Tribunale delle Libertà
sono stati rigettati. L'opinione pubblica italiana che è molto favorevole alla
repressione delle tangenti esercita sulla magistratura una notevole pressione,
alla quale quest'ultima non è insensibile, e che raggiunge il risultato di
rendere alcuni magistrati incaricati delle inchieste dei personaggi protagonisti
al riparo da qualsiasi critica pubblica". La stessa delegazione della
"Federation Internationale des Droits de l'Homme" ancora osserva :"Il compito di
purificatore che taluni magistrati si attribuiscono e che essi pubblicamente
proclamano, solleva problemi delicati nel rapporto tra potere giudiziario,
potere esecutivo e potere legislativo; e non solo perchè molti politici sono
oggetto della maggioranza dei procedimenti in corso, insieme ad industriali e
uomini d'affare; ma per la distorsione di tali rapporti, che può andare oltre il
caso specifico e determinare una preoccupante inclinatura dell'ordinamento
democratico". Spiace doverlo dire ma le ripetute affermazioni di magistrati,
talvolta solenni, talvolta sdegnate, che vogliono suonare come una proclamazione
di indipendenza e di indifferenza rispetto alla politica, agli effetti politici,
agli obiettivi politici, in molti troppi casi non convincono affatto e non
possono convincere. Penso agli arresti alla vigilia della formazione di governi
locali o dopo la loro formazione, alle retate di interi corpi amministrativi,
alle operazioni di marca preelettorale, agli scoops in vista di precise scadenze
politiche, alla disparità di trattamento, che meriterebbero un approfondimento a
parte, alle oculate selezioni, all'accanimento con il quale ci si e' mossi
soprattutto in certe direzioni ma, allo stesso modo, non in altre. Un grande
processo politico era preconizzato dagli ideologhi, magistrati e non, della
rottura traumatica che sui loro giornali scrivevano :"Il sistema politico e' la
culla piu' ospitale ed al tempo stesso la più formidabile difesa del crimine
organizzato della violenza mafiosa e camorristica delle lobbies illegali".
Leggiamo oggi una pubblicistica che si muove ad un passo financo dai testi della
letteratura terroristica quando questa si scagliava contro il "regime
politico-mafioso, DC-PSI", e contro "l'amerikano Craxi che si adopera per
accelerare il processo di edificazione del SIM (Stato Imperialista delle
Multinazionali)", contro il "gangster Craxi che si propone come baricentro dello
scenario politico". Contro un demone di questa natura allora tutto era
possibile, tutto giustificato, tutto lecito. Può capitare nel corso della storia
che la violenza nell'uso di un potere sia necessaria ed inevitabile ma è
necessario allora che essa sia chiamata con il suo nome, sia riconosciuta ed
esaltata come tale e non mistificata e proclamata in nome delle leggi o degli
ordinamenti in vigore. In questo caso sapremo senza possibilità di equivoci di
essere di fronte ad una nuova forza, ad una nuova legge e ad un nuovo potere.
Una "rivoluzione": così sono stati definiti e così molti concepiscono gli
avvenimenti di casa nostra. Può darsi. Però allora è bene essere consapevoli che
una rivoluzione è di per se sempre una grande incognita ed una grande avventura,
ma soprattutto che una rivoluzione senza un ceto organico di rivoluzionari è
destinata solo a distruggere ed a preparare un fallimento certo. C'è stata
violenza nell'uso del potere giudiziario, nell'uso dei sempre più potenti mezzi
di comunicazione, c'è stato un eccesso di violenza nella polemica politica,
nella critica, nel linguaggio, nei comportamenti. E la violenza non può far
altro che generare violenza, nei giudizi, nei sentimenti, nelle passioni, negli
animi. In quale democrazia del mondo, a memoria del secolo, inchieste
giudiziarie, ed il clima esasperato che attorno ad esse è stato creato, hanno
potuto provocare tanti suicidi, tentati suicidi e morti improvvise. In quale
Paese civile e libero del mondo si sono celebrati in piazza tanti processi
sommari, si è assistito a tanti pubblici linciaggi e si sono consacrate tante
sentenze di condanna prima ancora che sia stato pronunciato un rinvio a
giudizio? Tutto questo non può non far riflettere. Doveva far riflettere, mi
auguro che faccia riflettere. Non credo del resto che la moralizzazione della
vita pubblica possa esaurirsi con la denuncia ed il superamento dei sistemi di
finanziamento illegale dei Partiti e delle attività politiche e con la condanna
di tutte le forme degenerative che ne sono derivate. Non credo che solo in
questo consista la questione della corruzione della vita pubblica. Non credo che
il procedere in modo violento con l'inevitabile inasprimento dei traumi e dei
conflitti che ne scaturirà potrà aprire un periodo ordinato e rigoglioso nella
vita democratica. Non credo che per queste vie li Paese si incamminerà verso un
periodo di rinascita economica,di riequilibrio sociale,di un rinnovamento
politico ed istituzionale all'insegna di un grande decentramento dei poteri, nel
consolidamento dell'unità della Nazione, e insieme di riconquista di un
prestigio internazionale tanto più necessario quanto più aspre si vanno facendo
la competizione e la conquista di aree di influenza nel mondo. C'e' un problema
democratico di rinnovamento e di ricambio della classe politica dirigente, c'è
un problema di alternanza di forze nelle responsabilità di guida e di governo.
E' un problema che deve essere risolto democraticamente, nel modo più
trasparente e diretto, senza provocare il soffocamento del pluralismo politico e
senza fare ricorso alla barbarie della giustizia politica. Una politica che
fosse intrisa di demagogia e di ipocrisia, non sarebbe destinata a fare lunga
strada. Così come non è destinato a farla chi ancora oggi continua a non usare
il linguaggio della verità, per non parlare di chi si presenta di fronte al
paese con l'aria smemorata, con i tratti di chi non sapeva anche ciò che avrebbe
dovuto inevitabilmente sapere, di chi ha vissuto sino a ieri in preda a
superficiali distrazioni, di chi denuncia nomenklature, ignorando la propria di
cui continua a portare tutti i caratteri, e dimenticando il proprio ruolo, la
propria responsabilità, di chi addirittura giudica dall'alto delle sue
frequentazioni malavitose. Il 2 novembre dello scorso anno moriva
improvvisamente Vincenzo Balzamo, deputato al Parlamento, Segretario
Amministrativo nazionale del PSI. Dopo settimane di angosce e di tensioni un
infarto ne aveva stroncato l'esistenza. Solo pochi giorni prima aveva ricevuto
un avviso di garanzia per gravi reati. Da quel momento dopo la sua morte nel
giudizio degli inquirenti vengo considerato una sorta di successore universale
di tutte le condotte addebitate all'On. Balzamo e vengo investito da una raffica
di avvisi di garanzia per concorso in fatti veri o presunti attribuiti ai
responsabili dell'Amministrazione del PSI. Purtroppo la scomparsa immatura
dell'On. Balzamo lasciando un vuoto doloroso ci ha privato di un testimone
essenziale e decisivo per tante vicende che costituiscono oggetto di indagine.
Sta di fatto che fino alla sua morte gli inquirenti concludono con l'On. Balzamo
il rapporto concorsuale nei reati che vengono individuati. Alla sua morte
coprono con me il posto rimasto vuoto. In assenza di qualsiasi elemento
probatorio che possa legarmi agli atti ritenuti criminalizzabili, la traslazione
di condotte altrui sotto la responsabilità mia personale in forza della carica
che rivestivo e del vantaggio economico che il Partito ne ha tratto, è un fatto
del tutto arbitrario ed inammissibile nel diritto penalprocessualistico.
Ammenochè, data la straordinarietà del mio caso, non sia stato sospeso, e
soltanto nei miei confronti, il principio di diritto della responsabilità
personale, sancito dalla Costituzione. La verità è che sin dall'inizio si è
mossa contro di me una azione ispirata da un intento persecutorio evidente che
numerosi fatti, che emergono dalla semplice lettura degli atti, provano e
confermano in modo chiaro ed inequivocabile. L'obiettivo "Craxi" era un
obiettivo politico primario e per tentare di colpirlo si è agito con la più
grande determinazione e talvolta anche con la più grande spregiudicatezza,
violando ripetutamente la legge e le stesse prerogative della immunità e della
inviolabilità del Parlamentare. Di fronte alla Camera la Giunta delle
autorizzazioni a procedere ha recentemente dichiarato che ciò che bisogna
accertare ai fini della concessione dell'autorizzazione a procedere è
"l'esistenza anche di un ombra di volontà di persecuzione". L'esistenza del
"fumus persecutionis" per un principio di diritto che non può essere ignorato e
cancellato, risulta confermata ogni qualvolta il magistrato giunge a compiere
atti di indagine preliminare a carico del deputato prima della informazione di
garanzia e prima della concessa autorizzazione a procedere. Ebbene, nel "caso
Craxi" i magistrati incaricati dell'indagine senza la spedizione delle
informazioni di garanzia e senza la autorizzazione a procedere, hanno con
insistenza, con accanimento crescente e anche, a più riprese, con sotteso
atteggiamento di coartazione, richiesto e elencato elementi probatori da porre a
base delle accuse contro di me, presupposte in un teorema già elaborato e per un
obiettivo già ben delineato. Tutto questo è avvenuto sistematicamente a partire
dai primi atti dell'inchiesta. Ne è scaturita in questo modo una massa ingente
di indagini che sono state svolte su di me, illegittimamente, attraverso
interrogatori, perquisizioni, sequestri, accertamenti patrimoniali, deposizioni
testimoniali, acquisizione di atti. Si è proceduto ad accertamenti trasversali
per violare il divieto di indagine in mancanza di autorizzazione a procedere al
fine di costruire una ipotesi accusatoria irrimediabilmente viziata perchè
costruita dalla sommatoria di una notizia di reato artefatta e da dati di
riscontro formati e selezionati per sorreggerla. Scendendo solo per un attimo
nel particolare ricordo che si è giunti persino a sequestrare il conto del mio
ufficio di Milano, amministrato dalla mia segretaria che è a tutt'oggi privata
della libertà. I giornali ne diedero subito grande notizia e grande risalto
gridarono nei titoli "Otto miliardi trovati sul conto della segretaria di
Craxi". In realtà quel conto in quel momento era praticamente in rosso, gli otto
miliardi riguardavano l'insieme dei movimenti che su quel conto erano stati
fatti negli anni precedenti. Si trattava delle spese generali dell'ufficio, di
rimborsi spese fatti a collaboratori, di contributi versati a Centri Culturali,
Centri politici sociali ed assistenziali, di spese elettorali e personali.
Entrate e spese documentabili e perfettamente legittime. Sta di fatto che in
questo modo si è andati a spulciare l'attività che era passata per quasi un
decennio attraverso il mio ufficio di Milano e la sua amministrazione, nella
perfetta consapevolezza che si trattava di attività politiche e personali
risalenti alla responsabilità di un Parlamentare contro il quale non si poteva
procedere. Del resto il "Lei conosce Craxi?","Quali rapporti ha avuto con
Craxi?","Dica che ha versato a Craxi" e ancora "Quale ruolo aveva Craxi","Chi
incontrava Craxi?" è una lunga litania che si è snodata a lungo ed
insistentemente attraverso gli interrogatori, di indagati ed anche di testi
scelti a bella posta tra le persone dichiaratamente e notoriamente ostili. Si è
così indagato su di me e sulla mia famiglia, sulle mie proprietà, e si è trovato
modo di indagare sui miei figli e sui miei parenti. Ma v'è qualcosa di più e di
ancor più grave. Contro il principio generale ed indiscusso, secondo cui la
magistratura può indagare su di un cittadino solo in presenza di una notizia di
reato che essa apprende direttamente ovvero attraverso denuncia, querela o
informativa di polizia giudiziaria, con riferimento alla vicenda che mi
riguarda, i pubblici ministeri milanesi hanno pervicacemente fatto ricerca di
una pretesa notizia di reato sulla quale poter costruire il teorema
evidentemente gia' prescelto. Siffatta metodologia di per se sola la dice lunga
sul fumus persecutionis. Già insito nella costruzione di una accusa
manifestamente infondata, esso è innegabile allorché, in un contesto
minatorio,come quello legato a scarcerazioni anche immediate di chi si fosse
reso disponibile a rendere le dichiarazioni desiderate dagli inquirenti,si
riesca nel tentativo o semplicemente si tenti di selezionare le notizie di reato
e di dotarle di un contenuto piuttosto che un altro. Se in tutto questo non è
ravvisabile neppure "l'ombra" di un intento persecutorio allora diciamo pure che
il fumus persecutionis è qualcosa di indefinibile,di inaccertabile, di
inavvistabile e cioè è un qualcosa che praticamente non esiste. Anche questo
naturalmente lo si può decidere per ragioni politiche le più diverse,ma non per
ragioni di verità e giustizia. Aggiungo che non saprei dire,almeno allo stato
delle cose,che uso sia stato fatto,e se sia stato fatto,delle intercettazioni
telefoniche e d'altri metodi d'ascolto. E' ben possibile che tutto sia
perfettamente regolare. Tuttavia non sono il solo ad aver avvertito la presenza
come di una "mano invisibile", irresponsabile,illegale, che, come spesso avviene
nelle situazioni confuse e traumatiche,si è mossa e si muove allo scopo di
intorbidire le acque e di rendere più agevole l'organizzazione e lo svolgimento
di manovre di varia natura. Sta comunque di fatto che una "mano invisibile" in
questi mesi trascorsi, simulando furti, ha provveduto a perquisire il mio
ufficio, uffici di mia moglie, di mio figlio, locali della famiglia della mia
segretaria , e, nella stessa notte, la casa dove abitava mia figlia a Milano ed
il suo ufficio di Roma. Il "fumus persecutionis" ritorna ancora ben visibile
quando l'indagine viene sistematicamente sottratta alla riservatezza ed al
segreto istruttorio e consegnata, attività per attività, e sempre con grande e
singolarissima tempestività e con dovizia di particolari e di indiscrezioni di
varia natura, all'informazione e alla stampa, dalla quale sono poi derivate
molto spesso ed in molteplici casi deformazioni e distorsioni di portata e di
genere vario e variopinto. Questo riguarda non solo i verbali degli
interrogatori, o spezzoni dei verbali, subito diffusi,quando contenevano
riferimenti ed accuse dirette e indirette contro di me. Riguarda persino le
deposizioni testimoniali, la cui lettura è vietata anche al difensore della
persona indagata, che, invece, in alcuni casi, sono state integralmente riferite
alla stampa e da questa puntualmente pubblicate. E così contro di me sono state
deliberatamente alimentate nei mesi scorsi violente campagne denigratorie, di
tale brutalità e di tale natura, da non avere precedenti almeno fino a quel
momento, in tutta la storia della Nazione. Ho retto le maggiori responsabilità
del Partito Socialista per sedici anni guidandolo in dieci campagne
elettorali,ed egualmente per un lungo periodo ho partecipato e ne ho sorretto le
responsabilità di governo. Delle attività della struttura nazionale del Partito
ivi comprese quelle amministrative mi sono assunto tutte le responsabilità
politiche e morali di fronte al Parlamento ed al Paese come era mio dovere di
fare ma ho respinto e torno a respingere accuse che considero assolutamente
infondate,pretestuose e strumentali ed una campagna di aggressione personale e
politica che tutti hanno potuto vedere e valutare. Le accuse partono dal
presupposto che il Segretario politico del PSI sia, non il "percettore
materiale", indicati questi nell'amministratore, in suoi collaboratori o
fiduciari, ma uno che, alla fine, leggo testualmente: "riceve". A tutte le
attività che vengono descritte,iniziali e finali, e rispetto alle quali vengono
elevate gravi imputazioni, il Segretario politico nazionale del Partito
Socialista non ha invece mai partecipato in nessuna forma,in nessuna forma né
diretta né indiretta è intervenuto e in tutti i casi citati, per favorire
l'appalto di lavori, l'assegnazione di forniture, l'acquisto di immobili e
quant'altro. Ad un certo punto venivano complessivamente elencati nelle accuse i
nomi di quarantuno imprenditori e dirigenti di società private con i quali avrei
concorso in azioni esecutive di disegni criminosi. Di questi quarantuno
imprenditori e dirigenti di aziende, 38 io non li ho mai nè visti nè conosciuti,
e con uno solo di loro ho intrattenuto nel tempo rapporti di amicizia. Vengono
poi elencate 44 società di diversi settori produttivi in favore delle quali io
sarei intervenuto in concorso di attuazione di disegni criminosi. Non sono mai
intervenuto, ed in tutti i casi citati,e in nessuna occasione, in favore di
nessuna di queste 44 società nè ho intrattenuto rapporti con alcuna di esse,i
loro uffici,le loro strutture e per nessuna ragione, nè, per questo motivo, con
i "pubblici ufficiali" citati anche se spesso non nominati. Rispetto alla mia
posizione i pubblici ministeri non hanno ricostruito fatti,ma solo presupposto
un teorema che hanno tentato di supportare con atti di indagine adempiuti
nell'ambito complessivo dell'intera inchiesta. Ma, in tutto l'insieme, non e'
stato neppure avvicinato il livello minimo della garanzia di fondatezza. La
sostanza delle accuse che mi vengono rivolte si basa solo su congetture e falsi
sillogismi. Soprattutto una serie di condotte e di miei comportamenti che il PM
si è preoccupato di evidenziare non raggiungono in nessun modo il livello della
rilevanza penale come attività di partecipazione e quindi non possono costituire
il fondamento di una responsabilità per concorso, ciò che rappresenta l'aspetto
essenziale dell'intera impostazione accusatoria. Dei reati per i quali e' stata
formulata richiesta di autorizzazione a procedere, io dovrei rispondere non
quale autore materiale,ma come concorrente alla stregua dell'art.110 c.p..
L'argomento merita approfondimento, perché, anche a volere tenere ferme le
coordinate in fatto postulate dal teorema che viene disegnato, la fattispecie
concorsuale non può dirsi realizzata in base a regole di buon senso, ancor prima
che giuridiche. La responsabilità penale a titolo di concorso, infatti,è
rigorosamente legata al principio della personalità di cui al comma 1
dell'art.27 Cost.. Dal lato del c.d. concorso morale,si ritiene principio
univocamente acquisito che non possa essere mai la mera posizione occupata da un
soggetto a determinarne il coinvolgimento: il presidente o l'amministratore
delegato di una S.p.A., il capo di una amministrazione pubblica, e via dicendo,
non possono rispondere penalmente del fatto degli altri organi o persone in cui
si articola l'organizzazione,nemmeno in materia contravvenzionale o colposa,
secondo l'insegnamento giurisdizionale comunemente ricevuto, quando siano
individuabili gli estremi della delega di funzioni. La tesi dei pubblici
ministeri, se fondata,dovrebbe di per sè sola infatti giustificare la
sistematica chiamata in causa di tanti altri segretari politici dei Partiti,
perchè secondo quella tesi, il Segretario politico di quel Partito, in ragione
della sua carica, sapeva o doveva supporre che finanziamenti illegali o
irregolari erano diventati una fonte consistente di sostegno economico dei
Partiti. Quando si tratta di impostare problemi di responsabilità penale, dunque
a titolo di concorso morale, per fattispecie di concussione, corruzione,
ricettazione od altro,rispetto alle quali l'impianto accusatorio individua in
altri, con sicurezza, l'autore materiale o comunque l'attuatore della condotta
tipica, è tecnicamente impossibile affermare che, stante la posizione di
Segretario politico del Partito e perciò solo, come sostanzialmente dichiarato
nella richiesta di autorizzazione a procedere, non possa che in maniera
automatica espandersi le responsabilità ai reati presupposti. La verità è che è
tecnicamente impraticabile ogni fattispecie concorsuale a mio carico per il
titolo morale immaginato dalla magistratura milanese. In punto di diritto
giurisprudenza, dottrina e prassi giuridica depongono univocamente in questa
direzione. Da essa gli organi giudiziari inquirenti si sono allontanati per
dimostrare una volta di più il fumus persecutionis coltivato nei miei confronti,
tenuto conto della mia posizione politica ed istituzionale. Prima di compiere il
tragico gesto di togliersi la vita Sergio Moroni, deputato socialista, ha
dichiarato: "E' indubbio che stiamo vivendo mesi che segneranno un cambiamento
radicale sul modo di essere del nostro Paese, della sua democrazia, delle
istituzioni che ne sono l'espressione. Al centro sta la crisi dei Partiti (di
tutti i Partiti) che devono modificare sostanza e natura del loro ruolo".
"Eppure non è giusto che ciò avvenga attraverso un processo sommario e violento
per cui la ruota della fortuna assegna a singoli il compito di vittime
sacrificali. Né mi è estranea la convinzione che forze oscure coltivino disegni
che nulla hanno a che fare con il rinnovamento e la "pulizia"". "Un grande velo
di ipocrisia condivisa da tutti ha coperto per lunghi anni i modi di vita dei
Partiti e i loro sistemi di finanziamento. C'è una cultura tutta italiana nel
definire regole e leggi che si sa non potranno essere rispettate, muovendo dalla
tacita intesa che insieme si definiranno solidarietà nel costruire le procedure
e i comportamenti che violano queste stesse regole". "Né mi pare giusto -
continua Moroni - che una vicenda tanto importante e delicata si consumi
quotidianamente sulla base di cronache giornalistiche e televisive, a cui è
consentito distruggere immagine e dignità personale di uomini solo riportando
dichiarazioni e affermazioni di altri. Mi rendo conto che esiste un diritto
all'informazione ma esistono anche i diritti delle persone e delle loro
famiglie". "A ciò si aggiunge la propensione allo sciacallaggio di soggetti
politici che, ricercando un utile meschino,dimenticano di essere stati per molti
versi protagonisti di un sistema rispetto al quale oggi si ergono a censori".
"Non credo che questo nostro Paese costruirà il futuro che si merita coltivando
un clima da "pogrom"nei confronti della classe politica, i cui limiti sono noti
ma che pure ha fatto dell'Italia uno dei Paesi più liberi". Quando Sergio Moroni
si uccise un magistrato inquirente sentenziò con parole ignobili: "Si può morire
anche di vergogna". Dopo aver letto alla Camera la sua lettera-testamento, il
Presidente rivolse a tutti un invito alla riflessione. Ebbene penso che questa
riflessione dovrebbe ricondurre direttamente ed essenzialmente al valore della
giustizia che deve essere rigorosa ma anche e sempre serena, equilibrata,
obiettiva, umana. Nel mio caso la Camera può concedere o negare l'autorizzazione
a procedere dopo aver accertato se nei miei confronti è stata violata una norma,
o sono state violate più norme che proteggono i miei diritti di parlamentare e i
miei diritti di cittadino. Mi auguro che gli onorevoli deputati vorranno farlo,
nel modo più franco e libero, con tutto il senso di giustizia di cui sono
capaci."
LE MANI SPORCHE DI MANI PULITE. SILVIO BERLUSCONI.
Silvio Berlusconi. Da Wikipedia,
l'enciclopedia libera. Silvio Berlusconi (Milano, 29 settembre 1936) è un
politico e imprenditore italiano, conosciuto anche come il Cavaliere,
soprannome assegnatogli dal giornalista sportivo Gianni Brera in ragione
dell'onorificenza a cavaliere del lavoro conferitagli nel 1977 dal presidente
della Repubblica Giovanni Leone e cui ha rinunciato nel 2014. Ha iniziato la sua
attività imprenditoriale nel campo dell'edilizia. Nel 1975 ha costituito la
società finanziaria Fininvest e nel 1993 la società di produzione multimediale
Mediaset. Nell'ottobre dello stesso anno scende in politica lanciando il
movimento politico di centro-destra Forza Italia, strutturatosi nel gennaio
successivo, confluito nel 2008 ne Il Popolo della Libertà e poi rifondato nel
2013. Eletto alla Camera dei Deputati nel marzo 1994, è stato confermato nelle
successive quattro legislature, mentre nella XVII, a seguito delle elezioni
politiche del 24 e 25 febbraio 2013, è stato eletto per la prima volta senatore
a Palazzo Madama. Ha ottenuto quattro incarichi da presidente del Consiglio: il
primo nella XII legislatura (1994), due consecutivi nella XIV (2001-2005 e
2005-2006); ed infine nella XVI (2008-2011). Con 3340 giorni complessivi nel
ruolo di presidente del Consiglio è il politico che è durato più a lungo nei
governi dell'Italia repubblicana, superato in epoche precedenti solo da Benito
Mussolini e Giovanni Giolitti; inoltre ha presieduto i due governi più duraturi
dalla proclamazione della Repubblica. Secondo la rivista americana Forbes,
con un patrimonio personale stimato in 7,6 miliardi di dollari USA (circa 6,7
miliardi di euro) Berlusconi è nel 2015 il quinto uomo più ricco d'Italia e il
179º più ricco del mondo. È stato imputato in oltre venti procedimenti
giudiziari. Il 1º agosto 2013 è stato condannato a quattro anni di reclusione
(con tre anni condonati dall'indulto del 2006) per frode fiscale con sentenza
passata in giudicato nel cosiddetto "processo Mediaset". Il 19 ottobre dello
stesso anno gli è stata irrogata la pena accessoria dell'interdizione ai
pubblici uffici per due anni a seguito dello stesso processo. A causa della
suddetta condanna il 27 novembre 2013 il Senato della Repubblica ha votato a
favore della sua decadenza dalla carica di senatore. Berlusconi ha quindi
cessato di essere un parlamentare dopo quasi vent'anni di presenza ininterrotta
nelle due camere.
Biografia. È il primogenito di una
famiglia della piccola borghesia milanese. Ha trascorso la sua infanzia nel
Basso Varesotto, in primo luogo a Saronno, poi a Lomazzo durante l'occupazione
tedesca mentre suo padre si era rifugiato in Svizzera. Il padre Luigi (Saronno,
1908 – Milano, 1989) era impiegato alla Banca Rasini della quale nel 1957
divenne procuratore generale; la madre Rosa Bossi (Milano, 1911 – 2008) era
casalinga e in precedenza aveva lavorato come segretaria alla Pirelli. Oltre a
Silvio dal loro matrimonio nacquero Maria Antonietta (Milano, 1943 – 2009) e
Paolo (Milano, 1949). Cresciuto nel quartiere Isola, in via Volturno, nel 1954
conseguì la maturità classica al liceo salesiano Sant'Ambrogio di Milano. Si
iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza presso l'Università Statale dove, nel
1961, si laureò con lode, discutendo una tesi in diritto commerciale con
relatore il professor Remo Franceschelli. La tesi, intitolata Il contratto di
pubblicità per inserzione, fu premiata con cinquecentomila lire dall'agenzia
pubblicitaria Manzoni di Milano. Dopo la laurea, non svolse il servizio
militare. Nel 1964 conobbe Carla Elvira Lucia Dall'Oglio (La Spezia, 1940), che
sposò il 6 marzo 1965 e dalla quale ebbe in seguito i figli: Maria Elvira detta
Marina (Milano, 10 agosto 1966) e Pier Silvio (Milano, 28 aprile 1969). Nel
1980, al Teatro Manzoni di Milano conobbe l'attrice Veronica Lario, nome d'arte
di Miriam Bartolini (Bologna, 1956), intraprendendo subito con lei una relazione
extraconiugale, facendola trasferire a vivere insieme alla madre di lei nella
sede operativa della Fininvest, presso villa Borletti di via Rovani a Milano.
Nel 1985 Berlusconi divorziò da Carla Dall'Oglio e ufficializzò la relazione con
Veronica, che sposò con rito civile nel 1990, dopo la nascita dei figli: Barbara
(1984), Eleonora (1986) e Luigi (1988). Il 2 maggio 2009 Veronica Lario ha
annunciato di voler chiedere la separazione. Nel dicembre 2012 la sentenza di
separazione non consensuale depositata al tribunale di Milano pone fine al
matrimonio con la Lario e fissa a 3 milioni di euro, l'assegno di mantenimento
che Berlusconi deve versarle mensilmente. Tuttavia, gli avvocati difensori del
Cavaliere presentano ricorso contro la decisione dei giudici sulla sentenza di
primo grado e tale richiesta, viene resa nota e formalizzata nel marzo 2013.
Nel 2012 Berlusconi si è fidanzato con Francesca Pascale, showgirl napoletana
classe 1984, tra le fondatrici del club "Silvio ci manchi" e candidata alle
elezioni provinciali del 2009 (anche se sin dal gennaio 2011 aveva dichiarato di
avere una nuova compagna, pur non rivelandone l'identità). Dal 1974 al 2013
Berlusconi ha avuto la sua residenza ufficiale ad Arcore, presso la
settecentesca Villa San Martino, acquistata da Annamaria Casati Stampa di
Soncino, figlia ed erede dello scomparso marchese Camillo per tramite
dell'avvocato Cesare Previti che sino alla emancipazione era stato suo tutore
legale. La villa, passata di mano insieme ad alcuni terreni circostanti per 750
milioni di Lire, fu nel 1983 accettata dalla Cariplo come garanzia per un
prestito di circa 7 miliardi di Lire. Dal settembre 2013 risiede ufficialmente a
Roma, presso Palazzo Grazioli, in Via del Plebiscito.
Attività imprenditoriale. Edilizia.
Dopo le prime saltuarie esperienze lavorative giovanili come cantante e
intrattenitore sulle navi da crociera insieme all'amico Fedele Confalonieri e
come venditore porta a porta di scope elettriche insieme all'amico Guido Possa,
iniziò l'attività di agente immobiliare e, nel 1961, fondò la Cantieri Riuniti
Milanesi Srl insieme al costruttore Pietro Canali. Il primo acquisto immobiliare
fu un terreno in via Alciati a Milano, per 190 milioni di lire, grazie alla
fideiussione del banchiere Carlo Rasini (titolare e cofondatore della Banca
Rasini, nella quale lavorava il padre di Silvio). Nel 1963 fonda la Edilnord
Sas, in cui è socio d'opera accomandatario, mentre Carlo Rasini e il
commercialista svizzero Carlo Rezzonico sono soci accomandanti. In
quest'azienda, Carlo Rezzonico fornisce i capitali attraverso la finanziaria
Finanzierungsgesellschaft für Residenzen AG di Lugano. Gli anonimi capitali
della finanziaria svizzera vengono in parte depositati presso l'International
Bank di Zurigo e pervengono alla Edilnord attraverso la Banca Rasini. Nel 1964,
l'azienda di Berlusconi apre un cantiere a Brugherio per edificare una città
modello da 4 000 abitanti. I primi condomìni sono pronti già nel 1965, ma non si
vendono con facilità. Nel 1968 nasce la Edilnord Sas di Lidia Borsani e C. (la
Borsani è cugina di Berlusconi), generalmente chiamata Edilnord 2, che acquista
712 000 m² di terreni nel comune di Segrate, dove sorgerà Milano Due, a seguito
alla dichiarazione del 1971 con cui il consiglio dei Lavori Pubblici dichiara
ufficialmente residenziale il suolo ed a seguito della concessione delle licenze
edilizie da parte del comune di Segrate. La vicenda con cui ottenne a Roma il
cambio di talune rotte aeree dell'aeroporto di Linate — le cui intollerabili
onde sonore, superiori a 100 decibel, rendevano arrischiato l'investimento e
difficoltosa la vendita degli appartamenti — fu ricostruita da Camilla Cederna
come frutto di un'intensa attività di lobbying presso i Ministeri
competenti. Nel 1972 viene liquidata la Edilnord e creata la Edilnord Centri
Residenziali Sas di Lidia Borsani, quest'ultima socia accomandante, con i
finanziamenti della Aktiengesellschaft für Immobilienlagen in Residenzzentren AG
di Lugano. Nel 1973 viene fondata la Italcantieri Srl, trasformata poi in SpA
nel 1975, con Silvio Berlusconi quale presidente. I capitali sono di due
fiduciarie svizzere e precisamente della Cofigen, legata al finanziere Tito
Tettamanti e alla Banca della Svizzera Italiana e della Eti AG Holding di
Chiasso, il cui amministratore delegato è Ercole Doninelli. Nel 1974 viene
costituita a Roma l'Immobiliare San Martino, amministrata da Marcello Dell'Utri
(amico di Berlusconi fin dagli anni universitari), con il finanziamento di due
fiduciarie della Banca Nazionale del Lavoro, la Servizio Italia Fiduciaria Spa e
la Società Azionaria Fiduciaria. Il 2 giugno 1977, a coronamento di questa ampia
e riuscita attività edilizia, Silvio Berlusconi viene nominato cavaliere del
lavoro dal presidente della Repubblica Giovanni Leone. Nel gennaio 1978, viene
liquidata la Edilnord per dare vita alla Milano 2 Spa, costituita a Segrate
dalla fusione con l'Immobiliare San Martino Spa. Televisioni. Dopo
l'esperienza in campo edilizio Berlusconi allarga il proprio raggio d'affari
anche al settore della comunicazione e dei media. Nel 1976, infatti, la sentenza
n. 202 della Corte costituzionale apre la strada all'esercizio dell'editoria
televisiva, fino ad allora appannaggio esclusivo dello Stato, anche ad emittenti
locali. Nel 1978, Berlusconi rileva Telemilano dal fondatore Giacomo Properzj.
Si tratta di una televisione via cavo, operante dall'autunno del 1974 nella zona
residenziale di Milano 2. A tale società due anni dopo viene dato il nome di
Canale 5 ed assume la forma di rete televisiva a livello nazionale, comprendente
più emittenti. Sempre nel 1978, Berlusconi fonda Fininvest, una holding che
coordina tutte le varie attività dell'imprenditore. Il canale nel 1981 trasmette
il Mundialito, un torneo di calcio fra nazionali sudamericane ed europee,
compresa quella italiana. Per tale evento, nonostante gli iniziali pareri
sfavorevoli da parte di ministri del governo Forlani, ottiene dalla RAI l'uso
del satellite e la diretta per la trasmissione in Lombardia, mentre nel resto
d'Italia l'evento viene trasmesso in differita. A partire dal 1981, Berlusconi
inizia ad utilizzare la propria rete di emittenti locali come se fosse un'unica
emittente nazionale: si registra con un giorno d'anticipo il palinsesto e le
pubblicità e li si trasmette il giorno seguente in contemporanea in tutta
Italia. Nel 1982 il gruppo si allarga con l'acquisto di Italia 1 dall'editore
Edilio Rusconi e di Rete 4 nel 1984 dal gruppo editoriale Arnoldo Mondadori
Editore (all'epoca controllato dall'editore Mario Formenton). Nel 1984 i pretori
di Torino, Pescara e Roma oscurano le reti Fininvest per violazione della legge
che proibiva alle reti private di trasmettere su scala nazionale. L'azione
giudiziaria viene fermata dopo pochi giorni dal governo guidato da Bettino Craxi
che con un apposito decreto legge legalizza la situazione della Fininvest. Il
gruppo Fininvest riesce perciò, seppur con strumenti non legali per la
legislazione di quegli anni, a spezzare l'allora monopolio televisivo RAI. Nel
1990 fu la Legge Mammì a stabilizzare le situazione presente rendendo
definitivamente legale la diffusione a livello nazionale di programmi
radiotelevisivi privati. Negli anni seguenti il gruppo si diffonde in Europa: in
Francia fonda, nel 1986, La Cinq (chiusa nel 1992), in Germania, nel 1987, Tele
5 (si legge Telefünf; chiuderà nel 1992, per poi riaprire nel 2002), in
Spagna Telecinco (fondata nel 1990 e ancora oggi attiva). Editoria e altri
media. Nel campo editoriale diventa, ed è, il principale editore italiano
nel settore libri e periodici; nel gennaio 1990 acquisisce la maggioranza
azionaria di Mondadori (in cui è confluita negli anni novanta la Silvio
Berlusconi Editore, fondata dal magnate milanese negli anni ottanta e attiva
nella stampa periodica, e che comprò TV Sorrisi e Canzoni) con una
manovra che causerà un contenzioso (vedi Lodo Mondadori) e la Giulio Einaudi
Editore (comprata dalla prima), e di alcune rilevanti case minori (Elemond,
Sperling & Kupfer, Grijalbo, Le Monnier, Pianeta scuola, Frassinelli, Electa
Napoli, Riccardo Ricciardi editore, Editrice Poseidona). Nel campo della
distribuzione audiovisiva, Berlusconi è stato socio dal 1994 al 2002, attraverso
Fininvest, di Blockbuster Italia. Controlla inoltre il gruppo Medusa Film. Nel
2007, Berlusconi, tramite Trefinance (una controllata del gruppo Fininvest), ha
finanziato OVO s.r.l., una media company il cui progetto è realizzare
un'enciclopedia video formata da centinaia di brevi clip di carattere
enciclopedico (storia, fisica, arte, letteratura, biografie, ecc.); uno dei
canali della stessa doveva chiamarsi OVOpedia. Il progetto, sebbene non fosse
ancora stato reso pubblico (il lancio era previsto nel primo trimestre del
2009), è stato accusato di revisionismo, perché sarebbe stato teso a
controbattere la storiografia dominante che secondo Berlusconi sarebbe
controllata dalla sinistra; la società è attualmente in liquidazione. Grande
distribuzione e assicurazioni. Berlusconi effettua anche investimenti nel
settore delle grandi distribuzioni, acquisendo il gruppo Standa dalla Montedison
nel 1988 e i Supermercati Brianzoli dalla famiglia Franchini nel 1991. Nel 1995
il gruppo Standa vende Euromercato al gruppo Promodès-GS. Nel 1998 scorpora e
vende il gruppo Standa; la parte "non alimentare" al gruppo Coin e la parte
"alimentare" a Gianfelice Franchini, ex proprietario dei Supermercati Brianzoli.
A tal proposito Berlusconi dichiarerà in seguito di esser stato costretto a
vendere la Standa successivamente alla sua entrata in politica, affermando che
in comuni gestiti da giunte di centrosinistra non gli concedevano le necessarie
autorizzazioni per aprire nuovi punti vendita. Secondo i critici di Berlusconi
l'acquisizione e la successiva vendita della Standa sarebbe stata determinata
dalla volontà di creare una liquidità per il gruppo Fininvest, che attraversava
un difficile periodo tra il 1990 e il 1994 (egli stesso aveva asserito di essere
esposto con le banche per una cifra in lire di diverse migliaia di miliardi). Il
Gruppo Fininvest, con le partecipazioni nelle società Mediolanum e Programma
Italia, ha una forte presenza anche nel settore delle assicurazioni e della
vendita di prodotti finanziari. Sport. Dopo un iniziale interessamento
all'acquisto dell'Inter, che secondo l'opinione di Sandro Mazzola, del direttore
sportivo Giancarlo Beltrami e dell'avvocato Prisco si concretizzò nel tentativo
di comprare la società prima da Fraizzoli nel 1978 e poi da Pellegrini nel 1986,
dal 20 febbraio 1986 Silvio Berlusconi è proprietario dell'Associazione Calcio
Milan, club calcistico del quale resse la presidenza dal giorno dell'acquisto
fino al 21 dicembre 2004, quando lasciò la carica a seguito dell'approvazione di
una legge disciplinante i conflitti d'interesse. Ha ricoperto di nuovo la carica
dal 15 giugno 2006 all'aprile 2008 quando è stato rieletto alla presidenza del
Consiglio dei ministri. Sotto la sua gestione il Milan si è laureato 8 volte
campione d'Italia, 5 volte campione d'Europa e 3 volte campione del mondo; ha
vinto inoltre 6 Supercoppe nazionali e 5 europee nonché una Coppa Italia, per un
totale di 28 trofei ufficiali in 28 anni. Nei primi anni novanta, Berlusconi
estese l'attività sportiva del Milan, cambiandone il nome in Athletic Club (per
mantenere l'acronimo) e trasformandolo in società polisportiva, costituita
comprando i titoli sportivi di società lombarde di varie discipline quali
baseball, rugby, hockey su ghiaccio, pallavolo, e acquistando per importi mai
visti in precedenza i migliori giocatori a disposizione. La polisportiva si
sciolse nel 1994, dopo la vittoria elettorale, e le squadre in essa accorpate
(Amatori Milano di rugby, Gonzaga Milano, già Mantova, di pallavolo, Devils
Milano di hockey e Milano Baseball) seguirono destini diversi.
Assetto societario. All'atto di entrare
in politica, Silvio Berlusconi ha lasciato tutte le cariche sociali che
ricopriva nelle sue imprese, rimanendo proprietario. Nel 2011 Forbes stima tutto
il patrimonio del Cavaliere in 7,8 miliardi di dollari americani, in calo
rispetto ai 9 miliardi del 2010. Questa stima è fatta tenendo conto che Silvio
Berlusconi risulta in possesso del 99,5% delle azioni della società Dolcedrago
S.p.A (il restante 0,5% è diviso in parti uguali tra i figli Marina e
Piersilvio). La Dolcedrago possiede e gestisce le principali proprietà
immobiliari di Berlusconi, tra cui la Villa San Martino ad Arcore, due ville a
Porto Rotondo (le confinanti Villa Certosa e Villa Stephanie), una a Macherio,
Lesa, Lesmo e alle Bermuda. La Dolcedrago S.p.A controlla anche le quote di
maggioranza di altre piccole e medie società immobiliari italiane e detiene il
totale controllo della Videodue S.r.l, società che gestisce i diritti di 106
film. Silvio Berlusconi possiede inoltre il 61% di Fininvest. La quota restante
è nelle mani dei cinque figli (7,65% a testa per Marina e Piersilvio e 7,143% a
testa a Barbara, Eleonora e Luigi). Fininvest controlla a sua volta Mediaset
(38%), Mondadori (50%), A.C. Milan (100%), Mediolanum (35%) e Teatro Manzoni
(100%). Intestati alla persona di Silvio Berlusconi risultano inoltre cinque
appartamenti a Milano (di cui uno in comproprietà), un terreno in Antigua e
Barbuda e tre imbarcazioni.
Attività politica. Le primissime prese
di posizione politiche di Berlusconi in pubblico risalgono al luglio 1977,
allorché sostenne la necessità che il Partito Comunista Italiano (che l'anno
precedente aveva superato il 34% dei voti) "rimanesse confinato all'opposizione
dall'azione di una Democrazia Cristiana trasformata in modo da recuperare al
governo il Partito Socialista Italiano", alla segreteria del quale era asceso
nel luglio del 1976 Bettino Craxi. L'incontro tra i due era stato propiziato a
metà anni settanta dall'uomo di fiducia di Craxi, l'architetto milanese Silvano
Larini. Craxi e il PSI mostreranno per tutti gli anni successivi una
significativa apertura verso le TV private, culminata con il varo del cosiddetto
"decreto Berlusconi" del 16 ottobre 1984 e con la sua reiterazione attraverso il
"Berlusconi bis" nel successivo 28 novembre. Nel corso degli anni ottanta e fino
al 1992, Berlusconi sosterrà sui suoi network con molteplici spot elettorali il
PSI e l'amico Bettino. Nel 1984, Craxi è padrino di battesimo di Barbara
Berlusconi. Nel 1990, alla celebrazione del matrimonio tra Veronica Lario e
Silvio Berlusconi, Anna Craxi (moglie del leader socialista) e Gianni Letta sono
i testimoni di nozze per la sposa, mentre Craxi e Fedele Confalonieri lo sono
per lo sposo. Come ulteriore testimonianza della vicinanza di Berlusconi a
Craxi, va ricordata la realizzazione di uno spot televisivo di ben 12 minuti,
girato dalla regista Sally Hunter e presentato nella primavera del 1992 per
essere trasmesso sulle emittenti di Berlusconi nel corso della campagna
elettorale, nel quale compare lo stesso Berlusconi vicino ad un pianoforte che,
commentando l'esperienza dei governi presieduti da Bettino Craxi (1983-1987),
dichiara: «Ma c'è un altro aspetto che mi sembra importante, ed è quello della
grande credibilità politica di quel governo. La grande credibilità politica sul
piano internazionale, che è - per chi da imprenditore opera sui mercati -
qualcosa che è necessario per poter svolgere un'azione positiva in ambienti
anche politici sempre molto difficili per noi italiani, e qualche volta
addirittura ostili». Infine, nell'ultimo periodo politico di Craxi (1993), in
occasione dell'ennesima richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dalla
magistratura contro l'ex leader socialista e respinta dalla Camera, Berlusconi
espresse pubblicamente la propria solidale soddisfazione. Nel novembre 1993, in
occasione delle elezioni comunali di Roma, intervistato all'uscita
dell'Euromercato di Casalecchio di Reno, auspicò la vittoria di Gianfranco Fini,
all'epoca segretario del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale, che
correva per la carica di sindaco contro Francesco Rutelli. Nell'inverno del
1993, in seguito al vuoto politico che si era formato dopo lo scandalo di
Tangentopoli, Berlusconi decide di scendere direttamente in prima persona
nell'arena politica italiana. Dall'esperienza dei club dell'Associazione
Nazionale Forza Italia, guidati da Giuliano Urbani e dalla diretta discesa in
campo di funzionari delle sue imprese, soprattutto di Publitalia '80, nasce così
il nuovo movimento politico Forza Italia, uno schieramento di centrodestra che,
nelle intenzioni, deve restituire una rappresentanza agli elettori moderati e
contrapporsi ai partiti di centrosinistra. E proprio il 26 gennaio 1994, giorno
della sua discesa, rilascia una dichiarazione preregistrata a tutte le
televisioni e in cui afferma la sua scelta con queste parole:« L'Italia
è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui
ho imparato da mio padre e dalla vita, il mio mestiere d'imprenditore. Qui ho
anche appreso, la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo, e di
occuparmi della cosa pubblica, perché non voglio vivere in un Paese illiberale
governato da forze immature, e da uomini legati a doppio filo, a un passato
politicamente ed economicamente fallimentare.» Allo stesso tempo
Berlusconi dà le dimissioni da alcuni incarichi di imprenditore presso il gruppo
da lui fondato (affidando la gestione ai figli o a persone di fiducia e
mantenendone la proprietà). L'eleggibilità di Berlusconi è anche oggetto di
dibattito, in relazione all'articolo 10 del D.P.R. n. 361 del 1957, secondo cui
«non sono eleggibili [...] coloro che [...] risultino vincolati con lo Stato
[...] per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità
economica». Nel luglio 1994 la Giunta per le elezioni (con la presenza di due
terzi dei deputati) respinge a maggioranza tre ricorsi che lamentavano
l'illegittimità dell'elezione di Berlusconi. La stessa questione verrà
ridiscussa nell'ottobre 1996 dalla Giunta per le elezioni che, a maggioranza,
delibererà di archiviare i reclami per "manifesta infondatezza". Sovvertendo le
previsioni espresse dai principali quotidiani nazionali, le elezioni politiche
del 27 marzo 1994 si concludono con la vittoria elettorale di Forza Italia in
corsa con la Lega Nord di Umberto Bossi nelle regioni settentrionali e l'MSI di
Gianfranco Fini nel resto d'Italia. Negli ultimi mesi di campagna elettorale,
alcuni fra i volti più famosi delle reti Fininvest dichiarano in televisione il
loro appoggio politico, all'interno dei programmi di intrattenimento da loro
condotti, scatenando reazioni che in seguito determineranno l'emanazione delle
regole per la cosiddetta par condicio elettorale. La prima esperienza di
governo di Silvio Berlusconi, avviata il 10 maggio 1994, ha però vita dura e
breve, e si conclude nel dicembre dello stesso anno, quando la Lega Nord ritira
l'appoggio al Governo e avvia una violenta campagna ai danni dell'ex alleato
Berlusconi, esplicitamente accusato di appartenere alla mafia. Il 22 dicembre
Berlusconi rassegna le proprie dimissioni al presidente della Repubblica Oscar
Luigi Scalfaro. Al suo posto viene formato un governo tecnico guidato dal
ministro del Tesoro uscente, Lamberto Dini. Berlusconi, che aveva chiesto invano
le elezioni anticipate, non sosterrà il nuovo governo. Negli anni successivi,
Berlusconi attribuirà la responsabilità della caduta del suo governo
all'inaffidabilità di Bossi. In seguito, anche per il riavvicinamento con la
Lega Nord in occasione delle elezioni politiche del 2001, accuserà la
magistratura e Scalfaro, il quale, secondo lo stesso Berlusconi, avrebbe indotto
Bossi a ritirare l'appoggio all'esecutivo, compiendo «un golpe». Le successive
elezioni sono vinte da L'Ulivo (con l'appoggio esterno di Rifondazione
Comunista), la coalizione di centrosinistra capeggiata da Romano Prodi.
Berlusconi guida l'opposizione di centrodestra fino al 2001. Durante la
legislatura collabora con Massimo D'Alema alla Bicamerale, che si occupa
principalmente di riforme costituzionali e giudiziarie (per approfondimenti si
veda la voce sulle riforme giudiziarie dell'Ulivo). Le elezioni del 2001 portano
alla vittoria la Casa delle Libertà, una coalizione capeggiata da Silvio
Berlusconi e comprendente, oltre a Forza Italia, i principali partiti di
centrodestra (inclusa la Lega Nord), mentre il centrosinistra si presenta
diviso. Durante la campagna elettorale Berlusconi sigla, presso la trasmissione
Porta a Porta di Bruno Vespa, il cosiddetto Contratto con gli italiani:
un accordo fra lui ed i suoi potenziali elettori in cui si impegna, in caso di
vittoria, a realizzare ingenti sgravi fiscali, il dimezzamento della
disoccupazione, l'avviamento di centinaia di opere pubbliche, l'aumento delle
pensioni minime e la riduzione del numero di reati; impegnandosi altresì a non
ricandidarsi alle successive elezioni nel caso in cui almeno quattro dei cinque
punti principali non fossero stati mantenuti. L'11 giugno Berlusconi viene per
la seconda volta nominato presidente del consiglio, dando inizio al Governo
Berlusconi II. Durante il secondo semestre del 2003 ricopre la carica di
presidente del Consiglio dell'Unione Europea in quanto capo del Governo
italiano. Dopo la pesante sconfitta della Casa delle Libertà alle elezioni
regionali del 2005, si apre una rapida crisi di governo: Berlusconi si dimette
il 20 aprile e dopo due giorni viene varato il Governo Berlusconi III che
ricalca in gran parte come composizione e azione politica il precedente Governo
Berlusconi II. Il periodo pre-elettorale è infiammato dalla pubblicazione di
sondaggi, commissionati prevalentemente dai quotidiani nazionali, che prevedono
una vittoria de L'Unione, la coalizione di centrosinistra formatasi a sostegno
della ricandidatura di Romano Prodi alla carica di capo del governo, con circa
il 5% di vantaggio rispetto alla Casa delle Libertà. Solo tre sondaggi elaborati
su commissione di Berlusconi da una società statunitense attribuiscono un lieve
vantaggio per la Casa delle Libertà. A marzo 2006, durante la visita ufficiale
negli Stati Uniti, è invitato a pronunciare un discorso ai due rami del
Congresso degli Stati Uniti riuniti in seduta comune, come era precedentemente
accaduto a De Gasperi, Craxi e Andreotti. Durante l'orazione, il presidente del
Consiglio ringrazia gli Stati Uniti per la liberazione dell'Italia, durante la
seconda guerra mondiale. Nel dicembre 2010 un documento dell'ambasciata
americana in Italia, risalente a pochi giorni prima dell'incontro con Bush
dell'ottobre 2005 e diffuso da WikiLeaks, ha rivelato che quell'intervento al
Congresso era stato esplicitamente chiesto fin dall'autunno da Berlusconi, per
fini di campagna elettorale, e che egli avrebbe puntato nella campagna
elettorale su una politica estera pro-USA contrapposta a quella europeista di
Prodi, soprattutto sulla questione irakena. Silvio Berlusconi e Romano Prodi si
incontrano in due dibattiti televisivi molto seguiti, andati in onda su Raiuno.
Berlusconi conclude il secondo dibattito il 3 aprile annunciando, a sorpresa, di
voler eliminare l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) sulla prima casa. Nei
giorni successivi, durante la trasmissione Radio anch'io su Radio Uno,
promette anche l'eliminazione della tassa sui rifiuti. L'esito delle elezioni
del 2006 è caratterizzato da una forte incertezza perdurata fino al termine
dello scrutinio delle schede e si risolve con una leggera prevalenza della
coalizione di centrosinistra capeggiata da Romano Prodi, che vince le elezioni.
Dopo l'esito del voto, Berlusconi inizialmente contesta il risultato delle
votazioni denunciando brogli e chiedendo il riconteggio dei voti.
Successivamente giudica l'esito un «sostanziale pareggio», e suggerisce di
formare un governo istituzionale di coalizione ispirato alla "Große Koalition"
tedesca, proposta però rifiutata dai partiti del centrosinistra e dalla Lega
Nord. Prodi viene quindi nominato presidente del consiglio sostenuto dalla
coalizione di centrosinistra. Le Giunte per le elezioni, attivatesi per il
riconteggio delle schede bianche e nulle, nel settembre 2007 confermeranno il
risultato elettorale. Tuttavia Berlusconi non riconoscerà la vittoria
dell'avversario. Nel novembre del 2006, annunciando dal palco di un convegno a
Montecatini Terme l'intenzione di "convincere tutte le forze politiche della
Casa delle libertà a fondersi in un unico grande partito della libertà", viene
colto da improvviso malore e conseguente breve perdita dei sensi. Dal 16 al 18
novembre 2007 Berlusconi ha organizzato una petizione popolare per richiedere
elezioni anticipate, con l'obiettivo di raccogliere almeno 5 milioni di firme.
Il risultato comunicato da Sandro Bondi è stato di 7.027.734, sebbene ci sia chi
ha avanzato dubbi sulla cifra e sulla verifica della regolarità delle adesioni
via Internet e via SMS. Con questa cifra alla mano, il 18 novembre durante un
comizio in piazza San Babila a Milano Berlusconi ha annunciato lo scioglimento
di Forza Italia e la nascita del Popolo della Libertà, un nuovo soggetto
politico contro i «parrucconi della politica», che fonderà insieme a Gianfranco
Fini. Il giorno successivo, in una conferenza stampa tenuta a Roma in Piazza di
Pietra ha sostenuto che «il bipolarismo […] nella presente situazione italiana,
con la frammentazione dei partiti che esiste, non è qualcosa che può funzionare
per il governo del Paese» e ha dichiarato la sua disponibilità a trattare per la
realizzazione di un sistema elettorale proporzionale puro con sbarramento alto
per evitare il frazionamento dei partiti. Berlusconi ha affermato che il nuovo
partito «intende rovesciare la piramide del potere» e che la scelta del nome,
dei valori, dei programmi, dei rappresentanti e del leader del nuovo soggetto
politico spetta ai cittadini e non alle segreterie. Una successiva petizione
popolare tenutasi il 1º e 2 dicembre 2007 ha stabilito, con il 63,14% delle
preferenze, che il nome di tale formazione politica fosse Il Popolo della
Libertà. Tale nome era già stato utilizzato per definire i partecipanti alla
manifestazione contro il Governo Prodi tenutasi il 2 dicembre 2006 che aveva
visto, secondo gli organizzatori, scendere in piazza 2.200.000 persone. Durante
la XV Legislatura Berlusconi come deputato è stato l'onorevole più assenteista:
4623 assenze su 4693 votazioni parlamentari. Il 14 aprile 2008 la coalizione
formata da Popolo della Libertà, Lega Nord e Movimento per l'Autonomia a
sostegno della candidatura di Silvio Berlusconi a presidente del consiglio ha
vinto le elezioni politiche con circa il 47% dei voti e ha ottenuto un'ampia
maggioranza in entrambi i rami del Parlamento. Il successivo 8 maggio, con il
giuramento nelle mani del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,
Berlusconi ha inaugurato il suo quarto governo. Il 30 agosto 2008 il leader
libico Muammar Gheddafi e Berlusconi hanno firmato un trattato di Amicizia e
Cooperazione nella città di Bengasi. Tale trattato offre una cornice di
partenariato tra i due paesi e comporta il pagamento da parte dell'Italia di 5
miliardi di dollari (tramite esborso di 250 milioni di dollari all'anno per 20
anni) alla Libia come compensazione per l'occupazione militare. In cambio, la
Libia prenderà misure per combattere l'immigrazione clandestina dalle sue coste,
e favorirà gli investimenti nelle aziende italiane. Il trattato è stato
ratificato dall'Italia il 6 febbraio 2009 e dalla Libia il 2 marzo, durante una
visita di Berlusconi a Tripoli. Il 29 marzo 2009 Silvio Berlusconi viene eletto
all'unanimità e per alzata di mano presidente del Popolo della Libertà. Il 3
febbraio 2010 il premier Silvio Berlusconi, durante la sua visita in Israele, ha
tenuto un discorso alla Knesset, il parlamento israeliano: era la prima volta
che un Presidente del Consiglio italiano parlava davanti al Parlamento
israeliano. Nel suo intervento, Berlusconi ha definito «un'infamia» le leggi
razziali del 1938 e ha assicurato che l'Italia guarda al popolo ebraico come a
«un fratello maggiore». La sera del 12 novembre 2011, dopo l'approvazione della
Legge di stabilità 2012 in entrambe le camere del Parlamento, Silvio Berlusconi,
come aveva precedentemente accordato con il capo dello Stato Giorgio Napolitano,
sale al Quirinale per rassegnare le dimissioni da presidente del consiglio dei
ministri e quelle del suo Governo, a causa della perdita della maggioranza
assoluta alla Camera dei deputati e della crisi economica del paese. Dal 16
novembre gli succederà il Governo Monti. Dopo aver presentato formalmente il
passaggio di consegne con quest'ultimo atto politico, Berlusconi partecipa come
deputato ad alcune iniziative parlamentari diradando però le sue uscite
pubbliche. Nel pomeriggio del 24 ottobre 2012 in un comunicato stampa ufficiale,
Berlusconi annuncia di non volersi ricandidare alla Presidenza del Consiglio,
dando il benestare alle primarie per la scelta del candidato premier del
centro-destra per il 16 dicembre. Tuttavia, nelle settimane successive si
rincorrono con sempre maggiore insistenza voci che danno Berlusconi pronto a
candidarsi nuovamente, suscitando reazioni contrapposte all'interno del mondo
politico. Il 6 dicembre 2012 il segretario del PdL Angelino Alfano annuncia la
candidatura di Berlusconi alle elezioni politiche del 2013, aggiungendo
contestualmente che non si terranno più le primarie del partito. Due giorni
dopo, è lo stesso Berlusconi a confermare la sua decisione di scendere
nuovamente in campo. Alle successive elezioni la coalizione di centro-destra
viene battuta da quella guidata da Pier Luigi Bersani con un scarto di soli 300
000 voti, mentre Berlusconi viene eletto per la prima volta come senatore. Dopo
la sconfitta incassata, seppur minima come distacco nelle politiche, e il
pesante tonfo uscito dalle urne nelle ultime amministrative, il 29 giugno 2013,
Berlusconi annuncia l'intenzione di rifondare Forza Italia come movimento
politico autonomo. Il 16 novembre il Consiglio Nazionale del partito ha poi
sancito la rinascita di Forza Italia. Il 1º agosto 2013 Berlusconi viene
condannato in via definitiva al terzo grado di giudizio dalla Cassazione nel
cosiddetto processo Mediaset, iniziato circa 8 anni prima, con l'accusa di frode
fiscale, disponendo tuttavia il rinvio alla Corte d'appello di Milano per la
rideterminazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Il
4 ottobre la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha
votato a favore della decadenza di Berlusconi da senatore per effetto della
legge n.235 del 31/12/2012, cosiddetta legge Severino. Il 19 ottobre la Corte
d'Appello condanna Berlusconi a due anni di interdizione dai pubblici uffici,
accogliendo le richieste dell'accusa e respingendo le tesi della difesa, che
dispone il ricorso in Cassazione. Si legge nelle motivazioni della sentenza che
l'evasione è aggravata dalla posizione pubblica che il leader del PdL occupa. Il
27 novembre 2013 il Senato convalida la decadenza da senatore di Berlusconi,
respingendo nove odg presentati da Forza Italia in contrapposizione alla
delibera della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato,
che si era espressa per la mancata convalida dell'elezione dell'ex premier a
senatore nella Circoscrizione Molise, per effetto del decreto legislativo n. 235
del 31 dicembre 2012 ("Legge Severino") Al suo posto andrà il primo dei non
eletti, Ulisse Di Giacomo, che ha aderito al Nuovo Centrodestra. Dopo la
decadenza da senatore, Berlusconi ha affermato di volersi candidare alle
Europee, ma il 18 marzo 2014 la Cassazione ha confermato l'interdizione di 2
anni dai pubblici uffici e, di conseguenza, la sua incandidabilità. Il 19 marzo
2014 si autosospende dalla carica di Cavaliere del Lavoro. Il 15 aprile 2014 il
Tribunale di sorveglianza di Milano, in esecuzione della condanna definitiva nel
processo Mediaset, dispone per Berlusconi l'affidamento in prova al servizio
sociale. L'esecuzione della pena ha termine il successivo 8 marzo 2015 e
Berlusconi riacquista la piena libertà, pur permanendo la sua incandidabilità
sino al 2019 per effetto della legge Severino.
Aspetti controversi dell'attività imprenditoriale.
Aspetti controversi dell'attività edilizia: i finanziamenti di origine
ignota. Per avviare la sua attività imprenditoriale nel 1961 nel campo
dell'edilizia Berlusconi ottenne una fideiussione dalla Banca Rasini, indicata
da Michele Sindona e in diversi documenti della magistratura come la principale
banca usata dalla mafia nel nord Italia per il riciclaggio di denaro sporco e
fra i cui clienti si potevano elencare Totò Riina, Bernardo Provenzano e Pippo
Calò. Nella società fondata da lui e Pietro Canali impegnò 30 milioni di lire,
provenienti, secondo quanto da lui affermato, dalla liquidazione anticipata di
suo padre Luigi, procuratore della Banca Rasini. Il resto venne da una
fideiussione fornita dalla stessa banca. Riguardo invece all'origine di alcuni
finanziamenti, provenienti da conti svizzeri alla Fininvest negli anni
1975-1978, dalla fondazione all'articolazione in 22 holding (i quali ammontavano
a 93,9 miliardi di lire dell'epoca) Berlusconi, interrogato in sede giudiziaria
dal pubblico ministero Antonio Ingroia, si avvalse della facoltà di non
rispondere; così, anche a causa delle leggi svizzere sul segreto bancario, non è
stato possibile accedere alle identità dei possessori dei conti cifrati inerenti
al flusso di capitali transitato all'epoca e in piena disponibilità della
Fininvest. Nell'agosto 1998 il quotidiano La Padania pubblicò un'inchiesta nella
quale si contestava a Berlusconi l'origine di diversi aumenti di capitale di
alcune società da lui possedute, avvenuti tra il 1968 ed il 1977. Al tempo in
cui Luigi Berlusconi era procuratore generale della Banca Rasini, questa entrò
in rapporti d'affari con la Cisalpina Overseas Nassau Bank, nel cui consiglio
d'amministrazione figuravano Roberto Calvi, Licio Gelli, Michele Sindona e
monsignor Paul Marcinkus, presidente dello IOR), di fatto la banca dello Stato
della Città del Vaticano. Tutti questi personaggi hanno poi avuto un grosso
rilievo nella cronaca giudiziaria. Secondo Sindona e alcuni collaboratori di
giustizia, la Banca Rasini era coinvolta nel riciclaggio di denaro di
provenienza mafiosa (il che spiegherebbe la grossa presenza di finanziatori
svizzeri nei primi anni di attività di Berlusconi). Nel 1999 Francesco
Giuffrida, vicedirettore della Banca d'Italia a Palermo, durante il processo
Dell'Utri, sostenne (in una consulenza da lui eseguita per conto della Procura
di Palermo riguardante la ricostruzione degli apporti finanziari intervenuti
alle origini del gruppo Fininvest tra gli anni 1975-1984) che non era possibile
identificare la provenienza di alcuni fondi Fininvest del valore di 113 miliardi
di lire dell'epoca, in contanti e assegni circolari (corrispondenti a circa
trecento milioni di euro odierni). La questione riguardava i sospetti di
presunti contributi di capitali mafiosi all'origine della Fininvest. Querelato
per diffamazione da Mediaset, nel 2007 Giuffrida giunse a un accordo transattivo
con i legali di questa, per il quale il consulente della Procura ha riconosciuto
i limiti delle conclusioni rassegnate nel proprio elaborato e delle
dichiarazioni fornite durante il processo (definite incomplete e parziali a
causa della scadenza dei termini di indagine, che non gli avevano permesso di
approfondire a sufficienza l'origine di otto transazioni dubbie) e la
dichiarazione conseguente che le «operazioni oggetto del suo esame consulenziale
erano tutte ricostruibili e tali da escludere l'apporto di capitali di
provenienza esterna al gruppo Fininvest». I legali di Giuffrida nel processo per
diffamazione hanno comunque rilasciato una dichiarazione, riportata dall'ANSA,
in cui sostengono di essere stati avvertiti solo pochi giorni prima (il 18
luglio) del fatto che i legali Mediaset avevano proposto una transazione al loro
assistito, di non condividere né quel primo documento ("una bozza di accordo che
gli stessi non hanno condiviso, ritenendo che quanto affermato nel documento non
corrispondesse alle reali acquisizioni processuali"), né la versione definitiva
leggermente corretta ("non sottoscriveranno non condividendo la ricostruzione
dei fatti e le affermazioni in esso contenute"). La perizia di Giuffrida era
stata ritenuta dai giudici già al tempo basata su "una parziale documentazione",
ma era stata ritenuta valida anche in virtù del fatto che non aveva "trovato
smentita dal consulente della difesa Dell'Utri", in quanto lo stesso professor
Paolo Iovenitti (perito della difesa), davanti alle conclusioni di Giuffrida,
aveva ammesso che alcune operazioni erano "potenzialmente non trasparenti" e non
aveva "fatto chiarezza sulla vicenda in esame, pur avendo il consulente della
difesa la disponibilità di tutta la documentazione esistente presso gli archivi
della Fininvest". Tale ritrattazione, contenuta nell'accordo transattivo
raggiunto dai legali Mediaset ed il professor Giuffrida a composizione della
controversia instaurata dalla Mediaset stessa per diffamazione, non consente
comunque di fare chiarezza sulla provenienza dei capitali del gruppo societario
facente capo a Silvio Berlusconi. Berlusconi, essendo iscritto alla loggia
massonica Propaganda 2 di Licio Gelli aveva accesso a finanziamenti altrimenti
inottenibili: la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2,
infatti, affermò, nella relazione di maggioranza firmata da Tina Anselmi, che
alcuni operatori appartenenti alla Loggia (tra cui Genghini, Fabbri e
Berlusconi), trovarono appoggi e finanziamenti presso le banche ai cui vertici
risultavano essere personaggi inclusi nelle liste P2 "al di là di ogni merito
creditizio". Il 1º febbraio 2010 Massimo Ciancimino ha raccontato, basandosi su
informazioni ricevute direttamente dal padre e su appunti dello stesso ritenuti
autentici dalla Polizia scientifica, che il generale dei carabinieri Mario Mori
e il colonnello Mauro Obinu, tra la fine degli anni settanta e gli inizi degli
anni ottanta, tramite Marcello Dell'Utri e i costruttori Antonino Buscemi e
Franco Bonura aveva investito soldi in Milano 2. Il 18 settembre Il Fatto
Quotidiano ha pubblicato un appunto di Vito Ciancimino con su scritto: "In piena
coscienza oggi posso affermare che sia io, che Marcello Dell'Utri ed anche
indirettamente Silvio Berlusconi siamo figli dello stesso sistema ma abbiamo
subito trattamenti diversi soltanto ed unicamente per motivi geografici".
Giovanni Scilabra, ex-direttore generale della Banca Popolare di Palermo, in
un'intervista ha affermato che Vito Ciancimino e Marcello Dell'Utri nel 1986 gli
chiesero un finanziamento di circa 20 miliardi di lire per Berlusconi. La
difesa: Le ipotesi di riciclaggio non hanno mai trovato conferma, anche a causa
del segreto bancario vigente in Svizzera. Stando alle dichiarazioni dello stesso
Silvio Berlusconi, fu la liquidazione del padre Luigi Berlusconi, divenuto poi
collaboratore del figlio all'Edilnord e in molti altri momenti cruciali della
sua vita imprenditoriale, che servì a finanziare gli inizi della sua attività
imprenditoriale e a costituire la metà del capitale dei Cantieri Riuniti
Milanesi. Silvio Berlusconi si definisce un "uomo che si è fatto da solo" perché
il suo successo - stando a queste dichiarazioni - si basa sulle sue "capacità
imprenditoriali", sul suo "fiuto per gli affari", sul suo "lavoro indefesso" e
su una serie di "fortuite circostanze", che gli avevano garantito la fiducia dei
vari finanziatori. Aspetti controversi delle attività nel campo televisivo.
La creazione di un gruppo di canali televisivi appariva di fatto in contrasto
con la legge in vigore e con le sentenze della Corte costituzionale che, sin dal
1960 (numero 59/1960), aveva mostrato il suo orientamento in materia. Un tema
ripreso anche dal più recente pronunciamento del 1981, dove veniva riaffermata
la mancanza di costituzionalità nell'ipotesi di permettere ad un soggetto
privato il controllo di una televisione nazionale, considerando questa
possibilità, visti gli spazi limitati a disposizione, come una lesione al
diritto di libertà di manifestazione del proprio pensiero, garantito
dall'articolo 21 della Costituzione. Tre pretori da Roma, Milano e Pescara
intervennero il 16 ottobre 1984, disponendo - in base al codice postale
dell'epoca - il sequestro nelle regioni di loro competenza del sistema che
permetteva la trasmissione simultanea nel Paese dei tre canali televisivi. In
conseguenza di ciò e per protesta, le emittenti Fininvest interessate dal
provvedimento apposero sul video un messaggio, rinunciando a trasmettere la
programmazione canonica. Dopo quattro giorni, il 20 ottobre 1984, il governo di
Bettino Craxi intervenne direttamente nella questione aperta dalla magistratura,
emanando un decreto legge in grado di rimettere in attività il gruppo. Ma il 28
novembre il Parlamento, invece di convertirlo in legge, lo rifiutò, giudicandolo
incostituzionale e permettendo alla magistratura di riprendere l'azione penale
contro Fininvest. Craxi varò quindi il 6 dicembre 1984 un nuovo decreto, ponendo
al Parlamento la questione di fiducia, che ottenne. La Corte Costituzionale
esaminò la legge solo tre anni dopo, mantenendola in vigore, ma sottolineandone
la dichiarata transitorietà. L'approvazione del provvedimento fu da alcuni
giustificata nella stretta e mai celata amicizia tra Bettino Craxi e Silvio
Berlusconi. Secondo altri, invece, il disegno di modernizzazione del Paese del
segretario socialista passava per lo scardinamento del monopolio culturale che -
attraverso la RAI - era esercitato dalla Democrazia Cristiana sulla
programmazione radiotelevisiva nazionale; l'oligopolio a cui si giunse, però,
probabilmente non corrispondeva alla ratio con cui la Corte
costituzionale nel 1976 (invocando l'articolo 21 della Costituzione) aveva
ammesso a latere della concessionaria pubblica un sistema plurale di
molteplici reti, distribuite sul territorio a livello esclusivamente locale. Il
rapporto con Craxi fu documentato nell'archivio dell'ex-presidente del
Consiglio, in cui fu trovata anche una lettera a firma di Berlusconi:« Caro
Bettino grazie di cuore per quello che hai fatto. So che non è stato facile e
che hai dovuto mettere sul tavolo la tua credibilità e la tua autorità. Spero di
avere il modo di contraccambiarti. Ho creduto giusto non inserire un riferimento
esplicito al tuo nome nei titoli-tv prima della ripresa per non esporti oltre
misura. Troveremo insieme al più presto il modo di fare qualcosa di meglio.
Ancora grazie, dal profondo del cuore. Con amicizia, tuo Silvio.» Nel
1990 con la legge Mammì si tornò a legiferare in materia e fu stabilito che non
si poteva essere proprietari di più di tre canali, non introducendo però limiti
che compromettessero l'estensione assunta dalle reti di Berlusconi.
L'approvazione della legge rinnovò forti polemiche e cinque ministri del VI
Governo Andreotti si dimisero per protesta. Berlusconi, essendo state decise
anche norme volte a impedire posizioni dominanti contemporaneamente
nell'editoria di quotidiani, venne costretto a cedere le proprie quote della
società editrice de Il Giornale, che vendette al fratello Paolo. Nel
1994, una nuova sentenza della Corte (la numero 420) dichiarò incostituzionale
parte della legge, richiamando la necessità di porre limiti più stretti nella
concentrazione di possedimenti in campo mediatico. Retequattro e il digitale
terrestre. Berlusconi continua ad operare nel settore televisivo (tramite
l'azienda Mediaset) con concessioni a valenza transitoria. La proprietà di
Mediaset da parte di Berlusconi ha suscitato notevoli polemiche a causa del
conflitto di interessi. Tale conflitto traspare per esempio nella gestione della
concessione di Retequattro. La situazione della rete televisiva è incerta dalla
fine degli anni ottanta, quando in seguito all'acquisto della Mondadori da parte
di Fininvest iniziò il dibattito sulla concentrazione dei mezzi di informazione.
La giurisprudenza si è pronunciata in più occasioni imponendo al canale di
migrare dal sistema analogico a quello satellitare. Le sue frequenze analogiche
sarebbero dovute passare a Europa 7, emittente televisiva di proprietà del
legittimo vincitore della gara d'appalto Francesco Di Stefano. Tale situazione
ha potuto perdurare ulteriormente, dopo che, grazie alla legge Gasparri,
Retequattro ha potuto continuare a trasmettere in chiaro fino al completo
passaggio al digitale terrestre di tutte le emittenti televisive nazionali e
locali. Tale sistema, permettendo la trasmissione di un maggior numero di
canali, ha consentito il superamento della limitatezza di frequenze, ma ha
lasciato irrisolta la questione legale. Anche in merito alla promozione
aggressiva del digitale terrestre da parte del secondo governo Berlusconi sono
state sollevate accuse analoghe, ed effettivamente Berlusconi non ha mai
partecipato a causa del conflitto di interessi alle votazioni su tale materia.
Tuttavia, un'inchiesta dell'Antitrust terminata nel 2006 non ha rilevato alcuna
violazione della legge sul conflitto di interessi.
Aspetti controversi dell'attività politica. Appartenenza alla
loggia massonica P2. L'iscrizione di Berlusconi alla
loggia massonica P2 avviene il 26 gennaio 1978 nella sede di via dei Condotti a
Roma, all'ultimo piano del palazzo che ospita il gioielliere Bulgari insieme a
Roberto Gervaso; la tessera è la n. 1816, codice E. 19.78, gruppo 17, fascicolo
0625, come risulta dai documenti e dalle ricevute sequestrate ai capi della
loggia. Berlusconi ha negato la sua partecipazione alla P2, ma ha ammesso in
tribunale di essere stato iscritto. Nell'autunno del 1988 (nel corso di un
processo contro due giornalisti accusati di averlo diffamato celebrato dal
tribunale di Verona), Berlusconi dichiarò: «Non ricordo la data esatta della mia
iscrizione alla P2, ricordo comunque che è di poco anteriore allo scandalo.
[...] Non ho mai pagato una quota di iscrizione, né mai mi è stata chiesta». Per
tali dichiarazioni il pretore di Verona Gabriele Nigro ha avviato nei confronti
di Berlusconi un procedimento per falsa testimonianza. Al termine il magistrato
veronese ha prosciolto in istruttoria l'imprenditore perché il fatto non
costituisce reato. Il sostituto procuratore generale Stefano Dragone ha però
successivamente impugnato il proscioglimento e la Corte d'appello di Venezia ha
avviato un nuovo procedimento in esito al quale ha stabilito che «Berlusconi,
deponendo davanti al Tribunale di Verona nella sua qualità di teste-parte
offesa, ha dichiarato il falso» ma che «il reato attribuito all'imputato va
dichiarato estinto per intervenuta amnistia». Successivamente dichiarò: "Non
sono mai stato piduista, mi mandarono la tessera e io la rispedii subito al
mittente: comunque i tribunali hanno stabilito che gli iscritti alla P2 non
commisero alcun reato, e quindi essere stato piduista non è titolo di demerito".
In altra occasione, ha affermato che la P2 "per la verità allora appariva come
una normalissima associazione, come se fosse un Rotary, un Lions, e non c'erano
motivi, per quello che se ne sapeva, per pensare che la cosa fosse diversa. Io
resistetti molto a dare la mia adesione, e poi lo feci perché Gervaso insistette
particolarmente dicendomi di rendere una cortesia personale a lui". Secondo le
risultanze della Commissione parlamentare d'inchiesta Anselmi la loggia
massonica era "eversiva". Essa fu sciolta con un'apposita legge, la n. 17 del 25
gennaio 1982. La P2 era "un'organizzazione che mirava a prendere il possesso
delle leve del potere in Italia attraverso il «piano di rinascita democratica»,
un elaborato a mezza via tra un manifesto e uno «studio di fattibilità».
Conteneva una sorta di ruolino di marcia per la penetrazione di esponenti della
loggia nei settori chiave dello Stato, indicazioni per l'avvio di opere di
selezionato proselitismo e anche un preventivo dei costi per l'acquisizione
delle funzioni vitali del potere". Il Piano programmava la dissoluzione dei
partiti e la costruzione di due poli organizzati in club territoriali e
settoriali; tendeva al monopolio dell'informazione, al controllo della banche,
alla Repubblica presidenziale e al controllo della magistratura da parte del
potere politico. Secondo il fondatore della P2 Licio Gelli, Berlusconi "ha preso
il nostro Piano di rinascita e lo ha copiato quasi tutto". Anche il vescovo di
Ivrea Luigi Bettazzi rimprovera al primo governo Berlusconi, al momento della
sua caduta (1995), di essere "l'attuazione fatta e programmata da Berlusconi del
Piano di rinascita democratica proposto dalla Loggia P2 già nel 1976". A partire
dal 1985, gli archivi di Gelli testimoniano l'intervento della P2
nell'acquisizione da parte di Berlusconi dell'allora più diffuso settimanale
popolare italiano, TV Sorrisi e Canzoni. La transazione, se vista come
una delle tante compiute all'interno della stessa intricata ragnatela di imprese
legate al sistema creditizio vaticano, risulta quasi solo un passaggio di
consegna per la realizzazione del programma. È il giugno del 1983 quando la
consociata all'estero Ambrosiano Group Banco Comercial di Managua cede a
Berlusconi il 52% del pacchetto azionario della rivista. A interessarsi
dell'affare sono i finanzieri Roberto Calvi e Umberto Ortolani. A seguito della
presentazione delle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla
P2, la loggia fu sciolta per legge in ragione dei «fini eversivi» che si
prefiggeva. Gelli fu condannato e arrestato, benché al riguardo ancora nel 1988
Berlusconi dichiarasse al Corriere della Sera di essere «sempre in
curiosa attesa di conoscere quali fatti o misfatti siano effettivamente
addebitati a Licio Gelli». Al momento del suo ingresso ufficiale in politica
(1993), Berlusconi presentò un partito la cui struttura e programma parvero ad
alcuni simili a quelle prefigurate nel disegno eversivo della P2: «Club dove
siano rappresentati... operatori imprenditoriali, esponenti delle professioni
liberali, pubblici amministratori» e solo «pochissimi e selezionati» politici di
professione. Il 25 gennaio 2006 la maggioranza parlamentare guidata da
Berlusconi, nell'ambito della riforma dei reati d'opinione, approvò una modifica
dell'articolo 283 del Codice Penale sulla base del quale era stata ritenuta
illecita la P2, riducendo la reclusione minima da 12 a 5 anni e ritenendo
necessari degli atti violenti. Il testo precedente era questo: Chiunque
commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del
Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è
punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.» (Articolo 283 c.p.
prima della novella legislativa del 2006). Il testo modificato è invece il
seguente: « Chiunque, con atti violenti, commette un
fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di
governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. » (Articolo 283
c.p. dopo la novella legislativa del 2006). Un conflitto di interessi
emerge in presenza di proprietari di imprese che vengono ad assumere cariche
pubbliche. La contemporanea proprietà di società di assicurazione, di colossi
dell'editoria, di imprese turistiche, e così via, acuisce questo problema nella
figura di Silvio Berlusconi. Conflitto di interessi. Secondo il
settimanale britannico The Economist, Berlusconi, nella sua doppia veste
di proprietario di Mediaset e Presidente del Consiglio, nel 2001 deteneva il
controllo di circa il 90% del panorama televisivo italiano. Questa percentuale
include sia le stazioni da lui direttamente controllate, sia quelle su cui il
suo controllo può essere esercitato in maniera indiretta attraverso la nomina (o
l'influenza sulla nomina) degli organismi dirigenti della televisione pubblica.
Questa tesi viene respinta da Berlusconi che nega di controllare la RAI
(malgrado l'apparente contenuto di varie intercettazioni, rivelate dalla stampa
nel luglio 2011, prefiguri un'azione di concerto, mirante a favorirlo, messa in
atto da una parte dei vertici RAI e Mediaset: la cosiddetta struttura riservata
"Delta"). Egli sottolinea il fatto che durante il suo governo siano stati
nominati presidente della RAI persone facenti riferimento al centrosinistra, in
primo luogo Lucia Annunziata. All'epoca del suo ultimo governo, il presidente
della RAI è stato Paolo Garimberti, di centrosinistra, mentre il ruolo di
direttore generale venne ricoperto da Lorenza Lei; attualmente tali incarichi,
dal luglio 2012 sono stati invece affidati rispettivamente ad Anna Maria
Tarantola e al manager Luigi Gubitosi, scelti e nominati dal Governo Monti. Il
vasto controllo sui media esercitato da Berlusconi è stato collegato da molti
osservatori italiani e stranieri alla possibilità che i media italiani siano
soggetti ad una reale limitazione delle libertà di espressione. L'Indagine
mondiale sulla libertà di stampa del 2004 (Freedom of the Press 2004
Global Survey), uno studio annuale pubblicato dall'organizzazione americana
Freedom House, ha retrocesso l'Italia dal grado di "Libera" (Free) a quello di
"Parzialmente libera" (Partly Free) sulla base di due principali ragioni, la
concentrazione di potere mediatico nelle mani del Presidente del consiglio
Berlusconi e della sua famiglia, e il crescente abuso di potere da parte del
governo nel controllo della televisione pubblica RAI. L'indagine dell'anno
successivo ha confermato questa situazione con l'aggravante di ulteriori perdite
di posizione in classifica. Reporter Senza Frontiere dichiara inoltre che nel
2004, «Il conflitto d'interessi che coinvolge il primo ministro Silvio
Berlusconi e il suo vasto impero mediatico non è ancora risolto e continua a
minacciare la pluralità d'informazione». Nell'aprile 2004, la Federazione
internazionale dei giornalisti si unisce alle critiche, obiettando al passaggio
della Legge Gasparri. Lo stesso Berlusconi, per rispondere alle critiche su un
suo conflitto di interessi, pochi giorni prima delle elezioni politiche del
2001, in un'intervista al Sunday Times annunciò di aver contattato tre
esperti stranieri («un americano, un britannico e un tedesco»"), di cui però non
fece i nomi, che lo consigliassero nel trovare una soluzione alla questione.
Pochi giorni dopo ribadì al TG5 la sua decisione, specificando che: «In cento
giorni farò quel che la sinistra non ha fatto in sei anni e mezzo: approverò un
disegno di legge che regolamenterà i rapporti tra il Presidente del Consiglio e
il gruppo che ha fondato da imprenditore», a cui fecero eco le parole del
presidente di AN Gianfranco Fini e di altri politici della CdL, i quali nei
giorni seguenti confermarono più volte che, in caso di vittoria alle elezioni,
l'intenzione del governo era quella di presentare entro i primi 100 giorni un
disegno di legge per risolvere la questione tramite un blind trust. Non vennero
mai resi noti i nomi dei tre esperti stranieri che si sarebbero dovuti occupare
della questione, ma venne presentato un disegno di legge, poi approvato, che
regolamentava il conflitto d'interesse. Il centrosinistra al governo dal 1996 al
2001, non era intervenuto invece sul tema del conflitto d'interessi. Il 28
febbraio 2002 Luciano Violante, allora capogruppo DS alla Camera, dichiarò in
Aula che il PDS aveva dato nel 1994 la «garanzia piena» a Berlusconi e Gianni
Letta «che non sarebbero state toccate le televisioni» con il cambio di governo.
Ricordò inoltre di quando la sua parte politica aveva votato per dichiarare
«eleggibile Berlusconi nonostante le concessioni» e il fatto che durante i
governi di centrosinistra il fatturato di Mediaset fosse aumentato di 25 volte.
Il 13 luglio 2004 il Parlamento Italiano varava la Legge n. 215, recante "Norme
in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", cosiddetta legge
Frattini. Tale legge riceveva in seguito le dure critiche della Commissione
di Venezia del Consiglio d'Europa. A tutt'oggi il conflitto di interessi non è
stato ancora risolto da nessun governo. Accuse di approvazione di leggi ad
personam. Con la locuzione legge ad personam si intende un
provvedimento legislativo creato di fatto ad hoc a scopi prettamente
personali e non erga omnes. Durante i governi presieduti da Berlusconi,
succedutisi dal 1994 in poi, il Parlamento ha varato alcuni provvedimenti
legislativi aspramente contestati dall'opposizione e da alcuni settori della
stampa i quali ritenevano che questi fossero stati emanati appositamente per
favorire la posizione dello stesso Berlusconi, per difenderlo dai processi in
cui era coinvolto direttamente o indirettamente o per difendere e/o rafforzare
il proprio patrimonio. Per gli avvocati e amici di Silvio Berlusconi, almeno i
provvedimenti in materia giudiziaria, «servono a dare maggiori garanzie ai
cittadini. Perché a nessun altro succeda quello che è accaduto a Silvio
Berlusconi» (Niccolò Ghedini), o comunque «per proteggersi. Se non fai la legge
ad personam vai dentro» ovvero «sono la risposta a una guerra ad
personam contro di lui» (Fedele Confalonieri). Quanto ai presunti benefici
per le imprese di famiglia, Marina Berlusconi, presidente di Mondadori e figlia
di Silvio, ha fatto notare come «se le leggi (...) sono sacrosante, che cosa si
vorrebbe, che le nostre aziende non le utilizzassero solo perché fanno capo alla
famiglia Berlusconi? Questo sì che è il vero conflitto di interesse, quello
all'incontrario». Durante la campagna elettorale del 2006, lo stesso Berlusconi
ha dichiarato che «una legge ad personam è quella che risulta essere
giusta solo per un singolo individuo e sbagliata per il resto della
popolazione», pertanto, a suo dire, «non c'è una sola legge di questo tipo
approvata dal mio governo». Secondo due inchieste de la Repubblica al 24
novembre 2009 le leggi «che hanno prodotto benefici effetti per Berlusconi e le
sue società» sarebbero state 19. Fra le leggi contestate, alcune avrebbero
fornito a Berlusconi immediati benefici su procedimenti penali in corso contro
di lui, altre gli avrebbero garantito vantaggi economici. Tra le prime rientrano
le seguenti: Legge sulle rogatorie internazionali (Legge n. 367/2001): limita
l'utilizzabilità delle prove acquisite. Con questa legge i movimenti illeciti
sui conti svizzeri effettuati da Cesare Previti e Renato Squillante, al centro
del processo Sme-Ariosto 1, sono stati coperti. Riforma del diritto societario
(D. Lgs. n. 61/2002): depenalizzazione del falso in bilancio che ha consentito a
Berlusconi di essere assolto nei processi "All Iberian 2" e "Sme-Ariosto 2"
perché "il fatto non è più previsto dalla legge come reato". Legge Cirami sul
legittimo sospetto (Legge n. 248/2002): introduzione del "legittimo sospetto"
sull'imparzialità del giudice che permette la ricusazione e il trasferimento del
processo ad un altro giudice. Lodo Schifani (Legge n. 140/2003): introduzione
del divieto di sottomissione a processo delle cinque più alte cariche dello
Stato tra le quali il presidente del Consiglio in carica. La legge è dichiarata
incostituzionale il 13 gennaio 2004. Fu riapprovato con qualche modifica nel
2008 (vedi punto 8). Segreto di Stato sull'area denominata “Villa La Certosa” di
Punta della Volpe (Olbia) (decreto del Ministro dell'Interno 6 maggio 2004 prot.
n. 1004/100 – 1158): l'apposizione del segreto di Stato sulla villa di
Berlusconi impedì le ispezioni disposte dal Tribunale di Tempio Pausania
nell'ambito di un'indagine penale per violazione delle normative in materia
edilizia ed ambientale. Legge Pecorella (Legge n. 46/2006), proposta dal
parlamentare Gaetano Pecorella, avvocato di Silvio Berlusconi, che sanciva
l'inappellabilità da parte del pubblico ministero per le sole sentenze di
proscioglimento (DL n. 3600), bocciata quasi integralmente nel 2007 dalla Corte
Costituzionale Legge ex-Cirielli (Legge n. 251/2005): riduzione della
prescrizione, che ha consentito l'estinzione dei processi "Lodo Mondadori",
"Lentini", "Diritti tv Mediaset" per decorrere dei tempi processuali. Lodo
Alfano (Legge n. 124/2008), riproposizione del Lodo Schifani, emanato poco prima
della conclusione del processo per corruzione dell'avvocato David Mills in cui
Berlusconi era coimputato. Dichiarato incostituzionale il 7 ottobre 2009.
Legittimo impedimento: per 18 mesi il Presidente del Consiglio è legittimamente
impedito a comparire in aula di tribunale se impegnato in attività di governo.
Tra le leggi che avrebbero dato vantaggi economici vengono citate le seguenti:
Tremonti bis (Legge n. 383/2001, art. 13): abolizione dell'imposta su
successioni e donazioni per grandi patrimoni, che in precedenza l'Ulivo aveva
abolita per patrimoni fino a 350 milioni di lire. Finanziaria 2003 (Legge n.
289/2002, art. 9): introduzione di un condono fiscale, di cui hanno beneficiato
anche le imprese del gruppo Mediaset. Decreto salva-calcio (Legge n. 27/2003,
art. 3): concessione alle società sportive della possibilità di diluire le
svalutazioni dei giocatori sui bilanci in un arco di dieci anni, con importanti
benefici economici in termini fiscali. La norma ha trovato applicazione anche
all'A.C. Milan. Lodo Retequattro (Decreto-legge n. 352/2003): ha permesso a Rete
4 di continuare a trasmettere in analogico. Finanziaria 2004 (Legge n. 350/2003,
art. 4, comma 153) e Finanziaria 2005 (Legge n. 311/2004, art. 1, comma 246):
introduzione di un incentivo statale all'acquisto di un decoder. A beneficiare
prevalentemente dell'incentivo è stata la società Solari.com, il principale
distributore in Italia dei decoder digitali Amstrad del tipo Mhp, controllata al
51% da Paolo e Alessia Berlusconi. Legge Gasparri (Legge n. 112/2004):
introduzione del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) e riordino del
sistema radiotelevisivo e delle comunicazioni. Nel 2004 il presidente di
Mediaset, Fedele Confalonieri, ha stimato i vantaggi derivanti dalla legge
Gasparri per il gruppo di Silvio Berlusconi fra 1 e 2 miliardi di Euro.
Estensione del condono edilizio alle zone protette (Legge n. 308/2004, art. 1
commi 36-39): ammissione delle zone protette tra le aree condonabili, comprese
quelle della villa "La Certosa" di proprietà di Berlusconi. Testo unico della
previdenza complementare (Decreto Legislativo n. 252/2005): introduzione di una
serie di norme che favoriscono fiscalmente la previdenza integrativa
individuale, a beneficio anche della società assicurative di proprietà della
famiglia Berlusconi. Decreto anticrisi (Decreto-legge n. 185/2008, art. 31):
abolizione dell'IVA agevolata del 10% sulla pay tv via satellite (dominata da
Sky Italia) che ritorna così all'aliquota standard del 20%. Tale operazione di
allineamento delle imposte era stata richiesta dalla Commissione europea in
seguito ad un reclamo presentato alla commissione stessa. L'iniziativa
legislativa ha suscitato nell'opposizione (principalmente per voce di Antonio di
Pietro) diverse polemiche poiché viene visto in questo provvedimento un modo per
penalizzare Sky Italia, principale concorrente privato di Mediaset. Acquisto
delle proprie azioni (Legge n. 33/2009, art. 7, commi 3-quater e 3-sexies):
viene aumentata la soglia di capitale (dal 3% al 5%) che gli azionisti con una
partecipazione superiore al 30% possono acquisire senza essere soggetti
all'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria; e viene
incrementato (dal 10% al 20%) il limite massimo previsto dall'art. 2357 cc. nei
confronti delle società per azioni in materia di acquisto di azioni proprie con
l'intento di prevedere strumenti di difesa delle società rispetto a possibili
manovre speculative (OPA). Scudo fiscale (Legge n. 102/2009, art. 13-bis):
permette, pagando un'imposta una tantum del 5%, di rimpatriare o
regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali frutto di evasione fiscale
detenute all'estero. Liti pendenti col fisco (Legge n. 73/2010): la Mondadori ha
utilizzato il provvedimento per chiudere un contenzioso col fisco pendente dal
1991 pagando 8 milioni e 653 000 euro al posto dei 173 milioni pretesi
dall'erario. Anche se non rientra nel novero delle leggi, possiamo citare a tal
proposito il ricorso del governo contro la legge della regione Sardegna al
divieto di costruire a meno di due chilometri dalle coste (ricorso n. 15/2005
alla legge regionale 8/2004) (che bloccava, tra l'altro, l'edificazione di
"Costa Turchese", insediamento di 250 000 m³ della Edilizia Alta Italia di
Marina Berlusconi).
Aspetti controversi delle modificazioni indotte nella società
civile. Il regista e drammaturgo Dario Fo, lo
scrittore Umberto Eco, il regista Nanni Moretti e il comico Beppe Grillo hanno
rilasciato pubbliche dichiarazioni circa le conseguenze che i valori veicolati
dai media di Berlusconi potrebbero avere, secondo la loro opinione, alla lunga
sulla stessa società civile, indirizzandone gusti e tendenze allo scopo di
favorire la sua parte politica. A questo proposito, Dario Franceschini, leader
del Partito Democratico, è arrivato a dire: le
italiane e agli italiani vorrei rivolgere una semplice domanda: fareste educare
i vostri figli da quest'uomo? Chi guida un Paese ha il dovere di dare il buon
esempio, di trasmettere valori positivi.» Secondo questa linea di
pensiero, la comparsa sulla scena politica di Berlusconi avrebbe causato
profonde mutazioni di costume nel tessuto civile del Paese e tra le sue diverse
componenti sociali. Essi sostengono che sarebbe improprio, in un sistema
democratico, esercitare al contempo azione di governo e di controllo su fonti di
informazione a causa dell'influenza che i mass media (tv, radio, stampa,
Internet) possono esercitare sulla società. L'opposizione ha chiesto invano a
Berlusconi di rinunciare alla proprietà dei mass media giudicando anomala una
simile concentrazione in mano al capo di una coalizione politica. La tesi di
tale denuncia è che in Italia ci sarebbe uno sbilanciamento mediatico, possibile
veicolo di orientamento dell'opinione pubblica attraverso metodi di propaganda
più o meno nascosta, e che guidare una coalizione politica e al contempo un
gruppo mediatico editoriale risulta contrario ai principi di equilibrio
stabiliti dalla Costituzione italiana; tali principi trovano concreta tutela
anche per mezzo dell'art. 10 DPR 30 marzo 1957 numero 361, ove si prevede la
«ineleggibilità di coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali
di società o imprese private risultano vincolati allo Stato per contratti di
opere o di somministrazioni oppure per concessioni o autorizzazioni
amministrative di notevole entità economica».
I rapporti con la mafia, Dell'Utri e Mangano.
Nella prima metà degli anni settanta la criminalità organizzata
di stanza a Milano organizzava numerosi sequestri di persona a scopo di
estorsione. In questo contesto, nel luglio 1974, tramite l'avvocato palermitano
Marcello Dell'Utri (all'epoca collaboratore di Berlusconi), Vittorio Mangano fu
«chiamato a svolgere la funzione di "garanzia e protezione", a tutela della
sicurezza del suo datore di lavoro e dei suoi più stretti familiari, in un
momento in cui si era deciso il trasferimento di Berlusconi nella tenuta di
Arcore, appena acquistata». Secondo i magistrati, dunque, Berlusconi «temeva che
i suoi familiari fossero oggetto di sequestri di persona», e perciò Dell'Utri si
adoperò «per l'assunzione di Vittorio Mangano presso la villa di Arcore (...)
quale “responsabile” (o “fattore” o “soprastante” che dir si voglia) e non come
mero “stalliere”, pur conoscendo lo spessore delinquenziale dello stesso Mangano
sin dai tempi di Palermo (ed, anzi, proprio per tale sua “qualità”), ottenendo
l'avallo compiaciuto di Stefano Bontate e Teresi Girolamo, all'epoca due degli
“uomini d'onore” più importanti di “cosa nostra” a Palermo». Inoltre «è certo
che ad Arcore rimase, per tutto il 1975, la famiglia del Mangano [composta da
moglie e figlie], il quale conservò ivi la sua residenza anagrafica ancora fino
al mese di ottobre del 1976. Risulta ancora che, in data 1º dicembre 1975,
Mangano, tratto nuovamente in arresto perché trovato in possesso di un coltello
di genere vietato, dichiarò di essere residente ad Arcore e il 6 dicembre 1975,
al momento in cui uscì dal carcere, elesse domicilio in via San Martino n. 42,
dove è ubicata la villa di Arcore». Al riguardo la Corte fa riferimento anche a
un'intervista a Dell'Utri pubblicata sul Corriere della Sera del 21 marzo
1994. Dal processo contro Dell'Utri non sono emersi elementi che «consentono di
datare con certezza» l'allontanamento di Mangano da Arcore, e tuttavia «è certo
che l'allontanamento avvenne in modo indolore per decisione (autonoma o
suggerita da Marcello Dell'Utri) presa da Silvio Berlusconi, il quale continuò
ad ospitare presso la propria villa la famiglia del Mangano e non risulta che
abbia in alcun modo indirizzato i sospetti degli investigatori sul suo
“fattore”, conservando ancora a distanza di molti anni le grate parole del
Mangano»; al contrario di Dell'Utri che «non ha mai interrotto i suoi rapporti
con il Mangano, pur essendo ben consapevole, alla luce delle sue stesse
ammissioni, della caratura criminale del personaggio». Il 26 maggio 1975 una
bomba esplose nella villa di Berlusconi in via Rovani a Milano, allora in
restauro, «provocando ingenti danni con lo sfondamento dei muri perimetrali e il
crollo del pianerottolo del primo piano». Secondo quanto testimoniato da Fedele
Confalonieri, subito dopo l'allontanamento di Mangano da Arcore, Berlusconi
aveva ricevuto delle lettere con minacce: «Proprio a causa di quelle minacce -
dichiarò Confalonieri -, Berlusconi prese la sua famiglia e la portò prima in
Svizzera; io mi ricordo che andammo anche a accompagnarlo con Marcello Dell'Utri
a Nyon, che è vicino a Ginevra. Credo che poi stettero lì un paio di settimane o
tre settimane e poi andarono nel sud della Spagna, a Marbella e stettero lì
qualche mese». Nelle indagini dell'epoca gli autori dell'attentato restarono
ignoti; «è risultato, invece, dal contenuto di conversazioni telefoniche
intercettate circa 11 anni dopo, in occasione di un secondo attentato commesso
in data 28 novembre 1986 ancora ai danni della stessa villa di via Rovani, che
da parte di Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri non vi fossero dubbi in
merito alla riconducibilità dell'attentato del 1975 proprio alla persona del
Mangano». Il secondo attentato creò danni unicamente alla cancellata esterna.
Berlusconi, intercettato, commentò l'esplosione al telefono con Dell'Utri
definendola scherzosamente una cosa «fatta con molto rispetto, quasi con affetto
(...) perché mi ha incrinato soltanto la parte inferiore della cancellata»,
aggiungendo che «secondo me, è come una rich... un altro manderebbe una lettera
o farebbe una telefonata: lui ha messo la bomba!». La conversazione prosegue,
anche con Confalonieri, con riferimenti all'attentato del 1975 e alla persona di
Mangano ritenuto appena scarcerato. L'intercettazione del 1986 per la
magistratura dimostra «adeguatamente come nessuno dei tre interlocutori nutrisse
alcun dubbio nel ricondurre alla persona di Mangano Vittorio la responsabilità
dell'attentato commesso ai danni della villa di via Rovani undici anni prima
(...). Malgrado non si nutrissero dubbi in merito al responsabile, nessuna utile
indicazione all'epoca dei fatti era stata offerta agli investigatori ma, al
contrario, si era deciso addirittura di non denunciare direttamente
l'attentato». L'attentato, invece, non è attribuibile a Mangano, che all'epoca
del fatto era detenuto. Esso è ascrivibile altresì (come risulta dalle
dichiarazioni di Antonino Galliano) alla mafia catanese, «evento che Totò Riina
aveva voluto furbescamente sfruttare per le ulteriori intimidazioni telefoniche
all'imprenditore ordinate a Mimmo Ganci e da costui effettuate poco tempo dopo
da Catania. Una volta raccordatosi con il suo sodale Santapaola di Catania, il
capo di “cosa nostra” aveva, come si suol dire, “preso in mano la situazione”
relativa a Berlusconi e Dell'Utri, che, come si è visto (per concorde
dichiarazione di Ganci, Anzelmo e Galliano), sarebbe stata sfruttata non
soltanto per fini prettamente estorsivi, ma anche per potere “agganciare”
politicamente l'on.le Bettino Craxi». Un rapporto della Criminalpol di Milano
(rapporto numero 0500/CAS/Criminalpol del 13 aprile 1981) notava che «l'aver
accertato attraverso la citata intercettazione telefonica (del 14 febbraio 1980
su l'utenza telefonica dell'Hotel Duca di York di Milano in uso a
Mangano, ndr) il contatto tra Mangano Vittorio, di cui è bene ricordare sempre
la sua particolare pericolosità criminale, e Dell'Utri Marcello ne consegue
necessariamente che anche la Inim spa e la Raca spa (società per le quali il
Dell'Utri svolge la propria attività), operanti in Milano, sono società
commerciali gestite anch'esse dalla mafia e di cui la mafia si serve per
riciclare il denaro sporco, provento di illeciti». Secondo la Corte, Dell'Utri
«“rappresentava” presso i mafiosi gli interessi del gruppo [Fininvest, ndr], per
conto di Silvio Berlusconi. «Era un manager dotato di altissima autonomia e di
capacità decisionali, non un qualunque sottoposto al quale non restava altro che
eseguire le decisioni del proprietario dell'azienda, in ipotesi impostegli. «È
significativo che egli, anziché astenersi dal trattare con la mafia (come la sua
autonomia decisionale dal proprietario ed il suo livello culturale avrebbero
potuto consentirgli, sempre nell'indimostrata ipotesi che fosse stato lo stesso
Berlusconi a chiederglielo), ha scelto, nella piena consapevolezza di tutte le
possibili conseguenze, di mediare tra gli interessi di “cosa nostra” e gli
interessi imprenditoriali di Berlusconi (un industriale, come si è visto,
disposto a pagare pur di stare tranquillo). «Dunque, Marcello Dell'Utri ha non
solo oggettivamente consentito a “cosa nostra” di percepire un vantaggio, ma
questo risultato si è potuto raggiungere grazie e solo grazie a lui». Il boss
mafioso Mangano, nuovamente in carcere dal 1995 in regime di 41 bis, morì nel
luglio 2000, pochi giorni dopo essere stato condannato all'ergastolo per duplice
omicidio. Dell'Utri commentò nell'aprile 2008 che Mangano era «un eroe, a suo
modo» perché «sarebbe uscito dal carcere con lauti premi se avesse accusato me e
il presidente Berlusconi», e dello stesso avviso si è il giorno dopo detto
Berlusconi. La procura di Palermo ha indagato su Silvio Berlusconi e su Marcello
Dell'Utri dal 2 gennaio 1996 per concorso esterno in associazione mafiosa e
riciclaggio di denaro. Nel 1997 la posizione di Berlusconi è stata archiviata al
termine delle indagini preliminari, che erano state prorogate per la massima
durata prevista dalla legge, mentre Dell'Utri è stato rinviato a giudizio. Nel
2004 Marcello Dell'Utri è stato condannato in primo grado a Palermo a 9 anni per
concorso esterno in associazione mafiosa, pena ridotta in appello a 7 anni,
avendo la Corte ritenuto che il fatto non sussiste limitatamente al periodo
successivo al 1992. Il 9 marzo 2012 la quinta sezione penale della Corte di
Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d'appello, accogliendo così il
ricorso della difesa avverso alla condanna a sette anni. Al processo di Marcello
Dell'Utri per concorso esterno in associazione mafiosa, la Cassazione ritiene
pienamente confermato l'incontro tra Berlusconi, Dell'Utri e i capimafia
Francesco Di Carlo, Stefano Bontate e Mimmo Teresi, testimoniato dallo stesso Di
Carlo, attualmente collaboratore di giustizia, e di cui ha parlato anche
Galliano, un altro collaboratore. L'incontro sarebbe avvenuto nel 1974 in foro
Bonaparte a Milano, dove venne presa la “contestuale decisione di far seguire
l'arrivo di Vittorio Mangano presso l'abitazione di Berlusconi in esecuzione
dell'accordo” per la protezione ad Arcore. La Corte parla “senza possibilità di
valide alternative di un accordo di natura protettiva e collaborativa raggiunto
da Berlusconi con la mafia per il tramite di Dell'Utri che, di quella
assunzione, è stato l'artefice grazie anche all'impegno specifico profuso da
Cinà”. Il 22 agosto 2013 l'ex boss Totò Riina di Cosa Nostra, in un dialogo
durante l'ora d'aria con il co-detenuto Alberto Lorusso ripreso dalle telecamere
del carcere di Opera, fa numerose dichiarazioni su Dell'Utri e Berlusconi,
rivelando che quest'ultimo dagli anni ottanta pagava il pizzo a Cosa Nostra per
ottenere in cambio dei favori reciproci e futuri, 250 milioni di lire ogni sei
mesi. Nel 2014 vennero pubblicate alcune conversazioni tra Emilio Fede ed il suo
personal trainer, Gaetano Ferri, segretamente registrate da quest'ultimo, in cui
l'ex direttore del TG4 rivela particolari importanti sui rapporti illeciti tra
Berlusconi e la mafia siciliana, veicolati attraverso Marcello Dell'Utri, che
faceva da tramite per Silvio. In questi dialoghi registrati Fede parla anche di
Flavio Briatore, che, secondo quanto risulta dalle registrazioni di Ferri,
sarebbe stato coinvolto anch'egli in una storia di mafia, ordinando l'assassinio
di un industriale di Cuneo.
I rapporti con il mondo dell'informazione. Dichiarazione contro
Biagi, Santoro e Luttazzi. Il 18 aprile 2002, durante
la visita di Stato a Sofia in Bulgaria Berlusconi, da circa un anno presidente
del consiglio rende un'assai discussa dichiarazione (soprannominata dai suoi
oppositori il "diktat bulgaro" o l'"editto di Sofia"):« L'uso
che Biagi, come si chiama quell'altro...?
Santoro, ma l'altro... Luttazzi,
hanno fatto della televisione pubblica, pagata coi soldi di tutti, è un uso
criminoso. E io credo che sia un preciso dovere da parte della nuova dirigenza
di non permettere più che questo avvenga.» I tre non vennero più chiamati
a condurre programmi in RAI: di fatto la nuova dirigenza RAI insediatasi
all'epoca del governo Berlusconi e da esso spronata a prendere provvedimenti,
espulse Biagi, Santoro e Luttazzi da tutte le programmazioni televisive. La
situazione perdurò fino al 2006 quando, in seguito ad azioni giudiziarie che li
hanno visti vincenti sulla dirigenza RAI, Biagi e Santoro hanno ripreso a
condurre programmi giornalistici. Dissapori con la TV pubblica.
Berlusconi ha sempre avuto rapporti contrastati con la televisione pubblica, da
lui spesso accusata di essere, se non totalmente schierata a sinistra, per gran
parte controllata dai partiti dell'opposizione (soprattutto Raitre, definita da
Berlusconi «una macchina da guerra contro il Presidente del Consiglio»). Questa
visione è ovviamente ribaltata secondo il punto di vista dei suoi oppositori che
lo accusano di averla pesantemente occupata nel periodo in cui è stato capo del
governo. È del 12 marzo 2006 (durante la campagna elettorale per le elezioni
politiche) la polemica, in occasione del programma di Raitre, In mezz'ora,
tra Berlusconi che accusava la conduttrice Lucia Annunziata di muoversi sulla
base di posizioni di pregiudizio nei suoi confronti e di aperta partigianeria in
appoggio della sinistra, e la giornalista stessa che gli rimproverava
l'incapacità di trattare con i giornalisti. Silvio Berlusconi lasciò lo studio
dopo 17 minuti. Il caso Saccà. Nel 2007 la procura di Napoli apre
un'inchiesta su Berlusconi (allora leader dell'opposizione) sospettato di aver
corrotto Agostino Saccà, direttore di Rai Fiction. Tra gli atti dell'inchiesta
c'è un'intercettazione telefonica tra i due imputati che viene pubblicata in
tutti i media quando l'indagine è ancora in corso. Nella telefonata si ascolta
Saccà esprimere una posizione di appassionato appoggio politico a Berlusconi e
di critica per il comportamento degli alleati. Berlusconi sollecita Saccà a
mandare in onda una trasmissione voluta da Umberto Bossi e Saccà si lamenta del
fatto che ci sono persone che hanno diffuso voci su questo accordo provocandogli
problemi. Berlusconi poi chiede a Saccà di dare una sistemazione in una
fiction ad una ragazza spiegando in modo molto esplicito che questo
servirebbe per uno scambio di favori con un senatore della maggioranza che lo
aiuterebbe a far cadere il governo. Saccà saluta esortando Berlusconi a
impadronirsi della maggioranza quanto prima possibile. Berlusconi ha sostenuto
in sua difesa: «Lo sanno tutti nel mondo dello spettacolo, in certe situazioni
in Rai si lavora soltanto se ti prostituisci oppure se sei di sinistra.[...]In
Rai non c'è nessuno che non sia stato raccomandato». L'indagine napoletana è
giunta a gennaio alla richiesta di rinvio a giudizio ma, prima che si aprisse il
processo, nel luglio 2008 gli avvocati di Berlusconi chiesero ed ottennero dal
GIP lo spostamento dell'indagine a Roma per incompetenza territoriale. Nel 2008
i pm romani nuovi titolari dell'inchiesta hanno chiesto l'archiviazione
dell'inchiesta e la distruzione delle intercettazioni argomentando che «Non c'è
alcuna certezza del "do ut des". Lo stretto legame tra l'onorevole Berlusconi e
Saccà, che emerge con evidenza dall'attività investigativa, era tale da
consentire al primo di effettuare segnalazioni al secondo senza dover promettere
o ottenere nulla in cambio».
Scandali di natura sessuale. Il caso Carfagna.
Nel quarto governo Berlusconi, l'onorevole Mara Carfagna, ex showgirl, è stata
scelta per ricoprire il ruolo di ministro delle Pari Opportunità. Secondo
numerose indiscrezioni, alcune intercettazioni telefoniche effettuate
nell'ambito di un'inchiesta per corruzione a carico di Berlusconi avrebbero
prodotto materiale non penalmente rilevante riguardante presunti favori sessuali
ottenuti dal Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi in cambio
dell'incarico da ministro. Oltre alla stampa estera, dell'esistenza delle
intercettazioni parlò Sabina Guzzanti durante una manifestazione politica e
successivamente il deputato PdL Paolo Guzzanti sul suo blog, ritenendo
esistessero «proporzionati motivi per temere che la signorina in questione
occupi il posto per motivi che esulano dalla valutazione delle sue capacità di
servitore dello Stato, sia pure apprendista». Le dichiarazioni sortirono una
citazione in sede civile per Sabina Guzzanti. Il caso Noemi. Il 28 aprile
2009, la moglie di Berlusconi, Veronica Lario, in un'e-mail all'ANSA espresse il
suo sdegno riguardo alla possibile scelta del marito di candidare giovani
ragazze di bella presenza, alcune delle quali senza esperienza politica, per le
vicine elezioni europee. Il 2 maggio seguente, dopo aver saputo che Berlusconi
si era recato alla festa del diciottesimo compleanno di Noemi Letizia (una
ragazza di Portici), ha poi affidato ad un avvocato l'incarico di presentare
richiesta di separazione dal marito. La Lario, a questo punto, ha fatto menzione
di una supposta abitudine del marito di frequentare minorenni: «Non posso stare
con un uomo che frequenta le minorenni», «...figure di vergini che si offrono al
drago per rincorrere il successo, la notorietà e la crescita economica», «Ho
cercato di aiutare mio marito, ho implorato coloro che gli stanno accanto di
fare altrettanto, come si farebbe con una persona che non sta bene. È stato
tutto inutile». Il 14 maggio il quotidiano La Repubblica pubblica un
articolo in cui mostra le molte contraddizioni e discordanze della versione di
Berlusconi concernente le sue frequentazioni con Noemi Letizia con le
dichiarazioni degli altri protagonisti della vicenda, chiedendo al Presidente
del Consiglio di rispondere a dieci domande, poi riformulate. Berlusconi non
ritiene opportuno rispondere a queste domande, e il 28 agosto dà mandato al suo
avvocato, Niccolò Ghedini, di intentare una causa civile di risarcimento contro
il quotidiano per il danno di immagine causatogli (lo stesso avviene
contestualmente anche nei confronti de L'Unità). Successivamente Berlusconi ha
parzialmente risposto alle 10 domande di Repubblica sul libro di Bruno Vespa
Donne di Cuori. Il 28 maggio Berlusconi giura sulla testa dei suoi figli di
non aver mai avuto relazioni "piccanti" con minorenni, e che se stesse mentendo
si dimetterebbe immediatamente. La questione è stata ampiamente trattata dalla
stampa estera (per esempio dai quotidiani britannici The Times,
Financial Times e dalla BBC). Scatti di Porto Rotondo. L'attenzione
dei giornali è stata in seguito attirata da numerose foto che il fotografo
Antonello Zappadu aveva scattato in diverse occasioni: alcune documentano una
vacanza del maggio 2008 nella residenza estiva di Berlusconi a Porto Rotondo e
vi appare l'allora primo ministro della Repubblica Ceca Mirek Topolanek in veste
adamitica: durante la festa si vedono giovani ragazze in bikini o in topless. Il
5 giugno 2009 il quotidiano spagnolo El País pubblica 5 delle 700 foto
della festa. La Procura di Roma, su segnalazione di Berlusconi, ha sequestrato
il materiale fotografico per violazione della privacy. Il caso D'Addario.
Nel luglio 2009 il giornale L'Espresso pubblica sul suo sito le
registrazioni audio ambientali degli incontri tra Silvio Berlusconi e l'escort
Patrizia D'Addario, effettuate da quest'ultima nell'ottobre 2008 a palazzo
Grazioli, residenza privata del capo di governo dell'epoca, e ancora depositate
dalla stessa persona presso la Procura di Bari che le ha secretate in plichi
sigillati collocati in una cassaforte blindata; sono state invece rese pubbliche
altre intercettazioni di tipo telefonico acquisite dalla procura nell'ambito del
procedimento giudiziario che intendeva far luce sui presunti favoritismi di
Berlusconi verso l'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini, concretizzàtisi poi
in incarichi, affari pubblici ed appalti in cambio di prestazioni di natura
sessuale da parte di ragazze appositamente reclutate e indotte alla
prostituzione. Poco dopo il Premier dichiarò: "Non sono un santo, spero lo
capiscano anche quelli di Repubblica". Al di là dell'interesse di natura
scandalistica, le vicende riguardanti i presunti rapporti extraconiugali di
Berlusconi con escort e giovani ragazze dello spettacolo hanno attirato
l'attenzione dell'opinione pubblica e di parte del mondo politico, in quanto
paiono essere in più punti intrecciate con la promessa di candidature politiche
nelle liste del PdL e affiliate (La Puglia prima di tutto) in occasione delle
elezioni europee e delle amministrative del giugno 2009. Il caso Ruby. A
novembre 2010 scoppia il cosiddetto "caso Ruby". La vicenda ruota attorno
all'allora minorenne marocchina Karima El Mahroug detta Ruby Rubacuori, fermata
per furto nel maggio 2010 a Milano. Accertata la minore età della ragazza, il
magistrato dispose l'affidamento secondo le normali procedure. Tuttavia, dopo
che Berlusconi ebbe telefonato in questura sostenendo che la giovane fosse la
nipote dell'allora presidente egiziano Hosni Mubarak (fatto poi dimostratosi
falso), la ragazza venne affidata al consigliere regionale PdL Nicole Minetti.
Ruby dichiarò di essere stata più volte ospite di Berlusconi presso la sua
residenza di Arcore e d'aver ricevuto denaro in tali occasioni. Ritenendo che
quel denaro fosse stato il compenso per prestazioni sessuali, a gennaio 2011 la
procura della Repubblica di Milano ha contestato a Berlusconi i reati di
concussione e prostituzione minorile. La vicenda ha avuto un grande clamore
anche sui media internazionali e ha acceso il dibattito all'interno
dell'opinione pubblica italiana. Il 24 giugno 2013 Berlusconi viene condannato
in primo grado a sette anni di reclusione per i reati di concussione per
costrizione e favoreggiamento della prostituzione minorile, nonché alla perpetua
interdizione dai pubblici uffici; tuttavia, al termine del processo d'appello,
con la sentenza del 18 luglio 2014, viene assolto dalla concussione perché il
fatto non sussiste e dalla prostituzione minorile perché il fatto non
costituisce reato. Le motivazioni della sentenza ufficializzeranno infatti
che nessuna prova è stata accertata sul fatto che Berlusconi avesse esercitato
un atteggiamento intimidatorio o quanto meno un'induzione indebita nei confronti
del responsabile della questura milanese affinché rilasciasse la minorenne
marocchina, né che fosse a conoscenza dell'età della ragazza all'epoca dei
rapporti sessuali.L'assoluzione diventa definitiva il successivo 10 marzo 2015
con la favorevole sentenza della Corte di Cassazione.
Dichiarazioni e comportamenti controversi.
In Italia e all'estero grande risalto mediatico hanno ricevuto alcune sue
dichiarazioni, battute di spirito e comportamenti irrituali che gli hanno dato
una fama di gaffeur, contribuendo nel contempo a caratterizzare la sua
immagine pubblica. Secondo Peter Weber questi episodi avrebbero contribuito a
far riemergere vecchi pregiudizi nei confronti della politica estera italiana
condotta con «ambizione e leggerezza». Nel settembre 2001, in seguito agli
attentati terroristici sferrati da al-Qa'ida agli Stati Uniti, dichiarò: «Noi
[occidentali] dobbiamo essere consapevoli della superiorità della nostra
civiltà, il nostro è un sistema che ha garantito il benessere, il rispetto dei
diritti umani e, a differenza dei paesi islamici, il rispetto dei diritti
religiosi e politici. Un sistema che ha come valore la comprensione delle
diversità e la tolleranza». L'affermazione suscitò le proteste di diverse
nazioni islamiche e della Lega araba. Nel 2003, particolarmente controversa fu
la polemica che al Parlamento europeo – in occasione del suo esordio come
presidente del Consiglio dell'UE – lo vide opposto all'eurodeputato socialista
tedesco Martin Schulz, che lo criticò per i suoi problemi giudiziari, per il suo
rapporto con l'informazione, e che lo accusò di avere un conflitto d'interessi.
Berlusconi replicò all'intervento dell'eurodeputato dicendo: «Signor Schulz, so
che in Italia c'è un produttore che sta facendo un film sui campi di
concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di kapò, lei sarebbe
perfetto». Alle critiche da parte di alcuni europarlamentari, Berlusconi rispose
rivolgendo un «turisti della democrazia» all'ala sinistra del Parlamento che lo
contestava. Il presidente Pat Cox lo invitò a scusarsi, ma Berlusconi replicò:
«Il signor Schulz mi ha offeso gravemente e personalmente, era solo una battuta
ironica e non la ritiro». Accettò poi di scusarsi con il popolo tedesco, ma non
con Schulz e l'Europarlamento. La controversia coinvolse anche il cancelliere
Schröder, che convocò l'ambasciatore italiano a Berlino spingendo il governo
italiano a fare lo stesso con quello tedesco a Roma. Successivamente Berlusconi
dichiarò che in Italia «girano da anni storielle sull'Olocausto» perché «gli
italiani sanno scherzare su tragedie come quella nel tentativo di superarle»,
provocando le proteste della comunità ebraica di Roma e dell'ANED. Qualche mese
dopo, gli procurò altre critiche dalla comunità israelita, unite a quelle di
alcuni familiari delle vittime dello squadrismo fascista, l'intervista concessa
al periodico britannico The Spectator in cui disse che Mussolini, a
differenza di Saddam Hussein, non avrebbe «mai ammazzato nessuno» e si sarebbe
limitato a mandare «la gente a fare vacanza al confino». Della stessa intervista
fu contestato anche il giudizio espresso sui giudici, definiti «mentalmente
disturbati», che spinse il presidente della Repubblica Ciampi ad intervenire in
difesa della magistratura. Ripercussioni sul piano diplomatico ci furono anche
in altre occasioni. Nel 2005, quando irritò il governo finlandese dicendo di
aver «rispolverato tutte le arti da playboy» con Tarja Halonen, capo di Stato
della nazione finnica, per fare in modo che ritirasse la candidatura di Helsinki
a sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare in favore di Parma, non
essendoci per lui «alcuna possibilità di confronto tra il culatello di Parma e
la renna affumicata». In seguito a quell'episodio la catena di pizzerie
Kotipizza chiamò "Pizza Berlusconi" la sua pizza alla renna affumicata. La pizza
vinse il primo premio dell'America's Plate International nel marzo 2008.
Nel 2006 contrariò il governo cinese dichiarando durante un comizio elettorale:
«Leggetevi il libro nero del comunismo e scoprirete che nella Cina di Mao i
comunisti non mangiavano i bambini, ma li bollivano per concimare i campi». Nel
febbraio 2009, Berlusconi affermò in un comizio: «Di me hanno detto di tutto i
signori della sinistra, [...] che sono come quel dittatore argentino che faceva
fuori i suoi oppositori portandoli in aereo con un pallone, poi apriva lo
sportello e diceva: C'è una bella giornata, andate fuori un po' a giocare. Fa
ridere ma è drammatico». Il Ministero degli esteri argentino convocò
l'ambasciatore italiano Stefano Ronca per esprimere «la profonda preoccupazione»
per le frasi dette sui cosiddetti voli della morte, per il governo
italiano si trattò di uno stravolgimento delle parole pronunciate dal Presidente
del Consiglio, un «finto caso». Sempre nel 2009, secondo indiscrezioni di un
tabloid inglese, durante un vertice di capi di governo dell'Unione Europa a
Bruxelles per discutere le questioni relative al cambiamento climatico in vista
del summit di Copenaghen, alla presenza di leader quali Gordon Brown, Brian
Cowen, Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, Berlusconi avrebbe scarabocchiato
disegnini di "mutande femminili nel corso della storia" sotto il titolo
"Mutandine da donna attraverso i secoli", passando i suoi bozzetti agli altri
premier affinché potessero apprezzarli, creando ilarità e imbarazzo fra i
presenti. Hanno suscitato clamore anche alcuni comportamenti scherzosi tenuti in
presenza di ministri e governanti stranieri. Nel 2002 fece discutere la foto di
gruppo dei ministri degli Esteri riuniti a Cáceres, in cui Berlusconi, titolare
ad interim della Farnesina, fu immortalato mentre faceva il gesto delle corna
alle spalle del suo omologo spagnolo per divertire un gruppo di boy-scout. Nel
2008, durante una conferenza stampa con il presidente russo uscente Vladimir
Putin, dopo che una giornalista pose a quest'ultimo una domanda sgradita circa
una sua presunta relazione extra-coniugale, Berlusconi mimò un mitra che le
sparava. Il gesto fu criticato dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana a
causa dei numerosi casi di giornalisti assassinati in Russia. La cronista
coinvolta successivamente puntualizzò: «Ho visto il gesto del vostro presidente
e so che scherza sempre. So che il gesto non avrà alcuna conseguenza». Lo stesso
anno, in seguito all'elezione dell'afro-americano Barack Obama alla presidenza
degli Stati Uniti, Berlusconi, durante una conferenza stampa congiunta con il
nuovo presidente russo Dmitrij Medvedev al Cremlino, affermò: «Ho detto a
Medvedev che Obama ha tutto per andare d'accordo con lui: è giovane, bello e
anche abbronzato». La frase suscitò polemiche poiché il termine "abbronzato" (in
inglese tanned o suntanned) è stato talvolta impiegato in maniera
dispregiativa nei confronti delle persone di colore. In seguito Berlusconi
affermò che la sua intenzione era quella di rivolgere ad Obama «una carineria
assoluta, un grande complimento», e definì «imbecilli» chi aveva criticato la
dichiarazione. I media internazionali diedero ampio risalto alla vicenda. Il 27
settembre 2009 tornò sull'argomento dicendo: «Vi porto i saluti di uno che si
chiama... uno abbronzato... Ah, Barack Obama. Voi non ci crederete, ma sono
andati a prendere il sole in spiaggia in due, perché è abbronzata anche la
moglie». L'anno successivo, durante la riunione del G20 a Londra, dopo la foto
di rito Berlusconi chiamò il presidente statunitense a voce alta attirando
l'attenzione della regina Elisabetta II che, giratasi per capire da dove e da
chi provenisse il richiamo, apparentemente irritata esclamò: «Che cos'è?
Ma perché deve urlare?» (What is it? Why
does he have to shout?). L'episodio ricevé
ampia eco mediatica da parte della stampa internazionale. Il giorno successivo
Buckingham Palace intervenne puntualizzando che la sovrana non era affatto
infastidita dall'irritualità del capo di governo italiano. In Italia hanno
sollevato polemiche alcune sue esternazioni rivolte agli avversari politici ed
alla magistratura. Nel 2006, in prossimità delle elezioni politiche che lo
avrebbero contrapposto al candidato del centro-sinistra Romano Prodi, durante un
discorso alla Confcommercio affermò: «Ho troppa stima dell'intelligenza degli
italiani per pensare che ci siano in giro così tanti coglioni che possano votare
contro i propri interessi». Definì inoltre la magistratura «il cancro del
paese». Due anni dopo, alla Confesercenti, ribadì lo stesso concetto definendo
«i giudici e i P.M. ideologizzati» una «metastasi della nostra democrazia».
L'ANM protestò per la dichiarazione temendo una delegittimazione dell'intera
categoria. Nel 2009, fu protagonista di uno scontro istituzionale con il
presidente della Repubblica Napolitano, che rifiutò di firmare il decreto legge
approvato dal Consiglio dei ministri che avrebbe vietato l'interruzione
dell'alimentazione e dell'idratazione artificiale di Eluana Englaro. Berlusconi,
contrariato dalla mancata firma, dichiarò: «si vogliono attribuire dei poteri
che secondo l'interpretazione mia e del governo non sono del capo dello Stato ma
semmai spettano al governo», quindi sollecitò una riforma della Costituzione, da
lui ritenuta necessaria «perché la Carta è una legge fatta molti anni fa sotto
l'influenza della fine di una dittatura e con la presenza al tavolo di forze
ideologizzate che hanno guardato alla Costituzione russa come a un modello da
cui prendere molte indicazioni». La dichiarazione fu accolta da diverse
polemiche a cui Berlusconi replicò: «Ho giurato sulla Costituzione. La rispetto.
È la prima legge alla base dello Stato. Non ho mai pensato di attaccarla», poi
aggiunse: «La Costituzione però non è un Moloch: può evolvere con i tempi», ma
ribadì: «Che i valori costituzionali abbiano guardato alla Carta dell'Unione
Sovietica è una realtà storica». Hanno suscitato generale sorpresa, in Italia
come all'estero, le affermazioni di Berlusconi in una conversazione del 13
luglio 2011, in cui definiva l'Italia un "paese di merda". Stando ad un articolo
de Il Fatto Quotidiano del 10 settembre 2011 nel parlamento italiano
girava voce di un'intercettazione in cui Berlusconi avrebbe etichettato Angela
Merkel con l'epiteto di «culona inchiavabile». L'intercettazione in oggetto non
è mai stata pubblicata, ma parte della stampa tedesca, tra cui il Financial
Times Deutschland e il Der Spiegel, ha dato ampio risalto alla
notizia e si sarebbe rischiato il richiamo dell'ambasciatore a Roma. In
occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio 2013 Berlusconi dichiarò
che «per tanti versi Mussolini aveva fatto bene ma il fatto delle leggi razziali
è stata la peggiore colpa», suscitando ampie critiche da parte delle comunità
ebraiche, dell'Anpi e di molti esponenti politici.
Procedimenti giudiziari a carico di Berlusconi.
Silvio Berlusconi è stato oggetto di numerosi procedimenti
penali, uno dei quali si è concluso con una sentenza definitiva di condanna
passata in giudicato il 1º agosto 2013 nel processo Mediaset; fino ad allora
nessuno dei procedimenti penali a suo carico si era concluso con una sentenza
definitiva di condanna, per via di assoluzioni, declaratorie di prescrizione e
depenalizzazioni dei reati contestati. Alcuni di questi procedimenti sono stati
archiviati in fase di indagine; a seguito di altri è stato instaurato un
processo nel quale Berlusconi è stato assolto. In altri processi, infine, sono
state pronunciate, in primo grado o in appello, sentenze di condanna per reati
quali corruzione giudiziaria, finanziamento illecito a partiti e falso in
bilancio. In alcuni casi, dopo un esito del primo o del secondo grado di
giudizio sfavorevole a Berlusconi, i procedimenti non si sono conclusi con una
sentenza di condanna: ciò grazie a sopravvenuta amnistia, al riconoscimento di
circostanze attenuanti che, influendo sulla determinazione della pena, hanno
comportato il sopravvenire della prescrizione oppure a nuove norme che hanno
modificato le pene e la struttura di taluni reati a lui contestati, come nel
caso del reato di falso in bilancio. Dette norme, approvate in Parlamento dalla
maggioranza di centro-destra mentre Silvio Berlusconi ricopriva la carica di
Presidente del consiglio, in taluni casi hanno imposto una valutazione di non
rilevanza penale di alcuni dei fatti contestati, poiché il fatto non è più
previsto dalla legge come reato; in altri casi la riduzione della pene prevista
per le fattispecie di reato contestate ha fatto sì che i termini di prescrizione
maturassero prima che fosse pronunciata sentenza definitiva. Di seguito viene
fornito uno schema delle sentenze.
Sentenze di condanna passate in giudicato:
Processo Mediaset, frode fiscale, falso in bilancio, appropriazione indebita,
creazione di fondi neri gestendo i diritti tv di Mediaset. Condannato in via
definitiva, con sentenza della Corte di Cassazione del 1 agosto 2013, a 4 anni
di reclusione, di cui 3 condonati per effetto dell'indulto disposto dalla legge
241 del 2006.
Sentenze di non doversi procedere passate in giudicato. Reati
estinti per prescrizione: Lodo Mondadori, corruzione
giudiziaria (attenuanti generiche); Bilanci Fininvest 1988-1992, falso in
bilancio e appropriazione indebita relativi ai bilanci Fininvest dal 1988 al
1992; All Iberian 1, 23 miliardi di lire di finanziamenti illeciti al PSI di
Bettino Craxi; Consolidato Fininvest, falso in bilancio; Caso Lentini, falso in
bilancio; Tangenti a David Mills, corruzione giudiziaria. Reati estinti per
intervenuta amnistia: Falsa testimonianza P2 (amnistia applicata in fase
dibattimentale); Terreni Macherio, imputazione per uno dei due falsi
in bilancio (amnistia applicata in seguito al condono fiscale del 1992).
Sentenze di assoluzione passate in giudicato.
Assoluzioni per intervenuta modifica della legge (il fatto non costituisce
più reato): All Iberian 2, falso in bilancio (stralciato in base alla
riforma degli illeciti penali ed amministrativi delle società commerciali decisa
col Dlgs 61/2002 emanato dal governo Berlusconi II); Sme-Ariosto
(falso in bilancio) (stralciato in base alla riforma degli illeciti penali ed
amministrativi delle società commerciali decisa col Dlgs 61/2002 emanato dal
governo Berlusconi II). Altre assoluzioni: Sme-Ariosto (capo A),
corruzione in atti giudiziari per due versamenti a Renato Squillante (assolto
per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste); Sme-Ariosto
(capo B), corruzione giudiziaria; Tangenti alla guardia di finanza (assolto per
non aver commesso il fatto, anche grazie alla falsa testimonianza dell'avvocato
David Mills); Telecinco (in Spagna), violazione della legge antitrust, frode
fiscale e reati vari (quali riciclaggio di denaro); Medusa cinematografica,
falso in bilancio (assolto in quanto per la sua ricchezza potrebbe non essere
stato al corrente dei fatti contestati); Terreni Macherio, imputazione per
appropriazione indebita, frode fiscale, e uno dei due falsi in bilancio;
Inchiesta Mediatrade di Milano, appropriazione indebita e frode fiscale,
Berlusconi insieme ad un socio occulto, l'egiziano Frank Agrama, si sarebbe
appropriato illegalmente di fondi della società; Inchiesta Mediatrade di Roma,
evasione fiscale e reati tributari compiuti negli anni 2004, 2005; Caso Ruby,
concussione e prostituzione minorile. Condannato in primo grado a 7 anni di
carcere e interdizione perpetua dai pubblici uffici, viene poi assolto con
formula piena in appello il giorno 18 luglio 2014 perché il fatto non sussiste
(concussione) e "perché il fatto non costituisce reato" (prostituzione
minorile).L'assoluzione diviene definitiva il giorno 10 marzo 2015 con la
sentenza favorevole della Corte di Cassazione.
Procedimenti archiviati: Spartizione
pubblicitaria Rai-Fininvest (archiviato per insufficienza di prove); Traffico di
droga; Tangenti fiscali pay TV; Stragi 1992-1993 (concorso in strage); Caso
Saccà, corruzione nei confronti di senatori per far cadere il governo Prodi;
Concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio (insieme a Marcello
Dell'Utri); Abuso d'ufficio, abuso nell'uso dei voli di Stato; Diffamazione
aggravata dall'uso del mezzo televisivo; Caso Trani, abuso d'ufficio;
Rivelazione di informazioni coperte da segreto istruttorio relative
all'inchiesta Bnl-Unipol. Il 7 marzo 2013 il Tribunale di Milano lo condanna a
un anno di reclusione e al risarcimento di 80 000 euro in solido col fratello
Paolo Berlusconi. Il 31 marzo 2014 la Seconda Corte d'Appello di Milano ha
dichiarato la prescrizione del reato, confermando il risarcimento di 80 000 euro
a Piero Fassino. Il ricorso alla Cassazione per il proscioglimento nel merito è
respinto ed il 30 marzo 2015 la Cassazione conferma la prescrizione.
Sentenze non passate in giudicato:
Procedimenti in corso: Corruzione e finanziamento illecito ai partiti,
Berlusconi è indagato con l'accusa di aver corrotto nel 2006, con 3 milioni di
euro, il senatore Sergio De Gregorio per favorire il suo passaggio tra le file
della Casa delle Libertà.
Su molti dei procedimenti giudiziari contro Berlusconi, alcuni dei quali ancora
in corso, c'è acceso dibattito tra i suoi sostenitori e i suoi detrattori.
Berlusconi ed i suoi sostenitori affermano che i processi relativi alla sua
attività imprenditoriale sarebbero cominciati dopo la sua "discesa in campo", ed
esclusivamente a scopo persecutorio nei suoi confronti. Sostengono che tali
processi, che ritengono basati su mere illazioni (spesso definite "teoremi")
prive di riscontro probatorio, siano stati istruiti nell'ambito di una
persecuzione giudiziaria orchestrata delle "toghe rosse", ossia da magistrati
vicini ai partiti e alle ideologie di sinistra (iscritti a Magistratura
democratica), che utilizzerebbero illegittimamente la giustizia a fini di lotta
politica. I critici di Berlusconi sostengono invece che i processi siano
iniziati prima della "discesa in campo" (e precisamente nel 1993), asserendo che
se non fosse entrato in politica sarebbe finito in bancarotta e probabilmente in
galera, e che, grazie alle cosiddette leggi ad personam varate dal suo
governo, avrebbe evitato di essere condannato. A questo proposito Fedele
Confalonieri dichiarò che se Berlusconi non fosse entrato in politica sarebbe
stato condannato o costretto al fallimento. I critici inoltre sottolineano che
svariate pronunce di proscioglimento non ne dichiarano l'assoluzione, ma la
sopravvenuta prescrizione del processo: affermano quindi che, se avesse voluto
che fosse riconosciuta la propria innocenza anche in tali processi, avrebbe
potuto rinunciare espressamente alla prescrizione. Riguardo alle accuse di
parzialità dei giudici, infine, essi osservano che Berlusconi, rispetto ad altri
imputati, abbia al contrario giovato del vedersi riconoscere dai giudici le
attenuanti generiche, anche se le attenuanti generiche, pur rimesse in toto alla
discrezionalità del giudice, vengono di regola concesse sempre a chi sia
incensurato, così come era incensurato Berlusconi sino al 1º agosto 2013. Silvio
Berlusconi ha più volte ribadito che le indagini hanno seguito la sua "discesa
in campo", e ha denunciato i magistrati milanesi, presso la procura di Brescia,
per il reato di «attentato ad organo costituzionale»; la denuncia è stata
archiviata, e nelle motivazioni si legge: « Risulta
dall'esame degli atti che, contrariamente a quanto si desume dalle
prospettazioni del denunciante, le iniziative giudiziarie [...] avevano
preceduto e non seguito la decisione di "scendere in campo" (Carlo Bianchetti,
giudice per le udienze preliminari di Brescia, ordinanza di archiviazione della
denuncia, 15 maggio 2001).»
Le aggressioni. Il 31 dicembre 2004, in
piazza Navona a Roma, Silvio Berlusconi venne colpito con un treppiede da
macchina fotografica da Roberto Dal Bosco, un giovane muratore di Marmirolo.
Dopo essere stato diciannove ore in arresto, Dal Bosco fu scarcerato e inviò le
sue scuse al primo ministro italiano che decise di non sporgere denuncia. Il
comitato "L'altrainformazione" e il senatore Mario Luzi ipotizzarono, in
seguito, una possibile strumentalizzazione di Silvio Berlusconi dell'aggressione
subita. Il 13 dicembre 2009, dopo un comizio in piazza del Duomo a Milano,
Silvio Berlusconi venne colpito al volto con una riproduzione del duomo,
lanciatagli da distanza ravvicinata, riportando diverse ferite al volto, nonché
la frattura del setto nasale e di due denti dell'arcata superiore. L'aggressore,
incensurato e precedentemente in cura per problemi psichici, fu subito arrestato
e, in seguito, messo agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica; il 29
giugno 2010 fu assolto perché incapace di intendere e di volere.
I Riconoscimenti. Il 23 settembre 2003,
a New York, gli è stato consegnato il premio "Statista dell'anno" dalla
Anti-Defamation League, l'organizzazione ebraica che combatte
l'antisemitismo nel mondo. Il 2 marzo 2006, negli Stati Uniti d'America, durante
l'annuale celebrazione del "saluto alla Libertà", la Intrepid Foundation, ente
privato statunitense, lo ha insignito del premio Libertà Intrepid 2006 per «la
coraggiosa leadership contro il terrorismo». Il 27 settembre 2006 gli viene
riconosciuto il premio "Madonnina d'oro" offerto dalla Comunità Incontro di Don
Gelmini per il contributo personale dato alla ricostruzione di una scuola in
Thailandia, dopo lo tsunami, e per l'ampliamento di un ospedale in Bolivia.
Laurea honoris causa in ingegneria gestionale dall'Università della Calabria
— 27 novembre 1991. Onorificenze. Onorificenze italiane: Cavaliere del
lavoro «Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei
voti, decise di dar vita ad una attività indipendente nel settore dell'industria
edile fondando la Società "Cantieri Riuniti Milanesi S.p.A.". Nel 1963 ha
costituito la Società "Edilnord" che ha realizzato, tra l'altro, in provincia di
Milano, un centro per quattromila abitanti, il primo in Lombardia dotato di
centro commerciale, centro sportivo, campi di giuoco, scuole materne ed
elementari. Dal 1969 al 1975, in applicazione di una nuova concezione
urbanistica, Silvio Berlusconi ha realizzato la costruzione di "Milano 2", una
città per diecimila abitanti contigua a Milano, dotata di tutte le più moderne
attrezzature pubbliche e sociali, la prima unità urbana in Italia con tre
circuiti differenziali per auto, ciclisti e pedoni. È Presidente e Direttore
Generale della Edilnord progetti S.p.A. e Presidente della Fininvest S.p.A.» — 2
giugno 1977 (autosospeso il 19 marzo 2014); Cavaliere di Gran Croce di merito
con Placca d'Oro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio — 14
marzo 2003. Onorificenze straniere: Membro di I Classe dell'Ordine del Re
Abd al-Aziz (Arabia Saudita)— Jeddah, 22 novembre 2009; Cavaliere di I Classe
dell'Ordine della Stara Planina (Bulgaria) — 2009; Grand'Ufficiale dell'Ordine
delle Tre Stelle (Lettonia)— 2005; Compagno d'Onore Onorario dell'Ordine
Nazionale al Merito (Malta)— 20 gennaio 2004; Cavaliere di Gran Croce
dell'Ordine Reale Norvegese al Merito (Norvegia)— 2001; Gran Croce dell'Ordine
al Merito della Repubblica di Polonia (Polonia)— 2002; Cavaliere di Gran Croce
dell'Ordine della Stella di Romania (Romania)— 2002; Cavaliere dell'Ordine Piano
(Santa Sede — 2005).
La figura di Silvio Berlusconi è stata rivisitata molto spesso in opere nella
cultura di massa da cineasti, cantanti, fumettisti e letterati.
Berlusconi, vent’anni di rapporti con la magistratura. Dalle
«toghe rosse» ai ringraziamenti per i giudici della Cassazione che hanno
confermato l’assoluzione nel processo Ruby. Dal 22
novembre 1994 - data in cui Berlusconi, capo del governo, riceve un invito a
comparire dalla Procura di Milano che sta indagando sulle tangenti alla Guardia
di finanza - fino a oggi, sono stati altalenanti e spesso conflittuali i
rapporti del leader di Forza Italia con la magistratura, scrive “Il Corriere
della Sera”.
1. Il pool «Mani Pulite» e l’avviso di garanzia del 1994.
Il primo interessamento della giustizia nei confronti di
Berlusconi risale al 1983 quando la Guardia di finanza segnalò un suo presunto
coinvolgimento in un traffico di droga con la Sicilia. L’inchiesta venne
archiviata. La prima condanna, invece, è del 1990: la Corte d’appello di
Venezia, dichiara Berlusconi colpevole di aver giurato il falso davanti ai
giudici, a proposito della sua iscrizione alla lista P2. Nel settembre 1988,
infatti, in un processo per diffamazione da lui intentato contro alcuni
giornalisti, Berlusconi aveva dichiarato al giudice: «Non ricordo la data esatta
della mia iscrizione alla P2, ricordo che è di poco anteriore allo scandalo».
Nonostante la Corte d’appello di Venezia dichiari Berlusconi colpevole (il
giudice era Luigi Lanza), il reato è considerato estinto per l’amnistia del
1989. Il 22 novembre del 1994 Berlusconi, capo del governo, mentre presiede la
Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla criminalità transnazionale, riceve
un invito a comparire dalla Procura di Milano che stava indagando sulle tangenti
alla Guardia di finanza. Le tangenti servivano per alleggerire le verifiche alle
società Mondadori, Mediolanum, Videotime, Telepiù: in primo grado Berlusconi è
stato condannato a 2 anni e 9 mesi; in appello, grazie alle attenuanti
generiche, è scattata la prescrizione.
2. All Iberian, dalle accuse alla prescrizione.
Il 12 luglio 1996 Silvio Berlusconi, l’ex segretario del Psi
Bettino Craxi, l’amministratore delegato di Mediaset Ubaldo Livolsi vengono
rinviati a giudizio con altre nove persone per l’ inchiesta sul presunto
finanziamento illecito della Fininvest, attraverso la società All Iberian, al
Psi nel 1991. Il processo inizia il 21 novembre 1996 davanti ai giudici della
seconda sezione penale del tribunale di Milano. Il pm Francesco Greco chiede per
Berlusconi 5 anni e 6 mesi di reclusione e 12 miliardi di multa poi, dopo lo
stralcio del reato di falso in bilancio, riformula la richiesta in due anni e
mezzo di reclusione e 12 miliardi di multa. Nel 1998 Berlusconi viene condannato
in primo grado (2 anni e 4 mesi). «I giudici hanno riscritto il codice penale
per allineare le norme alle esigenze repressive della procura» dichiara
Berlusconi. In appello però, nel 2000, sempre per le attenuanti generiche scatta
la prescrizione.
3. Colombo, il caso Lentini e la prescrizione.
C’e’ anche un capitolo «sportivo»: versamento in nero di una decina di miliardi
dalle casse del Milan a quelle del Torino, per l’acquisto di Gianluigi Lentini.
Il dibattimento si conclude con la dichiarazione che il reato è prescritto,
grazie alla legge che abolisce il falso in bilancio. È lo stesso pubblico
ministero Gherardo Colombo a chiedere l’applicazione della prescrizione, dopo
che il tribunale respinge la sua eccezione di incostituzionalità della normativa
varata nel marzo 2002 in materia di falso in bilancio.
4. Il tribunale civile e il risarcimento a De Benedetti.
Berlusconi è poi coinvolto in una lunga serie di processi per
la corruzione dei giudici romani in relazione al Lodo Mondadori e al caso Sme.
Sono i processi che hanno protagonista Stefania Ariosto, il teste «Omega» e
Cesare Previti. Condanne per Cesare Previti e il giudice Metta. Per quanto
riguarda il Lodo Mondadori, dopo una guerra durata vent’anni, si stabilisce che
Berlusconi deve risarcire De Benedetti. Luigi de Ruggiero, Walter Saresella e
Giovan Battista Rollero sono i tre giudici della seconda sezione civile della
Corte d’Appello di Milano che emettono la sentenza nell’ambito della vicenda del
Lodo Mondadori che condanna Fininvest al pagamento di circa 560 milioni di euro.
La cifra diventa 494 milioni dopo la Cassazione.
5. De Pasquale e l’accusa nel caso Mills, ma è prescrizione.
Le procure di Caltanissetta e Firenze che hanno indagato sui mandanti a volto
coperto delle stragi del 1992 e del 1993 hanno svolto indagini sull’eventuale
ruolo che Berlusconi e Dell’Utri possono avere avuto in quelle vicende.
L’inchiesta è stata chiusa con l’archiviazioni nel 1998 (Firenze) e nel 2002
(Caltanissetta). La procura di Palermo, inoltre, ha indagato su Berlusconi per
mafia: concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio di denaro sporco.
Nel 1998 l’indagine e’ stata archiviata per scadenza dei termini massimi
concessi per indagare. Definitiva la prescrizione per il caso Mills, l’avvocato
inglese che avrebbe ricevuto 600 mila euro da Berlusconi per testimonianze
reticenti ai processi per All Iberian e tangenti alla Gdf. A sostenere l’accusa
contro Berlusconi il pm Fabio De Pasquale.
6. Caso Ruby, Boccassini è pubblica accusa.
Il procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini, insieme al pm
Antonio Sangermano, rappresenta la pubblica accusa nel processo di primo grado
sul caso Ruby. I rapporti di Berlusconi con Boccassini sono conflittuali. L’ex
premier respinge le accuse e condanna l’operato dei pm di Milano.
7. Tre donne per la condanna in primo grado.
Il 24 giugno 2013, nel processo Ruby, Silvio Berlusconi viene
condannato in primo grado a 7 anni per entrambi i reati contestati: concussione
per costrizione e prostituzione minorile. Il collegio della quarta sezione
penale del Tribunale di Milano che giudica Berlusconi è composto da donne: la
presidente Giulia Turri, che nel marzo del 2007 firmò l’ordinanza di arresto per
il “fotografo dei vip” Fabrizio Corona; Carmen D’Elia, che già nel 2002 aveva
fatto parte del collegio di giudici del processo Sme che vedeva come imputato,
tra gli altri, proprio Silvio Berlusconi; Orsola De Cristofaro, la terza
componente del collegio, con un passato da pm e gip, già giudice a latere nel
processo che ha portato alla condanna a quindici anni e mezzo di carcere per
Pier Paolo Brega Massone, l’ex primario di chirurgia toracica, imputato con
altri medici per il caso della clinica Santa Rita.
8. L’assoluzione in appello. Il presidente si dimette.
Il processo d’appello per il caso Ruby si tiene davanti alla seconda Corte
d’Appello: Enrico Tranfa è il presidente, Concetta Lo Curto e Alberto Puccinelli
i giudici a latere. Berlusconi viene assolto dal reato di concussione «perché il
fatto non sussiste» e dal reato di prostituzione minorile «perché il fatto non
costituisce reato». L’ex Cavaliere commenta che «la maggioranza magistrati è
ammirevole». Enrico Tranfa, il presidente, si dimette subito dopo aver firmato
le motivazioni della sentenza, in dissenso con la sentenza presa a maggioranza
con il sì degli altri due giudici. E così, dopo 39 anni di servizio, a 15 mesi
dalla pensione, il magistrato lascia anzitempo la toga. Tranfa ha esercitato la
professione in gran parte a Milano. Negli anni 90 è stato all’ufficio Gip. Come
giudice delle indagini preliminari, nel periodo di Mani Pulite, si era occupato
di uno dei filoni dell’inchiesta sugli appalti Anas e di quella sulla centrale
dell’Enel a Turbigo per cui dispose l’arresto, tra gli altri, dell’ex assessore
lombardo in quota alla Dc Serafino Generoso. Nel 2002 è stato nominato
presidente del Tribunale del Riesame sempre di Milano. Come giudice d’appello ha
confermato, tra l’altro, la condanna a tre anni di carcere per Ubaldo Livolsi
per la bancarotta di Finpart. Concetta Lo Curto, entrata in magistratura nel
1990, è stata giudice al Tribunale di Milano, prima all’ottava sezione penale e
poi alla terza dal 1995 al 2013 quando poi è passata in Corte d’Appello. Nel
2010 assolse l’allora deputato del Pdl Massimo Maria Berruti, imputato per la
vicenda Mediaset (la sua posizione era stata stralciata da quella di Berlusconi
e degli altri). Puccinelli, entrato in magistratura nell’89, è stato il giudice
relatore al processo di appello che si è concluso con la prescrizione per
Berlusconi, imputato per la vicenda del «nastro Unipol».
9. Processo Ruby, il pg De Petris contro l’assoluzione.
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione confermato l’assoluzione, che
diventa definitiva, di Silvio Berlusconi nel processo Ruby. Il sostituto
procuratore della Corte d’Appello Pietro De Petris aveva fatto ricorso in
Cassazione contro l’assoluzione.
10. Processo Mediaset, l’accusa di De Pasquale e Spadaro.
Il 18 giugno 2012 i pm di Milano Fabio De Pasquale e Sergio
Spadaro chiedono una condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione per Silvio
Berlusconi, imputato di frode fiscale nel processo sulle presunte irregolarità
nella compravendita dei diritti tv da parte di Mediaset. Il 26 ottobre 2012
l’ex premier viene condannato a 4 anni di reclusione, cinque anni di
interdizione dai pubblici uffici e tre anni di interdizione dagli uffici
direttivi delle imprese.
11. Pena più severa di quanto richiesto.
Il presidente del collegio che condanna Berlusconi in primo grado è Edoardo
D’Avossa con i giudici a latere Teresa Guadagnino e Irene Lupo). La pena è
maggiore di quanto chiesto dai pm. Berlusconi commenta: «È una condanna
politica, incredibile e intollerabile. È senza dubbio una sentenza politica come
sono politici i tanti processi inventati a mio riguardo».
12. Il giudice Galli conferma in appello.
L’8 maggio 2013, dopo quasi sei ore di camera di consiglio, i
giudici della seconda Corte d’Appello di Milano, presieduti da Alessandra Galli
(nella foto Brandi/Fotogramma), confermano la condanna a 4 anni di
reclusione, di cui tre coperti da indulto, per Silvio Berlusconi, accusato di
frode fiscale nell’ambito del processo sulla compravendita dei diritti tv
Mediaset. Berlusconi parla di «persecuzione» da parte della magistratura che
vuole eliminarlo dalla scena politica.
13. Esposito, la Cassazione e l’intervista contestata.
Il primo agosto 2013 la Cassazione conferma la condanna a quattro anni di
carcere. A leggere la sentenza sul processo Mediaset è il presidente della
sezione feriale della corte di cassazione Antonio Esposito. Nei giorni
successivi, il giudice Esposito finisce nella bufera per un’intervista a «Il
Mattino» in cui parla della sentenza sul processo Mediaset-Berlusconi. Lo stesso
magistrato farà seguire una smentita riguardo ad alcuni passaggi. In
particolare, Esposito smentisce anche «di aver pronunziato, nel colloquio avuto
con il cronista - rigorosamente circoscritto a temi generali e mai attinenti
alla sentenza, debitamente documentato e trascritto dallo stesso cronista e da
me approvato - le espressioni riportate virgolettate: “Berlusconi condannato
perché sapeva non perché non poteva non sapere».
10 marzo 2015. La Corte di Cassazione assolve.
Questa donna (la Boccassini) ha distrutto il Paese Ma resterà impunita. Anche un
magistrato come Emiliano si indigna: "Chieda scusa". E nonostante tutto Ilda
Boccassini rimarrà al suo posto come sempre, scrive Alessandro Sallusti su “Il
Giornale”. Per La Repubblica, Berlusconi non è un innocente perseguitato ma un
«colpevole salvato», come si evince dal titolo che racconta con stizza
dell'assoluzione definitiva in cassazione sul caso Ruby. Il Corriere della Sera
affida invece al suo segugio Luigi Ferrarella la difesa senza se e senza ma
dell'operato dei pm milanesi. Un ufficio stampa della procura non avrebbe saputo
fare di meglio e, ovviamente, Ferrarella tace sul fatto che lui stesso e
autorevoli colleghi del suo giornale nel corso di questi anni avevano già emesso
la sentenza di colpevolezza in centinaia di articoli nei quali si spacciavano
per prove certe i farneticanti teoremi dell'accusa. Non sappiamo invece il
commento di Ilda Boccassini, la pm che ha fatto da redattore capo di quella
grande messa in scena truffaldina ed esclusivamente mediatica che è stata
l'inchiesta Ruby. Una cosa però conosciamo. E cioè che la Boccassini, grazie a
questa inchiesta, è stata inclusa dalla rivista statunitense Foreign Policy al
57esimo posto nella lista delle personalità che nel corso del 2011 hanno
influenzato l'andamento del mondo nella politica, nell'economia, negli
esteri.Non stiamo parlando di un dettaglio. Anche dall'altra parte dell'Oceano
erano giunti alla conclusione che le notizie costruite dalla procura di Milano e
spacciate da Corriere e Repubblica non costituivano un mero fatto giudiziario ma
avevano contribuito in modo determinante a modificare giudizi sull'Italia con
ricadute decisive financo sul piano internazionale. Oggi, grazie alla sentenza
di Cassazione, sappiamo che si trattò di una iniziativa scellerata,
completamente falsa, paragonabile a un complotto per destabilizzare un Paese
sovrano. Complotto ordito da magistrati e sostenuto da complici, o almeno utili
idioti, nelle redazioni dei giornali nazionali ed esteri, nelle stanze di
governi stranieri e in quelle della politica di casa. A partire da quella più
prestigiosa del Quirinale, allora abitata da Giorgio Napolitano. Il quale non
solo non mosse un dito per fermare il linciaggio del suo primo ministro, ma,
proprio sull'onda di quella destabilizzazione, ricevette in segreto banchieri,
editori e imprenditori di sinistra per organizzare un controgoverno (Monti, per
intenderci) nonostante quello in carica godesse ancora della piena fiducia del
Parlamento. Alla luce di tutto questo, e in attesa che la Corte europea faccia
giustizia di un'altra bufala giudiziaria (la condanna di Berlusconi per evasione
fiscale, avvenuta grazie al trucco di assegnare la sentenza non al giudice
naturale, ma a un collegio costruito ad hoc, guarda caso su sollecitazione del
Corriere della Sera ), ora si pongono problemi seri che meritano risposte veloci
e all'altezza di un Paese libero e democratico. Riguardano la permanenza nelle
loro delicate funzioni dei responsabili e la riabilitazione politica della
vittima Berlusconi. Nessuno, su questo, può permettersi di fare il pesce in
barile.
Il giallo Tranfa e quei Servizi rimasti muti,
scrive Giovanni Maria Jacobazzi su “Il Garantista”. Il processo Ruby non è stato
un processo come tanti. Molti aspetti, oscuri, hanno connotato questa vicenda
penale che ha portato alla caduta di un governo e allo sfascio di un partito.
Tralasciando lo sputtanamento internazionale e il ludibrio planetario che hanno
investito Silvio Berlusconi e, di riflesso, il Paese. Due, principalmente, sono
gli episodi che fanno riflettere e che ad oggi non hanno avuto risposta. Episodi
che riguardano proprio l’inizio e la fine dell’inchiesta. Il primo riguarda le
modalità con cui sono state condotte le indagini preliminari da parte della
Procura della Repubblica di Milano. Il secondo le dimissioni del giudice Enrico
Tranfa, il presidente del collegio che in appello ha assolto Silvio Berlusconi
dopo la condanna in primo grado a sette anni. Per scoprire cosa accadesse la
sera nella residenza di Arcore, la Procura di Milano non ha lesinato energie.
Con un dispiegamento di forze senza pari in relazione ai tipo di reato
perseguito, una ipotesi di prostituzione minorile e di concussione, i
pubblici ministeri milanesi hanno posto in essere un numero elevatissimo di
intercettazioni telefoniche. Tranne Silvio Berlusconi che, essendo parlamentare,
non poteva essere intercettato, chiunque entrasse in contatto con Villa San
Martino si ritrovava il telefono sotto controllo. Decine di ragazze, ma non
solo, furono intercettate per mesi. Ogni loro spostamento
accuratamente monitorato. Centinaia i servizi di osservazione, controllo e
pedinamento come si usa dire in gergo questurile. All’epoca dei fatti, il 2009,
Silvio Berlusconi era il presidente del Consiglio. Il suo uomo più fidato,
Gianni Letta, sottosegretario di Stato con delega ai Servizi. Come è stato
possibile effettuare una attività investigata di queste proporzioni, migliaia
le intercettazioni effettuate, senza che nessuno, in maniera
ovviamente riservata, facesse arrivare il “messaggio” all’indagato eccellente
di prestare attenzione alle persone frequentate ed ai comportamenti da tenere?
Nessuna indicazione dai gestori telefonici? Nessun dubbio circa questa anomala
concentrazione di utenze sotto controllo proprio nella residenza privata del
presidente del Consiglio, sottoposta a misure di massima sicurezza secondo la
legge 801 che disciplina il segreto di Stato? Ma il rapporto anomalo con
gli apparati di sicurezza è anche alla base dell’accusa più grave caduta sulla
testa di Berlusconi. Quella di concussione nei confronti del capo di gabinetto
della Questura di Milano. Come mai il presidente del Consiglio, residente a
Milano, città dove ha il centro dei suoi interessi e dove vive la sua famiglia,
non si rivolge, per motivi di opportunità e riservatezza, direttamente
al Questore ma passa attraverso il suo capo di gabinetto, peraltro chiamatogli
al telefono dal suo capo scorta? Essendo il Consiglio dei ministri preposto alla
nomina dei questori delle città, non si può proprio dire che l’allora premier
non conoscesse chi fosse al vertice della pubblica sicurezza del capoluogo
lombardo. E infine le dimissioni improvvise e inaspettate del giudice
Enrico Tranfa, il presidente del collegio di Appello che ha assolto
Silvio Berlusconi, subito dopo il deposito delle 330 pagine delle motivazioni
della sentenza. Come si ricorderà, dopo aver depositato la sentenza di
assoluzione, Enrico Tranfa fece domanda per essere collocato in pensione.
Poteva restare in servizio altri quindici mesi. Decise di anticipare l’uscita
dalla magistratura. Campano di Ceppaloni, il paese che ha dato i natali anche a
Clemente Mastella, collocabile nella corrente di Unicost, Tranfa era dal 2012 a
Milano in Corte d’Appello come presidente della seconda sezione penale.
Equilibrato, molto preparato, mai una parola fuori posto. Un persona mite. Nulla
che potesse far prevedere una reazione del genere. Le sue dichiarazioni, a chi
gli chiedeva il perché di una simile decisione, furono soltanto “è una decisione
molto meditata, perché in vita mia non ho fatto niente di impulso. Tutti
sono utili, nessuno è indispensabile”. Per poi aggiungere: “Il compito di un
giudice non è quello di cavillare con i tecnicismi, ma prendere un fatto,
valutarlo alla luce delle norme, e poi fare un atto di
volontà, decidendo. Altrimenti è la giustizia di Ponzio Pilato”. Sul caso montò
la contrapposta lettura politica: “Solidarietà” dal Pd e dure critiche da Forza
Italia. Le dimissioni in polemica con l’assoluzione scatenarono anche le ire del
presidente della Corte d’Appello Giovanni Canzio. “Se dettate da un personale
dissenso per l’assoluzione di Silvio Berlusconi non appaiono coerenti con le
regole ordinamentali e deontologiche che impongono l’assoluto riserbo sulle
dinamiche della Camera di consiglio”, disse Canzio, “trattasi di un gesto
clamoroso e inedito”. Se per ogni disaccordo in un collegio il magistrato
dovesse dimettersi, in magistratura rimarrebbero in pochi. Ma quell’anomalia,
come la prima, con ogni probabilità rimarrà senza risposta.
Processo Ruby, pool di Milano: le lettere segrete delle toghe
rosse alla giudice che assolse Silvio Berlusconi,
scrive “Libero Quotidiano”. Le toghe rosse di Milano si attendevano
l'annullamento dell'assoluzione in secondo grado. Volevano Silvio
Berlusconi di nuovo alla sbarra nel processo Ruby. Ma così non è
andata. Confermata l'assoluzione. E dopo la conferma, oltre al Cav, ci sono
state diverse persone che si sono levate dei sassolini dalle scarpe. Una di
queste era la giudice Concetta Locurto, toga stimata e
progressista, già coordinatrice milanese di Area, il cartello tra le correnti di
sinistra di Magistratura Democratica. Una, insomma, che aveva il "pedegree"
giusto per condannare Berlusconi in secondo grado. Già, perché la Locurto la
scorsa estate era la relatrice della sentenza di assoluzione del Cav nel
processo Ruby. L'assoluzione scatenò un vespaio di polemiche in
magistratura, culminate con le dimissioni del suo collega e presidente del
collegio, Enrico Tranfa, che con il passo indietro volle
dissociarsi da un verdetto che non condivideva. La Locurto, al tempo, non volle
commentare. E non ha voluto commentare neppure dopo la conferma dell'assoluzione
che, nei fatti, ha confermato la bontà del suo operato. E il silenzio le deve
essere costato, perché come spiega il Corriere della Sera la toga che
ha assolto Berlusconi ha vissuto mesi da incubo, tra "attacchi
e implicite insinuazioni di cosa di oscuro potesse essere accaduto attorno al
processo" per spingere Tranfa alle dimissioni. Ha taciuto, la Tranfa. Almeno in
pubblico. Già, perché secondo quanto scrive sempre il Corsera, la toga
avrebbe scritto una piccola lettera ai colleghi (agli stessi colleghi che nei
mesi precedenti tempestavano la sua email parlando di "torsione del diritto").
Il Corsera ha provato a chiederle del contenuto della lettera, ma la
Tranfa, fedele alla sua riservatezza, ha scelto di non parlare.
Eppure qualcosa è emerso. Nonostante il rifiuto della giudice, è stato
ricostruito quanto abbia detto interpellando i destinatari della missiva. La
Tranfa non giudicava la bontà della sentenza, ma metteva in guardia dai rischi
di "una malevola dietrologia faziosa", del "pregiudizio", dei
"pensieri in libertà da chiacchiera da bar" della quale è stata vittima per mesi
per aver fatto il suo lavoro, che nella fattispecie prevedeva di assolvere
Berlusconi. La Tranfa avrebbe scritto dei "magistrati che giudicano senza
conoscere, finendo - proprio loro - per partecipare al tiro al piccione
senza alcun rispetto per l'Istituzione e le persone". E il piccione, in quel
momento, era proprio lei. E il "piccione", ora, si toglie le sue soddisfazioni.
Nella missiva avrebbe aggiunto l'invito ai colleghi ad "andarsi a rileggere i
provvedimenti redatti nel corso dell'intera carriera, piccoli o grandi che
fossero, per avere certezza dell'identità di metro di valutazione
utilizzato indifferentemente per extracomunitari e potenti". Quel metro di
giudizio imparziale che però, i colleghi, le rimproverano: se c'è il Cav alla
sbarra deve essere condannato.
Filippo Facci su “Libero Quotidiano”: logica da pm. Se Silvio Berlusconi
conosce Noemi Letizia, è colpevole. La Cassazione doveva confermare o non
confermare l’assoluzione di Silvio Berlusconi (caso Ruby) per
concussione e prostituzione: dopodiché, lo schema era il solito. La Corte che si
riunisce nel primo pomeriggio, i giornalisti italiani e stranieri che ciacolano,
la consueta assicurazione che la sentenza arriverà «in serata» e che perciò
potranno scriverne, hurrà. Ma forse i giudici non erano aggiornati: non sapevano
che i quotidiani hanno le chiusure sempre più anticipate, mannaggia: come
possono non tener conto delle sacre esigenze mediatiche? Come possono aver
saltato i telegiornali della sera? I giudici (presidente Nicola Milo,
consiglieri Giorgio Fidelbo, Stefano
Mogini e Gaetano De
Amicis) dovevano prendere esempio dal procuratore generale Eduardo
Scardaccione, che nel pomeriggio aveva esposto una requisitoria mediaticamente
perfetta. Niente di strano che abbia chiesto di annullare - con rinvio in
Appello - l’assoluzione di Berlusconi per entrambi i reati: è ciò che ci si
attendeva da lui, un’apologia di quel processo che in primo grado aveva
condannato il Cav a sette anni. Mentre invece le assoluzioni di luglio scorso -
pochi mesi fa: la giustizia italiana sa essere velocissima - secondo
Scardaccione andavano polverizzate: altro che «il fatto non sussiste»
(concussione) e «il fatto non costituisce reato» (prostituzione minorile). Sin
qui tutto normale. Ma sono altri argomenti che ha adottato - poi - a farci
pensare ancora una volta che taccuini e telecamere andrebbero tenuti lontani dai
palazzi di giustizia. Scardaccione ha detto che le accuse sono «pienamente
provate» (vabbeh) e che la Corte d’appello non doveva riaprire il processo bensì
rideterminare la pena di primo grado: e ci sta anche questo. Poi lo show:
«L’episodio nel quale Berlusconi racconta che Ruby è la nipote di Mubarak è
degno di un film di Mel Brooks e tutto il
mondo ci ha riso dietro». Uhm. Purtroppo «il mondo» non ha testimoniato a
processo. E neppure Mel Brooks. A ogni modo il procuratore Scardaccione
ha proseguito spiegando che la concussione c’è stata, anzi «c’è stata una
violenza irresistibile» per ottenerla. Lo proverebbe il fatto che dal momento in
cui ha ricevuto la telefonata di intervento da Berlusconi il capo di gabinetto
della Questura di Milano «non capisce più nulla e fa ben 14 telefonate: c’è
spazio per ritenere che la pressione fosse resistibile?... No... L’intervento ha
avuto una potenza di fuoco tale da annullare le scelte autonome del
funzionario». Par di capire che qualsiasi telefonata di Berlusconi in quel
periodo - essendo lui premier ed essendo Berlusconi - avesse una potenziale
valenza concussoria: chiunque ne riceveva una andava praticamente in
palla e veniva annullato nella volontà, una forma di ipnosi. Il
procuratore generale non ha contemplato che i dirigenti della Questura fossero
banalmente eccitati all’idea di poter fare un favore al presidente del
Consiglio: cosa che avrebbe avuto una valenza più che ambigua se solo avessero
fatto qualcosa che non dovevano fare. Ma ciò che fecero (identificazione di
Ruby, foto segnalazione e ricerca di una comunità per l’affido) corrispondeva
alla prassi in vigore. Ma secondo Scardaccione no, c’è stata «una violenza
grave, perdurante e irresistibile anche a margine della consegna di Ruby a
Nicole Minetti». Il dettaglio è che l’idea di consegnare Ruby alla Minetti non
fu un’idea di Berlusconi bensì una soluzione escogitata in questura. Ma -
possiamo dirlo? - ci sta anche questo. È passando al reato di prostituzione
minorile che si giunge all’incredibile: perché Scardaccione ha tirato in ballo
Noemi Letizia, una ragazza che non c’entra un accidente - mai tirata in
ballo in nessun processo, in nessun modo - perché la circostanza che Noemi e
Ruby fossero due minorenni «non è una coincidenza» e rende «non
credibile» che Berlusconi non sapesse della minore età di Ruby. Scardaccione ha
ricordato quanto aveva detto Ruby in un’intercettazione: «Noemi è la sua pupilla
e io il suo culo». Cioè: il fatto che due amici di Berlusconi avessero una
figlia minorenne non poteva essere un caso. E chissà - aggiungiamo noi -
quanti milioni di elettori di Forza Italia, negli ultimi vent’anni,
hanno avuto figlie minori. Insomma: se Berlusconi sapeva che la figlia di due
suoi amici era minorenne, beh, doveva sapere anche l’età di tutta la carovana di
signorine che la sera gli portavano a casa con la carriola. Pagandole, certo:
perché Franco Coppi, l’avvocato di Berlusconi, ieri non l’ha negato: «La
sentenza d’appello ammetteva che ad Arcore avvenivano fatti di
prostituzione, cosa che non contestiamo nemmeno noi difensori: ma
manca, in fatto, la prova che Berlusconi prima del 27 maggio sapesse che Ruby
era minorenne». Sempre che i processi si facciano ancora con le prove.
Il caso Ruby c’è costato mezzo milione. Per i pm le spese ammontano a 65mila
euro, ma facendo altri calcoli si sfiorano i 600mila, scrive Simone Di Meo su
“Il Tempo”. Quanto è costata l'inchiesta Ruby alle casse dello Stato? La
classica domanda da un milione di dollari ha una doppia risposta. La versione
minimalista, accreditata dai conti della Procura della Repubblica di Milano
contenuti nel faldone 33 del procedimento, parla di appena 65mila euro così
suddivisi: in sei mesi sono stati pagati 26mila euro per le intercettazioni e
39mila euro per trascrizioni di interrogatori, traduzioni dall’arabo, per il
noleggio auto, la più costosa delle quali - una Golf - è stata pagata 4mila
euro, e per l’acquisto di registratori digitali. Pochi spiccioli anche per le
trasferte dei poliziotti in alcuni hotel di Rimini: poco meno di 200 euro per
tre diversi viaggi. Insomma, per questa scuola di pensiero il procedimento
penale del pm Ilda Boccassini non ha prosciugato le casse del ministero della
Giustizia ma si è mantenuto addirittura al di sotto dello standard della
Direzione distrettuale antimafia. Questione risolta, allora? Mica tanto perché a
questa immagine light dell'inchiesta se ne contrappone una più approfondita che
zavorra con almeno uno zero la cifra iniziale portandola a oltre mezzo milione
di euro. Ci sono alcuni costi che, nel computo del pubblico ministero, non
vengono infatti elaborati. Sarà sicuramente una distrazione, ma bisogna fare
chiarezza. Stiamo parlando dei cosiddetti costi fissi che riguardano l'utilizzo
della polizia giudiziaria per condurre un'indagine fatta a pezzi dalla Corte
d'appello e dalla Cassazione dopo una prima condanna a sette anni nei confronti
di Silvio Berlusconi. Un'indagine fondata su due capi di imputazione che
tecnicamente non hanno retto al vaglio delle toghe. Perché è vero che un
poliziotto o un carabiniere viene ugualmente stipendiato dallo Stato (e ci
mancherebbe) ma c'è un particolare di cui non tutti si ricordano: il poliziotto
o il carabiniere in questione avrebbe potuto essere impiegato su un altro
versante giudiziario, magari più interessante e utile. E questo - dal punto di
vista aziendalistico - è un costo che non può essere omesso se si vuole davvero
fare una descrizione esatta del valore contabile del fascicolo Ruby. Dare per
scontate queste voci di costo è un errore. Così come è un errore non calcolare
il noleggio dell'apparecchiatura utilizzata per geolocalizzare i cellulari che
hanno agganciato la cella di Arcore alla ricerca delle utenze delle partecipanti
alle "cene eleganti". Un'attrezzatura che, secondo quanto risulta a Il Tempo
costa in media 1000 euro al giorno: è probabile che fosse già in dotazione agli
uomini del Servizio centrale operativo cui sono state delegate le attività
investigative, ma il suo utilizzo, in termini economici, dev'essere
adeguatamente riportato nello schema della Procura. I "target" di
intercettazioni e acquisizioni di traffico telefonico e di tabulati sono stati
circa trenta per oltre 115mila conversazioni monitorate. Nell'intera operazione
è presumibile che siano stati impegnati oltre cento poliziotti che, per la
durata delle indagini, sono stati distolti da altri fascicoli, ovviamente. Non
sbirri qualunque, ma uomini dello Sco, l'organo investigativo di punta del
Viminale che solitamente dà la caccia a mafiosi, narcotrafficanti e serial
killer. Per dire: i due superlatitanti del clan dei Casalesi, Antonio Iovine e
Michele Zagaria, sono stati presi anche con la collaborazione del Servizio
centrale. Che, nel caso in esame, è stato invece sguinzagliato sulle tracce
delle olgettine e del ragionieri Spinelli, lauto pagatore ufficiale del Cav.
Anche i loro stipendi, anche i loro straordinari, anche i loro ticket sono dei
costi a carico dello Stato (e quindi dei cittadini) che devono essere inseriti
nel bilancio Ruby. Alla fine, calcoli alla mano, l'indagine di "Ilda la rossa"
tra costi fissi (quelli appena descritti, che riguardano l'intera struttura) e
costi variabili (i famosi 65mila euro, che dipendono appunto dalle necessità
investigative del momento) ha gravato sulle casse dello Stato per circa 600mila
euro. È una stima prudenziale ma che ha un suo fondamento considerato che un
poliziotto viene pagato in media 100 euro lordi al giorno. Qualcuno ci
aggiungerebbe anche i costi dei processi (stipendi dei giudici, dei cancellieri,
del personale amministrativo, fotocopie) ma entriamo nel fantastico mondo delle
ipotesi e allora tutte le ricostruzioni sono possibili.
Signori del Csm, quell’inchiesta è senza ombre?
Scrive Tiziana Maiolo su “Il Garantista. Sono politici, non morali, i motivi per
cui è andato in onda per cinque anni il Pornofilm del Bungabunga che ha messo
nel tritacarne un presidente del Consiglio, preso a picconate il suo partito,
distrutto la sua reputazione nel mondo, insieme alla sua immagine personale e i
suoi affetti. Tutto nasce non tanto dal fermo, in una serata di maggio del 2010,
di una giovane marocchina. Né dalla successiva telefonata di Berlusconi alla
questura di Milano. Casomai dall’uso che dell’episodio venne fatto dalla Procura
della Repubblica più famosa e discussa d’Italia. E’ negli uffici del quarto
piano del palazzo di giustizia di Milano, già allenati dalla caccia
al cinghialone ai tempi di Craxi e di Tangentopoli, che parte la crociata di
stampo talebano che prende di mira il presidente del Consiglio per i suoi
costumi sessuali. Ma il Pornofilm è solo l’involucro, un uovo di pasqua con
sorpresa. La sorpresa è tutta politica. Se il Consiglio superiore della
magistratura volesse occuparsene, potrebbe rilevare parecchie anomalie, dentro
quell’uovo. Prima cosa: Ruby viene fermata e rilasciata in una notte di
fine maggio. Che cosa è successo tra quella data e quella in cui Silvio
Berlusconi viene iscritto nel registro degli indagati (21 dicembre 2010) e
in seguito raggiunto da un invito a comparire (14 gennaio 2011)? Succede che
Ruby viene ripetutamente interrogata, una serie di persone che frequentavano la
casa di Arcore viene monitorata e intercettata e si tende la tela del ragno che
deve catturare la preda. Che la preda sia un Arcinemico di certa magistratura e
certi Pubblici ministeri non è un segreto. Che dalle parti di Milano si usino
metodi disinvolti sulle competenze territoriali (un presidente del Consiglio non
dovrebbe essere giudicato dal Tribunale dei ministri?) è cosa altrettanto
nota. Ma quel che succede a Milano è qualcosa di ben più mostruoso: per
sette-otto mesi vengono fatte indagini su un contesto che ha al centro
una persona che non è indagata, vengono disposte intercettazioni a persone che
parlano al telefono con un parlamentare senza che sia chiesta, come prescrive la
legge, l’autorizzazione alla Camera di appartenenza. Nei fatti si indaga su
una persona in violazione delle normali procedure di legge. A nulla valgono le
proteste degli avvocati, le interrogazioni parlamentari del deputato di Forza
Italia Giorgio Stracquadanio, la curiosità che comincia a serpeggiare
nella stampa italiana e anche straniera. La Procura di Milano tira dritto.
Apparentemente arrogandosi il diritto di moralizzare i costumi altrui, in realtà
con obiettivi ben più ambiziosi. Ma un’altra anomalia esplode clamorosa a
un certo punto, la rissa da cortile tra il procuratore capo Bruti Liberati e il
suo aggiunto Robledo sulle competenze tematiche e le assegnazioni delle
inchieste. Perché le indagini su Berlusconi e il “caso Ruby” vengono assegnate a
Ilda Boccassini, titolare delle inchieste sulla mafia e non a Robledo che si
occupa di Pubblica Amministrazione? Berlusconi non è forse accusato di aver
abusato del suo potere di presidente del Consiglio, con quella famosa telefonata
in questura che gli costerà la condanna in primo grado per concussione? Questo
aspetto della vicenda giace nelle scartoffie (nei fatti archiviate) del Csm
sulla querelle Bruti-Robledo, che nessuno pare avere la curiosità di esaminare
più. Sarebbe bene, invece, che l’organo di autogoverno di Pm e giudici
riaprisse gli occhi, su questo punto, e si chiedesse “perché” fosse così
importante quella sostituzione di Robledo con Boccassini in un’inchiesta dal
sapore squisitamente politico. Questo è il succo della vicenda: forzature
e anomalie per il raggiungimento di uno scopo. Addirittura il procuratore
generale di Milano, pur di fare il ricorso in Cassazione, si è appellato a
questioni di merito, trascurando il fatto che il terzo grado di giudizio
può riguardare solo questioni di legittimità. Un’altra delle anomalie
“lombarde”, che la Cassazione avrebbe dovuto rilevare subito, rigettando
il ricorso in dieci minuti. Nove ore di discussione sono un bel tributo
alle tricoteuses di tutta Italia. In ogni caso,tutto il resto è contorno, il
Pornofilm, il Bungabunga, sparsi a piene pani tramite un ventilatore in funzione
permanente con lo scopo dello Sputtanamento. Oggi, con Berlusconi che porta
a casa con una certa velocità (quattro anni per tre gradi di giudizio
sono un’altra, piacevole, anomalia) l’assoluzione piena da due reati infamanti,
resta il reato di Sputtanamento ancora vivo e vegeto nelle immagini del
Pornofilm, tanto che gli avvocati sono stati costretti a dire (un po’ andando di
fantasia) che, in fondo si, forse un po’ di prostituzione ad Arcore c’è stata,
per rafforzare la realtà dei fatti sulla non conoscenza dell’età di una
quasi-diciottenne che dimostrava, a detta di tutti, almeno venticinque anni. E
che probabilmente era più una mantenuta che una prostituta. Anche in questo il
processo Ruby è stato speciale. Ma non può finire qui. Il Csm ci deve spiegare
se tutte queste violazioni sono consentite, se anche il nuovo corso
“renziano” ha intenzione di chiudere gli occhi, come già si fece 20 anni fa con
Tangentopoli, su questi metodi machiavellici, per cui la finalità politica può
fare a pezzi le regole dello Stato di diritto e prevale sempre la filosofia del
“tipo d’autore” (individuo la tipologia del colpevole, poi colpisco la persona),
per cui la responsabilità penale non è più personale ma esplicitamente politica.
Alla faccia dell’obbligatorietà dell’azione penale.
«Cittadini impotenti davanti ai magistrati»,
scrive Daniel Rustici su “Il Garantista”. «Il Csm cominci
a fare sul serio il suo lavoro che fino ad oggi ha svolto, per usare un
eufemismo, in modo deficitario. Sono stati puniti solo i magistrati fuori dal
coro, mai quelli che hanno sbagliato nell’esercizio della professione. Il
caso più emblematico è quello del processo Tortora dove i giudici di uno dei più
clamorosi casi di malagiustizia hanno fatto carriera. Il Csm dovrebbe essere
meno indulgente e ”perdonista” nei confronti dei magistrati che commettono gravi
errori». Chi parla è uno dei giudici più intransigenti e
celebri per le sue feroci polemiche contro pezzi del mondo politico, e a
difesa della magistratura: Antonio Ingroia. In un’intervista al nostro
giornale ha detto che bisogna difendere i cittadini che talvolta sono troppo
deboli di fronte ai magistrati e ai loro eventuali errori. Ha parlato anche di
carcerazione preventiva, e ha detto che «in un Paese in cui i tempi per
arrivare a una sentenza definitiva sono così lunghi, è facile che si arrivi ad
utilizzare la carcerazione preventiva come una sorta di anticipazione della pena
prevista in caso di condanna dopo i tre gradi di giudizio».
Ingroia, stanno facendo molto rumore le sue dichiarazioni sulla
responsabilità civile dei giudici. Ha parlato di cittadini «impotenti»
davanti al potere della magistratura. Detto da un’ex toga…
«Voglio precisare prima di
tutto che sono contrario alla responsabilità civile dei magistrati. Penso invece
che per garantire i diritti dei cittadini bisognerebbe che il Csm cominci a fare
sul serio il suo lavoro che fino ad oggi ha svolto, per usare un eufemismo, in
modo deficitario. Sono stati puniti solo i magistrati fuori dal coro, mai
quelli che hanno sbagliato nell’esercizio della professione. Il caso
più emblematico è quello del processo Tortora dove i giudici di uno dei più
clamorosi casi di malagiustizia hanno fatto carriera. La verità è che
all’interno della magistratura troppo spesso si va avanti sulla base
dell’appartenenza a questa o a quella corrente piuttosto che grazie al merito».
Cosa non la convince del disegno di legge del governo
sulla punibilità dei giudici?
«La responsabilità civile non
è uno strumento idoneo per difendere i cittadini. In primo luogo non lo è perché
può portare il magistrato ad assumere una posizione di soggezione
davanti all’imputato, specie se questo è ricco e potente. E non lo è
perché moltiplicherebbe il lavoro nei tribunali e quindi, dilatando ancora di
più i mostruosi tempi della nostra giustizia, paradossalmente andrebbe contro
gli interessi degli imputati stessi. Lo ripeto, il vero problema è il Csm che
dovrebbe essere meno indulgente e ”perdonista” nei confronti di chi commette
gravi errori».
Sparare sul Consiglio nazionale della magistratura ora che
ha smesso i panni di pm,non è troppo facile?
«Queste cose le ho sempre
dette. Qualcuno potrebbe anche dire che parli male del Csm per come sono stato
tratto io, per le parole contro le mie partecipazioni a manifestazioni
pubbliche. Allora non parliamo di me, ma di un altro magistrato:
Di Matteo. Perchè il Csm ostacola la sua nomina alla Procura nazionale antimafia
e favorisce invece personaggi obiettivamente con meno competenze in materia?»
Perché?
«La risposta è semplice: ci
si muove in base a logiche burocratiche e correntistiche invece che di sostanza».
Faceva prima riferimento alle sue contestate partecipazioni
a manifestazioni politiche quando era ancora magistrato. È una scelta che
rivendica?
«Sì. Mi è capitato di fare il
pm nella stagione sbagliata. Trent’anni fa nessuno si scandalizzava se Terranova
partecipava ai convegni del Pci e negli anni 70 nessuno si sognava di mettere in
discussione la professionalità di Borsellino perché andava a parlare di
giustizia nei consessi del Movimento sociale italiano. Resto convinto che un
magistrato vada giudicato per quello che fa nell’orario di lavoro e che
abbia tutto il diritto di esprimere le proprie opinioni. Io però sono stato
subissato da attacchi, sia da parte del mondo politico sia dalla magistratura
stessa…»
Nelle scorse settimane si è molto discusso delle ferie dei
giudici. Ha ragione Renzi a volerle tagliare?
«Penso si tratti di un falso
problema. Effettivamente 45 giorni sono tanti ma io, ad esempio, non ho mai
goduto dell’intero periodo di ferie e come me la maggior parte dei giudici.
Sostenere che la lentezza della giustizia italiana dipenda dalle
toghe fannullone è solo un modo di trovare un capro espiatorio».
Quali sono invece le ragioni di questa lentezza e come si
può intervenire per accelerare i tempi dei processi?
«Credo sia arrivata l’ora di
mettere in discussione l’esistenza del processo d’appello. Con un grado secco di
giudizio e un unico processo che decreti l’innocenza o la colpevolezza di un
imputato si risparmierebbero un sacco di soldi e di energie. Ritengo poi
necessario mettere fine alla corsa alla prescrizione, limitando l’abuso di
questo strumento».
A proposito di abusi, cosa pensa dell’uso molto disinvolto della
carcerazione preventiva che spesso viene fatto dai giudici?
«In un Paese in cui i tempi
per arrivare a una sentenza definitiva sono così lunghi, è facile che si arrivi
ad utilizzare la carcerazione preventiva come una sorta di anticipazione di
quella prevista in caso di condanna dopo i tre gradi di giudizi».
Sì, ma è incostituzionale: esiste la presunzione d’innocenza.
«Certo nessuno vuole mettere
in discussione la sacralità della presunzione d’innocenza ma ribadisco, finché i
tempi della giustizia saranno questi credo che la carcerazione preventiva verrà
ancora usata con questa frequenza».
Ora che esercita la professione di avvocato, come è cambiata
la sua prospettiva sul mondo giudiziario?
«Cambiando osservatorio,
sono rimasto delle mie opinioni: viviamo in un Paese profondamente ingiusto
perché indulgente con i potenti e forte con i deboli».
Cosa significa per lei la parola ” garantismo”?
«Garantismo significa dare la
garanzia a tutti i cittadini di un processo giusto e assicurare il diritto di
difesa. Chi vede il garantismo come un modo per disarmare i pm però sbaglia.
Essere garantisti significa anche fare in modo che la legge sia davvero uguale
per tutti e permettere di punire chi ha sbagliato».
Ha dichiarato di essere pronto a tornare in politica e di
guardare con attenzione a Landini. Pensa si aprirà davvero un nuovo spazio
politico a sinistra del Pd?
«Credo che il nostro Paese
abbia bisogno che emerga una nuova soggettività politica progressista, popolare
e di sinistra. Mi sento politicamente vicino a Landini e Rodotà, e sono pronto a
dare il mio contributo per la costruzione di una coalizione sociale per
l’equità, la lotta alla criminalità organizzata e ai reati dei colletti bianchi».
Adesso andiamo
a “mettere il naso” in casa dei magistrati: il Csm, Consiglio superiore della
magistratura. Il Csm si occupa anche di sanzionare disciplinarmente i magistrati
che violano le regole e la legge. Una sorta di “organo interno” per i “colleghi
che sbagliano”, scrive “The Frontpage”. Vediamo dal sito del Csm cosa prevede
l’azione disciplinare. La legge ha introdotto, infatti, l’applicazione del
criterio tale crimen talis poena, come conseguenza doverosa della
tipizzazione degli illeciti.
Le varie
sanzioni previste dalla legge sono:
a)
l’ammonimento, che è un richiamo all’osservanza dei doveri del magistrato;
b) la censura,
che è una dichiarazione formale di biasimo;
c) la perdita
dell’anzianità, che non può essere inferiore a due mesi e non superiore a due
anni;
d)
l’incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, che
non può essere inferiore a sei mesi e non superiore a due anni;
e) la
sospensione dalle funzioni, che consiste nell’allontanamento dalla funzioni con
la sospensione dello stipendio ed il collocamento fuori dal ruolo organico della
magistratura;
f) la
rimozione, che determina la cessazione del rapporto di servizio.
Vi è poi la
sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio che il giudice disciplinare può
adottare quando infligge una sanzione più grave dell’ammonimento, mentre tale
sanzione ulteriore è sempre adottata in taluni casi specificamente individuati
dalla legge. Il trasferimento d’ufficio può anche essere adottato come misura
cautelare e provvisoria, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione
disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza. Secondo l’Anm,
l’Associazione nazionale magistrati, l’Italia sarebbe tra i primi posti a
livello europeo in termini quantitativi di provvedimenti disciplinari, con 981
casi in nove anni dal 1999 al 2008. Il dato viene confortato dalla ricerca del
CEPEJ che dice che il numero delle sanzioni disciplinari applicate ogni 1000
magistrati in Italia è 7,5. Al secondo posto dopo l’Austria con un fattore 8. A
parte che questo significa che i nostri magistrati sono quelli che a questo
punto sbagliano più di tutti, il CEPEJ non dice il resto. Così come
furbescamente non lo dice l’Anm. E noi adesso lo diremo. Siamo cattivelli. Lo
stesso rapporto dell’Anm dice all’interno (badando bene da non riportare il dato
nei comunicati stampa) che sì, è vero che il Csm ha vagliato 981 posizioni in
nove anni, ma di queste le condanne sono state solo 267 (il solo 27%).
Praticamente solo tre magistrati su dieci sono stati “condannati” dal Csm. Già
questo dovrebbe far ridere o piangere a secondo il punto di vista. Ma non
finisce qui.
Di quei 267
condannati dal Csm:
a) 157, quasi
il 59%, sono stati condannati alla sanzione minima dell’ammonimento (vedi capo a
dell’elenco dei provvedimenti disciplinari);
b) 53, il 20%
circa, alla censura (vedi capo b dell’elenco dei provvedimenti disciplinari);
c) 1 solo, lo
0,4 % circa, alla incapacità (temporanea) delle funzioni direttive (vedi capo d
dell’elenco dei provvedimenti disciplinari);
d) 9 soltanto, il 3% circa, sono stati rimossi (vedi capi e-f dell’elenco dei
provvedimenti disciplinari);
Il resto sono
al capo c o semplicemente trasferiti d’ufficio. Ma l’Anm, anche se i dati sono
sconfortanti, non la dice tutta. Dagli studi di Bianconi e Ferrarella sui dati
del 2007 e del 2008 esce un dato a dir poco “offensivo” per il comune senso
della giustizia. Prima di giungere sul tavolo di Palazzo dei Marescialli, sede
del Csm, la “pratica disciplinare” passa per altre vie. L’esposto di chi vi
ricorre viene presentato alla Procura generale presso la Corte di Cassazione che
vaglia la posizione e se ravvisa fondati motivi nell’esposto passa la pratica al
Csm, che poi prende l’eventuale provvedimento. Bene, anzi male: nel 2007 la
Cassazione ha ricevuto 1.479 esposti e ne ha passati al Csm solo 103, poco meno
del 7%. Stessa musica nel 2008. Dei 1.475 fascicoli presentati in Cassazione,
solo 99 passano al Csm, circa il 7%. Quindi prendere ad esempio i dati del CEPEJ
sic et simpliciter è improprio, per due motivi: se i dati fossero
analizzati (e non lo sono) sulla base del rapporto tra fascicoli aperti e
condanne, il risultato sarebbe impietoso per l’Italia; secondo: all’estero non
esistono sanzioni disciplinari come l’ammonimento o la censura, bensì si passa
dalla sanzione di rimozione in alcuni paesi (inclusa una sanzione pecuniaria
rilevante e il pagamento dei danni morali e materiali alle vittime) sino alla
condanna in carcere in alcuni altri. Ma non è ancora finita. Il periodo
1999-2008 è stato un periodo “di comodo” perchè il meno peggiore, e inoltre i
numeri non sarebbero veritieri per come riportati dall’Anm. Secondo un’analisi
di Zurlo, mai contraddetta, i casi vagliati dal Csm dal 1999 al 2006 sono stati
1.010, di cui 812 sono finiti con l’assoluzione e solo 192 con la condanna (il
19% circa).
Di queste
“condanne”:
- 126 sono
stati condannati con l’ammonimento (circa il 66%!);
- 38 sono
stati condannati con la censura (circa il 20%);
- 22 sono
stati condannati con la perdita da 2 mesi a due anni di anzianità (circa l’11%);
- 6 sono stati
espulsi dall’ordine giudiziario (il 3%);
- 2 sono
stati i rimossi (l’1%);
Ora, che cosa
si evince? Una cosa semplice. Un magistrato, specie inquirente, può consentirsi
quello che vuole e commettere ogni tipo di errore o abuso, tanto cosa rischia?
Vediamolo in numeri semplici:
- oltre 9
volte su 10 può contare sul fatto che l’esposto presentato contro di lui
presso la Procura generale della Cassazione non venga passato al Csm;
- qualora
anche passasse al vaglio del Csm può contare sul fatto che dalle 7 alle 8
volte su 10 verrà assolto dal Csm stesso;
- qualora
anche venisse condannato dal Csm rischierebbe 9 volte su 10 solo un
“tirata d’orecchie” o “una lavata di capo”.
Insomma ha
solo dalle 7 alle 8 possibilità su mille di venire cacciato dalla
magistratura, senza contare che per lui le porte del carcere non si apriranno
mai. Potremmo dire: ho visto giudici trattati con così tanto riguardo che voi
normali cittadini non potreste nemmeno immaginarvi.
Quelle
balle in Procura che il Csm vuol insabbiare.
Incongruenze nella guerra tra toghe: qualcuno ha mentito. Ma il Consiglio
superiore della magistratura starebbe pensando di archiviare tutto, scrive Luca
Fazzo su “Il Giornale”. C'è ormai solo una prospettiva peggiore del disastro in
corso alla Procura della Repubblica di Milano, straziata da contrapposizioni,
veleni, accuse frontali. Ed è che il Consiglio superiore della magistratura,
chiamato a sciogliere questo nodo, a stabilire chi ha ragione e chi torto in
questo scontro passato rapidamente dal fioretto alla clava, scelga di non
decidere. Di insabbiare. Di chiudere senza vincitori né vinti, lasciando
all'infinito uno degli uffici giudiziari più delicati del paese nel clima
avvelenato di questi giorni. È un tentativo che serpeggia dentro al Csm, sempre
in nome di quegli equilibri di corrente che sono in buona parte gli stessi
colpevoli del degrado del tempio di Mani Pulite. Ma è chiaro che in queste
settimane qualcuno ha mentito, e continua a farlo. E il Csm non potrà rinunciare
a capire. Nelle ultime ore, il fuoco dell'indagine del Csm sembra concentrarsi
su un dettaglio dello scontro tra Edmondo Bruti Liberati, procuratore della
Repubblica, e il suo vice Alfredo Robledo: il pedinamento in contemporanea di un
indagato del caso Expo da parte della Guardia di finanza, su incarico di
Robledo, e di un'altra pattuglia, sempre delle Fiamme gialle, su ordine di Ilda
Boccassini. La dottoressa sostiene che i «suoi» finanzieri dovettero sospendere
l'attività per non andare a sbattere su quelli di Robledo («hanno fatto tremila
passi indietro»); Robledo sostiene, forte di una dichiarazione dei vertici della
Gdf, che l'episodio non è mai accaduto; Bruti ribadisce che è tutto vero, e che
Robledo non l'aveva avvisato dell'indagine in corso; Robledo si prepara a
mandare altri documenti al Csm per dimostrare il contrario. E in tutto questo, i
magistrati qualunque, quelli che ogni giorno sgobbano lontano dai riflettori, si
domandano come sia possibile che si sia arrivati a questo punto. In questi
giorni Ilda Boccassini sta facendo sentire tutta la sua potenza - di immagine,
di esperienza, di carattere - per portare il Csm a archiviare il caso e a
lasciare Bruti al suo posto. Ha rivelato, quando il Csm l'ha interrogata,
dettagli inediti: come quando ha raccontato di avere ricevuto una busta con dei
proiettili dopo che Silvio Berlusconi è finito in affidamento ai servizi
sociali, o di essersi dimessa da capo dell'Antimafia quando venne messa in
discussione la sua puntualità nel rispetto delle regole dell'ufficio (poi ci
ripensò, su richiesta del suo pool). E ha minacciato di querelare, quando questa
storia sarà finita, «chi ha detto il falso». Robledo, ovviamente, che l'accusa
di avergli scippato l'inchiesta Expo con la complicità di Bruti. Ma bugiardo è,
per la Boccassini, anche un altro collega, il pm nazionale antimafia Filippo
Spiezia, che al Csm ha ribadito che la Boccassini non rispetta le regole, non fa
circolare le notizie, e che tra i suoi pm c'è malumore. «Assolutamente falso»,
dice Ilda. Certo, se finirà a querele e a processi, anche questo sarà una novità
impensabile. La Boccassini difende Bruti anche per difendere se stessa: se il
capo dovesse saltare, e al suo posto arrivare un nuovo procuratore, magari non
milanese, la scelta di azzerare tutti i dipartimenti per fare piazza pulita di
ruggini e rivalità sarebbe quasi inevitabile. Oltretutto, agli atti del Csm c'è
un documento a sua firma, che sembra smentire quanto la dottoressa ha sempre
sostenuto, cioè di avere tenuto in mano a tutti i costi l'indagine Expo perché
contigua a indagini sulla 'ndrangheta. Invece il 16 aprile 2012 la Boccassini
scrive a Bruti dicendo, parlando dell'inchiesta Expo che «allo stato non
risultano contatti con esponenti della criminalità organizzata». Eppure non si
spoglia dell'inchiesta, si limita a proporre un coordinamento con il pool di
Robledo, che di fatto verrà poi estromesso dall'indagine. La Boccassini adesso
rivolge un «accorato appello» contro «le delegittimazioni della Procura di
Milano che non le merita». E invita il Csm a fare in fretta. Ma non tutti, nel
Csm, pensano che la fretta sia il modo migliore per capire che diavolo stia
accadendo.
Vi ricordate di Antonio Esposito, uno
dei giudici della Corte di Cassazione che condannò Silvio Berlusconi per il
processo “Mediaset”? «Chist'è na stupotaggine». Ormai la battuta gira
irrefrenabile. Il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, ha dato
mandato all'ispettorato del ministero per approfondire la vicenda relativa
all'intervista del giudice Antonio Esposito, presidente del collegio della
Cassazione che ha emesso la sentenza Mediaset, e ha nominato come consulente
Felice Caccamo, scrive Aldo Grasso su “Il Corriere della Sera”. Il direttore e
fondatore del giornale 'O Vicolo è l'unico in grado di interpretare lo spirito
di quella famosa intervista passata alla storia come «Vabbuò, chill' nun poteva
nun sapere». Quando si ascolta la registrazione della telefonata del presidente
Esposito al giornalista del Mattino viene spontaneo immaginarselo nelle vesti di
Felice Caccamo: giacca azzurra, cravatta con nodo esagerato, gli occhiali dalle
lenti spesse e il Vesuvio sullo sfondo: «Tengo 'o mare n' fronte, 'o cielo n'
ccoppa». Il tormentone su Caccamo (forse il più riuscito personaggio di Teo
Teocoli) è partito da un articolo di Annalisa Chirico su Panorama.it e ha fatto
in fretta a diffondersi, come succede a quelle battute che diventano subito una
spia di consenso. Persino la senatrice Alessandra Mussolini si è esibita in
un'imitazione della telefonata. Certo, tra un esimio presidente della Corte di
Cassazione e un giornalista, un po' cialtrone, intento più alle sue singolari
abitudini alimentari ('o struzzo di mare oppure 'a frittura globale), che a
scovare notizie, la differenza è abissale. Ma sono bastati una telefonata in
dialetto («Tiziu, Caiu e Semproniu an tit che te l'hanno riferito. E allora è nu
pocu divers»), un momento di eccesso di confidenza, uno stato di rilassamento
familiare per avvicinarli in maniera incredibile. Caccamo vive con la moglie
Innominata (che prende puntualmente a «mazzate in faccia») e i figli Tancredi,
Boranga e Ielpo. I suoi inseparabili amici sono Pesaola, Bruscolotti e l'ex
presidente del Napoli Ferlaino, suo vicino di casa. Ormai è una maschera
napoletana, come Pulcinella, Tartaglia (il vecchio cancelliere balbuziente,
astuto e pedante, dai grossi occhiali verdi), 'O Pazzariello («Attenzione...
battaglione... è asciuto pazzo 'o padrone...»). Caccamo sa bene che i
magistrati parlano attraverso le sentenze, ma sa anche che qualche volta parlano
al telefono.
Certo non era una verginella riguardo ai suoi trascorsi.
I guai disciplinari di Esposito: già due processi davanti al Csm.Il
magistrato è stato imputato a fine anni '90 per "protagonismo", minacce a un
cancelliere e per il doppio lavoro all'Ispi. Ma si è salvato, scrive
Emanuela
Fontana su “Il Giornale”. Non è la prima volta che il Consiglio superiore
della magistratura deve occuparsi del caso Esposito. Il giudice della Cassazione
che ha presieduto il collegio che ha condannato Silvio Berlusconi, e che in
un'intervista bomba al Mattino ha spiegato le ragioni della sentenza prima che
ne siano state depositate le motivazioni, era stato interrogato per ben due
volte in qualità di «imputato» in altrettanti procedimenti disciplinari a suo
carico. Vicende finite con l'assoluzione, ma che hanno visto comunque il
magistrato ora nell'occhio del ciclone nella scomoda posizione di difendersi di
fronte all'organo di controllo delle toghe. In uno dei due procedimenti, ricorda
adesso con Il Giornale uno dei membri della sezione che si era occupata di
questo caso, la posizione del giudice fu «in bilico e la sentenza molto
combattuta». Le accuse si chiusero comunque, va ribadito, con un nulla di fatto.
Furono rivolte tutte a Esposito alla fine degli anni 90, quando era pretore a
Sala Consilina, e riguardavano una serie di questioni, da un incarico
extra-lavorativo del magistrato, con un presunto utilizzo improprio degli uffici
giudiziari, a una presunta minaccia nei confronti di un cancelliere, passando
per accuse di «protagonismo». Le tracce di questo percorso che si è incrociato
più volte con il giudizio del Csm sono ora decriptabili grazie alla raccolta di
file audio e video di Radio Radicale. Il 18 settembre del '98, dunque, Antonio
Esposito viene ascoltato in qualità di imputato al Csm per rispondere di tre
questioni. Il segretario magistrato lo accusava di aver «gravemente mancato ai
propri doveri rendendosi immeritevole della fiducia di cui il magistrato
dovrebbe godere». Prima di tutto perché in qualità di consigliere pretore
dirigente della pretura circondariale di Sala Consilina aveva celebrato nel '91
un procedimento penale contro Maria Pia Moro per interruzione di pubblico
servizio «senza che tale procedimento fosse compreso tra quelli a lui
assegnabili». I colleghi lo accusavano del desiderio di «coltivare la propria
immagine» attraverso un processo celebre che avrebbe attirato «gli organi di
informazione». Nella relazione si parla anche di «spirito di protagonismo» («Non
protagonismo, ma assunzione di responsabilità», era stata la replica di
Esposito). La seconda accusa riguardava la concessione a «un messo comunale di
frequentare gli uffici della sede distaccata di Sapri», e di avere le chiavi di
ingresso come «uomo di fiducia» di Esposito, per il quale effettuava «vari
servizi», come il «trasporto suo e dei familiari», consegna di spese e recapito
della corrispondenza. La terza accusa era la meno facile da controbattere: il
Csm chiedeva conto a Esposito della sua attività e del suo ruolo «di estremo
rilievo» divenendo il «gestore di fatto», dell'Istituto superiore di studi
socio-pedagogici di Sapri. Il «dottor Esposito», proseguiva il segretario
magistrato, era stato autorizzato a «svolgere un incarico gratuito» di docente
in materie giuridico che invece «veniva retribuito». Non solo: «Utilizzava il
personale della sezione distaccata di Sapri per la battitura di tesi attinenti
al corso». Il capitano della compagnia dei carabinieri di Sapri, Ferdinando
Fedi, testimoniò al Csm che «il dottor Esposito era quasi sempre reperibile
presso la sede dell'Ispi». Altro appunto: Esposito era intervenuto varie volte
sulle tv locali «per reclamizzare l'istituto di cui fino a poco tempo addietro
era presidente sua moglie». Dell'altro procedimento disciplinare il Csm si è
occupato nel 99. In questo caso Esposito era stato accusato dai collaboratori di
Sala Consilina di aver pronunciato nel 94 «espressioni minacciose». Questa la
frase oggetto del processo: «Se mi va bene una certa cosa vi devo spezzare le
gambe a tutti quanti» all'indirizzo di un cancelliere. Parlando così, Esposito
«violava i doveri professionali di correttezza e di rispetto». Il processo era
partito dopo gli accertamenti del presidente del tribunale di Sala Consilina.
La rete di affari di Esposito: ecco perché fu trasferito.
Il Csm lo spostò: "Con la sua scuola guadagna centinaia di milioni che gli
permettono di avere una Jaguar, una villa a Roma e un motoscafo". Nelle carte i
favori ricevuti. E spuntano una Mercedes gratis e le cene a sbafo, scrivono
Massimo Malpica e Patricia
Tagliaferri su “Il Giornale”.
Tutta colpa di una scuola e di affari milionari. A far traslocare da Sala
Consilina Antonio Esposito, dopo un quarto di secolo nel quale il magistrato era
rimasto affezionatissimo a questa piccola perla del Tirreno, è stato il plenum
del Csm, il 7 aprile del 1994. In poco meno di cinque ore, l'organo di
autogoverno della magistratura votò a maggioranza la proposta di trasferimento
per incompatibilità ambientale. Le 32 pagine di verbale di quella seduta
raccontano il dibattito serrato dei consiglieri che dovevano decidere del suo
futuro. Forse con una certa apprensione, visto che in apertura venne ricordata
l'ispezione ministeriale condotta da Vincenzo Maimone, con lo 007 portato in
tribunale da Esposito e «prima condannato per calunnia e poi assolto in
appello», a maggio del 1992, perché il fatto non costituiva reato. Così il
consigliere togato Gianfranco Viglietta rilevò «come il dottor Esposito si
rivolga in modo pesantemente critico nei confronti di tutti coloro i quali
esprimano riserve sul suo operato», osservando che «ciò è certamente indice di
non particolare equilibrio». Una sindrome del complotto, insomma. Che toccava
anche uno dei presenti nel plenum, Alfonso Amatucci, il quale infatti mise a
verbale di essere «a giudizio di Esposito (...) una sorta di quinta colonna di
quel complotto presso il Csm». Ruolo che Amatucci, va da sé, negò con forza.
Spiegando di aver appreso frequentando Sapri dei «molti giudizi negativi» sul
giudice, ai quali non aveva dato peso. A far cambiare approccio ad Amatucci era
stato un primo episodio «significativo», quando «dopo aver cenato in un
ristorante», a Sapri, il consigliere «ricevette i complimenti del ristoratore
per il fatto che egli, a differenza di altri magistrati del luogo, era
intenzionato a pagare il conto». «Da quel momento» Amatucci «prese a considerare
con maggior attenzione le voci sul conto di Esposito». Lo stesso consigliere
rivelò anche un'altra «vicenda emblematica: sarebbe stata portata, per conto
della ditta Palumbo (un costruttore attivo all'epoca nell'area del golfo di
Policastro, ndr), una vettura Mercedes di colore beige, gli pare di ricordare a
benzina, acquistata» da un direttore romano di banca «con chiavi nel cruscotto,
sotto l'abitazione del dottor Esposito». Ancora Amatucci rispolverò la fresca
assoluzione dell'avvocato Francesco Vallone (che aveva dato il via con un
esposto al procedimento disciplinare contro Esposito) nel processo per calunnia
e falsa testimonianza intentato contro di lui proprio dall'ex pretore, e Vallone
aveva parlato proprio di presunti favoritismi della pretura di Sapri nei
confronti del costruttore che avrebbe «recapitato» la lussuosa berlina tedesca.
Il plenum sostenne che Amatucci, che aveva parlato di episodi non presenti negli
atti dell'istruttoria, avrebbe dovuto «comunicare per tempo elementi così gravi
e rilevanti». Alcuni consiglieri cominciarono a valutare l'ipotesi di un rinvio
della pratica in commissione, altri, come Laudi, consideravano invece
«paradossale rinviare la decisione in ragione del fatto che sono stati
presentati elementi aggravanti». Si decise di votare per il rinvio, ma la
proposta venne respinta. Il coinvolgimento di Esposito nella «scuola» di
famiglia, l'Ispi, ebbe un forte peso nella decisione, e il relatore spiegò che
quell'elemento, insieme alla presenza «ultraventennale», avevano «accresciuto il
potere» di Esposito, dando luogo «qualcosa di diverso e incompatibile con la
funzione di pretore dirigente». Anche perché il contributo che il pretore dava
alla scuola non era solo per passione. Ecco cosa scrivono i consiglieri del Csm
quando definiscono il trasferimento. Sulla scuola di formazione si soffermano a
lungo, e un po' si stupiscono davanti al tenore di vita del magistrato,
«proprietario di un villino a Roma, di una Jaguar e di un motoscafo». Avallano
così «l'ipotesi che l'Ispi abbia consentito la realizzazione di guadagni
nell'ordine di centinaia di milioni, come sembrerebbe potersi evincere dai costi
di iscrizione e dalle rette di frequenza». Insomma, toglierlo da Sapri è un
gesto «di buon governo». Al voto, 14 consiglieri sono per il trasferimento, 11
votano contro, 4 si astengono. Non è finita. Esposito a gennaio '97 cita in
giudizio davanti al Tribunale di Roma, chiedendo un risarcimento danni per 4
miliardi di lire, due componenti del Csm - Amatucci e il relatore, Franco Coccia
- insieme all'avvocato Vallone e a Ermanno Marino, «reo» d'aver raccontato ad
Amatucci di aver guidato la famosa Mercedes. Ma il tribunale di Roma respinse la
sua richiesta. Far pagare i consiglieri per le opinioni espresse nell'esercizio
delle loro funzioni era davvero troppo.
E il giudice querela il Giornale ma non chiarisce il caso Ispi.
Esposito si fa scudo dell'associazione Caponnetto e denuncia Il Giornale
per lo scoop sul doppio lavoro. Il colloquio col Mattino è lungo 40
minuti: al Csm l'audio integrale, scrivono Massimo
Malpica e Patricia
Tagliaferri su “Il Giornale”.
Il giudice Antonio Esposito si sente diffamato. Quello che ancora non conosciamo
è invece l'umore del dottor Antonio Esposito, il tuttofare della scuola Ispi,
quello che mette il suo numero di telefono tra i contatti per chi vuole fare
master o esami nella sede locale dell'università telematica. Non si sa, insomma,
cosa pensano l'uno dell'altro. L'unica cosa certa è che sono la stessa persona e
di fatto il giudice fa un doppio lavoro. La domanda allora è: si può fare?
Esposito promette querela. L'annuncio non lo fa di persona, ma si nasconde
dietro l'associazione Antonino Caponnetto di cui è presidente onorario (e che
sulla pagina Facebook «si stringe intorno al suo presidente e ai suoi familiari
vittime di una campagna vergognosa e diffamatoria dopo la sentenza di condanna
emessa a carico di Berlusconi»). In pratica tira in ballo una colonna della
lotta alla mafia per ribadire quello che il Giornale in realtà non ha mai
nascosto, e cioè che la sezione disciplinare del Csm lo ha sempre ritenuto
estraneo a tutte le accuse. O meglio, a quasi tutte, visto che il 7 aprile del
'94 il plenum del Csm approvava a maggioranza la proposta di trasferimento
d'ufficio dell'allora pretore di Sala Consilina, che venne destinato alla Corte
d'Appello di Napoli nonostante lui avesse fatto presente che l'adozione del
provvedimento gli avrebbe causato danni incalcolabili, ledendo irreversibilmente
il suo onore e il suo prestigio professionale e denunciando che la relativa
procedura sarebbe stata condotta con spirito persecutorio e diffamatorio nei
suoi confronti, in esecuzione di un disegno comune ai convenuti». I suoi
colleghi, insomma, conoscevano l'intreccio di interessi tra il pretore e la vita
sociale ed economica di Sapri. E per questo lo hanno trasferito. Nell'ultima
seduta del Csm i consiglieri ne hanno parlato a lungo, anche scontrandosi sulle
diverse interpretazione di certi episodi. Ma alla fine sono stati d'accordo sul
fatto che «la presenza ultraventennale di Esposito nella pretura di Sala
Consilina e il suo coinvolgimento nella gestione dell'Ispi hanno determinato una
situazione particolare che ha accresciuto il suo potere fino a dar luogo a
qualcosa di diverso e di incompatibile con la funzione di pretore dirigente».
Sulla scuola di formazione i consiglieri si soffermano a lungo, ipotizzando che
il particolare tenore di vita del magistrato che risultava «proprietario di un
villino a Roma, di una Jaguar e di un motoscafo avallassero l'ipotesi che l'Ispi
avesse consentito la realizzazione di guadagni nell'ordine di centinaia di
milioni, come sembrerebbe potersi evincere dai costi di iscrizione e dalle rette
di frequenza». Alla fine è stata proprio la gestione dell'Ispi a determinare il
trasferimento. «Dovrebbe essere provato - si legge nel provvedimento - che
Esposito svolga attività ulteriori rispetto a quella dell'insegnamento per il
quale è stato autorizzato dal Csm». E come emerge dagli accertamenti del
capitano dei carabinieri Ferdinando Fedi. «Esposito - scrivono i consiglieri -
poteva essere reperito sistematicamente presso i locali della scuola e i
collegamenti con l'Ispi venivano tenuti anche in pretura. Pure i carabinieri a
volte dovevano attendere perché nello studio del pretore erano a colloquio delle
studentesse della scuola stessa». Ora, invece, Antonio Esposito deve chiarire il
pasticciaccio della sua intervista al Mattino di Napoli. Qualche domanda se la
sta facendo anche il ministro Cancellieri, che ha messo in campo gli ispettori
di via Arenula per indagare sulla vicenda. Qualcosa non torna neppure al Csm,
dove il presidente della prima commissione Annibale Marini e il vicepresidente
Michele Vietti si sono affrettati ad acquisire l'audio integrale del colloquio.
Il Mattino ne ha pubblicato on line solo una manciata di minuti. Il resto, quasi
40 minuti, non è irrilevante. Forse il primo a dover pretendere trasparenza è
proprio il giudice Esposito. Chieda al suo amico giornalista di farci ascoltare
tutto.
Il buonsenso vorrebbe che le dichiarazioni di Esposito fossero considerate
gravi. Invece non è così, anche se danno a Berlusconi un ottimo alibi per fare
ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, scrive Alessandro Tantussi
su “Imola Oggi”. Gli “ermellini” sono basiti: ora si aprono nuovi scenari.
Ubi maior minor cessat, però mi vanto di averlo detto prima. La gravità
della sortita del magistrato non può e non deve sfuggire alla gente di buon
senso, anche a chi non mastica tutti i giorni diritto. Esposito ha smentito di
aver pronunciato quelle frasi, ma il sonoro dell’intervista registrata lo
inchioda alle sue responsabilità. Il direttore del quotidiano napoletano lo ha
ribadito: il magistrato voleva proprio dire quello, ha anticipato ad un organo
d’informazione le motivazioni della sentenza, non ancora rese note per le vie
ufficiali. Alla faccia della terzietà, della sobrietà, dello stile di vita
specchiato e della limpidezza operativa che dovrebbe contraddistinguere chi fa
la professione di Esposito. Si è verificato l’ennesimo cortocircuito tra settori
politicizzati della magistratura e alcuni media che puntano ad esasperare il
conflitto tra poteri. In Cassazione tutti sono basiti. Con le sue dichiarazioni,
che di fatto anticipano i contenuti di una sentenza impostata sul principio che
Berlusconi “sapeva” della frode fiscale, Esposito apre inevitabilmente (e
inconsapevolmente) nuovi scenari. Quelle parole, seppure ritrattate dal diretto
interessato inchiodato dal sonoro della registrazione che quindi si è beccato
del bugiardo a ragione veduta, sono un assist sia per la difesa, che ora avrà
ulteriori motivi per tentare la strada del ricorso alla Corte europea dei
diritti dell’uomo.
E anche Wanna Marchi fa ricorso a Strasburgo.
Il magistrato svelò la condanna prima della sentenza. La difesa:
"Diritti violati", scrive Stefano Zurlo
su “Il Giornale”. L'intervista show di
Antonio Esposito invade ancora giornali e tv come un'onda anomala. E lui, il
giudice del Cavaliere, si ritrova sempre più al centro dell'attenzione. Ora, e
pare incredibile, anche Wanna Marchi, l'urlatrice di Castel Guelfo, ha deciso di
portare Esposito, o meglio la claudicante giustizia italiana, a Strasburgo,
davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il motivo è molto semplice:
anche la Marchi ha letto sul Giornale il documentatissimo articolo firmato da
Stefano Lorenzetto, giornalista e scrittore con un passato nella redazione di
via Negri. Ricordate? In quel pezzo Lorenzetto rievocava una cena avvenuta a
Verona, in occasione della consegna del premio «Fair play», il 2 marzo 2009. Nel
corso della festa Lorenzetto aveva conosciuto proprio lui, Antonio Esposito. E
il magistrato, fra una portata e un brindisi, l'aveva deliziato descrivendo le
presunte performance a luci rosse del Cavaliere, lo stesso Cavaliere che
Esposito ha condannato la scorsa settimana con sentenza definitiva. Non solo:
già che c'era, gli aveva preannunciato un altro verdetto importante: quello che
di lì a un paio di giorni avrebbe travolto proprio Wanna Marchi, la regina delle
teletruffatrici, e la figlia Stefania. Affondate, rispettivamente con 9 anni e 6
mesi e 9 anni e 4 mesi di carcere. Quella sera, a sentire Lorenzetto, Esposito
era stato perentorio: la Marchi che gli stava, per usare un eufemismo,
antipatica, era colpevole. Senza se e senza ma. E puntualmente di lì a poche ore
arrivò la condanna, irrevocabile, come si dice in questi casi, per madre e
figlia. Giù il sipario, dunque. Le Marchi erano scomparse dai nostri radar.
Peccato che le sentenze non possano però essere anticipate, così come non si
dovevano bruciare sul tempo le motivazioni del processo Mediaset che il relatore
deve ancora vergare. Ma Esposito corre in avanti. Troppo. Con Silvio Berlusconi
e con Wanna Marchi, senza aspettare quel momento burocratico e noioso, ravvivato
da chissà quali sbadigli, chiamato camera di consiglio. Così le Marchi, dopo
aver digerito la clamorosa sorpresa, hanno deciso di giocare la carta del
ricorso a Strasburgo: se le rivelazioni a posteriori sono esatte, il presidente
del collegio non era imparziale. «Attenzione - spiega l'avvocato Liborio
Cataliotti - Wanna Marchi non intende negare le proprie responsabilità e neppure
cerca una qualche scorciatoia rispetto alla pena, in gran parte già scontata, e
al successivo percorso di reinserimento nella società insieme alla figlia. Wanna
ha avuto prima il lavoro esterno, poi la sospensione della pena; Stefania ha
lasciato la cella per motivi di salute ed è detenuta ai domiciliari. Però le
Marchi chiedono come tutti che i loro diritti fondamentali siano rispettati».
Dunque, a Strasburgo si cercherà di capire se la Suprema corte abbia agito in
modo canonico oppure se quelle confidenze spifferate nel bel mezzo di un
banchetto conviviale costituiscano una ferita che oggi deve essere sanata. Il
viaggio a Strasburgo non sarà una passeggiata: ci vorrà tempo e certo
un'eventuale condanna non riabiliterebbe la Marchi, a capo di una vera e propria
associazione a delinquere pensata per spolpare migliaia e migliaia di creduloni
sparsi su tutto il territorio nazionale, ma sarebbe uno schiaffo per l'alto
magistrato e soprattutto per la credibilità della nostra giustizia sulla vetrina
internazionale. Cataliotti, l'avvocato di Reggio Emilia che i lettori del
Giornale conoscono bene perché a lui è affidata la maxi-causa civile, una sorta
di class action, contro Antonio Ingroia, è pronto alla battaglia. E questa volta
è lui a suggerire il possibile finale: «Se otterremo un risarcimento i soldi
andranno dritti alle parti civili». Sì, alle vittime dei raggiri della
teleimbonitrice. Senza trucco e senza inganno.
PROCESSO
MEDIASET. LA CONDANNA DI SILVIO BERLUSCONI.
I tratti
giovanili e insieme antichi del sostituto procuratore generale della Cassazione
Antonello Mura non si scompongono nel momento del successo, scrive Giovanni
Bianconi su “Il Corriere della Sera”. Professionale, s'intende. Quando il
presidente della Corte Antonio Esposito la sera del 1 agosto 2013 legge nel
dispositivo le parole «annulla limitatamente alla statuizione della condanna
accessoria» e subito dopo «rigetta nel resto», è chiaro che ha vinto il
rappresentante dell'accusa. Ma lui non lo dà a vedere. Non tradisce emozioni.
Davanti a cinque giudici chiamati «supremi» perché oltre loro la giustizia umana
non è previsto che vada, ha prevalso la tesi che Mura - per conto del suo intero
ufficio, come ha ripetuto più volte nella requisitoria - ha sostenuto nella
causa numero 27884/13 iscritta al ruolo con il numero 8, contro «Berlusconi
Silvio +3». «Nessuno dei motivi di ricorso sulla configurazione del reato e
sulla colpevolezza degli imputati ha fondamento giuridico» aveva detto con tono
pacato in quattro ore di intervento, dopo l'ormai famosa premessa sulle
«passioni e le aspettative di vario genere» che dovevano rimanere fuori
dall'aula del «palazzaccio». Le ha lasciate fuori lui e le hanno lasciate fuori
i giudici della sezione feriale della Cassazione, un collegio di magistrati
istituito con criteri casuali nel mese di maggio, ancor prima che arrivasse il
ricorso di Berlusconi contro la condanna a 4 anni di carcere nel processo
chiamato «Mediaset». Dopodiché, di fronte alle carte di quella causa e alle
ragioni esposte da accusa e difesa, i giudici hanno preso la loro decisione.
Sulla base del dispositivo letto ieri sera dal presidente Esposito si può ben
dire che hanno aderito quasi per intero all'impostazione della Procura generale.
Tranne che su un punto: la rideterminazione dell'interdizione dai pubblici
uffici, stabilita in cinque anni dalla Corte d'appello. Dovevano essere tre,
aveva detto la Procura generale, perché deve applicarsi la legge speciale del
2000 anziché la norma generale; un ricalcolo che poteva fare direttamente la
Cassazione, secondo il pg Mura, mentre la Corte ha ritenuto di non averne il
potere. Perciò rispedirà il fascicolo a Milano, insieme alle motivazioni,
affinché una nuova sezione della Corte d'appello si pronunci «limitatamente alla
statuizione della pena accessoria». Per il resto le sentenze di primo e secondo
grado, da considerarsi nel loro insieme, non presentavano vizi tali da farle
annullare; l'aveva sostenuto l'accusa e l'ha ribadito la Corte, a dispetto dei
47 motivi di presunta nullità presentati dagli avvocati Franco Coppi e Niccolò
Ghedini. Non sul piano della procedura, che è stata rispettata; non sul piano
della efficacia probatoria, ché gli elementi a fondamento della condanna si sono
rivelati coerenti e ben motivati; non sul piano del diritto, dal momento che i
reati contestati erano quelli che bisognava contestare. Ogni altra valutazione
non competeva ai giudici di legittimità. Il nocciolo del giudizio riguardava il
secondo gruppo di lamentele avanzate dalla difesa: sotto il presunto «vizio di
motivazioni» gli avvocati avevano ribadito che non c'era la prova che Berlusconi
fosse colpevole di frode fiscale, poiché dal 1994 non riveste più cariche
all'interno della Fininvest e di Mediaset e non si poteva condannarlo col
criterio del «non poteva non sapere» ciò che facevano i suoi sottoposti. Anche
il professor Coppi, aggregato dall'ex premier per quest'ultimo passaggio
giudiziario, aveva insistito sulle «prove travisate» e mancanti, sul diritto di
difesa negato, prima di immaginare un diverso tipo di reato. Ebbene, secondo i
giudici tutto questo non è vero. I dibattimenti di primo e secondo grado si sono
svolti nel rispetto delle regole del «giusto processo» e la responsabilità del
proprietario di Fininvest e Mediaset non è legata al «non poteva non sapere»,
bensì al riscontro di una partecipazione diretta al sistema illecito individuato
nelle sentenze di condanna. «Vi è la piena prova, orale e documentale che
Berlusconi abbia direttamente gestito la fase iniziale dell'enorme evasione
fiscale realizzata con le società off shore» aveva decretato la Corte d'appello.
E dopo la cessazione dalle cariche sociali aveva affidato il sistema di cui
continuava ad essere dominus, persone di sua stretta fiducia, che rispondevano
solo a lui. Ora la Cassazione ha stabilito che i giudici di merito sono giunti a
queste conclusioni senza violare alcuna norma di legge, senza contraddizioni o
illogicità. Con «motivazioni solide», aveva detto il pg. Nemmeno il fatto che
altri due giudici, a Roma e Milano, su questioni simili avessero prosciolto l'ex
premier con sentenze confermate in Cassazione significa che in questo processo
si dovesse giungere alle stesse conclusioni. «Sono decisioni che non toccavano
la questione centrale di questo processo» secondo il pg e così deve aver
ritenuto la corte. che non poteva sconfinare nella rivalutazione dei fatti. La
sentenza è arrivata dopo oltre sette ore di discussione, nelle quali i cinque
giudici «feriali» si sono confrontati per giungere a una conclusione che - vista
con gli occhi della premessa condivisa anche dagli avvocati difensori, tranne
Ghedini che non riusciva a staccarsi dalle «passioni» - sembra sancire una volta
di più l a cosiddetta «autonomia della giurisdizione». E considerato chi l'ha
pronunciata, si presta poco alle abituali letture sulla magistratura
politicizzata, condizionata da questo o quel colore.
«Non farò la
fine di Bettino Craxi». «Non mi faranno finire come Giulio Andreotti». Negli
ultimi mesi, con frequenza significativa, Silvio Berlusconi esorcizzava il
pantheon tragico dei suoi predecessori della Prima Repubblica tritati dalla
macchina della giustizia, scrive Massimo Franco, sempre su “Il Corriere della
Sera”. E senza volerlo, né saperlo, accostava la propria sorte alla loro. Il
primo, ex premier socialista, morto contumace o esule, secondo i punti di vista,
in Tunisia; il secondo, democristiano, assolto per alcuni reati e prescritto per
altri dopo processi lunghi e tormentati. Ma comunque liquidato politicamente. Il
ventennio berlusconiano cominciò all'inizio della loro fine. E adesso può essere
archiviato da una sentenza della Corte di cassazione che conferma una condanna
per frode fiscale e dilata il vuoto del sistema politico: un cratere di
incertezza più profondo di quello lasciato dalla fine della Guerra Fredda.
Puntellare la tregua politica sarà meno facile. Anche se tutti sanno che i
problemi rimangono intatti e non esiste un'alternativa al governo di larghe
intese di Enrico Letta. Il tentativo di stabilizzazione dell'Italia vacilla dopo
un verdetto che riconsegna, irrisolto, il problema dei rapporti fra politica e
magistratura. Mostra entrambe impantanate in una lotta che ha sfibrato il Paese;
e che si conclude con una vittoria dei giudici dal sapore amaro: se non altro
perché allunga un'ombra di precarietà su un'Italia bisognosa di normalità. E
poi, una parte dell'opinione pubblica tende a percepire Berlusconi come una
vittima e la sentenza rischia di accentuare questa sensazione: il tono del
videomessaggio di ieri sera a «Porta a porta» è studiato e esemplare, in
proposito. Certamente, non si tratta più del Cavaliere in auge che sugli
attacchi e sugli errori altrui mieteva consensi e potere; che risorgeva da ogni
sconfitta e sentenza sfavorevole per riemergere più agguerrito di prima, a farsi
beffe della sinistra e dei «magistrati comunisti». Non è il Berlusconi del
contratto con gli italiani stipulato davanti alle telecamere né il leader
colpito in faccia da una statuetta scagliata da un fanatico nel dicembre del
2009 dopo un comizio in piazza Duomo, a Milano, che si issava sanguinante sul
predellino dell'auto come per gridare: «Sono invincibile». Stavolta c'è un
signore appesantito dagli anni, che ha perso oltre sei milioni di voti alle
elezioni di febbraio e che lotta per la sopravvivenza. Continuando a inanellare
sbagli, la sinistra gli ha dato un altro vantaggio nelle elezioni per il
Quirinale. E non è escluso che la sentenza della Cassazione gli regali un
ultimo, involontario aiuto. Ma la corsa è diventata affannosa da tempo. Da un
paio d'anni, da quando l'illusione del berlusconismo «col sole in tasca» si è
trasformato nell'incubo di un'Italia immersa nella crisi finanziaria e
economica, la sua lotta ha velato il tentativo di salvarsi dai processi; e
l'incapacità di liberarsi del passato e di preparare una nuova classe dirigente.
Le immagini di Palazzo Grazioli, la sua residenza romana, ieri sera davano
l'idea del bunker nel quale si discuteva l'ultima battaglia. Un'offensiva
segnata stavolta dalla disperazione e dall'esasperazione, però, senza più
certezze di vittoria. Il governo e la sua maggioranza anomala sono in attesa di
sapere che cosa succederà: sebbene Berlusconi sappia che difficilmente potrebbe
nascere una coalizione meno ostile al centrodestra; anzi, forse non ne potrebbe
nascere nessuna. Fosse stato il 2008, anno della vittoria più trionfale, avrebbe
messo in riga tutti in un amen. Ora non più: le tribù berlusconiane sono in
lotta e lui fatica a tenerle unite. A frenare l'impatto della sentenza non basta
l'annullamento della parte che riguarda la sua interdizione dai pubblici uffici,
sulla quale dovrà pronunciarsi di nuovo la Corte d'appello di Milano. Né è stato
sufficiente il capovolgimento della strategia processuale, attuato dal professor
Franco Coppi: il tentativo tardivo di difendere Berlusconi nel processo e non
dal processo, come avevano fatto i suoi legali eletti in Parlamento.
L'impressione è che, accusando la magistratura di perseguitarlo, il Cavaliere
abbia alimentato senza volerlo quello che chiama «l'accanimento» della Procura;
e spinto la Cassazione a confermare le sue responsabilità senza grandi margini
di interpretazione. Il contraccolpo che si teme è quello di radicalizzare le
posizioni nel Pdl e nel Pd, nonostante i richiami del Quirinale a guardare
avanti. Le opposizioni urlano di gioia, pregustando la destabilizzazione. Ma
bisogna capire se nel centrodestra l'urto di chi vuole una crisi prevarrà
davvero sul tentativo dell'ex premier di «tenere» su una linea di
responsabilità. E, sul versante opposto, se il Pd resisterà o no alla pressione
di quella sinistra che non ha mai digerito un'alleanza in nome dell'emergenza.
Il videomessaggio diffuso da Berlusconi fornisce scarsi indizi. Sembra il
sussulto drammatico di un leader che lega le vicende di Tangentopoli del 1992-93
alle proprie, additando una parte della magistratura come «soggetto
irresponsabile». I fantasmi del passato lo tallonano, mettendogli in tasca non
raggi di sole ma presagi di umiliazione. Lui reagisce promettendo il miracolo
dell'ultima rivincita. Evoca Forza Italia e la ripropone per le elezioni europee
del 2014. Ma è un ritorno al 1994: la parabola di un ventennio.
Vent'anni
di persecuzione continua.
Cambiano
accuse e processi, ma l'obiettivo della Procura di Milano è sempre lo stesso: il
berlusconismo e l'impero del Cav, scrive
Luca Fazzo su
“Il Giornale”. E pensare che sarebbe bastato poco. Forse un po' di pazienza in
più da parte di Silvio Berlusconi. Forse qualche oscillazione nei misteriosi,
delicati equilibri di potere che governano la Procura milanese. Quattordici anni
fa, la pace che avrebbe cambiato la storia del paese era a portata di mano: e
non si sarebbe arrivati alla sentenza di oggi. Una domenica di maggio del 1999
Berlusconi salì nell'ufficio del pubblico ministero Francesco Greco e ci rimase
tre ore. Con Greco e il suo collega Paolo Ielo si parlò ufficialmente di una
accusa di falso in bilancio. Ma era chiaro a tutti - e il procuratore capo
Gerardo D'Ambrosio lo rese esplicito - che quell'incontro era il segno di un
tentativo di dialogo. Berlusconi faceva alcune ammissioni, concedeva - e lo mise
per iscritto in una memoria - che l'«espansione impetuosa» del suo gruppo poteva
avere creato «percorsi finanziari intricati». La Procura si impegnava ad evitare
accanimenti, e a trattare Berlusconi alla stregua di qualunque altro
imprenditore: con la possibilità di fuoriuscite soft come quelle concesse al
gruppo Fiat. Sarebbe interessante capire ora, a distanza di tanti anni, dove si
andò a intoppare il dialogo. Sta di fatto che rapida come era emersa, la strada
si arenò. Il partito della trattativa si arrese. E riprese, violento come prima
e più di prima, lo scontro senza quartiere. Da una parte un gruppo inquirente
che ha dimostrato di considerare Berlusconi, nelle multiformi incarnazioni dei
suoi reati, all'interno di quello che può in fondo essere letto come un unico
grande processo, come la sintesi dei vizi peggiori dell'italiano irrispettoso
delle leggi: il berlusconismo, insomma, come autobiografia giudiziaria della
nazione. Dall'altra, il Cavaliere sempre più convinto di avere di fronte un
potere fuori dalle regole, dalla cui riduzione ai binari della normalità dipende
la sua stessa sopravvivenza. Da vent'anni Berlusconi e la Procura di Milano
pensano che l'Italia sia troppo piccola per tutti e due. Ma da dove nasce, come
nasce, questa contrapposizione insanabile? L'apertura formale delle ostilità ha,
come è noto, una data precisa: 22 novembre 1994, data del primo avviso di
garanzia a Berlusconi. Ma la marcia di avvicinamento inizia prima. Inizia fin
dalla prima fase di Mani Pulite, quando il bersaglio grosso della Procura
milanese è Bettino Craxi. E, passo dopo passo, i pm si convincono che Berlusconi
- che pure con le sue televisioni tira la volata all'inchiesta - è la vera
sponda del «Cinghialone», il suo finanziatore e beneficiario. Chi c'è dietro All
Iberian, la misteriosa società che nell'ottobre 1991 versa quindici miliardi di
lire a Craxi, e riesce anche a farsene restituire cinque? Dietro questa domanda,
che diventa strada facendo una domanda retorica, i pm lavorano a dimostrare la
saldatura tra Craxi e Berlusconi. Quando nell'aprile 1994 Berlusconi diventa
presidente del Consiglio, per il pool la vicinanza Craxi-Berlusconi diventa
anche continuità politica, perché da subito la battaglia craxiana contro il
potere (o strapotere) giudiziario diventa uno dei cavalli di battaglia del nuovo
premier. Dal Quirinale viene messo il veto alla nomina di Cesare Previti a
ministro della Giustizia. Ma al ministero va Alfredo Biondi, che di lì a poco
vara il decreto subito etichettato come «salva ladri», ritirato a furor di
popolo dopo il pronunciamento del pool in diretta tv. È da quel momento che lo
scontro compie il salto di qualità. Per la Procura milanese non c'è differenza
sostanziale tra il Berlusconi imputato e il Berlusconi politico, perché il
secondo è funzionale al primo: come dimostreranno poi le leggi ad personam, e,
più di recente, la telefonata salva-Ruby alla questura di Milano. Le inchieste
che si susseguono in questi vent'anni stanno tutte in questo solco, dentro la
teoria della «capacità a delinquere» che diverrà uno dei passaggi chiave della
sentenza per i diritti tv. Sotto l'avanzare degli avvisi di garanzia, Berlusconi
si irrigidisce sempre di più, come ben racconta l'evoluzione delle strategie
difensive: da un professore pacato come Ennio Amodio si passa all'ex
sessantottardo Gaetano Pecorella, poi si approda alla coppia da ring, Niccolò
Ghedini e Piero Longo. Le dichiarazioni di sfiducia di Berlusconi verso la
serenità della giustizia milanese si fanno sempre più esplicite. Per due volte,
nel 2003 e nel 2013, il Cavaliere chiede che i suoi processi siano spostati a
Brescia, sotto un clima meno ostile. Per due volte la Cassazione gli dà torto.
Eppure, fino alla condanna definitiva di oggi, nessuno dei processi era arrivato
ad affossare Berlusconi. Assoluzioni con formula piena, prescrizioni,
proscioglimenti. Il catalogo dei modi in cui l'asse Ghedini-Longo riesce a
tenere l'eterno imputato al riparo da condanne definitive è ricco. Una parte
nasce da leggi varate per l'occasione, ma altre assoluzioni danno atto
dell'inconsistenza di accuse che la Procura riteneva granitiche. La si potrebbe
leggere come una prova della tenuta di fondo del sistema giudiziario, dei
contrappesi tra pubblici ministeri e giudici? Berlusconi non la pensa così. E la
severità delle ultime sentenze, i giudizi sferzanti dei tribunali del caso
Unipol, la batosta del risarcimento a De Benedetti, la decisione dei giudici del
processo Ruby 2 di candidarlo a una nuova incriminazione per corruzione in atti
giudiziari lo avevano già convinto definitivamente che la contiguità tra pm e
giudici era arrivata livelli intollerabili. Guardia di finanza, All Iberian,
Mills, Sme, Lodo Mondadori, diritti tv, Mediatrade, Ruby, il rosario delle pene
giudiziarie del Cavaliere a Milano sembra interminabile. Cambiano i procuratori,
cambiano alcuni dei pubblici ministeri, ma la linea non cambia. Eppure questa è
la Procura dove due magistrati di spicco del pool, Antonio Di Pietro e Gerardo
D'Ambrosio, hanno detto a posteriori di non avere condiviso la decisione
dell'avviso di garanzia del 1994 (il procuratore Borrelli replicò a Di Pietro
pacatamente, «Ha detto così? Beh, se si presenta in Procura lo butto giù dalle
scale»). È la Procura dove, con Romano Prodi al governo, Francesco Greco andò a
un convegno di Micromega ad accusare il centrosinistra, «questi fanno quello che
neanche Forza Italia ha osato fare». È insomma la Procura dove la parte più
pensante si rende conto che l'insofferenza di Berlusconi verso la magistratura è
in fondo l'insofferenza di tutta la politica verso il potere giudiziario, e che
non è affatto sicuro che il dopo Berlusconi porti alle toghe spazio e prebende.
Ma per adesso lo scontro è con lui, con il Cavaliere. E i pochi giudici che in
questi anni hanno disertato, in corridoio venivano guardati storto.
BERLUSCONI:
CONFLITTO INTERESSI; INELEGGIBILITA’; ABITUALITA’ A DELINQUERE. MA IN CHE ITALIA
VIVIAMO?
"Ci è stato
negato il diritto di difenderci". L'avvocato Ghedini che assiste Berlusconi
da 16 anni: "Superato ogni limite Ascoltati soltanto i testi dei pm, a noi ne
hanno concessi appena 6", scrive Patricia Tagliaferri su “Il Giornale”.
Avrebbe voluto parlare di più, almeno tre o quattro ore, ma l'invito del
presidente Antonio Esposito a stringere i tempi lo ha spinto ad essere più
breve. Veloce ma ugualmente efficace nel cercare di convincere i giudici della
Cassazione che nel tessuto della sentenza della Corte d'Appello di Milano sui
diritti Tv Mediaset «manca la prova che Berlusconi abbia partecipato al reato».
Comincia da qui l'arringa dell'avvocato Niccolò Ghedini. Un processo che è
diventato il «suo incubo notturno», senza un solo elemento probatorio contro il
Cavaliere, condizionato dai tempi della prescrizione e dove sarebbero stati
violati i diritti della difesa. E al pg Antonio Mura che martedì aveva chiesto
di lasciare fuori dall'aula le passioni replica che è d'accordo con lui, ma che
per gli avvocati non vale: «Nel nostro mestiere le passioni ci devono
accompagnare». «Ci stato negato il diritto alla prova - attacca Ghedini - c'è un
limite all'applicazione del codice ma in questa storia è stato ampiamente
superato. Sono 16 anni che difendo il Cavaliere, sicuramente troppi, e da sempre
sento dire che dobbiamo difenderci nel processo e non dal processo. Ma come
facciamo a difenderci nel processo con il Tribunale che mi dice di concordare
con il pm le domande per i testi?». Si sofferma a lungo sui testimoni negati,
ridotti dai 171 richiesti inizialmente ai 6 effettivamente sentiti in 100
udienze, per di più comuni alle altre difese, mentre quelli della Procura sono
stati citati dal primo all'ultimo. Ghedini ammette che inizialmente la loro
lista testi fosse effettivamente «un po' entusiastica», ma poi quei nomi sono
stati ridotti su invito dei giudici a 76. Eppure non è bastato. «Ce ne hanno
concessi prima 22 - spiega il legale - poi 14, salvo dirci che erano lontani dal
nucleo essenziale della questione. Ma come si fa a dire che David Mills o i
dirigenti Mediaset che nel 2003 e nel 2004 si erano occupati degli ammortamenti
fossero lontani dal nucleo dell'imputazione? E come è possibile non voler
sentire i dirigenti della major? Gli unici testimoni ascoltati sulle asserite
società fittizie hanno detto di aver sempre operato con il gruppo, quindi hanno
smontato la tesi accusatoria e infatti non vengono neppure citati nelle
sentenze». C'è poi il capitolo sulla responsabilità soggettiva di Berlusconi e
qui la memoria deve tornare a quelle due sentenze «dimenticate», una proprio
della Cassazione, in cui si esclude che l'ex premier avesse responsabilità nella
gestione di Mediaset negli anni '90 e si afferma che fosse l'azienda a decidere
gli ammortamenti. «Stavolta il concetto usato dall'accusa è stato più raffinato
del non poteva non sapere - sostiene Ghedini - è stato detto che un buon
imprenditore come Berlusconi non poteva non avvedersi che i ricavi erano
gonfiati». La ricostruzione del Pg («Efficace e fantasiosa in alcune soluzioni
tecnico giuridiche») viene contestata punto per punto. «Il pg - sostiene Ghedini
- ha detto che per Berlusconi ci sarebbero state attività ulteriori oltre alla
fatturazione. Quindi mi sarei aspettato delle integrazioni rispetto alle
motivazioni della Corte d'Appello, in cui non c'è nulla a riguardo. Integrazioni
che non ci sono state perché non ci sono attività ulteriori oltre la
fatturazione». Le ultime parole sono per il ruolo di International Media
Service, una delle società considerate scatole vuote. «Il pg non ha affrontato
questo tema perché era il più debole. Ims era una società consolidata, che ha
versato fino all'ultimo centesimo gli utili alla capogruppo e che aveva costi
bassissimi. Faccio fatica a capire come possa essere considerata fittizia».
I fatti, così
come li racconta Franco Coppi nell'aula Brancaccio della Cassazione, sono di una
semplicità disarmante, scrive Anna Maria Greco su “Il Giornale”. Silvio
Berlusconi non è colpevole di frode fiscale: il reato non c'è com'è stato
configurato nelle due sentenze che lo hanno portato all'ultimo grado di
giudizio, perché riguardano un comportamento «non penalmente rilevante». Con
un'arringa che fa capire, anche ai più digiuni di diritto, perché merita appieno
il titolo di principe dei cassazionisti, il legale del Cavaliere chiede
l'annullamento della pronuncia d'appello, «frutto di un pregiudizio cementato
dal collante del cui prodest» e di un «abnorme travisamento della prova», per
descrivere il leader del Pdl come «il dominus di una catena truffaldina», mentre
non gestiva più il suo impero dalla discesa in politica del '94 ( come
dimostrerebbero altre sentenze, Mills e Mediatrade, mai acquisite). Solo in
subordine, Coppi chiede l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello: se la
sua tesi non venisse accolta il reato di frode fiscale andrebbe derubricato in
quello di false fatturazioni. La pena sarebbe più bassa e, per i termini ridotti
di prescrizione, sarebbe già estinto o a rischio di estinzione. «Berlusconi
doveva essere assolto già in primo grado - dice l'avvocato - le prove sono state
travisate e i fatti che gli vengono contestati non sono di rilevanza penale». Il
professore parla con uno tono sempre misurato e più che rispettoso della corte,
spesso si scusa per le ripetizioni di tesi già espresse dagli altri legali.
Comincia a parlare alle 17 e 30, dopo Niccolò Ghedini e per oltre due ore
inaugura, nella difesa di Berlusconi, uno stile tutto nuovo: spiega con garbo,
argomenta con rigore, analizza, documenta e smonta le accuse con motivazioni che
appaiono più che convincenti. Premette, citando il giurista Francesco Carrara,
che «quando la politica entra dalla porta del tempio, la giustizia fugge
impaurita dalla finestra». È solo con le ragioni del diritto che Coppi vuole
vincere. Così, se nella prima parte dell'arringa entra nel merito delle
sentenze, sempre sul piano della legittimità, nella seconda tira fuori l'asso
nella manica e, con il sorriso sulle labbra, distrugge alla radice la ragione
stessa del processo. In punta di diritto, il professore afferma che per questi
fatti si poteva parlare semmai di «abuso di diritto» con finalità di «elusione»
delle tasse, cioè solo di un illecito amministrativo e tributario. Che potrebbe
avere conseguenze penali in una precisa circostanza qui assente: il contrasto
con una disposizione antielusiva. Per Coppi, della legge 74 del 2000 sui reati
tributari, va preso in considerazione l'articolo 2 (dichiarazione infedele) e
non il 4 ( dichiarazione fraudolenta), com'è stato fatto per la condanna di
Berlusconi. «Siamo fuori - spiega - dall'ambito di applicazione dell'articolo 2
e della frode fiscale, che comporta fatture per operazioni inesistenti». Quelle
per l'acquisto di diritti tv, sono invece operazioni reali, di società «non
fittizie», con pagamenti «fatturati» e un rincaro di prezzo «giustificato».
Cambia, dunque, la loro stessa «fisionomia». L'avvocato cita diverse sentenze
della Cassazione civile, sezione tributaria, oltre a pronunce delle Sezioni
Unite e verdetti come quello per gli stilisti Dolce e Gabbana. Alla sezione
feriale, presieduta da Antonio Esposito che come gli altri segue con massima
attenzione ogni sua parola, offre la possibilità di scrivere una pagina nuova
nella giurisprudenza della Suprema Corte traendo conclusioni già implicite negli
altri pronunciamenti.
L'avvertimento di Craxi a Berlusconi ai primi tempi dell'esilio ad Hammamet: "La
macchina giudiziaria agirà anche contro di te",
scrive
Stefania Craxi su “Il Giornale”. L'avvertimento di mio padre a
Berlusconi («La macchina giudiziaria agirà anche contro di te») risale ai primi
tempi del suo esilio ad Hammamet. Craxi era rimasto molto impressionato
dall'avviso di garanzia recapitato a Berlusconi, allora presidente del
Consiglio, direttamente a Napoli dove stava presiedendo una conferenza
internazionale sulla criminalità. Assurda l'accusa, ma ancora più straordinarie
le modalità della consegna. L'avviso di garanzia fu infatti pubblicato a tutta
pagina dal Corriere della Sera, e portato a conoscenza dell'allora capo dello
Stato, Oscar Luigi Scalfaro, prima ancora di essere consegnato all'interessato.
Craxi voleva capire. Voleva capire chi avesse dato il via alla Procura di Milano
per l'attacco al Psi e agli altri partiti storici della democrazia italiana. Che
Mani Pulite fosse una iniziativa del procuratore Borrelli, non lo credeva, e non
lo avrebbe creduto nemmeno un bambino. Pensava che dietro alla Procura di Milano
ci fossero i soldi che sempre accompagnano i sommovimenti politici. C'erano i
soldi dietro Guglielmo Giannini e l'Uomo Qualunque, fin quando De Gasperi
persuase l'allora presidente della Confindustria Cicogna a tagliare i
finanziamenti; c'erano i soldi dietro Tambroni; recentemente, chissà se c'erano
i soldi dietro il tentativo di Gianfranco Fini di disarcionare Berlusconi? Mio
padre si arrovellava per capire l'origine dello tsunami che aveva distrutto la
democrazia in Italia, e ora che la giustizia politicizzata si era rimessa in
moto, avvertiva Berlusconi, facile profeta, dei guai che lo attendevano: «C'è un
vero e proprio piano al massacro che procede con gradualità e per linee
convergenti ma che ha al fondo un obiettivo, uno e uno solo, e cioè Silvio
Berlusconi». È un vero scandalo che a più di vent'anni dai fasti di Mani Pulite
non esista ancora non dico un libro, ma almeno un saggio che scavi a fondo la
verità di Tangentopoli; è un vero scandalo che la giustizia politica imperversi
ancora fino a condizionare lo svolgimento della vita politica del paese. È
avvilente che la democrazia italiana debba ancora attendere con trepidazione un
verdetto di giudici ormai impossibilitati ad essere imparziali. Ma io sono
convinta che qualsiasi sia il verdetto della Cassazione, Berlusconi saprà
dimostrarsi più forte dei suoi persecutori, un soggetto politico di primo piano
pronto a mettere gli interessi della Nazione davanti ai suoi interessi
personali.
Il Pd, prima Pci-Pds-Ds, che in questo ventennio ha fatto dell’antiberlusconismo
il suo unico vero programma per tenere unite le anime più disparate.
"Non si
può pensare di eliminare l'avversario attraverso una legge": per battere Grillo
e Berlusconi, il Partito democratico deve "tirare fuori le idee e non gli
avvocati". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, a margine della
cerimonia di chiusura dell'anno accademico della "Johns Hopkins University" di
Bologna. "Pensare come ha fatto qualche parlamentare del mio partito che si
possa sconfiggere Beppe Grillo facendo una legge per dire che il M5s non può
partecipare alle elezioni è ridicolo - ha ribadito Renzi -. Non si può pensare
di eliminare l'avversario attraverso una legge; puoi sconfiggerlo con le idee e
le proposte". Questo, secondo il sindaco, "vale per Berlusconi esattamente allo
stesso modo" pensando di sconfiggerlo "attraverso l'interpretazione di una
norma". Per Renzi "non si può pensare dopo 19 anni di dire che Berlusconi è
ineleggibile, perché se lo era, lo era anche prima. Per battere e mandare a casa
Berlusconi e per battere Grillo il Pd deve tirare fuori le idee, non gli
avvocati". Infine un riferimento all'Esecutivo. "Non si può sapere quanto durerà
il governo Letta perché non è uno yogurt che ha indicata la scadenza sulla
confezione. Se fa le cose va avanti, se non le fa va a casa" ha evidenziato
Renzi. Renzi aveva già detto e riconferma: la speranza di sconfiggere il
Cavaliere per via giudiziaria è «un errore» che la sinistra ha alimentato troppo
a lungo. Detto questo, l'eventuale condanna di Berlusconi a quattro anni, tre
coperti dall'indulto, rappresenta un unicum nella storia italiana per
l'indiscutibile rilievo politico del personaggio. Ex premier per quattro volte,
leader del Pdl, fama internazionale, si ritroverà a fare i conti con una pena
che, anche se solo di un anno, cambierà profondamente la sua vita personale e
pubblica. Né, per lui, potranno essere sovvertite le regole che valgono per i
normali cittadini. Se alla pena si aggiungerà anche l'interdizione - 3 o 5 anni
poco cambia - Berlusconi rischia di trovarsi anche senza la copertura
parlamentare che comunque gli garantisce spazi più ampi di movimento.
BERLUSCONI
E CRAXI: DUE CONDANNATI SENZA PASSAPORTO.
I due
condannati, senza passaporto. Analogie e differenze delle storie di Berlusconi e
Craxi dopo la sentenza della Cassazione, scrive Paolo Sacchi su “Panorama”.
«La vede, signora, la fine che avrebbero voluto farmi fare…». 21 gennaio 2000,
giorno dei funerali di Bettino Craxi. Cinque della sera, Hammamet, cimitero
cristiano, lapidi bianche, tra la Medina e il mare, che guarda l’Italia. La
famiglia Craxi volle che «Bettino» fosse sepolto così: con la bara rivolta verso
l’Italia negata. Per alcuni minuti il Cavaliere, allora spodestato da Palazzo
Chigi, ma già in rimonta dopo una lunga traversata nel deserto, e senza il thè
del fim di Bernardo Bertolucci, girato proprio in Tunisia, si apparta. Si
nasconde e piange a dirotto dietro a una tomba del cimitero cristiano di
Hammamet. Chi scrive lo raggiunge. Ha gli occhi ancora umidi. Lui si riprende e
scolpisce in via riservata con la cronista la frase ( «Lo vede che fine
avrebbero voluto farmi fare») che probabilmente avrà accompagnato, come una
sfida ma al tempo stesso una minaccia, le sue tre volte tre di presidente del
Consiglio, negli ultimi vent’anni di politica italiana. Era sinceramente
commosso e profondamente addolorato quel giorno il Cavaliere per la morte
dell’amico Bettino, e già presagiva che per lui sarebbe stata dura. Anzi,
durissima. Invitò a pranzo all’Abou Nawas di Tunisi i socialisti superstiti,
allora guidati da Enrico Boselli. Li chiamò a una battaglia di libertà, ma loro,
che avevano all’epoca ministri nel governo di Massimo D’Alema , nicchiarono.
Fino a scomparire. In molti in questi vent’anni hanno tirato per la giacca, e da
morto, Bettino Craxi. Sarebbe stato con la destra o la sinistra? Di certo lui
non sarebbe stato con quelli che nei momenti più drammatici degli ultimi giorni
all’ Hopital Militaire di Tunisi, definì «i miei assassini», ovvero gli eredi
del Pci. Non sarebbe stato neppure con Forza Italia. Ma forse un po’ più vicino
a Forza Italia sì, se proprio avesse dovuto scegliere. La sua ultima idea era
quella di fare un federazione liberalsocialista con un ritorno al sistema
proporzionale. Di certo, Berlusconi per lui era un vero e sincero amico. Tant’è
che Craxi confidò a chi scrive: «Vedrai proveranno a farlo fuori con l’arma
giudiziaria». E ancora: «Non è vero che fui io a consigliargli di entrare in
politica, gli dissi semplicemente: se te la senti, fallo. Mi sono sempre chiesto
come ha fatto a prendere tutti quei voti, io mi sono fermato alla soglia del 12
o 13 per cento….». Craxi-Berlusconi: ora c’è anche il ritiro di un passaporto
che li accomuna. Ma Craxi, come ha ricordato Berlusconi a «Libero», fu costretto
all’esilio (aveva una richiesta di condanne di oltre 20 anni e il suo partito lo
abbandonò). Berlusconi consegnerà il suo passaporto, ma gli resterà quello
datogli da quasi dieci milioni di elettori. Anche questo l’ex premier e leader
socialista, politico a tutto tondo, sulla cui tomba continuano ad andare
scolaresche e turisti italiani in pellegrinaggio, all'epoca divisi tra craxiani
e anticraxiani, a suo modo, da statista e leader visionario, aveva previsto.
DA
ALMIRANTE A CRAXI CHI TOCCA LA SINISTRA MUORE.
Da Almirante a
Craxi chi tocca la sinistra muore, scrive Marcello Veneziani su “Il Giornale”.
Vorrei conoscere la segreta legge in base alla quale chi si oppone alla sinistra
è sempre un delinquente. Cito tre esempi principali, diversi per stile ed epoca,
più altri casi paralleli. Quarant'anni fa il delinquente si chiamava Giorgio
Almirante. Aveva ottenuto un gran successo elettorale, riempiva le piazze,
spopolava in tv. Perciò si decise che era un criminale, e dunque andava messo
fuori legge col suo partito. Badate bene, il Msi in quella fase era meno
fascista di prima, era in doppiopetto, era diventato destra nazionale, apriva a
liberali e monarchici, aveva perfino (...) (...) partigiani. Ma allora risorse
il fronte antifascista. La stessa criminalizzazione era avvenuta nel '60 quando
l'Msi aveva svoltato in senso moderato, appoggiando un governo centrista, presto
rovesciato da un'insurrezione violenta di piazza. L'antifascismo veniva
sfoderato non quando si sentiva odore di fasci ma quando si sentiva odore di
voti e di governo. Su Almirante piovvero stragi e accuse tremende, si creò un
cordone sanitario per isolare la destra, la sua stampa e le sue idee, si favorì
una scissione. La persecuzione finì quando il Msi tornò piccolo e innocuo. Le
accuse di fascismo non risparmiarono neanche due combattenti antifascisti come
Sogno e Pacciardi che erano però militanti anticomunisti. La campagna infame si
accanì col Quirinale: Leone, eletto con i voti del Msi e senza quelli del Pci,
fu massacrato e costretto a dimettersi, con accuse poi rivelatesi infondate.
Vent'anni fa il delinquente si chiamava Bettino Craxi, e la sua associazione a
delinquere era non solo il Psi, ma il Caf, che comprendeva Andreotti e Fanfani
vituperato anticomunista (poi sostituito da Forlani). Craxi aveva inchiodato il
Pci all'opposizione, aveva conquistato la centralità del sistema politico,
voleva modernizzare lo Stato. Eliminato. Parallelamente Cossiga, da quando si
emancipò dall'intesa consociativa che lo aveva eletto al Quirinale e cominciò a
esternare contro i partiti, fu linciato, minacciato di impeachment, accusato di
stragi e delitti. Fino a che Cossiga depose ogni progetto gollista e si limitò a
esercitare l'arte del paradosso. Andreotti è un caso contorto ma anche lui
diventò un delinquente solo quando smise di presiedere i governi consociativi.
Ora il delinquente si chiama Berlusconi, dopo un ventennio di caccia all'uomo.
Vi risparmio di farvi la storia del berluschicidio, vi esce ormai dalle
orecchie. Dirò solo che rispetto agli altri lui ha l'aggravante tripla di essere
ricco, di non essere un politico e di avere un grande elettorato. Con lui ci
sono altri casi annessi (anche extrapolitici, come Bertolaso e don Verzè).
Esempio? Il modello Lombardia di Formigoni&Cl, un sistema di potere analogo a
quello delle coop rosse in Emilia, con le stesse ombre, ma con risultati di
eccellenza in termini di amministrazione. Massacrato mentre le coop rosse furono
risparmiate. Per la sanità la Lombardia fu indagata di pari passo con la Puglia
di Vendola, ma con una differenza: la prima funzionava bene, la seconda no.
Risultato: la prima fu sfasciata a norma di legge, la seconda no. Anche lì
l'aggravante era il largo consenso recidivo a Formigoni. Cos'hanno in comune i
casi citati? Erano antagonisti della sinistra. E poi un'altra peculiarità: da
Almirante a Pacciardi e Sogno, da Fanfani a Cossiga, a Craxi e a Berlusconi,
volevano una repubblica presidenziale, bestia nera del Partito-Principe. Il
mistero resta: come mai tutti coloro che si oppongono alla sinistra sono
delinquenti, chi per eversione, chi per golpismo, chi per malaffare? C'è una
spiegazione logica, scientifica a questa curiosa coincidenza? Cosa c'era di vero
nelle accuse? Almirante era fascista, è vero, ed è pure vero che alcuni
neofascisti erano violenti; ma Almirante e il suo partito non c'entravano nulla
con stragi, assassini e violenze, di cui furono più vittime che artefici. Craxi
navigò alla grande nel sistema delle tangenti, è vero, usò modi illeciti per
finanziare la politica, ma la tangente fu inventata storicamente dalla sinistra
dc parastatale e i finanziamenti illeciti, prima di Craxi riguardò la Dc, il Psi
antecraxi, gli alleati, più i soldi che arrivavano da Mosca al Pci e le tangenti
sull'import-export con l'est. Anche Berlusconi non è uno stinco di santo, ma se
qualunque grande azienda italiana o qualunque grande partito italiano fosse
setacciato, intercettato e perquisito con la stessa meticolosità, avrebbero
trovato reati analoghi, anzi delitti peggiori e pure arricchimenti illeciti a
spese del denaro pubblico. Appena si è scoperchiato l'affare Monte dei Paschi
vedete cosa ne è venuto fuori, suicidi inclusi. Se avessero poi applicato il
criterio usato per Berlusconi - il capo è colpevole degli illeciti compiuti nel
suo regno - avremmo avuto in galera i due terzi del capitalismo nostrano e della
partitocrazia. A questo punto la conclusione è netta: o avete il coraggio di
teorizzare l'iniquità razziale di chiunque si opponga alla sinistra, e dunque il
nesso etico e genetico tra antisinistra e criminalità, o c'è qualcosa di turpe
nella sistematica criminalizzazione del nemico. Certo, non tutti i giudici che
si sono occupati di Berlusconi e dei casi precedenti erano di parte. Alcuni
decisamente sì, erano di parte; altri invece erano solo nella parte, ovvero
accettate quelle premesse non puoi che avere quelle conseguenze; si crea un
meccanismo a cascata, una coazione a ripetere e a non contraddire le sentenze
dei colleghi di casta. Il punto era ridiscutere i presupposti dell'indagine, a
partire dall'accanimento selettivo; e poi, a valle, porsi il problema della
responsabilità, cioè considerare le conseguenze per l'Italia. I giudici non sono
una vil razza dannata, sono nella media degli italiani: l'unica differenza è che
solo loro dispongono di un potere assoluto, inconfutabile, irresponsabile. Che
non risponde di sé né dei danni pubblici che arreca. La serra in cui fioriscono
le sentenze è una Cupola editoriale-giudiziaria-finanziaria, benedetta da alcuni
poteri transnazionali. Un allineamento di fatto, non un complotto premeditato;
non è una congiura ma una congiuntura. La sinistra politica ne è solo il
terminale periferico. Non sono affatto innocentista, ma l'esperienza mi conduce
a una conclusione: ogni potere ha la sua fogna, in forme e misure diverse; ma
alcune vengono portate alla luce e altre no. Usciamo in fretta dalla seconda
repubblica: non quella nata nel '94, ma quella abortita dal '68.
BERLUSCONIANI CONTRO ANTIBERLUSCONIANI.
Berlusconiani Vs Antiberlusconiani: solito spettacolo penoso,
scrive Diego Fusaro su “Lo Spiffero”. Si è per l’ennesima volta riproposto
l’osceno spettacolo che tiene da vent’anni prigioniera la politica italiana:
quel penoso conflitto tra berlusconiani e antiberlusconiani che continua a
ottundere le menti, illudendole che il solo vero problema del nostro Paese sia
l’incarcerazione del Cavaliere o, alternativamente, la sua santificazione in
terra. Uno spettacolo patetico e, insieme, disgustoso. Se mai è possibile, per i
motivi che subito dirò, l’antiberlusconismo è più spregevole dello stesso
berlusconismo. Il berlusconismo non è un fenomeno politico. È, semplicemente,
l’economia che aspira a neutralizzare la politica, riconfigurandola – avrebbe
detto von Clausewitz– come la continuazione stessa dell’economia con altri
mezzi. Non ha nulla a che vedere con il fascismo, con buona pace della sinistra
perennemente antifascista in assenza integrale di fascismo. Il berlusconismo è
osceno, perché è di per sé oscena la dinamica, oggi dilagante, della reductio
ad unum operata dalla teologia economica, ossia di quell’integralismo
economico che aspira a ridurre tutto all’economia, alla produzione e allo
scambio delle merci. Il berlusconismo ne rappresenta l’apice, aggiungendo a
questa oscenità pittoreschi elementi da commedia all’italiana su cui è
pleonastico insistere in questa sede. Ma l’antiberlusconismo è ancora più
osceno. Nella sua intima logica, l’antiberlusconismo si regge su
un’esasperazione patologica della personalizzazione dei problemi. Quest’ultima
si rivela sempre funzionale all’abbandono dell’analisi strutturale delle
contraddizioni: ed è solo in questa prospettiva che si spiega in che senso per
vent’anni l’antiberlusconismo sia stato, per sua essenza, un fenomeno di
oscuramento integrale della comprensione dei rapporti sociali. Questi ultimi
sono stati moralizzati o, alternativamente, estetizzati, e dunque privati della
loro socialità, inducendo l’opinione pubblica a pensare che il vero problema
fossero sempre e solo il “conflitto di interessi” e le volgarità esistenziali di
un singolo individuo e non l’inflessibile erosione dei diritti sociali e la
subordinazione geopolitica, militare e culturale dell’Italia agli Stati Uniti.
Grazie all’antiberlusconismo, la sinistra ha potuto indecorosamente mutare la
propria identità, passando dall’anticapitalismo alla legalità, dalla lotta per
l’emancipazione di tutti al potere dei magistrati e dei giudici, dalla questione
sociale a quella morale, da Carlo Marx a Serena Dandini, da Antonio Gramsci alla
Gabbanelli. La sinistra, muta e cieca al cospetto della contraddizione
capitalistica, ha fatto convergere le sue attenzioni critiche su una persona
concreta (il Cavaliere), presentandola come la contraddizione vivente. In tal
maniera, ha potuto cessare di farsi carico dei problemi sociali e della miseria
prodotta dal sistema della produzione, illudendo l’elettorato e inducendolo a
pensare che il sistema, di per sé buono, fosse inficiato dall’agire immorale e
irresponsabile di un’unica persona. Quest’ultima, lungi dall’essere – nonostante
i deliri di onnipotenza del caso – la causa della reificazione globale, ne è un
effetto: più precisamente, si presenta come l’esempio vivente dell’illimitatezza
del godimento gravido di capitale, che travolge apertamente ogni limite e ogni
barriera, ogni legge e ogni istituzione che non riconosca il plus ultra
desiderativo come unica autorità e come sola legge. L’antiberlusconismo ha
permesso alla sinistra di occultare la propria adesione supina al capitale
dietro l’opposizione alla contraddizione falsamente identificata nella figura di
un’unica persona, secondo il tragicomico transito dal socialismo in un solo
paese alla contraddizione in un solo uomo. Come l’antifascismo in assenza
integrale di fascismo, così l’antiberlusconismo ha svolto il ruolo di fondazione
e di mantenimento dell’identità di una sinistra ormai conciliata con l’ordine
neoliberale (si pensi alle penose rassicurazioni di Bersani circa l’alleanza del
PD con i mercati e con il folle sogno dell’eurocrazia indecorosamente chiamata
Europa). Ingiustizia, miseria e storture d’ogni sorta hanno così cessato di
essere intese per quello che effettivamente sono, ossia per fisiologici prodotti
dell’ordo capitalistico, e hanno preso a essere concepite come
conseguenze dell’agire irresponsabile di un singolo individuo. Per la sinistra
oggi essere antiberlusconiani è l’alibi per non essere anticapitalisti.
Permettendo di riconvertire la passione anticapitalistica in indignazione
morale, l’avversione per le regole sistemiche ingiuste in loro difesa a
oltranza, l’antiberlusconismo ha, pertanto, svolto una funzione di primo piano
nella celere e performativa sostituzione dell’identità precedente della sinistra
con una nuova e indecorosa fisionomia, quella dell’adesione cadaverica alle
leggi del mercato e del capitale. Se la sinistra smette di interessarsi alla
questione sociale e, più in generale, alla galassia di problemi che, con
diritto, potrebbero compendiarsi nell’espressione programmatica “ripartire da
Marx”, con il ricco arsenale di passioni politiche che in tale figura si
cristallizzano, è opportuno smettere di interessarsi alla sinistra. I recenti
fenomeni di piazza ne sono l’esempio più tragico: mentre il popolo dei
berlusconiani si scontrava con quello degli antiberlusconiani, le sacre leggi
del mercato facevano il loro corso, sconvolgendo, ancora una volta, le nostre
vite, erodendo i diritti sociali. La situazione è, una volta di più, tragica ma
non seria. La prima mossa da compiere per tornare a pensare e a praticare la
politica è uscire dal vicolo cieco del conflitto tra berlusconiani e
antiberlusconiani.
I ROSSI
BRINDANO ALLA CONDANNA.
La stampa
rossa cavalca l'odio e brinda alla nuova Liberazione. Piovono insulti e
sberleffi dai giornali di sinistra: 1º agosto come il 25 aprile. Le offese di
Repubblica: "Vecchio attore che fa pena", scrive Stefano Filippi su “Il
Giornale”. Gran fermento nelle redazioni di tanti giornali, da Repubblica al
Fatto, dal Manifesto all'Unità. È scattata l'operazione sbianchettamento sui
calendari: la festa della Liberazione non è più il 25 aprile, ma il 1° agosto,
giorno fausto della condanna di Silvio Berlusconi. Basta con le anticaglie del
secolo scorso, c'è un nuovo piazzale Loreto: è la piazza Cavour di Roma dove
s'affaccia il Palazzaccio della Cassazione, il luogo dell'esecuzione, del
ludibrio, dello sbeffeggio di «Al Tappone», come ha scritto con la consueta
eleganza Marco Travaglio sul Fatto quotidiano, al quale non è bastato scrivere
che «Al Capone è il suo spirito guida». Suo, di Berlusconi. La gioia è esplosa
incontenibile come i tappi di champagne nelle ricorrenze più importanti.
«Condannato». «Condannato il delinquente». «Cassato». «Il pregiudicato
costituente». Un «proclama eversivo». Un irrefrenabile sentimento di «Vittoria
alata», come ha titolato il Manifesto. Sì, vittoria, come in una gara tra buoni
e cattivi, anzi tra i buoni e il Cattivo. «Certo in un Paese normale sarebbe
stata auspicabile una sconfitta politica», ammette Giuseppe Di Lello. Ma che
vuoi farci, bisogna accontentarsi: non si va troppo per il sottile pur di fare
fuori il Cavaliere (e naturalmente tutti chiedono che gli venga tolta
l'onorificenza assieme alla libertà). Dove non arriva la politica soccorre la
magistratura: «In uno stato di diritto anche le sentenze svolgono il loro ruolo
di controllo della legalità e da esse non si può prescindere», si legge sul
quotidiano che ha Toni Negri tra i collaboratori. A Repubblica è tutto un fuoco
d'artificio. Altro che la Resistenza partigiana: le truppe di Carlo De Benedetti
si sentono il Cln del ventunesimo secolo, le nuove Brigate Garibaldi, i veri
liberatori dal Nemico. Ebbro di esultanza, Francesco Merlo abbandona i toni
raffinati del passato e scende nel volgare. Per lui Berlusconi è «un vecchio
attore che per non subire la pena faceva pena». Il suo videomessaggio «una
sceneggiata con la lacrima, come il gorgonzola e i fichi». Nel Pantheon del Cav,
un «delinquente comune» e «mattatore nel baraccone della finta pietà», si
trovano «solo gli evasori truffatori». E quando la dose di volgarità è finita
subentra la violenza: «Davvero Berlusconi - arriva a scrivere Merlo -
preferirebbe che dei forsennati lo trascinassero per strada e gli infliggessero
qualche atroce supplizio». L'ex premier si è già preso nei denti una non
metaforica statuetta del duomo di Milano: poca roba, per gli intellettuali chic
di Repubblica. Anche Filippo Ceccarelli tira un sospiro di sollievo: «Si può
dire che se l'è voluta, cercata e trovata - e adesso si spera che un po' si
metta tranquillo». Ma, riconosce, «non sarà facile» liberarsi di questo
«imputato permanente e privilegiatissimo»: «Troppe visioni, troppi processi,
troppo di Berlusconi è stato sparso nella società perché lo si possa bruciare,
liquidare, o sradicare nel tempo breve di un'estate», come sarebbe augurabile.
Mai contenti, a Repubblica. Dove si definisce il videomessaggio «un proclama
eversivo». E dove il direttore Ezio Mauro trasforma l'intera parabola del
Cavaliere in un vortice di malaffare: «Il falso miracolo imprenditoriale che
nella leggenda di comodo aveva generato e continuamente rigenerava l'avventura
politica di Silvio Berlusconi ieri ha rivelato la sua natura fraudolenta».
Berlusconi è stato condannato per aver evaso, nel 2002 e 2003, 7,3 milioni di
euro a fronte di 709 milioni dichiarati: l'1 per cento in soli due anni. Che per
Repubblica è sufficiente per gettare nel fango una vita intera. Nel calendario
del Fatto - dove Travaglio si crogiola tra «fuorilegge», «delinquente
matricolato», «pregiudicato costituente» - oltre alla nuova data della
Liberazione appare anche un nuovo santo: è Fabio De Pasquale, il pubblico
ministero che ha ottenuto la prima condanna definitiva per Berlusconi e, prima
di lui, fu il primo a incastrare Bettino Craxi. Santo subito, più della beata
Ilda Boccassini. Curiosità: il Fatto e il Manifesto hanno messo in prima pagina
la stessa foto di Berlusconi corrucciato. Come insegnava la buonanima rossa di
Mao, marciare divisi per colpire uniti.
QUANDO IL
PCI RICATTO' IL COLLE: GRAZIA ALL'ERGASTOLANO.
Quando il Pci
ricattò il Colle: grazia all'ergastolano. Moranino era fuggito a Praga e
rientrò in Italia dopo l'atto di clemenza di Saragat, scrive Stefano Zurlo
su “Il Giornale”. La storia non si ripete, però ci sorprende e ci spiazza. La
storia, se si rileggono certi passaggi, può scombussolare le fondamenta dei
ragionamenti che si ripetono in questi giorni surriscaldati di mezza estate. Si
dice che la grazia non può essere un quarto grado di giudizio e che il
condannato non può riceverla se non ha cominciato ad espiare la pena. Si
ammucchiano tanti concetti, tutti politically correct, poi t'imbatti nella
vicenda tragica e drammatica di Francesco Moranino, il comandante «Gemisto»,
comunista doc, partigiano, deputato e tante altre cose ancora e sei costretto a
rivedere quei giudizi affrettati. Il caso Moranino è per certi aspetti ancora
aperto come tante pagine controverse del nostro passato, ma alcuni elementi sono
chiari. Il primo: nel 1955 il Parlamento concesse l'autorizzazione a procedere,
la prima nel Dopoguerra, e Moranino fu condannato all'ergastolo per l'uccisione
di cinque partigiani bianchi e di due delle loro mogli; il secondo: non rimase
in Italia a scontare mestamente la condanna. No, fu aiutato dal Pci a scappare.
Riparò a Praga e là attese gli eventi. Attenzione: Praga era la capitale di un
paese nemico nell'Europa sull'orlo del conflitto degli anni Cinquanta e
Sessanta. Da Praga Moranino portò a casa due risultati clamorosi; prima, nel
'58, il presidente Giovanni Gronchi commutò la sua pena: dal carcere a vita a 10
anni. Poi nel '65 il suo successore Giuseppe Saragat gli concesse la grazia. Sì,
avete letto bene. Il presidente della Repubblica cancellò con un colpo di spugna
la pena. Saragat non si preoccupò del fatto che la grazia potesse sconfessare
l'opera della magistratura e suonare appunto come un quarto grado di giudizio.
Anzi, il presidente non si fermò neppure quando il procuratore generale di
Firenze, chiamato ad esprimersi, diede un parere negativo. La grazia fu firmata
lo stesso, anche se Moranino era latitante, in fuga oltre la Cortina di ferro.
E, insomma, la sorprendente conclusione poteva essere interpretata come una resa
dello Stato ad una parte. Per piantare la bandierina della grazia, Saragat scalò
una parete di sesto grado, altro che la frode e l'evasione fiscale di cui si
parla in questi giorni. Moranino naturalmente si proclamava innocente e poi
tutto quel periodo storico convulso, la stagione della Resistenza e la sua coda
nelle settimane successive al 25 aprile, era ed è oggetto di una grande disputa:
le esecuzioni senza pietà dovevano essere coperte dallo scudo della Resistenza
che tutto giustificava e assorbiva. La querelle, come è noto, si è trascinata
nel tempo: il sangue dei vinti, come l'ha chiamato Giampaolo Pansa, non ha
ancora trovato pace. Ma Saragat non si soffermò sulle conseguenze giuridiche di
quell'atto e puntò dritto all'obiettivo della pacificazione. La politica, con i
suoi accordi sotterranei, vinse su tutto il resto, anche sull'indecenza di un
atto che, pur se bilanciato da misure di clemenza verso i neri della Repubblica
sociale, sconcertò molti italiani. L'ha spiegato molto bene Sergio Romano
rispondendo ad un lettore dalla colonne del Corriere della sera: «Credo che
Giuseppe Saragat abbia pagato un debito di riconoscenza al partito che aveva
contribuito ad eleggerlo». Saragat era diventato capo dello Stato il 28 dicembre
1964, con il contributo determinante del Pci. La grazia arrivò a tamburo
battente il 27 aprile 1965. Ci fu probabilmente un baratto: l'elezione in cambio
della chiusura di quel capitolo orrendo. Moranino rientrò con comodo, nel '68, e
il Pci non ebbe alcun imbarazzo a ricandidarlo e a farlo rieleggere. A Palazzo
Madama. L'Italia usciva così definitivamente dal clima avvelenato della guerra,
ma il prezzo pagato allo stato di diritto fu altissimo. Era il ”Re del Grano”,
l´inventore di Zemanlandia, il fautore del miracolo del Foggia in serie A e
dell´Avellino in serie B, ma per tredici anni Pasquale Casillo, noto a tutti
come “Don Pasquale” da San Giuseppe Vesuviano, pesava l´accusa del famigerato
articolo 110 - 416bis, concorso esterno in associazione di stampo mafioso: un
reato grave da cui Casillo, soltanto in tarda mattina del 16 febbraio 2007, è
stato assolto dai giudici del tribunale di Nola, in provincia di Napoli, che
hanno accolto le richieste del pubblico ministero Vincenzo D´Onofrio. Per Don
Pasquale, dunque, assistito dall´avvocato Ettore Stravino e da Bruno Von Arx, è
giunta l´assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto. Casillo
fu arrestato il 21 aprile del 1994 non solo per associazione mafiosa, ma anche
per truffa e peculato. Era stato accusato, insieme ad altri, infatti, di aver
frodato l’Aima, l´Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo. Per
questi ultimi reati è scattata la prescrizione, ma per Pasquale Casillo restava
in piedi la ben più grave macchia, il 416bis, che da ieri non ha più nulla a che
fare con l´ex Re del Grano. Un “impero”, quello di Casillo, che valeva milioni e
milioni di euro e che gli deve essere restituito poiché sono stati revocati i
provvedimenti di sequestro cautelare sulle aziende e sui beni personali. «In
questa brutta storia, potevo perdere tutto ma non la dignità» ha dichiarato
l´imprenditore. Nei primi anni ´90 l’industriale campano, presidente
dell´Assindustria di Foggia, era il gotha dell´imprenditoria nazionale: il suo
“impero” era impegnato in tutti i campi, dal commercio allo stoccaggio del
grano, dai trasporti navali al mondo del calcio. E che calcio. Ma Casillo aveva
anche partecipazioni importanti in istituti di credito (Banca Mediterranea e
Caripuglia) e società immobiliari e turistiche. E poi, oltre al Foggia di Zeman,
era proprietario anche di Salernitana e Bologna e voleva “mettere le mani” sulla
Roma di Ciarrapico. Poi, quel 21 aprile, l´arresto a Foggia: a far emettere le
ordinanze dai giudici di Napoli le deposizioni di un pentito della camorra, il
boss Pasquale Galasso. Nonostante un pool di primarie banche, coordinate
dall´ABI, avesse offerto un cospicuo finanziamento ponte di 100 miliardi di
vecchie lire, rifiutato dal neoamministratore giudiziario del gruppo, scatta la
molla dell´istanza di fallimento, richiesta dai creditori del gruppo Casillo.
Nel maggio del 1994, su istanza del Banco di Napoli, finiscono in tribunale i
libri della capogruppo, la “Casillo Grani Snc”, società in nome collettivo. E
incomincia il pellegrinaggio dell´inchiesta principale. Casillo si è sempre
dichiarato innocente, anzi «perseguitato dai giudici», e ha sempre richiesto di
essere processato subito. Con gli anni vengono prescritti tutti gli eventuali
reati fiscali. Restava, fino a ieri, solo il 416bis. E per Casillo il fantasma
della mafia, anzi della camorra campana, svanisce, così come era svanito,
qualche anno prima, per l´ex ministro dell´Interno Antonio Gava, che è stato
assolto - come molti altri imputati eccellenti - in tutti i gradi nel processo
per camorra basato in massima parte sulle dichiarazioni del medesimo pentito
Pasquale Galasso, lo stesso accusatore di Casillo.
I magistrati, diceva Calamandrei, sono come i maiali. Se ne tocchi uno gridano
tutti. Non puoi metterti contro la magistratura, è sempre stato così, è una
corporazione.
In tema di Giustizia l'Italia è maglia nera in Europa. In un anno si sono
impiegati 564 giorni per il primo grado in sede civile, contro una media
di 240 giorni nei Paesi Ocse. Il tempo medio per la conclusione di un
procedimento civile nei tre gradi di giudizio si attesta sui 788 giorni.
Non se la passa meglio la giustizia penale: la sua lentezza è la causa
principale di sfiducia nella giustizia (insieme alla percezione della mancata
indipendenza dei magistrati e della loro impunità, World Economic Forum). La
durata media di un processo penale, infatti, tocca gli otto anni e tre mesi,
con punte di oltre 15 anni nel 17% dei casi. Ora, tale premessa ci sbatte in
faccia una cruda realtà. Per Silvio Berlusconi la giustizia italiana ha tempi
record, corsie preferenziali e premure impareggiabili. Si prenda ad esempio
il processo per i diritti televisivi: tre gradi di giudizio in nove mesi, una
cosa del genere non si è mai vista in Italia. Il 26 ottobre 2012 i
giudici del Tribunale di Milano hanno condannato Silvio Berlusconi a quattro
anni di reclusione, una pena più dura di quella chiesta dalla pubblica accusa
(il 18 giugno 2012 i PM Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro chiedono al giudice
una condanna di 3 anni e 8 mesi per frode fiscale di 7,3 milioni di euro). Il 9
novembre 2012 Silvio Berlusconi, tramite i suoi legali, ha depositato il ricorso
in appello. L'8 maggio 2013 la Corte d'Appello di Milano conferma la
condanna di 4 anni di reclusione, 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e 3
anni dagli uffici direttivi. Il 9 luglio 2013 la Corte di Cassazione ha fissato
al 30 luglio 2013 l'udienza del processo per frode fiscale sui
diritti Mediaset. Processo pervenuto in Cassazione da Milano il 9 luglio con i
ricorsi difensivi depositati il 19 giugno. Per chi se ne fosse scordato - è
facile perdere il conto tra i 113 procedimenti (quasi 2700 udienze) abbattutisi
sull'ex premier dalla sua discesa in campo, marzo 1994 - Berlusconi è stato
condannato in primo grado e in appello a quattro anni di reclusione e alla pena
accessoria di cinque anni di interdizione dai pubblici uffici. Secondo i
giudici, l'ex premier sarebbe intervenuto per far risparmiare a Mediaset tre
milioni di imposte nel 2002-2003. Anni in cui, per quanto vale, il gruppo versò
all'erario 567 milioni di tasse. I legali di Berlusconi avranno adesso
appena venti giorni di tempo per articolare la difesa. «Sono esterrefatto,
sorpreso, amareggiato» dichiara Franco Coppi. Considerato il migliore avvocato
cassazionista d'Italia, esprime la sua considerazione con la sua autorevolezza e
il suo profilo non politicizzato: «Non si è mai vista un'udienza fissata con
questa velocità», che «cade tra capo e collo» e «comprime i diritti della
difesa». Spiega: «Noi difensori dovremo fare in 20 giorni quello che pensavamo
di fare con maggior respiro». Tutto perché? «Evidentemente - ragiona Coppi -, la
Cassazione ha voluto rispondere a chi paventava i rischi della prescrizione
intermedia. Ma di casi come questo se ne vedono molti altri e la Suprema Corte
si limita a rideterminare la pena, senza andare ad altro giudice. Al di là degli
aspetti formali, sul piano sostanziale, dover preparare una causa così
rinunciando a redigere motivi nuovi, perché i tempi non ci sono, significa
un'effettiva diminuzione delle possibilità di difesa». Il professore risponde
così anche all'Anm che definisce «infondate» le polemiche e nega che ci sia
accanimento contro il Cavaliere.
113 procedimenti. Tutto iniziò nel 1994
con un avviso di garanzia (poi dimostratosi infondato) consegnato a mezzo stampa
dal Corriere della Sera durante il G8 che si teneva a Napoli. Alla faccia del
segreto istruttorio. E’ evidentemente che non una delle centinaia di accuse
rivoltegli contro era fondata. Nessun criminale può farla sempre franca se
beccato in castagna. E non c’è bisogno di essere berlusconiano per affermare
questo.
E su come ci sia commistione criminale tra giornali e Procure è lo stesso
Alessandro Sallusti che si confessa. In un'intervista al
Foglio di Giuliano Ferrara, il direttore de Il
Giornale racconta i suoi anni al Corriere della Sera, e il suo
rapporto con Paolo Mieli: «Quando pubblicammo l'avviso di
garanzia che poi avrebbe fatto cadere il primo governo di Silvio Berlusconi, ero
felicissimo. Era uno scoop pazzesco. E lo rifarei. Ma si tratta
di capire perché certe notizie te le passano. Sin dai tempi di Mani pulite il
Corriere aveva due direttori, Mieli e Francesco Saverio
Borrelli, il procuratore capo di Milano. I magistrati ci passavano le
notizie, con una tempistica che serviva a favorire le loro manovre. Mi ricordo
bene la notte in cui pubblicammo l'avviso di garanzia a
Berlusconi. Fu una giornata bestiale, Mieli a un certo punto, nel
pomeriggio, sparì. Poi piombò all'improvviso nella mia stanza, fece chiamare
Goffredo Buccini e Gianluca Di Feo, che firmavano il pezzo, e ci disse, pur con
una certa dose di insicurezza, di scrivere tutto, che lo avremmo pubblicato.
Parlava con un tono grave, teso. Quella notte, poi, ci portò in pizzeria, ci
disse che aveva già scritto la lettera di dimissioni, se quello che avevamo non
era vero sarebbero stati guai seri. Diceva di aver parlato con Agnelli e poi
anche con il presidente Scalfaro. Ma poi ho ricostruito che non era così, non li
aveva nemmeno cercati, secondo me lui pendeva direttamente dalla procura di
Milano».
Si potrebbe sorridere al fatto che i processi a Silvio Berlusconi, nonostante
cotanto di principi del foro al seguito, innalzino sensibilmente la media
nazionale dello sfascio della nostra giustizia. Ma invece la domanda, che fa
capolino e che sorge spontanea, è sempre la stessa: come possiamo fidarci di
"questa" giustizia, che se si permette di oltraggiare se stessa con l’uomo più
potente d’Italia, cosa potrà fare ai poveri cristi? La memoria corre a quel film
di Dino Risi, "In nome del popolo italiano", 1971. C'è il buono, il
magistrato impersonato da Tognazzi. E poi c'è il cialtrone, o presunto tale, che
è uno strepitoso Gassman. Alla fine il buono fa arrestare il cialtrone, ma per
una cosa che non ha fatto, per un reato che non ha commesso. Il cialtrone è
innocente, ma finalmente è dentro.
Ciononostante viviamo in un’Italia fatta così, con italiani fatti così, bisogna
subire e tacere. Questo ti impone il “potere”. Ebbene, si faccia attenzione alle
parole usate per prendersela con le ingiustizie, i soprusi e le sopraffazioni,
le incapacità dei governati e l’oppressione della burocrazia,i disservizi, i
vincoli, le tasse, le code e la scarsezza di opportunità del Belpaese. Perché
sfogarsi con il classico "Italia paese di merda", per quanto
liberatorio, non può essere tollerato dai boiardi di Stato. E' reato, in
quanto vilipendio alla nazione. Lo ha certificato la Corte di cassazione -
Sezione I penale - Sentenza 4 luglio 2013 n. 28730. Accadde che un vigile, a
Montagnano, provincia di Campobasso, nel lontano 2 novembre 2005
fermò un uomo di 70 anni: la sua auto viaggiava con un solo faro acceso. Ne
seguì una vivace discussione tra il prossimo multato e l'agente. Quando
contravvenzione fu, il guidatore si lasciò andare al seguente sfogo: "Invece di
andare ad arrestare i tossici a Campobasso, pensate a fare queste stronzate e
poi si vedono i risultati. In questo schifo di Italia di merda...". Il vigile
zelante prese nota di quella frase e lo denunciò. Mille euro di multa -
In appello, il 26 aprile del 2012, per il viaggiatore senza faro che
protestò aspramente contro la contravvenzione arrivò la condanna,
pena interamente coperta da indulto. L'uomo decise così di rivolgersi alla
Cassazione. La sentenza poi confermata dai giudici della prima sezione penale
del Palazzaccio. Il verdetto: colpevole di "vilipendio alla nazione".
Alla multa di ormai otto anni fa per il faro spento, si aggiunge quella - salata
- di mille euro per l'offesa al tricolore. L'uomo si era difeso
sostenendo che non fosse sua intenzione offendere lo Stato e appellandosi al
"diritto alla libera manifestazione di pensiero". «Il diritto di manifestare il
proprio pensiero in qualsiasi modo - si legge nella sentenza depositata - non
può trascendere in offese grossolane e brutali prive di alcuna correlazione con
una critica obiettiva»: per integrare il reato, previsto dall'articolo 291 del
codice penale, «è sufficiente una manifestazione generica di vilipendio alla
nazione, da intendersi come comunità avente la stessa origine territoriale,
storia, lingua e cultura, effettuata pubblicamente». Il reato in esame, spiega
la Suprema Corte, «non consiste in atti di ostilità o di violenza o in
manifestazioni di odio: basta l'offesa alla nazione, cioè un'espressione di
ingiuria o di disprezzo che leda il prestigio o l'onore della collettività
nazionale, a prescindere dai vari sentimenti nutriti dall'autore». Il
comportamento dell'imputato, dunque, che «in luogo pubblico, ha inveito contro
la nazione», gridando la frase “incriminata”, «sia pure nel contesto di
un'accesa contestazione elevatagli dai carabinieri per aver condotto
un'autovettura con un solo faro funzionante, integra - osservano gli “ermellini”
- il delitto di vilipendio previsto dall'articolo 291 cp, sia nel profilo
materiale, per la grossolana brutalità delle parole pronunciate pubblicamente,
tali da ledere oggettivamente il prestigio o l'onore della collettività
nazionale, sia nel profilo psicologico, integrato dal dolo generico, ossia dalla
coscienza e volontà di proferire, al cospetto dei verbalizzanti e dei numerosi
cittadini presenti sulla pubblica via nel medesimo frangente, le menzionate
espressioni di disprezzo, a prescindere dai veri sentimenti nutriti dall'autore
e dal movente, nella specie di irata contrarietà per la contravvenzione subita,
che abbia spinto l'agente a compiere l'atto di vilipendio».
A questo punto ognuno di noi ammetta e confessi che, almeno per un volta nella
sua vita, ha proferito la fatidica frase “che schifo questa Italia di merda”
oppure “che schifo questi italiani di merda”.
Quando la disinformazione è l’oppio dei popoli, che li rincoglionisce. I
giornalisti corrotti ed incapaci ti riempiono la mente di merda. Anziché essere
testimoni veritieri del loro tempo, si concentrano ad influenzare l’elettorato
manovrati dal potere giudiziario, astio ad ogni riforma che li possa
coinvolgere e che obbliga i pennivendoli a tacere le malefatte delle toghe.
Silvio Berlusconi: ossessione dei giornalisti di destra e di sinistra.
Il Caimano in prima pagina: vent'anni di copertine dell'Espresso. 88. La prima,
il 5 ottobre del 1993. L'ultima, ma non ultima, il 25 novembre 2013. Ecco come
l'Espresso ha sbattuto il Cavaliere in prima pagina.
5 ottobre 1993. Berlusconi a destra. Nuove Rivelazioni: QUI MI FANNO NERO!
Dietro la svolta: Le ossessioni, la megalomania, la crisi Fininvest….
17 ottobre 1993. Esclusivo. I piani Fininvest per evitare il crac. A ME I SOLDI!
Rischio Berlusconi. Rivelazioni. Il debutto in politica e l’accordo con segni. A
ME I VOTI!
21 novembre 1993. Elezioni. Esclusivo: tutti gli uomini del partito di
Berlusconi. L’ACCHIAPPAVOTI.
7 gennaio 1994. BERLUSCONI: LE VERITA’ CHE NESSUNO DICE. Perché entra in
politica? Forse per risolvere i guai delle sue aziende? Che senso ha definirlo
imprenditore di successo? Quali sono i suoi rapporti oggi con Crazxi? Cosa
combina se si impadronisse del Governo? Quali banchieri lo vedono già a Palazzo
Chigi? Esistono cosi occulti nella Fininvest? Chi sono? Insomma: questo
partito-azienda è una barzelletta o una cosa seria?
4 marzo 1994. Speciale elezioni. CENTO NOMI DA NON VOTARE. Dossier su: buoni a
nulla, dinosauri, inquisiti, riciclati, voltagabbana.
11 marzo 1994. DIECI BUONE RAGIONI PER NON FIDARSI DI BERLUSCONI. Documenti
esclusivi da: commissione P2, magistratura milanese, Corte costituzionale.
29 luglio 1994. Troppe guerre inutili. Troppi giochetti d’azzardo. Troppe
promesse a vuoto. Troppo disprezzo degli altri. Troppe docce fredde per lira e
borsa….LA FANTASTICA CANTONATA DEGLI ITALIANI CHE SI SONO FIDATI DI BERLUSCONI.
26 agosto 1994. Tema del giorno. Atroce dubbio su Berlusconi: ci sa fare o è
un…ASINO?
18 novembre 1994. Dossier Arcore: LA REGGIA. Storia di un Cavaliere furbo, di un
avvocato, di un’ereditiera. Dossier alluvione. LA PALUDE. Storia di un governo
ottimista e di una catastrofe.
14 aprile 1995. L’incubo di pasqua. Ma davvero la destra vince? VENDETTA!
9 giugno 1995. L’AFFARE PUBBLITALIA. Tre documenti eccezionali. 1. Dell’Utri.
Viaggio tra i fondi neri. Della società che voleva conquistare un paese. 2.
Berlusconi. Le prove in mano ai giudici: dal caso Berruti alla pista estera. 3.
Letta. I verbali dei summit di Arcore. Con i big di giornali e televisioni
Fininvest.
10 settembre 1995. Case d’oro/ esclusivo. L’ALTRA FACCIA DELLO SCANDALO.
Rapporto sui raccomandati di sinistra. Rivelazioni: manovre ed imbrogli della
destra.
17 settembre 1995. L’ALTRA FACCIA DI AFFITTOPOLI/NUOVE RIVELAZIONI.
745.888.800.000! Come, dove e quanto hanno incassato i fratelli Berlusconi
rifilando palazzi e capannoni agli enti previdenziali.
25 ottobre 1995. SHOWMAN. Berlusconi ultimo grido. L’attacco a Dini e Scalfaro:
astuzie, bugie, sceneggiate.
2 febbraio 1996. L’uomo dell’inciucio. Segreti, imbrogli, stramberie, pericoli….
SAN SILVIO VERGINE.
5 aprile 1996. Dall’album di Stefania Ariosto: festa con il cavaliere. C’ERAVAMO
TANTO AMATI. Nuove strepitose foto/La dolce vita di Berlusconi & C. Caso
Squillante/Tutto sui pedinamenti. E sui gioielli Fininvest. Se vince il Polo
delle Vanità/Poveri soldi nostri…
24 ottobre 1996. D’Alema e Berlusconi: il nuovo compromesso. Origini,
retroscena, pericoli. DALEMONI.
18 dicembre 1996. FORZA BUFALE. Rivelazioni. Chi e come alimenta la campagna
contro Di Pietro. Qual è la fabbrica delle false notizie agghiaccianti sul Pool
Mani Pulite. Che cosa fa acqua nei rapporti della Guardia di Finanza. I segreti
dell’agenda di Pacini Battaglia. Le grandi manovre per l’impunità. E il ritorno
di fiamma dell’amnistia….C’è in Italia un partito antigiudici. Ha capi, quadri,
ha compagni di strada. Per vincere deve spararle sempre più grosse. Inchiesta su
un malessere che non passa. E che nessuna riforma risolve.
3 maggio 1996. THE END.
10 aprile 1997. ALBANIA SHOW. Speciale/tragedie e polemiche, sceneggiate e
pericoli.
3 agosto 2000. Esclusivo. Un rapporto dei tecnici della Banca d’Italia. COSI’ HA
FATTO I SOLDI BERLUSCONI.
22 marzo 2001. LA CARICA DEI 121. Fedelissimi, folgorati e riciclati. Con loro
Berlusconi vorrebbe governare l’Italia.
16 maggio 2001. L’AFFONDO. Berlusconi si gioca il tutto per tutto. Ma la partita
è ancora aperta. Le urne diranno se sarà alba o tramonto.
24 magio 2001. E ORA MI CONSENTA. L’Italia alle prese con il Cavaliere
pigliatutto.
19 dicembre 2001. GIUSTIZIA FAI DA ME. Sondaggio choc: i giudici, gli italiani e
Berlusconi.
7 febbraio 2002. L’importante è separare la carriera degli imputati da quella
dei giudici. L’ILLUSIONE DI MANI PULITE.
15 MAGGIO 2003. COMPARI. Negli affari, nella politica, nei processi. Berlusconi
e Previti pronti a tutto. A riscrivere le leggi e a sconvolgere le istituzioni.
11 settembre 2003. Esclusivo. GLI ZAR DELLA COSTA SMERALDA. Le foto segrete
dell’incontro Berlusconi-Putin.
29 gennaio 2004. RISILVIO. Vuole rifare il governo, rifondare Forza Italia,
riformare lo Stato. E per cominciare si è rifatto.
13 maggio 2004. LE 1000 BUGIE DI BERLUSCONI. Il suo governo ha stabilito il
record di durata. E anche quello delle promesse non mantenute. Ecco il bilancio.
24 giugno 2004. – 4.000.000. Ha perso voti e credibilità. Ora gli alleati gli
presentano il conto. L’estate torrida del cavalier Silvio Berlusconi.
3 marzo 2005. AFFARI SUOI. Società e fiduciarie nei paradisi fiscali. Falsi in
bilancio. Così Silvio Berlusconi dirottava i proventi del gruppo Mediaset sui
diritti Tv.
7 aprile 2005. RISCHIATUTTO. Il voto delle regionali segnerà il destino dei
duellanti. Romano Prodi e Silvio Berlusconi? Ecco che cosa ci aspetta dopo il
verdetto delle urne.
21 aprile 2005. FARE A MENO DI BERLUSCONI. L’ennesima sconfitta ha chiuso un
ciclo. Gli alleati del Cavaliere pensano al dopo. E a chi potrà prendere il suo
posto.
2 febbraio 2006. PSYCHO SILVIO. Impaurito dai sondaggi tenta di rinviare la
campagna elettorale. Occupa radio e tv. Promuove gli amici nei ministeri.
Distribuisce una pioggia di finanziamenti clientelari. Così Berlusconi le prova
tutte per evitare la sconfitta.
6 aprile 2006. DECIDONO GLI INDECISI. Identikit degli italiani che ancora non
hanno scelto. Ma che determineranno l’esito del voto del 9 aprile.
9 novembre 2006. LA CASA DEI DOSSIER. Da Telecom-Serbia alle incursioni
informatiche. Ecco il filo che lega le trame degli ultimi anni. Con un
obbiettivo: delegittimare Prodi e la sinistra.
29 novembre 2007. Retroscena. VOLPE SILVIO. Il piano segreto di Berlusconi per
far cadere Prodi e tornare al Governo. Fini e Casini azzerati. L’Unione
sorpresa. Ma Veltroni è tranquillo. Non mi fanno paura.
24 aprile 2008. Elezioni. L’ITALIA DI B&B. Il ciclone Berlusconi. Il trionfo di
Bossi. Lo scacco a Veltroni. E l’apocalisse della sinistra radicale rimasta
fuori dal Parlamento.
15 maggio 2008. Inchiesta. LA MARCIA SU NAPOLI. Silvio Berlusconi arriva in
città con il nuovo governo. Per liberarla dai rifiuti ma anche per spazzare via
la sinistra da Comune e Regione.
25 giugno 2008. DOPPIO GIOCO. Si propone come statista. Aperto al dialogo. Ma
poi Berlusconi vuole fermare i suoi processi. Ricusa i giudici. Vieta le
intercettazioni. Manda l’esercito nelle città. Ed è solo l’inizio.
3 luglio 2008. Esclusivo. PRONTO RAI. Raccomandazioni. Pressioni politiche.
Affari. Le telefonate di Berlusconi, Saccà, Confalonieri, Moratti, Letta,
Landolfi, Urbani, Minoli, Bordon, Barbareschi, Costanzo….
19 febbraio 2009. Berlusconi. L’ORGIA DEL POTERE. L’attacco al Quirinale e alla
Costituzione. Il caso Englaro. La giustizia. Gli immigrati. L’offensiva a tutto
campo del premier.
19 marzo 2009. Inchiesta. PIER6SILVIO SPOT. Le reti Mediaset perdono ascolto. Ma
fanno il pieno di pubblicità a scapito della Rai. Da quando Berlusconi è tornato
al governo, i grandi inserzionisti hanno aumentato gli investimenti sulle tivù
del cavaliere.
14 maggio 2009. SCACCO AL RE. Il divorzio chiesto da Veronica Lario a
Berlusconi. Tutte le donne e gli amori del Cavaliere. La contesa sull’eredità.
Le possibili conseguenze sulla politica.
11 giugno 2009. SILVIO CIRCUS. Per l’Italia la fiction: tra promesse fasulle e
clamorose assenze come nel caso Fiat-Opel. Per sé il reality: le feste in villa
e i voli di Stato per gli amici.
17 giugno 2009. Governo. ORA GUIDO IO. Umberto Bossi è il vero vincitore delle
elezioni. E già mette sotto ricatto Berlusconi e la maggioranza.
Nell’opposizione Di Pietro si prepara a contendere la leadership al PD, reduce
da una pesante sconfitta.
25 giugno 2009. ESTATE DA PAPI. Esclusivo. Le foto di un gruppo di ragazze
all’arrivo a Villa Certosa. Agosto 2008.
9 luglio 2009. Il vertice dell’Aquila. G7 E MEZZO. Berlusconi screditato dalle
inchieste e dagli scandali cerca di rifarsi l’immagine. Con la passerella dei
leader della terra sulle macerie. L’attesa per un summit che conferma la sua
inutilità.
16 luglio 2009. SILVIO SI STAMPI. Tenta di intimidire e limitare la libertà dei
giornalisti. Ma Napolitano stoppa la legge bavaglio. E i giornali stranieri non
gli danno tregua. Umberto eco: “E’ a rischio la democrazia”.
23 luglio 2009. TELESFIDA. Tra Berlusconi e Murdoch è il corso una contesa senza
esclusione di colpi. Per il predominio nella Tv del futuro. Ecco cosa succederà
e chi vincerà.
30 luglio 2009. Esclusivo. SEX AND THE SILVIO. Tutte le bugie di Berlusconi
smascherate dai nastri di Patrizia D’Addario. Notti insonni, giochi erotici,
promesse mancate, E ora la politica si interroga: può ancora governare il paese?
12 agosto 2009. Governo. SILVIO: BOCCIATO. Bugie ed escort. Conflitti con il
Quirinale. Assalti al CSM. Debito Pubblico. Decreti di urgenza. Soldi al Sud.
Clandestini e badanti. Bilancio del premier Berlusconi. E, ministro per
ministro, a ciascuno la sua pagella.
3 settembre 2009. DOPPIO GIOCO. Montagne di armi per le guerre africane. Vendute
da trafficanti italiani a suon di tangenti. Ecco la Libia di Gheddafi cui
Berlusconi renderà omaggio. Mentre l’Europa chiede di conoscere il patto anti
immigrati.
10 settembre 2009. SE QUESTO E’ UN PREMIER. Si scontra con la chiesa. Litiga con
l’Europa. Denuncia i giornali italiani e stranieri non allineati. E, non
contento, vuol metter le mani su Rai 3 e La7.
1 ottobre 2009. GHEDINI MI ROVINI. Oggi è il consigliere più ascoltato del
premier. Autore di leggi ad personam e di gaffe memorabili. Storia
dell’onorevole-avvocato, dai camerati al lodo Alfano.
8 ottobre 2009. SUA LIBERTA’ DI STAMPA. Attacchi ai giornali. Querele. Bavaglio
alle trasmissioni scomode della tv. Così Berlusconi vuole il controllo totale
dell’informazione.
15 ottobre 2009. KO LODO. La Consulta boccia l’immunità, Berlusconi torna
imputato. E rischia un’ondata di nuove accuse. Ma la sua maggioranza si rivolge
alla piazza. E apre una fase di grande tensione istituzionale.
19 novembre 2009. LA LEGGE DI SILVIO. Impunità: è l’obbiettivo di Berlusconi.
Con misure che annullano migliaia di processi. E con il ripristino dell’immunità
parlamentare. Mentre Cosentino resta al governo dopo la richiesta di arresto.
16 dicembre 2009. SCADUTO. I rapporti con i clan mafiosi. Lo scontro con Fini. I
guai con la moglie Veronica e con le escort. L’impero conteso con i figli.
L’anno orribile di Silvio Berlusconi.
21 gennaio 2010. Palazzo Chigi. SILVIO QUANTO CI COSTI. 4.500 dipendenti. Spese
fuori controllo per oltre 4 miliardi di euro l’anno. Sono i conti della
Presidenza del Consiglio. Tra sprechi, consulenze ed eventi mediatici.
4 marzo 2010. UN G8 DA 500 MILIONI DI EURO. Quanto ci è costato il vertice tra
la Maddalena e l’Aquila. Ecco il rendiconto voce per voce, tra sprechi e
raccomandazioni: dal buffet d’oro ai posacenere, dalle bandierine ai cd
celebrativi.
18 marzo 2010. SENZA REGOLE. Disprezzo della legalità. Conflitti con il
Quirinale. Attacchi ai magistrati e all’opposizione. Scandali. E ora per la
sfida elettorale Berlusconi mobilita la piazza. Con il risultato di portare il
paese nel caos.
31 marzo 2010. STOP A SILVIO. Le elezioni regionali possono fermare la deriva
populista di Berlusconi. Bersani: “Pronti al dialogo con chi, anche a destra,
vuole cambiare”.
13 maggio 2010. IL CASINO DELLE LIBERTA’. Le inchieste giudiziarie. Gli scontri
interni al partito. La paralisi del Governo. Dopo le dimissioni di Scajola,
Berlusconi nella bufera.
27 maggio 2010. STANGATA DOPPIA. Prima il blocco degli stipendi degli statali, i
tagli sulla sanità, la caccia agli evasori e un nuovo condono. Poi la scure
sulle pensioni e un ritorno alla tassa sulla casa.
8 luglio 2010. I DOLORI DEL VECCHIO SILVIO. La condanna di Dell’Utri per mafia e
il caso Brancher. La rivolta delle Regioni contro i tagli e l’immobilismo del
governo. Le faide nel Pdl e i sospetti della Lega. Il Cavaliere alla deriva.
15 luglio 2010. SENZA PAROLE.
11 novembre 2010. BASTA CON ‘STO BUNGA BUNGA. BASTA LO DICO IO.
18 novembre 2010. QUI CROLLA TUTTO. Le macerie di Pompei. L’alluvione annunciata
in Veneto. L’agonia della maggioranza. L’economia in panne. Per non dire di
escort e bunga bunga. Fotografia di un paese da ricostruire.
16 dicembre 2010. La resa dei conti tra Berlusconi e Fini è all’atto finale. Chi
perde rischia di uscire di scena. FUORI UNO.
22 dicembre 2010. FINALE DI PARTITA. Voti comprati. Tradimenti.
Regalie…Berlusconi evita a stento la sfiducia, ma ora è senza maggioranza e deve
ricominciare daccapo. Anche se resisterà, una stagione s’è chiusa. Eccola, in 40
pagine, di foto e ricordi d’autore.
27 gennaio 2011. ARCORE BY NIGHT. Un harem di giovanissime ragazze pronte a
tutto. Festini, orge, esibizioni erotiche, sesso. L’incredibile spaccato delle
serate di Berlusconi nelle sue ville. Tra ricatti e relazioni pericolose.
10 febbraio 2011. PRETTY MINETTI. Vita di Nicole, ragazza chiave dello scandalo
Ruby. Intima di Berlusconi, sa tutto sul suo harem. Se ora parlasse.
26 maggio 2011. MADUNINA CHE BOTTA! Milano gli volta le spalle, Bossi è una mina
vagante, il PDL spaccato già pensa al dopo. Stavolta Berlusconi ha perso
davvero. Analisi di una disfatta. Che, Moratti o non Moratti, peserà anche sul
governo.
21 giugno 2011. Esclusivo. VOI QUORUM IO PAPI. Domenica 12 giugno l’Italia
cambia, lui no. Domenica 12 giugno l’Italia corre a votare, lui a villa Certosa
a occuparsi d’altro. In queste foto, la wonderland del cavaliere. Lontana anni
luce dal paese reale.
7 luglio 2011. Sprechi di Stato. IO VOLO BLU MA PAGHI TU. Il governo brucia
centinaia di milioni per i suoi viaggi. E Berlusconi si regala due super
elicotteri. A spese nostre.
21 luglio 2011. MISTER CRACK. La tempesta economica. La borsa in bilico. La
paura del default. E un premier sempre isolato. Il varo della manovra è solo una
tregua. Prima della resa dei conti. E spunta l’ipotesi di un governo guidato da
Mario Monti.
25 agosto 2011. LACRIME E SANGUE. Diceva: ,meno tasse per tutti. Ma la pressione
fiscale non è mai stata così alta. Chiamava Dracula gli altri. Ma ora è lui a
mordere i soliti. Processo all’iniqua manovra d’agosto. Che ci cambia la vita e
non tocca gli evasori.
15 settembre 2011. E SILVIO SI TAGLIO’ 300 MILIONI DI TASSE. Il Premier impone
il rigore agli italiani. Ma gli atti sulla P3 svelano le trame per evitare la
causa fiscale sulla Mondadori. Dal presidente della Cassazione al
sottosegretario Caliendo, ecco chi si è mosso per salvarlo dalla maximulta.
29 settembre 2011. SERIE B.
13 ottobre 2011. SQUALIFICATO. Condannato dalla Chiesa, mollato dagli
imprenditori, bocciato dalle agenzie di rating. E’ l’agonia di un leader né
serio né credibile che non si decide a lasciare. Denuncia Romano Prodi a
“L’Espresso”: Qualsiasi governo sarebbe meglio del suo.
17 novembre 2011. THE END. Berlusconi tenterà di sopravvivere, ma ha dovuto
prendere atto della fine del suo governo. Intanto la crisi economica si fa
sempre più drammatica e la credibilità dell’Italia è ridotta a zero. Non c’è più
tempo da perdere.
19 gennaio 2012. I GATTOPARDI. Crescita, liberalizzazioni, lotta all’evasione e
alla casta…Monti è atteso alla prova più dura. Ma i partiti frenano. Come se
avessero voluto cambiare tutto per non cambiare niente.
5 luglio 2012. RIECCOLO. Attacco euro e Merkel. Destabilizza il governo Monti.
Blocca la Rai. E rivendica la leadership del suo partito. Così Berlusconi prova
ancora una volta a farsi largo.
14 febbraio 2013. VI AFFONDO IO. Pur di risalire al china Silvio Berlusconi
sfascia tutto accende la campagna elettorale con promesse da marinaio e
terrorizza i mercati. Davvero può farcela? Chi lo fermerà? E come dovrebbe
reagire il PD? L’Espresso lo ha chiesto a due guru.
19 settembre 2013. BOIA CHI MOLLA. Accettare il silenzio la decadenza o
l’interdizione. O fare un passo indietro prima del voto. Berlusconi ha pronta
una via d’uscita. Per restare il capo della destra.
29 novembre 2013. EXTRA PARLAMENTARE. Per Berlusconi si chiude un ventennio e
comincia lo scontro finale: fuori dal Senato e in piazza, dalle larghe intese
all’opposizione dura. Contro il governo, contro Napolitano, contro l’Europa…..
1977: quell'articolo premonitore di Camilla Cederna su Silvio Berlusconi. Uno
splendido pezzo di una grande firma de "L'Espresso". Che aveva già capito tutto
dell'ex Cavaliere, agli albori della sua ascesa. Il 9 maggio 2014 Silvio
Berlusconi ha cominciato a scontare la pena per frode fiscale con il “servizio
sociale” per gli anziani della Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Ma continua a
dominare le tribune elettorali, convinto di un destino da «padre della patria» e
dei risultati di Forza Italia. Inarrestabile, come è sempre stato. Ecco gli
albori della sua ascesa descritti da Camilla Cederna sul numero de “l’Espresso”
del 10 aprile 1977: un articolo in cui del personaggio si capiva già tutto e
pubblicato proprio dal “L’Espresso” il 12 maggio 2014. In un ambiente di lusso,
saloni uno via l’altro, prati di moquette, sculture che si muovono, pelle,
mogano e palissandro, continua a parlare un uomo non tanto alto, con un faccino
tondo da bambino coi baffi, nemmeno una ruga, e un nasetto da bambola. Completo
da grande sarto, leggero profumo maschio al limone. Mentre il suo aspetto
curato, i suoi modini gentili, la sua continua esplosione di idee piacerebbero a
un organizzatore di festini e congressi, il suo nome sarebbe piaciuto molto a
C.E. Gadda. Si chiama infatti Silvio Berlusconi. Un milanese che vale miliardi,
costruttore di smisurati centri residenziali, ora proprietario della stupenda
villa di Arcore dove vissero Gabrio Casati e Teresa Confalonieri (con collezione
di pittori lombardi del ’500, e mai nessun nudo per non offendere la moglie,
religiosissima), quindi della villa ex Borletti ai margini del parco di Milano.
Allergico alle fotografie («magari anche per via dei rapimenti», spiega con un
sorriso ironico solo a metà) è soddisfattissimo che nessuno lo riconosca né a
Milano né in quella sua gemma che considera Milano 2. Siccome è la sua prima
intervista, è felice di raccontarmi la sua vita felice. Media borghesia, il papà
direttore di banca che, a liceo finito, non gli dà più la mancia settimanale; ma
lui non si dispera, perché, mentre studia legge, lavora in vari modi: suonando
Gershwin o cantando le canzoni francesi alle feste studentesche. Non solo, ma
fra un trenta e lode e l’altro, fa il venditore di elettrodomestici, e la sua
strada è in salita: da venditore a venditore capo a direttore commerciale. Dopo
la sua tesi di laurea sulla pubblicità (il massimo dei voti) inizia la sua vera
attività entrando successivamente in due importanti imprese di costruzione. A
venticinque anni crea un complesso di case intorno a piazza Piemonte, ecco
quindi la fortunatissima operazione di Brugherio, una lottizzazione destinata al
ceto medio basso, mille appartamenti che van via subito; e preso dal piacere di
raccontare, ogni tanto va nel difficile, dice “congesto”, macrourbanistica,
architettura corale, la connotazione del mio carattere è la positività, “natura
non facit saltus”. Il suo sogno sarebbe esser ricercato in tutto il mondo per
fare città, e “chiamiamo il Berlusconi” dovrebbe essere l’invocazione di terre
desiderose di espandersi. Di Milano 2, l’enorme quartiere residenziale nel
Comune di Segrate, parla come di una donna che ama, completa com’è di ogni
bellezza e comfort, e centomila abitanti, che a dir che sono soddisfatti è dir
poco. Lui legge tutte le novità di architettura e urbanistica, qualche
best-seller ogni tanto, rilegge spesso “L’utopia” di Tommaso Moro, sul quale
vorrebbe scrivere un saggio. Si ritiene l’antitesi del palazzinaro, si ritiene
un progressista, è cattolico e praticante, ha votato Dc; e «se l’urbanistica è
quella che si contratta fra costruttori e potere politico, la mia allora non è
urbanistica». Grazie, e vediamo cosa dicono gli altri di lui. Lo considerano uno
dei maggiori speculatori edilizi del nostro tempo che, valendosi di grosse
protezioni vaticane e bancarie, vende le case e prende i soldi prima ancora di
costruirle, lucrando in proprio miliardi di interessi. Si lega prima con la base
dc (Marcora e Bassetti), poi col centro, così che il segretario provinciale
Mazzotta è il suo uomo. Altro suo punto di riferimento è il Psi, cioè Craxi, che
vuoi dire Tognoli, cioè il sindaco. E qui viene contraddetta la sua avversione
verso l’urbanistica come compromesso tra politici e costruttori. La società di
Berlusconi è la Edilnord, fondata nel ’63 da lui e da Renzo Rezzonico, direttore
di una società finanziaria con base a Lugano, liquidata nel ’71 per segrete
ragioni. Viene fondata allora la Edilnord centri residenziali con le stesse
condizioni della compagnia di prima: lo stesso capitale sociale (circa 10 mila
dollari), la stessa banca svizzera che fa i prestiti (la International Bank di
Zurigo), ed ecco Berlusconi procuratore generale per l’Italia. Nel ’71 il
consiglio dei Lavori Pubblici dichiara ufficialmente residenziale la terra di
Berlusconi (comprata per 500 lire al metro quadralo nel ’63 e venduta
all’Edilnord per 4.250). Da Segrate (amministrazione di sinistra prima, poi
socialista e dc) vengono concesse all’Edilnord licenze edilizie in cambio di
sostanziose somme di danaro. Umberto Dragone, allora capo del gruppo socialista
nel consiglio di Milano, pensa che l’Edilnord abbia pagato ai partiti coinvolti
il 5-10 per cento dei profitti (18-19 miliardi) che si aspettava da Milano 2.
(Qualche appartamento arredato pare sia stato dato gratis ad assessori e tecnici
dc e socialisti. Certo è che questo regalo lo ha avuto un tecnico socialista che
vive lì con una fotomodella). «II silenzio non ha prezzo, ecco il paradiso del
silenzio », era scritto sulla pubblicità di questa residenza per alta e media
borghesia. Ma il silenzio da principio non c’era. L’aeroporto di Linate è lì a
un passo, ogni 90 secondi decollava un aereo, intollerabili le onde sonore,
superiori a 100 decibel. Così l’Edilnord si muove a Roma, manovrando i
ministeri, per ottenere il cambio delle rotte degli aerei. Approfittando della
vicinanza di un ospedale, il San Raffaele, diretto da un prete trafficone e
sospeso a divinis, don Luigi Maria Verzé, manda ai vari ministeri una piantina
in cui la sua Milano 2 risulta zona ospedaliera e la cartina falsa verrà
distribuita ai piloti (con su la croce, simbolo internazionale della zona di
rispetto), così le rotte vengono cambiate spostando l’odioso inquinamento da
rumore da Milano 2 alla sezione nord-est di Segrate che per anni protesterà
invano: e il prezzo degli appartamenti viene subito triplicato. Altre notizie.
Berlusconi sta mettendo in cantiere la sua nuova Milano 3 nel Comune di Basiglio
a sud della città, con appartamenti di tipo “flessibile”, cioè con pareti che si
spostano secondo le esigenze familiari. In settembre comincerà a trasmettere dal
grattacielo Pirelli la sua Telemilano, una televisione locale con dibattiti sui
problemi della città, un’ora al giorno offerta ai giornali (egli possiede il 15
per cento del “Giornale” di Montanelli). «Troppi sono oggi i fattori ansiogeni»,
dice, «la mia sarà una tv ottimista». Staff di otto redattori, più tecnici e
cameramen, quaranta persone in tutto. E pare che in questo suo progetto sia
stato aiutato dall’amico Vittorino Colombo, ministro delle Poste e della Tv.
Berlusconi aveva anche pensato di fondare un circolo di cultura diretto da
Roberto Gervaso; la sua idea preferita però era quella di creare un movimento
interpartitico puntato sui giovani emergenti, ma per adesso vi ha soprasseduto.
Gli sarebbe piaciuto anche diventare presidente del Milan, ma la paura della
pubblicità lo ha trattenuto. Massima sua aspirazione sarebbe infine quella di
candidarsi al Parlamento europeo. Ci tiene anche a coltivare al meglio la sua
figura di padre, cercando di avere frequenti contatti coi suoi figlioletti. Quel
che deplora è che dalle elementari di adesso sia stato esiliato il nozionismo: a
lui le nozioni, in qualsiasi campo, hanno giovato moltissimo.
Camilla Cederna.
1977: Berlusconi e la pistola. Il fotografo Alberto Roveri decide di trasferire
il suo archivio in formato digitale. E riscopre così i ritratti del primo
servizio sul Cavaliere. Immagini inedite che raccontano l'anno in cui è nato il
suo progetto mediatico. Con al fianco Dell'Utri. E un revolver sul tavolo per
difendersi dai rapimenti, scrive Gianluca Di Feo su “L’Espresso”.
Formidabile quell'anno. È il 1977 quando il Dottore, come l'hanno continuato a
chiamare i suoi collaboratori più intimi, diventa per tutti gli italiani il
Cavaliere: il cavaliere del Lavoro Silvio Berlusconi. L'onorificenza viene
concessa dal presidente Giovanni Leone all'imprenditore quarantenne che ha
tirato su una città satellite, sta comprando la maggioranza del "Giornale" di
Indro Montanelli e promette di rompere il monopolio della tv di Stato. È l'anno
in cui il neocavaliere stabilisce rapporti fin troppo cordiali con il vertice
del "Corriere della Sera" e in un'intervista a Mario Pirani di "Repubblica"
annuncia di volere schierare la sua televisione al fianco dei politici
anticomunisti. Fino ad allora lo conoscevano in pochi e soltanto in Lombardia:
era il costruttore che aveva inventato Milano Due, la prima new town che
magnificava lusso, verde e protezione a prova di criminalità. Il segno di quanto
in quella stagione di terrorismo e rapine, ma soprattutto di sequestri di
persona, la sicurezza fosse il bene più prezioso. E lui, nella prima di queste
foto riscoperte dopo trentatre anni, si mostra come un uomo d'affari che sa
difendersi: in evidenza sulla scrivania c'è un revolver. Un'immagine che riporta
a film popolari in quel periodo di piombo, dai polizieschi all'italiana sui
cittadini che si fanno giustizia da soli agli esordi pistoleri di Clint
Eastwood. "Con una Magnum ci si sente felici", garantiva l'ispettore Callaghan e
anche il Cavaliere si era adeguato, infilando nella fondina una piccola e
potente 357 Magnum. È stato proprio quel revolver a colpire oggi il fotografo
Alberto Roveri mentre trasferiva la sua collezione di pellicole in un archivio
digitale: "Le stavo ingrandendo per ripulirle dalle imperfezioni quando è
spuntata quell'arma che avevo dimenticato". Come in "Blow Up" di Antonioni, a
forza di ingrandire il negativo appare la pistola: "All'epoca quello scatto
preso da lontano non mi era piaciuto e l'avevo scartato". Roveri era un
fotoreporter di strada, che nel 1983 venne assunto dalla Mondadori e negli anni
Settanta lavorava anche per "Prima Comunicazione", la rivista specializzata sul
mondo dei media: "Quando nel 1977 il direttore mi disse che dovevo fare un
servizio su Berlusconi, replicai: "E chi è?". Lui rispose: "Sta per comprare il
"Giornale" e aprire una tv. Vedrai che se ne parlerà a lungo"". Quella che
Roveri realizza è forse la prima serie di ritratti ufficiali, a cui il giovane
costruttore volle affidare la sua immagine di vincente. L'incontro avvenne negli
uffici Edilnord: "Fu di una cordialità unica, ordinò di non disturbarlo e si
mise in posa. Con mio stupore, rifiutò persino una telefonata del sindaco
Tognoli". Il solo a cui permise di interromperlo fu Marcello Dell'Utri,
immortalato in un altro scatto inedito che evidenzia il look comune: colletti
inamidati e bianchi, gemelli ai polsini, pettinature simili. Sono una coppia in
sintonia, insieme hanno creato una città dal nulla, con un intreccio di fondi
che alimentano sospetti e inchieste. Una coppia che solo pochi mesi dopo si
dividerà, perché Dell'Utri seguirà un magnate molto meno fortunato: Filippo
Alberto Rapisarda, in familiarità con Vito Ciancimino. Tornerà indietro nel
1982, organizzando prima il colosso degli spot, Publitalia, e poi quello della
politica, Forza Italia. La loro storia era cominciata nel 1974, trasformandosi
da rapporto professionale in amicizia. Dell'Utri è anche l'amministratore di
Villa San Martino, la residenza di Arcore. E dopo pochi mesi vi accoglie uno
stalliere conosciuto a Palermo che fa ancora discutere: Vittorio Mangano, poi
arrestato come assassino di Cosa nostra. Una presenza inquietante, che per la
Procura di Palermo suggella le intese economiche con la mafia in cambio di
tutela contro i sequestri. Nel 1977 però Mangano è già tornato in Sicilia. E
Berlusconi tanto sereno non doveva sentirsi, come testimonia il revolver nella
fondina. Ricorda il fotografo Roveri: "Dopo più di due ore di scatti mi invitò a
pranzo ma prima di uscire tirò fuori da un cassetto due pistole, una per sé e
una per l'autista. Di fronte alla mia sorpresa, si giustificò: "Ha idea di
quanti industriali vengono rapiti?". Poi siamo saliti su una Mercedes che lui
definì "blindatissima" per raggiungere un ristorante a soli 200 metri da lì".
Sì, quelli in Lombardia erano anni cupi, prima che, grazie anche a Canale 5,
alla nebbia di paura si sostituisse il mito luccicante della Milano da bere.
Dall'archivio di Roveri ricompare il momento della svolta, quando si cominciano
a materializzare i pilastri dell'impero del Biscione tra partiti, media e
relazioni molto particolari. È la festa del 1978 che trasforma il Cavaliere in
Sua Emittenza, con l'esordio di Telemilano nelle trasmissioni via etere. La
politica ha il volto di Carlo Tognoli, sindaco socialista che per un decennio
guida la metropoli mentre passa dagli scontri di piazza al jet set danzante
della moda. Un personaggio defilato rispetto alla statura del grande sponsor di
Berlusconi, quel Bettino Craxi che ne ha sorretto la crescita con decreti su
misura, ricevendo in cambio spot e finanziamenti. Li univa la stessa cultura del
fare che dà scarso peso alle regole, la stessa visione di una politica sempre
più spettacolo, fino a plasmare la società italiana di oggi. In questa
metamorfosi tutta televisiva la carta stampata ha avuto un ruolo secondario.
All'epoca però l'attenzione era ancora concentrata sul "Corriere della Sera", la
voce della borghesia lombarda. In questi scatti il direttore Franco Di Bella
ammira soddisfatto il giovane Silvio. Rapporti letti in un'ottica molto più
ambigua dopo la scoperta della P2: negli elenchi di Licio Gelli c'erano Di
Bella, il direttore generale della Rizzoli Bruno Tassan Din e l'editore Angelo
Rizzoli. E c'era pure il nome di Berlusconi, data di affiliazione gennaio 1978,
anche se lui ha sempre negato l'iscrizione alla loggia delle trame. Sin da
allora le smentite a qualunque costo sono un vizio del Cavaliere a cui gli
italiani si sono abituati. Come i divorzi, che segnano la sua carriera
professionale, quella politica e la vita privata. Nelle foto del party al fianco
di Silvio c'è Mike Bongiorno, il testimonial della sua ascesa mediatica.
Resteranno insieme tra alti e bassi fino al 2009: un altro legame chiuso con una
rottura burrascosa. E c'è anche Carla Dall'Oglio che si offre ai flash
sorridente, afferrando per il braccio un marito dall'aria distaccata. Lei ha 37
anni e da dodici è la signora Berlusconi: poco dopo, nel 1980, quella scena di
ostentata felicità sarà spazzata via dal colpo di fulmine per Veronica Lario. Il
divorzio è arrivato nel 1985, consolidato da una manciata di miliardi e da una
decina di immobili: da allora Carla Dall'Oglio è scomparsa dalla ribalta, dove
però sono sempre più protagonisti i suoi figli Marina e Piersilvio, i nuovi
Berlusconi.
Contro Berlusconi la sinistra contrappone i suoi miti.
San Berlinguer martire e apostolo. È in atto la costruzione di un Mito,
l'invenzione di un Grande. Serve a nobilitare il comunismo passato. A deprecare
il presente renziano, scrive Marcello Veneziani
su “Il Giornale”. San Berlinguer, il Terzo Santo. Dopo i film, i libri,
gli inserti, ora un largo Berlinguer al centro di Roma e la canonizzazione
proclamata da Napolitano in un libro-intervista, Quando c'era Berlinguer,
curato da Veltroni. È in atto la costruzione di un Mito, l'invenzione di un
Grande. A cosa serve? A nobilitare il comunismo passato. A deprecare il presente
renziano. A rianimare un partito spaesato. A cercare nel vintage un titolo di
nobiltà. A rifarsi le labbra col silicone moralista. A lanciare qualcuno per il
Quirinale. Berlinguer non aveva la statura di Togliatti e, quanto a svolte, fu
più ardito Occhetto, seppur col favore dei muri crollati. Berlinguer era
modesto, per lunghi anni allineato anche ai più sordidi eventi, mestamente
comunista, non lasciò tracce importanti, si oppose alla socialdemocrazia e la
storia gli dette torto, considerò il Partito come l'Assoluto. Fu una persona
onesta, per bene, ma basta la sua decorosa mediocrità per farne un santo con
relativa agiografia? In realtà, tramite la copiosa apologetica su di lui, si
vuol celebrare il popolo di sinistra. Berlinguer è un pretesto narrativo per
santificare gli eredi. L'industria del santino che abbina il leader del Pci a
Papa Francesco (Scalfari dixit) è all'opera. Rischiamo un pantheon di fuffa, tra
finti eroi e finti geni, finti grand'uomini e palloni gonfiati, sfornati dalla
Ditta Tarocco che produce falsi d'autore. Il P.C. oggi si traduce con
Politically Correct. Finite le sciagurate illusioni, la sinistra passò
all'illusionismo.
Perché Berlinguer sì e Togliatti no!
Lo stalinista Togliatti che non disse mai: "Compagni, ci siamo sbagliati". Il
segretario del Pci appoggiò l’eliminazione politica e fisica di molti comunisti
dissidenti. Non per paura di Mosca ma per "coerenza" ideologica, scrive Piero
Ostellino su “Il Giornale”. Molti anni fa, in un libro diventato famoso
(Togliatti 1937, Rizzoli 1964) Renato Mieli si chiedeva perché anche i comunisti
italiani - dopo le rivelazioni di Kruscev sui crimini di Stalin - non sentissero
la necessità di «stabilire la verità sulla fine di quei dirigenti comunisti
europei che scomparvero nell'Unione Sovietica durante quel periodo». Commentava
Mieli: «Il silenzio dei comunisti europei su questo doloroso passato è veramente
sconcertante». Ma, scomparso Togliatti, l'ultimo dei grandi superstiti del
Comintern e anche l'unico che avrebbe potuto parlare e rifiutò di farlo, la
verità resta sepolta sotto la pesante coltre delle complicità e dell'omertà. «Il
tempo - scriveva allora Mieli - cancellerà le tracce e gli uomini
dimenticheranno ciò che è stato. È questo che si vuole? Un delitto perfetto
insomma». Palmiro Togliatti era, nel 1937, col bulgaro Dimitrov, il finlandese
Kuusinen e il sovietico Manuilski, uno dei membri della segreteria del
Comintern. Furono loro ad avallare lo sterminio di tutti i dirigenti del partito
comunista polacco (con l'eccezione di Gomulka) a opera della polizia staliniana
con una sentenza di condanna politica. Quali fossero le ragioni che potevano
aver indotto Stalin a liberarsi del partito comunista polacco appare evidente
dal particolare momento in cui si svolsero quegli avvenimenti. Mosca stava per
accordarsi con Hitler attraverso il Patto del 1939 che avrebbe portato alla
spartizione della Polonia e allo scoppio della guerra. Il Pc polacco
rappresentava un ostacolo a tale spartizione e perciò Stalin lo eliminò per
spianarsi la strada all'eliminazione della stessa Polonia come Stato
indipendente. A spiegare l'atteggiamento dei dirigenti del Comintern c'è invece
una sola ragione, e cioè, come scrive Mieli, «la loro fedeltà al comunismo e
quindi la loro totale sottomissione al tiranno e la conseguente loro impotenza
ad opporsi». Ma avrebbero potuto Togliatti e i suoi compagni opporsi a Stalin?
Lo stesso Mieli riconosce che «c'era poco da scegliere in quelle condizioni: o
si collaborava con il regime o si finiva in galera. Togliatti, come tanti altri,
è riuscito a sopravvivere appunto perché non ha scelto la galera». Il clima di
terrore instaurato da Stalin in Urss e all'interno del movimento comunista
internazionale non è sufficiente, però, a giustificare la remissività e persino
la complicità di cui si resero responsabili gli uomini come il segretario del
Pci. Alle radici più profonde dei loro comportamenti c'era una ragione
sostanziale: che essi erano intimamente stalinisti e che in quel momento essere
comunisti e militare nella Terza internazionale equivaleva a essere dalla parte
di Stalin e condividerne i metodi. Togliatti non solo approvò ed esaltò, a
titolo personale e a nome del suo stesso partito, gli eccidi di Zinoviev e di
Kamenev, di Bukharin e di Rykov, del maresciallo Tukacevski e degli altri
ufficiali dell'Armata rossa, ma adottò del sanguinario dittatore al servizio del
quale si era messo e aveva messo il suo partito anche e soprattutto l'ideologia.
Mieli ce ne fornisce intelligentemente un esempio, riferendo dell'atteggiamento
tenuto dal segretario del Pci sulla questione polacca anche dopo le rivelazioni
di Kruscev al XX congresso del Pcus. Togliatti, da quel momento, non sostenne
più, come in precedenza, che la lotta di frazione all'interno del Pc polacco
fosse una prova sufficiente a dimostrare che il partito era stato infiltrato
dalla polizia di Pilsudski. Ma non smise, solo per questo, di affermare che
all'epoca in cui si erano svolti i fatti ciò poteva essere ritenuto verosimile,
cioè che il frazionismo bastava da solo a rendere responsabili i dirigenti di
quel partito delle colpe di cui li si accusava ingiustamente. «Questo -
concludeva Mieli - è esattamente il pensiero di Stalin che fu all'origine del
periodo del terrore». In altre parole il segretario del Pci, pur riconoscendo di
essere stato indotto in errore dalla falsa teoria staliniana sull'inasprimento
della lotta di classe e dalle prove fornite dalla polizia sovietica, non ammise
mai di essere stato egli stesso uno degli artefici della condanna politica del
Pc polacco che giustificò l'annientamento fisico dei suoi dirigenti. E
soprattutto non riconobbe mai di non aver neppure cercato di appurare se le
accuse a loro carico fossero false, in base all'assunzione che le motivazioni di
Stalin erano «in sé» sufficienti a giustificare il comportamento di un buon
comunista in quella circostanza. «Che questa scelta fosse coerente con
l'ideologia originaria - scriveva Mieli - è ovvio. Ma come si coniuga al
presente, tenendo conto della pretesa del Pci di essere considerato come
democratico? Come può un partito sedicente democratico riconoscersi in un
passato che è una negazione brutale della democrazia?» Scriveva Mieli che, per i
comunisti, «non si tratta di processare questo o quel dirigente di altri tempi,
bensì di condannare il sistema che essi tentarono di instaurare, in ossequio a
una ideologia totalitaria, che non sembra del tutto scomparsa nelle loro file».
In altre parole, il Pci avrebbe dovuto riprendere il grido disperato a suo tempo
inascoltato di una delle vittime italiane del terrore staliniano, Emilio
Guarnaschelli: «Compagni, ci siamo sbagliati». Ma poteva un'organizzazione di
massa, un grande partito come il partito comunista proclamare formalmente il
fallimento degli ideali per i quali è nato e si è battuto nel corso di tutta la
sua esistenza? Personalmente ne dubito. Del resto, è proprio questa la ragione
per la quale le generose sollecitazioni di Mieli al Pci affinché facesse luce
sul proprio passato sono cadute nel vuoto: perché ciò che per lui era un
imperativo morale, per il Pci era un impedimento politico. I comunisti italiani
sono sempre stati inchiodati alla loro storia come a una croce, perché è la
parola stessa «comunismo» che la storia ha condannato senza appello. Il fatto
poi che molti di loro, presi individualmente, lo sapessero non significa che
tale consapevolezza dovesse tradursi in comportamenti politici concreti a
livello di coscienza collettiva, cioè di partito. È a quest'ultimo che ieri
furono immolate tante vittime innocenti e oggi è sacrificata la ricerca della
verità sulla loro tragica sorte. Come membro autorevole del Comintern, Togliatti
ne divenne uno dei massimi dirigenti, contribuendo all'eliminazione, politica ma
anche fisica, di molti comunisti la cui sola colpa era di non condividere, nei
confronti dei propri Paesi, i brutali metodi di Stalin. Ciò non di meno fu, in
questo caso, ortodossamente machiavelliano, un grande realista sia escludendo,
con la «svolta di Salerno» e l'adesione alla democrazia parlamentare e
monarchica ormai nell'orbita degli Usa - che sarebbero intervenuti militarmente
in caso di pericolo rivoluzionario - sia in occasione dell'attentato subito,
quando raccomandò ai compagni di «non perdere la testa» e di non abbandonarsi a
tentativi rivoluzionari, un'avventura impraticabile che avrebbe portato il
Partito comunista, del quale era segretario pur non essendo mai stato eletto da
un Congresso, alla rovina.
Peccato però che davanti ai soldi, così come al pelo, tutti si arrendono alle
tentazioni.
Ci sono giornalisti che forse Tangentopoli la rimpiangono, del resto segnò la
loro giovinezza, la travolgente eccitazione di un periodo rivoluzionario, fatto
di personaggi straordinari, copie alle stelle, carriere in decollo: vien da
pensarlo, scrive Filippo Facci su “Libero Quotidiano”. Facciamo due esempi: 1)
Il pm di Reggio Calabria voleva contestare a Scajola e agli altri arrestati
anche l’aggravante mafiosa, ma il gip l’ha negata perché mancavano prove e anche
solo indizi. L’ha confermato lo stesso pm su Libero di sabato, dunque era noto.
Bene, ecco l’apertura di prima pagina del Corriere di domenica: «Scajola
indagato per mafia»; testo di prima pagina: «La stessa ipotesi di reato sarà
contestata a tutte le persone sospettate di aver favorito la latitanza di Amedeo
Matacena». Un falso. Una notizia manipolata, nella migliore delle ipotesi. 2)
Secondo esempio. Questa è l’apertura di prima pagina del Messaggero di domenica:
«Appalto Expo, c’è la ’ndrangheta»; sottotitolo: «I pm di Milano: legami tra gli
arrestati e le cosche"; testo di prima pagina: «La cupola di Frigerio, Greganti
e Grillo avrebbe avuto legami anche con la ’ndrangheta». Ah sì? E allora perché
l’aggravante non è stata neppure contestata? Risposta: perché non importa,
l’aggravante mafiosa ormai è come una spezia per insaporire inchieste e
resoconti. E poi scrivere, una tantum: uh, torna tangentopoli, magari.
Montanelli stronca Travaglio. In materia di giustizia Montanelli
smentisce il capofila dei giornalisti forcaioli anche dall'oltretomba, scrive
Alessandro Sallusti su “Il Giornale”. Il
tintinnio di manette riaccende gli entusiasmi di Marco Travaglio, capofila dei
giornalisti forcaioli tanto cari alle procure. Si è autonominato erede unico del
pensiero di Indro Montanelli, del quale millanta (sapendo di non poter essere
smentito) l'amicizia e la stima. Sarà, ma il vecchio Indro, che non ha mai amato
presunti portavoce, lo smentisce anche dall'oltretomba. E che smentita. È
contenuta in un articolo scritto su Il Giornale il 13 luglio dell'81.
Il giorno prima Spadolini aveva ottenuto la fiducia del suo primo governo ma il
Pci annunciava sfaceli perché il neopremier aveva posto con forza la questione
della riforma di una giustizia già malata allora. Ecco come commentava
l'accaduto Montanelli: «Riduciamo i termini all'osso. Ci sono state, per eccesso
di garantismo istruttorie svogliatamente durate anni e concluse con assoluzioni
poco meno che scandalose; mentre ci sono le manette per reati che non le
comportano obbligatoriamente, seguiti da procedimenti penali che, anche quando
si concludono col proscioglimento da ogni accusa, segnano la rovina materiale e
morale di chi ne è stato bersaglio». E ancora: «Non è possibile andare avanti
con queste invasioni di campo della magistratura che sono arrivate a tal punto
da rendere plausibile il sospetto che certi magistrati le pratichino non per
ristabilire l'ordine ma per sovvertirlo, scatenando caccia alle streghe e
colpendo all'impazzata». Aggiungeva Montanelli: «Questi magistrati sono
inamovibili, impunibili, promossi automaticamente, pagati meglio di qualsiasi
altro dipendente pubblico, incensati dai giornali di sinistra (cioè dalla
maggioranza) e molto spesso malati di protagonismo». E ancora: «I comunisti non
possono rinunciare alla magistratura com'è. Essa costituisce la più potente arma
di scardinamento e di sfascio di cui il Pci dispone». E chiudeva: «Questa non è
la magistratura, è solo il cancro della magistratura. Ma che è già arrivato allo
stadio di metastasi». Trent'anni dopo siamo ancora lì. I giornali di sinistra
(più Travaglio) a fare da addetti stampa a magistrati eversivi ed esibizionisti,
noi de Il Giornale a puntare il dito sul «cancro della magistratura»
che sta distruggendo il Paese. E siamo fermi anche nel puntare il dito contro
ladri e mascalzoni. Ma contro tutti i mascalzoni (anche se di sinistra, anche se
magistrati) e soprattutto se davvero ladri oltre ogni ragionevole dubbio.
Chissà qual è la verità tra tutte quelle propinate dai pennivendoli.
Le strane relazioni del giudice che ha condannato Silvio Berlusconi, scrive
“Libero Quotidiano”. C'è una famiglia di imprenditori di Cassino, in provincia
di Frosinone, in guerra con la magistratura da trent'anni. Loro, come spiega
Giacomo Amadori su Libero in edicola oggi, sono Vincenzo
Gabriele Terenzio, 62 anni, e il figlio Luigi, 41
anni. Sono stati arrestati e processati diverse volte. Tra prescrizioni ed
assoluzioni hanno sempre evitato la galera. "Sono vicini alla camorra",
dicono i magistrati. I reati? Truffa, evasione fiscale, bancarotta. Ma
soprattutto l'accusa di rapporti con la criminalità organizzata. Nel luglio
2013, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la confisca dei beni del 2009 e
del 2011: un tesoro da circa 150 milioni di euro. Ora si
attende la conferma del sequestro da parte della Suprema Corte. Tra i beni
confiscati diversi immobili, terreni, imbarcazioni, auto e rapporti bancari.
Secondo la Dia, i Terenzio, nel corso degli anni hanno movimentato la bellezza
di "76 milioni di euro a fronte di redditi minimi". Il figlio
Luigi, il membro più facoltoso, risulta dipendente della società svizzera Az
Fashion: stipendio di 10mila euro lordi. Insomma, la storia dei
Terenzio è costellata da guai giudiziari, e sulla stessa storia si allunga
l'ombra lunga della criminalità organizzata. La famiglia, oggi, si è stabilita
sulle rive del lago di Lugano. La Svizzera, dunque, da cui comunque continuano
ad intessere la loro rete di rapporti. Ed è proprio spulciando tra le relazioni
dei Terenzio che spunta il nome di Claudio D'Isa, 65 anni, di
Piano di Sorrento: nel 2013 fece parte della sezione feriale che condannò
Silvio Berlusconi nel processo Mediaset (per inciso, D'Isa fu
più volte corteggiato dal Pd per candidarsi a sindaco di Sorrento). Claudio
D'Isa avrebbe conosciuto i Terenzio tramite il figlio Dario, avvocato e
imprenditore. Da quella che era una vicenda giudiziaria nacque un'amicizia,
tanto che Luigi Terenzio e Dario D'Isa, dopo la sentenza
Mediaset, trascorsero insieme le vacanze estive. Un legame
scivoloso, insomma, quello tra la famiglia del giudice D'Isa e una famiglia di
pluriinquisiti e arrestati, sospettati di rapporti con la criminalità
organizzata. Un rapporto che Claudio D'Isa - intervistato da Libero in
edicola oggi - cerca di ridimensionare. Eppure sul nostro quotidiano riportiamo
testimonianze che raccontano di un quadro ben differente. Un rapporto difficile
da giustificare, per D'Isa, sempre in prima linea contro la criminalità
organizzata, tra presentazioni dei libri di Antonio Ingroia a e
lezioni nei licei sorrentini. A una di quelle lezioni, nel 2013, attaccò
Berlusconi poiché aveva criticato Roberto Saviano. Durante
quella lezione, al fianco di Claudio D'Isa, era seduto Antonio Esposito,
il presidente di quella sezione feriale di Cassazione che pochi giorni prima
aveva condannato Berlusconi. Proprio quell'Esposito finito al centro delle
polemiche per aver anticipato le motivazioni della condanna al quotidiano Il
Mattino.
Esposito, da Antonio a Vitaliano: una famiglia di toghe tra gaffe e scivoloni,
scrive “Libero Quotidiano”. Una famiglia spesso in prima pagina, e non sempre in
buona luce. Quella degli Esposito è una storia fatta di toghe, giustizia,
scivoloni e gossip. Il più famoso è ormai Antonio Esposito,
presidente della sezione feriale della Cassazione (nonché alla guida dell'Ispi)
che lo scorso agosto condannò Silvio Berlusconi al processo sui
diritti tv Mediaset e che, pochi giorni dopo, anticipò le motivazioni di quella
sentenza in una improvvida conversazione con un abile cronista del Mattino.
Inevitabili il polverone delle polemiche e le accuse di parzialità del collegio
giudicante, anche perché un testimone riferì di presunti commenti contro
Berlusconi rilasciati in libertà dal giudice durante una cena. Pare probabile
che il Csm voglia archiviare il caso senza procedere a sanzioni disciplinari. La
figuraccia, in ogni caso, resta, con tanto di richiamo del presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, in quelle caldissime settimane
di fine estate 2013, alla "continenza" per chi di mestiere fa il giudice. Le
bucce di banana per la Esposito family non finiscono qui: l'ultimo a inciamparci
è il figlio di Antonio, Ferdinando Esposito. Pubblico ministero
a Milano, risulta indagato a Brescia e a Milano in seguito alle accuse di un suo
amico avvocato, che sostiene di avergli prestato soldi e di essere stato
"pressato" per pagargli l'affitto di casa. Prima ancora, era finito al centro
del gossip per un incontro con Nicole Minetti (sotto processo
per il Rubygate) avvenuto in un prestigioso ristorante milanese
nel 2012. L'altro ramo della famiglia è altrettanto prestigioso:
Vitaliano Esposito, fratello di Antonio, è stato Procuratore generale
della Cassazione. Sempre sul finire dello scorso agosto è stato "paparazzato" in
spiaggia nel suo stabilimento abituale ad Agropoli, nel Cilento. Piccolo
particolare: lo stabilimento era abusivo. Foto imbarazzante, invece, per sua
figlia Andreana Esposito, giudice alla Corte europea dei
diritti dell'Uomo. Un po' di clamore aveva suscitato lo scatto da lei pubblicato
sui social network (e poi cancellato in fretta e furia) in cui esibiva una
maglietta decisamente inappropriata per una toga: "Beato chi crede nella
giustizia perché verrà... giustiziato", slogan che aveva messo in allarme lo
stesso Cavaliere, che di lì a qualche mese si sarebbe rivolto proprio alla Corte
europea per vedere ribaltata la sentenza stabilita dallo zio di Andreana. Un
corto circuito da barzelletta.
Quando gli attacchi al governo italiano vengono da fuori.
Caso Geithner, ira Berlusconi: “Fu un complotto contro di me”.
La ricostruzione dell’ex segretario Usa del Tesoro anticipata da La Stampa:
“Funzionari dell’Ue chiesero a Obama di far cadere Silvio”. Brunetta: s’indaghi.
Bruxelles: erano gli americani a volere l’Italia sotto tutela. Kerry: io non so
nulla, scrive “La Stampa”.
La ricostruzione di Timothy Geithner in merito alla caduta di Silvio
Berlusconi irrompe nella campagna elettorale. Il leader di Forza Italia è
furioso: «Questa è la mia rivincita. La conferma che nel 2011 c’è stato un Colpo
di Stato», dice. Mentre i suoi parlamentari chiedono un’inchiesta per fare luce
sull’accaduto. Nell’autunno del 2011, quando la drammatica crisi economica aveva
portato l’euro ad un passo dal baratro, alcuni funzionari europei avvicinarono
il ministro Geithner, proponendo un piano per far cadere il premier italiano
Berlusconi. Lui lo rifiutò, come scrive nel suo libro di memorie appena
pubblicato “Stress Test”. La ricostruzione di Geithner, anticipata da La
Stampa, fa discutere. Berlusconi
si butta in un nuovo tour mediatico (intervista al Corriere.it, al Tg5, e poi al
quotidiano il Foglio). È incontenibile: sono stato vittima di un «complotto» e
con me «è stata messa in discussione anche la sovranità dell’Italia». Berlusconi
non fa trasparire in pubblico tutta la rabbia che ha dentro per quanto trapelato
dagli Stati Uniti. Anzi, si affretta a ribadire più e più volte di «non essere
per nulla sorpreso » da quanto detto dall’ex ministro dell’economia americano:
«Già nel giugno del 2011, quando ancora non era scoppiato l’imbroglio degli
spread, il Presidente della Repubblica Napolitano riceveva Monti e Passera, come
è stato scritto, per scegliere i tecnici di un nuovo governo tecnico». In
privato però la reazione è bene diversa. L’ex premier con i suoi si dice
consapevole che questa storia non sposterà un voto, ma chiede comunque ai
vertice azzurro di alzare il polverone. Da Forza Italia parte il fuoco di fila
con la richiesta di una commissione d’inchiesta parlamentare sui fatti del 2011
ed un chiarimento da parte del governo: «Renzi venga a riferire in Parlamento»,
dice Renato Brunetta pronto a chiamare in causa anche Giorgio Napolitano: «Gli
ho scritto una lettera - fa sapere - proprio per sapere cosa intenda fare». Già
perché è proprio il Capo dello Stato che l’ex capo del governo ha sempre
chiamato in causa bollandolo come «regista» dell’operazione che portò alle sue
dimissioni. Dal Quirinale non trapela nessuna replica, così come dalla Casa
Bianca: no comment, è il massimo che fanno sapere dallo staff del presidente
americano. Sulle barricate è invece Bruxelles che non ci sta a passare come
parte in causa di un complotto: «Erano gli americani a volere l’Italia sotto
tutela», è la replica delle fonti europee alle rivelazioni di Geithner. A
parlare ufficialmente è il presidente della Commissione Barroso sostenendo che
ai tempi del G20 del 2011 «l’Italia era vicinissima all’abisso e alcuni
tentarono di metterla sotto la supervisione del Fmi, mente noi siamo stati quasi
soli a dire che questo non doveva succedere». Anche la linea del governo
italiano è quella di non intervenire sulla questione: «Abbiamo voltato pagina,
non è utile tornare su questi eventi», si limita a dire il ministro degli Esteri
Federica Mogherini. A palazzo Grazioli però la pensano diversamente, tanto che
il Cavaliere coglie ogni occasione per ricordare come sono andati i fatti: «I
magistrati che mi hanno perseguitato una vita senza prove li chiamerebbero
“riscontri” del colpo di Stato». L’idea però che la vicenda possa avere dei
riscontri positivi sui sondaggi non sembra convincere Berlusconi, pronto però a
«sfruttare» in termini di voti a Forza Italia la «delusione degli elettori verso
Matteo Renzi». L’ex capo del governo non nasconde lo scetticismo per il governo
guidato dal leader del Pd tanto, raccontano da Forza Italia, da averne parlato
nei giorni scorsi con il Colle. Il leader di Fi è sempre più convinto che le
elezioni politiche si avvicinano perché il presidente del Consiglio è sempre più
impantanato, anche sul fronte del rilancio dell’economia: Le persone iniziano ad
essere stanche degli annunci - è stato il ragionamento fatto a via del
Plebiscito - e le riforme non sono certo un tema che Matteo può giocarsi per
coprire l’aumento delle tasse. Dagli Usa, invece, il segretario di Stato Usa
John Kerry dice (in italiano): «Io non so niente». «Assolutamente è la prima
volta che ne sento parlare», ha aggiunto Kerry che aveva accanto a se il
ministro degli Esteri Federica Mogherini al termine dell’incontro al
dipartimento di Stato a a Washington. Rispondendo alla domanda se avesse letto
il libro ha detto: «No , non l’ho letto».
L’ex ministro Usa: funzionari europei ci proposero di far cadere Silvio.
Geithner: ovviamente dissi a Obama che non potevamo starci, scrive Paolo
Mastrolilli su “La Stampa”.
Nell’autunno del 2011, quando la drammatica crisi economica aveva portato l’euro
ad un passo dal baratro, alcuni funzionari europei avvicinarono il ministro del
Tesoro americano Geithner, proponendo un piano per far cadere il premier
italiano Berlusconi. Lui lo rifiutò, come scrive nel suo libro di memorie appena
pubblicato, e puntò invece sull’asse col presidente della Bce Draghi per salvare
l’Unione e l’economia globale. «Ad un certo punto, in quell’autunno, alcuni
funzionari europei ci contattarono con una trama per cercare di costringere il
premier italiano Berlusconi a cedere il potere; volevano che noi rifiutassimo di
sostenere i presti dell’Fmi all’Italia, fino a quando non se ne fosse andato».
Geithner, allora segretario al Tesoro Usa, rivela il complotto nel suo saggio
«Stress Test», uscito ieri. Una testimonianza diretta dei mesi in cui l’euro
rischiò di saltare, ma fu salvato dall’impegno del presidente della Bce Mario
Draghi a fare «tutto il necessario», dopo diverse conversazioni riservate con lo
stesso Geithner. I ricordi più drammatici cominciano con l’estate del 2010,
quando «i mercati stavano scappando dall’Italia e la Spagna, settima e nona
economia più grande al mondo». L’ex segretario scrive che aveva consigliato ai
colleghi europei di essere prudenti: «Se volevano tenere gli stivali sul collo
della Grecia, dovevano anche assicurare i mercati che non avrebbero permesso il
default dei paesi e dell’intero sistema bancario». Ma all’epoca Germania e
Francia «rimproveravano ancora al nostro West selvaggio la crisi del 2008», e
non accettavano i consigli americani di mobilitare più risorse per prevenire il
crollo europeo. Nell’estate del 2011 la situazione era peggiorata, però «la
cancelliera Merkel insisteva sul fatto che il libretto degli assegni della
Germania era chiuso», anche perché «non le piaceva come i ricettori
dell’assistenza europea - Spagna, Italia e Grecia - stavano facendo marcia
indietro sulle riforme promesse». A settembre Geithner fu invitato all’Ecofin in
Polonia, e suggerì l’adozione di un piano come il Talf americano, cioè un muro
di protezione finanziato dal governo e soprattutto dalla banca centrale, per
impedire insieme il default dei paesi e delle banche. Fu quasi insultato. Gli
americani, però, ricevevano spesso richieste per «fare pressioni sulla Merkel
affinché fosse meno tirchia, o sugli italiani e spagnoli affinché fossero più
responsabili». Così arrivò anche la proposta del piano per far cadere
Berlusconi: «Parlammo al presidente Obama di questo invito sorprendente, ma per
quanto sarebbe stato utile avere una leadership migliore in Europa, non potevamo
coinvolgerci in un complotto come quello. “Non possiamo avere il suo sangue
sulle nostre mani”, io dissi». A novembre si tenne il G20 a Cannes, dove secondo
il Financial Times l’Fmi aveva proposto all’Italia un piano di salvataggio da 80
miliardi, che però fu rifiutato. «Non facemmo progressi sul firewall europeo o
le riforme della periferia, ma ebbi colloqui promettenti con Draghi sull’uso di
una forza schiacciante». Poco dopo cadde il premier greco Papandreu, Berlusconi
fu sostituito da Monti, «un economista che proiettava competenza tecnocratica»,
e la Spagna elesse Rajoy. A dicembre Draghi annunciò un massiccio programma di
finanziamento per le banche, e gli europei iniziarono a dichiarare che la crisi
era finita: «Io non la pensavo così». Infatti nel giugno del 2012 il continente
era di nuovo in fiamme, perché i suoi leader non erano riusciti a convincere i
mercati. «Io avevo una lunga storia di un buon rapporto con Draghi, e continuavo
ad incoraggiarlo ad usare il potere della Bce per alleggerire i rischi. “Temo
che l’Europa e il mondo guarderanno ancora a te per un’altra dose di forza
bancaria intelligente e creativa”, gli scrissi a giugno. Draghi sapeva che
doveva fare di più, ma aveva bisogno del supporto dei tedeschi, e i
rappresentanti della Bundesbank lo combattevano. Quel luglio, io e lui avemmo
molte conversazioni. Gli dissi che non esisteva un piano capace di funzionare,
che potesse ricevere il supporto della Bundesbank. Doveva decidere se era
disponibile a consentire il collasso del’Europa. “Li devi mollare”, gli dissi».
Così, il 26 luglio, arrivò l’impegno di Draghi a fare «whatever it takes» per
salvare l’euro. «Lui non aveva pianificato di dirlo», non aveva un piano pronto
e non aveva consultato la Merkel. A settembre, però, Angela appoggiò il «Draghi
Put», cioè il programma per sostenere i bond europei, che evitò il collasso.
Usa, l'ex ministro del Tesoro: "Nel 2011 complotto contro il Cav". Le
rivelazioni choc di Geithner, ex ministro del Tesoro Usa, nel saggio Stress
test: "Alcuni funzionari europei ci contattarono con una trama per
costringere Berlusconi a cedere il potere". Ma a Obama disse: "Non possiamo
avere il suo sangue sulle nostre mani", scrive Andrea
Indini su “Il Giornale”. Al G20 del 2011
funzionari europei chiesero agli Stati Uniti di aderire a un "complotto" per far
cadere l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Nel
memoir Stress test, anticipato oggi dalla Stampa e dal
Daily Beast, Timothy Geithner, ex ministro del Tesoro
americano, aggiunge nuovi, inquietanti tasselli al golpe ordito contro il
Cavaliere per cacciarlo da Palazzo Chigi e mettere al suo posto Mario
Monti, un tecnico scelto ad hoc per far passare le misure lacrime e
sangue imposte da Bruxelles e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. "Ma
a Obama dissi: 'Non possiamo avere il suo sangue sulle nostre mani'",
racconta ancora Geithner nel volume che ripercorre la disastrosa situazione
finanziaria che spinse quei funzionari a progettare il "complotto".
Le prime indiscrezioni su un golpe ai danni di Berlusconi sono state appena
sussurrate. E, inevitabilmente, i media progressisti hanno fatto a gara per
distruggerle. Oggi, invece, Geithner spazza via qualunque dubbio sul drammatico
piano che il 12 novembre del 2011, con lo spread tra i Btp
decennali e i Bund tedeschi artificiosamente pompato sopra i 470 punti,
Berlusconi si dimise dopo l'approvazione della legge della stabilità alla
Camera. Ebbene, dietro a quelle dimissioni c'è un vero e proprio piano ordito a
Bruxelles per far cadere un governo eletto democraticamente e piazzarne uno
tecnico e asservito ai diktat dell'Unione europea.
"Ad un certo punto, in quell'autunno, alcuni
funzionari europei ci contattarono con una trama per cercare di costringere il
premier italiano Berlusconi a cedere il potere - svela oggi Geithner - volevano
che noi rifiutassimo di sostenere i prestiti dell’Fmi all’Italia, fino a quando
non se ne fosse andato". Dal 26 gennaio 2009 al 28 febbraio 2013 Timothy
Geithner ricopre, infatti, l'incarico di segretario al Tesoro degli Stati Uniti
durante il primo governo presieduto da Barack Obama.
L'obiettivo degli innominati "funzionari
europei" è quello di accerchiare Berlusconi, anche attraverso i ricatti
del Fondo monetario internazionale, pur di farlo uscire di scena. Il golpe non
viene organizzato su due piedi, ma iniziò a essere tessuto nell'estate del 2010,
quando "i mercati
stavano scappando dall'Italia e la Spagna, settima e nona economia più grande al
mondo". Nel saggio Stress test Geithner scrive di aver
consigliato più volte ai colleghi europei di essere prudenti:
"Se volevano tenere gli stivali sul collo della
Grecia, dovevano anche assicurare i mercati che non avrebbero permesso il
default dei paesi e dell’intero sistema bancario". Ma all’epoca Germania
e Francia "rimproveravano ancora al nostro West
selvaggio la crisi del 2008" e rifiutavano i consigli del Tesoro
statunitense che chiedeva di mobilitare più risorse per prevenire il crollo
economico del Vecchio Continente. Nell’estate del 2011 la situazione precipita.
"La cancelliera Angela Merkel
insisteva sul fatto che il libretto degli assegni della Germania era chiuso -
racconta l'ex segretario del Tesoro - non le piaceva come i paesi che ricevevano
assistenza europea (Spagna, Italia e Grecia) stavano facendo marcia indietro
sulle riforme promesse". Quando a settembre Geithner arriva in Polonia
per partecipare all'Ecofin, propone ai Paesi dell'Eurozona di adottare un piano
simile al Term asset-backed securities loan facility (Talf), il muro di
protezione creato dalla Federal reserve e finanziato dal governo e soprattutto
dalla banca centrale per impedire insieme il default dei Paesi e delle
banche. Viene quasi insultato. "Gli
americani, però - continua Geithner - ricevevano spesso richieste per fare
pressioni sulla Merkel affinchè fosse meno tirchia, o sugli italiani e spagnoli
affinchè fossero più responsabili". È proprio in questo quadro
inquietante di supponenza tedesca e incompetenza europea che arrivano le prime
pressioni per cambiare il governo italiano. A G20 di Cannes lo
stesso governatore della Bce, Mario Draghi, gli promette "l'uso di una forza
schiacciante". "Parlammo al presidente Obama di
questo invito sorprendente - racconta Geithner - ma per quanto sarebbe stato
utile avere una leadership
migliore in Europa, non potevamo coinvolgerci in un complotto come quello".
Nonostante il niet degli Stati Uniti, i "funzionari europei" riescono
nell'intento: nel giro di poche settimane si dimette il premier greco George
Papandreou, Berlusconi viene sostituito con Monti ("un
economista che proiettava competenza tecnocratica") e in Spagna viene
eletto Mariano Rajoy. A dicembre la Bce approva il piano per finanziare per le
banche. Piano che viene accolto con euforia da Bruxelles che si fionda a
dichiarare che l'Europa è uscita dal tunnel della crisi.
"Io non la pensavo così", sottolinea
l'ex segretario del Tesoro. E, infatti, nel giugno del 2012 la minaccia del
default tornerà a mettere in ginocchio i mercati del Vecchio Continente.
Gli Stati Uniti: "Funzionari Ue ci chiesero di far cadere Silvio Berlusconi",
scrive “Libero Quotidiano”. Non solo Monti. Non solo Napolitano. Non solo Prodi.
Anche a Barack Obama fu chiesto da alcuni funzionari europei di
prendere al complotto per far cadere Silvio Berlusconi. A fare
pressioni sul presidente Usa furono alcuni funzionari europei, che proposero ad
Obama un piano per far crollare l'esecutivo, nell'infuocato 2011. Gli Stati
Uniti, però, si sottrassero al complotto: "Non possiamo avere il suo sangue
sulle nostre mani". La fonte di tali rivelazioni? Niente meno che l'ex ministro
del Tesoro, Timothy Geithner, che spiega quanto accaduto in un
libro di memorie uscito lunedì, Stress Test, e anticipata dalla stampa.
Dopo il il libro-rivelazione di Alan Friedman, Ammazziamo
il gattopardo, che svelava le indebite e (troppo) preventive pressioni di
Giorgio Napolitano su Mario Monti, ecco un
nuovo pamphlet destinato a fare molto rumore politico. Geithner, uno degli
uomini più potenti degli States, scrive: "Ad un certo punto in quell'autunno,
alcuni funzionari europei ci contattarono con una trama per cercare di
costringere il premier italiano Berlusconi a cedere il potere; volevano che noi
rifiutassimo di sostenere i prestiti del Fmi all'Italia, fino a quando non se ne
fosse andato". L'ennesima prova al fatto che l'Europa berlinocentrica
voleva far fuori lo Stivale e il suo presidente del Consiglio. Geithener si
riferisce ai mesi più difficili per l'Italia, alle prese con le bizze dello
spread, nell'autunno 2011. In particolare le richieste agli Stati Uniti furono
avanzate già a settembre 2011, prima che lo spread raggiungesse i massimi,
quando in Polonia all'Ecofin ricevette richieste per "fare pressioni
sulla Merkel affinché fosse meno tirchia, o sugli italiani e gli
spagnoli affinché fossero più responsabili". Contestualmente, come detto, arriva
anche la proposta di far cadere Berlusconi. Ma Geighner precisa che, per quanto
gli Usa avrebbero preferito un altro leader, gli Stati Uniti preferirono evitare
il complotto.
Angela Merkel pianse con Barack Obama: "Obbedisco alla Bundesbank", scrive
Martino Cervo su “Libero Quotidiano”. Sul Financial Times
è apparso uno degli articoli di giornale più appassionanti degli ultimi anni.
L’intero testo si trova all’indirizzo goo.gl/p11UOo (necessaria una
registrazione gratuita). È un lunghissimo retroscena sulla notte dell’euro, a
firma Peter Spiegel, che della testata è corrispondente da
Bruxelles. Un romanzo breve (5 mila parole), primo di una serie che il
quotidiano dedica alla ricostruzione delle giornate che cambiarono per sempre
l’Europa. L’interesse per il lettore italiano è doppio: il nostro Paese è, nel
novembre 2011, lo spartiacque per la sopravvivenza dell’euro, e manca una
ricostruzione non strumentale di cosa accadde in ore che costarono la
caduta di due governi (Papandreou e Berlusconi), sotto il rischio
concreto di una catastrofe finanziaria. Il racconto si apre con una scena
difficile da immaginare: Angela Merkel è in
una stanza di hotel con Obama, Barroso,
Sarkozy, e piange. «Non è giusto», stritola tra i denti con le
lacrime agli occhi, «Io non mi posso suicidare». Perché la signora d’Europa è
ridotta così? Libero riassume l’articolo di Spiegel per i suoi lettori. Siamo,
come detto, a inizio novembre 2011. L’estate si è conclusa avvolta dalle fiamme
dello spread. La Grecia è sul filo della permanenza nell’euro. L’Italia è la
prossima preda di chi scommette sull’implosione della moneta unica, lo spread
vola a quota 500, il governo traballa sulle pencolanti stampelle dei
«responsabili», Merkel e Sarko hanno appena sghignazzato in mondovisione alla
domanda sull’affidabilità di Berlusconi. Il G20 di Cannes del 3-4 novembre
diventa un appuntamento carico di tensione. Il premier greco Papandreou
ha annunciato un referendum sull’uscita dall’euro. L’eventualità manda
letteralmente nel panico soprattutto i paesi creditori. A 48 ore dall’inizio del
vertice Sarkozy raduna tutti i protagonisti del redde rationem: il premier
greco, la Merkel, il capo dell’eurogruppo Juncker (oggi candidato del Ppe alla
guida della Commissione Ue), il capo del Fondo monetario Christine
Lagarde, i capi dell’Unione José Barroso e Herman van Rompuy.
Il dramma greco è affiancato a quello italiano. Roma, rispetto ad Atene, è «too
big to bail». La Lagarde è durissima: «L’Italia non ha credibilità». Quel che si
fa con la Grecia avrà una ricaduta immediata, ed esponenziale, sul nostro Paese.
Con Papandreou c’è Venizelos, ministro delle Finanze. Sarkozy mette spalle al
muro il premier ateniese, per evitare il referendum e costringerlo a prendere
una decisione lì, sul posto: dentro o fuori. Qui si apre un retroscena nel
retroscena: il Ft racconta che Barroso poche ora prima, all’insaputa di Merkel e
Sarko (padrone di casa del G20), incontra il capo dell’opposizione greca
Samaras, offrendogli sostegno istituzionale a un governo di unità nazionale a
patto di abbattere il referendum. Poi inizia il vertice «vero». Senza che i
premier sappiano dell’accordo Barroso-Samaras, il capo della Commissione Ue fa
il nome di Lucas Papademos, vicepresidente della Bce, come
possibile guida di un esecutivo di larghe intese ad Atene. «Dobbiamo
ammazzare questo referendum», dice Barroso. Venizelos soppianta il suo
premier e cancella il referendum con una dichiarazione ufficiale. Papademos
diventerà premier sette giorni più tardi. La Grecia è «sistemata». A questo
punto bisogna sollevare una barriera contro l’assedio dei mercati all’euro. La
trincea si chiama Italia. Molti delegati sono sconcertati dalla presenza al
tavolo di Obama, che in teoria non ha titoli per sedersi a una riunione
informale sull’eurozona. Segno di debolezza delle istituzioni
comunitarie? Della gravità globale di un possibile tracollo che rischia di far
saltare un mercato decisivo per i prodotti Usa? Il nodo cruciale è il ruolo del
Fondo monetario. Come più volte raccontato da Giulio Tremonti,
l’Italia declina l’offerta di una linea di credito da 80 miliardi di dollari,
accettando solo il monitoraggio del Fmi. «I think Silvio is right», dice Obama,
buttando sul tavolo una carta nuova, che assegna a Berlino una posizione
cruciale. Per aggirare i veti dei trattati che impediscono alla Bce di
finanziare direttamente gli Stati, il presidente Usa - in accordo coi francesi,
alla faccia del tanto sbandierato asse Merkozy raccontato in quei giorni -
propone l’utilizzo del «bazooka» con un’ennesima sigla: SDR. Che sta per
«special drawing rights» (diritti speciali di prelievo), un particolare tipo di
valuta che il Fmi stesso usa come unità di conto della partecipazione
finanziaria dei singoli Stati. Una strategia simile (usare la potenza
di fuoco degli SDR contro la crisi) era stata usato nel post-Lehman. Qui si
tratterebbe di riversare quelle risorse nel fondo salvaStati europeo in via di
formazione. Quel che segue è il miglior esempio possibile per raffigurare il
nodo della democrazia ai tempi della crisi, e investe in pieno il tema della
famosa «indipendenza» delle Banche centrali. La gestione degli SDR è infatti in
capo a queste ultime. E il capo della Bundesbank è Jens Weidmann,
custode dell’ortodossia dell’austerity tedesca. Appena si diffonde il piano
Obama-Sarko, il «falco» apre le ali e dice «nein» al telefono con i delegati
tedeschi: la Germania non paga. La Merkel scoppia in pianto e pronuncia il suo:
«Non è giusto, non posso suicidarmi. Non posso decidere io al posto della
Bundesbank». Il dramma dell’euro è qui: quattro tra i più potenti governi
democraticamente eletti del mondo si fermano davanti al veto (legittimo) di un
banchiere. Obama vuole che la Germania alzi la quota degli SDR. La
Merkel apre, purché l’Italia accetti di farsi commissariare dal Fondo.
Tremonti e Berlusconi non mollano, Angela neppure, a causa di
Weidmann. La tensione è totale. La riunione si scioglie con un nulla di fatto,
salvo la richiesta al governo di Berlino di provare a smussare la Buba . «Non
mi prendo un rischio simile se non ottengo in cambio nulla
dall’Italia». Alla conferenza stampa dopo il G8 Berlusconi rivela l’offerta del
Fmi e il «no» italiano. Pochi giorni dopo, il governo cade. Al supervertice non
è successo nulla. Toccherà a Draghi tenere in piedi l’euro, e (anche) a noi
pagare per il fondo salvastati.
Gli attacchi vengono anche dal'interno. L'accordo tra Fini e Napolitano per
"eliminare" Berlusconi, scrive “Libero Quotidiano”. "Il golpe contro
Silvio Berlusconi non è cominciato nell’estate del 2011 come scrive
Friedman. Ma molto prima, nel 2009. E a muovere i fili furono il presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano e quello della Camera
Gianfranco Fini". A tirare in ballo altri protagonisti del
complotto anti Cav è Amedeo Labboccetta. In una intervista al
Tempo, l'allora braccio destro di Fini, racconta le ambizioni dell'ex
presidente della Camera che ha giocato di sponda con il Quirinale per fare le
scarpe al leader azzurro con l'obiettivo di prendere il suo posto a Palazzo
Chigi. "Fini me lo disse in più circostanze. 'Ma tu credi che io porterei avanti
un’operazione del genere se non avessi un accordo forte con Napolitano?!",
rivela Labboccetta a Carlantonio Solimene che racconta anche di come nacqua il
feeling tra Fini e il Colle: "Quando nel 2008 Berlusconi diventa premier e il
leader di An va alla presidenza della Camera, i rapporti con Napolitano
diventano strettissimi. Si sentono al telefono praticamente ogni giorno". E lui,
dice, di essere testimone di quelle chiamate essendo in quel periodo in una
posizione privilegiata. All'inizio, prosegue l'ex deputato del Pdl, Fini
giustificò il suo controcanto al Cavaliere come normali reazioni agli attacchi
de Il Giornale. Lui e Dell'Utri tentarono più volte di
fargli cambiare idea. Berlusconi, secondo il racconto di Labboccetta, arrivò
perfino ad offrirgli la segreteria del partito. Ma niente, Fini, non smetteva e
alzava la posta chiedendo la testa dei ministri La Russa e
Matteoli e del capogruppo al Senato Gasparri.
"Mi disse che non avrebbe mai lasciato la terza carica dello Stato perché da lì
poteva tenere per le palle Berlusconi', continua Laboccetta secondo il quale
l'obiettivo di Fini era di "eliminare politicamente Berlusconi". "Quando lo
costrinsi a spiegarmi con quali numeri e appoggi voleva farlo", rivela, "mi
confessò che Napolitano era della partita. Usò proprio queste parole. Aggiunse
che presto si sarebbero create le condizioni per un ribaltone e che aveva
notizie certe che la magistratura avrebbe massacrato il Cavaliere. "Varie
procure sono al lavoro", mi svelò, "Berlusconi è finito, te ne devi fare una
ragione". E aggiunse che come premio per il killeraggio del premier sarebbe nato
un governo di "salvezza nazionale" da lui presieduto con la benedizione del
Colle. Quando parlava di Silvio, Gianfranco era accecato dall’odio, sembrava un
invasato. Una volta mi disse: "Non avrò pace fino a quando non vedrò ruzzolare
la testa di Berlusconi ai miei piedi"». Labboccetta non
raccontò mai a Berlusconi quello che Fini stava ordendo alle sue spalle, ma si
giustifica sostenendo che si diede da fare perché quel piano saltasse: "Cercai
di fargli capire che Fini era solo l’esecutore, ma i disegnatori erano altri.
Magari con una regia extranazionale". "Me lo fece capire lo stesso Gianfranco,
parlando tra le righe. Non va dimenticato che in passato era stato ministro
degli Esteri, ed era stato bravo a tessere le giuste relazioni". Alla domanda di
Solimente: "Ma perché dice queste cose solo oggi?" Labboccetta risponde:
"All’epoca ho fatto di tutto per favorire una ricomposizione. In seguito, ho
ritenuto che era meglio lasciare queste cose alle miserie umane. Ma adesso che
la verità sta venendo a galla, è giusto che si sappia tutto di quegli anni".
Sallusti: "Dietro al complotto per far fuori Berlusconi c'è Clio Napolitano",
scrive “Libero Quotidiano”. “Dietro al golpe del 2011 c'è Clio Napolitano".
Alessandro Sallusti ai microfoni de La Zanzara su Radio 24
aggiunge nuove elementi alle rivelazioni di Alan Friedman che parlano di
una strategia chiara da parte del Colle per destabilizzare il governo Berlusconi
nel 2011 e sostituire il Cav a palazzo Chigi con Mario Monti. Il direttore de Il
Giornale punta il dito contro la moglie del Capo dello Stato e afferma: "Mi
dicono che la moglie di Napolitano, la comunista Clio, odia Silvio, e ha molto
peso sulle scelte del Quirinale. Dietro al complotto politico finanziario che ha
fatto cadere Berlusconi, c'è Clio Napolitano". Insomma secondo Sallusti la mano
occulta che guidò la caduta di Berlusconi nel 2011 appartiene a Clio Napolitano.
Il direttore de Il Giornale però non risparmia critiche nemmeno agli ex alleati
del Cav: "Sia Fini che Alfano sono stati cooptati da Napolitano per uccidere
Berlusconi". Sallusti parla anche dello spread: "Fu creato ad arte ed il
complotto contro Berlusconi ci fu". Infine l'annuncio poi confermato nel suo
editoriale di oggi su il Giornale: "Se siamo in un Paese libero, mettiamo in
stato d'accusa Napolitano".
Berlusconi: «Complotto contro di me? Obama si comportò bene». «Non mi sorprende
che l’uomo del presidente Usa abbia confermato le manovre nei miei confronti… Ma
lui si comportò bene durante tutto il G20 e mi diede ragione», scrive
Alan Friedman
su “Il Corriere della Sera”. Seduto nel giardino di Villa San Martino a Arcore,
Silvio Berlusconi è più che soddisfatto. Le anticipazioni del libro di memorie
di Timothy Geithner (Stress Test) confermano quello che il Cavaliere dice
di sapere da tempo, e cioè, che la Casa Bianca bocciò una richiesta da parte di
alcuni europei di far cadere il suo governo nell’autunno del 2011. «Non sono
sorpreso. Ho sempre dichiarato che nel 2011 nei confronti del mio governo, ma
anche nei confronti del mio Paese, c’è stato tutto un movimento che era partito
dal nostro interno ma poi si è esteso anche all’esterno per tentare di
sostituire il mio governo, eletto dai cittadini, con un altro governo», dice
Berlusconi. «Già nel giugno del 2011, quando ancora non era scoppiato
l’imbroglio degli spread, il Presidente della Repubblica Napolitano riceveva
Monti e Passera, come è stato scritto, per scegliere i tecnici di un nuovo
governo tecnico e addirittura per stilare il documento programmatico. E poi
abbiamo saputo anche che ci sono state quattro successive tappe di scrittura,
con l’ultima addirittura di 196 pagine». Berlusconi è in grande forma e viene
fuori un ricordo preciso. «Io avevo la contezza che stesse accadendo qualcosa e
avevo anche ad un certo punto ritenuto che ci fosse una precisa regia. Al G-20
di Cannes, addirittura, amici e colleghi di altri paesi mi dissero: "Ma hai
deciso di dare le dimissioni? Perché sappiamo che tra una settimana ci sarà il
governo Monti…". E l’ha rivelato per esempio Zapatero in un suo libro che
riguardava quel periodo». Non è sorpreso che queste nuove rivelazioni vengano da
un uomo di Obama. «Io devo dire che Obama si comportò bene durante tutto il G20.
Noi fummo chiamati dalla Merkel e Sarkozy a due riunioni in due giorni
consecutivi e in queste riunioni si tentò di farmi accettare un intervento dal
Fondo Monetario Internazionale. Io garantii che i nostri conti erano in ordine e
non avevamo nessun bisogno di aiuti dall’esterno e rifiutai di accedere a questa
offerta, che avrebbe significato colonizzare l’Italia come è stata colonizzata
la Grecia, con la Troika».
Eppure son tutti uguali.
Expo, appalti e tangenti: la sinistra spunta ovunque. Nelle carte ci sono
dozzine di nomi dell'area Pd tirati in ballo dagli arrestati. Da Bersani fino al
sottosegretario Delrio e al portavoce del partito Guerini, scrive
Enrico Lagattolla su “Il Giornale”. Lo dicevano spesso, quelli della
cupola. «Copriamoci a sinistra». Nel Paese degli appalti truccati servono santi
bipartisan. Di qua e di là. Ma di là - a sinistra - ce n'erano davvero parecchi.
Realtà o millanterie, sta di fatto che nelle carte dell'inchiesta milanese su
Expo e non solo ci sono dozzine di nomi dell'area Pd. Non è un caso, secondo una
teoria dell'ex senatore Luigi Grillo. «L'ho visto anche ieri Pier Luigi
(Bersani, che ha già smentito, ndr), io tengo sempre i rapporti - dice
a Giuseppe Nucci, ex ad della Sogin - lo informo degli sviluppi. Sai, loro, i
post-comunisti non sono diversi dai comunisti, cioè il dialogo lo accettano,
sono anche garbati e sono simpatici. Poi quando c'è da stringere per questioni
di potere preferiscono sempre il cerchio stretto». Ecco, gli affari sono affari.
E per ogni torta sul grande tavolo degli appalti pubblici, sostengono i pm, una
fetta doveva andare a sinistra. Attraverso le cooperative, che si aggiudicano i
lavori. Attraverso Primo Greganti, che avrebbe fatto da tramite tra il
partito, le coop e i manager di Stato, e che ieri è stato sospeso in via
cautelare dalla sezione del Pd di Torino a cui era iscritto («Ma qui non
l'abbiamo mai visto», racconta il segretario della sezione). E attraverso i
mille canali - più o meno reali - che ciascuno degli interessati sostiene di
poter smuovere per passare all'incasso. Greganti, per rendersi credibile, si
«vende» anche il nome di Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento
europeo ed ex candidato alle primarie del Pd, il quale ha smentito un suo
interessamento su Expo. «Io sono andato giù a Roma - dice Greganti il 6 marzo -
ho incontrato anche Gianni Pittella... è il presidente del Consiglio europeo
(Greganti si sbaglia, ndr)... grande... potere enorme... al posto di
parlamentare europeo... nel Pd è considerato potente ecco...». Poi qualcuno
bussa anche al ministero. Così, proprio Nucci racconta di aver incontrato
Claudio De Vincenti, viceministro allo Sviluppo economico nel Governo
Renzi. «Mi ha detto - racconta Nucci a Grillo - “io sono a disposizione per
tutte le cose che voi c'avete da fare”, e dico “io voglio lavorare per il mio
Paese”, lui ha detto “Ne parlerò col Gabinetto, col ministro, questa cosa mi
piace molto”». Ma a lambire il governo Renzi c'è anche un riferimento - assai
fumoso - a Graziano Delrio, sottosegretario alla presidenza del
Consiglio. A parlare è l'ex Dc Gianstefano Frigerio. «Però Guerini è un buon...
adesso non so se lo porta al governo ... forse lo lascia ... al partito i suoi
giri ... uno è Delrio e l'altro Guerini». Decisamente più significativi altri
passaggi che riguardano proprio Lorenzo Guerini, portavoce del Pd.
Ancora Frigerio al telefono, parla con Sergio Cattozzo della Città della salute
e degli appalti Sogin. «Devo parlarne a Guerini... a Lorenzo, devo parlarne...
». «Bisogno organizzare un incontro - suggerisce Cattozzo - io te e Guerini,
così lo tiriamo dentro il Guerini. Stiamo parlando di sette miliardi di lavoro,
ragazzi!». Tanti, tantissimi soldi. E gli appalti Sogin portano la cupola a
cercare più sponde possibili. È in questo contesto che spuntano i nomi di
Giovanni Battista Raggi, tesoriere del Pd in Liguria, e di Claudio
Burlando, già ministro dei Trasporti e ora governatore ligure. Greganti
avrebbe dovuto avvicinare Raggi e attraverso questi Burlando, per ottenere - si
legge in un sms di Cattozzo del settembre scorso - «un po' di sponsorizzazione
forte nazionale». Ma la cupola, secondo la Procura di Milano, era «glocal».
Oltre alle coperture nazionali, infatti, cercava appoggi sul territorio. Ovunque
c'era una gara milionaria, c'era da muoversi. Ed è così che si arriva in
Sicilia, dove la cricca sta seguendo i lavori per l'ospedale di Siracusa.
Frigerio, al telefono con Cattozzo, ragiona. «Sei amico di Enrico Maltauro (uno
degli imprenditori arrestati, ndr) tieni conto che stiamo seguendo per lui un
ospedale a Siracusa che dobbiamo parlare con Crocetta (Rosario Crocetta,
governatore siciliano, ndr) per l'autorizzazione compagnia bella ma tu sei
d'accordo... mah aspetta adesso ne parlo al mio consulente poi vediamo venerdì
quando viene da me glielo dirà a Enrico, mi ha chiamato Foti (Luigi Foti
ex parlamentare della Dc ora ritenuto vicino al Pd, ndr) vuole la mia copertura
sulla Sicilia per l'ospedale di Siracusa». Ma alla fine, erano ganci reali o
solo chiacchiere? Altro che balle, a sentire Stefano Boeri. Per l'ex
assessore comunale Pd di Milano, era tutto vero. «Sono stato fatto fuori dalla
partita Expo dalle lobby economiche, compresa la Lega delle Cooperative. Io
costituivo un ostacolo», ha spiegato in un'intervista. A Boeri ha replicato
l'assessore milanese Pierfrancesco Majorino. «Di Boeri si può pensare tutto e il
suo contrario, ma il nesso è totalmente inventato». Al netto delle faide interne
al partito, il dubbio resta.
Quelle larghe intese Cl-Coop per spartirsi affari e poltrone. Nelle carte
della Procura le prove dell'asse tra cooperative rosse e aziende cielline.
L'indagato Frigerio: "Anche Lupi è amico loro", scrive
Luca Fazzo su “Il Giornale”. Altro che
Peppone e don Camillo. Oggi i vecchi nemici fanno affari insieme. Nascosta nelle
carte dell'indagine sugli appalti dell'Expo 2015 c'è una traccia che costringe a
rivedere antiche certezze. E a prendere atto che quando oggi si parla dei
colossi delle coop, lanciati alla conquista di fette sempre più grosse degli
appalti pubblici, si parla di qualcosa di assai diverso dalle vecchie
cooperative emiliane, tutte business e ideologia, che fanno parte della storia
del Novecento italiano. Il grosso delle aziende aderenti alla Lega nazionale
cooperative e mutue continua, ovviamente, a stare nell'orbita del Pd. Ma dentro
la Legacoop cresce un nuovo partito di tutt'altra estrazione: uomini e aziende
che vengono dalla storia di Comunione e liberazione, e dal suo braccio
nell'imprenditoria, la Compagnia delle opere. Ex comunisti e ciellini convivono
e collaborano. E si ritrovano, nelle carte dell'indagine, a godere di protezioni
bipartisan. A spiegarlo chiaramente, tranquillizzando un interlocutore è
Gianstefano Frigerio, l'ex parlamentare della Dc e di Forza Italia, arrestato
mercoledì. Scrive la Guardia di finanza: «Frigerio dice che quelli che gli
presenterà della Manutencoop (alti dirigenti) non sono di sinistra ma sono dei
loro». Non è chiaro a chi si riferisca Frigerio. Ma il vecchio democristiano
torna sul tema in un'altra conversazione: «Ieri ho parlato con Pellissero e gli
ho raccomandato, guarda che la cosa migliore è Manutencoop e anche qualche sua
azienda... “sì sì lo so anche se hanno fatto un po' di alleanze eccessive con i
ciellini”». Un asse che può apparire singolare, quello tra i due mondi: ma che
si basa su due pilastri comuni, la vocazione sociale e il pragmatismo
imprenditoriale. Di fatto, Cdo e Legacoop si ritrovano da tempo alleate in
un'opera di lobbismo comune e trasversale per ottenere leggi che tutelino
l'imprenditoria sociale. Questo ha generato contiguità e alleanze. E anche
intrecci di poltrone: il caso più noto è quello di Massimo Ferlini, ex assessore
comunista a Milano, che oggi è uno dei principali esponenti della Compagnia
delle opere ma siede anche nel consiglio di amministrazione di Manutencoop.
Così, in nome di un comune sentire, si saldano intese un tempo impensabili.
Ancora Frigerio: «Anche Maurizio Lupi (ministro delle Infrastrutture, ciellino
doc) è amico di quelli di Manutencoop». Scrive la Finanza: «Frigerio sostiene di
conoscere bene i legami che ci sono tra Manutencoop e i ciellini tanto che negli
ultimi anni, con Formigoni, sempre a dire dell'indagato Manutencoop avrebbe già
ottenuto importanti lavori». E d'altronde in Lombardia non è un mistero che dopo
la caduta di Formigoni le aziende della Cdo, rimaste orfane di protezione
politica, si stiano ulteriormente avvicinando alle coop rosse. «Parlando con
Levorato lui è un vecchio comunista, io un vecchio democristiano, quindi
sappiamo come si parla tra noi», dice Frigerio di Claudio Levorato, il manager
di Manutencoop per cui la Procura aveva chiesto l'arresto: e in questa frase c'è
dentro un bel ritratto di storie simili cresciute su sponde diverse. D'altronde,
dice sempre Frigerio, «ti manderò il capo delle coop (...) copriamoci perché
sono le coop rosse e corrono meno incidenti. Prendeteveli perché sono rossi» . E
fin qui potrebbe sembrare un semplice calcolo di opportunità o un preaccordo di
spartizione. Ma quello che raccontano le carte è qualcosa di più, una sorta si
compenetrazione tra mondi solo apparentemente distanti. C'è una matrice forse
cattocomunista: basta guardare il profilo Linkedin di Fernando Turri, altro
manager coop che compare nell'inchiesta, a capo della Viridia: studi dai
salesiani, ma alle spalle il Quarto Stato di Pellizza. E c'è soprattutto una
consapevolezza che i tempi sono duri, la spending review ha tagliato gli
appalti, e così se si vuole sopravvivere bisogna abbattere vecchi steccati.
Frigerio: «Manutencoop, aldilà di quello che pensa Rognoni, è “così” con Cl».
Il ministero della Giustizia, attraverso il capo degli ispettori Arcibaldo
Miller, ha chiesto alla Corte d'appello di Milano copia della sentenza relativa
al Lodo Mondadori e dei motivi del ricorso in Appello di Fininvest. L'iniziativa
è una diretta conseguenza dell'esposto presentato da Marina Berlusconi per conto
di Fininvest sia al ministero della giustizia sia al procuratore generale della
Cassazione, entrambi titolari dell'azione disciplinare a carico dei magistrati.
Arcibaldo Miller che mai si è mosso su istanza del dr Antonio Giangrande,
Presidente dell'Associazione Contro tutte le Mafie, che ha avuto il coraggio di
denunciare i magistrati, senza conseguire calunnia.
Arcibaldo Miller, del quale “La Repubblica” delinea le caratteristiche a firma
di Liana Milella. "Di mattina compone la squadra degli ispettori pronti a
fare le pulci ai colleghi di Napoli e di Bari che hanno indagato su Tarantini, e
quindi anche su Berlusconi. Di sera Arcibaldo Miller, il magistrato che dal 2001
guida i segugi di via Arenula attraverso i ministri Castelli, Mastella, Alfano,
Palma, si ritrova a sua volta sotto inchiesta per il suo coinvolgimento
nell'inchiesta sulla P3, in cui è stato indagato. Il collegio dei probiviri
dell'Anm apre una pratica per espellerlo dall'associazione. Il Csm sta
verificando i presupposti per revocare lo stato di "fuori ruolo" di Miller. Il
Pd, con Donatella Ferranti chiede che lasci immediatamente il posto di capo
degli ispettori. È lapidario il ministro della Giustizia: «Miller non è stato
toccato da alcuna indagine penale, il procuratore generale della Cassazione ha
archiviato il suo caso». Non ha letto le carte. Quelle che hanno spinto il Csm
ad occuparsi di nuovo di lui dopo aver archiviato, il 27 giugno 2011, l'ipotesi
di un procedimento disciplinare. Un'archiviazione che suona come una
condanna. Dove è scritto: «Appare pacifico che Miller ha partecipato alla
riunione del 23 settembre 2009, presso l'abitazione romana di Denis Verdini,
dov'erano presenti Flavio Carboni, Arcangelo Martino, Pasquale Lombardi,
Marcello Dell'Utri, Giacomo Caliendo, Antonio Martone. In questa riunione si è
discussa la candidatura a presidente della Regione Campania di Nicola Cosentino
e si è concordata una condotta di illecita interferenza presso i componenti
della Corte costituzionale». Miller la sfanga per la terza volta nella sua vita.
Come quando finì - erano gli anni Novanta - nell'elenco dei frequentatori della
casa d'appuntamenti di via Palizzi a Napoli. O come quando i pentiti
Alfieri e Galasso parlarono di suoi rapporti con la camorra. Tutto finì
archiviato. Davanti al Csm, quando gli contestarono i rapporti con i Sorrentino,
imprenditori legati ai boss, lui si scusò: «È uno sbaglio che ammetto di aver
fatto e ne pagherò le conseguenze». Da pm di punta della procura di Cordova,
ebbe come suo uditore Woodcock. Adesso, di lui e degli altri che indagano su
Berlusconi, per ordine di Berlusconi e Palma, vuole scoprire le deviazioni."
«La democrazia non si può piegare alle trame di qualche Procura e di qualche
redazione». Lo afferma la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, in una
lunga intervista al Corriere della Sera, in cui parla anche dell’esposto
presentato dal Biscione avverso alla sentenza della Corte d’appello per
il lodo Mondadori, che ha condannato la holding a risarcire la Cir con 564
milioni di euro. «Abbiamo scoperto un tarlo, una falla clamorosa che mina dalle
fondamenta un castello di ingiustizie. Altro che leggi ad personam, qui siamo
alle sentenze ad personam, al diritto cucito su misura: quando ci sono di mezzo
mio padre o le nostre aziende, spuntano addirittura principi giurisprudenziali
inediti e totalmente innovativi. Peccato che siano principi inesistenti, nati
dal "taglio" di una frase addirittura sostituita da puntini di sospensione e
dalla mancata citazione di altre».
Un conto sono le sentenze, un conto le interpretazioni, come la
vostra.
«Qui non si tratta di interpretazioni, questi sono dati di fatto. Sono scomparse
frasi intere di una sentenza della Cassazione».
Sia esplicita, che cosa è successo, cosa hanno fatto i giudici?
«Con il taglio e l'omissione di alcune frasi questa pronuncia della Cassazione,
che ha un ruolo fondamentale ai fini della condanna, è stata letteralmente
stravolta, ed è stato in questo modo creato un precedente giuridico ad hoc».
Sta dicendo che la sentenza è stata manipolata. Accusa i giudici
di un falso?
«Me ne guardo bene, l'esposto si limita a segnalare alle autorità competenti
quanto è accaduto. È un fatto talmente evidente e grave che abbiamo non soltanto
il diritto, ma addirittura il dovere di renderlo noto, al di là del ricorso in
Cassazione che seguirà la sua strada. Il taglio e l'omissione di alcuni passaggi
ribalta totalmente la tesi della Cassazione con la conseguenza che noi dobbiamo
firmare un assegno da 564.248.108,66 euro. Incredibile? Assolutamente sì, è
quello che ho pensato quando i legali me ne hanno parlato. Però, ripeto, le
carte sono lì, basta confrontare i testi sul sito della Fininvest. Incredibile,
ma vero».
Senta, a me paiono scaramucce giudiziarie, costose quanto vuole
...
«Altro che scaramucce, stiamo parlando di più di mezzo miliardo».
Sì, ma è sempre la stessa storia.
«Eh no. Partiamo dalla sentenza del 1991 della Corte d'Appello di Roma, quella
che dava torto a De Benedetti, dalla quale tutto è cominciato. Dopo che uno, uno
solo badi bene, dei tre giudici romani era stato condannato per corruzione, per
cancellare gli effetti di quella sentenza d'Appello le norme davano a De
Benedetti una sola possibilità: rivolgersi al giudice della revocazione. Non è
una formalità, ma un istituto fondamentale, previsto dall' articolo 395 del
Codice di procedura civile. La Cir però la revocazione, che le regole avrebbero
peraltro imposto di discutere a Roma e non a Milano, non l'ha mai chiesta. I
termini sono scaduti nel settembre 2007. Morale: azione improponibile, fine
della storia».
Altro che fine della storia, poi il giudice Mesiano vi condanna a
un risarcimento di 750 milioni.
«Esatto. Questa è la dimostrazione che trovano sempre il modo per superare
ostacoli che dovrebbero essere insuperabili. Mesiano punta sulla chance: non ci
sono certezze, ma è molto probabile che un giudizio non viziato da corruzione
nel '91 avrebbe dato ragione alla Cir. Un escamotage così poco sostenibile che
la stessa Corte d' Appello lo "boccia" e cambia strada. Stabilisce che la
sentenza che ci aveva dato ragione era nulla. Si arroga il diritto di rifare il
processo e la Cir vince. Si sostituisce, quindi, al giudice della revocazione. E
per farlo utilizza, nel modo sconcertante che le ho detto, la pronuncia 35325/07
della Cassazione».
Capisco che tutto ciò vi crei problemi. Insisto: questioni
giuridiche, procedurali, da tribunali ...
«Non ci sono solo procedure, ci sono anche i fatti. Eccoli: la Cir non ha avuto
alcun danno da parte nostra; noi, che non avremmo dovuto pagare neppure un euro,
abbiamo subito un esproprio di 564 milioni, un danno gravissimo per un gruppo
che, non mi stancherò mai di sottolinearlo, è uno dei grandi protagonisti dell'
economia del Paese, e che solo per dare una cifra, negli ultimi 10 anni ha
versato nelle casse dello Stato la bellezza di oltre 5 miliardi di euro, più di
2 milioni al giorno».
Veramente è De Benedetti che lamenta un danno.
«Ma quale danno? La vicenda si concluse con una transazione impostaci dalla
politica che De Benedetti accettò entusiasticamente, come dimostrano le sue
dichiarazioni di allora, senza neppure ricorrere in Cassazione e ci credo che
fosse soddisfatto: si prendeva Repubblica, l'Espresso e i quotidiani locali di
Finegil, una parte rilevantissima della Mondadori, politicamente ed
economicamente».
Lascio a lei la responsabilità di quello che afferma su Cir e
magistratura. Ma a me pare l'ennesima versione della persecuzione contro suo
padre.
«Persecuzione? Non avevo dubbi sul fatto che si trattasse di una sentenza
politica, ora si scopre su che cosa si basa! Non tiro conclusioni, ma veda
lei... Purtroppo la verità è che parlare di persecuzione non è più sufficiente.
Ormai contro mio padre siamo alla barbarie quotidiana legalizzata».
Addirittura barbarie...
«Certo, mi ha molto turbato leggere articoli di informatissimi notisti politici
in cui si considera come un dato scontato che questa aggressione furibonda possa
mettere in discussione la sua libertà personale, il futuro delle sue aziende e
addirittura la sua incolumità. E nessuno fa un salto sulla sedia? Sì, barbarie
quotidiana legalizzata, ma assolutamente illegale».
Illegale cosa? E allora tutte le inchieste aperte da Napoli a
Bari, da Roma a Milano?
«Si inventano inchieste a ripetizione su reati inesistenti e senza vittime solo
per fabbricare fango. Poi il fango fabbricato viene palleggiato tra una Procura
e l' altra e infine riciclato. Il processo, con relativa, inevitabile condanna,
lo si celebra sui media. Quello in aula, se si farà e come finirà non interessa
più a nessuno. So bene, e ci tengo a ripeterlo, che dietro tutto questo c' è
solo una minoranza di toghe, che la magistratura come istituzione merita il
massimo rispetto. Ma il risultato non cambia. E mi chiedo che cosa tutto ciò
abbia a che fare con la giustizia, con l' informazione, con un Paese che si
considera civile».
Me l'aspettavo, il problema sono i magistrati che intercettano e
i giornali che pubblicano.
«Stiamo parlando di centinaia di migliaia di intercettazioni, un numero
spropositato, di cui si è fatto un uso fuori da ogni regola, mi riesce perfino
difficile trovare le parole per definirlo, la verità è che se ci penso mi viene
la nausea. Credo che raramente si sia assistito ad un tale spettacolo di
inciviltà. Altro che bavagli: ma davvero qualcuno può credere e sostenere che si
possa continuare così?»
Da Panorama l’elenco dei procedimenti penali a carico di Silvio Berlusconi
aggiornati al 19 aprile 2012:
1. Proc. Pen n. 5746/93 R.G.N.R. “Viganò Verzellesi” (si segnala che il
dott. Berlusconi è stato iscritto nel registro degli indagati il 28/01/1995)
Reati contestati: corruzione archiviato l’8/08/2000;
2. Proc. Pen. n. 842/95 R.G.N.R. “Falso in bilancio Fininvest libretti
al portatore” Reati contestati: falso in bilancio archiviato il
21/09/2004;
3. Proc. Pen. n. 6081/95 R.G.N.R. “Edilnord Commerciale” Reati
contestati: falso in bilancio archiviato il 21/09/2004;
4. Proc. Pen. n. 6031/94 R.G.N.R. “Palermo riciclaggio” Reati
contestati: concorso esterno in associazione mafiosa – riciclaggio concorso
esterno in associazione mafiosa: archiviato il 19/02/1997 riciclaggio:
archiviato il 25 – 27/11/1998;
5. Proc. Pen. n. 1370/98 “Stragi Caltanissetta” Reati
contestati: concorso in stragi archiviato il 3/05/2002;
6. Proc. Pen. n. 3197/96 R.G.N.R. “Stragi Firenze” Reati
contestati: concorso in stragi archiviato il 14/11/1998;
7. Proc. Pen. n. 3000/96 R.G.N.R. “Progetto Botticelli” Reati
contestati: falso in bilancio – frode fiscale archiviato il 16/02/1998;
8. Proc. Pen. n. 11343/99 R.G.N.R. “Lodo Mondadori” Reati
contestati: corruzione giudiziaria assolto. La sentenza della Corte d’Appello
del 12/05/2001 ha dichiarato di “non doversi procedere perché il reato si è
estinto per intervenuta prescrizione” (concesse le attenuanti generiche),
sentenza confermata in Cassazione;
9. Proc. Pen. n. 11262/94 R.G.N.R. “Tangenti GDF” Reati
contestati: corruzione assolto. La sentenza della Corte di Cassazione del
19/10/2001 ha “assolto in ordine a tutti i capi di imputazione per non aver
commesso il fatto”. Solo per il capo D) l’assoluzione è ai sensi dell’art. 530
co 2 (insufficienza probatoria), dichiarata dalla Corte d’Appello e confermata
dalla Cassazione;
10. Proc. Pen. n. 9811/93 R.G.N.R. “All Iberian 1” (si segnala che il
dott. Berlusconi è stato iscritto nel registro degli indagati il 23/11/1995)
Reati contestati: finanziamento illecito ai partiti assolto. La
sentenza della Corte d’Appello del 26/10/1999 ha dichiarato di “non doversi
procedere perché i reati si sono estinti per prescrizione”, sentenza confermata
in Cassazione;
11. Proc. Pen. n. 10594/95 R.G.N.R. “Medusa” Reati contestati:
falso in bilancio – appropriazione indebita assolto. La sentenza della Corte
d’Appello del 13/06/2000 ha “assolto dal reato ascritto per non aver commesso il
fatto”, sentenza confermata in Cassazione;
12. Proc. Pen. n. 4262/95 R.G.N.R. “Macherio” Reati contestati:
falso in bilancio – appropriazione indebita – frode fiscale assolto. La sentenza
della Corte d’Appello del 28/10/1999 (sentenza definitiva) ha “assolto dal reato
di falso in bilancio perchè il fatto non sussiste, dichiarato non doversi
procedere per il reato di appropriazione indebita per intervenuta amnistia e
confermata la sentenza del Tribunale per la frode fiscale perché il fatto non
sussiste”;
13. Proc. Pen. n. 11749/97 + 12193/98 R.G.N.R. “Corruzione Ariosto SME”
Reati contestati: corruzione assolto. La sentenza della Corte d’Appello
del 27/04/2007 ha “assolto dal reato per l’episodio di cui al capo A) per non
aver commesso il fatto ai sensi dell’art. 530 co 2 cpp e per l’episodio di cui
al capo B) perchè il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 530 co 1 cpp”
sentenza confermata in Cassazione;
14. Proc. Pen. n. 5888/02 R.G.Trib.(stralcio del n. 11749/97 + 12193/98)
“Falso in bilancio Ariosto SME” Reati contestati: falso in bilancio
assolto. La sentenza del Tribunale del 30/01/2008 (sentenza definitiva) ha
“dichiarato il non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato”;
15. Proc. Pen. n. 735/96 R.G.N.R. “Consolidato” Reati
contestati: falso in bilancio assolto. La sentenza del GIP del 13/02/2003 ha
“dichiarato il non doversi procedere in ordine al reato di falso in bilancio
ascritto perché gli stessi sono estinti per prescrizione”, sentenza confermata
in Cassazione;
16. Proc. Pen. n. 2569/99 R.G.N.R. (stralcio del n. 9811/93) “All
Iberian 2” Reati contestati: falso in bilancio assolto. La sentenza del
Tribunale del 26/09/2005 ha “assolto perché il fatto non è più previsto dalla
legge come reato”;
17. Proc. Pen. n. 2601/94 R.G.N.R. “Lentini” Reati contestati:
falso in bilancio assolto. La sentenza della Corte d’Appello del 13/12/2005 ha
confermato la sentenza del Tribunale “di non doversi procedere perché il reato
si è estinto per prescrizione”;
18. Proc. Pen. n. 262/97Y R.G.N.R. - Tribunale di Madrid “Telecinco”
Reati contestati: reati societari – reati contro la Pubblica
Amministrazione (diritto spagnolo) archiviato il 13/10/2008;
19. Proc. Pen. n. 22694/01 R.G.N.R. “Diritti” Reati contestati:
falso in bilancio – appropriazione indebita – frode fiscale con sentenze del
7/07/2006 e 28/05/2007 il Tribunale di Milano ha dichiarato il non doversi
procedere per i reati di falso in bilancio e di appropriazione indebita in
quanto estinti per prescrizione. Per il reato di frode fiscale è in corso il
dibattimento;
20. Proc. Pen. n. 6859/05 R.G.N.R. “Mills” Reati contestati:
corruzione giudiziaria Assolto: 25/02/2012 il Tribunale ha dichiarato il non
doversi procedere per intervenuta prescrizione;
21. Proc. Pen. n. 40382/05 R.G.N.R. “Mediatrade Milano” Reati
contestati: appropriazione indebita – frode fiscale Prosciolto: Il GUP di Milano
ha “prosciolto per non aver commesso il fatto”; in data 01/12/2011 il PM ha
depositato ricorso in Cassazione;
22. Proc. Pen. n. 31358/10 R.G.N.R. “Mediatrade Roma” Reati
contestati: frode fiscale In corso l’udienza preliminare;
23. Proc. Pen. “Santa Margherita Alitalia (convegno del giugno 2009)”
Reati contestati: aggiotaggio e insider trading Archiviato il
18/11/2011;
24. (*) Proc. Pen. n. 58833/07 R.G.N.R. “Intercettazioni Saccà”
Reati contestati: corruzione archiviato il 17/04/2009;
25. (*) Proc. Pen. n. 1349/08 R.G.N.R. “Corruzione Senatori”
Reati contestati: corruzione archiviato;
26. (*) Proc. Pen. Trib. Ministri “Saint Just” archiviato il
26/01/2009;
27. (*) Proc. Pen. Trib. Ministri “Voli di Stato” archiviato
l’8/10/2009;
28. (*) Proc. Pen. n. 41895/09 “UNIPOL - Intercettazioni Fassino
Consorte” Reati contestati: rivelazioni segreto d’ufficio. Disposto il
rinvio a giudizio il 7/02/2012. In corso il dibattimento(richiesta di
archiviazione del 16/12/2010 - 15/09/2011 il G.i.p. ha disposto l’imputazione
coatta per Berlusconi - 22/09/2011 chiesto il rinvio a giudizio);
29. (*) Proc. Pen. n. 55781/2010 + 5657/11 R.G.N.R. “Caso Ruby”
Reati contestati: concussione – favoreggiamento prostituzione minorile il
15/02/2011 il g.i.p. ha disposto con decreto il giudizio immediato (prima
udienza dibattimentale: 6/4/2011);
30. (*) Proc. Pen. “Innocenzi – Anno Zero” Reati contestati:
abuso d’ufficio Chiesta l’archiviazione;
31. (*) Proc. Pen. “Minzolini – De Scalzi” Reati contestati:
abuso d’ufficio. In corso le indagini preliminari;
32. (*) Proc. Pen. “vilipendio alla magistratura” Reati
contestati: vilipendio all’ordine giudiziario. In corso le indagini preliminari;
33. (*) Proc. Pen. Tribunale di Bari Reati contestati:
induzione a rendere false dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria
In corso le indagini preliminari.
(*) trattasi di procedimenti personali e quindi non riguardanti il Gruppo
Fininvest. I dati relativi non rientrano tra quelli della c.d. “sintesi”.
Indagini per stragi a Firenze,
Palermo e Caltanissetta: si tratta di tre indagini riguardanti le stragi di
mafia degli anni 1992/1993, indagini già archiviate in passato (v. n. 5 e 6). Ad
oggi non disponiamo di dati ufficiali, ma solo di notizie di stampa. Negli
ultimi mesi ci sono state sia smentite (Firenze), sia conferme (Palermo), circa
l’iscrizione di Silvio Berlusconi nel registro degli indagati.
Stefania
Craxi: "Ora l'Italia chieda scusa a mio padre". La figlia dello statista
socialista accusa i metodi da «Mani pulite»: "Una vergogna le modalità
dell'arresto di Scajola e i processi aperti sulla stampa per Expo 2015", scrive
Paola Sacchi su “Panorama”. «In questo paese sarebbe
venuta l’ora di chiedere scusa a Bettino Craxi….».
Dopo l’ondata di arresti di giovedì 8 maggio 2014, che hanno resuscitato stili e
metodi spettacolari da «Mani pulite» e che hanno fatto parlare di «una nuova
Tangentopoli», Stefania Craxi in questa intervista a Panorama.it invita ad
andare a rileggersi il celebre e inascoltato intervento dello statista
socialista alla Camera nel luglio 1992.
Ora quelle parole cadute nel vuoto perché tornano secondo lei più che mai
attuali?
"In un coraggiosissimo discorso di fronte al parlamento e alla
nazione Craxi denunciò la degenerazione alla quale era arrivata la società
italiana e chiamò la politica del tempo a porvi un rimedio. Ma seguì un vile
silenzio. In questi vent’anni hanno fatto come le scimmiette: non vedo, non
parlo, non sento. Il degrado è andato avanti di pari passo con una Giustizia
che utilizza spesso due pesi e due misure. Due fenomeni che sono andati a
braccetto. Certi magistrati dalla tentazione golpista, favoriti anche da una
politica imbelle, hanno fatto avanzare la corruzione. Se prima c’era qualche
corrotto, ma la politica era forte, ora non conta più la politica, contano solo
le lobby e gli affari. L’Italia somiglia sempre più a un paese del Sudamerica
che non a un paese moderno e occidentale".
Che effetto le ha fatto rivedere le stesse scene di vent’anni fa e le paginate
dei giornali che ricalcano gli stessi schemi del processo mediatico? Da una
lato, l’ex ministro Claudio Scajola, arrestato di fronte a una marea di
telecamere e fotografi, si dice avvisati per tempo, dall’altro ondate di verbali
di intercettazioni riversate sulla stampa, da Scajola all’inchiesta Expo 2015…
"Il metodo dell’arresto di Scajola è una vera vergogna. E la
vergogna di processi che avvengono prima sulla stampa che nell’aula di
tribunale continua. Anche un colpevole ha diritto a non avere la gogna. E poi i
contorni dell’inchiesta Expo sono pochi chiari perché tutto avviene all’interno
di uno scontro di potere dentro la mitica Procura di Milano".
Che opinione si è fatta?
"I tempi e i modi di questi nuovi arresti non sono estranei a
questo scontro dove c’entrano protezioni, coni d’ombra. Tutto si consuma in una
contrapposizione dove è emersa con molta chiarezza la voglia da parte di certi
magistrati di protagonismo e di avere assegnate le inchieste di grido. Questa è
la novità".
Gli arresti dell’8 maggio avvengono a meno di due settimane dal voto europeo. La
tempistica fa sempre riflettere?
"Avvengono come al solito a pochi giorni dalla elezioni. C’è un
uso improprio della custodia cautelare, che è anche un costo sociale abnorme per
le nostre carceri e i cittadini. A leggere i giornali italiani sembra la
sceneggiatura della stessa telenovela, con le medesime formule giornalistiche,
tipo la cupola, la cupola massonica internazionale…Ma dove è?".
Che impatto politico avranno questi nuovi arresti?
"Questo spettacolo indecente è chiaro che favorirà Beppe Grillo
che è un sintomo anche grave di un sistema malato. La sinistra ha sparso il
morbo giustizialista che è entrato nelle vene dell’elettorato italiano
mischiandosi a un impasto di invidia sociale e odio verso i potenti, aggravato
da una politica che non ha saputo dare risposte. Nella Prima Repubblica i
difetti c’erano, non a caso mio padre parlò di Grande Riforma già nel 1979, ma
c’erano anche le regole, a cominciare dall’articolo 68 della Costituzione
sull’immunità parlamentare, ora invece sono rimasti i difetti ma sono saltate
le regole".
È un fatto che la giornata degli arresti avviene dopo che Silvio Berlusconi è
tornato centrale per fare le riforme, non a caso è stata Forza Italia a salvare
Matteo Renzi al Senato. Che ne pensa?
"Da un lato c’è un giustizialismo che ha offuscato le menti e
generato mostri, e poi c’è sempre una regia da parte di poteri neppure tanto
dichiarati. Quelle di Renzi sono riformicchie, riforme fatte un tanto al chilo,
ma è chiaro che quello che è successo è volto a far saltare il banco. Questo
premier che sembra uscito dalla penna di Collodi elude la riforma della
Giustizia. E intanto il Pd l’altro giorno in commissione ha votato contro la
responsabilità civile dei magistrati".
LE MANI
SPORCHE DI MANI PULITE. PASQUALE CASILLO.
PASQUALE
CASILLO E BERLUSCONI.
Era il ”Re del
Grano”, l´inventore di Zemanlandia, il fautore del miracolo del Foggia in serie
A e dell´Avellino in serie B, ma per tredici anni Pasquale Casillo, noto a tutti
come “Don Pasquale” da San Giuseppe Vesuviano, pesava l´accusa del famigerato
articolo 110 - 416bis, concorso esterno in associazione di stampo mafioso: un
reato grave da cui Casillo, soltanto in tarda mattina del 16 febbraio 2007, è
stato assolto dai giudici del tribunale di Nola, in provincia di Napoli, che
hanno accolto le richieste del pubblico ministero Vincenzo D´Onofrio. Per Don
Pasquale, dunque, assistito dall´avvocato Ettore Stravino e da Bruno Von Arx, è
giunta l´assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto. Casillo
fu arrestato il 21 aprile del 1994 non solo per associazione mafiosa, ma anche
per truffa e peculato. Era stato accusato, insieme ad altri, infatti, di aver
frodato l’Aima, l´Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo. Per
questi ultimi reati è scattata la prescrizione, ma per Pasquale Casillo restava
in piedi la ben più grave macchia, il 416bis, che da ieri non ha più nulla a che
fare con l´ex Re del Grano. Un “impero”, quello di Casillo, che valeva milioni e
milioni di euro e che gli deve essere restituito poiché sono stati revocati i
provvedimenti di sequestro cautelare sulle aziende e sui beni personali. «In
questa brutta storia, potevo perdere tutto ma non la dignità» ha dichiarato
l´imprenditore. Nei primi anni ´90 l’industriale campano, presidente
dell´Assindustria di Foggia, era il gotha dell´imprenditoria nazionale: il suo
“impero” era impegnato in tutti i campi, dal commercio allo stoccaggio del
grano, dai trasporti navali al mondo del calcio. E che calcio. Ma Casillo aveva
anche partecipazioni importanti in istituti di credito (Banca Mediterranea e
Caripuglia ndr) e società immobiliari e turistiche. E poi, oltre al Foggia di
Zeman, era proprietario anche di Salernitana e Bologna e voleva “mettere le
mani” sulla Roma di Ciarrapico. Poi, quel 21 aprile, l´arresto a Foggia: a far
emettere le ordinanze dai giudici di Napoli le deposizioni di un pentito della
camorra, il boss Pasquale Galasso. Nonostante un pool di primarie banche,
coordinate dall´ABI, avesse offerto un cospicuo finanziamento ponte di 100
miliardi di vecchie lire, rifiutato dal neoamministratore giudiziario del
gruppo, scatta la molla dell´istanza di fallimento, richiesta dai creditori del
gruppo Casillo. Nel maggio del 1994, su istanza del Banco di Napoli, finiscono
in tribunale i libri della capogruppo, la “Casillo Grani Snc”, società in nome
collettivo. E incomincia il pellegrinaggio dell´inchiesta principale. Casillo si
è sempre dichiarato innocente, anzi «perseguitato dai giudici», e ha sempre
richiesto di essere processato subito. Con gli anni vengono prescritti tutti gli
eventuali reati fiscali. Restava, fino a ieri, solo il 416bis. E per Casillo il
fantasma della mafia, anzi della camorra campana, svanisce, così come era
svanito, qualche anno prima, per l´ex ministro dell´Interno Antonio Gava, che è
stato assolto - come molti altri imputati eccellenti - in tutti i gradi nel
processo per camorra basato in massima parte sulle dichiarazioni del medesimo
pentito Pasquale Galasso, lo stesso accusatore di Casillo.
Casillo: il
candidato ideale contro certe toghe rosse, scrive Ruggiero Capone su
“L’Opinione”. «Presidente
Berlusconi, dica a Pier Ferdinando Casini, dato che si dice cattolico: memento
homo! Visto l’atteggiamento ostile che l’onorevole Casini ha assunto nei Suoi
personali confronti, gli ricordi ciò che accadde la mattina dell’8 febbraio
1994, ultimo giorno utile per l’apparentamento delle liste delle famose elezioni
che La videro entrare nell’orbita politica. Lei accettò che Mastella, Casini e
D’Onofrio rientrassero in gioco (precedentemente rifiutati per la pretesa di
avere ministero del Lavoro e Istruzione) solo per le pressioni che Le feci prima
mediante Domenico Mennitti, mio ex direttore del “Roma”, poi attraverso Adriano
Galliani e, infine, per l’intervento risolutivo di Marcello Dell’Utri alle 7:30,
mentre la pietosa delegazione dei mendicanti avevano preso comunque l’aereo
verso Milano, speranzosi in un miracoloso ultimo mio intervento presso di Lei.
Ricordi a Casini che li fece prelevare in extremis all’aeroporto di Linate con
una vostra macchina. Rammenti anche a Casini che intervenni dopo le ossessive e
continue telefonate del giorno precedente continuate al mattino dell’onorevole
Mastella, il quale mi riferì che in macchina (in taxi verso Fiumicino) con lui
c’era anche Casini e D’Onofrio. Peccato, che non esistano tracce registrate!
Eppure, essendo il sottoscritto, già dall’anno precedente, nel mirino
dell’Antimafia di Napoli e, di lì a poco arrestato, mercoledì 21 aprile ’94, mi
fa meraviglia che un “camorrista” della mio livello, e, a dire degli inquirenti,
socio in malaffari di Alfieri e Galasso, non avesse il telefono sotto controllo!
Di tutto questo, me ne se sono lamentato anche in un pubblico processo. Le pare
verosimile? O non, piuttosto, che sia stato tutto messo a tacere? Poiché, delle
due una: o il mio telefono non era sotto controllo, e sarebbe roba da inetti
oppure è stato tutto dolosamente insabbiato. Le scrivo questo solo per ricordare
a Lei chi ero, a Casini la sua ingratitudine (senza di Lei, politicamente,
sarebbe già defunto) e allo Stato... qualche ridicola inadempienza! Saluti.
Roma, 17 gennaio 2013, Pasquale Casillo». Questo il contenuto della missiva che
Pasquale Casillo (all’epoca imprenditore agroalimentare di rilievo mondiale,
editore del quotidiano Roma e proprietario di club calcistici) ha inviato a
Silvio Berlusconi. «Attualmente ho la fedina penale integra! - precisa Casillo -
Sono stato assolto, dopo ben 13 anni, su richiesta della stessa Procura che mi
aveva arrestato, sequestrato l’intero patrimonio e conseguentemente fatto
fallire tutte le aziende del mio Gruppo (56 aziende in tutto il mondo) che
all’epoca fatturavano ben 2.000 miliardi, a causa di un amministratore
giudiziario (il mio Bondi) la cui segretaria era una “segreteria telefonica”.
Questo signore da me denunciato, e da ben quattro anni attendo un Ctu dalla
procura di Napoli». Le persecuzioni giudiziarie nei riguardi di Pasquale Casillo
sono durate 29 anni (iniziavano nel 1984). Ma l’imprenditore è poi risultato
assolto in tutti i processi. Dopo decine di assoluzioni nessun giornale ha mai
provveduto a riabilitare l’uomo dinnanzi all’opinione pubblica. Casillo ci
rammenta i due casi più recenti in ordine di tempo. «Il fallimento della società
capogruppo - spiega Casillo - la Casillo Grani snc, per una presunta accusa di
bancarotta fraudolenta aggravata (un caso simile a Cirio e Parmalat che si
consumava 10 anni prima) che si sarebbe prescritta dopo 18 anni e 6 mesi, ma che
a 17 anni, guardo un po’! - rimarca l’imprenditore - essendo ancora allo stato
indiziario (solo iscritta al modello 21) quindi senza neppure aver fatto
un’udienza o un interrogatorio, è stata archiviata (12 marzo 2012) con
motivazione “il fatto non sussiste”. È più grave assolvere col fatto non
sussiste o che oggi comunque si sarebbe prescritta senza iniziare. Si sarebbe
prescritta a febbraio 2013, non penso esista caso simile in Europa». L’episodio
che ancora turba Pasquale Casillo è come sia stato costruito in suo danno il
processo per “concorso in associazione camorristica”. «Processo per concorso in
associazione camorristica - ci ripete Casillo con tono indignato - dopo quasi 13
anni unico imputato… in quaranta minuti (di cui 10 di camera di consiglio),
senza contraddittorio dei pentiti, senza i testi di accusa e di difesa (ho
rinunciato ai mie 70 testi): sono stato assolto con formula piena su richiesta
della Procura. Non ho avuto il piacere di avere come testi d’accusa né il capo
dei Ros di allora né quello della Dia, eppure avevano firmato i verbali. E
pensare che i signori dell’antimafia avevano confuso l’ambasciatore Usa Peter
Secchia con un camorrista...». Pasquale Casillo è ancora una persona solare,
sorridente, alla mano. La persecuzione non ha nemmeno scalfito il suo carattere
mite, pacioso. «Era un vero amico del calcio!», ci rammentava un signore
incontrato in un bar di Foggia. Fu Casillo ad ingaggiare Zdenek Zeman per il
Foggia calcio scivolato in C1: Casillo contribuiva di fatto alla costruzione
d’una città per allenare i giovani, i giornali l’appellarono subito
“Zemanlandia”, intanto svettava il “Foggia dei miracoli”. Così Zeman, dopo una
stagione alla guida del Messina, non resisteva al nuovo ingaggio di Casillo,
sempre nel Foggia, neopromosso in Serie B. Nel 1989 al “Foggia dei miracoli” fa
solo ombra la Foggia che scende di tre punti nelle statistiche della
disoccupazione, grazie alle assunzioni nella Casillo grani. 1993-1994, ultima
stagione prima dell’addio di Zeman, il Foggia sfiora l’ingresso in Coppa Uefa,
sconfitto (0-1) da un Napoli all’ultima giornata di campionato. Nonostante la
persecuzione giudiziaria, Casillo non abbandona il campo. Nella stagione
2003-2004 all’Avellino calcio, Zeman ritrova il presidente Pasquale Casillo. Ed
arriviamo al 20 luglio 2010, quando la famiglia dell’ormai storico presidente
degli anni della ribalta (Pasquale Casillo) riacquista ufficialmente il Foggia,
e naturalmente richiama come allenatore Zeman. «Il Foggia dei miracoli è
tornato», urlano i tifosi per strada. Ma dopo aver continuato a pensare in
grande, con l’approvazione di un accordo di programma per realizzare un nuovo
stadio comunale e 1000 appartamenti a Foggia, la lobby dei costruttori mette in
piedi mille paletti per far abortire il sogno. Oggi chi restituirà i posti di
lavoro nella Casillo grani? Soprattutto chi risarcirà la famiglia Casillo di
quasi 30 anni di malagiustizia? Oggi Foggia è l’ultima città d’Italia per Pil,
ai tempi della Casillo grani se la batteva con le ridenti cittadine del
centro-nord.
La
provocazione di Casillo: "Io, sempre assolto, voglio Libera al mio fianco".
Alla presentazione del libro di cui chiede il sequestro, scrive “Foggia città
aperta”. E’ arrivato alla fine della presentazione. Si è seduto tra il pubblico.
Tra i tanti accorsi per sentir parlare di ‘Criminali di Puglia.
1973-1994: dalla criminalità negata a quella organizzata’, il libro scritto da
Nisio Palmieri ed edito dalle edizioni la meridiana. Completo scuro e aria di
chi sta per sbottare. Per gridare tutto il suo disappunto nei confronti
dell’autore che parla. Perché quello scritto da Nisio Palmieri è un libro che
l’ha fatto arrabbiare, che ha risvegliato un passato che voleva dimenticare.
Pasquale Casillo ieri sera non ha resistito. Del resto, la sua presenza nella
Sala Marcone della Biblioteca Provinciale ‘La Magna Capitana’ di Foggia, era
nell’aria. E alla fine si è materializzato. E’ apparso a tutti. Ed ha parlato.
“Penso che mi abbiate riconosciuto" ha esordito l’ex re del grano. E dopo
essersi alzato in piedi, ha preso la parola e davanti a tutti ha esposto il suo
pensiero. “Ho chiesto alla procura di Trani il sequestro del libro
perché Criminali di Puglia è un libro diffamatore, in cui mi vengono attribuiti
delitti gravissimi che non ho mai commesso”. Poi, l’affondo verso l’autore, che
nel suo libro ripercorre l’evolversi, l’insediarsi e l'espandersi della
criminalità organizzata pugliese. “Non stimo affatto Nisio Palmieri, ma il suo
libro mi ha dato l’occasione per raccontare nuovamente la mia vicenda personale,
la vicenda giudiziaria di cui sono vittima e da cui sono sempre stato assolto”.
Difficile togliergli la parola. Più facile, come farà Elvira Zaccagnino qualche
ora dopo, affidare allo scritto il proprio commento. La presidente delle
edizioni La meridiana racconta: “Non sono di Foggia. Non conosco Casillo -
scrive la Zaccagnino - se non dai giornali di oltre 30 anni di cronaca pugliese
e nazionale. Sempre assolto. E' vero. Ma ieri il suo fare, il suo dire, il suo
ammiccare erano tipici di un modus inquietante. Il suo minacciare e dichiarare
amicizia, il suo chiedere a Libera di essere al suo fianco a testimoniare la sua
innocenza toglievano il respiro. La cappa sulla città l'ho respirata in quella
sala“. Non manca un riferimento a Daniela Marcone. “A Daniela – evidenzia la
Zaccagnino – Casillo dice anche di una lettera inviata da un sacerdote a don
Luigi Ciotti che ha firmato la prefazione del libro. Noi lo sapevamo già.
Daniela no. Quel prete in quella lettera scagiona Casillo da tutto, anche da ciò
a cui non si fa riferimento nel libro e rimprovera Ciotti di essersi prestato a
scrivere la Prefazione di un libro simile". E poi: “Casillo conclude dicendo che
farà una conferenza stampa dove vuole accanto Daniela Marcone, che è referente
di Libera ed è la figlia di Francesco Marcone, funzionario dello Stato ammazzato
a Foggia, a testimoniare la sola verità: la sua".
"Mi chiedo da ieri sera - conclude la Zaccagnino - la ragione per cui 2 pagine
di un libro fanno paura di fronte ai 56 e oltre processi da cui si è stati
assolti. E mi chiedo come si faccia a fare di una città condominio una città
comunità. La sfida è questa per aggrapparsi alla speranza. Condividere la
cronaca di un momento forse è un modo per cominciare".
SE SGARRI A
PARLARE, I MANETTARI TI QUERELANO.
Facci massacra Travaglio: querela tutti (pure un morto) e perde,
scrive “Libero Quotidiano”. Mettetevi seduti. Il collega Marco Travaglio e il
suo avvocato Caterina Malavenda hanno querelato la bellezza di 49 articoli del
Giornale tutti insieme, più altri dei siti Dagospia e Macchianera: e cioè 27
articoli miei, 3 di Gian Marco Chiocci, 3 di Maria Giovanna Maglie, 2 di
Alessandro Sallusti, 2 di Mario Giordano, 2 di Paolo Bracalini, 2 di Paolo
Granzotto, più 1 a cranio scritti da Vittorio Feltri, Vittorio Sgarbi,
Alessandro Caprettini, Francesco Cramer, Renato Farina, Cristiano Gatti, Gianni
Pennacchi (che al momento della querela era morto da due anni) più la missiva di
un lettore, Renato Niccodemo. Ho scritto «querelato» per comodità, ma era una
causa civile (che punta direttamente ai soldi) la quale il 14 febbraio 2011 è
stata intentata principalmente al Giornale e che mirava a 400mila euro di
risarcimento più la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani, a caratteri
doppi del normale. I soldi dovevano ristorare la sofferenza di Marco Travaglio
in quanto da marzo 2008 a dicembre 2009 - si legge - «con cadenza giornaliera è
stato oggetto di attacchi diffamatori, insulti personali e notizie false e
denigratorie». La causa-querela per diffamazione vantava 57 allegati e citava il
sottoscritto quale «giornalista che si è distinto per numero e gratuità degli
attacchi nei confronti di Travaglio... Una vera e propria campagna di stampa,
della quale Facci rappresenta la punta di diamante, ma che trova in
editorialisti e giornalisti il necessario compendio». In altre parole io avrei
rivolto «epiteti offensivi» nonché «false informazioni circa vacanze trascorse
con persona indicata come favoreggiatore di mafiosi», oltre ad averlo indicato
«quale portavoce di uomini politici e magistrati». Com’è finita? Ci limitiamo ai
dati secchi e ci asteniamo dal commentare: anche se la tentazione sarebbe forte.
La sentenza ha negato un risarcimento e ha stabilito che anche «la richiesta di
pubblicazione della sentenza deve essere rigettata», mentre le spese processuali
s’intendono «integralmente compensate tra le parti». La sentenza è passata in
giudicato perché sono scaduti i termini per l’impugnazione, ma questo dopo che
le parti (gli avvocati) hanno raggiunto un accordo affinché ai querelanti siano
rifuse le spese legali. Il giudice Serena Baccolini, il 5 marzo 2014, ha infatti
deciso che «la domanda risarcitoria deve essere rigettata» in quanto Travaglio &
Malavenda hanno chiesto soldi «senza argomentare in ordine alla sussistenza del
pregiudizio patito», giacché «spetta a colui che chiede il risarcimento offrire
la prova dell’evento dannoso e dei pregiudizi conseguenti». Cioè: fare una causa
semplicemente ammassando articoli scritti contro Travaglio («introdurre un
contenzioso caratterizzato da una pluralità di condotte») comportava perlomeno
che il giornalista allegasse «l’incidenza lesiva dei singoli scritti...».
Insomma, Travaglio doveva anche spiegarli, questi danni patiti, ergo descriverli
al giudice: altrimenti qualcuno potrebbe pensare che volesse soltanto lucrare
querelando dei suoi colleghi, gente che, oltretutto, non ha mai querelato lui,
nonostante il linguaggio che adotta regolarmente. I legali dei querelati, su
questo, si sono anche permessi di fare dei chiari esempi «di come Travaglio si
rivolge a terzi», in particolare contro Facci, Feltri e Belpietro. Non
dispiacerà se omettiamo. Va detto che, tra i 49 articoli descritti nella
citazione, il giudice ha intravisto solo tre casi (3) in cui a suo dire è stato
«violato il principio della continenza formale»: due sono miei (12 maggio 2008 e
1° maggio 2009) e uno è di Renato Farina (15 dicembre 2009). Eviteremo di
ripetere le tre espressioni che il giudice ha ritenuto diffamatorie. Per
signorilità, tuttavia, eviteremo di ripetere anche tutte quante le espressioni
che, in 46 articoli su 49, non sono state ritenute diffamatorie. Poco importa
che sostantivi all’apparenza innocui («fighetta», «scarabeo», «becchino») siano
state giudicate «legittimo esercizio del diritto di critica». Altri contenuti
però riportano a fatti accaduti o a questioni ricorrenti, e il contenuto della
sentenza va comunque registrato: se non altro, anche qui, per legittimo
esercizio del diritto di cronaca e di critica, e fermo restando che le sentenze
non possono essere, al di là delle abitudini di Travaglio, gli unici parametri a
cui guardare. In vari articoli dello scrivente, per esempio, si citava la
vacanza trascorsa da Marco Travaglio con il maresciallo della Dia Giuseppe
Ciuro, inquisito per favoreggiamento di un mafioso: secondo la sentenza, «il
fatto è vero per pacifica ammissione anche dell’attore, e non è controverso che
Ciuro sia stato arrestato nel novembre 2003 per favoreggiamento nei termini
indicati. L’articolo nasce come risposta alle dichiarazioni di Travaglio sulle
dedotte frequentazioni dell’on. Schifani... La circostanza riferita da Facci,
sempre relativamente alla vacanza trascorsa da Travaglio in una struttura
sottoposta ad amministrazione con sottrazione alla proprietà, è vera». E su
questo non ci piove. Secondo il giudice, poi, si può scrivere che Travaglio è un
«pregiudicato» (16 ottobre 2008: «Facci, accostando genericamente il termine
“pregiudicato” a condanne penali e a condanne in sede civile, e con il ricorso
del virgolettato, ne fa intendere ai lettori l’uso non tecnico, mentre del tutto
irrilevanti risultano le dedotte inesattezze sulla prescrizione del reato in cui
avrebbe potuto incorrere Travaglio»). Ma su questo, paradossalmente, non siamo
neppure completamente d’accordo col giudice, anche se ci dà ragione: vero è che
la sentenza non fa giurisprudenza - perché non ha il sigillo della Cassazione -
ma ci lascia perplessi che un giudice possa valutare come meramente «non
tecnica» l’adozione del termine «pregiudicato» per un condannato in sede civile,
quale era Travaglio. Le condanne di Travaglio in sede penale sono un altro
discorso. Ci sono poi, ancora, varie espressioni ritenute lecite dal giudice e
che attengono soltanto a «un giudizio di Facci sull’attività di Travaglio nel
mondo del giornalismo». Ripetere queste espressioni, ora, sarebbe stucchevole.
In futuro, ci si limiterà a riusarle.
TOGHE
ROSSE…E TOGHE BIANCHE.
Successe più o meno la stessa cosa ai tempi di monsieur de
Robespierre e dei giacobini. Fatto fuori il re, si illusero di avere
la Francia in pugno. Manco per niente. Iniziarono a scannarsi l’un
l’altro. Fin quando un giorno accompagnarono Robespierre,
l’Incorruttibile, al patibolo. Gli gridavano dietro: «Morte al tiranno».
Avete capito la storia?
Ecco la prova: i giudici fanno politica. Lo studio di due ricercatori svela:
i magistrati di sinistra indagano di più la destra. Ecco la prova: i giudici
fanno politica. La persecuzione degli avversari rilevata in un saggio
scientifico, scrive Luca Fazzo su “Il Giornale”. Alla fine, la questione può
essere riassunta così, un po' cinicamente: ma d'altronde il convegno si tiene
nella terra del Machiavelli. «Chiunque di noi fa preferenze. Se può scegliere se
indagare su un nemico o su un amico, indaga sul nemico. È l'istinto umano. E
vale anche in politologia». Parola di Andrea Ceron, ricercatore alla facoltà di
Scienze politiche di Milano. Che insieme al collega Marco Mainenti si è messo di
buzzo buono a cercare risposte scientifiche a una domanda che si trascina da
decenni: ma è vero che in Italia i giudici indagano in base alle loro preferenze
politiche? La risposta Ceron e Mainenti la daranno oggi a Firenze, presentando
il loro paper - anticipato ieri dal Foglio - in occasione del convengo annuale
della Società italiana di Scienza politica. È una risposta basata su tabelle un
po' difficili da capire, modelli matematici, eccetera. Ma la risposta è chiara:
sì, è vero. La magistratura italiana è una magistratura politicizzata, le cui
scelte sono condizionate dalle convinzioni politiche dei magistrati. I pm di
sinistra preferiscono indagare sui politici di destra. I pm di destra chiudono
un occhio quando di mezzo ci sono i loro referenti politici. Una tragedia o la
conferma scientifica dell'esistenza dell'acqua calda? Forse tutte e due le cose
insieme. Ventidue pagine, rigorosamente scritte in inglese, intitolate «Toga
Party: the political basis of judicial investigations against MPs in Italy,
1983-2013». Dove MPs è l'acronimo internazionale per «membri del Parlamento». I
politici, la casta, quelli che da un capo all'altro della terra devono fare i
conti con le attenzioni della magistratura. Racconta Ceron: «Nei paesi dove i
magistrati sono eletti dalla popolazione, come l'America o l'Australia, che si
facciano condizionare dalla appartenenza politica è noto e quasi scontato. Ma
cosa succede nei paesi, come l'Italia, dove in magistratura si entra per
concorso e dove non c'è un controllo politico? Questa è la domanda da cui
abbiamo preso le mosse». Ricerca articolata su due hypothesis, come si fa tra
scienziati empirici: 1) più l'orientamento politico di un giudice è lontano da
quello di un partito, più il giudice è disposto a procedere contro quel partito;
2) i giudici sono più disponibili a indagare su un partito, quanto più i partiti
rivali aumentano i loro seggi. Come si fa a dare una risposta che non sia una
chiacchiera da bar? Andando a prendere una per una le richiesta di
autorizzazione a procedere inviate dalle procure di tutta Italia al Parlamento
nel corso di trent'anni, prima, durante e dopo Mani Pulite; catalogando il
partito di appartenenza dei destinatari. E andando a incrociare questo dato con
l'andamento, negli stessi anni e negli stessi tribunali, delle elezioni per gli
organi dirigenti dell'Associazione nazionale magistrati, l'organizzazione
sindacale delle toghe, catalogandoli in base al successo delle correnti di
sinistra (Magistratura democratica e Movimento per la giustizia), di centro
(Unicost) e di destra (Magistratura indipendente); e dividendo un po'
bruscamente in «tribunali rossi» e in «tribunali blu». «Il responso è stato
inequivocabile», dice Ceron. Ovvero, come si legge nel paper: «I risultati
forniscono una forte prova dell'impatto delle preferenze dei giudici sulle
indagini. I tribunali dove un numero più alto di giudici di sinistra
appartengono a Md e all'Mg, tendono a indagare maggiormente sui partiti di
destra. La politicizzazione funziona in entrambe le direzioni: un aumento di
voti per le fazioni di destra fa scendere le richieste contro i partiti di
destra». I numeri sono quelli di una gigantesca retata: 1.256 richieste di
autorizzazione a procedere nei confronti di 1.399 parlamentari. Di queste, i due
ricercatori hanno focalizzato quelle relative ai reati di corruzione e
finanziamento illecito: 526, per 589 parlamentari. Fino al 1993, come è noto,
l'autorizzazione serviva anche per aprire le indagini, oggi è necessaria solo
per arrestare o intercettare. Ma, secondo la richiesta di Ceron e Mainardi, non
è cambiato nulla: almeno nella componente ideologica dell'accusa, che i due
considerano scientificamente e platealmente dimostrata. Dietro due grandi alibi,
che sono la mancanza di risorse e la presunta obbligatorietà dell'azione penale,
di fatto vige la più ampia discrezionalità. È un pm quasi sempre ideologicamente
schierato a scegliere su quale politico indagare. E quasi sempre dimentica di
dimenticarsi le sue opinioni. «L'analisi dei dati - spiega Ceron - dice che i
comportamenti sono lievemente diversi tra giudici di sinistra e di destra:
quelli di sinistra sono più attivi nell'indagare gli avversari, quelli di destra
preferiscono risparmiare accuse ai politici del loro schieramento». Ma in ogni
caso, di giustizia piegata all'ideologia e all'appartenenza politica si tratta.
Unita ad un'altra costante, di cui pure qualche traccia si coglie a occhio nudo:
fino a quando un partito è saldamente al potere, i pm sono cauti. Ma quando il
suo potere traballa e si logora, allora si scatenano.
Dopo gli Anni di piombo e le decine di magistrati uccisi dalle Brigate rosse e
dall'eversione di destra e di sinistra la corrente di Md più vicina al Partito
comunista scala le gerarchie della magistratura e impone il suo diktat, come
racconta al Giornale un ex giudice di Md: «Serve una giurisprudenza alternativa
per legittimare la lotta di classe e una nuova pace sociale». Ma serviva una
legittimazione incrociata. Non dallo Stato né dal popolo, ma da quel Pci
diventato Pds in crisi d'identità dopo il crollo del Muro di Berlino.
Tangentopoli nacque grazie a un matrimonio d'interessi e un nemico comune:
Bettino Craxi.
Quell'abbraccio tra Pci e Md che fece scattare Mani pulite.
Magistratura democratica pianificò l'alleanza col Pds sul giustizialismo per
ridare smalto alle toghe e offrire agli eredi del Pci il ruolo di moralizzatore
contro la corruzione in Italia,
scrive Sergio d'Angelo su “Il
Giornale”. «La piattaforma politico-programmatica elaborata per la nuova
Magistratura democratica poteva convincere ed attirare buona parte dei giovani
magistrati, cresciuti politicamente e culturalmente nel crogiolo sessantottino.
Ma bisognava fornire a Md una base giuridica teorica che potesse essere
accettata dal mondo accademico e da una parte consistente della magistratura.
Ancora una volta fu la genialità di Luigi Ferrajoli a trovare una risposta: «La
giurisprudenza alternativa (...) è diretta ad aprire e legittimare (...) nuovi e
più ampi spazi alle lotte delle masse in vista di nuovi e alternativi assetti di
potere (...). Una formula che configura il giudice come mediatore dei conflitti
in funzione di una pace sociale sempre meglio adeguata alle necessità della
società capitalistica in trasformazione». In qualunque democrazia matura la
prospettiva tracciata da Ferrajoli non avrebbe suscitato altro che una normale
discussione accademica tra addetti ai lavori: ma la verità dirompente era tutta
italiana. Celato da slogan pseudorivoluzionari, il dibattito nel corpo
giudiziario ad opera di Md negli anni '70 e '80 presentava questo tema
fondamentale: a chi spetta assicurare ai cittadini nuovi fondamentali diritti
privati e sociali? Al potere politico (e di quale colore) attraverso
l'emanazione di norme (almeno all'apparenza) generali ed astratte, o all'ordine
giudiziario con la propria giurisprudenza «alternativa»? Un dubbio devastante
cominciò a infiltrarsi tra i magistrati di Md. Se la magistratura (o almeno la
sua parte «democratica») era una componente organica del movimento di classe e
delle lotte proletarie, allora da dove proveniva la legittimazione dei giudici a
«fare giustizia»? Dallo Stato (come era quasi sempre accaduto), che li aveva
assunti previo concorso e li pagava non certo perché sovvertissero l'ordine
sociale? Dal popolo sovrano? Da un partito? Quelli furono anni tragici per
l'Italia. Tutte le migliori energie della magistratura furono indirizzate a
combattere i movimenti eversivi che avevano scelto la lotta armata e la sfida
violenta allo Stato borghese: i giudici «democratici» pagarono un prezzo
elevato, l'ala sinistra della corrente di Md rimase isolata mentre l'ala
filo-Pci di Md mantenne un basso profilo. Dell'onore postumo legato al pesante
prezzo di sangue pagato dai giudici per mano brigatista beneficiarono
indistintamente tutte le correnti dell'ordine giudiziario, compresa Md e la
magistratura utilizzò questo vernissage per rifarsi un look socialmente
accettabile. Solo la frazione di estrema sinistra di Md ne fu tagliata fuori, e
questo determinò - alla lunga - la sua estinzione. Alcuni furono - per così dire
- «epurati»; a molti altri fu garantito un cursus honorum di tutto rispetto, che
fu pagato per molti anni a venire (Europarlamento, Parlamento nazionale, cariche
prestigiose per chi si dimetteva, carriere brillanti e fulminee per altri).
Quelli che non si rassegnarono furono di fatto costretti al silenzio e poi
«suicidati» come Michele Coiro, già procuratore della Repubblica di Roma,
colpito il 22 giugno 1997 da infarto mortale, dopo essere stato allontanato dal
suo ruolo (promoveatur ut amoveatur) dal Csm. L'ala filo Pci/Pds di Md,
vittoriosa all'interno della corrente, non era né poteva diventare un partito,
in quanto parte della burocrazia statale. Cercava comunque alleati per almeno
due ragioni: difendere e rivalutare un patrimonio di elaborazione teorica
passato quasi indenne attraverso il terrorismo di estrema sinistra e la lotta
armata e garantire all'intera «ultracasta» dei magistrati gli stessi privilegi
(economici e di status) acquisiti nel passato, pericolosamente messi in
discussione fin dai primi anni '90. Questo secondo aspetto avrebbe di sicuro
assicurato alla «nuova» Md l'egemonia (se non numerica certo culturale)
sull'intera magistratura associata: l'intesa andava dunque trovata sul terreno
politico, rivitalizzando le parole d'ordine dell'autonomia e indipendenza della
magistratura, rivendicando il controllo di legalità su una certa politica e
proclamando l'inscindibilità tra le funzioni di giudice e pubblico ministero.
Non ci volle molto ad individuare i partiti «nemici» e quelli potenzialmente
interessati ad un'alleanza di reciproca utilità. Alla fine degli anni '80 il Pci
sprofondò in una gravissima crisi di identità per gli eventi che avevano colpito
il regime comunista dell'Urss. Non sarebbe stato sufficiente un cambiamento di
look: era indispensabile un'alleanza di interessi fondata sul giustizialismo,
che esercitava grande fascino tra i cittadini, in quanto forniva loro
l'illusione di una sorta di Nemesi storica contro le classi dirigenti nazionali,
che avevano dato pessima prova di sé sotto tutti i punti di vista. La rivincita
dei buoni contro i cattivi, finalmente, per di più in forme perfettamente legali
e sotto l'egida dei «duri e puri» magistrati, che si limitavano a svolgere il
proprio lavoro «in nome del popolo». Pochi compresero che sotto l'adempimento di
un mero dovere professionale poteva nascondersi un nuovo Torquemada. Il Pci/Pds
uscì quasi indenne dagli attacchi «dimostrativi» (tali alla fine si rivelarono)
della magistratura che furono inseriti nell'enorme calderone noto come Mani
Pulite: d'altronde il «vero» nemico era già perfettamente inquadrato nel mirino:
Bettino Craxi. Chi scrive non è ovviamente in grado di dire come, quando e ad
opera di chi la trattativa si sviluppò: ma essa è nei fatti, ed è dimostrata dal
perfetto incastrarsi (perfino temporale) dei due interessi convergenti.
Naturalmente esistono alleanze che si costituiscono tacitamente, secondo il
principio che «il nemico del mio nemico è mio amico», e non c'è bisogno di
clausole sottoscritte per consacrarle. Quando il pool graziò il Pds e i
giudici diventarono casta. Mani pulite con la regia di Md sfiorò il partito
per dimostrare che avrebbe potuto colpire tutti Il Parlamento si arrese,
rinunciando all'immunità. E così consegnò il Paese ai magistrati - continua
Sergio d'Angelo su “Il
Giornale”. - Per rendersi credibile alla magistratura, il tacito accordo
tra Md e Pds avrebbe dovuto coinvolgere magistrati della più varia estrazione e
provenienza politica e culturale. Nel 1989 era entrato in vigore il nuovo codice
di procedura penale che apriva la strada ad un'attività dell'accusa priva di
qualunque freno, nonostante l'introduzione del Gip (giudice delle indagini
preliminari), in funzione di garanzia dei diritti della difesa. C'è un
significativo documento - intitolato I mestieri del giudice - redatto dalla
sezione milanese di Md a conclusione di un convegno tenutosi a Renate il 12
marzo 1988, in casa del pm Gherardo Colombo. In quel testo l'allora pm di Milano
Riccardo Targetti tracciò una netta distinzione tra «pm dinamico» e «pm
statico», schierandosi naturalmente a favore della prima tipologia, come il
nuovo codice gli consentiva di fare. Che cosa legava tra loro i componenti del
pool Mani pulite? Nulla. Che Gerardo D'Ambrosio (chiamato affettuosamente dai
colleghi zio Jerry) fosse «vicino» al Pci lo si sapeva (lui stesso non ne faceva
mistero), ma non si dichiarò mai militante attivo di Md. Gherardo Colombo era
noto per aver guidato la perquisizione della villa di Licio Gelli da cui saltò
fuori l'elenco degli iscritti alla P2: politicamente militava nella sinistra di
Md, anche se su posizioni moderate. Piercamillo Davigo era notoriamente un
esponente di Magistratura indipendente, la corrente più a destra. Francesco
Greco era legato ai gruppuscoli dell'estrema sinistra romana (lui stesso ne
narrava le vicende per così dire «domestiche»), ma nel pool tenne sempre una
posizione piuttosto defilata. Infine, Di Pietro, una meteora che cominciò ad
acquistare notorietà per il cosiddetto «processo patenti» (che fece piazza
pulita della corruzione nella Motorizzazione civile di Milano) e
l'informatizzazione accelerata dei suoi metodi di indagine, per la quale si
avvalse dell'aiuto di due carabinieri esperti di informatica. Il 28 febbraio
1993, a un anno dall'arresto di Mario Chiesa, cominciano a manifestarsi le prime
avvisaglie di un possibile coinvolgimento del Pds nell'inchiesta Mani pulite con
il conto svizzero di Primo Greganti alias «compagno G» militante del partito,
che sembra frutto di una grossa tangente. Il 6 marzo fu varato il decreto-legge
Conso che depenalizzava il finanziamento illecito ai partiti. Il procuratore
Francesco Saverio Borrelli va in tv a leggere un comunicato: la divisione dei
poteri nel nostro Paese non c'era più. Il presidente Oscar Luigi Scalfaro si
rifiuta di firmare il decreto, affossandolo. Alla fine di settembre il cerchio
sembra stringersi sempre di più intorno al Pds, per tangenti su Malpensa 2000 e
metropolitana milanese: tra smentite del procuratore di Milano Borrelli e timori
di avvisi di garanzia per Occhetto e D'Alema, la Quercia è nel panico. Il 5
ottobre Il Manifesto titola I giudici scagionano il Pds: l'incipit dell'articolo
- a firma Renata Fontanelli - è il seguente: «. La posizione di Marcello
Stefanini, segretario amministrativo della Quercia e parlamentare, verrà
stralciata e Primo Greganti (il «compagno G») verrà ritenuto un volgare
millantatore. Il gip Italo Ghitti (meglio noto tra gli avvocati come «il nano
malefico») impone alla Procura di Milano di indagare per altri quattro mesi poi
il 26 ottobre come titola il Manifesto a pagina 4 titola D'Ambrosio si ritira
dal pool per impedire speculazioni sui suoi rapporti «amicali» con il Pds. Quali
indicazioni si possono trarre da questa vicenda? Il pool dimostrò che la
magistratura sarebbe stata in grado di colpire tutti i partiti, Pds compreso; la
Quercia era ormai un partito senza ideologia e il suo elettorato si stava
fortemente assottigliando (era al 16%): c'era dunque la necessità di trovare un
pensiero politico di ricambio, che poteva venire solo dall'esterno; nessuna
forza politica avrebbe mai potuto modificare l'assetto istituzionale nonché
l'ordinamento giudiziario senza il consenso della magistratura; alla
magistratura fu fatto quindi comprendere che l'unico modo di conservare i propri
privilegi sarebbe stato quello di allearsi con un partito in cerca di ideologia.
Il Psi con Bettino Craxi, Claudio Martelli e Giuliano Amato avevano minacciato o
promesso un drastico ridimensionamento dei poteri e privilegi dell'ordine
giudiziario. Ma la reazione delle toghe fu tanto forte da indurre un Parlamento
letteralmente sotto assedio e atterrito a rinunciare ad uno dei cardini
fondamentali voluto dai costituenti a garanzia della divisione dei poteri:
l'immunità parlamentare. A questo punto il pallino passò al Pds, che non tardò a
giocarselo. Senza una vera riforma il Paese resterà ostaggio del potere
giudiziario. I giudici sono scesi in guerra per non rinunciare ai privilegi,
guidati dalla nuova "giustizia di classe" che Md è riuscita a imporre alle
toghe. È arrivato il momento di tirare le somme su quanto è accaduto tra
magistratura e politica negli ultimi venti anni. Magistratura democratica
avrebbe dovuto rappresentare una componente del «movimento di classe»
antagonista allo sviluppo capitalistico della società. L'ala filo-Pci della
corrente fu decisamente contraria a questa scelta così netta, e per molti anni
praticò una sorta di «entrismo» (né aderire né sabotare). La scelta di classe
operata dalla sinistra di Md presentava rischi pesantissimi di isolamento
all'interno della magistratura e tra le forze politiche egemoni nella sinistra,
che la lotta armata delle brigate rosse evidenziò immediatamente nel corso degli
anni '80 («né con lo Stato né con le Br? I brigatisti compagni che sbagliano?»).
Alla fine degli Anni di piombo, in pratica l'ala «rivoluzionaria» della
magistratura non esisteva già più, e quella filo-Pci ebbe campo libero. Il
crollo dell'Urss gettò il partito egemone della sinistra nello sconcerto: il Pci
non aveva più un'ideologia, né il cambiamento di sigla (Pds) poteva
rivitalizzarlo. Al contrario, l'ala di Md filo Pci/Pds aveva costruito una
immagine ed una ideologia di sé stessa - pagata anche col sangue di suoi
aderenti di spicco - che poteva essere spesa su qualunque piazza, ma le mancava
un alleato sotto la forma partito. L'interesse di entrambi era comunque troppo
forte perché l'alleanza sfumasse, anche se non mancarono resistenze e ricatti
reciproci: così, il Pci/Pds fu duramente minacciato (ed anche in piccola parte
colpito) durante la stagione di Mani Pulite. Alla fine, intorno al 1994,
l'alleanza andò in porto, e un partito senza ideologia accolse e fece propria
(probabilmente senza salti di gioia) un'ideologia senza partito. Due ostacoli,
tuttavia, si frapponevano tra questa alleanza e la conquista del potere: uno era
il cosiddetto Caf (Craxi, Andreotti, Forlani); l'altro era interno alla
magistratura, formato da tutti quei giudici che da sponde opposte si opponevano
a questa operazione. Il primo ostacolo fu eliminato attraverso Mani pulite, al
secondo si applicarono vari metodi; dal promoveatur ut amoveatur, ai
procedimenti disciplinari, alla elevazione al soglio parlamentare eccetera. Così
la magistratura più restia fu lusingata con l'obiettivo di mantenere i privilegi
e la fetta di potere (anche economico) cui era stata abituata, al punto di farle
accettare impunemente l'accordo che era sotto gli occhi di tutti. Il compito di
questa Md era pressochè esaurito, in quanto il nemico principale (il Caf ma
soprattutto Bettino Craxi) era stato abbattuto. Quando un nuovo nemico si
presentò all'orizzonte, i cani da guardia dell'accordo (ora la magistratura nel
suo complesso) non ci misero molto a tirar fuori zanne ed artigli, con
l'appoggio del loro referente politico. Fantasie, opinioni personali, dirà
qualcuno. Può darsi, ma certo occorre riflettere su tre punti cruciali
dell'inchiesta Mani pulite, che sono - come tanti altri elementi - caduti nel
dimenticatoio della Storia. Come abbiamo detto in precedenza, tra i membri del
pool non c'era assolutamente nessuna identità culturale o «politica», e non può
non destare perplessità la circostanza che essi furono messi insieme per
compiere un'operazione così complessa e delicata: fu davvero per garantire il
pluralismo e l'equidistanza fra i soggetti coinvolti o, come abbiamo sostenuto,
per raccogliere e compattare tutte le diverse anime della magistratura? Quando
esattamente fu costituito il pool? Al riguardo non abbiamo nessuna certezza, ma
di sicuro esso esisteva già il 17 febbraio 1992, data dell'arresto di Mario
Chiesa: chi, nei palazzi di giustizia milanesi e non solo, aveva la sfera di
cristallo? L'allora console statunitense a Milano Peter Semler dichiarò di aver
ricevuto da Antonio Di Pietro - nel novembre '91 - indiscrezioni sulle indagini
in corso, il quale gli avrebbe anticipato l'arresto di Mario Chiesa (avvenuto
nel febbraio '92) e l'attacco a Craxi e al Caf. In realtà, la magistratura
nell'arco di oltre vent'anni e fino ai giorni nostri ha difeso sé stessa e il
proprio status di supercasta: non già per motivi ideologico-politici bensì per
autotutela da un nemico che appariva pericolosissimo. La casta, in altri
termini, ha fatto e sempre farà quadrato a propria difesa, a prescindere
dall'essere «toghe rosse» o di qualunque altro colore. L'accanimento contro
Silvio Berlusconi riguarda - più che la sua persona - il ruolo da lui svolto ed
il pericolo che ha rappresentato e potrebbe ancora rappresentare per la
burocrazia giudiziaria e per gli eredi del Pci/Pds. Si può senz'altro convenire
che i giudici Nicoletta Gandus (processo Mills), Oscar Magi (processo Unipol,
per rivelazione di segreto istruttorio), Luigi de Ruggero (condanna in sede
civile al risarcimento del danno per il lodo Mondadori in favore di De
Benedetti) abbiano militato nella (ex) frazione di sinistra di Md, come pure il
procuratore Edmondo Bruti Liberati (noto come simpatizzante del Pci/Pds): si può
supporre che a quella corrente appartenga pure la presidente Alessandra Galli
(processo di appello Mediaset). Nel novero dei giudici di sinistra si potrebbe
anche ricomprendere la pm Boccassini: ma gli altri? Chi potrebbe attribuire in
quota Md il giudice Raimondo Mesiano (primo processo con risarcimento del danno
a favore di De Benedetti), il presidente Edoardo D'Avossa (I° grado del processo
Mediaset), la presidente Giulia Turri (processo Ruby), il pm Fabio De Pasquale,
il pm Antonio Sangermano, il presidente di cassazione Antonio Esposito e tutti
gli altri che si sono occupati e si stanno occupando del «delinquente»
Berlusconi? La verità è che la magistratura italiana da tempo è esplosa in una
miriade di monadi fuori da qualunque controllo gerarchico e territoriale,
essendo venuto meno (grazie anche al codice di procedura penale del 1989)
perfino l'ultimo baluardo che le impediva di tracimare; quello della competenza
territoriale, travolto dalla disposizione relativa alle cosiddette «indagini
collegate» (ogni pm può indagare su tutto in tutto il Paese, salvo poi alla fine
trasmettere gli atti alla Procura territorialmente competente). Ciascun pm è
padrone assoluto in casa propria, e nessuno - nemmeno un capo dell'ufficio men
che autorevole - può fermarlo. E la situazione non fa altro che peggiorare, come
è sotto gli occhi di tutti coloro che sono interessati a vedere. La magistratura
italiana - unica nel panorama dei Paesi occidentali democratici - è preda di un
numero indeterminato di «giovani» (e meno giovani, ma anche meno sprovveduti)
magistrati pronti a qualunque evenienza e autoreferenziali. Focalizzare
l'attenzione solo su Magistratura democratica significa non cogliere appieno i
pericoli che le istituzioni nazionali stanno correndo e correranno negli anni a
venire, con o senza la preda Berlusconi.
L'ala «ex» comunista del Pd - dal canto suo - non può più abbandonare
l'ideologia giustizialista, che ormai resta l'unica via che potrebbe portare
quella forma-partito al potere. Una democrazia occidentale matura non può fare a
meno di riflettere su questi temi, cercando una via di uscita dall'impasse
politico-istituzionale in cui questo Paese si è infilato per la propria
drammatica incoscienza, immaturità ed incapacità di governo: con buona pace di
una ormai inesistente classe politica.» Sergio D'Angelo Ex
giudice di Magistratura democratica.
A riguardo sentiamo il cronista che fa tremare i pm. "Sinistra ricattata dalle
procure". Dopo 35 anni a seguire i processi nelle aule dei tribunali Frank
Cimini è andato in pensione ma dal suo blog continua a svelare le verità scomode
di Milano: "Magistrati senza controllo", scrive Luca Fazzo su “Il Giornale”.
«Antonio Di Pietro è meno intelligente di me»: nel 1992, quando i cronisti di
tutta Italia scodinzolavano dietro il pm milanese, Frank Cimini fu l'unico
cronista giudiziario a uscire dal coro. Sono passati vent'anni, e Cimini sta per
andare in pensione. Confermi quel giudizio? «Confermo integralmente». Sul motivo
dell'ubriacatura collettiva dei mass media a favore del pm, Cimini ha idee
precise: «C'era un problema reale, la gente non ne poteva più dei politici che
rubavano, e la magistratura ha colto l'occasione per prendere il potere. Di
Pietro si è trovato lì, la sua corporazione lo ha usato. Mani pulite era un
fatto politico, lui era il classico arrampicatore sociale che voleva fare
carriera. Infatti appena potuto si è candidato: non in un partito qualunque, ma
nelle fila dell'unico partito miracolato dalle indagini». Uomo indubbiamente di
sinistra, e anche di ultrasinistra («ma faccio l'intervista al Giornale perché
sennò nessuno mi sta a sentire») Cimini (ex Manifesto, ex Mattino, ex Agcom, ex
Tmnews) resterà nel palazzo di giustizia milanese come redattore del suo blog,
giustiziami.it. E continuerà, dietro l'usbergo dell'enorme barba e
dell'indipendenza, a dire cose per cui chiunque altro verrebbe arrestato. Sulla
sudditanza degli editori verso il pool di Mani Pulite ha idee precise: «Gli
editori in Italia non sono editori puri ma imprenditori che hanno un'altra
attività, e come tali erano sotto scacco del pool: c'è stato un rapporto di do
ut des. Per questo i giornali di tutti gli imprenditori hanno appoggiato Mani
pulite in cambio di farla franca. Infatti poi l'unico su cui si è indagato in
modo approfondito, cioè Berlusconi, è stato indagato in quanto era sceso in
politica, sennò sarebbe stato miracolato anche lui. C'è stato un approfondimento
di indagine, uso un eufemismo, che non ha pari in alcun paese occidentale. Ma
lui dovrebbe fare mea culpa perché anche le sue tv hanno appoggiato la Procura».
Da allora, dice Cimini, nulla è cambiato: nessuno controlla i magistrati. «Il
problema è che la politica è ancora debole, così la magistratura fa quello che
vuole. Il centrosinistra mantiene lo status quo perché spera di usare i pm
contro i suoi avversari politici ma soprattutto perché gran parte del ceto
politico del centrosinistra è ricattato dalle procure. Basta vedere come escono
le cose, Vendola, la Lorenzetti, e come certe notizie spariscono
all'improvviso». Nello strapotere della magistratura quanto conta l'ideologia e
quanto la sete di potere? «L'ideologia non c'entra più niente, quella delle
toghe rosse è una cavolata che Berlusconi dice perché il suo elettorato così
capisce. Ma le toghe rosse non ci sono più, da quando è iniziata Mani pulite il
progetto politico che era di Borrelli e non certo di Di Pietro o del povero
Occhetto è stata la conquista del potere assoluto da parte della magistratura
che ha ottenuto lo stravolgimento dello Stato di diritto con la legge sui
pentiti. Un vulnus da cui la giustizia non si è più ripresa e che ha esteso i
suoi effetti dai processi di mafia a quelli politici. Oggi c'è in galera uno
come Guarischi che avrà le sue colpe, ma lo tengono dentro solo perché vogliono
che faccia il nome di Formigoni». Conoscitore profondo del palazzaccio milanese,
capace di battute irriferibili, Cimini riesce a farsi perdonare dai giudici
anche i suoi giudizi su Caselli («un professionista dell'emergenza») e
soprattutto la diagnosi impietosa di quanto avviene quotidianamente nelle aule:
«Hanno usato il codice come carta igienica, hanno fatto cose da pazzi e
continuano a farle». Chi passa le notizie ai giornali? «Nelle indagini
preliminari c'è uno strapotere della Procura che dà le notizie scientemente per
rafforzare politicamente l'accusa». E i cronisti si lasciano usare? «Se stessimo
a chiederci perché ci passano le notizie, i giornali uscirebbero in bianco».
"La politica ha delegato alla magistratura tre grandi questioni politiche, il
terrorismo, la mafia, la corruzione, e alcuni magistrati sono diventati di
conseguenza depositari di responsabilità tipicamente politiche". A dirlo è
Luciano Violante, ex presidente della Camera e esponente del Partito
democratico. Secondo il giurista, inoltre, "la legge Severino testimonia il
grado di debolezza" della politica perché non è "possibile che occorra una legge
per obbligare i partiti a non candidare chi ha compiuto certi reati". "È in
atto un processo di spoliticizzazione della democrazia che oscilla tra
tecnocrazia e demagogia", ha aggiunto, "Ne conseguono ondate moralistiche a
gettone tipiche di un Paese, l’Italia, che ha nello scontro interno permanente
la propria cifra caratterizzante". Colpa anche di Silvio Berlusconi, che
"ha reso ancora più conflittuale la politica italiana", ma anche della sinistra
che "lo ha scioccamente inseguito sul suo terreno accontentandosi della modesta
identità antiberlusconiana". "Ma neanche la Resistenza fu antimussoliniana, si
era antifascisti e tanto bastava", aggiunge. Quanto alle sue parole sulla legge
Severino e la decadenza del Cavaliere, Violante aggiunge: "Ho solo detto
che anche Berlusconi aveva diritto a difendersi. Quando ho potuto spiegarmi alle
assemblee di partito ho ricevuto applausi, ma oggi vale solo lo slogan, il
cabaret. Difficile andare oltre i 140 caratteri di Twitter". E sulle toghe
aggiunge: "Pentiti e intercettazioni hanno sostituito la capacità investigativa.
Con conseguenze enormi. Occorrerebbe indicare le priorità da perseguire a
livello penale, rivedendo l’obbligatorietà dell’azione che è un’ipocrisia
costituzionale resa necessaria dal fatto che i pubblici ministeri sono, e a mio
avviso devono restare, indipendenti dal governo".
LA SINISTRA
E LE TOGHE D’ASSALTO.
La sinistra e
le toghe d'assalto: la vera storia del patto di ferro. La ricostruzione
nel saggio di Cerasa: dalla nascita di Magistratura democratica a Mani pulite,
gli eredi del Pci hanno reclutato le Procure. Diventandone succubi, scrive Paolo
Bracalini su “Il Giornale”. «Ha cominciato a chiamarmi l'Anm. «Non sappiamo con
chi parlare al Pd. Per favore, abbiamo bisogno della Ferranti alla Giustizia». E
io ho risposto obbedisco ai magistrati, mica al Pd». La richiesta
dell'Associazione nazionale magistrati, rivelata (e poi smentita, come da
prassi) dal catto-dem Beppe Fioroni nei primi giorni del governo Letta, è stata
accontentata. Alla presidenza della commissione Giustizia della Camera siede
proprio lei, Donatella Ferranti, ex magistrato, e di una corrente non a caso, Md
(Magistratura democratica), le toghe di sinistra. L'interlocutore più gradito
all'Anm, a costo di un'invasione di campo plateale. Che però non sorprende
perché conferma un dato storico, l'alleanza tra sinistra e magistratura
italiana. Un «ammanettamento» che ha radici lontane, dalla nascita di Md - nel
clima del '68 - che nella sua assemblea nazionale si assegna il compito di
«costruire un rapporto costante e articolato con le forze politiche di
sinistra», alla «questione morale» come bandiera del Pci di Berlinguer (delegata
poi alle Procure), al pool di Mani pulite che opera già come un'unità politica.
Un processo ricostruito da Claudio Cerasa nel suo Le catene della sinistra,
facendo parlare i testimoni di questa mutazione genetica (doppia: dei giudici e
della sinistra). Racconta Sergio D'Angelo, ex magistrato schierato con Pci e poi
Ds, a lungo in Md da cui poi ha preso le distanze: «Dopo Tangentopoli la
politica ha iniziato a guardare al magistrato come ad una guida spirituale. E i
magistrati di sinistra, che esercitano un'egemonia culturale nel mondo delle
procure, hanno sposato la causa della rivoluzione politica». Una minoranza («un
settimo sui 9mila magistrati in servizio», dice D'Angelo) diventata maggioranza
culturale dentro la corporazione, al punto da dominarla e influenzarne anche le
sentenze. Ammette un altro magistrato, Francesco Misiani: «Non posso negare che
nelle mie decisioni da giudice non abbia influito, e molto, la mia ideologia».
Ma quando scatta l'ammanettamento tra sinistra e toghe? Cerasa lo domanda a due
magistrati di un'importante Procura, che per riservatezza non si svelano. Ma
rispondono e indicano due tappe. La prima, Tangentopoli: «Lì molti di noi si
sono convinti di avere una missione salvifica, di dover non solo combattere la
corruzione ma di redimere l'Italia. E la sinistra si illude di poter prendere il
potere con la magistratura». Il secondo, Berlusconi: «Assegnare alla
magistratura il compito di eliminare Berlusconi - racconta uno dei due pm - ha
dato alla magistratura un potere enorme che forse neanche la magistratura
intendeva ottenere. Ma di fatto, da quando Berlusconi è in campo, bisogna
riconoscere che la magistratura di sinistra è diventata un azionista importante,
per non dire prioritario, dell'universo del centrosinistra». La saldatura è
visibile dappertutto. Nelle carriere politiche di molti pm d'assalto, a
cominciare da quelli del famoso pool. Di Pietro ministro del governo Prodi,
Gerardo D'Ambrosio senatore del Pd, Borrelli supporter della segreteria
Veltroni. «Ma il mondo di centrosinistra è pieno di magistrati che una volta
poggiata la toga all'attaccapanni si sono buttati in politica» ricorda Cerasa. I
nomi più noti: Anna Finocchiaro, Luciano Violante, Michele Emiliano, Pietro
Grasso, ma pure i senatori Casson, Carofiglio e Maritati, la deputata Pd Lo Moro
e poi la Ferranti. Magistrato è anche un consigliere Rai indicato dal Pd,
Gherardo Colombo, anche lui ex pool. Proprio il Colombo che anni fa sulla
rivista Questione Giustizia teorizzò la missione politica della magistratura.
«Ritengo - scriveva l'ex pm - impraticabile una prospettiva di ritorno alla
terzietà (per la magistratura, ndr), che risulterebbe soltanto apparente». Il
giudice insomma, riassume Cerasa «ha il compito, quando necessario, di
sostituirsi all'opposizione parlamentare». Il magistrato diventa militante, e la
sinistra si consegna - manette ai polsi - alla sudditanza verso le Procure. Chi
ha analizzato a fondo questo fenomeno è Violante, che da ex magistrato ha
conosciuto entrambi i percorsi e il loro intreccio pericoloso. Il margine di
libertà che i pm più schierati politicamente hanno per orientare un'inchiesta è
enorme, dice Violante intervistato nel libro. I cardini sono due:
l'obbligatorietà dell'azione penale (che diventa «uno scudo per giustificare
indagini spericolate, fragili, ma efficaci sul piano politico») e poi «il
controllo di legalità», cioè la funzione di ricerca del reato, di controllo
della legalità, che spetta «alla polizia, allo Stato, alla politica». L'effetto
è la sinistra che si ammanetta da sola al giustizialismo, la politica che si
consegna alle Procure. Ai magistrati, aggiunge l'ex presidente della Camera, che
«non ne rispondono a nessuno».
Io quelli di Forza Italia li rispetto, scrive Filippo Facci su “Libero
Quotidiano”. Conoscendoli, singolarmente, li rispetto molto meno: ma
nell'insieme potrebbero anche sembrare appunto dei lealisti, dei coerenti, delle
schiene dritte, gente che ha finalmente trovato una linea del Piave intesa come
Berlusconi, come capo, come leader, come rappresentante di milioni di italiani
che non si può cancellare solo per via giudiziaria: almeno non così. Non con
sentenze infarcite di «convincimenti» e prove che non lo sono. Dunque rispetto
quelli di Forza Italia - anche se in buona parte restano dei cavalier-serventi -
perché tentano di fare quello che nella Prima Repubblica non fu fatto per
Bettino Craxi e per altri leader, consegnati mani e piedi alla magistratura
assieme al primato della politica. Solo che, dettaglio, Forza Italia ha perso:
ha perso quella di oggi e ha perso quella del 1994. E non ha perso ieri, o un
mese fa, cioè con Napolitano, la Consulta, la legge Severino, la Consulta, la
Cassazione: ha colpevolmente perso in vent'anni di fallimento politico sulla
giustizia. Dall’altra c’è qualcuno che ha vinto, anche se elencarne la
formazione ora è complicato: si rischia di passare dal pretenzioso racconto di
un’ormai stagliata «jurecrazia» - fatta di corti che regolano un ordine
giuridico globale - all'ultimo straccione di pm o cronista militante. Resta il
dato essenziale: vent’anni fa la giustizia faceva schifo e oggi fa identicamente
schifo, schiacciata com'è sul potere che la esercita; e fa identicamente schifo,
per colpe anche sue, la giustizia ad personam legiferata da Berlusconi, che in
vent'anni ha solo preso tempo - molto - e alla fine non s'è salvato. Elencare
tutte le forzature palesi o presunte per abbatterlo, magari distinguendole dalle
azioni penali più che legittime, è un lavoro da pazzi o da memorialistica
difensiva: solo la somma delle assoluzioni - mischiate ad amnistie e
prescrizioni - brucerebbe una pagina. Basti l'incipit, cioè il celebre mandato
di comparizione che fu appositamente spedito a Berlusconi il 21 novembre 1994
per essere appreso a un convegno Onu con 140 delegazioni governative e 650
giornalisti: diede la spallata decisiva a un governo a discapito di un
proscioglimento che giungerà molti anni dopo. L’elenco potrebbe proseguire sino
a oggi - intralciato anche da tutte le leggi ad personam che Berlusconi fece per
salvarsi - e infatti è solo oggi che Berlusconi cade, anzi decade. Ciò che è
cambiato, negli ultimi anni, è la determinazione di una parte della magistratura
- unita e univoca come la corrente di sinistra che ne occupa i posti chiave - a
discapito di apparenze che non ha neanche più cercato di salvare. I processi per
frode legati ai diritti televisivi non erano più semplici di altri, anzi, il
contrario: come già raccontato, Berlusconi per le stesse accuse era già stato
prosciolto a Roma e pure a Milano. Ciò che è cambiato, appunto, è la
determinazione dei collegi giudicanti a fronte di quadri probatori tuttavia
paragonabili ai precedenti: ma hanno cambiato marcia. Si poteva intuirlo dai
tempi atipici che si stavano progressivamente dando già al primo grado del
processo Mills, che filò per ben 47 udienze in meno di due anni e fece lavorare
i giudici sino al tardo pomeriggio e nei weekend; le motivazioni della sentenza
furono notificate entro 15 giorni (e non entro i consueti 90) così da permettere
che il ricorso in Cassazione fosse più che mai spedito. Ma è il processo
successivo, quello che ora ha fatto fuori Berlusconi, ad aver segnato un record:
tre gradi di giudizio in un solo anno (alla faccia della Corte Europea che ci
condanna per la lunghezza dei procedimenti) con dettagli anche emblematici, tipo
la solerte attivazione di una sezione feriale della Cassazione che è stata
descritta come se di norma esaminasse tutti i processi indifferibili del Paese:
semplicemente falso, la discrezionalità regna sovrana come su tutto il resto. Il
paradosso sta qui: nel formidabile e inaspettato rispetto di regole teoriche -
quelle che in dieci mesi giudicano un cittadino nei tre gradi - al punto da
trasformare Berlusconi in eccezione assoluta. Poi, a proposito di
discrezionalità, ci sono le sentenze: e qui si entra nel fantastico mondo
dell'insondabile o di un dibattito infinito: quello su che cosa sia
effettivamente una «prova» e che differenza ci sia rispetto a convincimenti e
mere somme di indizi. Il tutto sopraffatti dal dogma che le sentenze si
accettano e basta: anche se è dura, talvolta. Quando uscirono le 208 pagine
della condanna definitiva in Cassazione, in ogni caso, i primi commenti dei
vertici piddini furono di pochi minuti dopo: un caso di lettura analogica. E,
senza scomodare espressioni come «teorema» o «prova logica» o peggio «non poteva
non sapere», le motivazioni della sentenza per frode fiscale appalesavano una
gigantesca e motivata opinione: le «prove logiche» e i «non poteva non sapere»
purtroppo abbondavano e abbondano. «È da ritenersi provato» era la frase più
ricorrente, mentre tesi contrarie denotavano una «assoluta inverosimiglianza».
Su tutto imperava l’attribuzione di una responsabilità oggettiva: «La qualità di
Berlusconi di azionista di maggioranza gli consentiva pacificamente qualsiasi
possibilità di intervento», «era assolutamente ovvio che la gestione dei diritti
fosse di interesse della proprietà», «la consapevolezza poteva essere
ascrivibile solo a chi aveva uno sguardo d’insieme, complessivo, sul complesso
sistema». Il capolavoro resta quello a pagina 184 della sentenza, che riguardava
la riduzione delle liste testimoniali chieste dalla difesa: «Va detto per
inciso», è messo nero su bianco, «che effettivamente il pm non ha fornito alcuna
prova diretta circa eventuali interventi dell’imputato Berlusconi in merito alle
modalità di appostare gli ammortamenti dei bilanci. Ne conseguiva l'assoluta
inutilità di una prova negativa di fatti che la pubblica accusa non aveva
provato in modo diretto». In lingua italiana: l’accusa non ha neppure cercato di
provare che Berlusconi fosse direttamente responsabile, dunque era inutile
ammettere testimoni che provassero il contrario, cioè una sua estraneità. Ma le
sentenze si devono accettare e basta. Quando Berlusconi azzardò un
videomessaggio di reazione, in settembre, Guglielmo Epifani lo definì
«sconcertante», mentre Antonio Di Pietro fece un esposto per vilipendio alla
magistratura e Rosy Bindi parlò di «eversione». Il resto - la galoppata per far
decadere Berlusconi in Senato - è cronaca recente, anzi, di ieri, Il precedente
di Cesare Previti - che al termine del processo Imi-Sir fu dichiarato
«interdetto a vita dai pubblici uffici» - è pure noto: la Camera ne votò la
decadenza ben 14 mesi dopo la sentenza della Cassazione. Allora come oggi, il
centrosinistra era dell’opinione che si dovesse semplicemente prendere atto del
dettato della magistratura, mentre il centrodestra pretendeva invece che si
entrasse nel merito e non ci si limitasse a un ruolo notarile. Poi c’è il
mancato ricorso alla Corte Costituzionale per stabilire se gli effetti della
Legge Severino possano essere retroattivi: la Consulta è stata investita di
infinite incombenza da una ventina d’anni a questa parte - comprese le leggi
elettorali e i vari «lodi» regolarmente bocciati – ma per la Legge Severino il
Partito democratico ha ritenuto che la Corte non dovesse dire la sua. Il 30
ottobre scorso, infine, la Giunta per il regolamento del Senato ha stabilito che
per casi di «non convalida dell’elezione» il voto dovesse essere palese, volontà
ripetuta ieri dal presidente del Senato: nessun voto segreto o di coscienza,
dunque. Poi - ma è un altro articolo, anzi, vent'anni di articoli - ci sono le
mazzate che il centrodestra si è tirato da solo. La Legge Severino, come detto.
Il condono tombale offerto a Berlusconi dal «suo» ministro Tremonti nel 2002 -
che l'avrebbe messo in regola con qualsivoglia frode fiscale – ma che al
Cavaliere non interessò. Il demagogico inasprimento delle pene per la
prostituzione minorile promosso dal «suo» ministro Carfagna nel 2008. Però,
dicevamo, non ci sono solo gli autogol: c’è il semplice non-fatto o non-riuscito
degli ultimi vent’anni. Perché nei fatti c’era, e c’è, la stessa magistratura.
Non c’è la separazione delle carriere, lo sdoppiamento del Csm, le modifiche
dell’obbligatorietà dell’azione penale, l’inappellabilità delle sentenze di
assoluzione, la responsabilità civile dei giudici, i limiti alle
intercettazioni. Ci sono state, invece, le leggi sulle rogatorie, la Cirami, i
vari lodi Maccanico-Schifani-Alfano, l’illegittimo impedimento: pannicelli caldi
inutili o, per un po’, utili praticamente solo a lui. Per un po’. Solo per un
po’. Fino al 27 novembre 2013.
CARMINE SCHIAVONE. MAGISTRATI: ROMA NOSTRA!
"Ondata di ricorsi dopo il
«trionfo». Un giudice: annullare tutto. Concorsi per giudici, Napoli capitale
dei promossi. L'area coperta dalla Corte d'appello ha «prodotto» un terzo degli
aspiranti magistrati. E un terzo degli esaminatori".
O la statistica è birichina assai o c'è qualcosa che non quadra nell'attuale
concorso di accesso alla magistratura. Quasi un terzo degli aspiranti giudici
ammessi agli orali vengono infatti dall'area della Corte d'Appello di Napoli,
che rappresenta solo un trentacinquesimo del territorio e un dodicesimo della
popolazione italiana. Un trionfo. Accompagnato però da una curiosa coincidenza:
erano della stessa area, più Salerno, 7 su 24 dei membri togati della
commissione e 5 su 8 dei docenti universitari. Cioè oltre un terzo degli
esaminatori.
DELINQUENTE A CHI?
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia,
è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Parla l’ex capo dei Casalesi. La
camorra e la mafia non finirà mai, finchè ci saranno politici, magistrati e
forze dell’ordine mafiosi.
Riguardo la magistratura, l’avvocato astigiano Pierpaolo Berardi, classe 1964,
per anni ha battagliato per far annullare il concorso per magistrati svolto nel
maggio 1992. Secondo Berardi, infatti, in base ai verbali dei commissari, più di
metà dei compiti vennero corretti in 3 minuti di media (comprendendo “apertura
della busta, verbalizzazione e richiesta chiarimenti”) e quindi non “furono mai
esaminati”. I giudici del tar gli hanno dato ragione nel 1996 e nel 2000 e il
Csm, nel 2008, è stato costretto ad ammettere: “Ci fu una vera e propria
mancanza di valutazione da parte della commissione”. Giudizio che vale anche per
gli altri esaminati. In quell’esame divenne uditore giudiziario, tra gli altri,
proprio Luigi de Magistris, giovane Pubblico Ministero che si occupò inutilmente
del concorso farsa di abilitazione forense a Catanzaro: tutti i compiti
identici e tutti abilitati.
Francesco Caringella: "Troppi pm si sentono divi", scrive Giacomo Amadori su
“Libero Quotidiano”. Oggi nelle librerie di tutta Italia esce un nuovo romanzo.
«Dove è la notizia?» vi chiederete. Eccola: questo intrigante legal thriller
intitolato Non sono un assassino (Newton Compton Editori) è scritto da un
giudice che con gli occhi disincantati del tecnico del diritto analizza il
processo penale e redige una sentenza definitiva: tale rito in Italia è
fallito. Non solo per colpa dei magistrati. L'autore si chiama Francesco
Caringella, ha 49 anni, è barese ed è un membro del Consiglio di Stato. Ha vinto
ogni genere di concorso (da commissario di polizia, da magistrato, da
consigliere di Stato) e ha scritto manuali per insegnare ai ragazzi a emularlo.
Intervistare Caringella consente di rileggere alcune pagine della nostra storia
recente. A 26 anni è diventato giudice della settima sezione penale di Milano
negli stessi giorni in cui esplodeva Mani pulite. Lui si insediava e il
«mariuolo» Mario Chiesa veniva arrestato. Caringella a 29 anni fu il giudice
estensore del mandato di cattura nei confronti di Bettino Craxi. Ed ecco la
prima sorpresa.
«Dopo vent’anni mi chiedo se quella decisione sia stata giusta. E ho qualche
rimorso. Non intendo dire che Craxi fosse innocente. La Cassazione ha confermato
la sentenza di condanna. Ma mi chiedo se non ci potesse essere più umanità nei
confronti di un uomo sconfitto. Se il legislatore e il potere giudiziario non
potessero trovare una soluzione per consentirgli di curarsi in Italia e di
affrontare il processo da uomo libero. O quanto meno da uomo sano. Averlo
costretto a rimare in Tunisia gli ha probabilmente accorciato la vita».
Beh, sembra l'epitaffio di Mani Pulite.
«No. L’inchiesta era sacrosanta, ma ci sono state alcune forzature. Forse i
magistrati non potevano prevedere il consenso popolare che accompagnò il loro
lavoro e alcuni sono stati ubriacati da quell’improvviso successo».
Ritiene che l'indagine avesse fini politici? Tre dei pm di Mani
pulite sono poi diventati parlamentari o ministri, due con la sinistra e una con
Forza Italia.
«Non penso. Credo che la lettura giusta sia quella psicologica. Alcuni pm si
sono trovati nei panni dei divi e hanno dovuto fare i conti con la loro vanità e
le loro ambizioni personali».
Lei ha conosciuto tutti i pm di Mani pulite. Da chi non avrebbe
voluto essere inquisito?
«Da Antonio Di Pietro. Ho letto i suoi interrogatori e ho capito che con quel
suo fare poliziesco avrebbe fatto confessare pure un innocente, persino un
santo. Ma era anche simpatico. Mi ricordo che una volta si rivolse alla corte
con un saluto militare, battendo i tacchi».
Nel suo libro mi ha colpito la citazione dal libro di Dante
Troisi, Diario di un giudice. Leggo: "Sono la sentinella e l'aula di
udienza è la torretta da cui prendo la mira per colpire chi mi capita a tiro.
Proverò così il piacere nel falciare le vite delle persone senza trascurare di
lasciare indenne qualcuno per goderne la meraviglia".
Ha incontrato colleghi del genere?
«Per fortuna pochissimi. Forse uno solo. Era pugliese ed entrava in aula con il
cipiglio di chi dovesse stanare gli ultimi giapponesi nell’arcipelago delle
Okinawa. Per lui l’imputato era un nemico da sconfiggere».
Il potere che ha in mano un giudice non rischia di dare alla
testa?
«Sicuramente. E per capire se i miei colleghi siano stabili psicologicamente ci
sono i mesi di uditorato. Ma rarissimamente viene chiesta la decadenza di un neo
magistrato. Con conseguente pregiudizio per la credibilità del sistema».
Ci sono toghe in cura psichiatrica che continuano a esercitare la
propria funzione.
«Sarebbero necessari controlli periodici non solo sulla professionalità, ma
anche sull’equilibrio dei magistrati».
Non svelerò il finale, ma di certo il suo giallo non fa una buona
pubblicità al processo penale.
«Purtroppo la riforma del 1989 in Italia è fallita. Si pensava che grazie ai
riti alternativi pochi processi sarebbero arrivati a dibattimento, snellendo i
tempi della giustizia. È successo il contrario. Quasi tutti gli imputati
scelgono di andare in aula e così invece di avere processi brevi con testimoni
caldi, che ricordano bene i fatti su cui vengono interrogati, abbiamo processi
lunghi con testimoni freddi».
Lei scrive che il "giudice conosce fatti impalliditi dal tempo
nei pochi giorni d’udienza a disposizione".
«In Italia, per un eccesso di garantismo, abbiamo un secondo grado che è la
replica del primo. A cosa serve? Allunga i tempi e ribaltando le sentenze crea
sconcerto nei cittadini. Siamo l’unico paese con tre gradi di giudizio e due
diversi collegi che fanno lo stesso lavoro non avvicinano alla verità, ma
allontanano. Dopo la condanna in appello per Amanda Knox e Raffaele Sollecito,
mi ha telefonato persino mia madre per chiedermene conto».
Che cosa pensa dei processi mediatici?
«Il peggio possibile. Non immagina quanto possano condizionare un magistrato che
si trova a decidere su un fatto già giudicato mille volte in tv da colleghi
togati, giornalisti, esperti vari. L’animo umano ha la tendenza a uniformarsi e
una sentenza già scritta dai media è dannosissima».
Torniamo alla questione del giudizio d'appello. Quando una
decisione viene ribaltata si ha la sensazione che la verità giudiziaria non
esista…
«Purtroppo è così. Nel libro scrivo che tale verità è solo una bugia raccontata
meglio. Forse sarebbe meglio dire che è la verità più verosimile. Duque da Rivas
diceva che “in questo mondo traditore non c'è verità né menzogna. Tutto dipende
dal colore del vetro attraverso cui si guarda”».
Dunque ammette l'esistenza di una magistratura politicizzata.
«Il colore del vetro per me dipende anche da bugie, pregiudizi ed errori, non
solo dalle ideologie. Mi domando sono giuste le sentenze, per parlare solo delle
ultime, che hanno assassinato politicamente Silvio Berlusconi e Luigi De
Magistris? Rispondo che non esiste la sentenza giusta o sbagliata in senso
assoluto. Ogni giudizio è opinabile. Resta solo la speranza che sia corretto».
Nel romanzo sostiene che un processo è una specie di partita di
poker in cui tutti gli attori mentono e il giudice deve saper cogliere la verità
in mezzo a tanti bluff.
«È vero. Non fanno eccezione l’imputato innocente e il testimone sincero che
mentono, per dirla con il libro, “perché desiderano essere creduti e pensano che
la menzogna sia più seducente della verità”. La verità per essere verosimile
deve essere mescolata a un po’ di menzogna».
Un giudice, in mezzo a tutti questi inganni, come si districa?
«Quando ha un dubbio non aspetta altro che essere sedotto da una bella bugia, da
quella di un pm avvenente o di un avvocato particolarmente eloquente. Anche per
noi è difficile resistere a un'oratoria convincente o a una bellezza
sconvolgente».
Sta dicendo che in un processo conta anche l'aspetto esteriore?
«Certo. Pure i giudici sono uomini e per di più fallibili. Io nel romanzo
descrivo una pm seducente e il suo profumo di sandalo».
Il personaggio è ispirato a un magistrato esistente?
«Mi ricordava una collega di Milano, ma non posso dirle altro (sorride, ndr) se
non che chiedeva sempre la condanna degli imputati…»
Il lettore sarà sconcertato da questa alea nel giudizio…
«Ma io sto parlando di quei pochi processi da fascia grigia, in cui le prove non
sono schiaccianti».
In questi casi come ha giudicato?
«Nel 50% ho assolto e nell’altro 50 ho condannato».
Lei scrive anche che per un innocente è meglio essere giudicati
da una donna e per un colpevole da un uomo. Perché?
«Le signore in toga quando esprimo questa mia teoria si offendono. In realtà è
un complimento. Le colleghe mediamente sono più preparate e puntigliose e per
questo è più difficile che sbaglino. Ma quando ritengono di aver le prove della
colpevolezza non fanno sconti».
La sua tesi che le donne difficilmente puniscono un innocente
sembrerebbe contraddetta dal processo Ruby…
«Ha ragione: in questo caso Berlusconi è stato condannato da tre donne e poi
assolto in secondo grado. Ma questa potrebbe essere l’eccezione che conferma la
regola».
Ha mai dovuto giudicare Berlusconi?
«Una volta, anche se ho lasciato la corte prima della fine del processo. Mi
ricordo che venne in aula e la sua presenza fu molto teatrale. Passò l’intera
udienza a sfogliare il codice penale».
Lei è il terzo magistrato pugliese che si cimenta nel noir, dopo
Gianrico Carofiglio e Giancarlo De Cataldo. Tra voi chi è il più bravo come
scrittore?
«Se devo scegliere uno solo, voto per me».
E come magistrato?
«Uguale, ma di questo sono più sicuro».
Magistratura, la casta e le degenerazioni,
scrive Andrea Signini su “Rinascita”. “IMAGISTRATI SONO INCAPACI E CORROTTI, NE
CONOSCO MOLTISSIMI”. Il Presidente Francesco Cossiga (Sassari, 26 Luglio 1928 –
Roma, 17 Agosto 2010), appartenente ad una famiglia di altissimi magistrati e
lui stesso capo del Consiglio Superiore della Magistratura, intervistato dal
giornalista Vittorio Pezzuto, disse: “La maggior parte dei magistrati attuali
sono totalmente ignoranti a cominciare dall’amico Di Pietro che un giorno mi
disse testualmente: “Cosa vuoi, appena mi sarò sbrigato questi processi, mi
leggerò il nuovo codice di procedura penale”. Nel corso della medesima
intervista Cossiga sottolineava le scadenti qualità dei membri della
magistratura, li definiva “incapaci a fare le indagini”. Da Presidente della
Repubblica inviò i carabinieri a Palazzo dei Marescialli. Accadde nel 91, il 14
novembre, quando il presidente-picconatore ritirò la convocazione di una
riunione del plenum nella quale erano state inserite cinque pratiche sui
rapporti tra capi degli uffici e loro sostituti sull’assegnazione degli
incarichi. Cossiga riteneva che la questione non fosse di competenza del plenum
e avvertì che se la riunione avesse avuto luogo avrebbe preso «misure esecutive
per prevenire la consumazione di gravi illegalità». I consiglieri del Csm si
opposero con un documento e si riunirono. In piazza Indipendenza, alla sede del
Csm, affluirono i blindati dei carabinieri e due colonnelli dell’Arma vennero
inviati a seguire la seduta. Ma il caso fu risolto subito, perché il
vicepresidente, Giovanni Galloni, non permise la discussione. Invitato a dare
una spiegazione sull’incredibile ed ingiustificato avanzamento di carriera
toccato ai due magistrati (Lucio di Pietro e Felice di Persia) noti per aver
condannato ed arrestato Enzo Tortora e centinaia di persone innocenti
nell’ambito dello stesso processo (tutti rilasciati dopo mesi di carcere per
imperdonabili errori macroscopici), Cossiga rispose: “Come mi è stato spiegato,
la magistratura deve difendere i suoi, soprattutto se colpevoli”. La sicurezza
di quanto affermava il Presidente Cossiga gli proveniva da una confessione
fattagli da un membro interno di cui non rivelò mai il nome ma risulta evidente
che si tratti di un personaggio di calibro elevatissimo, “Un giovane membro del
Consiglio Superiore della Magistratura, appartenente alla corrente di
magistratura democratica, figlio di un amico mio, il quale mi è ha detto: “Noi
dobbiamo difendere soprattutto quei magistrati che fanno errori e sono colpevoli
perché sennò questa diga che noi magistrati abbiamo eretto per renderci
irresponsabili ed incriticabili crolla”! invitato a dare delle spiegazioni sul
come mai il nostro sistema (comunemente riconosciuto come il migliore al Mondo)
fosse così profondamente percorso da fatali fratture, Cossiga tuonò: “La colpa
di tutto questo è della DC! Lì c’è stato chi, per ingraziarsi la magistratura,
ha varato la famosa “Breganzola” che prevede l’avanzamento di qualifica dei
magistrati senza demerito. Ci pronunciammo contro quella Legge in quattro: uno
era l’Avvocato Riccio, il deputato che poi fu sequestrato ed ucciso in Sardegna;
Giuseppe Gargani, io ed un altro. Fummo convocati alla DC e ci fu detto che
saremmo stati sospesi dal gruppo perché bisognava fare tutto quello che dicevano
di fare i magistrati altrimenti avrebbero messo tutti in galera”. Questo breve
preambolo ci deve servire come metro per misurare, con occhio nuovo, quanto più
da vicino possibile, l’attuale situazione italiana. Dal 1992 (mani pulite), ad
oggi, di acqua sotto ai ponti ne è passata assai. E tutta questa acqua, per
rimanere nel solco dell’allegoria, ha finito con l’erodere i margini di garanzia
della classe politica (vedi perdita delle immunità dei membri del Parlamento –
1993) espandendo quelli dei membri della magistratura. Membri i quali, poco alla
volta, hanno preferito fare il “salto della scimmia” passando da un ramo
all’altro (dal ramo giudiziario a quello legislativo e/o esecutivo) e ce li
siamo ritrovati in politica come missili (di Pietro, de Magistris, Grasso,
Ingroia, Finocchiaro…). Pertanto, quella che da decenni a questa parte viene
rivenduta al popolo italiano come una “stagione di battaglia contro la
corruzione politica”, in realtà nascondeva e tutt’ora nasconde ben altro. Il
potere legislativo (facente capo al Parlamento), quanto il potere esecutivo
(facente capo al governo), si sono ritrovati in uno stato di progressiva
sofferenza indotta dalla crescente ed inarrestabile affermazione del potere
giudiziario (facente capo alla magistratura). Che le cose stiano così, è fuor di
dubbio! E “La cosa brutta è che i giornalisti si prestino alle manovre politiche
dei magistrati” [Cossiga Ibid.]. Ecco spiegato come mai ci si ostini a ritenere
“mani pulite” una battaglia alla corruzione e non già una battaglia tra i tre
poteri dello Stato. Ma, scusate tanto, e il POPOLO?!? No, dico, siamo o non
siamo noi italiani ed italiane – e non altri popoli diversi dal nostro – a
pagare sulla nostra pelle lo scotto generato dalle conseguenze di queste
“scalate al potere”? Non siamo forse noi quelli/e che stanno finendo dritti in
bocca alla rovina totale, alla disperazione ed al suicidio di massa? COSA CI
STANNO FACENDO DI MALE E’ PRESTO DETTO. Innanzi tutto, il riflesso peggiore che
ci tocca subìre è dato dal fatto che, dal precedente (prima di “mani pulite”)
clima culturale in cui eravamo usi vivere sentendoci protetti dalla magistratura
(vedi garanzia di presunzione d’ innocenza), ci siamo ritrovati catapultati in
un clima orrido in cui è “la presunzione di colpevolezza” a dettare il ritmo. E,
di conseguenza, tutto il discorso è andato a gambe all’aria e le nostre libertà,
nonché le nostre sovranità sono andate in fumo. E poi, chi di voi può affermare
di non aver mai sentito ripetere sino alla nausea frasi del tipo “Lo deve
stabilire la magistratura”, oppure “Lo ha stabilito una sentenza” od anche “Lo
ha detto in giudice”; e allora? Forse queste persone (che restano sempre
impiegati statali al servizio dello Stato e di chi vi abita) discendono dallo
Spirito Santo? Sono o non sono esseri umani? E se lo sono allora posso
commettere degli sbagli, sì o no? E se sbaglia un magistrato le conseguenze sono
letali, sì o no? E allora per quale ragione da 22 anni a questa parte si sta
facendo di tutto per collocarli nell’olimpo della saggezza? Perché è possibile
sputtanare un esponente del ramo legislativo o di quello esecutivo e GUAI se si
fa altrettanto con uno del ramo giudiziario? L’ex magistrato ed ex politico
Antonio Di Pietro (definito da Cossiga “Il famoso cretino… che ha nascosto cento
milioni in una scatola delle scarpe” e “Ladro” che si è laureato “Probabilmente
con tutti 18 e si è preso pure l’esaurimento nervoso per prepararsi la Laurea”
quando era a capo dell’IDV ci ha assillato per anni, farcendo all’inverosimile i
suoi discorsi con frasi come quelle succitate. E come lui, ma dall’altro lato
della barricata, Silvio Berlusconi ha infarcito i suoi discorsi contro la
magistratura corrotta e bla bla bla. Ci hanno fatto un vero e proprio lavaggio
del cervello, arrivando a dividere la popolazione in due: una parte garantista
ed una giustizialista. Il vecchio e amatissimo strumento del “dividi et impera”
inventato dai nostri avi latini per esercitare il potere sulla massa ignorante.
Ma se due terzi della medesima torta sono marci e putrescenti (il potere
legislativo e quello esecutivo), possibile che il rimanente terzo (potere
giudiziario) sia l’unico commestibile? Certo che non lo è, è ovvio! La
corruzione, in magistratura è a livelli raccapriccianti, “E’ prassi dividere il
compenso con il magistrato. Tre su quattro sono corrotti” confessa Chiara
Schettini (nomen omen) impiegata statale con la qualifica di giudice presso il
Tribunale dei Fallimenti di Roma, anzi ex, visto che le hanno messo le manette
ai polsi e poi sbattuta in galera con gravissime accuse di corruzione e
peculato. Ricostruiamo quello che la stampa di regime non osa nemmeno sfiorare.
“SONO PIU’ MAFIOSA DEI MAFIOSI” DICE SPAVALDAMENTE IL GIUDICE DI ROMA. La gente
normale, quella che lavora per guadagnare e consegnare il bottino allo Stato
vampiro, lo sa molto bene: se si può, meglio non fare causa! Si perde tempo, si
perdono soldi e non si sa se ti andrà bene. E, stando a quanto sta emergendo da
una prodigiosa inchiesta di cui prima o poi anche la stampa di regime sarà
costretta a parlare, l’impressione poggia su basi solidissime. E sarebbe bene
prendere le distanze da certa gente… più pericolosa dei delinquenti veri. In una
elaborazione di un articolo de Il Fatto Quotidiano del 31 Dicembre 2013 apparsa
l’1 Gennaio 2014 sul sito malagiustiziainitalia.it, si parla di “Perizie
affidate a consulenti dall’ampio potere discrezionale e dai compensi
stratosferici, mazzette spartite anche con i giudici. Un crocevia affaristico in
cui è coinvolto il vertice dell’ufficio [quello di Roma]”, in riferimento alla
vicenda che ha visto coinvolta Chiara Schettini di cui abbiamo appena accennato.
La stessa Schettini, chiama in causa (è il caso di dire) anche la magistratura
umbra, passivamente prona ai desiderata di quella romana: insabbiare gli
esposti, far finta di nulla ed attendere che trascorrano i tempi era l’ordine da
eseguire. Sotto interrogatorio, la Schettini ha confessato al giudice (onesto e
che ringraziamo a nome di tutti i lettori e le lettrici di signoraggio.it): “Si
entrava in camera di consiglio e si diceva questo si fa fallire e questo no”.
Chi si esprime così non è un temibile boss della mala ma è sempre lei, il
veramente temibile giudice Schettini, lei sì appartenente al ramo pulito del
potere, proprio quello!!! Nella sua crassa arroganza venata di ottusa
prosaicità, ella ricorreva sovente ad uscite agghiaccianti, sfornando un gergo
truce da gangster matricolato. Intercettata telefonicamente mentre parlava col
curatore fallimentare Federico Di Lauro (anche lui in galera) minacciava di
farla pagare al suo ex compagno: “Guarda, gli ho detto, sono più mafiosa dei
mafiosi, ci metto niente a telefonare ai calabresi che prendono il treno, te
danno una corcata de botte e se ne vanno” (da Il Fatto, 8 Luglio 2013, R. Di
Giovacchino). Non finisce qui. Sempre questo giudice donna, in un’altra
intercettazione che ha lasciato di stucco gli inquirenti che l’hanno più e più
volte riascoltato il nastro, parlando con un ignoto interlocutore, minacciava il
“povero” Di Lauro in questi termini: “Io a Di Lauro l’avrei investito con la
macchina… Lui lavorava con la banda della Magliana”. Ciliegina sulla torta:
parlando al telefono con un perito del Tribunale, riferendosi all’insistenza di
un Avvocato che non aveva intenzione di piegarsi supinamente al comportamento
della Schettini, commentava: “Il suo amico Massimo [l’Avvocato insistente Ndr.]
ha chiesto la riapertura di due procedimenti. Una rottura senza limiti. Gli dica
di non insistere perché non domani, né dopo domani ma fra 10 anni io lo
ammazzo”. Alla faccia della magistratura a cui tocca attenersi! Alla faccia
delle parole del magistrato “che c’azzecckkhhA” Di Pietro colui il quale, dopo
il salto della scimmia ci ha assillato ripetendo come un disco scassato che
dobbiamo “affidarci alla magistratura”! come no! Si accomodi lei Di Pietro,
prima di noi (senza balbettare come le accadde quando se la vide bruttina a
Milano). Nell’articolo della Di Giovacchino leggiamo inoltre: “L’amico Massimo
è in realtà l’avvocato Vita. Mai ricevuto minacce? “Non da Grisolia, però mi
hanno telefonato persone con accento calabrese, consigli…”. Messaggi? “Mi
dicevano lasci perdere la vecchietta…” La “vecchietta” è Diana Ottini, un tipo
tosto, La giudice le consegnò 500 mila euro stipulando una promessa di vendita
posticipata di 10 anni, affinché acquistasse la sua casa dal Comune. Ma venuto
il momento lei la casa se l’è tenuta e il Tribunale le ha dato ragione. Non è
andata altrettanto bene a Francesca Chiumento, altra cliente dell’avvocato Vita,
che da anni si batte per riconquistare il “suo” attico in via Germanico: 170
metri quadri, terrazza su tre livelli, che il padre aveva acquistato dagli eredi
di Aldo Fabrizi. La casa finì all’asta, nei salotti romani si parla ancora della
polizia arrivata con le camionette. Anche quell’asta porta la firma della
Schettini: la famiglia Chiumento era pronta a pagare, a spuntarla fu un medico
del Bambin Gesù che offrì 50 mila euro di meno. L’appartamento di via Germanico
alla fine fu rivenduto per 1 milione e 800 mila euro a una coppia importante.
Lei figlia di un costruttore, che ha tirato su villaggi turistici tra Terracina
e Sperlonga, lui avvocato della banca che aveva offerto il mutuo ai legittimi
proprietari” [Il Fatto Ibid.]. E pensare che questa sguaiata stipendiata statale
ha campato una vita sulle spalle di noi contribuenti ed ha potuto nascondere le
sue malefatte per anni dietro la protezione del ruolo affidatole dallo Stato e
di persone della sua medesima risma. Tutti suoi colleghi e colleghe.
Allucinante. Semplicemente allucinante. Solamente dopo essersi impaurita a causa
dei giorni trascorsi in prigione, ha confessato che il suo ex compagno
“Trafficava anche con il direttore di una filiale di Unicredit su 900 mila euro
gliene dava 200 mila” come stecca [malagiustizia. Ibid.]. L’organizzazione
funzionava a gonfie vele, il timore di essere scoperti non li sfiorava nemmeno:
‘Non ti preoccupare [la rincuorava il compagno, quello della stecca
all’Unicredit] sarà rimesso tutto perfettamente”. Suscita la ripugnanza leggere
la storia di questa squallida persona la quale, nel frattempo, con lo stipendio
da funzionario statale è riuscita ad accumulare un patrimonio di quasi 5 milioni
di euro (quasi 10 miliardi di Lire) oltre ad attici a Parigi e Miami, ville a
Fregene, un rifugio a Madonna di Campiglio… A proposito: il figlio della
carcerata si è rivelato meno sveglio della mamma ma comunque fatto della
medesima pasta! Infatti, mentre alla madre venivano serrati i polsi con le
manette, lui riceveva l’sms in cui la madre stessa gli ordinava di fare “quello
che sa” (Il Fatto, ibid.). Si avete proprio capito bene. Il figlio diciottenne,
evidentemente al corrente delle attività della madre (e del padre) ed istruito a
dovere su come agire in caso di necessità, si è prontamente attivato rendendosi
complice della vicenda facendo sparire la valigetta col contante, frutto di una
delle corruzioni cui la madre era avvezza. Solo che le sue limitate capacità
hanno consentito, a chi ha effettuato la perquisizione, di ritrovare tutto
all’istante. Ed il Consiglio Superiore della Magistratura dormiva in questi
anni? Certo che no! Provvedeva, come fa spessissimo, a trasferirla presso la
procura di l’Aquila per ragioni di incompatibilità ambientale. Non sarebbe male
saperne di più su questa scelta curiosa. Che questa sia una vicenda riguardante
un pugno di magistrati e non tutti i componenti della magistratura è
lapalissiano, scontato ed evidente. E CI MANCHEREBBE ALTRO! Ma sappiate che il
punto della questione non è arrivare a pronunciare frasi vuote quanto idiote del
genere “Sono tutti uguali. Tra cani non si mordono…” qui c’è solo da fare una
cosa: il POPOLO deve riconoscere il proprio ruolo di SOVRANO! E poi, non resta
che risalire alla fonte del problema e, per farlo, NOI uomini e donne della
cosiddetta “società civile” abbiamo il dovere di emanciparci. Se c’intendessimo
(mi ci metto dentro anch’io – sebbene non sia un tifoso) di finanza e Stato come
di calcio e cucina, con l’aiuto dei nostri veri angeli custodi seri (ed in
magistratura ce ne sono eccome), il nostro futuro sarebbe radioso. Ripartire da
un punto fermo è cogente. Tale punto risiede nella battaglia “persa contro la
magistratura che è stata perduta quando abbiamo abrogato l’immunità
parlamentare, che esistono in tutto il Mondo, ovvero quando Mastella, da me
avvertito, si è abbassato il pantalone ed ha scritto sotto dittatura di
quell’associazione sovversiva e di stampo che è l’Associazione Nazionale
Magistrati” – F. Cossiga, Di Pietro… Ibid.
Non
dimentichiamoci che di magistrati parliamo e delle loro ambizioni.
DA MANI
PULITE A TOGHE PULITE.
Denunce e
faide: i magistrati peggio dei politici, scrive Alessandro Da Rold su
“L’Inkiesta”. Da Mani Pulite a Toghe Pulite. A distanza di vent’anni da
Tangentopoli, quando notorietà e consensi erano agli apici, la magistratura
italiana vive uno dei momenti più difficili della sua storia, spaccata tra le
correnti, mal digerita agli occhi dell’opinione pubblica per la lungaggine dei
processi e per i costi, in una guerra senza esclusione di colpi tra articoli sui
giornali e persino indagini della stessa magistratura. Tra due settimane, il 25,
26 e 27 marzo, ci saranno le primarie per nominare i candidati al rinnovo del
Consiglio Superiore della Magistratura. La campagna elettorale è in corso, tra
spamming via mail, aperitivi e comizi nei vari tribunali, nello stile perfetto
della nostra politica. C’è chi a bassa voce se ne lamenta, cercando di evitare
di essere coinvolto. E a quanto pare sono tanti a cestinare missive di ogni
tipo, dove si tengono «diari» della campagna elettorale o si citano frasi a
effetto per conquistare qualche voto in più. Tre le correnti in campo: Unicost
(sorta di Democrazia Cristiana delle toghe), Magistratura Indipendente (più
vicina alla destra) e Area (zona centrosinistra). C'è poi il comitato Altra
Proposta che in pratica si oppone a tutte le correnti e vorrebbe nuove regole di
rappresentanza dell'autogoverno dei magistrati. Nel mentre l’attuale Csm deve
nominare il nuovi procuratori capo di Torino, Bari, Salerno e Firenze. Alcune
sedi sono vacanti da mesi, ma l’incrocio elettorale è talmente micidiale, tra
logiche correntizie e di potere, che è stato tutto spostato a data da
destinarsi. Si parla di inizio aprile, ma lo stesso vicepresidente del Csm
Michele Vietti non ha ancora dato un data precisa. Ad aggiungere benzina sul
fuoco, in questi giorni, si è messo Alfredo Robledo (vicino a Magistratura
Indipendente), procuratore capo del pool contro i reati della pubblica
amministrazione di Milano, che ha denunciato al Csm il Capo della Procura
Edmondo Bruti Liberati perché avrebbe «turbato» e «turba la regolarità e la
normale conduzione dell'ufficio»: una bomba atomica, scagliata contro uno degli
storici leader di Magistratura Democratica, ora confluita in Area, ma
soprattutto contro Francesco Greco capo del pool per reati finanziari e
protagonista proprio di Tangentopoli con l'ex pm Antonio Di Pietro. Il fascicolo
non è ancora arrivato sulle scrivanie di palazzo dei Marescialli, ma molti
consiglieri hanno letto la notizia sul Corriere della Sera. Nei prossimi
giorni la denuncia sarà girata con tutta probabilità alla prima commissione,
quella addetta appunto a «rapporti, esposti, ricorsi e doglianze concernenti
magistrati». Al tribunale di Milano parlano già di guerra senza esclusioni di
colpi. Il clima è irrespirabile, considerando che l’ufficio di Robledo è a pochi
metri da quello di Bruti Liberati. Quest’ultimo, intercettato dai cronisti, ha
preferito non commentare, idem per Greco, storico pm di Mani Pulite, adesso nel
calderone della denuncia, già accusato di non aver indagato su diversi reati
fiscali e in particolare su Sea. Del resto, Robledo, in questo documento di 12
pagine, parla di violazione dei «criteri organizzativi» e racconta nel dettaglio
diversi punti di rottura con il resto della procura. Come quando nel 2011, in
seguito allo scoppio dell’indagine sull’Ospedale San Raffaele che avrebbe poi
travolto la giunta lombarda di Roberto Formigoni, fu proprio Bruti Liberati,
secondo Robledo, a sottolineare «che si trattava di una situazione molto
delicata, essendo in corso trattative sulle quali non avrebbe voluto che le
indagini influissero in qualunque modo». È un attacco pesante che avviene nel
cuore di quel Palazzaccio che vent’anni fa si forgiava dei galloni per aver
debellato la corruzione nella politica italiana, indagando sul Psi di Bettino
Craxi e la Dc di Arnaldo Forlani. Ma da allora pare quasi che l’incantesimo
della magistratura con i cittadini si sia spezzato. I sondaggi degli ultimi
anni, spesso molto sporadici, sono in picchiata. Più del 50% degli italiani
sostiene di non credere più nella giustizia. Non solo. I dati europei non sono
confortanti. La giustizia civile italiana è la più lenta d’Europa dopo quella
maltese e la prima per casi pendenti che attendono ancora una sentenza
definitiva. È il risultato che emerge dal Quadro di valutazione Ue della
giustizia 2014. «Sono preoccupata per quei Paesi che sono in fondo alla lista”,
e dove magari “non ci sono progressi ma regressi”, ha affermato la commissaria
alla Giustizia, Viviane Reding. Non solo. Per finanziare il sistema giudiziario
in Europa si spendono 57,4 euro pro capite, in Italia la spesa arriva a 73 euro,
soltanto in Svizzera e nel Nord Europa si spende di più, per un sistema più
snello che pare funzionare. La nostra nazione ha il maggior numero di casi
civili pendenti, ben 4 milioni e 986 mila. I tempi sono lunghissimi: in media
circa 600 giorni per una sentenza solo di primo grado. Il quadro, in sostanza,
non è per nulla confortante. E questo si aggiunge a faide su faide, in
particolare proprio a Milano, dove i magistrati continuano a darsele di santa
ragione. A ottobre, prima di Bruti Liberati e Greco, è stato il turno della
Boccassini. «I giudici di provincia non capiscono nulla di mafia» disse durante
un convegno alla Bocconi l’11 ottobre. Apriti cielo. Le toghe di provincia
decisero di intervenire con un esposto sempre al Csm chiedendo all'organo di
autogoverno delle toghe, di valutare le affermazioni a loro avviso «gratuite»,
«denigratorie» e «generiche» pronunciate da Ilda la Rossa. Da Milano a Torino
fino a Firenze e Napoli è un brulicare di veleni e sospetti. Sotto la Mole
Antonelliana ha da poco lasciato il posto Giancarlo Caselli, non senza
polemiche. A novembre lasciò Magistratura Democratica dopo averla fondata e dopo
anni di militanza. Il motivo fu un contributo dello scrittore Erri De Luca al
giornale della corrente togata cosiddetta «rossa». In modo velato si parlava
della rivoluzione degli anni ’70 e si dava solidarietà ai No Tav della Val Susa,
che sono stati indagati e arrestati proprio dalla procura allora guidata da
Caselli (oggi in pensione) lo scorso anno per le violenze al cantiere e, per
alcuni, atti di terrorismo. Il magistrato di Alessandria se ne andò sbattendo la
porta. A tutto questo si aggiungano pure le inchieste piovute sullo stesso
Vietti e sugli ex magistrati che sono stati coinvolti nello scandalo
Finmeccanica, con al centro una commessa da 550 milioni di euro per 12
elicotteri in India. L’ex presidente della corte d’Appello di Milano Giuseppe
Grechi e l’ex presidente della corte d’Appello di Venezia Manuela Romei Pasetti,
diventati consulenti di piazza Montegrappa, finirono nel tritacarne, indagati in
un procedimento connesso. Il giudice per le indagini preliminari di Busto
Arsizio, Bruno Labianca, scrisse: «Gli indagati, informati dell’esistenza di una
indagine giudiziaria si sono attivati a porre in essere condotte di
sovvertimento della genuinità delle prove, anche con tentativi di pretesa
modifica della linea operativa dell’ufficio inquirente che procede e con
l’asservimento o, quanto meno la compiacenza presso i maggiori organi di
stampa». L'ennesima faida di una magistratura ormai allo sbando.
CHI CONTROLLA
I CONTROLLORI?
Fiamme Gialle travolte dagli arresti ai vertici. Riemerge il
caso: chi controlla i controllori? Alti ufficiali
della Guardia di Finanza fermati, perquisiti e indagati che gettano ombre
sull'impegno dei militari onesti. E, come venti anni fa, si ripropone il
problema della prevenzione: come impedire che i funzionari corrotti facciano
carriera, scrive Gianluca Di Feo su “L’Espresso”. Chi controlla i controllori?
Per la seconda volta in pochi giorni, le istruttoria coinvolgono ufficiali di
alto livello della Guardia di Finanza. Ieri è stato arrestato per corruzione il
colonnello Fabio Massimo Mendella, attualmente comandante delle Fiamme Gialle a
Livorno, ma soprattutto è stato perquisito l'ufficio del numero due del Corpo,
il generale Vito Bardi, anche lui indagato. Non era mai successo prima. Il
comando generale della Finanza non era stato perquisito nemmeno nella tempesta
del 1994, quando Mani Pulite coinvolse decine di graduati e ufficiali che in
Lombardia avevano alimentato un sistema di bustarelle. La scorsa settimana, la
piena del Mose aveva investito con violenza l'istituzione. L'ex generale Emilio
Spaziante è stato arrestato, con un'accusa ancora più grave delle bustarelle per
chiudere un occhio sulle verifiche fiscali: secondo i magistrati avrebbe
ottenuto oltre due milioni di euro per garantire alla macchina di quattrini
veneziana la protezione dalle inchieste penali. Una circostanza mai accaduta
durante la vecchia Tangentopoli. Con lui sono stati perquisiti Mario Forchetti,
ex generale a tre stelle nominato garante per la trasparenza degli appalti Expo,
e il colonnello Walter Manzon, ex comandante di Venezia: entrambi non risultano
indagati. Spaziante è stata fino a pochi mesi fa una figura di primissimo piano,
arrivata fino alla carica di capo di stato maggiore e comandante dell'Italia
Centrale. Un ufficiale a dir poco discusso. Le intercettazioni del faccendiere
Valter Lavitola avevano rivelato le pressioni nel 2009 su Silvio Berlusconi per
farlo arrivare al vertice del Corpo. «No, non per fare il numero uno. Per fare
una mediazione e lui fare il numero due», diceva Lavitola al premier: «La
mediazione la sta facendo il ministro (dell'Economia Giulio Tremonti, ndr)
ed è quasi fatta. Lei mi autorizzò a parlargliene. Lui mi ha detto che teneva
tutto fermo fino a quando lei non si muoveva e noi si rischia il caso che da
persone proprio amiche amiche amiche rischiamo insomma quanto meno che gli
diventiamo antipatici». Il generale Vito Bardi, comandante in seconda della
Guardia di finanza indagato per corruzione, intervistato a Bari nel 2012 spiega
i principi del finanziere modello: ''Un cittadino non avulso dal contesto che lo
circonda, di sani principi e pronto ad affrontare le difficoltà'' (immagini da
AntennaSud). Nonostante questo, Spaziante è riuscito nel 2013 ad arrivare alla
poltrona caldeggiata da Lavitola, grazie agli automatismi che regolano le
carriere. Poco dopo è esplosa un'altra inchiesta, questa volta della procura
antimafia di Roma, che ha registrato gli interventi sull'ufficiale di
un'industriale di Ostia per ottenere un documento, con cui realizzare un falso e
farsi assegnare un bene demaniale. Una vicenda in cui compariva anche un ruolo
dello studio professionale di Giulio Tremonti, chiamato a mediare su un
finanziamento da 100 milioni di euro che doveva essere stanziato da Unipol.
Guarda caso, la stessa società da cui pochi mesi fa Spaziante ha ottenuto una
consulenza dopo avere lasciato l'uniforme. Adesso l'ex generale è agli arresti.
Secondo gli accertamenti, condotti dalle stesse Fiamme Gialle, Spaziante e la
sua convivente hanno complessivamente dichiarato entrate per poco più di 2
milioni di euro, mentre sono state scoperte uscite pari a quasi 3,8 milioni.
Scrivono i pm: «In questo caso emerge inequivocabile l’elevatissimo tenore di
vita. Dalla scheda patrimoniale risultano auto sportive, barche di lusso, villa
con piscina, prestigiosi immobili, nonché la frequentazione di costosissimi
alberghi per i suoi spostamenti in Italia. Soggiorni settimanali a Milano in
hotel da mille euro a notte». E durante le perquisizioni nella residenza della
sua convivente, gli investigatori hanno trovato 200 mila euro con banconote
sporche di terra che sembravano essere state appena dissepolte. La correttezza
dell'istituzione non viene messa in discussione. Sono i militari delle Fiamme
Gialle a condurre le istruttorie più delicate del momento. Ed è stato proprio un
ufficiale, il colonnello Renato Nisi, a impedire che Spaziante venisse a
conoscenza della rete di microspie che hanno smascherato la ragnatela di
tangenti dell'Expo. Anche il procuratore capo di Napoli, Giovanni Colangelo, che
ha ordinato la perquisizione nel comando generale, ha detto: «Confermiamo
l'assoluta fiducia nel lavoro della Guardia di Finanza, ovviamente a partire dai
suoi vertici». Gli ultimi sviluppi mostrano però con chiarezza l'esistenza di un
problema di prevenzione, che riguarda tutta la pubblica amministrazione. Quali
strumenti esistono per impedire che la corruzione dilaghi? La questione era
stata posta venti anni fa, quando Mani Pulite aveva fatto finire in carcere
decine di militari e di funzionari degli uffici fiscali. Allora erano stati
proposti organismi di controllo, banche dati sui beni e altre iniziative,
rimaste lettera morta. E adesso tutto si ripropone. Uno dei punti chiave, che
anche in questo caso riguarda l'intera pubblica amministrazione, è l'assenza di
efficaci meccanismi disciplinari per valutare il comportamento dei funzionari.
Prima delle sentenza definitiva, non vengono quasi mai presi provvedimenti. Ma
il verdetto della Cassazione arriva dopo parecchi anni e la prescrizione
cancella quasi sempre le ipotesi di reato per i colletti bianchi. Come ha
evidenziato due mesi fa un'inchiesta de “l'Espresso”, in Italia l'impunità per
la corruzione è praticamente garantita. E nel frattempo le carriere proseguono,
fino ai piani più alti delle istituzioni. Figure come Spaziante o come Bardi
erano già state segnalate a vario titolo in diverse istruttorie: nell'estate
2011 entrambi erano citati nelle intercettazioni sulla cosiddetta P4. All'epoca
i pm avevano ricostruito una fuga di notizie sulle indagini, che aveva permesso
di mettere in guardia Gianni Bisignani, uomo chiave del potere romano. Ma non
c'erano state ripercussioni. Così come nulla è stato fatto per arginare le
frequentazioni molto interessate tra ufficiali e politici, in quella commistione
tra affari e nomine che è diventata il pilastro della nuova Tangentopoli, da
Milano a Venezia. Ora è necessario che questa nuova lezione si trasformi in
misure concrete, per evitare che accada ancora. E per impedire che la corruzione
di pochi getti ombre sull'attività di centinaia di militari delle Fiamme Gialle,
che tutti i giorni si impegnano con rigore e onestà per difendere quel che resta
della legalità nel nostro Paese.
Expo all’italiana: tangenti, pizzini e liti in procura.
Scrive
Tommaso Caldarelli su “Giornalettismo”.
Caos totale a Milano: spuntano nuovi appalti truccati. E in Tribunale i pm
litigano. Expo Milano 2015, il lavoro per i magistrati sembra non avere fine:
spuntano nuovi guai giudiziari, nuovi appalti truccati e nuove tangenti. Come se
non bastasse, davanti al Consiglio superiore della Magistratura è compiutamente
uscita fuori la frattura all’interno della Procura di Milano, con il Procuratore
Generale Edmondo Bruti Liberati che replica alle accuse del suo vice Alfredo
Robledo, sostenendo che egli abbia intralciato il corso delle indagini. Insomma,
veleni in procura: ne abbiamo parlato ieri
raccontando della guerra di note inviate al Csm che in qualche modo dovrà
dirimere la patata bollente. Lo scontro fra i due cavalli di razza, Bruti
Liberati e Robledo, con il primo che accusa il secondo di intralcio alle
indagini (ricorda Paolo Colonnello sulla Stampa: “Robledo pur essendo
costantemente informato del fatto che era in corso un’attività di pedinamento e
controllo su uno degli indagati, ha disposto analogo servizio delegando ad altra
struttura della Guardia di Finanza” con il rischio che il pedinato scoprisse di
esserlo. Solo l’abilità del personale operativo ha scongiurato questo rischio) e
il secondo che accusa il primo di tenerlo fuori dall’indagine, attraverso un
esposto al Csm che ha fatto finire, però, tutte le carte dell’inchiesta Expo sui
giornali e sui settimanali come Panorama ben prima che fosse opportuno. Intanto
i pubblici ministeri scoprono nuovi appalti truccati. Ancora il giornalista
della Stampa racconta che l’imprenditore Enrico Maltauro da Vicenza, il principe
delle tangenti della vicenda Expo Milano avrebbe versato a Giuseppe Cattozzo,
esponente dell’UdC ligure, qualcosa come un milione di euro complessivamente, in
più forme: contanti, fatture false, una bella Audi da 60mila euro. La domanda è:
“Se Maltauro per un paio di appalti aveva versato quasi un milione e promessi
altri 600mila euro, gli altri imprenditori per gli appalti sulal Sanità lombarda
che rappresentano oltre il 90% di questa inchiesta, quanto hanno pagato?”.
Sembra, moltissimi soldi, ed è per questo che una rogatoria con la Svizzera è
già stata avviata. E con ogni probabilità si aprirà anche una “fase due
dell’inchiesta”, con “file di imprenditori schierate in procura per confessare
corruzioni e tangenti”. Secondo il sondaggio della Stampa “si è aperta una nuova
tangentopoli”; ma non è tutto. Dall’ordine di arresto del manager Expo Angelo
Paris risulta che la cupola degli appalti (i magnifici tre: Frigerio, Grillo,
Greganti) aveva accesso libero ad Arcore, da Silvio Berlusconi, e buoni agganci
a Palazzo Lombardia da Roberto Maroni: con sempre nelle mani i famosi “pizzini”
sui quali sono annotati gli uomini delle tangenti e le percentuali da esigere.
L’uomo del contatto è Gianni Rodighiero, collaboratore di Sergio Frigerio, che
in più occasioni è ricevuto ad Arcore – e in un caso, lo stesso Frigerio è con
lui: principalmente “di lunedì e di venerdì”, dicono i protagonisti
dell’inchiesta; solo che, in tempi più recenti, bisogna stare più attenti, si
dicono al telefono, per scansare “il cerchio magico di Silvio Berlusconi”. Per
quanto riguarda Roberto Maroni e la regione, le carte riportate da Pietro
Colaprico ed Emilio Randacio su Repubblica sembrano dimostrare che Roberto
Maroni è stato agganciato una volta “per caso” e sarebbe stato proprio il
presidente a sollecitare Frigerio “per il lavoro sulle vie d’Acqua”, aggancio
che poi lo stesso Frigerio si rivendica, al telefono. Il figlio, Frigerio
Gianluigi, “risulta essere un funzionario di Regione Lombardia”: insomma,
Frigerio, in regione, possiede “maniglie solide” di cui non esita a vantarsi
ogni volta che è possibile.
Una nuova
tangentopoli su Expo 2015.
Il blitz, scattato alle prime luci dell'alba del 8 maggio 2014, ha portato
all'arresto di sette persone, tra cui il top manager Paris e l'ex parlamentare
Grillo ma anche vecchie conoscenze come Greganti e l'ex dc Frigerio. L'accusa è
di aver pilotato e gonfiato gli appalti dell'Esposizione universale, scrive
“Panorama”. Primo Greganti, Gianstefano Frigerio, nomi
che riportano indietro di oltre vent'anni le lancette dell'orologio della
cronaca giudiziaria e, in parte anche di quello del Paese. C'è poi quello di
Luigi Grillo, ex parlamentare ligure che i suoi guai giudiziari (per poi essere
assolto in appello) li ebbe in tempi più recenti, con la scalata della Banca
popolare italiana ad Antonveneta nel 2005, quella dei "furbetti del
quartierino". Greganti, Frigerio e Grillo ora sono in carcere per una
complicata vicenda di appalti, legata anche ad Expo: Frigerio quale "capo,
promotore ed organizzatore dell'associazione, con funzioni direttive e di
coordinamento degli altri associati". Greganti e Grillo quali "organizzatori
incaricati dell'attività di raccordo con il mondo politico, sia con finalità di
copertura e protezione in favore dell'imprese di riferimento, sia con finalità
di appoggio ai pubblici ufficiali coinvolti nelle procedure di appalto allo
scopo di assicurare agli stessi sviluppi di carriera nell'ambito degli enti e
delle società pubbliche quale corrispettivo del trattamento preferenziale
riservato alle imprese". Tradotto: associazione a delinquere, turbativa d'asta,
corruzione. Il blitz, imponente, che ha coinvolto oltre 200 finanzieri, è
scattato a Milano, alle prime luci dell'alba. Gli ordini di cattura sono sette.
L'accusa, sostanziata anche da alcune intercettazioni definite clamorose dai pm
milanesi, è quella di turbativa d'asta e associazione per delinquere per
pilotare e gonfiare i prezzi degli appalti pubblici, tra cui quelli di Expo
2015. Tra coloro che sono stati raggiunti dall'ordine di custodia cautelare ci
sono nomi pesantissimi. C'è Angelo Paris, 48 anni, il top manager di Expo.
C'è l'ex dc ed ex parlamentare di Forza Italia, Luigi Grillo, passato armi e
bagagli nelle fila dell'Ncd di Angelino Alfano. Ci sono vecchie conoscenze di
Mani Pulite che avevamo dimenticato, come Primo Greganti, il compagno G, l'ex
cassiere del Pci che rifiutò ogni collaborazione con i magistrati nei primi anni
90. O Gianstefano Frigerio, l'ex segretario regionale della Democrazia
cristiana, finito già allora in carcere con un passato anche come parlamentare
di Forza Italia, arrestato insieme al suo collaboratore Sergio Cattozzo, ex
segretario Udc Liguria. E ancora, il costruttore di riferimento del gruppo, il
vicentino Enrico Maltauro (che versava secondo i pm «30-40mila euro al mese» in
contanti o come fatturazione di consulenze alla «cupola degli appalti»);
Antonio Rognoni, di Infrastrutture Lombarde, la stazione appaltante
voluta da Roberto Formigoni, già accusato - nell'ambito della stessa inchiesta -
di aver pilotato appalti a favore di aziende amiche e gonfiato di almeno due
milioni di euro di spese ingiustificate (mascherate come consulenze) i lavori di
ristrutturazione dell'ospedale San Gerardo di Monza. Un gruppo di
immobiliaristi, politici e faccendieri, secondo la ricostruzione dei pm Claudio
Gittardi (pool antimafia) e Antonio D’Alessio (anticorruzione), che - muovendosi
per tempo sulla base delle informazioni riservate cui non avevano accesso i
concorrenti - si intascavano percentuali di tangenti, si aggiudicavano grazie
alle loro amicizie appalti pubblici chiave (come quello di Expo per
l'assegnazione delle case per le delegazioni straniere o il progetto definito 'Le
vie d’acqua') gonfiandone i prezzi e azzerando la concorrenza pulita.
Avevano anche una sede, il circolo culturale «Tommaso Moro», che per dirla con
Bruti Liberati «nemmeno la più fervida immaginazione avrebbe
immaginato». L'inchiesta (un faldone di 600 pagine in cui compaiono anche i
nomi, ma non sono indagati, di Maurizio Lupi, Silvio Berlusconi, Pierluigi
Bersani e Cesare Previti) su cui i pm lavoravano da mesi ha subito
un'accelerazione dopo che sono state registrate alcune intercettazioni
compromettenti che sarebbero giunte fino ai primi mesi del 2014. "Io vi do tutti
gli appalti che volete se favorite la mia carriera" avrebbe detto Angelo Paris,
il direttore pianificazione e acquisti di Expo 2015 parlando con alcuni
componenti dell’associazione per delinquere
finiti agli arresti. Ne emerge, dagli incartamenti, una «cupola degli appalti»
in Lombardia, con un meccanismo operativo definito dai pm molto semplice che
puntava a intascarsi percentuali di guadagno sugli appalti pubblici chiave non
solo di Expo ma anche di altri grandi lavori pubblici: quando c’era una gara
d’appalto giudicata interessante, l’associazione diretta da Frigerio avvicinava
il pubblico ufficiale competente, utilizzando gli appoggi e le amicizie
politiche che poteva vantare. Al sodalizio criminale venivano comunicati in
anticipo i bandi di gara interessanti, con le caratteristiche utili da
presentare per poterseli aggiudicare rispetto a eventuali concorrenti. La
squadra operava insomma «in modo coordinato», coinvolgendo aziende legate a
diversi partiti politici nei quali trovavano protezione. La promessa di carriera
e promozione - secondo i pm - diventava la leva fondamentale per coinvolgere i
nuovi adepti. Tra i lavori pubblici su cui il gruppo aveva rivolto le sue mire
ci sono anche (per un valore di bandi di gara di 323 milioni) i lavori della
Città della Salute di Sesto San Giovanni, gli appalti e le presunte finte
consulenze gonfiate per i lavori di ristrutturazione dell'ospedale San Gerardo
di Monza, la Pedemontana e la gestione dei servizi di supporto non sanitari
rivolti alle due Fondazioni IRCCS Carlo Besta e Istituto Nazionale dei
Tumori. «La politica non metta becco sulle indagini» ha dichiarato Matteo Renzi
a Genova, nell'ambito di un'iniziativa di Ansaldo Energia.
La confessione
di mister Expo. «Appalti in cambio di protezioni». Prime ammissioni di Paris, il
manager chiave dell'inchiesta: «E' vero, ho favorito Frigerio e Greganti, perché
ero isolato e mi servivano appoggi politici per la carriera. Ho sbagliato, ora
mi dimetto». Oggi due interrogatori paralleli per l'industriale Maltauro e il
politico Udc Cattozzo, scrive Paolo Biondani su “L’Espresso”. Prima svolta
nell'inchiesta sugli appalti dell'Expo. Angelo Paris, il direttore tecnico
arrestato per associazione per delinquere, ha confessato già nel primo
interrogatorio i fatti fondamentali che gli vengono contestati dai pm milanesi:
ha ammesso di aver fornito informazioni riservate sugli appalti dell'Expo alla
cosiddetta “cupola” politica guidata dall'ex democristiano poi berlusconiano
Gianstefano Frigerio e dall'ex comunista poi democratico Primo Greganti,
entrambi ora in carcere. Paris ha anche confermato di aver chiesto, in cambio,
l'appoggio dei due faccendieri politici per la sua futura carriera di manager
pubblico, candidato in particolare a guidare la società regionale Infrastrutture
Lombarde dopo il duplice arresto dell'ex numero uno ciellino Antonio Rognoni. In
questo primo interrogatorio, molto sofferto, Paris ha ammesso di aver fatto
questi «errori» e di volersene assumere la «responsabilità» presentando subito
le dimissioni. L'ex manager, inoltre, ha cominciato anche a spiegare a grandi
linee le ragioni che lo avevano spinto a mettersi a disposizione dei faccendieri
della “cupola degli appalti”: Paris ha detto che si sentiva sempre più «isolato»
nella struttura dell'Expo e di aver concluso che proprio personaggi come
Frigerio e Greganti potevano garantirgli quelle «protezioni politiche» che gli
sembravano necessarie. Dopo queste prime ammissioni, Paris verrà nuovamente
interrogato lunedì prossimo, questa volta dai magistrati dell'accusa, per
chiarire e approfondire tutti i fatti e spiegare meglio i motivi per cui un
tecnico dell'Expo possa pensare di dover chiedere «protezione politica» a due
noti pregiudicati per corruzione, concussione e finanziamenti illeciti come
Frigerio e Greganti, entrambi condannati con sentenza definitiva come tesorieri
delle mazzette nella storica Tangentopoli esplosa nel 1992-1994. Le ammissioni
di Paris, che occupava il ruolo chiave di responsabile del settore costruzioni e
dell'ufficio contratti, rappresentano un'importante conferma della solidità
dell'inchiesta coordinata dai pm Ilda Boccassini, Claudio Gittardi e Antonio
D'Alessio. Una svolta, arrivata già nel primo interrogatorio di garanzia davanti
al gip Fabio Antezza, che contraddice i dubbi sollevati invece dal procuratore
aggiunto Alfredo Robledo, che nel suo durissimo scontro con il procuratore capo
Edmondo Bruti Liberati aveva segnalato al Csm di non aver condiviso né firmato
proprio le accuse rivolte a Paris. Per oggi sono fissati altri due nuovi
interrogatori importanti: i pm, divisi in due squadre, sentiranno
contemporaneamente Enrico Maltauro, l'industriale vicentino che ha già ammesso
le prime tangenti, e Vito Cattozzo, il politico dell'Udc ligure che faceva da
tramite tra Frigerio e l'ex parlamentare di Forza Italia Luigi Grillo, curando i
rapporti con il centrodestra e con le banche. Gli interrogatori contemporanei
serviranno ad impedire ai due arrestati di poter concordare versioni di comodo,
mentre i pm potranno contestare subito all'uno le eventuali ammissioni
dell'altro, favorendo così dichiarazioni meno reticenti. Maltauro è il re degli
appalti che è stato videoregistrato dagli investigatori della Dia mentre
concordava e pagava tangenti, fino a consegnare di persona l'ultima bustarella
con 15 mila euro pochissimi giorni prima degli arresti.
Expo, Bruti
Liberati: "Robledo è stato d'intralcio alle indagini", scrive “Libero
Quotidiano”. Nuovo atto nella violenta guerra tra toghe che sta sconvolgendo il
pool di Milano. A riferire davanti al Consiglio superiore della Magistratura
tocca a Edmondo Bruti Liberati, procuratore capo della procura meneghina, il
"grande accusato" dal collega Alfredo Robledo. Bruti Liberati, in riferimento
alla vicenda Expo, ha affermato che "le iniziative del procuratore aggiunto
Robledo hanno determinato un reiterato intralcio alle indagini". La vicenda
affonda le sue radici allo scorso marzo, quando Robledo aveva denunciato al Csm
"fatti e comportamenti in essere dal procuratore della Repubblica, Edmondo
Brunti Liberati, che non ritengo possano essere più valutati come episodici e
che, in considerazione del loro ripetersi, hanno turbato e turbano il regolare
svolgimento della funzione nell'Ufficio e la sua normale conduzione". Le ragioni
- In soldoni si tratta di un caso clamoroso che sta turbando la presunta armonia
del pool di Milano: il magistrato (Robledo) denuncia il suo capo (Bruti
Liberati). Perché? Perché Robledo si sente scavalcato a causa del fatto che,
afferma, il capo assegnerebbe i fascicoli che riguardano reati contro la
pubblica amministrazione (di cui sarebbe competente il suo ufficio) al pool
reati finanziari, guidato dall'altro procuratore aggiunto, Francesco Greco,
vecchia conoscenza di Mani Pulite. Oppure a Ilda Boccassini, la pm anti-Cav per
eccellenza (la Boccassini è stata accusata dal pg di Milano, Manlio Minale, di
non avere la titolarità dell'inchiesta Ruby; l'accusa è piovuta sempre
nell'ambito dell'inchiesta avviata dopo l'esposto di Robledo). La battaglia - Lo
scontro, in atto da mesi, è deflagrato nuovamente lo scorso giovedì, in
parallelo all'esplosione dello scandalo Expo. Si è scoperto che Robledo non
aveva firmato gli atti dell'inchiesta. Bruti Liberati, in una conferenza stampa
in cui si era notata proprio l'assenza di Robledo, aveva spiegato che il collega
"non ne condivide l'impostazione" e dunque "non ha vistato" gli atti
dell'inchiesta Expo che non ha portato all'arresto di sette nomi di rilievo, e
all'iscrizione nel registro degli indagati di altre dodici persone, nonché a
perquisizioni a Milano, Roma, Torino, Vercelli, Alessandria, Pavia, Lecco,
Vicenza e Bologna. Ultimo atto - Ora, dunque, l'ultimo atto di questa vera e
propria battaglia che tiene banco tra i corridoi dei tribunali di Milano, ossia
l'accusa del capo (Bruti Liberati) al suo magistrato (Robledo) di aver
"ostacolato" l'inchiesta Expo che sta mettendo a repentaglio l'organizzazione
dell'evento e sta facendo tremare la politica italiana. Un'accusa pesantissima,
e che non farà altro che dilatare il conflitto. Bruti Liberati e Ilda Boccassini
da un lato, Alfredo Robledo dall'altro.
Bruti
Liberati, Robledo e il doppio pedinamento. La querelle tra magistrati al vertice
della Procura di Milano finisce in guerra. Ma un po' anche in farsa: perché è
stato chiesto un pedinamento che era già stato disposto, scrive Maurizio
Tortorella su “Panorama”. Lo
scontro al vertice della Procura di Milano si alza improvvisamente di livello e
diventa guerra guerreggiata. Il procuratore Edmondo Bruti Liberati, in una nota
destinata al Consiglio superiore della magistratura che da oltre un mese sta
affrontando la querelle aperta dal suo procuratore aggiunto Alfredo Robledo, ha
scritto che le iniziative di quest'ultimo "hanno determinato un reiterato
intralcio alle indagini" sugli appalti dell'Expo, appena scoppiate con la retata
dei mercoledì 7 maggio. Nella nota Bruti aggiunge che l'invio da parte
di Robledo al Csm di copie di atti del procedimento ha anche "posto a grave
rischio il segreto delle indagini". Ma qui, purtroppo, lo scontro scade in
farsa. Perché Bruti cita un "doppio pedinamento" che avrebbe potuto
compromettere l'inchiesta. Ecco che cosa annota il procuratore: "Robledo, pur
essendo costantemente informato del fatto che era in corso un'attività di
pedinamento e controllo su uno degli indagati, svolta da personale della polizia
giudiziaria, ha disposto, analogo servizio delegando ad altra struttura della
stessa Guardia di finanza". Il procuratore aggiunge che "solo la reciproca
conoscenza del personale Gdf che si è incontrato sul terreno ha consentito di
evitare gravi danni alle indagini". Si attendono ora altri "capitoli" dello
scontro tra Bruti Liberati e Robledo, e forse qualche conseguenza di tipo
direttamente giudiziario. Robledo, qualche giorno fa, aveva spiegato al Csm le
ragioni del suo mancato "visto" alle misure cautelari richieste per l’inchiesta
sull'Expo: il numero 2 della procura aveva lamentato di non essere stato messo
in condizioni dal procuratore Bruti Liberati, «in violazione della normativa»,
di fare una valutazione sulla posizione di uno degli indagati. In precedenza,
Robledo aveva accusato il capo dell’ufficio Bruti Liberati di una serie di
presunte irregolarità. Come il ritardo «di un anno» con cui era stato indagato
Roberto Formigoni nell’inchiesta San Raffaele-Fondazione Maugeri e l'affidamento
dell’inchiesta sul cosiddetto Rubygate, segnato a suo dire da gravi violazioni
delle regole: l’assegnazione indebito del procedimento a Ilda Boccassini,
procuratore aggiunto dell’antimafia di Milano, che secondo Robledo non avrebbe
avuto la competenza per occuparsi di quel procedimento. Bruti Liberati si è
difeso davanti al Csm sostenendo che tutte le accuse erano prive di fondamento.
Expo, ecco tutte le beghe fra Boccassini, Robledo e Bruti Liberati, scrive
Edoardo Petti su “Formiche”.
La ricostruzione dei dissidi fra i magistrati milanesi secondo i cronisti
giudiziari dei principali quotidiani. Una lettura non troppo commendevole, come
d'altronde quella sulle intercettazioni...Il terremoto giudiziario che si è
abbattuto su Expo 2015 con la scoperta di una “cupola”
trasversale finalizzata ad assegnare gli appalti in cambio di tangenti ha
portato alla luce una ragnatela capillare di protezioni e intrecci affaristici
tra manager, pubblici funzionari, politici e imprenditori, secondo le
accuse dei pm. Ma ha fatto affiorare al contempo un
conflitto radicale e reiterato fra le mura del Palazzo di Giustizia di Milano. A
partire dallo scontro fra il capo della Procura
Edmondo Bruti Liberati e il procuratore aggiunto Alfredo Robledo, che ha vissuto
un crescendo di accuse incrociate risalenti all’attribuzione a Ilda Boccassini
del fascicolo investigativo e processuale sul Rubygate. E dall’accusa, rivolta
al massimo responsabile dell’ufficio giudiziario milanese, di aver
rinviato di un anno gli accertamenti per i presunti pagamenti di mazzette dei vertici
dell’ospedale San Raffaele a favore dell’ex governatore della Lombardia Roberto
Formigoni. Tensione che ha assunto una rappresentazione plastica nella
conferenza stampa sui fenomeni di corruzione legati a Expo. E che non è rimasta
inosservata da parte dei giornali più attenti alle dinamiche della magistratura
ambrosiana. È il Corriere della Sera a mettere in rilievo una frase emblematica
pronunciata da Bruti Liberati nella giornata di ieri. Ai cronisti giudiziari che
gli ricordavano come l’inchiesta sulle illegalità relative agli appalti per Expo
2015 fosse uno dei filoni investigativi citati dal procuratore aggiunto Robledo
nell’esposto presentato contro di lui al Consiglio superiore della
magistratura per irregolarità nella gestione e
assegnazione dei fascicoli di indagine, il capo dei pm milanesi ha così
risposto: “Robledo non ha condiviso l’impostazione dell’inchiesta e non ha
vistato gli atti. Ma prima vi erano state numerose riunioni”. Argomentazioni che
hanno provocato una risposta repentina e sdegnata
da parte del numero due della Procura. Il quale ha spiegato come il dissenso
riguardasse la posizione di un indagato, su cui non vi erano a suo avviso gli
elementi per una misura cautelare rispetto ai reati di corruzione e turbativa
d’asta. Ragionamento di cui “mise a conoscenza Bruti Liberati e Ilda Boccassini,
senza ricevere risposta”. A tutto ciò Robledo ha fatto riferimento nell’esposto
trasmesso a Palazzo dei Marescialli. Un documento nel quale ha puntato il dito
contro il comportamento centralizzatore del procuratore capo, “che frena ogni
autonoma iniziativa di inchiesta, intercettazione e pedinamento”. Ma l’accusa
va ben oltre. Bruti avrebbe gestito i dossier
giudiziari penalizzando il suo ufficio specializzato nei reati contro la
pubblica amministrazione, a vantaggio della Direzione distrettuale anti-mafia
guidata da Boccassini. Le cui competenze, osserva il magistrato, non rientrano
nelle indagini sulle tangenti correlate a Expo. La risposta della pm già
appartenente al pool Mani Pulite giunge sulle pagine di Repubblica.
L’inchiesta, rileva Boccassini, rappresenta “una delle numerose costole” di un
filone investigativo risalente al luglio 2010 e concernente le relazioni nel
territorio lombardo tra cosche della ‘ndrangheta, personaggi politici e
manager di ospedali. Fattispecie criminose che spetta ai magistrati
anti-mafia appurare. Soltanto più tardi, precisa la pm, vennero alla luce
ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione: “Elementi che segnalai a
Bruti per una sinergia con il dipartimento coordinato da Robledo”. A fornire una
spiegazione sulle ragioni profonde della spaccatura nel Palazzo di Giustizia è
un articolo apparso sul Giornale a firma Luca Fazzo.
L’assenza fisica del procuratore aggiunto nella conferenza stampa dei magistrati
milanesi, scrive il cronista, è legata agli orientamenti politico-ideologici
dell’universo togato. Robledo, in breve, è estraneo all’entourage dei pm
progressisti di Magistratura Democratica legati
al capo della Procura. Figure tra le quali spicca la principale responsabile del
pool anti-mafia, “capace di assumere la guida dell’indagine su Expo 2015
esattamente come fece nella vicenda Ruby. Un’inchiesta di cui non aveva la
titolarità e che riguardava reati commessi da pubblici funzionari”. Ma vi è un
dissenso più remoto, connesso al metodo di lavoro adottato dai capi dei due
dipartimenti giudiziari: la scelta dell’organo di polizia giudiziaria cui
affidare le indagini. L’ex pm del pool Mani Pulite, evidenzia Il Giornale, ha
sempre utilizzato una squadra assai ristretta di militari della Guardia di
finanza in servizio alla Procura. Nell’inchiesta in corso la pm vuole in tutti i
modi ricorrere a questo gruppo di propria fiducia. L’obiezione avanzata da
Robledo riguarda il numero esiguo del personale investigativo. Poiché il
materiale giudiziario è sterminato, i magistrati inquirenti rischiano di perdere
il controllo su tutti gli spunti dell’inchiesta: “E sarebbero gli uomini delle
Fiamme Gialle a stabilire con ampio margine di discrezionalità le
intercettazioni da trascrivere”.
LA COERENZA
ED IL BUON ESEMPIO DEI FORCAIOLI.
Gli arresti
esaltano i manettari: "Nuova Mani pulite". M5S processa Scajola, la Lega
chiede pulizia. Pd spiazzato, Forza Italia garantista, scrive Fabrizio De
Feo su “Il Giornale”. C'è chi prova a salire sulla tigre giustizialista e a
cavalcarla (probabilmente incrociando le dita, nella speranza di non trovarsi
mai al posto degli indagati). E chi prova a far notare che c'è qualcosa che non
va, che ci si trova di fronte a un canovaccio già visto, con una serie di eventi
giudiziari a orologeria, dall'ampia eco mediatica, scoppiati a due settimane dal
voto. Nel giorno del doppio affondo giudiziario - tra inchiesta Expo e arresto
di Claudio Scajola - la politica si muove secondo schemi in qualche modo
«identitari». I grillini partono subito all'attacco e in un post sul blog di
Beppe Grillo, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Maurizio
Buccarella, chiede l'approvazione «di una nuova e seria legge anti-corruzione».
«Dopo Scajola», recita il post, «ecco la nuova Tangentopoli delle larghe intese
sugli appalti Expo 2015. Il Movimento 5 Stelle in tempi non sospetti aveva
denunciato con forza come l'Expo fosse un tangentificio a forte rischio
corruzione e infiltrazioni mafiose: grandi opere... grandi tangenti!». Il Pd,
invece, si muove in modo disordinato. C'è chi riflette sul clima dominante che
oggi regna nel Paese e dice a mezza bocca: «Meno male che in giunta per le
autorizzazioni a procedere abbiamo votato per l'arresto di Genovese, altrimenti
oggi saremmo nel mirino». Nel partito, però, c'è anche chi teme che il voto in
aula, che probabilmente ci sarà martedì o mercoledì, possa riservare qualche
sorpresa. Matteo Renzi, comunque, invia un messaggio chiaro e invita tutti a
stare alla larga dalla materia. «Massima fiducia nella magistratura e massima
severità se sono stati commessi reati», chiarisce il presidente del Consiglio.
«I politici facciano il loro lavoro e non commentino il lavoro della
magistratura». Toni duri imbraccia, invece, la Lega con Matteo Salvini. «Su Expo
vogliamo assoluta pulizia, spiace che certe facce del vecchio mondo siano ancora
in giro». Chi non si tira indietro dal sollevare perplessità su modalità e
tempistica degli eventi è Forza Italia. Una protesta che va al di là dei calcoli
sull'opportunità tattica della presa di posizione e del timore che le manette
possano tramutarsi in benzina versata sul fuoco grillino. «Il copione si ripete,
non appena sono vicine le elezioni scatta la giustizia a orologeria quasi sempre
verso esponenti di centrodestra anche quando, come nel caso di Scajola, non
fanno parte di questa competizione elettorale. Forza Italia resta un partito
garantista, Scajola dimostrerà la sua estraneità» dice Giovanni Toti. «Noi -
prosegue - continueremo nell'azione di rinnovamento delle liste e dei quadri
dirigenti del partito in modo totalmente indipendente dall'azione della
magistratura». Gianfranco Rotondi invita ad approfondire e verificare dal punto
di vista giuridico davvero la detenzione di Scajola sia una fattispecie
contemplata dal codice, o non si sia esagerato con questa misura. Infine,
Elisabetta Gardini, capolista nel Nord Est, non ha dubbi: «Non dico che ci sia
un complotto, ma avvenimenti come l'arresto di Scajola impediscono di parlare di
ciò che preme alla gente. Possiamo dire che c'è un cronoprogramma, un
affollamento di questi avvenimenti sempre intorno alle campagne elettorali».
Quella
barbarie delle manette facili. Indagare su Scajola è lecito ma metterlo
dentro è barbarie, scrive Vittorio Feltri su “Il Giornale”. Era scontato che
la Cassazione confermasse la condanna a 7 anni per Marcello Dell'Utri,
attualmente a Beirut, piantonato in un ospedale. Certi verdetti, anche se non si
possono sapere in anticipo, si annusano. Evidentemente lo stesso Dell'Utri aveva
subodorato che gli avrebbero inflitto una pena pesante, tant'è che, in attesa di
conoscere il proprio destino, si era trasferito in Libano, le cui autorità ora
decideranno se concedere l'estradizione. Il che non è automatico, poiché in quel
Paese il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non c'è e sarebbe una
forzatura se esse, nonostante ciò, si piegassero alla richiesta italiana di
rimandare in patria l'ex senatore del Pdl. In questi casi può succedere di
tutto. Non siamo in grado di stabilire se Dell'Utri sia colpevole o innocente:
la sua vicenda è talmente complicata anche per gli esperti di diritto,
figuriamoci per noi semplici orecchianti. Se però consideriamo che i magistrati
per arrivare alla sentenza definitiva hanno impiegato la bellezza di 20 anni,
sorge il sospetto che i giudici abbiano faticato a capirci qualcosa. Insomma, la
sensazione è che le accuse rivolte all'imputato non fossero poi così nette e
sostenute da prove inoppugnabili. Pare che un processo durato quattro lustri
meriti una citazione nel Guinness dei primati, essendo peraltro dimostrativo
dell'inaffidabilità della nostra Giustizia, notoriamente bisognosa di urgente
riforma, non solo perché lenta, ma pure incapace di apparire credibile. Il
problema va oltre la tardiva e controversa condanna del cofondatore di Forza
Italia. Come si fa a ostinarsi a tenere in piedi un sistema giudiziario barocco
e farraginoso quale il nostro, che per giudicare una persona cui si attribuisce
un reato le ruba preventivamente 20 anni di vita, costringendola a saltabeccare
da un tribunale all'altro, a campare col cuore in gola per il terrore di essere
imprigionata, a pagare parcelle su parcelle agli avvocati, ammesso che abbia i
mezzi per saldarle? Non è già questa una pena dolorosa? Nossignori. A un certo
punto, quando tale persona è stata distrutta nel morale e nel fisico, si trova a
dover scontare 7 anni di galera. E ci si stupisce se taglia la corda e si
rifugia in Medio Oriente allo scopo di non trascorrere gli ultimi sgoccioli di
esistenza dietro le sbarre? È più scandalosa la fuga o la lungaggine mostruosa
dei procedimenti che l'ha provocata? Domanda: se un giudizio si trascina per 20
anni, quanti secoli ci vorranno ancora per correggere i vizi e le storture della
cosiddetta giustizia? In questi giorni campeggia sui giornali un'altra notizia
di genere affine a quella che abbiamo esaminato sopra: l'arresto dell'ex
ministro Claudio Scajola, accusato di aver ordito un piano finalizzato a
consentire ad Amedeo Matacena di nascondersi all'estero, infischiandosene di una
condanna definitiva (5 anni di carcere) per il solito concorso esterno in
associazione mafiosa. Scajola, passato alla storia per la famosa casa ricevuta
in dono a «sua insaputa» (assolto), sarebbe stato inchiodato da intercettazioni
telefoniche (più ambigue che schiaccianti). Ovvio. Occorre fare chiarezza. Ed è
ciò che i Pm tentano lodevolmente di fare. Ma qualcuno ci spiega dove sia la
necessità di trattenere in cella uno le cui malefatte non sono ancora state
verificate? In circostanze simili, la risposta è la seguente: pericolo di fuga,
di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato. Scusate. Il pericolo di
fuga, come insegna l'esperienza, si presenta nel momento in cui scatta la
sentenza definitiva, non durante l'indagine, altrimenti l'ex ministro sarebbe
scappato anche quando era in corso l'inchiesta sulla casa. L'inquinamento delle
prove è impossibile se è vero che esse sono contenute nelle intercettazioni
telefoniche acquisite dal Pm. Infine, la reiterazione del reato, nella
fattispecie, è improbabile a meno che Scajola non abbia cambiato mestiere e
aperto un ufficio per l'espatrio dei pregiudicati. Altamente improbabile.
Pertanto, i domiciliari sarebbero stati più che sufficienti. Senza contare che
se il nostro tornasse a piede libero non avrebbe molte opportunità per
intralciare le investigazioni. Non sarà che inconsciamente alcuni magistrati
siano animati da una volontà punitiva insopprimibile per cui in dubbio pro
manette? C'è di che turbarsi.
Ed ancora. Il
caso Garlasco e l'inesauribile voglia di mostro. A sette anni o poco meno
dal delitto, se ne torna a parlare in un'aula di giustizia. Il clima in cui si
celebrerà il processo non promette nulla di buono, scrive Vittorio Feltri su “Il
Giornale”. A sette anni o poco meno dal delitto di Garlasco, se ne torna a
parlare in un'aula di giustizia, quella della terza Corte d'assise di Milano.
Non sono bastate due assoluzioni a scagionare il fidanzato della vittima, Chiara
Poggi, dall'accusa di esserne stato l'assassino. Incredibile la lunghezza del
giudizio definitivo. L'imputato, Alberto Stasi, vive in un incubo ogni dì
rinnovabile. Domani egli sarà di nuovo alla sbarra, come si dice, per
difendersi, poiché la Cassazione, qualche tempo fa, nell'esaminare la sentenza
d'appello che lo sollevava da ogni responsabilità, ha ordinato una sorta di
riesame. In altri termini, l'appello è da rifare perché i giudici di terzo grado
sono convinti che non tutti gli indizi siano stati valutati appieno. Cosicché,
nonostante Stasi sia stato processato con rito abbreviato una prima volta
(assolto) e una seconda (assolto) con tutti i crismi della legalità, è ancora ai
nastri di partenza, come se fino adesso le toghe avessero scherzato. Sette anni
sono lunghi da passare. Ma non conta. Il nostro sistema farraginoso prevede
sempre la possibilità di rifare tutto. In effetti, si ricomincia. Le torture non
finiscono mai. Ricostruire tutti i passaggi processuali, con i vari dettagli,
sarebbe per noi un'operazione troppo complicata, noiosa e forse inutile giacché
i lettori puntano al sodo. E il sodo è che Chiara Poggi è stata ammazzata in
casa sua con un'arma contundente (mai ritrovata). Da chi? Da una persona che
conosceva bene, tanto che la mattina di buon'ora le aprì la porta. Che cosa sia
accaduto poi in quella villetta non è dato sapere: lite, colluttazione, fuga e
inseguimento? Chi può dirlo. È un dato che la ragazza è stata trovata morta al
piano terra. Macchie di sangue dappertutto. L'indagine si svolge nel raggio di
mezzo chilometro. Chi può essere stato se non il fidanzato? Gli inquirenti
puntano su di lui. Come al solito, in vicende di questo tipo, si guarda
nell'ambito familiare. Stasi finisce subito in galera gravato da pesanti
sospetti. Perché la sera precedente l'aveva trascorsa con lei. Perché qui perché
là. Perché lui quella mattina si recò a casa di lei e la scorse morta in fondo
alla scala. Perché Alberto telefonò ai carabinieri e la sua voce non tradiva
emozione. Insomma, i racconti divulgati dalla stampa e dalle tivù sono
interpretati quali indici di colpevolezza. Pochi giorni dopo l'arresto,
tuttavia, Stasi viene rimesso in libertà in mancanza di prove. Andiamo veloci.
Seguono decine di programmi televisivi che sviscerano ogni dettaglio del giallo;
l'opinione pubblica, tanto per cambiare, si divide in colpevolisti e
innocentisti. Personalmente, difendo il ragazzo non perché sia simpatico; anzi,
è odioso. Ma contro di lui ci sono solamente pregiudizi: ha gli occhi di
ghiaccio (in realtà è solo miope), è un tipo strano, ha trascorso un mese a
Londra mentre la morosa aveva principiato a lavorare a Milano (uno stage), gli
piaceva compulsare il computer laddove c'è del porno. Un sacco di stupidaggini
che non c'entrano nulla con l'assassinio. Tra la coppia non vi sono state
telefonate in cui si percepiscano liti, non si rintracciano mail in cui emergano
liti o battibecchi. Tutto normale, piatto, piattissimo. Non è finita. Lui non si
è sporcato le scarpe sulla scena del delitto. Però vi sono sue impronte sul
sapone del bagno. Capirai. Uno che frequenta abitualmente la casa della
fidanzata si sarà talvolta, suppongo, lavato le mani nel gabinetto. Avete
capito? Tutta robetta. Manco una prova. Che dico, una prova, nemmeno mezza. Il
movente eventuale? Gli inquirenti si arrampicano sui vetri. Dicono: lei ha
scoperto che lui osservava le schifezze sul computer, ecco la causa della lite
che ha scatenato la furia omicida di Alberto. Congetture. Se contrasti fra i due
ci fossero, non sono stati appurati. E allora? Stasi dal presunto reato di
pedopornografia web è stato scagionato. Quindi le porcherie non possono essere
state il movente: tra l'altro piacevano anche a lei. Non mancano le
elucubrazioni degli avvocati di parte civile che vorrebbero incastrare il
giovane, ma sono inconsistenti e, quando si arriva davanti al giudice del rito
abbreviato, il professor Angelo Giarda non fatica a far risaltare l'innocenza
del suo assistito, Stasi, che viene assolto. Il verdetto di secondo grado è la
fotocopia del primo. Basta? Nossignori. La Cassazione rimette tutto in
discussione: bisogna approfondire questo e quell'elemento. Le toghe indicano
sette od otto punti da verificare. Nel frattempo sono trascorsi sette anni
(sette). Siamo al delirio. Ovvio che i genitori di Chiara pretendano che
l'omicida sia inchiodato e condannato. Anch'io sono dalla loro parte. Concordo.
S'identifichi l'assassino; non ci si accontenti però di punire uno qualsiasi cui
addossare a casaccio la colpa di aver ucciso. Come si fa ad accanirsi su un
tizio contro il quale non vi sono che oscuri presentimenti e dubbi? Il clima in
cui si celebrerà l'ennesimo processo non promette nulla di buono. Trasformare
pallidi indizi - mezzi indizi - in elementi probatori è tecnicamente un gioco da
bambini per magistrati esperti. Una sentenza di condanna spesso placa le
coscienze anziché tormentarle. Questo è il costume italiota. Fossi in Alberto,
sarei terrorizzato. Sento puzzo di verdetto pesante. Spero di sbagliare. Il suo
destino è nelle mani del professor Giarda, che è un fuoriclasse, ma non un
padreterno. Auguri.
Ma a proposito
di Pubblici Ministeri. Parliamo di loro. Per esempio quelli di Milano.
Liti e
denunce, scoppiano i pm anti-Cav. Dall’inchiesta sull’Expo a
Ruby, i vertici regolano i conti al Csm. Il pm Robledo si affida alla Gdf,
scrive Matteo Di Paolo Antonio su “Il Tempo”. Lui, lei, l’altro. Non è un
triangolo sentimentale, quello che sta andando in scena alla procura di Milano,
ma ci assomiglia per tanti aspetti. Le corna, qui, sono professionali, forse
anche con coloriture politiche. E anche in questo caso, come in quello di Mani
Pulite e tanti altri, una faccenda diciamo così «domestica», rischia di
scoperchiare il famoso "vaso di Pandora" in salsa meneghina. Lui, lei e l’altro
sono il procuratore capo Edmondo Bruti Liberati, l’aggiunto di fiducia Ilda
Boccassini e quello che si sente scavalcato e messo da parte, l’aggiunto Alfredo
Robledo, anche lui tra gli otto «vice» del capo. L’esposto di quest’ultimo al
Consiglio superiore della magistratura, a metà aprile, è l’atto che ha aperto
ufficialmente la guerra, provocando la dura reazione di Bruti Liberati, secondo
cui Robledo sarebbe stato d’«intralcio» in molte indagini importanti, a
cominciare da quella sull’Expo. Ma Robledo, che ha già denunciato gravi
irregolarità, manifeste violazioni e colpevoli ritardi nell’assegnazione delle
indagini da parte del procuratore Capo, ieri è ripassato all’attacco producendo
atti che proverebbero come Bruti Liberati, sull’ormai noto caso del doppio
pedinamento, abbia dichiarato il falso. Ma torniamo alle «corna». Secondo le
denunce di Robledo al Csm, Bruti Liberati avrebbe ignorato le competenze e le
regole interne, preferendo pm fidati e magari della sua corrente, cioè
Magistratura democratica, soprattutto per vicende dal forte impatto
politico-mediatico. Mentre Robledo non è certo di sinistra, è un «cane sciolto»,
semmai più vicino ai moderati: si è candidato (senza successo) anni fa per
Magistratura indipendente alle elezioni dell’Anm milanese, pur non essendo
iscritto alla corrente. La delicatissima inchiesta sul caso Ruby sarebbe
l’esempio principe di questi favoritismi: Bruti l’ha assegnata all’aggiunto
responsabile dell’antimafia Boccassini, mentre Robledo, che guida il
dipartimento sui reati contro la pubblica amministrazione, ne rivendica la
competenza. Al Csm anche Ferdinando Pomarici conferma «l’anomalia» di quella
decisione. Bruti Liberati, dunque, volle che fosse proprio Ilda a condurre
l’inchiesta che portò alla condanna a 7 anni di Berlusconi, per corruzione e
prostituzione minorile. E poi ce ne sono altre di inchieste, finite sempre nelle
mani dei pochi pm del «cerchio magico» del capo: quella sul San Raffaele, quella
Sea-Gamberale. Fino all’ultima, la più esplosiva, quella che rischia di essere
la nuova Tangentopoli per l’Epxo 2015 e sarebbe stata «scippata» a Robledo per
finire anch’essa nelle mani di «Ilda la rossa». Robledo non ha voluto firmare le
sette richieste di misure cautelari per altrettanti indagati, sostenendo di non
essere stato informato dal procuratore e di non aver potuto compiere le sue
valutazioni, «in violazione della normativa». E c’è anche, per altri versi, il
caso-Sallusti, che avrebbe portato a una decisione «unicum» sui domiciliari (non
richiesti) al direttore de Il Giornale , condannato per diffamazione. Una
scelta in deroga alla prassi corrente e contestata dai pm: solo per questo
diventata poi norma per tutti i casi analoghi, in seguito a una circolare che
Bruti Liberati dovette firmare per placare la polemica interna. Il quadro è
grave e può avere conseguenze pesanti non solo per i singoli, ma per la stessa
procura. Il capo rischia quantomeno la mancata conferma alla scadenza
dell’incarico, a luglio, se non un’indagine disciplinare. Il suo accusatore,
Robledo, potrebbe essere invece trasferito ad altra sede per incompatibilità
ambientale. La denuncia dell’aggiunto Robledo al Csm in queste settimane ha
portato alle audizioni di tutti i protagonisti dello scontro e ognuno racconta
la sua verità, rivelando scenari contraddittori. Del «cerchio magico» attorno a
Bruti Liberati, per Robledo, fa parte anche l’aggiunto Francesco Greco,
responsabile del pool sui reati finanziari. In questo caso, conteso è uno dei
filoni dell’inchiesta San Raffaele, che per il grande accusatore ha portato a un
ritardo di un anno nell’iscrizione dell’ex governatore della Lombardia, Roberto
Formigoni, nel registro degli indagati. Per Bruti Liberati e Greco, invece,
nessun ritardo: Robledo avrebbe voluto una sorta di spacchettamento
dell’indagine, mentre il fascicolo era assegnato al pm Orsi che si era
trasferito in quel periodo dal pool di Greco a quello di Robledo. Nell’audizione
di Greco si è parlato di una vicenda molto delicata, quella che più di altri
potrebbe prevedere sviluppi disciplinari per Bruti Liberati. É l’inchiesta
Sea-Gamberale e il fatto che il procuratore Capo, come poi da lui stesso
ammesso, avesse dimenticato il fascicolo in cassaforte. Per Greco, che difende
Bruti Liberati, si è trattato di un episodio «incolpevole», ma Robledo insiste
sul contrario. E al Csm la cosa viene valutata comunque come molto preoccupante.
L’ultimo atto dello scontro interno è la controffensiva di Bruti nei riguardi di
Robledo. In una lettera al Csm, che integra le sue dichiarazioni rilasciate a
palazzo de’ Marescialli il 15 aprile, scrive che le iniziative dell’aggiunto
«hanno determinato un reiterato intralcio alle indagini» sull’Expo. In
particolare, racconta che proprio per colpa del collega si è arrivati alla
situazione «surreale» di un doppio pedinamento di un indagato, che avrebbe
rischiato di compromettere l’inchiesta. Tesi accusatoria che Robledo ha
smentito, accusando il Capo di falso: l’episodio del doppio pedinamento - spiega
Robledo in una nota inviata al Csm, a cui ha chiesto anche di essere ascoltato -
non è mai avvenuto. E a sostegno della sua tesi avrebbe fornito una prova
documentale.
Nuovi scandali
e luoghi comuni, scrive Enzo Carra su “Il Tempo”. Non c’è soltanto
una rappresentazione di ordinaria, odiosa criminalità nelle vicende dell’Expo e
in quelle della direttrice Roma-Beirut via Reggio Calabria. C’è purtroppo anche
una nuova ondata di luoghi comuni. Tutto quello che serve a coprire le
responsabilità di quanti, in oltre vent’anni da Mani Pulite, non hanno fatto
abbastanza per bonificare i rapporti tra politica e affari e imporre sobrietà
alla politica. L’elenco ha inizio con la ridicola domanda: questa è, o no, una
nuova Tangentopoli? Ovvio che chi, come Di Pietro, allora era un magistrato
rampante e oggi è un politico declinante rimpianga quel periodo. Altri tempi.
C’è chi, invece, opta per un desolante giudizio sulla perversione dei nostri
tempi: allora si rubava per i partiti, adesso si ruba per sé. I confronti, per
nostra fortuna, non hanno ancora fatto imboccare agli spericolati opinionisti la
scriteriata conclusione che si stava meglio quando si stava peggio. In attesa di
arrivarci (non si sa mai) c’è chi invoca un’altra Mani Pulite. Come se le
Procure italiane avessero ogni tanto bisogno di un evento speciale per
dimostrare la propria efficienza anziché lavorare ogni giorno dell’anno.
L’elenco comprende con il segnalato ritorno dei soliti noti, anche quello dei
partiti che non ci sono più. Così, dirigenti locali della Dc come Frigerio
vengono innalzati al ruolo di parlamentari di quel partito, mentre lo sono
divenuti molti anni dopo, a Dc liquidata da tempo. Dietro il compagno G., come
Greganti, si intravede lo scavo della vecchia talpa leninista ormai in letargo.
Mancavano i socialisti, è vero. La loro assenza è stata tuttavia parzialmente
riscattata dall’apprendere che la signora Matacena è figlia di un esponente
socialista. In tanto discutere si fa però poca attenzione alla domanda più
importante: chi ha rimesso in giro, e soprattutto perché, questi signori?
Inchieste e
scontri di potere, scrive Stefania Craxi, figlia dell’ex premier Bettino, su
“Il Tempo”. Caro direttore. Cui prodest? È questo il quesito che ci poniamo
ogni qualvolta, nel pieno svolgimento di una competizione elettorale, assistiamo
all’ormai abituale catena di arresti eccellenti. La risposta, questa volta, non
solo è di più difficile individuazione ma è meno scontata del previsto. Se il
caso Scajola dimostra ancora una volta l’uso selvaggio e improprio delle misure
cautelari, le vicende che interessano il redivivo "Compagno G" e il mondo di
"Infrastrutture Lombarde" vanno inquadrate in un contesto più ampio e
articolato. Un’attenta lettura di questa vicenda è molto utile per comprendere
in pieno le degenerazioni che interessano una parte della Magistratura da cui
non è certo esente la Procura di Milano. Non bisogna essere dotati di grande
intuito o fantasia per comprendere che talune indagini hanno subito
un’accelerazione fulminea dopo l’esposto al Csm di Alfredo Robledo con il quale
il procuratore aggiunto di Milano accusa senza mezzi termini il capo della
Procura milanese, Edmondo Bruti Liberati, d’irregolarità nell’assegnazione e
nella gestione dei fascicoli, denunciando, di fatto, un’ampia area di
discrezionalità sui casi da perseguire e seguire. Non è questa una banale
contesa sull’organizzazione interna. È uno scontro di potere tra «gruppi» dal
quale emergono fatti inquietanti e si rivelano verità inconfessabili. Uno
scontro in cui cadono i protetti e si spezzano gli equilibri di un sistema che
fa scempio del diritto e della ragione in cui a farne le spese sono sempre e
comunque i cittadini italiani. Un caso isolato? Affatto. Vi sono ormai fin
troppi precedenti di conflitti interni il cui unico fine è l’accrescimento del
potere personale. Eppure, nulla cambia. La riforma della giustizia continua a
essere rinviata a un futuro futuribile senza che nessuno si interroghi sullo
stato e la qualità del nostro sistema democratico, molto più simile ai modelli
sudamericani che non alle liberal democrazie occidentali. Serve invertire la
rotta. E subito. L’ordinamento giudiziario ha bisogno di mutamenti profondi e
radicali. Se non ora, quando? Stefania Craxi.
Robledo vs
Bruti Liberati: le tappe della guerra. Giorno per giorno, frase per
frase, tutte le puntate della guerra interna a Palazzo di Giustizia di Milano,
scrive “Panorama”. Da una parte
Alfredo Robledo, classe 1950, procuratore aggiunto di Milano, massimo esperto di
inchieste su politica e corruzione e legato a Magistratura indipendente
(corrente di centrodestra). Dall’altra, Edmondo Bruti Liberati, classe 1944,
Procuratore capo del tribunale di Milano vicino a Magistratura Democratica
(corrente di centrosinistra). Al centro il Tribunale di Milano e le sue
inchieste. ecco, passo dopo passo, le tappe della vicenda e della guerra tra i
due:
- venerdì 14 marzo 2014.
Robledo invia una lettera (11 pagine) al vicepresidente del Csm, Vietti. al
presidente del Consiglio distrettuale milanese, Giovanni Canzio e al Capo della
Procura generale di Milano, Manlio Minale, nella quale accusa il procuratore
capo del Tribunale di Milano di aver turbato“la regolarità e la normale
conduzione dell’ufficio”nella gestione delle inchieste più scottanti. Robledo va
giù pesante contro il suo capo ritenendolo responsabile di “violazione dei
criteri di organizzazione vigenti nell’ufficio sulla competenza interna” e lo
definisce “garante di una serie di equilibri politici” favorendo i colleghi Ilda
Boccassini e Francesco Greco.
- mercoledì 19 marzo 2014.
Viene alla luce una lettera del protocollo riservato nella quale Bruti Liberati
ammette che un fascicolo del 2011 sull’inchiesta che vedeva Vito Gamberale
accusato di turbativa d’asta, era rimasto in un cassetto“per sua deplorevole
dimenticanza”. Non solo, l’inchiesta, invece di finire per competenza sulla
scrivania di Robledo, viene assegnata al capo del pool dei reati finanziari,
Francesco Greco che lo gira al pm Fusco e che, a sua volta, fa notare a Bruti
Liberati che sarebbe stato meglio assegnarlo a Robledo.
- giovedì 20 marzo 2014.
Robledo apre il coperchio alla nuova Tangentopoli milanese legata all’Expo. A
finire in manette sono Antonio Giulio Rognoni, direttore generale di
Infrastrutture Lombarde, e molto vicino al Roberto Formigoni, e altre sette
persone. Era questa una delle inchieste a cui faceva riferimento Robledo nella
lettera con la quale accusava Bruti Liberati. Lo scontro tra i due magistrati
sembra passare in secondo piano vista l’importanza della vicenda o addirittura
rientrare e per qualche giorno i due si ignorano.
- venerdì 28 marzo 2014.
La procura di Brescia decide di aprire un fascicolo per calunnia ipotizzando una
manovra “orchestrata” per screditare Robledo.
- martedì 15 aprile 2014.
I due magistrati vengono ascoltati al Palazzo dei Marescialli a Roma. Le due
audizioni sono un susseguirsi di accuse e contro accuse senza esclusione di
colpi. Robledo: “Non ho nessun motivo personale nei suoi confronti, ma siamo
arrivati a un punto limite, oltre il quale non è più possibile andare”. Bruti
Liberati: “Sia ben chiaro che io lezioni sull'obbligatorietà dell'azione
penale non le prendo”. Nel corso dell’audizione davanti al Csm emerge che
anche l’assegnazione dell’inchiesta di Ruby non doveva essere affidata alla
Boccassini e a sostenerlo è il presidente del Tribunale di Milano, Manlio
Minale: “Il procuratore aggiunto del pool antimafia
cosa c'entra? Non aveva titolarità”.
- mercoledì 7 maggio 2014.
Robledo non si presenta alla conferenza stampa, nonostante un suo magistrato
abbia seguito le indagini. Bruti Liberati dichiara: “l'indagine non è firmata
anche da lui in quanto non ha condiviso l'impostazione: per questa ragione non è
qui con noi”. Robledo risponde che Bruti Liberati non lo ha messo nella
condizione di fare una valutazione sulla posizione di un indagato:
“Ogni volta che bisogna prendere un'iniziativa di indagine
bisogna avvertirlo prima e lui deve dare il consenso di tutto, anche di stralci
e così via”.
- lunedì 12 maggio 2014.
Bruti Liberati invia un esposto al Csm accusando Robledo di aver “determinato
un reiterato intralcio alle indagini sull’Expo”. Al centro dell’accusa c’è
un doppio pedinamento nei confronti di un indagato: “Robledo pur essendo
costantemente informato del fatto che era in corso un'attività di pedinamento e
controllo su uno degli indagati svolta da personale della polizia giudiziaria,
ha disposto, analogo servizio delegando ad altra struttura della stessa Guardia
di Finanza”.
- mercoledì 14 maggio 2014.
Robledo che controattacca rispondendo al Csm: “Bruti Liberati dice il falso,
ne ho le prove”. In effetti la Guardia di Finanza con un rapporto ufficiale
conferma la tesi di Robledo spiegando che "non si sono
registrati episodi di sovrapposizione operativa con altro personale di Polizia
Giudiziaria presso la Procura di Milano".
Procura
Milano, tutti contro tutti. Guerra Bruti Liberati-Robledo. Nuovo clamoroso
scontro nella Procura di Milano. Il procuratore capo Edmondo Bruti Liberati al
Csm: da Robledo reiterato intralcio alle indagini. La risposta del pm: tutto
falso, voglio essere sentito. Intanto l'Antimafia attacca Ilda Boccassini: "Con
il suo arrivo i rapporti sono peggiorati", scrive “Affari Italiani”. "Le
iniziative del procuratore aggiunto Robledo hanno determinato un reiterato
intralcio alle indagini" sull'Expo. Lo scrive il procuratore capo di Milano
Edmondo Bruti Liberati in una nota trasmessa ieri al Csm. Bruti Liberati, in
particolare, ricorda la "prospettazione di stralcio", avanzata da Robledo e da
lui esclusa, che "non solo avrebbe fatto perdere la unitarietà di visione in
questa vicenda specifica, ma avrebbe comportato sicuro intralcio e ritardo alle
indagini". Inoltre, la trasmissione, da parte di Robledo, al Csm "di copie di
corrispondenza interna riservata e di copie di atti del procedimento in
delicatissima fase di indagine, con assunzione arbitraria della decisione delle
parti da segretare, ha posto - scrive Bruti a Palazzo dei Marescialli - a grave
rischio il segreto delle indagini". Il capo della Procura di Milano riferisce
anche un'"ultima surreale situazione" avvenuta nell'ambito dell'inchiesta Expo:
"Robledo - spiega Bruti - pur essendo costantemente informato del fatto che era
in corso una attività di pedinamento e controllo su uno degli indagati", svolta
da "personale della sezione di Polizia giudiziaria", ha "disposto analogo
servizio delegando ad altra struttura della stessa Gdf". Solo "la reciproca
conoscenza del personale Gdf che si è incontrato sul terreno - osserva Bruti -
ha consentito di evitare gravi danni alle indagini". Con la sua nota inviata a
Palazzo dei Marescialli, Bruti Liberati integra quanto esposto nell'audizione al
Csm dell'aprile 2014 scorso. Dopo gli arresti avvenuti negli scorsi giorni, sono
infatti venuti meno i segreti istruttori che non avevano permesso al capo della
procura milanese di essere più preciso davanti all'organo di autogoverno della
magistratura. La richiesta di misura cautelare diretta al gip nell'ambito
dell'inchiesta Expo "fu vistata dal procuratore aggiunto Boccassini", ricorda
Bruti, e Robledo "da me personalmente interpellato - aggiunge il procuratore
capo - mi disse che dissentiva in ordine ad alcune contestazioni di reato
relative all'indagato Paris e che non intendeva apporre il visto". Dunque,
"ritenevo - spiega Bruti Liberati - anche ad evitare una delegittimazione dei
sostituti, di apporre anche il mio visto sulla richiesta" che poi è stata
"accolta dal gip sui punti non condivisi dal procuratore aggiunto Robledo".
Quest'ultimo, "pur continuando ad essere costantemente informato di tutti gli
sviluppi ulteriori delle indagini ai fini del coordinamento in atto - conclude
Bruti - si era sottratto alla fase del procedimento cautelare e pertanto non gli
fu sottoposto al visto la successiva integrazione della richiesta al gip". Bruti
Liberati, infine, auspica una "sollecita definizione della vicenda" scaturita
dall'esposto di Robledo, "consentendo alla Procura della Repubblica di Milano di
svolgere il suo difficile compito in un clima di normalità, fuori dai riflettori
sul preteso scontro nella Procura di Milano". Con una nota inviata al Csm, il
procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo risponde alle accuse del
procuratore capo Edmondo Bruti Liberati secondo il quale avrebbe "determinato un
reiterato intralcio alle indagini" sull'Expo. Nella nota, Robledo afferma che
l'episodio del doppio pedinamento, di cui ha parlato Bruti, non è mai avvenuto
e, a sostegno della sua tesi, fornisce una prova documentale all'organo di
autogoverno della magistratura. Alfredo Robledo chiede di essere sentito dal Csm
in merito alle accuse che gli ha rivolto il procuratore di Milano Edmondo Bruti
Liberati in una nota inviata all'organo di autogoverno della magistratura, nella
quale lo accusa di avere intralciato le indagini su Expo. Bruti Liberati aveva
citato anche l'episodio di un presunto doppio pedinamento che avrebbe potuto
compromettere l'inchiesta. E' stata "anomala" l'assegnazione dell'inchiesta Ruby
al procuratore aggiunto Ilda Boccassini, "palesemente estranea" a quel tipo di
inchiesta. Questo, secondo quanto si è appreso, è uno dei passaggi
dell'audizione del pm di Milano, Ferdinando Pomarici, sentito oggi al Csm
nell'ambito della pratica avviata dalla prima e dalla settima commissione a
seguito dell'esposto con cui l'aggiunto Alfredo Robledo ha denunciato presunte
irregolarità nell'assegnazione dei fascicoli da parte del capo della Procura,
Edmondo Bruti Liberati. Pomarici è stato sentito per circa un'ora a palazzo dei
Marescialli: davanti alle commissioni, riunite in seduta congiunta, ha ricordato
di aver segnalato questi punti critici già in una lettera che aveva indirizzato
proprio a Bruti Liberati. "Di tutto ha bisogno il sistema giudiziario, tranne
che di delegittimazioni". Lo ha dichiarato il vicepresidente del Csm, Michele
Vietti, poco prima del plenum con il guardasigilli Orlando, affrontando la
questione dello scontro alla Procura di Milano. "Il Csm se ne sta occupando - ha
aggiunto - quindi non entro nel merito, ma mi auguro che le commissioni arrivino
ad una conclusione rapidissima dell'istruttoria e che si possa arrivare al
plenum con una decisione definitiva". C'è una "tradizione di difficili rapporti
tra la Dna e la Dda" di Milano, e con l'arrivo del procuratore aggiunto, Ilda
Boccassini, alla guida del pool antimafia milanese, c'è stato un "arretramento".
E' quanto emerge dall'audizione svolta la scorsa settimana al Csm del pm della
Direzione Nazionale Antimafia, Filippo Spiezia, che fino all'ottobre 2013 è
stato magistrato di collegamento tra la Dna e la Direzione Distrettuale
Antimafia milanese. "Col passaggio di consegne - ha detto Spiezia al Csm - la
dottoressa Canepa (il magistrato che prima di Spiezia svolgeva il coordinamento
con la Dda milanese, e che oggi è tornata a svolgere tale ruolo, ndr) mi mette a
disposizione tutto il suo patrimonio conoscitivo riguardante i rapporti con
Milano, scrive nel suo resoconto che la dottoressa Boccassini ha manifestato
perplessità connesse a ragioni di sicurezza e riservatezza in relazione
all'implementazione della banca dati nazionali, quindi in questo la collega
Canepa rilevava un arretramento rispetto alla posizione del dottor Pomarici
(l'aggiunto che era a capo della Dda di Milano prima di Ilda Boccassini, ndr)
che invece riteneva che la Banca Dati Nazionale venisse implementata con gli
atti dei procedimenti in corso". Tale dato, aggiunge Spiezia, "io poi l'ho
riscontrato nella pratica" e "si è riflesso poi nel livello qualitativo e
quantitativo degli atti trasfusi nella Banca dati nazionale". Nel corso del suo
mandato come magistrato di collegamento con la Dda di Milano, Spiezia afferma di
non aver registrato alcun "cambiamento di rotta", ma "addirittura c'è stato un
aggravamento rispetto ai dati che aveva registrato la dottoressa Canepa". Un
"bilancio assolutamente negativo", sottolinea Spiezia nelle sue audizioni,
riguarda il rilevamento della situazione sulle cosiddette "iscrizioni multiple":
"nel 2013 - osserva il magistrato della Dna - sono state inviate fino all'epoca
in cui mi sono occupato di questi rapporti, 49 segnalazioni di iscrizioni
multiple ricevendo zero risposte". "Ci sono difficoltà che il Csm sta
affrontando. Attendo il lavoro del Csm". Così il guardasigilli Andrea Orlando,
al termine del plenum al Palazzo dei Marescialli, ha risposto ai cronisti in
merito alla richiesta, avanzata dal togato Antonello Racanelli, di valutare
l'invio degli ispettori alla Procura di Milano. E poi: "Non considero che
diverse opinioni nella Procura di Milano abbiano compromesso l'imparzialità". "I
fatti vanno analizzati - ha aggiunto il ministro - il sistema prescinde da
potenziali conflittualità. Anche alla luce dell'inchiesta Expo, non bisogna
pensare che venga meno il ruolo e la funzione che la Procura di Milano ha
effettuato e continua a svolgere".
Procura di
Milano, alla fine per lo scontro pagherà solo Robledo. La Procura generale della
Cassazione chiede al Csm di rimuovere il procuratore aggiunto: contro di lui le
intercettazioni con l'avvocato della Lega Nord, scrive Luca Fazzo su “Il
Giornale”. Poteva finire con un nulla di fatto, con entrambi i contendenti
lasciati in qualche modo al loro posto; poteva finire con la cacciata di
entrambi i contendenti, e con l'azzeramento di fatto del gruppo dirigente della
Procura; e invece con un colpo di scena la faida interna al palazzo di giustizia
milanese sembra avviata a risolversi con la sconfitta piena solo di Alfredo
Robledo, il procuratore aggiunto che con il suo esposto al Consiglio superiore
della magistratura aveva sollevato nel marzo dello scorso anno il caso delle
presunte irregolarità nella gestione da parte del procuratore capo Edmondo Bruti
Liberati praticamente di tutte le inchieste più delicate. Nei confronti di
Robledo, il procuratore generale della Cassazione ha fatto partire nei giorni
scorsi una richiesta eccezionale: trasferimento immediato in via cautelare, di
fatto l'allontanamento dall'ufficio e il trasferimento a un altro incarico.
Tecnicamente, le accuse che potrebbero portare al defenestramento di Robledo non
sono collegate ai temi sollevati nel suo esposto, e di cui si è molto discusso
in questi mesi. La richiesta di rimozione del magistrato viene motivata dal pg
con una serie di intercettazioni che arrivano dall'altro capo d'Italia, ovvero
dalla indagine che la procura di Reggio Calabria sta svolgendo sui contatti tra
alcuni esponenti della Lega Nord e il mondo della criminalità organizzata: è
l'indagine che ha portato all'incriminazione dell'ex tesoriere del Carroccio,
Belsito, accusato di avere utilizzato canali contigui alla 'ndrangheta per
spostare e investire all'estero parte dei fondi del partito. Nell'ambito di
quella inchiesta è stato intercettato anche l'avvocato di fiducia dei vertici
leghisti, Domenico Aiello, e così la Dia ha registrato una serie di contatti
telefonici tra il legale e Robledo, all'epoca titolare delle indagini sui
finanziamenti pubblici al partito di Bossi. Contatti che indicano una certa
confidenza tra i due, e nei quali Robledo sembra garantire a Aiello che
l'inchiesta sarebbe stata condotta anche a carico di esponenti di altri partiti.
Ma è evidente che le notizie provenienti da Reggio Calabria hanno finito col
fare parte a pieno titolo dello scontro senza precedenti in corso alla Procura
di Milano, dove Robledo accusava Bruti di avere forzato la mano per affidare
tutte le inchieste con risvolti politici (dal San Raffaele a Ruby alla
Serravalle a Expo) solo a pm di sua fiducia, aggirando le norme interne
all'ufficio e le competenze dei diversi dipartimenti. Lo stesso consiglio
giudiziario di Milano, l'organismo locale di autogoverno della magistratura, ha
stigmatizzato questo comportamento di Bruti. Ma sia il procuratore capo che
Robledo (accusato da Bruti di interferenze e comportamenti irregolari) erano
usciti incolumi dalle azioni disciplinari avviate dal Csm. E la settimana scorsa
aveva preso quota la ipotesi di una soluzione ponte, con Robledo parcheggiato in
un'altra procura in attesa del pensionamento di Bruti. Invece stamane a sorpresa
dal Csm arriva la notizia della richiesta di rimozione immediata di Robledo
avanzat dal pg della Cassazione, Ciani. Una richiesta che verrà esaminata dal
Csm in tempi brevissimi, e che se dovesse venire accolta segnerebbe una vittoria
per ko di Bruti e del suo schieramento nello scontro con Robledo.
Milano, altri
guai per il pm Alfredo Robledo: "Ha favorito l'avvocato della Lega Nord". Il pg
della Cassazione contro l'aggiunto di Milano, già al centro di uno scontro con
il procuratore capo Bruti Liberati. Il motivo sono le intercettazioni di
un'inchiesta antimafia rivelate da l'Espresso. Secondo l'accusa il legale girava
a Roberto Maroni e Matteo Salvini le notizie ottenute dal magistrato che
indagava su Belsito, scrive Paolo Biondani “L’Espresso”. Alfredo Robledo Il
procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo, rischia il posto per i suoi
rapporti telefonici con l'avvocato della Lega, Domenico Aiello. Un caso
giudiziario nato da una serie di intercettazioni della procura antimafia di
Reggio Calabria e rivelato per la prima volta il 25 ottobre scorso da un
articolo de “l'Espresso” . Robledo è il magistrato che da mesi è protagonista di
uno scontro senza precedenti con il suo procuratore capo, Edmondo Bruti
Liberati. Oggi il procuratore generale della Cassazione, Gianfranco Ciani,
titolare dell'azione disciplinare, ha depositato al Csm una richiesta di
trasferimento d'ufficio a carico di Robledo, chiedendo che venga decisa
d'urgenza, come misura cautelare. Secondo l'accusa, Robledo dovrebbe non solo
cambiare città, ma addirittura perdere le funzioni di pubblico ministero. Il
vice-presidente del Csm, Giovanni Legnini, ha già fissato un'apposita udienza
della sezione disciplinare, che è chiamata a pronunciarsi il 5 febbraio. Il
trasferimento forzato di Robledo consacrerebbe la vittoria di Bruti Liberati
nella scontro con il suo aggiunto, che è già stato rimosso dall'incarico di
coordinatore delle indagini milanesi sui reati collegati alla corruzione. Il Csm
e lo stesso pg della Cassazione, però, devono ancora pronunciarsi sugli altri
capitoli ancora aperti della disfida tra toghe che ha spaccato la procura di
Milano. A Robledo vengono contestati i rapporti amichevoli con Domenico Aiello,
il penalista di fiducia di Roberto Maroni, diventato l'avvocato della Lega dopo
lo scandalo dei finanziamenti pubblici sottratti dall'ex tesoriere Belsito, che
ha coinvolto anche Umberto Bossi favorendo il cambio della guardia al vertice
del partito. Quell'inchiesta era diretta proprio da Robledo. Tra il 2012 e il
2013, mentre era ancora in corso l'indagine milanese sui soldi della Lega, la
procura reggina ha intercettato l'avvocato Aiello per tutt'altri motivi: il
professionista, che è di origine calabrese, risultava in contatto con
imprenditori sospettati di collusioni con la 'ndrangheta. Quella procura
antimafia ha così intercettato anche Robledo, ma solo indirettamente, perché era
in contatto con l'avvocato Aiello. Anche i parlamentari leghisti sono stati
intercettati solo indirettamente: sotto controllo c'era solo il telefonino
Aiello. Nella primavera del 2013 la procura di Reggio Calabria ha trasmesso un
faldone di intercettazioni ai pm di Brescia, competenti a indagare sui
magistrati di Milano, ipotizzando che Robledo avesse rivelato all'avvocato della
Lega notizie riservate sulle proprie indagini. Dopo un anno di accertamenti, i
pm bresciani Fabio Salamone e Paolo Savio hanno chiesto l'archiviazione di tutte
le accuse a carico di Robledo. Secondo i due magistrati competenti, quelle
comunicazioni tra Robledo e Aiello non hanno rilevanza penale: non ci sono i
presupposti per accusare il pm milanese, in particolare, di ipotetiche
violazioni del segreto istruttorio. Nelle motivazioni della loro richiesta, gli
stessi pm bresciani precisano però che l'archiviazione riguarda solo la vicenda
penale, «al di là di ogni valutazione sull'opportunità di frequenti contatti»
tra magistrato e avvocato «per ragioni non sempre strettamente correlate con le
rispettive qualità». Ora il pg della Cassazione, che invece rappresenta l'accusa
nei procedimenti disciplinari e può occuparsi anche di vicende personali che non
costituiscono reato, ha riletto gli stessi atti dell'indagine bresciana
ipotizzando, come precisa l'agenzia Ansa, uno «scambio di favori»: un
comportamento penalmente irrilevante, ma considerato inopportuno per un
magistrato. Sotto accusa, in particolare, ci sono alcuni sms inviati da Robledo
ad Aiello, e da quest'ultimo a parlamentari della Lega come Maroni, Salvini e
Speroni, mentre era ancora in corso l'inchiesta milanese sul caso Belsito. Il 28
dicembre 2012, ad esempio, Aiello manda a Maroni un sms che allude a una
riunione dei pm milanesi: «Finita riunione in Procura con capo e agg. Domani
sera mi daranno altri nominativi ns consiglieri indagati. Hanno intercettazioni
gravi contro Pdl, mentre su di noi pare ci sia una impiegata gola profonda».
Nello stesso periodo l'avvocato Aiello telefona anche all'attuale leader
leghista Matteo Salvini, sostenendo che Robledo gli avrebbe promesso di spedire,
prima delle elezioni del 2013, «gli stessi avvisi a Pd, Idv e Pensionati. (…) Mi
ha detto: “Domenico, te lo garantisco, ci puoi spendere la tua credibilità”».
Quando l'inchiesta milanese sui rimborsi-truffa coinvolge effettivamente anche
gli altri partiti, l'avvocato della Lega scrive un sms di ringraziamento al pm
milanese: «Uomo di parola! Poi grande magistrato!». E Robledo gli risponde con
una citazione in latino che sembra confermare una promessa: «Caro avvocato,
promissio boni viri est obligatio!». Esaminate tutte le intercettazioni, i
magistrati bresciani hanno concluso che va giudicato «assolutamente
comprensibile» che l'avvocato della Lega si preoccupi di informarsi sulla
posizione degli indagati della proprio parte politica. Quanto alle notizie sugli
altri partiti, Robledo si sarebbe limitato a fornirgli una «generica
informazione che l'indagine avrebbe riguardato in tempi brevi anche
l'opposizione», senza però rivelargli segreti investigativi. Ora però il pg
della Cassazione rilancia l'accusa, sostenendo che Robledo, il 18 dicembre 2012,
avrebbe anticipato ad Aiello almeno una notizia molto precisa, e cioè che la sua
inchiesta stava per coinvolgere altri 7-8 consiglieri regionali. Cosa
effettivamente successa il giorno dopo. Sotto accusa, sempre sul piano
disciplinare, c'è anche una serie di telefonate in cui Robledo avrebbe suggerito
ad Aiello di chiedere copia di una consulenza tecnica a carico della Lega, che
era stata anticipata nel febbraio 2013 da “l'Espresso”. Quando poi Aiello si
vide negare quei documenti integrali, Robledo, sempre secondo il pg della
Cassazione, avrebbe scaricato la colpa sul procuratore capo, Bruti Liberati. Da
altre telefonate, sempre secondo la ricostruzione dei pm bresciani, risulta
«evidente che Robledo si sia avvalso dell'aiuto del legale per intervenire nella
procedura dinanzi la Commissione europea» che lo vedeva contrapposto all'ex
sindaco di Milano, Gabriele Albertini, mentre quest'ultimo si era candidato alle
regionali in Lombardia contro Maroni. Nei mesi precedenti, Albertini aveva
accusato il pm milanese di aver condotto indagini illegali sui derivati
finanziari acquistati dal Comune di Milano. Contro-denunciato da Robledo, l'ex
sindaco, che rivestiva la carica di europarlamentare di Forza Italia, aveva
chiesto l'immunità politica, che però gli è stata negata. Di questo caso si era
occupata la stessa procura di Brescia, che alla fine ha chiesto di processare
proprio Albertini per calunnia ai danni di Robledo. In quel contesto, nelle sue
conversazioni con l'avvocato Aiello, Robledo chiedeva «solo che la mia lettera
vada alla Commissione, che prenda atto che questo ha detto balle totali». Ora
però il pg della Cassazione sostiene che Robledo, per poter preparare la sua
lettera, avrebbe ricevuto dall'avvocato Aiello una serie di documenti,
presentati da Albertini al Parlamento europeo per ottenere l'immunità, che
andrebbero considerati «non pubblici». Aiello glieli avrebbe fatti arrivare per
email. Nell'indagine bresciana erano finite anche alcune intercettazioni,
registrate sempre dai pm antimafia calabresi, delle telefonate tra Aiello e il
pm milanese Eugenio Fusco, titolare di un'inchiesta sul gruppo Finmeccanica che
sembrava poter coinvolgere anche la Lega. Ma i magistrati bresciani hanno
concluso che queste conversazioni, oltre a essere penalmente irrilevanti,
«rientrano nella prassi comune dei contatti tra pm e difensori».
Sull'archiviazione dell'inchiesta penale su Robledo, l'ultima parola spetterà ai
giudici bresciani. Ma ora il procuratore aggiunto rischia di essere allontanato
da Milano con un trasferimento disciplinare che potrebbe segnare la fine della
lunga stagione dei veleni in procura.
Quel filo
segreto tra la Lega e Robledo.
Il pm di Milano intercettato al telefono con l’avvocato di Maroni. L’antimafia
lo denuncia. E l’indagine finisce a Brescia, scrive Paolo Biondani su
“L’Espresso”. Da una parte c’è il procuratore aggiunto di Milano, Alfredo
Robledo, che in quei giorni sta indagando sui presunti ladroni del cerchio
magico di Umberto Bossi. All’altro capo del telefono c’è l’avvocato Domenico
Aiello, che dopo aver difeso Roberto Maroni sta diventando, proprio per effetto
di quel terremoto giudiziario, il penalista di fiducia dell’intero partito
padano. E in mezzo, ad ascoltare tutto, ci sono i carabinieri di una procura
antimafia del Sud Italia. Che non si aspettavano certo di dover registrare dei
colloqui riservati tra il pm anti-Lega e l’avvocato della Lega. Su questo strano
cortocircuito tra giustizia e politica sta indagando da circa un anno la Procura
di Brescia. Un’inchiesta riservatissima, che per il pm Robledo era iniziata
molto male. L’alto magistrato, almeno fino a pochi giorni fa, risultava ancora
indagato, a quanto pare per un’ipotetica violazione del segreto istruttorio. Ma
in questi mesi i pubblici ministeri bresciani hanno ormai approfondito il caso,
che sembra essersi ridimensionato. E ora a Brescia, dove nel frattempo il nuovo
procuratore Tommaso Buonanno ha scalzato lo storico pm Fabio Salamone, i
magistrati sarebbero orientati a chiedere l’archiviazione. Il verdetto finale
comunque spetterà ai giudici delle indagini e fino ad allora Robledo resterà,
suo malgrado, formalmente inquisito. Proprio come il suo grande nemico, il
procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati, a sua volta sospettato di
omissione di atti d’ufficio, per un’inchiesta sulla Sea dimenticata in
cassaforte e rivendicata da Robledo dopo un articolo de “l’Espresso”. La nuova
indagine bresciana non c’entra nulla con il feroce scontro tra Robledo e Bruti:
è invece uno spezzone di un’istruttoria altrui, molto più ampia e ancora
segreta. Si sa soltanto che una procura antimafia, per ricostruire le trame di
un colletto bianco, ha intercettato (come sempre) tutti i suoi interlocutori,
imbattendosi per caso in Aiello. E così, tra il 2012 e il 2013, per qualche
tempo finisce sotto controllo pure il telefonino dell’avvocato. Che, a sorpresa,
si sente più volte con Robledo. I carabinieri annotano. E nella primavera 2013
la loro procura manda a Brescia due denunce di reato. Il tenore delle
intercettazioni ha convinto quella procura antimafia che il pm Robledo e
l’avvocato Aiello stiano orchestrando manovre per colpire l’ex sindaco di
Milano, Gabriele Albertini. Che è un rivale politico: proprio in quei mesi si è
candidato contro Maroni in Lombardia. Altre telefonate fanno temere che il
magistrato possa avere anticipato all’avvocato qualche notizia riservata della
sua inchiesta sui presunti rimborsi-truffa incassati da altri partiti. Di qui la
trasmissione al Nord delle intercettazioni. A Brescia però, per fortuna di
Robledo, i pm sono in grado di ricostruire un quadro più completo. Albertini,
infatti, è già indagato (e oggi rischia il processo) con l’accusa di calunnia
proprio ai danni del magistrato milanese: era lui che tentava di screditarlo.
Denunciato da Robledo, l’ex sindaco cercava di avere l’immunità dal parlamento
europeo, che poi lo ha bocciato. In quelle telefonate Robledo non nasconde
l’antipatia per Albertini, ma cerca solo di d’informarsi se la Lega a Bruxelles
voterà a suo favore. Mentre per i rimborsi, all’avvocato che gli contesta di
perseguitare solo la Lega, il pm ribatte che indagherà su tutti i partiti, come
poi succederà, ma senza fornirgli particolari segreti. In attesa che i giudici
bresciani tirino le somme, certo è che il pm e l’avvocato non parlavano di altre
indagini che avrebbero potuto interessare entrambi. Nel 2010, quando è diventato
il difensore di Maroni, Aiello guidava il ramo penale dello studio
internazionale “Dla Piper”, dove a gestire il settore degli appalti era
l’avvocata Giorgia Romitelli. Che nel marzo 2014, su richiesta di Robledo, è
finita agli arresti domiciliari nell’inchiesta che ha decapitato Infrastrutture
Lombarde, la centrale regionale delle grandi opere.
Robledo
chiede alla Finanza di aiutarlo a incastrare Bruti.
Caos a Milano,
l'aggiunto scrive al Csm e controaccusa il suo capo: "Su Expo dice il falso, ho
le prove". E allega una relazione della GdF, scrive Anna Maria Greco su “Il
Giornale”. Alfredo Robledo non ci sta. Reagisce con durezza alle controaccuse
del procuratore di Milano, Bruti Liberati, e scrive una nota al Csm, accusandolo
di aver detto il «falso» e chiedendo di essere ascoltato per replicare. «Sono
radicalmente inventate e prive di qualunque fondamento - tuona - le affermazioni
su Expo». E da Magistratura indipendente arriva l'appello al Guardasigilli
Andrea Orlando: si mandino gli ispettori alla Procura di Milano. Raccontano che
l'aggiunto abbia dato in escandescenze martedì, quando ha saputo che nella
lettera mandata al Csm il suo capo denunciasse l'episodio, definito «surreale»,
del doppio pedinamento di un indagato, che l'aggiunto avrebbe disposto
rischiando di far saltare le indagini sull'Expo 2015. No, Robledo non ci sta e
ha richiesto urgentemente alla Guardia di finanza una dettagliata relazione,
allegata alla nota di due pagine inviata al Csm, per confutare la ricostruzione
del suo capo. Una ricostruzione che tenta di presentare lui, il grande
accusatore di irregolarità e violazioni nel Palazzo di giustizia milanese, come
il colpevole di iniziative che hanno portato «grave intralcio» ad importanti
inchieste. Ma Robledo fa una smentita a tutto campo. E con toni durissimi: «Le
inveritiere affermazioni del procuratore» di Milano Edmondo Bruti Liberati -
scrive - sul presunto "doppio pedinamento" (nelle indagini su Expo, ndr)
appaiono altamente lesive della dignità della funzione di procuratore aggiunto,
coordinatore del dipartimento dei reati contro la pubblica amministrazione che
attualmente svolgo, e turba «il regolare svolgimento della funzione». Uno
scontro senza precedenti. Nella sua lettera al Csm, resa nota martedì, Bruti
contesta il fatto che l'aggiunto (il quale polemicamente non ha firmato le 7
richieste d'arresto per l'inchiesta Expo, sostenendo che gli sarebbe stato
impedito di valutare compiutamente i fatti, «in violazione della normativa») non
sia stato tenuto al corrente delle indagini. Nate, secondo il capo, nella
Direzione antimafia guidata da Ilda Boccassini e coassegnate al Dipartimento sui
reati contro la pubblica amministrazione, di cui Robledo è responsabile. Come
esempio dei danni che l'aggiunto avrebbe causato, mettendosi di traverso alla
sua gestione della procura, il capo parla della vicenda del doppio pedinamento.
Contro il suo aggiunto ribelle Bruti denuncia molto altro, sostenendo di non
aver potuto dire tutto nell'audizione a Roma del 15 aprile, perché allora
l'indagine sull'Expo era ancora coperta dal segreto. Il procuratore sostiene
infatti che, inviando il mese scorso al Csm copie di atti di questo
procedimento, ancora «in delicatissima fase di indagine», Robledo «ha posto a
grave rischio il segreto delle indagini». Ma l'aggiunto controbatte, su tutta la
linea. Palazzo de' Marescialli deve ora valutare la fondatezza delle accuse di
Robledo e delle controaccuse di Bruti Liberati. Per il primo, il procuratore
avrebbe affidato troppe inchieste politicamente delicate (a cominciare da quella
Ruby) a pm come la Boccassini e Francesco Greco, non per competenza ma perché li
riteneva più fidati. Da notare, che Bruti Liberati è uno degli storici esponenti
della corrente di sinistra Magistratura democratica, mentre Robledo è vicino a
Magistratura indipendente. E proprio da Magistratura indipendente è arrivata la
richiesta di un'ispezione. A farla il togato Antonello Racanelli, nel corso del
plenum del Csm alla presenza del Guardasigilli Andrea Orlando. Il ministro ha
replicato dicendo di attendere le decisioni del Csm per decidere. «Il quadro
ormai è chiaro - racconta un consigliere di una delle commissioni interessate,
la prima (incompatibilità ambientale e funzionale) e la settima (organizzazione
degli uffici) - non ci dovrebbero essere altre audizioni». Il procuratore capo
Bruti, che a luglio termina il suo incarico, dopo questo scontro clamoroso
difficilmente potrà essere confermato alla guida dell'ufficio di Milano. Ma per
lui, anche se la vicenda al Csm si chiude senza conseguenze, potrebbe profilarsi
un'indagine disciplinare. In particolare, sulla vicenda del fascicolo
Sea-Gamberale, dimenticato dal procuratore in cassaforte, come lui stesso ha
ammesso. Ma anche per il suo vice Robledo potrebbero esserci conseguenze, perché
anche se il suo comportamento fosse ritenuto «incolpevole», ci potrebbe essere
all'orizzonte un trasferimento per incompatibilità con i colleghi dell'ufficio.
Ed ancora.
«Incompatibilità ambientale» Via da Milano il pm Esposito, scrive Luigi
Ferrarella su “Il Corriere della Sera”. Stop come pm e via dalla Procura di
Milano: la sezione disciplinare del Csm ha deciso in via cautelare il
trasferimento a Torino di Ferdinando Esposito per «incompatibilità ambientale»
(con la sede giudiziaria di Milano) e «funzionale» (con il ruolo inquirente) del
pm della Procura di Milano, nipote dell?ex procuratore generale della Cassazione
(Vitaliano) e figlio del magistrato (Antonio) che in Cassazione nell?estate 2013
presiedette il collegio di 5 giudici che condannarono Silvio Berlusconi per
frode fiscale Mediaset. Tra i capi di «incolpazione» disciplinare (per cui ora
proseguirà il procedimento di merito) c?erano la disponibilità per quasi 4 anni
di un attico per il quale circa 150.000 euro di affitto furono saldati dalla
società di un manager e da un banchiere all?epoca inquisito dalla Procura di
Milano; i rapporti con l?avvocato ed ex amico Michele Morenghi, per i quali il
pm è al momento indagato a Brescia; prestiti di denaro da più persone, tra le
quali un consulente proposto a un collega pm; e la storia del bigliettino dato
durante le indagini a questo collega pm per chiedergli «inventiamoci qualcosa?è
una cazzata ma è importante che le versioni coincidano». Esposito impugnerà il
trasferimento cautelare disciplinare alle Sezioni Unite civili della Cassazione.
«Non si può fare l’ayatollah dell’Antimafia», scrive “Tempi”. «A vent’anni di
distanza si deve prendere atto che è una vera illusione affidare alla
magistratura le leve del cambiamento». Parola di Giovanni Fiandaca, giurista,
candidato Pd alle Europee 2014. «Non si può fare l’ayatollah dell’Antimafia»,
dice oggi al Corriere della Sera Giovanni Fiandaca. Giurista palermitano,
celebrato trai maggiori esperti di diritto penale, Fiandaca correrà nelle liste
del Pd per le Europee. Il fatto è di straordinario interesse, soprattutto perché
segnala che, anche a sinistra, qualcosa si muove nel campo di chi non ne può più
di una politica asservita alla magistratura. Il fatto che poi Fiandaca sia un ex
membro del Csm, maestro di Antonio Ingroia, uno dei penalisti di riferimento
della sinistra, non fa altro che aumentare l’interesse per questa candidatura
(molto osteggiata infatti dalle parti di Travaglio e manettari affini). Nei mesi
scorsi, l’ordinario di Diritto Penale all’università palermitana ha avuto parole
molto nette sia sulla trattativa Stato-Mafia sia sul suo allievo Ingroia che ha
pesantemente criticato. Ma Fiandaca ha fatto anche un discorso di più ampio
respiro sulla situazione della giustizia in Italia, coinvolgendo nelle critiche
anche il mondo dell’informazione per la “drammatizzazione” eccessiva con cui si
sofferma su indagini e processi solo per attizzare gli istinti più bassi e
forcaioli. Al Corriere, dunque, Fiandaca spiega che l’Antimafia oggi va
ripensata perché «nessuno può arrogarsi il diritto di decretare cosa è Antimafia
autentica o fasulla». Così come un ripensamento va fatto sulla stagione che ha
seguito Tangentopoli: «A vent’anni di distanza si deve prendere atto che è una
vera illusione affidare alla magistratura le leve del cambiamento». Anche a
Repubblica il professore dice: «La sinistra, per 20 anni, ha coltivato
l’idea dell’intoccabilità dei magistrati. Da intellettuale non posso che
criticare con forza questo appiattimento fideistico e dogmatico».
E poi c’è la coerenza, scrive “Lettera 43”. Grillo, spettacolo nel teatro
sponsorizzato da Monte Paschi di Siena.
Per lo show Beppe ha affittato il Mandela Forum di Firenze. Struttura sostenuta
da Mps e Unicoop. Chi è senza peccato, scagli la prima pietra. E anche
l'integerrimo Beppe Grillo, in prima linea nella crociata contro lo strapotere
delle banche, ha fatto un passo falso. Quando il leader M5s ha fatto irruzione
all'assemblea dei soci della Monte Paschi di Siena il 29 aprile, non ha certo
usato i guanti di velluto. «Questa è la mafia del capitalismo, non la Sicilia»,
ha sbottato il comico. «Qui siamo nel cuore della peste rossa e del voto di
scambio. Mps è in tutti gli appalti». Concetto ribadito anche nel comizio di
Piombino di sabato 26: «Noi siamo qui nel regno schifoso di questa peste rossa.
Il Pd è la peste rossa e voi continuate e votarlo... Se credete ancora nei
sindacati e nella politica io non voglio il vostro voto». Una «peste» della
quale evidentemente Grillo non teme il contagio, visto che la tappa fiorentina
del suo tour Te la do io l'Europa è stata organizzata il 12 aprile al
Mandela Forum. La struttura è in gestione dell'associazione Palasport di
Firenze, costituita da Claudio Bertini, Rosetta Buchetti e Massimo Gramigni, si
legge nel sito. Ed è sponsorizzata tra gli altri anche da Monte dei Paschi e
Unicoop Firenze. E anche sulle coop Grillo non ci è mai andato giù leggero: già
nel 2009 quando in un post le definì «rosse sì, ma di vergogna». Nel 2012, a
Budrio, in provincia di Bologna, il capo pentastellato in un comizio disse pure
che il M5s non avrebbe vinto perché «stanno comprandosi i voti, stanno
comprandoseli le cooperative». Certo è che né Mps né Unicoop hanno finanziato in
alcun modo lo show. E che la struttura, a quanto risulta a Lettera43.it,
è stata noleggiata dall'agenzia Ad Arte di Firenze al «solito costo e cioè l'8%
dell'incasso netto», cifra che nessuno ha voluto dichiarare. Fatto sta che un
affitto dagli «appestati» Beppe non l'ha disdegnato.
Codice di
comportamento grillino: incoerenza a cinque stelle. Oggi tuona contro
l'assenza del vincolo di mandato e minaccia una multa di 250 mila euro per i
parlamentari grillini a Strasburgo che vengano sfiduciati dalla rete. Ieri
difendeva l'articolo 67 della Costituzione con toni altrettanto accesi: ma qual
è il vero Grillo? Scrive Paolo Papi su “Panorama”.
Il codice di comportamento per i futuri parlamentari europei (con annessa
penalità da 250mila euro per quei dissidenti che rifiutano di dimettersi a
seguito di una espulsione decretata dagli iscritti certificati del M5S) che
Beppe Grillo ha pubblicato ieri sul suo blog (Comunicato pubblico numero 54
) ripropone il tema, caro al MoVimento, dell'assenza del vincolo di mandato
previsto da un articolo della Costituzione contro il quale il comico ha spesso
polemizzato con toni infuocati e barricaderi: «L'articolo 67 della
Costituzione della Repubblica italiana - tuonava Grillo in un recente post
dal titolo Circonvenzione di elettore - consente la libertà più
assoluta ai parlamentari che non sono vincolati né verso il partito in cui si
sono candidati, né verso il programma elettorale, né verso gli elettori.
Insomma, l'eletto può fare, usando un eufemismo, il cazzo che gli pare senza
rispondere a nessuno». Ora lasciamo perdere per un attimo la questione della
palese illegalità di una norma tutta interna al Movimento che obbligherebbe i
parlamentari grillini a versare 250 mila euro qualora fossero espulsi e
rifiutassero di dimettersi, sulla quale scrive oggi Pietro Salvatori dell'Huffington
Post . Il punto è un altro e riguarda, come anche sostiene Grillo,
l'omniscente memoria della rete, capace di conservare dichiarazioni
imbarazzanti in palese contraddizione con le nuove parole dei politici della
Kasta, come la chiama, di cui a farne le spese sono stati negli anni quasi tutti
i politici, da Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Peccato che in questo caso, a
pagare pegno all'incoerenza, sia proprio Grillo che, fino a qualche anno fa,
difendeva l'articolo 67 della Costituzione sull'assenza del vincolo di mandato
con toni tanto accesi quanto quelli che usa ora per chiederne l'abolizione. Il
primo post è del 2010, ai tempi della furibonda polemica tra l'ex presidente
della Camera Gianfranco Fini (di cui Berlusconi chiedeva le dimissioni) e il
premier allora in carica. Scriveva Grillo: «L'articolo 67 della Costituzione
è molto chiaro. Chi è eletto risponde ai cittadini, non al suo partito».
Ancora più chiaro fu nel 2005 quando polemizzò in un altro post contro l'ex
ministro Giovanardi, reo di avere dichiarato quello che oggi sostiene Grillo, e
cioé che «Io non sono dipendente di nessuno se non dei miei elettori»
e ancora «in democrazia ognuno risponde delle sue idee e degli elettori che
lo hanno votato». Chiosava allora Beppe Grillo, nelle vesti allora di
difensore dell'articolo 67 della Costituzione: «Se ne deduce che chi ha
votato l’ex dipendente Giovanardi (ma come fa a sapere chi è se il voto è
segreto?) deve pagargli lui solo lo stipendio, non tutti i cittadini italiani».
Oggi, la nuova capriola. In nome di una coerenza che dura, come gran parte della
classe dirigente, il tempo di un battito di ciglio.
C’è un
passaggio della solenne cerimonia del 2015 che traccia un bilancio crudo, amaro.
Giorgio Santacroce, primo presidente della Cassazione, parla a un certo punto di
«parabola discendente». Si riferisce ai suoi colleghi magistrati, scrive Errico
Novi su “Il Garantista”. E se pure parte dalla «campagna irresponsabile di
discredito» condotta «per anni» contro le toghe, e dà così la colpa anche alla
politica, poi fa una diagnosi assai brutale: siamo davanti a «una situazione di
crescente disaffezione verso la magistratura, dopo l’alto consenso dei tempi di
Mani pulite è iniziata», appunto, «una parabola discendente».soprattutto, «i
magistrati appaiono, anche quando non lo sono, conservatori dell’esistente e
portatori di interessi corporativi». Di più: devono superare i loro
«arroccamenti », e il richiamo pronunciato «davanti al Csm dal presidente
Giorgio Napolitano» deve costituire per loro «un monito perché non ostacolino il
rinnovamento, ma anzi si rinnovino essi stessi».
Alla cerimonia
di inaugurazione dell’anno giudiziario le toghe finiscono dunque sul banco degli
imputati, quanto meno al pari della politica. Le parole di Santacroce sono
nette, ancora di più quando parla delle «tensioni» e delle «cadute di stile» che
si registrano soprattutto fra i pm. Non è da meno il pg di Cassazione Gianfranco
Ciani, che una mezz’ora più tardi interviene a sua volta nell’aula magna del
Palazzaccio romano e si scaglia contro quei pm «troppo deboli alle lusinghe
della politica». Due relazioni (di cui riportiamo ampi stralci nelle due pagine
successive, ndr) che lasciano almeno intravedere una svolta. I riferimenti dei
due più alti magistrati della Suprema Corte alle mancanze dei colleghi, ai
limiti e alle storture del Csm, al vizio del correntismo in toga, sono
numerosissimi.
Si sentono
stretti nella morsa. E reagiscono, scrive “Il Garantista”. Dopo le scudisciate
della cerimonia in Cassazione, i magistrati delle Corti d’Appello di tutta
Italia tentano di replicare ai massimi vertici della Suprema Corte. Venerdì il
primo presidente Giorgio Santacroce e il procuratore generale Gianfranco Ciani
avevano parlato di toghe arroccate nel corporativismo, di pm cedevoli alle
lusinghe dei media, di sacche d’inefficienza che il Csm spesso non riconosce.
Insomma l’avevano fatta nera. E così nel day after, cioè nella giornata di ieri
dominata dalle cerimonie inaugurali nei singoli distretti giudiziari, si è
sentito di tutto. Non su Santacroce e Ciani, ma contro l’altro polo del potere:
la politica. Si va dalla riforma di Renzi giudicata «ben misera cosa» a
Milano al presidente di Reggio Calabria Macrì secondo cui «l’assenza di
iniziative legislative di vasta portata» farà affondare «la giustizia nella
palude». E poi si contano gli anatemi contro la corruzione che soffoca Roma
da parte del presidente capitolino Antonio Marini, il quadro apocalittico delle
collusioni tra camorra e e malapolitica di Antonio Buonajuto a Napoli, e insomma
una batteria di denunce che stavolta si spostano dai vizi di giudici e pm a
quelli delle altre, corrotte istituzioni.
Da Torino è
partita la bordata più pesante, scrive “La Stampa”. Il procuratore generale
Marcello Maddalena usa l’arma del sarcasmo per affrontare uno dei temi più
controversi del piano del governo: «Il presidente del Consiglio non ha trovato
niente di meglio che ispirarsi al personaggio di Napoleone della Fattoria degli
animali di orwelliana memoria, che aveva scoperto il grande rimedio per tutti i
problemi della vita: far lavorare gli altri fino a farli crepare dalla fatica,
come il cavallo Gondrano».
Dottor
Maddalena, perché questo affondo rivolto al presidente del Consiglio?
«Adottare un
decreto di quel tipo, ammissibile solo in casi di necessità e urgenza, significa
additare un’intera categoria di fronte all’opinione pubblica considerandola
responsabile del cattivo funzionamento della Giustizia. Sono convinto che
ciascuno possa dare di più, ma in questo caso i contenuti sono discutibili. E il
modo offende».
Eppure
aumentano i processi che cadono in prescrizione.
«Appunto. In
un panorama segnato da migliaia di processi finiti in prescrizione sostenere che
i problemi da affrontare sono le ferie dei magistrati e la responsabilità civile
mi pare difficilmente tollerabile».
Durissimo
affondo da Maurizio Carbone, segretario nazionale dell'Anm: "Respingiamo
fortemente questa idea demagogica che il problema della giustizia siamo noi
magistrati e non di chi intasca le tangenti". La proposta di riforma dell’Anm è
quella sulla prescrizione. "Non ci possiamo più permettere una prescrizione,
soprattutto per i reati di corruzione, che parta dal momento in cui si commette
il fatto per tutti e tre i gradi di giudizio. Questo significa non avere una
risposta di giustizia. Noi chiediamo - ha concluso Carbone - che i termini di
prescrizione vengano sospesi con l’inizio del processo di primo grado o almeno
dopo la sentenza di primo grado".
«I Tribunali
non sono proprietà dei giudici», scrive Errico Novi su “Il Garantista”. Vogliono
rovinare la “festa”. Oggi sarebbe la giornata della giustizia, proclamata
dall’Anm per protestare contro la riforma del ministro Orlando e in particolare
contro il taglio delle ferie. I penalisti intervengono con una certa, brutale
franchezza e mettono in discussione i dati che oggi i magistrati proporranno ai
cittadini, per l’occasione liberi di entrare nei Palazzi di giustizia. Intanto,
dice il presidente dell’Unione Camere penali Beniamino Migliucci, l’iniziativa
del sindacato delle toghe è «la dimostrazione, come se ce ne fosse bisogno, di
una concezione proprietaria della giustizia e dei luoghi in cui essa si celebra,
da parte dei magistrati». I cittadini, dice, «non hanno bisogno di alcun invito
per accedere al Tribunale, luogo sacro in cui si svolgono i processi in nome del
popolo italiano». Dopodiché «i numeri forniti dall’Associazione magistrati
rischiano di offrire una visione autoreferenziale e alterata della situazione in
cui versa la giustizia italiana, nella quale si enfatizza la loro efficienza a
tutto discapito di una realtà che ci vede fra i primi paesi in Europa per numero
di condanne dalla Corte di Strasburgo». I numeri sono altri, secondo il
presidente dei penalisti, «a cominciare dalla sostanziale inattuazione del
sistema di controllo sulla responsabilità dei magistrati, dalle frequentissime
sentenze di riforma dei giudizi di primo grado, per passare al cospicuo importo
dei risarcimenti che lo Stato è costretto ogni anno a pagare per indennizzare le
vittime degli errori giudiziari, all’inevitabile ricorso, da parte della
magistratura togata, all’ausilio di magistrati onorari, il cui apporto è
determinante per il raggiungimento di quegli obiettivi di produttività che la
Anm enfatizza». Su una delle “contro-statistiche” proposte da Migliucci
interviene anche il cahier de doleance del viceministro della Giustizia Enrico
Costa, che dà notizia del boom di risarcimenti per ingiusta detenzione ed errori
giudiziari pagati dallo Stato nel 2014. «L’incremento rispetto all’anno
precedente è del 41,3%: 995 domande liquidate per un totale di 35 milioni e
255mila euro». Dal 1992, osserva Costa, «l’ammontare delle riparazioni raggiunge
così i 580 milioni: sono numeri che devono far riflettere, si tratta di persone
che si sono viste private della libertà personale ingiustamente e per le quali
lo Stato ha riconosciuto l’errore. Dietro c’è una storia personale, ci sono
trepidazioni, ansie, che un assegno, anche di migliaia di euro, non può
cancellare». Le contromisure di Parlamento e governo sono note: da una parte la
legge sulla custodia cautelare, che naviga ancora in acque incerte, dall’altra
quella sulla responsabilità civile dei giudici, prossima all’approvazione della
Camera. Sui problemi più generali del processo penale è ora all’esame della
commissione Giustizia di Montecitorio l’atteso ddl del governo, che si accoda al
testo base adottato proprio ieri dai deputati sulla prescrizione. «Sono
soddisfatta, abbiamo avviato tutti e due i provvedimenti, coerenti tra loro»,
dice la presidente Donatella Ferranti. Su un altro capitolo della riforma, la
soppressione di alcuni Tribunali, arriva dalla Consulta la bocciatura del
referendum con cui alcune regioni avevano impugnato le chiusure. Tra queste,
c’erano anche le sedi delle zone terremotate dell’Abruzzo.
Eppure c’è
ancora un’altra verità che si tace nella liturgia laica giudiziaria.
Sono Procure o
nidi di vipere? Si chiede Piero Sansonetti su “Il Garantista”. In un giorno solo
tre casi che dovrebbero scuotere la credibilità della magistratura (ma in Italia
è difficile scuoterla…). Il più clamoroso è l’atto di accusa dell’architetto
Sarno, che è il testimone chiave del processo contro l’ex presidente della
Provincia Filippo Penati (Pd). Sarno ha dichiarato: «Lo ho accusato,
ingiustamente, perché la Procura mi ha fatto capire che se non lo accusavo non
uscivo più di cella». Il secondo caso viene dalla Calabria: una Pm (la
dottoressa Ronchi) accusata di abuso di ufficio e falso ideologico per avere
provato a incastrare un collega (Alberto Cisterna, all’epoca numero due
dell’antimafia nazionale). Il terzo caso è quello del sostituto Procuratore di
Milano, Robledo, intercettato (abusivamente?) e affondato giornali se ne
occupano poco di queste cose, cioè delle lotte di potere, violentissime, che
scuotono la magistratura italiana e lasciano molte vittime sul terreno. Se ne
occupano poco non perché le notizie non abbiano un buon interesse giornalistico,
semplicemente perché il patto tra giornali e magistratura, che vige da molti
anni, ha creato un sistema di assoluta omertà. Vediamo: un sindaco indagato per
abuso di ufficio fa un bello scandalo, e sulla base delle leggi vigenti – se
condannato in primo grado – porta pressoché automaticamente alla rimozione del
sindaco stesso e a elezioni anticipate.
I capi
della Cassazione sgridano (un po’) i Pm,
scrive Errico Novi su “Il Garantista”. C’è un passaggio della solenne cerimonia
che traccia un bilancio crudo, amaro. Giorgio Santacroce, primo presidente della
Cassazione, parla a un certo punto di «parabola discendente». Si riferisce ai
suoi colleghi magistrati. E se pure parte dalla «campagna irresponsabile di
discredito» condotta «per anni» contro le toghe, e dà così la colpa anche alla
politica, poi fa una diagnosi assai brutale: siamo davanti a «una situazione di
crescente disaffezione verso la magistratura, dopo l’alto consenso dei tempi di
Mani pulite è iniziata», appunto, «una parabola discendente».soprattutto, «i
magistrati appaiono, anche quando non lo sono, conservatori dell’esistente e
portatori di interessi corporativi». Di più: devono superare i loro
«arroccamenti », e il richiamo pronunciato «davanti al Csm dal presidente
Giorgio Napolitano» deve costituire per loro «un monito perché non ostacolino il
rinnovamento, ma anzi si rinnovino essi stessi». Alla cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario le toghe finiscono dunque sul banco degli imputati, quanto
meno al pari della politica. Le parole di Santacroce sono nette, ancora di più
quando parla delle «tensioni» e delle «cadute di stile» che si registrano
soprattutto fra i pm. Non è da meno il pg di Cassazione Gianfranco Ciani, che
una mezz’ora più tardi interviene a sua volta nell’aula magna del Palazzaccio
romano e si scaglia contro quei pm «troppo deboli alle lusinghe della politica».
Due relazioni (di cui riportiamo ampi stralci nelle due pagine successive, ndr)
che lasciano almeno intravedere una svolta. I riferimenti dei due più alti
magistrati della Suprema Corte alle mancanze dei colleghi, ai limiti e alle
storture del Csm, al vizio del correntismo in toga, sono numerosissimi. Più che
in altre occasioni l’inaugurazione dell’anno giudiziario vede la magistratura
indicata tra le componenti responsabili della crisi della giustizia. Alla fine,
mentre il primo presidente Santacroce e il pg Ciani sono piuttosto severi con i
colleghi, deve provvedere il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, che è un
politico e non un giudice, a una difesa d’ufficio delle toghe. Dice che «una
magistratura compressa dalle inefficienze del sistema, suo malgrado non viene
percepita come autorevole». Certo, dopo di lui, e su bito prima di Ciani, ci
prova anche il ministro della Giustizia Andrea Orlando a sussurrare qualche
parola dolce. Oltre a definire i giudici «protagonisti del cambiamento» promette
loro una mano un po’ più delicata sulla spinosa questione dei pensionamenti: «Il
governo si riserva un’ulteriore riflessione sull’applicazione della nuova
disciplina» che abbassa a 70 anni l’età pensionabile dei magistrati, spiega il
Guardasigilli. Ma cambia poco. Continuerà a percepirsi assai più l’eco delle
parole di Ciani a proposito della «magistratura requirente» che «nell’anno
appena decorso», in taluni dei suoi appartenenti, ha dimostrato «un eccesso di
debolezza nei confronti delle lusinghe dell’immagine, della popolarità, e
soprattutto della politica ». E qui per giunta arriva un’altra stoccatina allo
stesso Csm: sulla questione, dice ancora il procuratore generale della
Cassazione, «è necessario un tempestivo intervento del legislatore per una più
adeguata regolamentazione della materia: quella secondaria del Consiglio
superiore si è rivelata insufficiente». Viceversa sia il pg che il primo
presidente Santacroce promuovono seppur con riserva la riforma di Orlando.
Plaudono soprattutto ad alcuni degli interventi sul civile, in particolare alla
negoziazione assistita che dovrebbe aiutare ad alleggerire il carico dei
tribunali. Un motivo di sollievo, per il ministro della Giustizia, in una fase
in cui sul suo ruolo si allunga l’ombra di Nicola Gratteri, che pochi giorni fa
ha annunciato la ”sua” riforma del processo penale. Ma l’altro tema forte nel
Palazzo di giustizia capitolino è quello delle carceri, e della condizione dei
detenuti in particolare. «C’è ancora molto da fare», avverte Santacroce, «le
misure prese vanno senz’altro nella direzione giusta ma non sono risolutive.
Anche se il numero dei detenuti tende a diminuire, l’emergenza sovraffollamento,
suicidi e tensioni nelle strutture penitenziarie non è ancora rientrata e non
può protrarsi ulteriormente». Bisogna assicurare, ricorda il primo presidente
della Suprema Corte, «il rispetto della dignità della persona nella fase
dell’esecuzione della pena: le carceri sono lo specchio della civiltà di un
Paese, sono la carta di identità dello Stato costituzionale di diritto. Se è
legittimo toglier a un uomo la libertà, non è legittimo togliergli la dignità».
Persino qui non mancano critiche alla magistratura: «Il problema dell’eccesso di
carcerazione chiama in causa anche i giudici, che non possono limitarsi a
sollecitare sempre e comunque l’intervento della politica e del legislatore »,
avverte Santacroce, «è necessario che assumano anche su di loro la
responsabilità di rendere effettivo il principio del minimo sacrificio
possibile, che deve governare ogni intervento, specie giurisdizionale, in tema
di libertà personale». Un passaggio che riscuote il plauso dell’associazione
Antigone («Santacroce ha totalmente ragione, anche sull’illegittimità della pena
per chi non se l’è ancora vista rideterminare dopo la bocciatura della
Fini-Giovanardi da parte della Consulta») e dell’Unione Camere penali. «Siamo
d’accordo sulla visione delle sanzioni penali e del carcere come extrema ratio»
e sul «richiamo ad approvare il reato di tortura», dice il presidente Beniamino
Migliucci. Una svolta c’è. Almeno sui limiti della magistratura e sul tema delle
carceri. E un po’ di merito, su questo, a Napolitano andrà dato.
Desirèe Di
Geronimo vittima dei corvi o della politica?
Alta tensione, chi tocca i fili muore; in sostanza, quando si mettono le mani su
vicende che scottano e che hanno tutta l’aria di essere poco pulite, succede che
si rischia di turbare certi equilibri tra politica e malaffare. I giornali
esprimono differenti opinioni sul comportamento del sostituto procuratore della
Repubblica che ha avuto l’ardire di osare di dubitare della buona fede di
personaggi legati al Presidente della Giunta Regionale, il comunista Nicola
Vendola. La Di Geronimo, da inquirente a inquisita e questo su sollecitazione di
togati di “area” per punire la loro collega, rea di aver espresso perplessità
sul comportamento del giudice barese Susanna De Felice che aveva assolto
Vendola. Al Tribunale di Bari comandano forse i togati di “area”? Significa che
sono politicamente schierati? Sarebbe questa la Giustizia uguale per tutti? E il
CSM non è anche espressione della politica? Il pesce come si è soliti dire,
puzza dalla testa, e se nei tribunali tra corvi e veleni si è scatenata una
rivolta, i cittadini possono ancora credere in una Giustizia giusta a due
binari? Il Parlamento deve urgentemente predisporre una commissione d’inchiesta
finalizzata a riportare serenità tra i magistrati il cui compito è quello di
essere imparziale e di non ritenersi padroni di vita e di morte. E’ urgente la
riforma della Giustizia e la separazione delle carriere. Basta con l’accanimento
giudiziario nei confronti di nemici politici da eliminare. Abbiamo compreso poco
nella vicenda Di Geronimo-Bretone contro Susanna De Felice difesa dai togati di
“area”, ed avendo come motivo della contesa l’assoluzione di Vendola da una
pesante accusa. Ricordo solo per la cronaca che in questi tempi recenti nel
tribunale di Bari non si è respirata aria salubre. In attesa che le vicende si
chiariscano esprimiamo la nostra convinta solidarietà alla Dott.ssa Desirèe Di
Geronimo autrice di tante inchieste coraggiose, scrive Lucio Marengo su Made in
Italy.
La Pm che ha indagato sull’ex
assessore alla Sanità della Regione Puglia Alberto Tedesco si sentiva isolata
dai suoi stessi colleghi,
scrivono Giovanni Longo e Massimiliano Scagliarini su “La Gazzetta del
Mezzogiorno”. E oggi che a Lecce appare come parte offesa, è interessante
leggere le dichiarazioni di Desirèe Digeronimo agli ispettori del ministero
della Giustizia: gli stessi che hanno ritenuto «non sussistente» l’ipotesi di
dissapori in Procura a Bari. E che l’accusano di non essersi astenuta, visti i
suoi rapporti con una delle amiche più strette di Lea Cosentino, ex manager
della Asl Bari indagata. Ma il procuratore di Lecce Motta e l’aggiunto De Donno
la vedono in modo diverso, tanto da contestare al Pm Giuseppe Scelsi l’abuso
d’ufficio: avrebbe intercettato Paola D’Aprile proprio per «incastrare» la
Digeronimo. Il racconto parte nell’estate 2009, quando inizia un «bombardamento
mediatico» anche nei suoi confronti: «Infuriava una campagna di stampa sulla
vicenda Tarantini che mi preoccupò non poco per il clima di sovraesposizione, e
ritenni pertanto opportuno (...) avvertire il procuratore delle intercettazioni
tra il Tedesco e il fratello di Pino Scelsi, poiché emergeva dalla mia indagine
un conflitto acceso tra i Tarantini e Tedesco, e che il dottor Michele Scelsi,
fratello del collega, si lamentava con Tedesco di alcune scelte in materia
sanitaria effettuate dalla Cosentino, all'epoca direttore generale dell'Asl
Bari, indagata dal collega e da me unitamente al Tedesco». Dicevamo
dell’isolamento. «Dall'estate del 2009 e sino a quando ho iniziato a collaborare
con i colleghi Bretone e Quercia (...) sono stata completamente isolata dagli
altri colleghi e pertanto, non ho avuto più rapporti con loro, come ad esempio
con Scelsi, la Pirrelli, la Iodice, persone con le quali maggiormente mi
confrontavo in merito a questioni lavorative, perché eravamo amici, anche per la
comunanza correntizia («Magistratura democratica). A un certo punto ho capito
che l'indagine sull'assessorato alla Sanità, che coinvolgeva il Tedesco,
esponente del centrosinistra, verosimilmente aveva inciso sui miei rapporti con
loro. Ho chiesto formalmente, anche a seguito di ciò, la cancellazione dalla mia
corrente». E come esempio del clima la Digeronimo ricorda l’episodio in cui la
collega Iodice le negò l’accesso ad alcune intercettazioni «con allegato il
parere dei due procuratori aggiunti Drago e Di Napoli». «Molto spesso apprendevo
dalla stampa dell'esistenza di elementi utili per le indagini in corso su
Tedesco». E poi le intercettazioni della D’Aprile. Dopo una cena con la Gdf,
Laudati «mi fece ascoltare la registrazione di una conversazione tra me e la
D'Aprile e mi chiese di chiarire alcune circostanze rilevabili dal colloquio». E
così in Procura cominciano i veleni: «Nella stessa circostanza in cui Laudati mi
fece ascoltare la conversazione di cui sopra, mi disse, sempre informalmente,
che Scelsi aveva diffuso in ufficio pettegolezzi sul mio conto dicendo che io e
Marzano lo avevamo pressato per archiviare il procedimento a carico della
Cosentino (...). Inoltre, gli evidenziai che la Cosentino era ancora indagata
nel mio procedimento». Poi, dice la Digeronimo, ne parlò con Scelsi: «Gli dissi
come mai gli era venuto in mente di mettere in giro voci del genere sul mio
conto, prive del tutto di fondamento. Lui ha farfugliato che “si era dovuto
difendere perché, dopo l'arrivo di Laudati, gli erano stati contestati errori
nelle indagini”».
C'è la prova: le toghe rosse hanno in mano la politica.
Fioroni rivela: l'Anm ha premuto perché ritirassi la candidatura in
commissione Giustizia della Camera per far posto alla Ferranti. Poi le strane
smentite, scrive Anna Maria Greco su
“Il Giornale”. La legge del contrappasso
colpisce l'Anm. Mentre protesta a gran voce contro il Pdl che «delegittima» i
magistrati sulle vicende giudiziarie di Berlusconi, ecco che le scoppia in casa
la bomba Fioroni. A dimostrazione delle sue logiche di potere e delle pretese di
condizionare la politica. La nota dell'Anm critica le «espressioni violente e
offensive, estranee a ogni legittimo esercizio del diritto di critica» contro i
magistrati e richiama gli inviti di Giorgio Napolitano ad evitare conflitti.
Nella stessa giornata Beppe rivela (ma poi in serata smentisce) di telefonate
avute dal sindacato delle toghe per garantire un posto chiave in parlamento a
un'esponente di Magistratura democratica: Donatella Ferranti, ex segretario
generale del Csm. Nel caos che regna nel Pd sul dopo-Bersani, Fioroni doveva
fare il presidente di commissione ma è costretto al passo indietro. «Mi hanno
detto - racconta a Repubblica- o ci sei tu o c'è la Ferranti. Ha cominciato a
chiamarmi l'Anm. "Non sappiamo con chi parlare al Pd. Per favore, abbiamo
bisogno della Ferranti alla Giustizia. Sa, con Nitto Palma al Senato...". E io
ho risposto obbedisco ai magistrati, mica al Pd». Segue scambio di sms, sempre
rivelato dall'esponente Pd, con il premier Enrico Letta che gli chiede se è
«contrariato» e l'ex-Ppi che gli promette di contrariarlo sabato all'assemblea
del partito. La storia suscita una sfilza di domande inquietanti. Perché
dall'Anm chiamano un Pd per una questione di posti? Perché hanno bisogno della
Ferranti in commissione Giustizia della Camera? Perché, poi, Fioroni dovrebbe
«obbedire» ai magistrati? In serata arriva la smentita dell'ex ministro, ieri a
colloquio, sembra, col Guardasigilli Cancellieri: «Tutte le ricostruzioni sono
fantasiose e infondate. Nessuna associazione, tantomeno di magistrati, ha mai
parlato con me, ho condiviso la presidenza della commissione Giustizia
all'onorevole Ferranti». Anche l'Anm in serata smentisce: «Mai intervenuta per
condizionare l'elezione del presidente della commissione Giustizia della
Camera». Dietrofront a parte, sembra che la Ferranti pensasse di avere in tasca
il sottosegretariato alla Giustizia e per lei sia stato un colpo vederselo
scippare da Giuseppe Berretta. Tanto più che in quota Pdl è stato scelto Cosimo
Ferri, leader della corrente d'opposizione all'Anm, Magistratura indipendente.
Una nomina andata di traverso al sindacato delle toghe e contestata da Md. Come
quella di Palma, presentata come uno scandalo. Tutto questo dimostra quanto
l'Anm pretenda di essere forza politica, pur lanciando appelli all'indipendenza
e autonomia della magistratura, e pretenda di condizionare le scelte del
Palazzo. Collateralismo, lo chiamano. «Se fosse vero quello che dice Fioroni -
commenta al Giornale Lorenzo Pontecorvo, vicepresidente di Mi e membro del
direttivo dell'Anm - sarebbe molto grave. L'associazione dovrebbe occuparsi
dello svolgimento dell'attività giudiziaria, non intromettersi nelle questioni
della politica, tantomeno se si tratta delle commissioni Giustizia del
parlamento». Il fatto è che l'Anm, guidata dal cartello di sinistra e da
Unicost, vive una crisi storica. Rappresenta forse la metà dei 9mila magistrati,
se gli iscritti sono ben sotto gli 8mila, 3mila votano Mi, 300 Proposta B e
tanti non partecipano. La base è in subbuglio, insofferente per il correntismo e
un vertice troppo orientato a sinistra che si preoccupa di politica e non di
questioni sindacali, si moltiplicano i movimenti indipendenti e Mi, uscita
vittoriosa dalle urne, si trova all'opposizione.
Altro che "toghe rosse": ecco la pattuglia di magistrati che
difende Berlusconi. Sin dal 1994 il leader indiscusso
del centrodestra accusa i pubblici ministeri "comunisti". Un articolo
dell'Espresso racconta come al suo fianco in realtà ci sia una vera e propria
pattuglia di magistrati. E' uno dei cavalli di battaglia di
Silvio Berlusconi, e non certo da oggi. Sin dal 1994 il leader indiscusso del
centrodestra accusa i pubblici ministeri 'comunisti'. Un
articolo dell'Espresso racconta come al suo fianco in realtà ci sia
una vera e propria pattuglia di magistrati di peso, scesa in
campo con il centrodestra per salvare il Cavaliere da guai. Da Nitto Palma a
Giacomo Caliendo. Dopo l'ultima tornata elettorale la pattuglia dei giudici
diventati parlamentari si è dimezzata: tra Camera e Senato sono nove (cinque del
Pd, tre del Pdl, uno di Scelta Civica), mentre erano diciassette nella
precedente legislatura. Il partito di Berlusconi non ha mai smesso di portare in
parlamento toghe di livello come l'ex ministro Francesco Nitto Palma e l'ex
sottosegretario alla giustizia Giacomo Caliendo, che sono stati appena rieletti
al Senato. Caliendo si è messo in luce come teorico della riforma che punta a
dimezzare le pene per il concorso esterno in associazione mafiosa: una leggina
ribattezzata dai critici "salva-Dell'Utri" (e per ora accantonata) per il suo
sicuro effetto di evitare la galera al manager fondatore di Forza Italia,
ricondannato in appello a sette anni proprio per quel reato. Nel frattempo Nitto
Palma, numero uno del Pdl in Campania, si è fatto notare prima per la scelta di
visitare in carcere l'ex sottosegretario Nicola Cosentino, arrestato per
camorra. Ancora più preziosi per Berlusconi, scrive il settimanale, sono
quei magistrati che entrano nei palazzi come tecnici, come il giudice
Augusta Iannini, chiamata dal 2001 a dirigere il ministero della Giustizia e ora
nominata vicepresidente dell'Autorità garante della privacy. "Nemica" dei pm
milanesi ha aperto un sito (augustaiannini.it) dove taccia di "maschilismo" chi
la etichetta solo come moglie di Bruno Vespa e rivendica i suoi 35 anni di
lavoro come "giudice imparziale". Il corteggiamento delle toghe ad Arcore, del
resto, precede addirittura la nascita di Forza Italia. Correva l'anno 1993,
quando Berlusconi riuscì a sfilare al pool Mani Pulite l'allora pm Tiziana
Parenti: eletta dopo mille utilissime polemiche sulle tangenti rosse, ora fa
l'avvocata ed è vicina al nuovo Psi. E dopo il trionfo di Forza Italia nel '94
perfino Di Pietro e Piercamillo Davigo si videro offrire poltrone da ministri
nel primo governo Berlusconi, che tre mesi dopo, al culmine delle indagini sulla
Fininvest, varò il famoso decreto Biondi (niente carcere per le tangenti).
Alla faccia delle toghe rosse, scrive
Paolo Biondani su “L’Espresso”.
Berlusconi accusa i pm 'comunisti' ma al suo fianco c'è una vera e propria
pattuglia di magistrati di peso, scesa in campo con il centrodestra per salvare
il Cavaliere da guai. Da Nitto Palma a Giacomo Caliendo. Toghe rosse? No,
azzurre. Vent'anni di bombardamenti della propaganda berlusconiana su
fantomatici complotti dei giudici al servizio dei comunisti (o viceversa)
rischiano di far dimenticare il ruolo e l'importanza dei magistrati che sono
invece scesi in campo con il centrodestra. Con le ultime elezioni la pattuglia
dei giudici diventati parlamentari si è dimezzata: tra Camera e Senato,
l'associazione Openpolis ne ha contati nove (cinque del Pd, tre del Pdl, uno di
Scelta Civica), contro i diciassette della precedente legislatura. Eppure prima
e dopo la campagna elettorale si è parlato moltissimo di loro. Non di tutti,
però, solo di alcuni: da Piero Grasso, l'ex procuratore antimafia eletto
presidente del Senato con il Pd, ad Antonio Ingroia, il pm di Palermo che dopo
la bocciatura politica ora si oppone al trasferimento alla procura di Aosta. Ma
anche il partito di Berlusconi non ha mai smesso di candidare e continua
tutt'oggi a portare in parlamento toghe di grande esperienza come l'ex ministro
Francesco Nitto Palma e l'ex sottosegretario alla giustizia Giacomo Caliendo.
Rieletti al Senato, hanno già sfornato disegni di legge assai contestati,
soprattutto dai magistrati rimasti nei tribunali. Caliendo si è messo in luce
come teorico della riforma che punta a dimezzare le pene per il concorso esterno
in associazione mafiosa: una leggina ribattezzata dai critici "salva-Dell'Utri"
(e per ora accantonata) per il suo sicuro effetto di evitare la galera al
manager fondatore di Forza Italia, ricondannato in appello a sette anni proprio
per quel reato. Nel frattempo Nitto Palma, numero uno del Pdl in Campania, si è
fatto notare prima per la scelta di visitare in carcere l'ex sottosegretario
Nicola Cosentino, arrestato per camorra, e poi per una raffica di progetti di
legge (al momento nove, ma di altri sette è cofirmatario) che hanno fatto
rumore: dal rilancio del condono per l'abusivismo edilizio, ai nuovi illeciti
disciplinari a geometria variabile per colpire i pm ritenuti politicizzati. Il
bello è che nessuno ha mai accusato loro, i due ex magistrati berlusconiani, di
aver fatto politica con indagini e processi, nonostante la delicatezza dei tanti
fascicoli trattati. Caliendo, napoletano d'origine, è stato per più di
trent'anni giudice e sostituto procuratore generale a Milano e poi in
Cassazione, diventando anche capocorrente al Csm: un magistrato ascoltatissimo
dal centrodestra (grazie ai buoni rapporti con ex dc come Giuseppe Gargani)
ancor prima di entrare in parlamento nel 2008. Mentre Nitto Palma è stato uno
dei pm di punta della procura di Roma, prima di diventare amico di Cesare
Previti (l'ex ministro oggi pregiudicato) e sbarcare in parlamento nel 2001,
segnalandosi subito per un tentativo di resuscitare l'immunità parlamentare
totale. Oggi è il presidente della commissione giustizia del Senato. Nel lustro
2008-2013, tra i magistrati in aspettativa perché eletti, il Pd ne schierava 9,
il Pdl 7 e i centristi uno. Oggi alla Camera, stando alle autocertificazioni dei
diretti interessati, resistono tre giudici, equamente divisi: Donatella Ferrante
del Pd, Stefano Dambruoso di Scelta Civica, Ignazio Abrignani del Pdl. A ben
guardare, però, quest'ultimo non è un magistrato, ma un avvocato civilista
siciliano, fedele all'ex ministro Scajola, che faceva anche il giudice
tributario. Al Senato invece il Pd batte il Pdl per quattro a due, con l'ex pm
Felice Casson, Anna Finocchiaro, Doris Lo Moro e Piero Grasso, che peraltro si è
dimesso dalla magistratura appena candidato. Le due toghe azzurre in compenso
pesano molto: Caliendo e Nitto Palma sono tra i pochissimi in grado di
influenzare la linea di Berlusconi sulla giustizia, tema tornato urgente dopo la
condanna anche in appello per le maxi-frodi fiscali sui diritti tv di Mediaset.
Preziosissimo, per il miliardario di Arcore, è anche il lavoro dei magistrati
che entrano nei palazzi come tecnici. Tra i più in vista c'è il giudice romano
in aspettativa Augusta Iannini, chiamata dal 2001 a dirigere il ministero della
Giustizia e ora nominata vicepresidente dell'Autorità garante della privacy. Da
sempre ostile ai pm milanesi, per replicare a una puntata di "Report" ha aperto
un sito (augustaiannini.it) dove taccia di «maschilismo» chi la etichetta come
«moglie di Bruno Vespa» e rivendica i suoi 35 anni di lavoro, portati benissimo,
come «giudice imparziale». Qualità dimostrata, per altro, già ai tempi di
Tangentopoli, quando chiese di astenersi sulla richiesta di arresto per Gianni
Letta e Adriano Galliani, spiegando: «Siamo amici di famiglia». Ora, nel
governissimo di Enrico Letta, brilla la stella di Cosimo Ferri, sottosegretario
alla Giustizia e capocorrente di Magistratura Indipendente, capace di farsi
eleggere al Csm da ben 553 magistrati benché chiacchierato (ma non indagato) per
le intercettazioni di Calciopoli, del caso Santoro-Mills e della cosiddetta P3.
Con la nuova legislatura, intanto, il centrosinistra ha detto addio a ex
magistrati del livello di Gerardo D'Ambrosio, l'ex procuratore Silvia Della
Monica o il giudice-scrittore Gianrico Carofiglio, senza contare gli ex pm che
avevano lasciato la toga più di vent'anni fa, come Antonio Di Pietro o Luciano
Violante. Ma anche il centrodestra ha rinunciato a ex magistrati di governo come
Franco Frattini e Alfredo Mantovano, avvicinatisi a Monti e non ricandidati. Per
non parlare di uomini di legge come Melchiorre Cirami, l'ex giudice di Agrigento
entrato in Parlamento nel '96 con l'Udc, passato nel '98 al centrosinistra con
l'Udeur e rieletto nel 2001 con il centrodestra dopo il patto
Cuffaro-Berlusconi: portano ancora il suo nome la versione originale del
"legittimo sospetto" (per fermare i processi, bastava chiederne il
trasferimento) e il comma "super-513" (per annientare i verbali d'accusa,
bastava far tacere il complice), subito dichiarato incostituzionale. La fede nel
Grande Sud del sottosegretario Gianfranco Miccichè (meno dell'1 per cento a
Siracusa) ha tradito anche Roberto Centaro, altra toga azzurra in missione
parlamentare dal 1996 al 2013: un presidente della commissione antimafia capace
di polemizzare con tutte le procure, oltre che relatore della legge-bavaglio
contro le intercettazioni. Incolmabile, poi, il vuoto lasciato da Alfonso Papa,
ex pm di Napoli e Roma eletto nel 2008 con il Pdl: nel 2011 è diventato il primo
parlamentare, dai tempi dell'esplosivista missino Massimo Abbatangelo, a entrare
in carcere perdendo l'immunità. Tornato libero, Papa ha chiesto di riprendere il
lavoro di magistrato, ma per ora resta imputato: in teoria dovrebbe preoccuparlo
la condanna patteggiata dal suo coindagato, il piduista per sempre Luigi
Bisignani, ma a suo favore gioca ancora il privilegio politico che gli ha
garantito la distruzione delle prove più insidiose, le famigerate
intercettazioni. Il corteggiamento delle toghe ad Arcore, del resto, precede
addirittura la nascita di Forza Italia. Correva l'anno 1993, quando Berlusconi
riuscì a sfilare al pool Mani Pulite l'allora pm Tiziana Parenti: eletta dopo
mille utilissime polemiche sulle tangenti rosse, ora fa l'avvocata ed è vicina
al nuovo Psi. E dopo il trionfo di Forza Italia nel '94 perfino Di Pietro e
Piercamillo Davigo si videro offrire poltrone da ministri nel primo governo
Berlusconi, che tre mesi dopo, al culmine delle indagini sulla Fininvest, varò
il famoso decreto Biondi (niente carcere per le tangenti). Da allora Berlusconi
gioca soprattutto in difesa: oggi il Pdl schiera 17 avvocati al Senato e 21 alla
Camera. Ma su questo fronte il Pd post-giustizialista non teme i rivali-alleati:
ha 9 legali tra i senatori e 37 tra i deputati. In totale nel nuovo parlamento,
secondo i dati di Openpolis, si contano ben 105 avvocati, che a differenza dei
magistrati possono continuare a fare processi (e incassare parcelle dai clienti)
anche mentre hanno il potere di cambiare le leggi.
Lo abbiamo visto partecipare ai
convegni di partito, stringere la mano al presidente della Camera
Gianfranco Fini, intervenire alla manifestazione dell'Idv di Di Pietro
e Travaglio contro il bunga bunga per sbeffeggiare Berlusconi, sedersi sullo
scranno di Annozero insieme con Ciancimino, parlare dal palco delle festa
bolognese della Fiom. E il dubbio che il sostituto procuratore di Palermo
Antonio Ingroia fosse, diciamo così, "di parte" era balenato
nella mente. Ma poi questo dubbio si scontrava con le rassicurazioni e le
dichiarazioni dello stesso pm che ha più volte sottolineato come “agli occhi del
cittadino il magistrato non soltanto deve essere imparziale ma deve anche
apparirlo”.
Ma quando poi sempre lo stesso pm
ammette la sua vera inclinazione politica, ecco che ogni dubbio viene spazzato.
Il palco dal quale arriva la confessione è quello di Rimini, precisamente quello
del VI Congresso nazionale del comunisti italiani. E’ il
30 ottobre 2011.
Ingroia fa il suo comizio. Dichiara
che «siamo in una fase critica. Le parti migliori della società devono
impegnarsi dentro e fuori le istituzioni per realizzare un’Italia migliore. La
magistratura deve essere autonoma e indipendente. La politica deve essere
ambiziosa: deve fare la sua parte. C’è tanta stanchezza fra gli italiani. La
politica con la ’p’ minuscola chiede alla magistratura di fare un passo
indietro. C’è bisogno invece di una politica con la ’p’ maiuscola. Senza verità
non c’è democrazia. Fino a quando avremo verità negate avremo una democrazia
incompiuta. Legalità senza sconti per nessuno, in armonia con i principi
costituzionali. Abbiamo bisogno di eguaglianza. Un’Italia di eguali contro
un’Italia di diseguali. - E poi ancora parole in difesa della
Costituzione - La Costituzione è sotto assedio. Che fare? Resistere non
basta. I magistrati non possono essere trasformati in esecutori materiali di
leggi ingiuste.- Infine viene fuori il vero Ingroia - Un magistrato deve essere
imparziale quando esercita le sue funzioni, e non sempre certa magistratura che
frequenta troppo certi salotti e certe stanze del potere lo è, ma io confesso
non mi sento del tutto imparziale, anzi, mi sento partigiano. Partigiano
non solo perché sono socio onorario dell’Anpi, ma sopratutto perché sono un
partigiano della Costituzione. E fra chi difende la Costituzione e chi
quotidianamente cerca di violarla, violentarla, stravolgere, so da che parte
stare».
Insomma, parole destinate a far
scalpore, ma pronunciate comunque, nonostante il pm fosse consapevole di ciò che
avrebbero provocato. «Ho accettato l’invito di Oliviero Diliberto pur prevedendo
le polemiche che potrebbero investirmi per il solo fatto di
essere qui - ha infatti esordito il magistrato di Palermo dal palco dell’assise
del Pdci - ma io ho giurato sulla Costituzione democratica, la difendo e sempre
la difenderò anche a costo di essere investito dalle polemiche».
La previsione sulle critiche è stata
azzeccata. Infatti, dal Pdl sono giunte affermazioni di biasimo nei confronti
del reo confesso. Il capogruppo del Pdl alla Camera, Fabrizio Cicchito,
ha ringraziato ironicamente il «dottor Ingroia per la sua chiarezza. Sappiamo
che le vicende più delicate riguardanti i rapporti tra mafia e politica stanno a
Palermo nelle mani di pm contrassegnati dalla massima imparzialità».
Più dure le parole del presidente dei
senatori del Pdl, Maurizio Gasparri. «Sono gravi e inquietanti le parole di
Ingroia che confermano l’animo militante di alcuni settori della
magistratura. Da persone così invece che comizi politici ci saremmo
attesi le scuse per aver fatto di Ciancimino jr una icona antimafia quando
invece organizzava traffici illeciti e nascondeva tritolo in casa. Ingroia
conferma i nostri dubbi. E sul caso Ciancimino dovrebbe spiegare molte cose.
Porteremo questo scandalo e il suo comizio odierno all’attenzione del Parlamento
dove sarà anche il caso di discutere della nostra mozione sul 41 bis che fu
cancellato per centinaia di boss al tempo di Ciampi e Scalfaro e che anche ora
il partito di Vendola vorrebbe abolire».
«Non era mai accaduto che un
magistrato in servizio, già esposto mediaticamente su più di un fronte,
prendesse la parola a un congresso di partito per attaccare maggioranza
parlamentare e governo. Oggi il dottor Ingroia lo ha fatto con
il suo intervento al congresso dell’ultimo partito comunista rimasto,congresso
che naturalmente lo ha applaudito in sfregio a qualsiasi principio di
separazione dei poteri», sottolinea Giorgio Stracquadanio, deputato del Pdl.
Insomma, Ingroia se lo aspettava: le sue parole avrebbe suscitato un vespaio. E
così è stato.
Ma non c'è da stupirsi della
partigianeria di Ingroia. Qualunque magistrato è partigiano a favore di una
Costituzione "catto-comunista" che ha elevato a "dio in terra" la figura del
magistrato e che l'andazzo istituzionale ha legittimato la magistratura da
organo costituzionale a "Potere costituzionale", pur non avendo alcuna delega
rappresentativa del potere del popolo sovrano.
La stampa ha coniato l’epiteto “Toghe Rosse” per definire il cartello di
magistrati riconducibili allo schieramento del centrosinistra, organizzati in
correnti e sindacati di categoria, influentissimi, determinanti e ben
rappresentati in Parlamento. A loro è addebitato il tentativo si sovvertire il
sistema democratico, quindi controllare il potere legislativo, attraverso l’uso
politico ed illegale del potere giudiziario. In un libro («L'uso politico della
giustizia», ed. Mondadori, pag.320), tutti gli aspetti dell'anomalia italiana
sono descritti analiticamente da Fabrizio Cicchitto: l'anomalia italiana e il
sistema Tangentopoli, la Prima Repubblica e il finanziamento irregolare dei
partiti, la mafia, Andreotti, Falcone, Violante e le cooperative rosse e
bianche, Magistratura democratica, l'uso politico della giustizia e Berlusconi,
Marcello Dell'Utri e la mafia, l'establishment finanziario-editoriale e i
furbetti del quartierino e la Banca d'Italia. A cominciare dalla scelta fatta da
Palmiro Togliatti di fare il ministro di Grazia e Giustizia nel primo governo di
unità nazionale: «Il segno di un'attenzione, poi risultata crescente, del Pci
nei confronti degli apparati dello Stato (magistratura, polizia, carabinieri,
esercito, Guardia di finanza, servizi segreti), che doveva fare il suo salto di
qualità negli anni Settanta con l'azione condotta da Ugo Pecchioli e
successivamente da Luciano Violante». Mentre «nella magistratura emergeva
progressivamente la tendenza a una crescente conquista di influenza, di potere,
di immagine nella società italiana», spinte favorite dall'ordinamento giuridico
italiano che consente alla magistratura un'autonomia assoluta, e finché nel 1964
sorge Magistratura democratica, un'associazione di magistrati dichiaratamente di
sinistra e che diventa un vero e proprio soggetto politico e si collega al
Partito comunista dando un colpo mortale allo Stato di diritto, fondato sulla
divisione dei poteri e sulla terzietà del giudice.
È in questo quadro che Cicchitto passa in rassegna la vicenda di Tangentopoli e
di Mani pulite, con l'interpretazione dominante e paradossale di opporre
politici colpevoli ad imprenditori vittime, mentre le grandi imprese italiane
erano tutt'altro che concusse e dal sistema di Tangentopoli traevano tutti gli
utili possibili: «C'è ancora da spiegare - e Cicchitto cita Francesco Cossiga -
perché la classe politica fu decimata mentre la classe imprenditoriale fu
risparmiata, considerando i corrotti più colpevoli dei corruttori». Sicchè i
nomi di Craxi, Forlani, Andreotti vengono cancellati dalla nomenclatura del
paese, mentre Agnelli, De Benedetti, Ligresti neppure vengono sfiorati, «un
colpo di Stato legale, nel senso che un ordine autonomo dello Stato,
indipendente ma non sovrano, ha surrogato il potere sovrano del Parlamento, ha
prevaricato gli altri poteri, ha modificato gli equilibri della vita politica
democratica, ha decretato la morte di passati storici, usando come arma di
giudizio storico e politico l'indagine giudiziaria».
Il Ministro per i Rapporti con le
Regioni, Raffaele Fitto, replica sulla “Gazzetta del Mezzogiorno” del 1 aprile
2009, contrattaccando, alla interrogazione al Ministro della Giustizia, Alfano,
presentata dai senatori Pd sul suo conto, segnalando la "coincidenza" con
iniziative e decisioni del Csm.
Il Ministro Alfano ha disposto
un’ispezione Ministeriale presso la Procura di Bari per verificare il suo modus
operandi, mentre il CSM ha respinto un esposto di Fitto contro la stessa
Procura. "In Spagna - scrive Fitto in una nota - un ministro della giustizia
socialista si dimette per essere stato fotografato a caccia con un magistrato
che indaga sul partito popolare. Da noi alla fine ci si mette anche una "casta"
togata che siede "pro tempore" sui banchi del Senato a interrogare il Ministro
Alfano. Sei pubblici ministeri su nove firme. Nomi celebri: Finocchiaro, Casson,
D'Ambrosio, Della Monica ma anche: Gianrico Carofiglio, fino all'altro giorno
pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Bari, dove la moglie,
Francesca Romana Pirrelli esercita la stessa attività nel pool che indaga sui
reati contro la Pubblica Amministrazione, competente quindi sul Comune di Bari
del quale è sindaco l'ex collega magistrato e compagno di partito del marito,
Michele Emiliano. Competente anche sulla Regione Puglia. Tra l'altro dello
stesso magistrato e della moglie magistrata circolano nella Rete foto in
atteggiamenti di grandi familiarità con parenti stretti del Presidente Vendola.
Firmatario anche Alberto Maritati, già sostituto procuratore presso la Procura
di Bari e successivamente applicato a Bari dalla Direzione Nazionale Antimafia.
Celebre per avere suscitato un immenso clamore con la cosiddetta "Operazione
Speranza", alla metà degli anni novanta, che vide decine di persone tra
arrestate e variamente imputate in una serie di procedimenti che, dopo ben più
di un decennio, si sono conclusi tutti con assoluzioni in tutti i gradi di
giudizio. Ma ebbe di che consolarsi con un patteggiamento. Né va dimenticato che
nella stessa indagine Maritati si imbatté in esponenti politici dai quali, senza
difficoltà, in seguito ottenne la candidatura nel medesimo partito".
Secondo Fitto, poi, "non va
dimenticato che è sindaco di Bari Michele Emiliano, magistrato presso la Procura
della stessa città e che a lungo indagò sulla cosiddetta Missione Arcobaleno,
ipotizzando reati gravissimi a carico di tutta una serie di alti esponenti di
quello che, con nuova denominazione, è diventato il partito del quale è
segretario regionale e che, a suo tempo lo candidò a sindaco del Comune di
Bari". E "che sono stato definito "mafioso" in un`intervista al giornale La
Repubblica da Marco Di Napoli, magistrato impegnato in un`indagine sulla mia
persona. Segue in proposito una denuncia penale e un procedimento civile". Così
come "un altro magistrato, Roberto Rossi, analogamente impegnato in un`indagine
sulla mia persona si lasciava fotografare in ridente condivisione con una
assessore comunale di Bari dei Verdi, nel corso del cosiddetto Vaffa Day in
svolgimento nella stessa città nella quale esercita il suo delicato ufficio.
Peraltro compiendo eloquente gesto".
Inoltre, "un altro firmatario non
magistrato, Nicola Latorre ha sicuramente minuziosa conoscenza di tutte queste
vicende". "Per il resto - prosegue il ministro- vale il criterio opinabilissimo
dell'opportunità che una serie tanto nutrita di magistrati si impegni in
politica e che alcuni lo facciano all'indomani di indagini delicatissime a
carico di esponenti dello stesso partito che finisce con il candidarli? Va da
sé: liberi tutti.... E mi si vuole negare la libertà di un esposto, più volte
integrato in questi mesi con ulteriori elementi, peraltro nel più rigoroso
rispetto delle regole e che riguardano, per ciò che mi concerne, intercettazioni
ambientali tra avvocati e indagati in colloqui precedenti all'interrogatorio,
iscrizione nel registro degli indagati e successiva autorizzazione alle
intercettazioni a distanza di 23 mesi dalla notizia di reato e senza che ci
fossero fatti nuovi e in coincidenza con la mia campagna elettorale, indagini
preliminari che durano 7 anni. Telefonate intercettate e riportate in brogliacci
come "non inerenti" e il cui contenuto è invece totalmente riferibile alla
vicenda. Telefonate riportate con degli omissis, contenenti invece brani che
attribuiscono diverso significato. Tentativo con diversi ostacoli durato 2 anni
per poter esercitare il mio legittimo diritto, previsto dal Codice di ascoltare
tutte le telefonate e non solo quelle scelte dai P.m.. E potrei continuare".
"Peraltro - conclude Fitto- vedo che con una velocità del tutto inusitata, non
solo si mobilitano le associazioni dei magistrati locale e nazionale, ma lo
stesso CSM non archivia, come si è detto, ma eccepisce la sua non competenza, a
tempo di record, sul mio esposto e, sempre a tempo di record, si dispone a
intervenire sul caso dell'ispezione come ci informa, per agenzia, il Consigliere
del CSM, Ciro Riviezzo, che appartiene alla stessa corrente di alcuni pubblici
ministeri titolari delle indagini a mio carico. Sicuramente tutte strane
coincidenze".
«Riteniamo gravissime e degne di
attenzione da parte del ministro della Giustizia le dichiarazioni del Capo della
Procura di Bari, Emilio Marzano, in merito ad una delle inchieste in corso sulla
sanità pugliese». Lo sostengono in una interrogazione parlamentare dell’8 luglio
2009 i deputati pugliesi del Pdl (primo firmatario Luigi Vitali), in relazione
alle indagini sulle tangenti, festini, appalti truccati, intercettazioni, il cui
scandalo ha coinvolto la Giunta regionale pugliese di sinistra presieduta da
Niki Vendola, che aggiungono: «Il procuratore Marzano incredibilmente giustifica
l'operato di un pm, Roberto Rossi, che tiene aperta fino ad oggi una inchiesta
per fatti commessi tra il 2001 e il 2004, causando probabilmente, e per stessa
ammissione del Procuratore Capo, la prescrizione dei reati, piuttosto che
chiedergliene conto. Ma quel che è più grave è che sulla Gazzetta del
Mezzogiorno di oggi il procuratore Marzano aggiunge anche che ad alcuni degli
indagati in questa inchiesta sarebbe stato contestato il reato di associazione a
delinquere solo per "questioni di metodo legate al potenziale coordinamento con
inchieste sorelle"».
«Insomma – dicono i deputati – non
solo il procuratore giustifica un pm che tiene aperta una inchiesta per 5 anni,
arrivando forse a far prescrivere i reati, ma ammette candidamente che un reato
gravissimo come l’associazione a delinquere viene contestato solo per questioni
di metodo… Peccato che nel frattempo, nonostante reati prescritti e questioni di
metodo, quelle persone siano finite in prima pagina su tutti i giornali accusate
di associazione a delinquere. Quel che accade alla Procura di Bari è vergognoso:
alcune inchieste, su cui pure sembrano emergere fatti gravissimi e a quanto pare
riscontrati, vengono condotte con i guanti bianchi, quasi giustificando
l’esigenza di interrogare persone informate dei fatti, altre invece vengono
direttamente sbattute in prima pagina con foto e nomi di persone a cui, a quanto
dice il Procuratore, vengono ascritti contestati reati o prescritti o contestati
solo per "metodo". Riteniamo che ci siano tutti gli elementi affinchè il
Ministro della Giustizia valuti se avviare iniziative ispettive, al fine della
individuazione delle responsabilità in ordine a questi gravissimi
comportamenti».
“Il giornale” del 25 giugno 2009
riporta una notizia. C’è un’inchiesta, a Bari, che anziché restare riservata
finisce sui giornali, perché riguarda indirettamente un premier e/o persone a
lui vicine presumibilmente in contatto con alcune prostitute. E c’è un’altra
inchiesta, a Roma, che invece resta «sconosciuta» per quasi dieci anni e che
riguarda l’entourage di un altro premier in contatto sicuramente con una
scuderia di prostitute d’alto bordo. Il doppiopesismo mediatico-giudiziario cui
si fa riferimento concerne un’inchiesta avviata nel 1999 dal pm capitolino
Felicetta Marinelli e conclusasi il 4 ottobre 2000 con il patteggiamento a un
anno della maîtresse R.F. che secondo l’accusa inviava sue «squillo» ai
fedelissimi dell’allora presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, per ottenere
ritorni economici di vario genere.
A giocar troppo col fuoco si rischia di rimaner bruciati:
quelli che a sinistra puntavano il dito contro Silvio Berlusconi,
storcendo il naso per la “politica priva di morale” del Cavaliere, avrebbero
dovuto ricordarlo questo proverbio della saggezza popolare. Perché il ritornello
si è ritorto contro.
L’inchiesta pugliese alla base della
“scossa di Bari” si è, infatti, allargata con nuove “ragazze” pronte a
testimoniare e nuovi festini: incredibilmente non più solo a
Palazzo Grazioli, come preferirebbero quelli del partito del dito puntato, ma
anche a Cortina, Milano e nella stessa Bari. Festini che
coinvolgerebbero numerosi altri nomi noti fra imprenditori, professionisti e
politici, fra cui - appunto - alcuni esponenti baresi del PD.
Articolo che parla di prostitute
d’alto bordo coinvolte con uomini importanti e di ingressi “confidenziali” alla
Camera dei Deputati, che non ha reso per nulla contento l’ex Presidente del
Consiglio, Massimo D’Alema, che ha dato mandato ai suoi legali di querelare il
quotidiano. In quell’articolo viene tirato in ballo anche l’on. Cesa dell’UDC.
In relazione alla querela annunciata
dall’On. Massimo D’Alema e dall’onorevole Lorenzo Cesa,
Il Giornale
ribadisce che la notizia pubblicata si fonda su un dato di fatto
incontrovertibile: Cesa era socio, nella Global Media Srl, di R.F., la maitresse
che aveva organizzato un giro di squillo per ottenere favori da un gran numero
di politici, tra i quali alcuni stretti collaboratori di Massimo D’Alema. In
quella società Cesa era intestatario di quote per 11 milioni, R.F per otto.
Sui corsi e ricorsi storici, inutile
dirlo: la Rete ha buona memoria.
Correva l’anno 1994. Il pubblico
ministero pugliese, Alberto Maritati, stava indagando su un finanziamento
illecito erogato - tramite assegno - dal patron delle Cliniche Riunite di Bari a
Massimo D'Alema.
Nel giugno del 1995, quel processo fu
archiviato per decorrenza dei termini di prescrizione, su richiesta dello stesso
pm Maritati. Il gip Concetta Russi, con queste parole dispose l’archiviazione: “Uno
degli episodi di
illecito finanziamento riferiti, e
cioè la
corresponsione di un contributo di 20 milioni in favore del Pci,
ha trovato
sostanziale conferma, pur nella
diversità di alcuni elementi marginali,
nella leale dichiarazione
dell’onorevole D’Alema, all’epoca dei
fatti segretario regionale del Pci. Con riferimento all’episodio riguardante
l’illecito finanziamento al Pci, l’onorevole D’Alema non ha escluso che la somma
versata dal Cavallari fosse stata proprio dell’importo da quest’ultimo indicato”.
D’Alema, dunque, confessò di aver
percepito un finanziamento illecito per il Partito comunista. E tuttavia, non
venne condannato e non finì in gattabuia grazie alla prescrizione del reato da
lui compiuto. Destino diverso toccò agli indagati di Di Pietro.
Va aggiunto, inoltre, che il pubblico
ministero di questo processo, Alberto Maritati, fu candidato - per volontà di
D’Alema - alle elezioni suppletive del giugno 1999 (si era liberato un seggio
senatoriale, dopo la morte di Antonio Lisi). E divenne sottosegretario
all’Interno del governo presieduto dallo stesso D’Alema. Ancora oggi, Maritati,
siede al Senato nelle fila del Partito democratico.
Dalle mie parti si dice: una parola è
poca, e due sono troppe.
PARLIAMO DI “TOGHE BIANCHE”?
Di seguito si riporta il testo
integrale della lettera del 7 agosto 2009 di Niki Vendola, Presidente della
giunta regionale pugliese di centro sinistra, alla Desiree Digeronimo, P.M.
antimafia di Bari. Da premettere che Vendola, a causa delle inchieste sulla
“sanitopoli pugliese” aveva già ritenuto opportuno azzerare la sua giunta,
designando nuovi assessori.
“Gent.ma
Dott.ssa Digeronimo, l’amore per la verità non mi consente più di tacere.
Ho l’impressione di assistere ad un paradossale capovolgimento
logico per il quale i briganti prendono il posto dei galantuomini e viceversa.
Io ho la buona e piena coscienza non solo di non aver mai commesso alcun
illecito nella mia vita, ma viceversa di aver dedicato tutte le mie energie a
battaglie di giustizia e legalità. “Nichi il puro” titola “Panorama” per
stigmatizzare le mie presunte relazioni con un imprenditore che non conosco e a
cui ho chiuso, dopo trent’anni, una discarica considerata un autentico
eco-mostro (stupefacente notare che “L’Espresso” pubblica un articolo fotocopia
del rotocalco rivale: sarebbe carino indagare sul calco diffamatorio che origina
questa singolare sintonia di scrittura!). In effetti mi considero un puro: e non
rinuncio ad aver fiducia nel genere umano e a credere che la giustizia debba
alla fine trionfare. In questi anni di governo ogni volta che ne ho ravvisato la
necessità ho adottato provvedimenti tanto tempestivi quanto drastici a tutela
delle istituzioni: sono fatti noti, che fanno la differenza tra il presente e il
passato.
Ma la sua indagine, dott.ssa Degironimo, sta diventando, suo
malgrado, lo strumento di una campagna politica e mediatica che mira a colpire
la mia persona pur non essendo io accusato di nulla. Per antico rispetto verso
la magistratura e verso di lei ho evitato, in queste settimane, di reagire alla
girandola di anomalie con le quali si coltiva un’inchiesta la cui efficacia si
può misurare esclusivamente sui Tg.
La prima anomalia è che lei non abbia sentito il dovere di
astenersi, per la ovvia e nota considerazione che la sua rete di amici e parenti
le impedisce di svolgere con obiettività questa specifica inchiesta.
La seconda anomalia riguarda l’aver trattenuto sotto la
competenza della Procura Antimafia una mole di carte che hanno attinenza con
eventuali profili di illiceità nella Pubblica Amministrazione.
La terza riguarda l’acquisizione di atti che costituiscono il
processo di gestazione di alcune leggi, come se le leggi fossero sindacabili
dall’autorità inquirente.
La quarta riguarda la incredibile e permanente
spettacolarizzazione dell’inchiesta: che si svolge, in ogni suo momento, a
microfoni aperti e sotto i riflettori. Così per la mia convocazione in Procura.
Così per l’inaudita acquisizione dei bilanci di alcuni partiti e addirittura di
alcune liste elettorali. Il polverone si è mangiato i fatti: quelli
circostanziati legati al cosiddetto sistema Tarantini: e nella festosa scena
abitata da questo imprenditore io, a differenza persino di alcuni magistrati,
non ho mai messo piede.
Lei è così presa dalla sua inchiesta che forse non si è accorta
di come essa clamorosamente precipita fuori dal recinto della giurisdizione:
sono diventato io, la mia immagine, la mia storia, la posta in gioco di questa
ignobile partita. Non dico altro. Il dolore lo può intuire. Qualcuno sta
costruendo scientificamente la mia morte. Per me che amo disperatamente la vita
è difficile non reagire. Le chiedo solo di riflettere su queste scarne parole.
Nichi Vendola”.
Nel riportare i fatti, non ci possiamo esimere di eccepire sul
comportamento delle parti. Quando, nelle alte sfere, qualcuno è toccato dalle
grinfie della magistratura, si accusa la medesima di adoperarsi per protagonismo
o nell’interesse di una parte politica: mai per la giustizia.
Certo nessuno fa bella figura: non il politico danneggiato, né il
magistrato accusato, né i media che si prestano a dare voce solo al potente
pizzicato e non a migliaia di innocenti in carcere.
In questo stato di cose, però, quando siamo noi ad essere
fogocitati dalla Giustizia, con quale spirito ci possiamo affidare nelle mani di
questi signori ?? E chi ascolta le nostre grida di sofferenza??
Toghe rosse, toghe nere, toghe rotte. I giudici come le seppie e
i polpi: cambiano colore a seconda degli imputati? Si
chiede “Pocavista”. Vi ricordate le toghe rosse, celebrate dalla stampa e dalla
TV berlusconiana? Ebbene si è scoperto che le toghe indossate dai magistrati
sono dotate di particolari cellule, i cromatofori, come le seppie, i polpi e i
camaleonti. Per un fenomeno non ancora chiarito, i magistrati sarebbero in grado
di cambiare il colore delle proprie toghe a seconda dell’imputato che si trovano
di fronte: se l’imputato è di destra, la toga presenta pigmenti porpora; se di
sinistra, la toga vira al nero. Quando l’imputato è di centro, come nel caso di
Totò Cuffaro in carcere per mafia, le toghe assumono di nuovo un colore
rossastro. Il fenomeno è stato scoperto recentemente da Libero con l’articolo
“La toga rossa che inchioda i compagni”, dedicato a quel PM di Monza – esponente
di Magistratura Democratica, la corrente di sinistra della magistratura – che
indaga su Penati e la tangentopoli rossa. Finora i mezzi di informazione vicini
a Berlusconi sembravano ignorare che c’erano magistrati – rossi o neri che
fossero – che mandavano in galera il presidente democratico della Regione
Abruzzo, l’ex-socialista Del Turco; che mettevano sotto inchiesta il Sindaco di
Bologna, Del Bono; il PD Bassolino; la famiglia Mastella; il verde Pecoraro
Scanio; l’assessore alla sanità della Regione Puglia e così via. Era molto più
comodo definire “rossi” tutti i magistrati, per preparare il terreno a una
riforma che mettesse la giustizia di fatto sotto il controllo dell’esecutivo.
Dopo aver diffuso per anni la bufala che la magistratura è tutta di sinistra,
che il pool di Mani Pulite ha voluto salvare l’allora PCI dalle inchieste e che
perseguita Berlusconi solo da quando è entrato in politica, adesso i giornalisti
di destra tessono elogi di un PM “rosso” che diventa “nero” mettendo nei guai il
PD. Una parentesi : il Pool di Mani Pulite ha salvato l’allora PCI? Ricordiamo
che tra i primi arresti di tangentopoli ci furono Soave e Li Calzi del PCI; la
direzione del PCI di Milano, con Barbara Pollastrini & co (la Pollastrini venne
poi assolta dalle accuse pochi anni dopo) fu totalmente decapitata; mentre il
compagno Greganti, tesoriere del PCI, si fece diversi mesi di galera.
Altri esempi di trasformazione cromatica dei magistrati.
La potenza dei mezzi di informazione, specie TV, è tale da
colorare di rosso o di nero magistrati di volta in volta scomodi o che invece
portano acqua al proprio mulino. Gerardo D’Ambrosio, definito “nero” negli anni
70 dopo aver scagionato sia il commissario Calabresi per la morte dell’anarchico
Pinelli, sia Pino Rauti per la strage di Piazza Fontana, appena membro del Pool
di Mani Pulite divenne improvvisamente una “toga rossa” perché colpiva i
corrotti di Tangentopoli. Pierluigi Davigo, esponente della corrente
conservatrice della magistratura e considerato la mente giuridica del Pool di
Mani Pulite, diviene improvvisamente per la stampa berlusconiana un pericoloso
rivoluzionario di sinistra. Stessa sorte per Antonio Di Pietro, allora assai
vicino a esponenti del MSI. Pochi ricorderanno che Berlusconi, nel formare il
suo primo governo nel 94, lodava l’operato di Mani Pulite (che allora andava di
moda e che gli aveva spalancato le porte del governo) e aveva chiesto invano a
Davigo e Di Pietro di entrare al governo come Ministri della Giustizia e
dell’Interno. Circostanza poi negata successivamente da Berlusconi. Ilda
Bocassini, divenuta rossa per aver incriminato Previti e le toghe sporche da lui
corrotte per consegnare la Mondadori a Berlusconi, poi definita da alcuni “nera”
quando indagava sulle nuove BR, sventando tra l’altro un attentato a Paolo
Berlusconi e a “Libero”. Oggi è di nuovo” rossa”, da quando si occupa del caso
Ruby. Paolo Ielo, il magistrato “rosso” accusato di avere insabbiato le indagini
di Titti Parenti sul PCI, oggi sembra virare al nero, perché indaga sullo
scandalo ENAV di esponenti vicini a Bersani e D’Alema. Il giudice Mesiano,
quello che ha condannato La Fininvest a risarcire De Benedetti per averlo
scippato della Mondadori, ha i cromatofori perfino nei calzini, che diventano
pervinca all’occorrenza. E si potrebbe continuare.
Se Sparta piange, Atene non ride.
Notiamo solo che ogni volta che un esponente del PDL o della Lega passa dei guai
giudiziari, gli organi di informazione berlusconiani e leghisti parlano di
“persecuzione delle toghe rosse”, si fanno approvare leggi ad personam e si
punta alla prescrizione. Quando a finire nei guai è invece uno di
centrosinistra, si usa esprimere una rituale“fiducia nella magistratura” e
talvolta si fa dimettere l’indagato: ma per chi ha posto al centro della propria
azione politica la “questione morale” e ha rivendicato una propria “superiorità
morale” non rimane che l’imbarazzo. Imbarazzo che è ormai della maggioranza
degli italiani. Tuttavia tra chi a destra ha fatto della protervia e del
vittimismo il proprio stile di potere e chi a sinistra manifesta imbarazzo
quando viene colto con le mani nella marmellata, preferiamo chi è ancora capace
di arrossire.
Il problema forse non è tanto nel colore delle toghe ma nella
loro insita incapacità di cogliere la verità storica nelle vicende umane. La
loro presunta superiorità morale e culturale rispetto alla massa, avallata dal
concorso truccato che li abilita, li pone talmente in alto che miseri loro non
riescono a leggere bene la realtà che li circonda. Insomma loro son loro e noi
“non siamo un cazzo”.
Le strade italiane, oramai, sono diventate molto più transitabili, quasi
deserte, non perché le persone son diventate improvvisamente più casalinghe e
pantofolaie, ma semplicemente perché certuni PM e Giudici di casa nostra amano
sbattere nelle patrie galere chiunque gli giri intorno: quindi, tutti dentro
appassionatamente! Così scrive Massimo Melani su “Totalità”. La Corte Europea
dei Diritti Umani di Strasburgo accusa ad alta voce il nostro Paese, che viene
giustamente condannato per il trattamento inumano e degradante dei carcerati
detenuti nelle infernali galere italiche. Pensate che tale richiamo abbia
minimamente scosso gli uomini dalla galera facile? I pubblici ministeri, i Gip,
i Gup e i Procuratori Capo? Neanche per idea! Al minimo dubbio, al fresco, nei
Grand Hotel Italiani a -7 stelle; le cui stanze di meno di 3 metri quadrati
possono contenere anche tre o quattro detenuti. Ma, a loro cosa può interessare;
per le tenebrose toghe nere ciò che conta è apporre tacche su tacche alle loro
pistole fumanti. Tanto chi paga quest’ammasso di carne sovrapposta in loculi
invivibili è il cittadino italiano, i tantissimi processi, indagini, rinvii a
giudizio per chi non ha fatto un emerito c…., e i tantissimi suicidi che si
verificano settimanalmente in tali luoghi di tortura, non contano niente.
L’importante è che di fronte a una ridottissima controversia ci si copra le
spalle, ammanettando coloro che -di fatto- potrebbero a tutti gli effetti, e
molti lo sono, essere innocenti. Tanto i Giudici, i PM e compagnia bella non
verranno mai toccati, né verranno mai chiamati a rispondere in solido (
pecuniariamente, moralmente, penalmente) dei misfatti compiuti. Solo nei casi
eclatanti di magistrati pedofili, di giudici che usano il proprio ufficio per
ricattare sessualmente viados o donne della mala, o di quelli conniventi con le
varie mafie, si arriva a arrestarli, sed post breve tempus tutto viene
subdolamente fatto passare nel dimenticatoio. Questa, purtroppo, è la disperata
situazione della legge italiana, a voler continuare a non separare le carriere,
a rimandare da tempo immemore la riforma della giustizia, e all’equiparare reati
inferiori, quello, per esempio, di Fabrizio Corona, a reati gravissimi come
l’omicidio, altro esempio la sentenza vergognosa del macellaio Jucker che si è
fatto solo 10 anni per aver trucidato la fidanzata. In campagna elettorale si
parla di tutto, meno della libertà del cittadino italiano che sta scomparendo,
terrorizzato dalle cupe toghe nere.
Il rischio della rappresentanza politica è sbagliare il rappresentante, perché
questi signori nominati dall’alto si presentano in un modo e poi si comportano
al contrario. Uno strano decreto sui magistrati fuori ruolo.
Nel decreto del governo, la possibilità di aggirare i limiti di tempi e
di assumere incarichi nell'esecutivo scrive Milena Gabanelli, Luca Chianca su
“Il Corriere della Sera”.
Prima di esalare l’ultimo respiro il Governo Monti deve
completare l’approvazione delle norme che riguardano il famoso decreto
anticorruzione. Nell’ambito di questo decreto ce n’è
una che riguarda i magistrati fuori ruolo, ovvero quei magistrati chiamati a
ricoprire temporaneamente un incarico presso l’ufficio legislativo dei vari
ministeri, Capo gabinetto, le Autorità indipendenti, la Presidenza del
Consiglio, ecc.
Nella maggior parte dei casi questi incarichi prevedono un nuovo
stipendio senza perdere quello originario, fermo
restando l’obbligo a ritornare al loro posto dopo 5 anni.
Cosa significa? Che dopo l’approvazione
della norma il magistrato potrà fare il Direttore delle Agenzie, per esempio
l’Agenzia delle Entrate, delle Dogane, oppure il capo dipartimento dei
Ministeri, per esempio dell’Agricoltura o dello Sviluppo Economico, aprendo così
la strada ad una possibile situazione di conflitto permanente di interessi fra
organi dello Stato.
Ma perché un magistrato dovrebbe poter gestire il portafoglio
dell’industria italiana? Non dovrebbe essergli
consentito poiché appartiene alla funzione giurisdizionale, che per sua natura è
super partes e per definizione è organo terzo rispetto agli interessi pubblici
da gestire. La legge non dovrebbe pertanto consentire al magistrato di assumere
ruoli di gestione che spettano all’esecutivo! Dovrebbe prima dimettersi, e poi,
da libero cittadini, va a fare quello che vuole.
E come viene superato il limite massimo dei 10 anni in fuori
ruolo? Scrivendo nella norma: “i magistrati ordinari
contabili, amministrativi, militari, gli avvocati e i procuratori dello Stato
che ricoprono cariche apicali o semiapicali presso organi o enti partecipati o
controllati dallo Stato sono comunque collocati obbligatoriamente in aspettativa
senza assegni”.
Un linguaggio ambiguo e furbo che permette di superare ogni
vincolo temporale, poiché sull’“aspettativa senza assegni” la legge
anticorruzione non ha apposto nessun limite. In altre
parole: se oggi il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Antonio Catricalà, sarebbe costretto a tornare a fare il giudice
perché ormai sono passati 10 anni da quando è in fuori ruolo, con questa norma
potrebbe fare il Presidente di Eni o Finmeccanica, o all’Enel, o alla Rai, senza
tagliare il cordone ombelicale con la magistratura.
Ma chi in Presidenza del Consiglio ha predisposto il decreto
legislativo in corso di approvazione? Sappiamo che
Catricalà “filtra” le carte da portare a Monti, sappiamo che il ministro della
Funzione Pubblica (Filippo Patroni Griffi), che annovera tra le sue competenze
quelle di carattere ordinamentale come la norma in esame, è lui stesso un
Consigliere di Stato in fuori ruolo, come lo è il suo capo gabinetto
(consigliere Garofoli), ma chi abbia “cucinato” questo piattino, e in quali
stanze .. impossibile saperlo.
Se poi si considera che i magistrati in fuori ruolo sono 227, e
che gli uffici di provenienza sono il Tar, il Consiglio di Stato, la Corte dei
Conti, non si può eludere la domanda: con quale
indipendenza verranno giudicati i ricorsi contro gli atti di gestione approvati
da magistrati che saranno al contempo Capi dipartimento di Ministeri o
Presidenti di Società a partecipazione pubblica? Magistrati in palese conflitto
di interessi e che abdicano alla loro funzione di terzietà. Siamo sicuri che lo
spirito che animava il decreto anticorruzione era questo?
Monti si è rivelato un tecnocrate, un amministratore ante litteram che nulla ha
a che fare con l’innovazione e la progettualità necessaria ad uno Stato moderno.
Un tecnico fuori luogo che si è comportato come farebbe un medico che infierisse
con una cura da cavallo ad un paziente che non ne ha bisogno. Un burocrate alla
corte della signora Merkel, poco interessata all’Unione Politica Europea e molto
presa, di contro, dall’imporre la leadership economica e finanziaria della sua
Germania su tutti. Fatta questa premessa, scrive Francesco Saverio Di Lorenzo su
“Mondo Libero On Line”, senza pregiudizio alcuno e per essere il più possibile
asettico mi sono voluto togliere lo scrupolo di esaminare da vicino le svariate
iniziative parlamentari presentate dal Governo Monti. Così facendo mi sono
imbattuto, con un’autentica sorpresa, nella “propina”. Un termine nuovo che ho
abbinato immediatamente ad un medicinale od a qualcosa di simile. No, non lo è.
E’ un emolumento, manco a dirlo un’indennità particolare percepita solo da pochi
eletti. Vi chiederete: possibile? E chi sono i fortunati? Presto detto, sono gli
ottomila della Magistratura Ordinaria, ma anche quelli in organico
dell’Avvocatura dello Stato, del Tar, della Corte dei Conti, del Consiglio di
Stato. E quindi, si va dal rigorosissimo Giuseppe Esposito, magistrato del Tar
di Napoli, che partecipa a incontri con le scolaresche di Vico Equense e devolve
gli 800 euro di compenso alla biblioteca scolastica. Al ben diverso caso del
Consigliere di Stato Gabriele Carlotti che, oltre allo stipendio regolare,
riceve dall’Autorità per l’Energia 100 mila euro l’anno, in quanto responsabile
della Direzione degli Affari Giuridici. Dalla lettura degli atti si evince che
nell’ultimo anno il CSM ha autorizzato 1423 incarichi a tempo parziale. Nella
gran parte si tratta di incarichi di docenza, per lo più lezioni universitarie
di Magistrati che incassano poche migliaia di euro, ma li incassano. Di ben
altro tenore e spessore sono gli incarichi dei 516 Giudici della Magistratura
Amministrativa, dei 456 della Contabile e dei 360 dell’Avvocatura dello Stato.
Gli emolumenti incassati da questi ultimi ammontano a 54 milioni di euro,
decurtati per le misure di solidarietà a 53 milioni (grazie!). A questi vanno
aggiunti altri 55 milioni di euro per un’indennità particolare detta “propina”.
Per fare dei casi esplicativi, il Capo Ufficio dell’Avvocatura Generale dello
Stato, sua eccellenza Filippo Ignazio Caramazza, gode di un trattamento
fondamentale di 289 mila euro a cui va aggiunta la “propina” di altri 324 mila
euro. Caramazza risulta avere un incarico extragiudiziale in quanto membro della
commissione di accesso ai documenti amministrativi. Pierluigi Di Palma,
Vicesegretario Generale della Difesa, Giudice dell’Avvocatura di Stato incassa
179 mila euro di trattamento fondamentale e 186 mila di “propina” e nel corso
del 2011 anche 70 mila euro come consulente giuridico dell’Agenzia Spaziale
Italiana. Non basta, risulta essere anche presidente del collegio arbitrale per
una vertenza tra Anas e Asfalti Sintex, ma qui non sappiamo l’ammontare
dell’emolumento. La categoria dei Giudici Amministrativi, provenienti dal Tar e
dal Consiglio di Stato, rappresenta la spina dorsale dei ministeri. Sono
moltissimi quelli che hanno il doppio incarico di Giudice e di Capo Ufficio
Legislativo o Capo di Gabinetto. Il più noto è forse Filippo Patroni Griffi,
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. In quanto Ministro alla Pubblica
Amministrazione è colui che ha portato questi dati in Parlamento e doverosamente
ha inserito anche i dati che lo riguardano. Patroni Griffi comunica quindi di
essere fuori ruolo dal momento della nomina nell’Esecutivo. Da quella data
guadagna 17 mila euro al mese in quanto Ministro. Ha appena esaurito anche
l’incarico extragiudiziario di Presidente del Consiglio arbitrale in una
vertenza tra Fiat e Tav, percependo 76.950 euro netti. Vi sono poi, una raffica
di doppi incarichi: Michele Buonauro cumula l’incarico di Giudice del Tar con la
consulenza giuridica all’Autorità per le Comunicazioni e che per due giorni a
settimana di impegno incassa 35 mila euro lordi; Paolo Carpentieri ottiene 60
mila lordi come Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni
Culturali; Giuseppe Caruso prende 58 mila lordi in quanto membro della
Commissione di Valutazione dell’Impatto Ambientale al Ministero dell’Ambiente;
il Sottosegretario alla Presidenza Antonio Catricalà è fuori ruolo e incassa 25
mila euro netti dalle funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri; Claudio
Contessa incassa 73 mila euro per l’Ufficio Legislativo del Ministero del
Lavoro; Roberto Garofoli ottiene 70 mila euro lordi in quanto Capo di Gabinetto
del Ministro per la Pubblica Amministrazione. I dati sugli emolumenti, sulla
“propina”, di moltissimi altri alti funzionari non sono ancora giunti, perché il
Ministero si è riservato di comunicarli. Eccovi serviti. Non viene l’amaro in
bocca e la rabbia nel verificare quanti sperperi ci siano ancora in giro e
quanti altri ancora probabilmente esistono? Perché, Monti nel provvedimento
“Salva Italia”, non ha inserito ed annullato la “propina”, anzi che tassare e
propinare a noi sacrifici e balzelli? Il Professore in loden, il Senatore della
Repubblica, l’uomo che ha la presunzione di aver risollevato le sorti del Paese,
forte con i deboli e debole con i forti, ha adoperato due pesi e due misure.
Peccato, la sua poteva essere un’operazione di glasnost senza precedenti. Per la
prima volta nella storia si era creata la concreta possibilità di incidere
profondamente sui mali della politica ed in ciò che ha ingenerato, Si poteva
riformare seriamente lo Stato tranciando le sue cancrene ed offrire al Paese
delle riforme profonde, stabilendo un giusto freno ad alcuni titolati, già di
per se privilegiati ed intoccabili. Invece? Nulla. La strategia è stata banale,
tipica del “Centolaqualunque”. Nelle Aule Parlamentari presentava provvedimenti
chiedendo il voto di fiducia con la formula del decreto di necessità ed urgenza,
come la famigerata IMU, il taglio alla spesa pubblica, la riforma delle
pensioni, quella sul lavoro e le tasse che hanno vessato le famiglie ed i ceti
medio bassi. Mentre le liberalizzazioni, l’abolizione degli Ordini
Professionali, i tagli alle caste (tra queste quella della politica),
l’abolizione delle Province (ridotte, poi, a semplice accorpamento di alcune di
esse) faceva seguire un iter più complesso ed usuale attraverso il disegno di
legge. Ecco, in estrema sintesi la realtà. Potrà sempre dire il buon Monti che
non ha avuto tempo a sufficienza per condurre a termine il proprio lavoro,
perché nel frattempo è stato sfiduciato. Non ci rimane che attendere la prossima
puntata ed “incazzatura”, trasparenza e Movimento 5 Stelle permettendo!
TOGHE
COLLUSE.
Punta sul rosso, bluffa con una doppia coppia..., scrive Enzo D’Errico su “Il
Corriere della Sera”. C'è una serata che fila per il verso giusto e altre,
tante altre, in cui va tutto storto: le carte non entrano, i numeri non
escono... E alla fine, quando si tratta di tirare i conti, t'accorgi che in
rosso ci sei finito tu. E' capitato così anche a Nicola Boccassini, procuratore
della Repubblica di Vallo della Lucania, un paesino dell'entroterra salernitano.
Aveva trovato il modo di turare le falle, il magistrato: quel che perdeva al
gioco, lo riguadagnava vendendo processi, condoni edilizi e provvedimenti d'ogni
tipo. Si faceva addirittura pagare soggiorno e scommesse a Saint Vincent, dove
era cliente fisso del casinò. E, come se non bastasse, in cambio dei suoi
servigi chiedeva favori: un posto di lavoro per una figlia, una perizia tecnica
da assegnare al genero, un appalto per qualche parente. Però, gli agenti della
Dia di Napoli l'hanno arrestato su mandato del Gip Luigi Esposito. Le accuse:
corruzione, concussione, favoreggiamento e abuso d'ufficio. Con lui sono finite
in galera altre 6 persone, coinvolte a vario titolo nel giro d'affari del
procuratore. Sarebbero stati emessi anche 7 avvisi di garanzia, uno dei quali
riguarderebbe Anacleto Dolce, procuratore aggiunto a Vallo della Lucania e
fratello di un altro magistrato, Romano Dolce, arrestato a Como nelle scorse
settimane. Il sospetto è che il numero due della procura abbia spalleggiato gli
imbrogli di Boccassini. Nella rete degli investigatori, comunque, è caduto
l'avvocato Mario Siniscalco, ex consigliere comunale socialista di Salerno: era
lui, secondo gli inquirenti, a fare da mediatore fra il magistrato e i suoi
"clienti". Avevano messo in piedi una piccola ma efficiente società del
malaffare. Siniscalco, tra l'altro, è stato a lungo presidente della commissione
edilizia di Salerno, organismo di cui ha fatto parte anche Boccassini. E lì
dentro i due hanno concesso più di un condono sospetto. L'inchiesta prende il
via dalle dichiarazioni di Mario Pepe, un pentito della camorra, e
dell'imprenditore Elio Graziano, ex presidente dell' Avellino, coinvolto tempo
fa nello scandalo delle "lenzuola d'oro". L'industriale ha raccontato che,
sborsando una trentina di milioni, ottenne dal procuratore il condono edilizio
per la sua villa. E che Boccassini, all'epoca sostituto a Salerno, aggiustò un
processo d'appello in cui Graziano era imputato di omicidio colposo per la morte
in fabbrica di un operaio: condannato in primo grado, assolto in seconda
istanza. L'imprenditore pagò l'intercessione assumendo una figlia del magistrato
e scucendo altri milioni. "C'erano giorni in cui Siniscalco mi chiamava e mi
diceva: "Prenotaci una stanza a Saint Vincent" ed io ero costretto a pagare
albergo e casinò", ha detto in sostanza Graziano. Manette anche per i
faccendieri Franco Ferolla e Antonio Sabia. Si vantavano di poter condizionare i
processi e furono messi sott'inchiesta da Boccassini per millantato credito.
Sembra, però, che quell' indagine servì solo ad accordarsi coi due e
coinvolgerli nel giro d'affari. Arrestate, infine, Laura e Liliana Clarizia,
titolari dell' agenzia pubblicitaria "First Agency", di cui era socia un' altra
figlia del procuratore. L'azienda, grazie a Boccassini, ricevette dalla comunità
montana Lambro Mingardo la fornitura di 20 mila depliant pubblicitari. Non a
caso, in cella è finito pure il sindaco di Ascea, Angelo Criscuolo, ex
presidente della comunità montana.
Ottavio Ragone, "La Repubblica", 15 giugno 1994. Ai tavoli verdi di Saint
Vincent, Nicola Boccassini era un volto conosciuto. Tra un poker e uno chemin de
fer, il procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania, grosso centro del
Salernitano, trascorreva intere notti al casinò. Amava giocare d'azzardo
Boccassini, ma era un perdente, sperperava milioni, accumulava debiti su debiti.
Per pagarli - sostiene l'accusa - il giudice vendeva i processi, garantiva
assoluzioni a archiviazioni al miglior offerente. Oppure chiedeva un posto di
lavoro per le figlie. Ieri Boccassini è stato arrestato in casa, a Salerno, in
un'operazione che ha portato in carcere altre sei persone. I detective della Dia
gli hanno mostrato un ordine di custodia cautelare per corruzione, concussione,
abuso d'ufficio, favoreggiamento. Si è scoperto che quel giudice sempre
elegante, frequentatore dei salotti buoni di Salerno, era stato per dieci anni
il temutissimo ras della procura di Vallo della Lucania. "Boccassini andava al
casinò e io dovevo pagargli la stanza d' albergo", ha raccontato l'industriale
Elio Graziano, ex presidente dell' Avellino calcio, che dopo l'arresto di tre
mesi fa ha scelto di collaborare. "Una sera gli consegnai un milione, lo perse
in mezz' ora con puntate sballate". Boccassini apriva inchieste a suo
piacimento, le usava come armi di ricatto per rastrellare denaro. E assegnava
perizie d'ufficio al suo futuro genero Attilio Roscia pagandogli di persona le
consulenze, affinché mettesse qualcosa da parte in vista del matrimonio con la
figlia. Mesi fa, dopo le prime accuse dei pentiti tra cui il camorrista Mario
Pepe, il Csm aveva sospeso Boccassini dalle funzioni e dallo stipendio,
ordinando il trasferimento d'ufficio. Cionostante il giudice frequentava ancora
loschi personaggi, come provano le foto scattate dalla Dia. Ma i sospetti
investono pure un'altra toga di Vallo della Lucania, il sostituto procuratore
Anacleto Dolce, fratello di Romano Dolce, il magistrato di Como arrestato
settimane fa nell'inchiesta su un traffico di armi e scorie nucleari. Dolce ha
ricevuto un'informazione di garanzia per abuso d'ufficio: anche lui avrebbe
affidato perizie a Roscia e liquidato le parcelle. Si parla di un terzo giudice
inquisito, ma sul nome c'è riserbo. Oltre a Boccassini, che oggi sarà
interrogato dal gip Luigi Esposito, la procura di Napoli ha arrestato l'avvocato
Marco Siniscalco, ex consigliere comunale psi a Salerno, amico e "socio" di
Boccassini con cui spendeva un patrimonio al casinò; Angelo Criscuolo,
presidente della Comunità Montana Lambro e Mingardo e sindaco di Ascea, nel
Cilento; i faccendieri Franco Ferolla e Antonio Sabia; le sorelle Laura e
Liliana Clarizia, titolari della "First Agency" di cui era socia una figlia di
Boccassini e dove si vedeva spesso anche la moglie del giudice. Si è scoperto
che la "First Agency" ottenne un lucroso appalto dalla Comunità Montana, la
fornitura di 20 mila depliant turistici, un "omaggio" del presidente Criscuolo
ai familiari di Boccassini. Ferolla e Sabia chiesero venti milioni ad una coppia
per "aggiustare" un processo nel tribunale di Vallo, si sospetta con la regìa
del procuratore. L' avvocato Siniscalco faceva parte della commissione comunale
per il condono edilizio, di cui era membro pure Boccassini. Si misero d' accordo
e dietro compenso fecero in modo che non fosse demolita la villa abusiva di Elio
Graziano, imprenditore, anni fa coinvolto nello scandalo delle "lenzuola d' oro"
delle Ferrovie. Proprio Graziano ha raccontato i segreti di Boccassini. I due si
conobbero quando il giudice era sostituto procuratore generale a Salerno.
Graziano, condannato per omicidio colposo per la morte sul lavoro di un suo
operaio, fu assolto in appello grazie all'intervento del magistrato. Dopo la
sentenza Boccassini avvicinò l'imprenditore: "Mia figlia cerca lavoro", disse. E
Graziano, pronto: "Eccellenza, sono a disposizione". La ragazza fu assunta ma
secondo l'industriale intascava lo stipendio senza presentarsi in ufficio: "In
pratica le pagavo gli studi", ha spiegato l'ex presidente dell'Avellino,
aggiungendo che Siniscalco e Boccassini pretesero un mutuo di settanta milioni
per l'acquisto di una casa. Il giudice volle un altro prestito di trenta milioni
dalla Cassa rurale di Omignano Scalo, presieduta fa Fernando Cioffi: l'istituto
era sotto inchiesta, ma il solerte Boccassini chiese l'archiviazione del
fascicolo.
Luca Fazzo, "La Repubblica", 14 novembre 1993. Il magistrato Alberto Nobili è
uno dei quattro pm sui quali, secondo le dichiarazioni del pentito, i giudici
fiorentini starebbero indagando. Sarebbe accusato di non aver arrestato Giovanni
Salesi in occasione dell'inchiesta sulla morte di un pregiudicato gelese. Nobili
coordinò la recente operazione. "Nord-sud" che coinvolse il generale dei
carabinieri Delfino. Tre paginette di verbale, dettate da un mafioso catanese,
mettono una contro l'altra due tra le Procure più importanti d'Italia, quella di
Milano e quella di Firenze, portando in piazza storie vere o inventate di
giudici corrotti, di inchieste nascoste, di contatti inconfessabili tra gli
uomini dello Stato e i suoi nemici. Otto giorni fa, il 6 novembre, il "pentito"
catanese - sconvolto, quasi in lacrime - si presenta dai giudici lombardi con
cui collabora da tempo e dice: mi hanno chiamato i giudici di Firenze Pierluigi
Vigna e Giuseppe Nicolosi, quelli che indagano sull'autoparco milanese in mano
alla mafia. Loro, e i loro amici della Guardia di finanza, mi hanno detto che
sanno che i giudici di Milano sono corrotti. Mi hanno chiesto conferme, altre
rivelazioni, particolari. Non hanno messo niente a verbale. Ma mi hanno fatto
dei nomi: Antonio Di Pietro, Armando Spataro, Alberto Nobili, Francesco Di
Maggio. Scoppia il finimondo Ieri le affermazioni del pentito vengono riportate
dal Corriere e dal Giornale. E scoppia il finimondo. Francesco Saverio Borrelli,
il capo della Procura, parla a nome di tutti: "Reagiremo - dice - con la massima
fermezza. Da sempre, e in particolare da qualche anno, la Procura di Milano è
impegnata su più fronti nell'accertamento di fatti gravissimi di criminalità
mafiosa, la recente brillante operazione guidata da Alberto Nobili ne è la
riprova, e nel campo della pubblica amministrazione. Essendo questo impegno
evidente, ed essendo evidente anche l'esistenza di interessi assai cospicui che
vengono posti a repentaglio dall'attività dei magistrati di Milano, era
prevedibile ma non perciò meno deplorevole che si sarebbero infittiti i
tentativi di gettare discredito. Noi contro questo tentativo, che non sappiamo
ancora da quale direzione provenga, reagiremo con la massima fermezza ma anche
con la massima serenità perché siamo certi, graniticamente certi, della nostra
assoluta trasparenza e aggiungo, quale responsabile dell' ufficio, che ben
conosco la professionalità altissima dei miei aggiunti e dei miei sostituti. In
questa situazione, come sempre, i miei sostituti avranno da me la massima
copertura". Del pentito che ha incontrato i giudici di Firenze dice: "E' un
collaboratore della Procura e non si discute la sua credibilità verso quello che
dice a noi nell' ambito delle nostre indagini. Questa vicenda invece è tutta da
accertare". Borrelli conferma di avere partecipato personalmente all'
interrogatorio del pentito e di avere chiesto per iscritto chiarimenti al
collega Pierluigi Vigna: una lettera rimasta, finora, senza risposta. Passano le
ore, senza che si riesca ad afferrare il bandolo della vicenda. I contatti tra i
magistrati intanto continuano frenetici. Ma l'impressione è che un tentativo di
chiarimento sia in corso. Alle otto di sera, al termine di questa giornata
campale, Francesco Saverio Borrelli appare più rilassato che durante il briefing
di mezzogiorno. Signor procuratore, molte cose non quadrano. Lei ha spiegato di
avere scritto a Vigna per chiedere spiegazioni, il suo collega di Firenze dice
invece di avere appreso delle rivelazioni del pentito solo dai giornali. "Ho
parlato al telefono con Pierluigi Vigna all'inizio del pomeriggio. Mi ha detto
di non avere ancora ricevuto la mia lettera, e questo è comprensibile visti i
tempi delle poste italiane. Mi ha confermato che mi risponderà immediatamente.
Io attendo per martedì o mercoledì prossimi i chiarimenti che gli abbiamo
chiesto nello spirito di correttezza che contraddistingue i nostri rapporti". Le
affermazioni del pentito, per la verità, non descrivono un quadro di grande
correttezza. "Nel merito di queste dichiarazioni preferirei non entrare. Voi
pretendete valutazioni immediate, invece vi sono delle circostanze in cui è
necessario approfondire". Però lei stamane ha rivendicato l' attendibilità di
questo personaggio. "Attenzione, io ho semplicemente fatto presente che il
contributo dato da questo collaboratore alle inchieste della Procura di Milano
si è rivelato n contributo serio. Non ho detto, né potevo dire, che questo
signore dice la verità qualunque argomento tratti. Voglio dirle anche che io
penso da sempre che la comunicazione è qualcosa di complicato, a volte le parole
invece che veicolare il pensiero lo confondono. Vi è stato un incontro, e
bisogna capire chi ha detto e cosa ha detto, e l' altro come ha recepito questo
messaggio. E' difficile, ed anche per questo io non vorrei drammatizzare".
Stamane lei sembrava molto preoccupato. "Certo, perché in un passaggio
periglioso per le istituzioni, in cui la magistratura, e non solo quella
milanese, ha assunto tanta importanza bisogna tenere gli occhi bene aperti per
evitare di cadere in trappola. Bisogna però anche evitare ogni precipitazione,
perché potrebbe essere segno di debolezza mentre noi siamo molto tranquilli".
Vigna le scriverà, spiegherà cosa è accaduto quel giorno durante l'
interrogatorio. Ma se alla fine, come è possibile, la situazione fosse del tipo:
la parola del pentito contro la parola di Vigna, voi a chi credete? "Mi sembra
un paragone improponibile. E' chiaro che non possono esistere dubbi". Il clima
creato nel tribunale milanese dall' esplodere della vicenda è molto pesante,
anche perché i nomi che compaiono nei verbali sono quattro dei nomi più noti e
rispettati del palazzaccio di corso di Porta Vittoria. Uno, Francesco Di Maggio,
è diventato quest' anno vicedirettore generale delle carceri. Gli altri tre sono
ancora in Procura: Antonio Di Pietro è il simbolo dell' Italia che cambia,
Alberto Nobili e Armando Spataro sono due tra i magistrati di punta della
Direzione distrettuale antimafia, autori delle più importanti inchieste degli
ultimi tempi contro il crimine organizzato in Lombardia. Dall' ufficio del
procuratore capo Saverio Borrelli partono telefonate a raffica verso tutti i
protagonisti della vicenda. Ma, con il passare delle ore, la situazione invece
di chiarirsi si complica sempre di più. Giulio Catelani, procuratore generale a
Milano, durante un convegno conferma integralmente le anticipazioni dei due
quotidiani. "Mi scappa da ridere", dice (ma senza nemmeno l' ombra di un
sorriso) Armando Spataro. "Mi aspettavo il tritolo o le calunnie - commenta
Alberto Nobili - e per adesso sono arrivate le calunnie". Antonio Di Pietro e
Francesco Di Maggio si chiudono nel silenzio. Ma ormai anche le forme, che di
solito racchiudono le polemiche tra giudici, sono saltate. Molto preciso I
magistrati di Milano fanno sapere che il racconto del "pentito" sul suo incontro
con i giudici fiorentini è preciso in modo impressionante, che la sua
attendibilità è considerata altissima, e accusano senza mezzi termini i colleghi
fiorentini di indagare su di loro in modo clandestino, fuori da ogni regola del
codice e con ipotesi di reato gravissime. Si viene a sapere che uno dei
magistrati chiamati in causa ha chiesto al procuratore Borrelli che l'
interrogatorio del "pentito" sia trasmesso subito alla procura di Bologna,
competente per i reati commessi dai giudici di Firenze: l' ipotesi di reato
sarebbe, nel migliore dei casi, quella di abuso d' ufficio, per avere
interrogato il catanese senza metterne a verbale le dichiarazioni. I fiorentini
ribattono facendo capire che è in corso una manovra per screditarli, per
togliere attendibilità alle scoperte compiute in questi mesi dal Pm Nicolosi
sulla penetrazione della mafia a Milano e sui suoi contatti - attraverso una
loggia massonica - con gli apparati dello Stato. E' l' inchiesta sull' autoparco
milanese di via Salomone, la stessa che ha portato poche settimane fa Vigna e
Nicolosi a fare arrestare cinque poliziotti milanesi tra cui un vicequestore,
Carlo Iacovelli, indagato per associazione mafiosa.
Cinzia Sasso, "La Repubblica" del 16 novembre 1996. Ruota intorno al costruttore
Antonio D'Adamo, ai rapporti con il suo difensore Giuseppe Lucibello e con il
cliente più famoso di quest' ultimo, Francesco Pacini Battaglia, l'ultima
trincea dell' inchiesta su Antonio Di Pietro. I magistrati di Brescia avevano
già ricevuto dai colleghi di La Spezia i pacchi di intercettazioni telefoniche,
i rapporti del Gico e pure i riscontri dei rapporti patrimoniali fra il
banchiere e D'Adamo. Rapporti di denaro, molto denaro, transitato estero su
estero, da società di Pacini a società di D'Adamo. E D'Adamo è, dai vecchi
tempi, un buon amico di Di Pietro. Tanto amico da aver dato in uso a Susanna
Mazzoleni, moglie dell'ex pm, un telefono cellulare nell'epoca in cui il
portatile era uno status symbol per pochi. Ma a Brescia è stata riaperta nei
giorni scorsi anche un'altra vicenda che rischia di provocare un nuovo
terremoto: quella sull' Autoparco di via Salamone a Milano, l'autoparco della
mafia scoperto dal Gico di Firenze e all' origine del rancore tra la Procura di
quella città e quella di Milano. Da Bologna, dov'era finito protocollato a
modello 45, è arrivato a Brescia il nuovo rapporto del colonnello Giuseppe
Autuori (sollevato dall'incarico di comandante del gruppo Gico di Firenze e
trasferito a Bologna), compilato nel '95 e incentrato sui sospetti di coperture
da parte degli ambienti investigativi e giudiziari milanesi a quella che è stata
ritenuta una base della mafia al nord. Sono passati due anni dalla chiusura di
un' altra inchiesta, a Brescia, su alcuni aspetti di quella vicenda. Un pentito
aveva accusato - e poi ritrattato le accuse - un pm al di sopra di ogni
sospetto, Alberto Nobili, della Dda milanese. L'indagine si era chiusa con
un'archiviazione per Nobili e l'apertura di un procedimento per calunnia contro
il pentito che l' aveva accusato. Ma nel rapporto di Autuori non si parla solo
di Nobili: si parla anche di Di Pietro, ai tempi commissario al quarto distretto
di polizia, nella competenza del quale rientrava l'Autoparco, e di altri
magistrati e investigatori milanesi. Per Giancarlo Tarquini, da poco arrivato a
dirigere la Procura di Brescia, i grattacapi non finiscono qui: i primi giorni
di ottobre, dal gip di Roma Maurizio Pacioni, è arrivata una relazione su
presunte irregolarità compiute dal pool milanese di Mani pulite quasi al
completo più l'ex gip Italo Ghitti a proposito di un' inchiesta - cominciata a
Milano e finita a Roma con un'archiviazione - su un appartamento-tangente dato
dalla Fiat al senatore democristiano Giorgio Moschetti. A Roma era stato il pm
Francesco Misiani a occuparsene e aveva avuto non poche difficoltà a ottenere le
carte dai colleghi di Milano. In questo caso i magistrati di Milano sono stati
iscritti al registro degli indagati per abuso d' ufficio. La vicenda è molto
complessa e riguarda anche Filippo Dinacci, figlio dell'ex capo degli ispettori
ministeriali Ugo Dinacci (sotto processo a Brescia per la presunta concussione
ai danni di Di Pietro). Quell'appartamento della Fiat - valore 2 miliardi e 400
milioni - sarebbe poi stato messo a disposizione, secondo il dirigente della
Fiat Ugo Montevecchi che denunciò il caso, del figlio di Dinacci (che ha sempre
smentito). Oggi, a Brescia, si ricomincia. "Il confronto con i colleghi di La
Spezia - ha detto alle 20.15 il procuratore Tarquini rientrato in Procura - è
stato utile, come lo sono sempre i confronti con i colleghi". E si ricomincia da
Antonio D' Adamo, dal suo ruolo che a Brescia era già stato al centro dell'
attenzione. Già secondo il pm Fabio Salamone c'era D'Adamo dietro molti misteri
del caso Di Pietro. Le carte di La Spezia pare gli stiano dando ragione.
Virus su rai 2 condotto da Nicola Porro. 22:33
va in onda un servizio dedicato al caso del magistrato Antonio Lollo di Latina.
Gomez: "C'è un problema in Italia riguardo i tribunali fallimentari. Non è la
prima volta che un magistrato divide i soldi con il consulente. Nelle
fallimentari, è noto che c'è la cosiddetta mano nera. Sulle aste, succedono cose
strane. E se lo dice Peter Gomez, direttore de "Il Fatto Quotidiano",
notoriamente giustizialista e manettaro oltre che asservito alla magistratura, è
tutto dire.
"Tangenti e
cricche si possono sconfiggere ma ci sono anche giudici riluttanti".
"La magistratura in qualche caso ha dato l’impressione d’essere dura e pura
davanti a questioni banali e di non saper affrontare con fermezza i problemi più
gravi. E qualche collega non ha voglia di impegnarsi in inchieste difficili".
Intervista a Raffaele Cantone, presidente dell'Anticorruzione, tratta dal nuovo
libro scritto con Gianluca Di Feo.
«Non voglio
creare illusioni, ma neppure lasciare alibi. La guerra alla corruzione si può
fare. L’Autorità che guido non può arrestare né intercettare: non può bloccare
le tangenti. Ma ha altri poteri, che cominciano a dare qualche risultato».
Raffaele
Cantone è il presidente della prima struttura creata in Italia per cercare di
prevenire la corruzione. Un modo nuovo di affrontare il problema, insistendo
sulla trasparenza, sul merito, sulla fiducia nella capacità di riscatto del
Paese. In un solo anno ha dovuto misurarsi con gli scandali dell’Expo, del Mose
e di Mafia Capitale. E adesso affida a un libro intervista scritto con Gianluca
Di Feo de “l’Espresso” l’analisi de “Il male italiano” più grave: un morbo più
profondo delle tangenti, che ha contaminato l’intera società. Cantone discute
delle colpe della politica, degli imprenditori e della burocrazia. Senza
risparmiare critiche alla magistratura, a cui è orgoglioso di appartenere. Come
in queste pagine che anticipiamo.
Raffaele
Cantone, lei sostiene che per domare la corruzione è necessario puntare su tre
pilastri: repressione, prevenzione e una battaglia culturale per cambiare
l’atteggiamento degli italiani. Partiamo dalla repressione: cosa bisogna fare?
«Prima di
tutto, bisogna porre l’attenzione su una questione organizzativa, ossia la
capacità della magistratura di mettere in campo il meglio. Ancora oggi esistono
realtà in cui non si aprono indagini per tangenti, nonostante nel Paese non
esistano zone franche. Questo male si manifesta ovunque, seppure con diversi
livelli di intensità. Se la corruzione non viene scoperta, significa che c’è un
problema, nelle procure o negli inquirenti, e questo è anche specchio
dell’inefficienza della magistratura nell’affrontare questioni complesse. Credo
che sia necessaria un’autocritica sull’organizzazione giudiziaria e
sull’importanza che viene riconosciuta alla lotta alla corruzione. Per esempio,
non tutti gli uffici investigativi hanno pool specializzati per i reati di
questo tipo. Che richiedono grande impegno e professionalità: quando le
inchieste vengono fatte bene, i risultati arrivano sempre».
Ma se la
giustizia non funziona, come si può fermare la corruzione? Oggi l’impunità per i
colletti bianchi è praticamente certa: la maggioranza dei procedimenti per
corruzione si chiude con la prescrizione o con pene irrisorie. Quasi sempre i
protagonisti degli scandali riescono a tornare al loro posto.
«La
repressione giudiziaria è il momento chiave della lotta, senza il quale la
prevenzione non ha alcun senso. Inutile mettere in campo strumenti per impedire
la corruzione, se i reati non vengono puniti. Anche negli anni di Mani Pulite le
inchieste sono state a macchia di leopardo. In quel periodo c’è stato il più
alto livello di incriminazioni, ma studiando le statistiche giudiziarie ci si
rende conto che esistono vuoti assoluti in alcune zone d’Italia: perché quelle
procure non hanno indagato? Di sicuro non perché in quei territori non ci
fossero tangenti o finanziamenti illeciti. La legge Cirielli del 2005 è stata
devastante, perché ha reso la prescrizione di questi reati più rapida, ma anche
prima di allora tanti processi venivano buttati via perché si perdeva troppo
tempo. Ricordo la prima indagine sulle ecomafie in Italia, che ha fatto finire
alla sbarra l’alleanza tra boss casalesi, politici e funzionari campani: una
vicenda fondamentale, l’origine dell’avvelenamento di un’intera regione.
L’assessore della Provincia – che aveva intascato tangenti per autorizzare il
trasporto di rifiuti illeciti – venne condannato, in primo grado, poi in appello
ci sono stati talmente tanti rinvii che si è arrivati alla prescrizione. E di
casi come questi ce ne sono moltissimi. Oggi ci sono istruttorie che vengono
cancellate dal tempo prima ancora che sia pronunciato qualunque giudizio:
l’inchiesta finisce nel cestino senza neppure l’incriminazione. Questo ha un
effetto disastroso: oltre a non dare un colpo al malaffare, trasmetti la
certezza dell’impunità. Una parte della magistratura compie il proprio dovere e
difende i processi. Ma bisogna riconoscere che un’altra parte, sicuramente
minoritaria, non sempre ha fatto tutto quello che poteva».
Nel 1992 i
risultati delle indagini milanesi e il sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino hanno cementato il consenso degli italiani verso i giudici.
Piercamillo Davigo ha detto che la magistratura non ha fatto una rivoluzione, ma
ha salvato la credibilità delle istituzioni, impedendo che la crisi economica e
politica di quegli anni degenerasse nel caos. Adesso la fiducia nella categoria
è ai minimi e la paralisi della giustizia insostenibile. Ma non sembra che la
magistratura tenti di trovare soluzioni.
«Nella
magistratura convivono varie anime. Lei ha citato il 1992, ma anche allora era
divisa. Mentre Falcone, Borsellino, Livatino venivano uccisi, c’era un pezzo di
magistratura che faceva in modo molto più burocratico la sua parte. Nel 1980,
l’assassinio del procuratore di Palermo Gaetano Costa, una figura la cui probità
dovrebbe essere d’esempio a tanti, venne collegato al fatto che alcuni colleghi
avevano preso le distanze dalle sue decisioni, rifiutandosi di firmare l’ordine
d’arresto per i capi di Cosa nostra. Oggi come allora, tra le toghe c’è chi fa
il suo dovere con abnegazione, correndo rischi altissimi, e chi non lo fa:
numericamente questi ultimi sono molti di meno, una percentuale inferiore alla
media riscontrata negli altri settori della pubblica amministrazione. E non è un
caso che nel 1988 si sia preferito insediare Antonino Meli e non Falcone alla
guida degli inquirenti di Palermo. Perché? Falcone era antipatico a molti,
veniva considerato un «supergiudice» e tra i colleghi c’era invidia nei suoi
confronti. Ma anche perché con il suo lavoro metteva in discussione la figura
del magistrato che si limita a fare il minimo indispensabile. Negli ultimi anni
questa fascia della magistratura si è ridotta, ma esiste ancora».
Ci sono
importanti magistrati che hanno fatto l’apologia del «giudice senza qualità»,
che si limita ad applicare la legge senza protagonismi. Ma così si rischia di
avallare la débâcle della giustizia. Perché le regole processuali favoriscono
chi ha le risorse economiche per sfruttare in pieno la prassi dei ricorsi fino
al traguardo della prescrizione.
«La
magistratura è per certi versi schizofrenica. In qualche caso abbiamo dato
l’impressione d’essere duri e puri davanti a questioni banali e di non saper
affrontare con fermezza i problemi più gravi. Somigliamo per certi versi alla
tela del ragno: più grossa è la vittima che cade nella nostra rete, più è facile
che le sue maglie cedano e la lascino scappare indenne. Per il ragno, è una
dimostrazione di intelligenza: a che serve affannarsi a imprigionare un animale
troppo grande per le sue forze? Meglio concentrarsi sugli insettini inermi che
si impigliano nella sua trappola. Per la magistratura, invece, questa diventa
una dichiarazione di impotenza».
I pezzi
grossi, infatti, beneficiano della situazione. E non solo grazie al colpo di
spugna della prescrizione. Ci sono tribunali di provincia dove raramente si dà
fastidio ai potenti, senza contare che la procura di Roma, per decenni, è stata
«il porto delle nebbie» in cui tutte le indagini scomparivano nel nulla. Se si
tratta di punire emarginati e piccoli delinquenti, però, gli stessi giudici
sanno essere inflessibili.
«L’impressione
è che spesso sia così. E questo consolida il potere dei forti. Basta vedere
quanto spesso i processi ai colletti bianchi finiscono nel nulla rispetto ai
giudizi contro cittadini comuni. Certo, sono processi più complessi, ma questo
giustifica solo in parte le disparità negli esiti. La verità è che molti non
hanno voglia di impegnarsi in inchieste difficili, e il fatto che i meccanismi
di valutazione della produttività siano spesso oggetto di valutazioni meramente
burocratiche peggiora le cose: se tu condanni uno scippatore che ha rubato venti
euro, o un concussore che ha intascato milioni con metodi sofisticati, non fa
differenza. Nelle statistiche possono valere entrambi uno, anche se l’impegno
richiesto per assicurarli alla giustizia è molto diverso».
IL PARTITO DEI GIUDICI.
La caduta (parziale) degli Dei, scrive Piero Sansonetti su "Il Garantista". Il
segretario dell’Anm, il dottor Maurizio Carbone, dice che la riforma delle norme
sulla responsabilità civile dei magistrati, approvata l’altro ieri dal
Parlamento, «è un tentativo di normalizzare la magistratura». Lo ha dichiarato
ieri, durante la conferenza stampa dell’ Anm, che è su tutte le furie per questa
piccola riforma. Già: «normalizzare». Cioè rendere normale. Oggi la magistratura
non è normale: è l’unica istituzione dello Stato ad essere al di sopra dello
Stato, della legge, ad essere – nell’esercizio delle sue funzioni – immune dalla
legge, e insindacabile, e non dipendente dallo Stato ma sovraordinata allo
Stato. «Normalizzare» la magistratura, cioè toglierle la sua caratteristica di
”deità” (che non è la ”terzietà” di cui spesso l’Anm parla) non sarebbe una cosa
cattiva. Libererebbe forse l’Italia da un sovrappeso ”feudale” che ancora ne
condiziona profondamente la struttura democratica, e che probabilmente è in
contrasto con lo spirito della Costituzione, che è una Costituzione Repubblicana
e che prevede l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Alcuni
magistrati dicono: ma noi siamo magistrati, non cittadini. E su questa base
pretendono di non dover sottostare alla legge. Ritengono – temo in buona fede –
che la saldezza di una società, e la sua moralità, e il suo essere ”società
etica” (successivamente si passa all’idea dello ”Stato Etico”) non possono che
essere affidati ad una entità e ad un gruppo di persone migliori degli altri (”aristoi”)
i quali siano in grado di ”sapere” la vita degli altri, valutarla, giudicarla,
punirla. Non è questa una funzione – pensano – che possa essere affidata alla
democrazia, o al libero svolgimento delle relazioni umane e sociali, perché la
democrazia è un buon sistema di governo ma è viziato da corruzione. E l’eccesso
della libertà, della deregolamentazione, sono pericolose per la collettività. La
democrazia deve essere ”corretta”, o comunque controllata, e anche la società,
da qualcosa di superiore e di ”certamente morale”: e cioè da i giudici.
Contestare questa funzione dei giudici vuol dire contestare la loro
indipendenza. E mettere in discussione l’indipendenza dei giudici vuol dire
correre il rischio che la magistratura finisca per non essere più autonoma dalla
politica. L’autonomia dalla politica non è vista come una condizione di
funzionamento della magistratura, o come un elemento necessario nell’equilibrio
dei poteri, ma come un valore assoluto al quale una società ”morale” deve
sottomettersi, e in assenza del quale la società diventa ”immorale” e la
democrazia, e le istituzioni, scendono in una condizione di subalternità alla
politica. La politica è ”il male” , la giustizia (lo dice la parola stessa) è il
bene, e il bene può governare il male, e può redimerlo, correggerlo,
sottometterlo. Il male non solo non può governare il bene, ma non può aspirare
ad essere alla pari col bene. Ecco, questo ragionamento è alla base delle molte
dichiarazioni rilasciate ieri dal dottor Carbone, e anche dal presidente
dell’Anm Sabelli. Il quale ha rimproverato al governo di avere promesso una
riforma della Giustizia in 12 punti, e di avere realizzato invece l’unico punto
che non va bene, e cioè la riforma della responsabilità dei giudici. I
magistrati invece – ha spiegato – vogliono cose diverse: per esempio la
riduzione della prescrizione, l’estensione dei poteri speciali ”antimafia” anche
ad altri reati, il processo telematico (cioè la cancellazione del diritto
dell’imputato ad essere presente al suo processo), la riduzione dei gradi di
giudizio, eccetera. In sostanza, la proposta dell’Anm (che più o meno è stata
organicamente strutturata nella proposta di riforma del dottor Nicola Gratteri)
è quella di escludere norme che riportino alla normalità la magistratura,
ristabilendo la legittimità dello Stato liberale e dell’equilibrio dei poteri,
ma, viceversa, decidere un forte aumento dei poteri della magistratura, un
ridimensionamento drastico dei diritti dell’imputato, e un rafforzamento della
condizione di preminenza e di insindacabilità dei pubblici ministeri. Sabelli ha
anche annunciato che l’Anm ha chiesto un incontro al Presidente della
Repubblica. Per dirgli cosa? Per esprimere le proprie rimostranze contro il
Parlamento. Già nella richiesta dell’incontro c’è un elemento di scavalcamento
dell’idea (puramente platonica in Italia) dell’indipendenza dei poteri. La
magistratura ritiene che il suo compito non sia quello semplicemente di
applicare le leggi, ma di condizionarne il progetto e la realizzazione.
L’associazione magistrati chiede al Presidente della Repubblica di frenare, o
condizionare, o rimproverare il Parlamento. E vuole discutere nel merito delle
leggi. La magistratura considera inviolabile la propria indipendenza dagli altri
poteri, e inaccettabile la pretesa di indipendenza degli altri poteri dalla
magistratura. Devo dire che la passione con la quale i magistrati hanno reagito
alla miniriforma della responsabilità civile mi ha colpito soprattutto per una
ragione: questa riforma è quasi esclusivamente simbolica. La responsabilità dei
giudici resta limitatissima. L’unica vera novità è la rimozione del filtro che
in questi vent’anni aveva permesso solo a 4 cittadini di ottenere un
risarcimento per la mala-giustizia (nello stesso periodo sono stati processati e
condannati 600.000 medici). Tutte le altre barriere restano. I magistrati
saranno giudicati solo in caso che sia accertata una colpa grave, o addirittura
un dolo nel loro comportamento, saranno giudicati non da una autorità esterna ma
dai loro colleghi (visto che oltretutto non esiste una divisione delle carriere)
e se alla fine saranno ritenuti colpevoli pagheranno con una sanzione che in
nessun caso potrà superare la metà dell’ammontare di un anno di stipendio. Voi
conoscete qualche altra categoria professionale protetta fino a questo punto? La
probabilità di essere condannati per i magistrati è così bassa, e l’esiguità
della pena così forte, che chiunque può mettersi al riparo pagando una
assicurazione con poche decine di euro. Cosa che non vale per i medici, o gli
ingegneri (non parliamo dei giornalisti) che essendo espostissimi al rischio di
condanna (anche senza dolo e senza colpa grave) se vogliono sottoscrivere una
assicurazione devono pagare migliaia e migliaia di euro. Diciamo che il
privilegio non è affatto toccato da questa riformetta. Appena appena scalfito. E
allora? Il fatto è che comunque la riforma ha un valore ideale, è una specie di
metafora. Il Parlamento, per una volta, non si è inginocchiato davanti alla
magistratura. E’ questa la novità che ha messo in allarme i settori più
corporativi della magistratura. Il timore è che davvero possa cambiare il clima
politico e possa essere aperta una via alle riforme vere, e al ridimensionamento
della ”Divina Giustizia”. No, la riforma non comporterà la caduta degli Dei.
Solo che gli Dei non sopportano gli oltraggi. Sono permalosi. E’ sempre stato
così, dai tempi di Omero. E questa legge è uno sberleffo inaccettabile, anche se
innocuo.
Esiste in Italia il partito dei giudici? Certo che sì, risponde “Il Messaggero”.
Potremmo definirlo così: il partito dei giudici è quel fronte trasversale che,
con l’alibi di una emergenza che cambia faccia a seconda delle stagioni
(terrorismo, mafia, corruzione, malapolitica), sostiene la necessità che la
magistratura svolga un ruolo di supplenza, quando non di vera e propria
sostituzione, rispetto alla politica. Chi fa parte del partito dei
giudici? Magistrati, ovviamente. Ma non solo: a loro si sono sempre
affiancati partiti e associazioni, giornali e riviste, più quella magmatica
forma di opinione pubblica che nella mitologia amica ha assunto di volta in
volta la definizione di popolo dei fax, popolo della Rete, popolo viola e altre
improbabili declinazioni di popolo. Il partito dei giudici non nasce con
Tangentopoli, a differenza di quanto pensano i più, bensì alla fine degli
Settanta, quando si sperimenta il primo laboratorio del giustizialismo e si
creano alcuni dei circoli viziosi che hanno portato alla situazione attuale.
E nasce a sinistra, il che spiega in parte perché è diventato
egemonico in un pezzo rilevante dell’elettorato di quel versante, quando i
vertici del Pci decidono che occorre aprire un canale diretto con alcuni
magistrati per orientare le indagini contro il terrorismo e massimizzare i
risultati della repressione giudiziaria. È in questa fase che in nome
dell’obiettivo di fondo - la difesa della democrazia e dell’agibilità politica -
si comincia a sorvolare sulla liceità degli strumenti messi in campo: si forza
il diritto (arresti preventivi di massa, cambio in corsa dei capi di
imputazione, sforamento dei tempi d'indagine e di fermo), si perseguono i
fenomeni anziché i singoli reati, si usano i mezzi di stampa amici per
enfatizzare le inchieste e mitizzare l’azione dei pm, si promulgano leggi
speciali e altre se ne invocano, in una rincorsa all’emergenzialità nella quale
la politica sceglie di farsi ancella delle richieste che arrivano dalle Procure.
D’altra parte, questo collateralismo finisce per orientare politicamente molte
inchieste. Lo sconfinamento dei poteri giudiziari prodotto negli anni
della lotta al terrorismo viene quindi trasferito in blocco negli anni
Ottanta verso la nuova emergenza e per un’altra causa in sé nobilissima: la
lotta alla mafia. Sono gli anni in cui si estremizza l’uso barbaro del
pentitismo (non occorre citare il caso Tortora), brandito come una clava e con
la pretesa di utilizzare i collaboratori senza alcuna garanzia in tutte le fasi
dell’azione giudiziaria. I giudici cominciano a diffidare pubblicamente la
politica dal mettere mano a riforme che ripristinino le condizioni dello Stato
di diritto. La situazione esplode poi con Tangentopoli, quando la molla della
nuova emergenza, la sacrosanta lotta alla corruzione, unita all’indebolimento
del collante sociale dei partiti, proietta i magistrati nella lotta politica
senza più mediazioni e dissimulazioni. Si ripropone il solito catalogo di
svarioni giuridici ma ormai sdoganato, con la teorizzazione esplicita della
carcerazione preventiva come mezzo di pressione per estorcere confessioni, della
gogna per gli imputati, delle condanne mediatiche come alternativa rapida alle
condanne giudiziarie. Non è un trattamento che colpisce solo potenti e famosi
(come se poi, in una società liberale, fosse lecito accanirsi su alcune
categorie), e casomai il torto di molti garantisti part time è di accorgersi di
questo stato di cose solo quando colpisce i più noti. E così, mentre i pm vanno
in tv a chiedere di bloccare questo o quel provvedimento governativo, si
comincia a vaneggiare di governo dei giudici (una proposta cui è dedicato un
famigerato numero monografico di Micromega). Quindi, con l’arrivo delle
intercettazioni e della loro allegrissima trascrizione in tempo reale sui
quotidiani la magistratura diventa soggetto politico a tutto tondo, anzi di più:
capace di imporre l’agenda politica, distruggere carriere, orientare scalate di
Borsa. Intendiamoci, questo non è il ritratto della magistratura
italiana. È il ritratto di un suo pezzo che ha completamente
smarrito il senso della propria missione, appoggiandosi a sponde politiche e
sociali sempre più aggressive nelle loro crociate di presunta moralizzazione. In
un’Italia segnata da scandali e malaffare, il partito dei giudici ha potuto
avanzare e rafforzarsi, ha miscelato umori reazionari e insoddisfazione
democratica, ha reso primitivo il dibattito pubblico sulla giustizia.
Argomentare contro il partito dei giudici non è difficile. È inutile. Vuoi
regolamentare l’uso dei pentiti? Sei colluso con la mafia. Critichi Mani pulite?
Vuoi difendere la politica corrotta. Sei a favore di una legge che limiti la
pubblicazione delle intercettazioni? Vuoi proteggere Berlusconi e i criminali.
Fino all’ultimo caso: se difendi Napolitano dai vergognosi attacchi di cui è
oggetto è perché non vuoi la verità sulla trattativa Stato-mafia. Né vale
ricordare agli ultras delle manette i molti flop dei lori beniamini. Se
un’inchiesta del partito dei giudici fa flop, questo viene negato o comunque
giustificato con lo scatenarsi di forze ostili. Nessuna buona causa può
diventare una ragione per pretendere che uno dei poteri dello Stato
invada il campo degli altri o per giustificare comportamenti totalmente fuori
dal dettato costituzionale, oltre che dal codice di procedura penale. Purtroppo
l’idea che questo sconfinamento sia non solo necessario ma addirittura
auspicabile ha trovato invece terreno fertile, proliferando in una opinione
pubblica che si considera ultrademocratica nonostante sostenga tesi che spingono
in direzione esattamente opposta.
La provocazione di Vittorio Feltri -
«Silvio, diventa compagno se vuoi salvarti!» - è certamente fondata, ma
Berlusconi, prima deve recitare il “mea culpa” per non essere riuscito a
riformare l’ordinamento giudiziario, che è la causa principale non solo dei suoi
guai ma dei guai di tutti i cittadini, spiega Titta Sgromo su “L’Opinione”.
La giustificazione, “non ci sono riuscito per colpa di Fini e di Casini”, lascia
il tempo che trova, posto che quando si da luogo ad un partito che coinvolge
altri due partiti che in proposito hanno idee diverse e due leader ambiziosi
quali erano Fini e Casini, si deve andare avanti con i piedi di piombo. Invero i
risultati sono stati quelli che sono evidenti a tutti. Il partito dei giudici,
che si chiama Anm, sotto la guida di magistrati appartenenti a varie correnti,
ma con egemonia di quella di estrema sinistra, determina e condiziona la
carriera dei magistrati, a seconda non del valore dimostrato degli stessi, ma
dell’appartenenza ad una corrente anziché ad un'altra. Tutto ciò, lo ripeto per
l’ennesima volta, a causa della sciagurata riforma dell’ordinamento giudiziario
approvata dalle Camere a maggioranza catto-comunista nel 1973, e che porta il
nome di un deputato democristiano, il cui nome, Breganze è ignoto a tutti anche
agli attuali politici, a qualsivoglia schieramento appartengano. I magistrati,
prima del 1973, per fare carriera dovevano affrontare prove durissime
contraddistinte dalla eccelsa preparazione giuridica e non solo, anche dalla
solerzia nel lavoro che dava luogo a pronunciamenti rapidi e giusti. Di quei
magistrati ormai si è conservato solo il ricordo, ragione per cui per avere una
sentenza in primo grado non sono sufficienti cinque anni, per un giudizio di
appello non ne bastano nove e per una pronuncia di legittimità ne passano
quattro se non cinque. In questo contesto il Csm, composto come noi addetti ai
lavori sappiamo, sotto la Presidenza di fatto del vice Presidente Vietti, lo
ricordo per l’ennesima volta voluto dal Cavaliere, per far piacere a Casini,
difende le toghe, ed avalla una dichiarazione che definire sconcertante è poco,
per una carica istituzionale:«Scellerato attaccare le toghe». Ma non è più che
scellerato che alcuni magistrati, sull’esempio nefasto dell’inimitabile Di
Pietro, si giovino dell’arma letale delle indagini, condotte per lo più con le
intercettazioni telefoniche, per intervenire nell’agone politico condizionando
in modo pestante l’esercizio del potere legislativo e del potere esecutivo. Cosa
ha fatto il Csm, quando il Dott. Ingroia, indossando ancora la toga, partecipava
a congressi e convegni di partito, violando chiaramente i principi cardine della
funzione del magistrato, sia inquirente che giudicante, l’autonomia e
l’indipendenza. Nulla se non un timido richiamo. Vigente il vecchio ma incisivo
ordinamento giudiziario, Ingroia sarebbe stato allontanato dalla magistratura.
Un’associazione a delinquere di stampo massomafioso, finalizzata a sovvertire
l’Ordinamento democratico e la legalità, è in grado di condizionare l’attività
giudiziaria da nord a sud del Paese, attraverso la collusione di intranei ai
centri di comando delle istituzioni, sino alla Corte di Cassazione, al C.S.M. e
alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo che, ignorando svariate
migliaia di denunce inviate ogni anno da cittadini e imprenditori italiani,
garantiscono l’impunità di magistrati corrotti, collusi con banche, finanziarie,
usurai, speculatori, partiti, logge massoniche e criminalità organizzata, scrive
“Avvocati senza frontiere”. Dopo oltre 25 anni di attività abbiamo compreso che
il sistema delle aste è strutturalmente marcio e privo di dialettica interna e
controlli esterni: solo una rivoluzione civile dal basso potrà cambiarlo,
trattandosi di un sistema autoreferenziale, dove ogni rimedio giurisdizionale
interno è vanificato, a causa dell’assoluta discrezionalità nell’interpretazione
ed applicazione delle leggi. A partire dal caso eclatante del Tribunale di
Milano, i media già 10 anni fa diedero grande risalto alla dilagante corruzione
giudiziaria legata alle vendite giudiziarie e ai fallimenti. Lo stesso Tribunale
di Milano fece pubblicare varie pagine a pagamento sui maggiori quotidiani
nazionali, facendoci credere che con gli arresti di alcuni avvocati e pubblici
funzionari di quella che fu definita la “compagnia della morte“, si
sarebbe posto fine al cartello di speculatori, in grado di condizionare le gare
d’asta per l’acquisto degli immobili pignorati e svenduti a valori vili “agli
amici degli amici”. Istituzioni e media di regime si affannarono a spiegare ai
cittadini che per svariati anni una banda di “professionisti” aveva potuto agire
impunemente, scoraggiando la partecipazione alle aste del pubblico, che veniva
intimidito e minacciato, imponendo il pagamento di una tangente (o “pizzo”) pari
al 10-15% del valore dell’immobile pignorato, ovvero pilotando l’assegnazione su
prestanomi, professionisti e società, i cui interessi, ci veniva però
sottaciuto, risultavano spesso riferibili agli stessi magistrati o loro parenti,
come nei casi da noi vanamente denunciati, tra quello dell’allora Presidente
della Sezione Esecuzioni immobiliari, dr.ssa Gabriella D’Orsi, tuttora applicata
presso altra sezione del Tribunale di Milano, senza che il CSM e la Procura di
Brescia abbiano adottato alcun provvedimento a quanto risulta neanche di
carattere disciplinare. Si trattò infatti solo di un’operazione di maquilllage
per cercare di ridare credibilità al volto corrotto della giustizia italiana e
del sistema delle aste, solo a fini di marketing. Lo dimostrano l’alto numero di
denunce che interessano pressoché tutti i tribunali italiani, senza trovare
risposta e soluzione da parte degli organi giurisdizionali interni e
sovranazionali. Gli immobili per lo più pignorati dalle banche continuano a
venire svenduti a valori infimi a società vicine o soggetti privati legati a
doppio filo agli interessi degli stessi istituti di credito e alle loro
clientele politico-affaristiche dedite alla speculazione e allo strozzinaggio,
come insegna il caso eclatante dell’associazione a delinquere denominata Monte
dei Paschi di Siena, anello di congiunzione tra il malaffare berlusconiano e
quello delle cooperative rosse, su cui si arenò anche “mani pulite”. Attraverso
gli sportelli MPS, come di altri Istituti bancari accreditati ad aprire agenzie
all’interno dei tribunali italiani, passano, tra l’altro, senza alcun controllo,
il riciclaggio e l’autoriciclaggio di ingenti capitali di illecita provenienza,
con il beneplacito degli stessi magistrati che dispongono la vendita e
l’assegnazione degli immobili pignorati, grazie a una legislazione costruita
ad hoc che, dopo le recenti riforme, nonostante la crisi economica, ha
ristretto sempre più le possibilità e gli strumenti di difesa dei cittadini
esecutati, lasciati in balia delle mafie locali che controllano i tribunali,
seppure spesso risultino oberati da pretese illegittime e tassi usurari. I casi
da noi raccolti e in parte pubblicati nella mappa della malagiustizia vedono tra
i tribunali più corrotti Milano, Treviso, Alessandria, Brescia, Firenze, Lucca,
Roma, Perugia, Napoli, Palermo, etc. Lo stesso dicasi per quanto attiene
l’ambito delle procedure fallimentari controllate da un vero e proprio racket di
professionisti delle estorsioni, che con il caso del maxi-ammanco negli uffici
giudiziari del Tribunale di Milano (Radio 101), da cui furono sottratti in 10
anni da una cinquantina di fallimenti, circa 35 milioni di euro, mietendo oltre
7000 vittime, misero a nudo una ultradecennale capacità di delinquere interna
agli uffici istituzionali, in grado di resistere ad ogni denuncia-querela, forma
di controllo ed ispezione ministeriale. Fatti per i quali si è cercato, anche in
questo caso, di farci credere che tutto sarebbe avvenuto all’insaputa dei
magistrati, dei vertici del Tribunale di Milano e degli organismi di controllo
preposti (CSM, Ministero di Giustizia, Procura di Brescia, Procura Nazionale
Antimafia), i quali, invero, seppure edotti di tutto, dagli anni ’80, hanno
sistematicamente insabbiato anche le stesse segnalazioni di magistrati onesti,
come la dr.ssa Gandolfi, occultando svariate decine di migliaia di esposti a
carico di avvocati, magistrati e curatori fallimentari, nei cui confronti sono
rimasti del tutto inerti, giungendo, persino, a tollerare la dolosa elusione del
tassativo obbligo di registrazione delle denunce nel Registro delle notizie di
reato. A riguardo, basti ricordare i ben 26.000 procedimenti mai registrati e
occultati in soffitta, sotto la reggenza dell’ex Procuratore di Brescia,
Francesco Lisciotto, che anche dopo il ritrovamento, dietro nostra denuncia,
sono rimasti inesaminati, portando al mero trasferimento-promozione del
magistrato con tessera P2, salito, per dirla come Monti, alla Corte di
Cassazione. Analoghi insabbiamenti sono toccati alle
denunce di onesti magistrati fallimentari romani, come nel caso del Dott. Paolo
Adinolfi, il quale è stato addirittura fatto sparire fisicamente.
Un caso di lupara bianca insabbiato dalla Procura di Perugia ad alta densità
massonica, trattato anche dalla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”.
Secondo quanto riferito dal magistrato Giacomo De Tommaso, Adinolfi gli confidò
il timore di essere seguito e spiato. La moglie di Adinolfi, Nicoletta Grimaldi,
rivelò che il marito aveva acquisito prove e documenti che avrebbero potuto far
affondare l’intero Tribunale di Roma. Inoltre Adinolfi pochi giorni prima della
sua scomparsa aveva chiesto ed ottenuto un appuntamento con il P.M. di Milano
Carlo Nocerino, davanti al quale avrebbe voluto testimoniare come persona
informata sui fatti. Le uniche indagini possibili in questo Paese sono solo
quelle rivolte nei confronti di coloro che denunciano con prove alla mano i
misfatti del potere, accusandoli a scopo eminentemente persuasivo e dissuasivo,
come ai tempi del fascismo, di reati ideologici, quali “diffamazione, calunnia,
oltraggio a magistrato in udienza, resistenza a pubblico ufficiale…”, molto
spesso in relazione agli stessi scritti difensivi e alle denunce mai esaminate
delle incolpevoli vittime delle mafie. La vastità e gravità del fenomeno che non
riguarda le sole zone del sud a forte concentrazione criminale ci ha portati a
coniare la definizione di “mafia giudiziaria”, in quanto abbiamo rilevato
trattarsi di una condizione connaturata all’esercizio stesso della giurisdizione
e alle modalità di gestire le funzioni giurisdizionali, a tutela di interessi
particolaristici, corporativi e lobbistici, ovvero al modo di intendere le
stesse finalità del diritto, secondo una visione deviata rispetto ai principi
dello stato di diritto, ad esclusivo appannaggio di partiti e gruppi affaristici
trasversali, corporazioni, logge massoniche, che della giustizia e del suo
capillare controllo hanno fatto strumento di indebito arricchimento e fonte di
finanziamento illecito, in base ad un “codice non scritto“, secondo cui vince
chi ha le giuste aderenze e si sottomette alle logiche dominante, che hanno
messo in ginocchio l’intera nazione, entrando a fare parte del “giro” dei vari
comitati d’affari. Un codice criminale e perverso imposto dalla politica e dalla
cultura del potere che lega larghi settori della magistratura di regime alla
criminalità organizzata, dando luogo ad un fenomeno di elevatissima pericolosità
e allarme sociale, che possiamo definire come “mafia giudiziaria”, il cui fine è
quello di arricchirsi indebitamente, fare carriera negli apparati della
burocrazia statale e attingere, consenso, protezione, scambio di favori e
illeciti vantaggi, grazie ai legami con la massoneria e la criminalità
organizzata. Non crediate, dunque, di essere gli unici ad avere subito
un’ingiustizia dallo svolgimento delle aste giudiziarie o da anomale procedure
fallimentari. Si tratta di un sistema criminale istituzionalizzato, da nord a
sud del Paese, voluto ed alimentato da banche, partiti, colletti bianchi e mafie
locali che controllano il territorio. Un malaffare legalizzato e tollerato dallo
Stato-mafia, che pur cercando di mostrare il volto legale dei propri tribunali,
non riesce a celare, alla prova dei fatti, il largo coinvolgimento nel racket
delle aste e dei fallimenti da parte di magistrati ed infedeli funzionari. A
riguardo, basti dire che l’ex Presidente della sezione esecuzioni immobiliari
del Tribunale di Milano, dr.ssa Gabriella D’Orsi, indicata nel succitato
articolo del quotidiano “La Repubblica”, come una sorta di eroina, che avrebbe
denunciato il controllo delle aste giudiziarie da parte della “compagnia della
morte”, risultava essa stessa indagata dalla Procura di Brescia per avere
favorito la vendita di un appartamento, a prezzo irrisorio, in favore della
figlia, quando è notoriamente vietato dall’Ordinamento Giudiziario a magistrati
e pubblici funzionari di partecipare, anche tramite terzi, alle aste
giudiziarie….
"Nessuno contesta il diritto di manifestare e di manifestare anche in materia di
giustizia. Ma se si sollecita una manifestazione contro la magistratura o volta
a condizionarne l'azione, è inaccettabile". Così l'Anm replica alle parole di
Silvio Berlusconi sulla manifestazione contro le toghe del 23 marzo 2013,
annunciata dal Tribunale di Milano, dove si trovava per rilasciare le
dichiarazioni spontanee nel processo d'appello Mediaset. Continua l'Associazione
nazionale magistrati: "Invocare la piazza in un momento come questo è molto
pericoloso, vuol dire screditare l'istituzione magistratura in un sistema
complesso e unitario come lo Stato, significa indebolire lo Stato stesso e le
istituzioni tutte". Berlusconi ha ripetuto quanto detto più volte negli attacchi
alla magistratura: "Parte della magistratura - ha detto - è una patologia e un
cancro per la democrazia". E proprio in risposta alle parole dell'ex premier
Berlusconi, i vertici dell'Anm hanno spiegato: "Oggi la magistratura, o una
parte di essa, viene equiparata al cancro, sabato scorso eravamo peggio della
mafia, ma non abbiamo replicato perché il giorno prima delle elezioni. Sono
parole che andrebbero liquidate come sciocchezze, ma sono molto offensive per
chi ha pagato il prezzo della criminalità mafiosa e per i malati". Così i
vertici dell'Anm in risposta alle parole dell'ex premier Berlusconi. Favorevole
alla manifestazione, Augusto Minzolini, giornalista e senatore Pdl. "C'è un
problema giustizia che è collegato strettamente al problema di informazione:
quello che ti tolgono non te lo ridà nessuno. Andrò in piazza non per la vicenda
ma perché in questo Paese c'è un problema giustizia".
Se l’ANM replica a Berlusconi il CSM va oltre. A scatenare il Csm è la volontà
del Cavaliere di portare in piazza il popolo di centrodestra contro «sinistra e
magistrati». Tanto basta per scatenare le toghe, riunite in plenum il 6 marzo
2013. A dar fuoco alle polveri, Paolo Carfì, magistrato di sinistra ed ex
giudice del processo a Cesare Previti. «Berlusconi ha superato il limite con una
escalation di disprezzo di un'istituzione che può avere conseguenze gravi sulla
tenuta sociale e morale del Paese - mette in guardia la toga - Tacere di fronte
a questo sarebbe colpevole». A seguire, l'intervento del laico di centrosinistra
Glauco Giostra: «Evocare la piazza contro i magistrati è agli antipodi della
democrazia, si tratta di attacchi scellerati». C'è chi, poi, come il togato di
Area (schieramento di cui fanno parte Magistratura democratica e il Movimento
per la Giustizia, ovvero le due correnti di sinistra delle toghe) Francesco
Vigorito, chiede di «reagire a una barbarie, con una risposta forte a tutela di
uno dei valori fondanti del sistema democratico, cioè l'autorità e
l'indipendenza dei magistrati». E il collega Roberto Rossi: «I magistrati di
Napoli e di Milano sono colpevoli soltanto di fare il loro dovere. Non si può
accostare il lavoro dei magistrati a quel terribile male che è il cancro». Fuori
dal coro il togato di centrodestra, Bartolomeo Romano: «Forse non tutti i
magistrati hanno avuto nel loro comportamento una serietà tale da ottenere
rispetto». Naturalmente dal Pdl parte la controffensiva. Il primo è Andrea
Costa: «Il Csm è talmente avvolto dalla nebbia delle correnti e dei loro
traffici d'influenza che invece di occuparsi di chi usa i tribunali a fini
politici, censura chi richiama l'attenzione a questa triste realtà. Questo fa
perdere credibilità alla giustizia. Non altro». A seguire Capezzone: «I comizi
di numerosi consiglieri del Csm contro Berlusconi hanno due soli effetti: danno
la sensazione di una supercasta che si autoprotegge, e minano agli occhi
dell'opinione pubblica l'imparzialità della magistratura».
IL PARTITO DELLE TASSE E DELLE MANETTE…PER GLI ALTRI.
Partito di tasse e di manette. L'accanimento contro Berlusconi ecco dove e come
ricorda quanto avvenuto con Bettino Craxi, scrive Paola Sacchi su “Panorama”.
Ha ragione Paolo Guzzanti su
«Il Giornale». Gli insulti a Silvio Berlusconi, che viene messo ancora una volta
al bando solo per aver detto una frase forte, paradossale, ma che rende
efficacemente l’idea della persecuzione alla quale è sottoposto lui e la sua
famiglia, hanno radici nel lontano 1976. Dalle ingiurie del Pci e della sinistra
estrema contro Bettino Craxi. Perché reo di aver portato al potere la sinistra
anticomunista e di aver dominato un decennio di politica italiana, negli anni
’80, facendo ballare la Dc e il Pci, pur con il suo magro 12 per cento. Ma, come
dice Gianni De Michelis nel libro «Il crollo del Psi» (Marsilio editore): «Bettino
era dotato di una intelligenza politica laser, che travolgeva e stupiva ogni
volta anche i più stretti e fedeli collaboratori (lo stesso ex potente e
autorevole ministro degli Esteri compreso ndr)». Denunciò Stefania Craxi a chi
scrive poche ore dopo la morte del padre tra le sue braccia (Hammamet, cinque
della sera del 19 gennaio 2000): «Papà è stato ammazzato da un odio
devastante». Disse suo fratello Bobo, tra le lacrime che scorrevano come una
fontana, il giorno dopo nella Chiesa cristiana di Tunisi: «Caro papà, caro
Monsieur le President, come tutti qui ti chiamavano, in segno di rispetto, tu te
ne vai, vittima di una campagna d’odio senza precedenti!». Peccato, Bobo,
poi prese altra strada, accompagnandosi con quella sinistra i cui esponenti suo
padre, negli ultimi giorni di calvario all’Hopital Militare di Tunisi definì
lucidamente: «I miei assassini». Chi scrive, da ex inviata speciale
dell’«Unità», inviata speciale, in quei mesi tra il finire del 1999 e il 2000,
in Tunisia per seguire il «Caso C», lo sa per certo. Il mio allora direttore
(ultimo direttore in quel giornale dove non lavoro più dal 2000) Peppino
Caldarola, uomo di sinistra ma intelligente, di vaste letture, dalemiano ma
capace anche di riattaccare la cornetta del telefono al medesimo Massimo
D’Alema, allora premier, su mia sollecitazione e soprattutto dietro mie
informazioni esclusive sul grave stato di salute dello statista socialista, mi
diede il via per un’intervista a Craxi. Rompendo un tabù, anzi abbattendo in
quel giornale il muro di Bettino. Inviai le domande concordate con Caldarola,
dove ad un certo punto mettemmo la parola «tecnicamente latitante» per i Pm (era
l’unica forma di mediazione per far passare quell’intervista e non esere
cacciati il giorno dopo). Craxi lesse, si rigirò sul suo letto d’ospedale e
davanti a Bobo e al direttore di «Critica sociale» ( la rivista fondata da
Turati) Stefano Carluccio urlò: «Io non dò interviste al giornale dei miei
assassini, anche se lei (la sottoscritta) è una brava e coraggiosa donna».
Aggiunse Stefania: «E Caldarola è una persona intellettualmente onesta».
L’intervista non ci fu. Nonostante arditamente «Peppino» e la sottoscritta
inviarono domande, dalle quali scomparì la parola «latitante». Ma ci fu un
editoriale di «Peppino» che coraggiosamente diceva: fate tornare in Italia
quell’uomo per essere curato e senza essere piantonato». D’Alema fu informato a
Palazzo Chigi da «Peppino» a editoriale fatto, ma non ancora pubblicato. E dette
il là con un sostanziale silenzio. Da Botteghe Oscure l’allora leader dei Ds,
Walter Veltroni, non approvò. Ma non licenziò, forse per miracolo, Caldarola e
la sottoscritta. Pochi mesi dopo, «L’Unità» venne chiusa, perché certamente
gravata da ingenti debiti. Ma è un fatto che Caldarola non rientrò più come la
sottoscritta e per nostra esclusiva volontà. Ognuno ovviamente per ragioni
diverse e non solo per il caso Craxi, ma accomunati dal no al tunnel
giustizialista. Questo forse fu l’ultimo piccolo tentativo (fatto più da due
giornalisti che da D’Alema) di una sinistra riformista, antigiustizialista, di
uscire dal tunnell nel quale si è cacciata con il fallimento del Pd, Matteo
Renzi o non Matteo Renzi. Forse questo fu l’ultimo piccolo concreto tentativo di
salvare la sinistra dal cancro dell’odio nei confronti dei suoi avversari.
Quello per «Bettino» fu tale che il portavoce di Enrico Berlinguer, Antonio
Tatò lo definì: «Un bandito, un avventuriero». L’epiteto più gentile quando
Craxi era premier fu «il ciccione, il ladro, il cinghialone». Ci fu poi «il
foruncolone», di cui secondo Antonio Di Pietro Craxi era malato (sic!). Era
talmente un «foruncolone» che gli tagliarono, a causa del diabete, in una
clinica tunisina alcune dita dei piedi. Il suo calvario non solo lo ha portato
alla tomba del cimitero cristiano di Hammamet, ma ha messo a serio repentaglio
l’Italia. Craxi in Tunisia era protettissimo dalla polizia di Ben Alì. E per
muoversi ogni volta doveva viaggiare accompagnato da una sorta di discreto
corteo di auto. Mi sono sempre chiesta: se un commando di un’altra nazionalità
un bel giorno lo avesse rapito, allora sì che l’Italia sarebbe stata messa a
rischio, essendo stato Craxi negli anni a Palazzo Chigi depositario di tutti i
rapporti dei nostri servizi segreti. Doveva andare a S. Vittore? Aveva 59 anni
quando scattò la campagna d’odio per via giudiziaria contro di lui. E in quegli
anni in carcere ci si suicidava sotto i colpi di «Mani pulite». Prima di andare
a Hammamet, Craxi passò per Parigi, dove, ricordò, «mi si aprì una ferita che mi
spaccò il piede». Aveva un carico di condanne di oltre 20 anni. Ci sarebbe
ancora da vergognarsi di essere italiani per la sorte che toccò a lui, proprio
allo statista che l’Italia la fece entrare nel G7. E c’è purtroppo ancora da
vergognarsi di essere italiani per la sorte che sta toccando al tre volte tre
presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Vittima anche lui di una campagna
d’odio senza precedenti. E senza che il Colle anche questa volta intervenga a
difesa, neppure dalle ingiurie, di un leader che ha rappresentato l’Italia nel
mondo, ha presieduto un G7 e un G8. Comparse una volta un manifesto del Pd che
lo sfotteva per i capelli ripiantati. La nuca era ben messa in evidenza.
Immagine inquietante. «Ma il Pd ormai è il Ptt». Cioè? Spiega un parlamentare
che di centrodestra non è e Berlusconi non lo ha mai votato: «Partito di tasse e
di manette».
Il Paese del garantismo immaginario. Le vanterie sull'Italia patria di
Beccaria? Sono sciocchezze: la cultura manettara è egemone, scrive
Alessandro Gnocchi su “Il Giornale”.
Viviamo in una società garantista? Il garantismo è pensiero corrente, se
non egemone? No, è la risposta secca di Non giudicate, il saggio di Guido
Vitiello edito da Liberilibri. Un giro in libreria, scrive Vitiello, a caccia di
tomi che propugnino ideali garantisti, si risolverebbe in una ricerca senza
frutto. Al contrario, gli scaffali sono ben riforniti di libri firmati da
«magistrati-sceriffo impegnati sulla frontiera delle mille emergenze nazionali»
o da «reduci gallonati di Mani pulite» o da giudici «scomodi» ma non al punto da
non trovare frequente ospitalità nei vari talk show serali. La tivù è la tribuna
da cui levano doglianze sui paletti alle indagini posti dai politici in nome del
«garantismo» (quasi sempre «peloso», nota Vitiello). Basta dare un'occhiata alle
cronache dei quotidiani per rendersi conto che gli avvisi di garanzia sono
percepiti come sentenze della Cassazione; e che spesso l'odio (ma anche l'amore)
per l'inquisito o il condannato di turno fa velo alla valutazione dei fatti. Il
pensiero supposto egemone si rivela «solitario», e paga il conto anche ai «falsi
garantisti» che si sono mescolati ai veri, «finché la moneta cattiva ha
scacciato la buona e reso sospetti tutti i commerci». Insomma, la reputazione
«ben poco commendevole» del garantismo in parte, ma solo in parte, è meritata:
c'è stata poca chiarezza nel distinguere casi personali e questioni di
principio. La tesi di Vitiello comunque è limpida: «L'imbarbarimento giudiziario
italiano è sotto gli occhi di chiunque abbia voglia di vederlo, e non abbia
interessi di bottega tali da suggerirgli una cecità deliberata. Basta gettare
uno sguardo, anche distratto, sul punto di caduta o di capitolazione - le
carceri di un sistema che è in disfacimento fin dalla testa, per arrossire
quando sentiamo ripetere quelle insulse vanterie sul Paese di Beccaria».
L'originalità del saggio consiste nel farci vedere i principi incarnati in
quattro ritratti di garantisti doc: Mauro Mellini, Domenico Marafioti, Corrado
Carnevale, Giuseppe Di Federico. Sono pagine nate sulle colonne del Foglio
(l'introduzione è di Giuliano Ferrara) ampliate e arricchite da un carteggio fra
Mellini ed Enzo Tortora. E proprio la vicenda di Tortora, insieme con Marco
Pannella e le battaglie dei Radicali, lega tutti i protagonisti di Non
giudicate. Tocca a Mellini, avvocato di conio liberale, leader radicale e
deputato per svariate legislature, introdurre il lettore all'abbecedario
garantista, cioè alle parole di cui diffidare perché sventolate al fine di
giustificare l'indebito allargamento dei poteri della magistratura. Emergenza:
«cela il proposito di passar sopra a certe fisime per instaurare una giustizia
di guerra»; giustizia d'assalto: «ha dato la stura a innumerevoli interventi di
magistrati ritenuti o autodefinitisi provvidenziali, di cosiddette supplenze e
vicarianze di altri poteri»; esemplare: è una sentenza «che punisce con
esagerata severità in un determinato momento, quindi una sentenza esemplarmente
ingiusta». Domenico Marafioti, avvocato e letterato, è l'uomo delle profezie
inascoltate: nel 1983 pubblicò La Repubblica dei procuratori. Sottolineava,
scrive Vitiello, «i prodromi dell'integralismo giudiziario, dell'esondare della
magistratura, specie di certe sue avanguardie, dalle dighe che legge e
Costituzione le assegnano»; criticava il modello inquisitorio del processo;
segnalava la nascita del giudice pedagogo, che vuole redimere il prossimo.
Corrado Carnevale, presidente della Prima sezione penale della Cassazione dal
1985, è noto come l'ammazzasentenze, nomignolo affibbiatogli da una campagna
stampa denigratoria iniziata dopo l'annullamento dell'ergastolo ai mandanti
dell'omicidio di Rocco Chinnici. La corporazione non si levò certo in sua difesa
(lo fece Pannella). Più volte finito sotto processo, sempre assolto, Carnevale
illustra cos'è «l'astratto formalismo» che gli veniva imputato: osservanza
scrupolosa della legge scritta. «Quando il giudice si considera legibus solutus
e piega le leggi al suo fine, foss'anche per intenti nobili, mette lo Stato
sullo stesso piano delle organizzazioni criminali». Carnevale rifiuta
l'appellativo di garantista: «E nel fare giustizia il garantismo che c'entra?
Non esiste per il giudice qualcosa di diverso dall'applicazione corretta,
intelligente della legge». Giuseppe Di Federico ha fondato il Centro studi
sull'ordinamento giudiziario dell'università di Bologna. È lui a sollevare un
altro insieme di questioni: la separazione delle carriere, l'assenza di un
valido sistema di valutazione dell'operato dei giudici, il tabù
dell'obbligatorietà dell'azione penale. Questi sono i limiti non solo, per così
dire, ideologici del sistema ma anche gli ostacoli all'efficienza della
macchina. Se vi sembra che queste idee siano moneta corrente nel nostro Paese
«garantista»...
I GIOVANI VERGINELLI ATTRATTI DAL GIUSTIZIALISMO.
Come è possibile che i giovani siano
attratti dal pensiero giustizialista? Cronaca della presentazione del libro “Non
giudicate” di Guido Vitiello su “Zenit”.
L’opera, con la prefazione di Giuliano Ferrara, raccoglie le voci di alcuni
“veterani del garantismo” italiano, scrive Antonio D’Angiò. Sabato 27
ottobre 2012 è stato presentato alla Camera dei deputati, in occasione della
quarta edizione delle “Giornate del libro politico a Montecitorio”, il
“libretto” (così definito dallo stesso autore) di Guido Vitiello intitolato “Non
giudicate” edito da liberilibri. Vitiello, nato trentasette anni fa a
Napoli, è docente all’Università di Roma La Sapienza e collabora, tra gli altri,
con il “Corriere della Sera” e “Il Foglio”. Per una fortuita coincidenza
temporale, all’interno dell’opera è raccontato quanto avvenuto precisamente
dieci anni fa, cioè il 30 ottobre 2002, quando il Presidente di Cassazione
Corrado Carnevale è stato assolto, con formula piena, dall’accusa di concorso
esterno in associazione mafiosa (accusato di aver “aggiustato” alcuni processi
di mafia e da alcuni pentiti di essere un referente dei boss) dopo circa un
decennio di vicende processuali. Iniziamo da questa “ricorrenza temporale” per
parlare del libro di Guido Vitiello, perché Corrado Carnevale, con Mauro
Mellini, Domenico Marafioti e Giuseppe Di Federico è uno dei quattro veterani
(tutti ultraottantenni all’epoca dell’intervista e, peraltro, tutti meridionali)
che l’autore ha incontrato per discutere del garantismo in Italia e
successivamente dare vita a questa pubblicazione. Ma soprattutto perché
Carnevale è l’unico dei quattro che oltre a discutere, descrivere, documentare,
applicare i temi e i commi della legislazione, è stato sia giudice che imputato
e come recita la terza di copertina, è stato “esemplare garante del giusto
processo, per questo ha subìto una persecuzione mediatico-giudiziaria, uscendone
vittorioso”. Una serata (nell’affollata sala Aldo Moro del Parlamento) dove le
riflessioni di giovani come Guido Vitiello e Serena Sileoni (Direttore
Editoriale di liberilibri, coordinatrice dell’evento) si sono ben
integrate nei toni e nei contenuti con quelle di tre maestri del giornalismo
italiano: Pierluigi Battista, Massimo Bordin e Giuliano Ferrara, quest’ultimo
autore della introduzione all’opera. Scrivendo e parlando della giustizia, non
poteva non essere posta in relazione la giustizia degli uomini con quella di Dio
(o amministrata per conto di Dio), in particolare nelle assonanze con alcune
ritualità tra inaugurazione degli anni giudiziari e i “riti basilicali”; in
alcune forme sceniche dei processi che ricordano in Italia più i tribunali
dell’inquisizione in confronto con quelle della legge britannica (dove
l’imputato è al centro e in alto rispetto alla corte giudicante); nonché con
quel “non giudicate” che fa proprio uno dei passaggi del discorso della Montagna
di Gesù Cristo o, infine, nel riferimento a Ponzio Pilato o al bacio di Giuda.
Così come è stata più volte ripresa, per i cultori del diritto, la conseguenza
che comporta sui processi la combinazione, tipicamente italiana, tra
l’obbligatorietà dell’azione penale, la carcerazione preventiva, la limitata
responsabilità civile dei magistrati e l’assenza della separazione delle
carriere tra pubblici ministeri e giudici. Oppure, per gli appassionati di
vicende processuali, i racconti su alcuni processi, come quelli nei confronti di
Enzo Tortora o di Scattone e Ferraro (questi ultimi accusati dell’omicidio della
studentessa Marta Russo) che fanno emergere quanto, questi processi, abbiano
rappresentato un’occasione mancata per una più ampia riflessione sul sistema
giudiziario, prima che il termine garantismo fosse abbandonato da chi lo aveva
nel suo patrimonio culturale e politico e fosse acquisito (l’autore dice
“sputtanato”) da neofiti in virtù di un’interpretazione forzatamente privata, “ad
personam”, di questioni comunque universali. Infine, i riferimenti letterari
a Sciascia, Borges, Kafka, Pasolini, Dostoevskij, Gide, Anatole France, Gadda,
Dante Trosi, rappresentano un vero e proprio elenco di consigli per la
costruzione di una biblioteca del garantismo nella quale cercare le motivazioni
più profonde sull’essenza del giudicare. L’avvocato e politico radicale (e
anticlericale) Mellini, lo scrittore e avvocato Marafioti (di formazione
repubblicana, deceduto pochi mesi dopo l’intervista), il professore di diritto
Di Federico, il cattolico magistrato di Cassazione Carnevale, aiutati dalla
prefazione di Giuliano Ferrara, tendono a spiegare quello che Vitiello rende
immediatamente percepibile con una domanda. Come è stato possibile che i
giovani, gli studenti (che peraltro lui incontra nelle aule universitarie) siano
stati attratti dal pensiero giustizialista con quell’incarognimento che li ha
portati a parlare di legalità, manette, intercettazioni con sillogismi feroci? E
allora, per chiudere, pensiamo che le parole finali della conversazione con
Corrado Carnevale in un certo qual modo possano spiegare il senso più profondo
del libro e lasciare a credenti e non credenti il cercare di comprendere se e
quanto ampio, in tema di giustizia, sia oggi la distanza tra cultura radicale,
liberale e cristiana, per provare a indicare una nuova direzione alle giovani
generazioni. “Ecco, ho sempre cercato di giudicare il mio simile nel modo più
umano possibile, senza eccessi di moralismo. Non mi sono sentito diverso e
migliore anche dal peggior delinquente che talvolta mi è capitato di dover
giudicare.” Suona come una variante del precetto evangelico che abbiamo scelto
come titolo per questo libro, “Non giudicate”, nel quale Sciascia credeva
dovesse radicarsi la missione stessa del giudice. Qualcosa di non troppo diverso
intende Carnevale: “Benedetto Croce diceva che non possiamo non dirci cristiani,
e aveva ragione. Il Cristianesimo ha degli aspetti che non dovrebbero essere
trascurati. Io sono credente. Ma grazie al cielo il Cristianesimo non è una
corrente associativa.”
Mose,
incredibile difesa del Pd: gli arrestati non sono del Pd, scrive Maurizio
Belpietro su “Libero Quotidiano”. Scusate, ci siamo sbagliati. Il Pd non c’entra
nulla con il malaffare di Venezia. Hanno arrestato 35 persone, tra cui il
sindaco della città, e un altro centinaio di signori è stato indagato con le
peggiori accuse, ma il Partito democratico ha le mani pulite. Così almeno
informa un comunicato della segreteria regionale del suddetto gruppo. In una
nota diffusa dalle agenzia di stampa nella mattinata di ieri, dunque a botta
ancora calda per i provvedimenti della magistratura, i vertici del partito di
Renzi non recitano il mea culpa per non aver vigilato sulle tangenti che hanno
preso il largo insieme al Mose, ma ci informano che, pur essendo stato eletto
con i voti del Pd e pur guidando un giunta a forte impronta Pd, il primo
cittadino Giorgio Orsoni non è del Pd, perché non ha mai chiesto la tessera.
(...)Dietro le manette c'è la guerra totale per il futuro del Pd. Dopo aver
negato di conoscere il sindaco tangentista di Venezia, sostenendo che Giorgio
Orsoni non è del partito nonostante il partito lo avesse candidato e fatto
eleggere alla guida della giunta di sinistra che regna sulla laguna, ieri il Pd
si è superato. Questa volta non c’entrano le calli e neppure il Mose né ci sono
di mezzo appalti e fatture milionarie. Però c’è quella che doveva essere una
delle amministrazioni locali da portare ad esempio di buona amministrazione e
soprattutto di cambiamento di verso. Ci riferiamo alla Città eterna, la Capitale
della svolta. Da un anno ai vertici del Campidoglio c’è Ignazio Marino, un
allegro chirurgo che dopo aver messo da parte il bisturi si è scoperto una
passione per la politica. Prima come parlamentare, poi come primo cittadino di
Roma. Nel marzo dell’anno scorso Marino si sottopose alle primarie per la scelta
del candidato di centrosinistra e, vinta piuttosto facilmente la sfida, non fece
fatica a battere Gianni Alemanno, che di Roma era stato a sorpresa sindaco per
cinque anni. Sorpresa perché da un ventennio e più la Capitale era a guida
sinistra e dunque un primo cittadino post-missino non era tra le ipotesi
contemplate. All’errore di aver affidato la città a uno di destra, Marino pose
rimedio con l’appoggio di tutte le forze antifasciste e democratiche e sulla
base di un programma che prevedeva un radicale cambiamento di rotta.
I moralisti
delle mazzette, scrive Nicola Porro su “Il Giornale”. Eccoci di nuovo a
commentare storie di arresti e mazzette. L’ultima in ordine di tempo è la diga
di Venezia, quella che avrebbe dovuto evitare l’acqua alta. La chiamano il Mose,
ma con l’accento sbagliato. Il pubblico ministero che ha indagato e chiesto gli
arresti (Carlo Nordio) è un signore che, a differenza dei suoi simili, prima di
arrestare un povero cristo si farebbe tagliare le mani. Odia la giustizia
spettacolo. Ieri ha subito detto: «In Italia la corruzione continua perché le
leggi sono troppo complesse e farraginose. A nulla serve aumentare le pene e
inventarsi nuovi reati». I contribuenti sono gabbati più volte. Prima dai propri
rappresentanti, che abusano delle tasse incassate. Poi dal fatto che queste
benedette opere pubbliche, se mai si realizzano, non si chiudono mai nei tempi e
nei modi promessi. Chi ancora pensa che l’Expo possa avere il fascino
scintillante che ci avevano raccontato agli esordi? Arrivano infine i nuovi
politici che, cavalcando l’indignazione, gridano allo scandalo (che c’è) e
chiedono subito di bloccare tutto, nuove leggi, nuove commissioni e maggiori
pene (come dice Nordio). Il 31 marzo 2010, all’indomani delle amministrative,
Travaglio-porta-iella, rivolto al Pd di Bersani, scriveva: «Bastava candidare
gente seria e normale, fuori dal solito lombrosario, come a Venezia, dove il
professor Orsoni è riuscito addirittura a rimpicciolire Brunetta». Con 400mila
euro di finanziamento illecito, sostiene oggi l’accusa. Vogliamo dire che dalla
palude in cui siamo non se ne esce con i moralisti e le morali. Siamo un Paese
in cui non si può fare nulla. Un bar non può mettere un’insegna, un artigiano
non può assumere un apprendista, un ragazzo non può fare un lavoretto,
un’impresa un capannone. O meglio, tutto si può fare: ma dopo una giungla
burocratica e autorizzativa. In un sistema come questo è tutto corrotto. Il Mose
è corrotto perché a prendere i soldi sono i politici. Ma nelle sue fondamenta
diventa corrotta, marcia, la nostra economia. Essa non è più volta a raggiungere
cospicui e sani profitti, ma a sfuggire le sanzioni previste da norme, codici,
regolamenti. Le interpretazioni giudiziarie sono poi talmente divergenti che il
diritto diventa arbitrio e i Tribunali ruote della fortuna. È inevitabile dunque
che gli investimenti dei privati nell’ultimo triennio siano diminuiti del 15 per
cento e del doppio circa quelli pubblici. Ieri abbiamo scoperto che anche il
Brasile ci ha superato nella produzione industriale. Con la propensione ad
investire così in calo, c’è da attendersi che il futuro ci riserverà una
classifica ancora più inclemente. Il lavoro, poi, lo creeremo per legge. Sulla
carta. Su questo siamo i numeri uno.
L’EXPO, il Mose & The Italian Job.
Per capire che
quello della mazzetta è un male storico del paese ecco cosa successe negli anni
'50 e '60 per l'aeroporto di Fiumicino, scrive Sabino Labia su “Panorama”. La
vicenda del Mose è il classico scandalo all’italiana con tutti gli interpreti al
posto giusto come nel film The Italian Job. Una grande opera da realizzare, i
miliardi inviati a pioggia da gestire, i politici (locali e nazionali, di destra
e di sinistra) a gestire il flusso di denaro, e una pletora di senza nome e,
soprattutto, prestanome che organizzano società occulte, scatole cinesi, false
fatturazioni e passaggi di denaro. A fare da spettatori a questo enorme circo di
malaffare ci sono loro, gli italiani che ogni volta sperano che questa sia
l’ultima. Per capire come funziona lo Scandalo all’italiana nelle grandi opere
(tralasciando volutamente gli scandali legati alle ricostruzioni post disastri
naturali: Vajont, Belice, Irpinia, L’Aquila etc. etc.), torniamo indietro di
mezzo secolo, e più precisamente al 1961. E’ il Gennaio del 1961 e Giulio
Andreotti parla dal banco del governo del Senato: “Io rispetto di più le persone
della camorra perché Pupetta Maresca (la donna che uccise l’assassino di suo
marito) con le sue revolverate rischia di andare in galera e ci va. Noi abbiamo
nella camorra politica di certi ambienti qualche cosa di meno nobile, perché si
lanciano sassi e colpi di pugnale senza rischiare niente e non mostrando mai il
proprio volto”. A cosa si riferiva il Divo Giulio nel ritenere la politica
peggiore della camorra? In Aula si discuteva dello Scandalo dell’Aeroporto di
Fiumicino. Lo scalo romano comincia la sua storia con la posa della prima pietra
avvenuta il 10 dicembre 1950. Costo previsto: 29 miliardi di lire; fine dei
lavori: 1° gennaio 1960 (giusto in tempo per accogliere atleti e turisti della
XVII Olimpiade). Inaugurazioni effettuate: diverse, l’ultima il 13 agosto 1974,
in occasione dell’apertura della terza pista costata altri 25 miliardi di lire.
Spesa complessiva finale oltre 130 miliardi. I primi problemi cominciano con la
scelta del terreno. In principio era stata preferita la zona di Casal Palocco,
nell’area sud-ovest molto vicina a Roma e, particolare non di poco conto, non
paludosa. Troppo bello per essere vero e, infatti, così non è. L’area è di
proprietà della Società Generale Immobiliare che riesce a evitare l’esproprio,
evitando un notevole danno economico. A questo punto si decide di optare per la
palude di Fiumicino, 1088 ettari di proprietà dei principi di Torlonia, i quali
vengono generosamente ricompensati con 45 lire al metro quadro. Tanto per capire
com’era il mercato nella stessa zona, sempre i Torlonia, vendevano i loro
terreni ai privati a 3 lire al metro quadro e l’amministrazione statale
espropriava altre aree circostanti e di proprietà di un’opera pia, a 7 lire al
metro quadro. Un vero e proprio regalo. Veniamo ai finanziamenti. Inizialmente
furono stanziati 4 miliardi e 450 milioni; Dopo cinque anni, nel 1955, si
aggiungono altri 14 miliardi per la costruzione della pista e per tutte le opere
accessorie, compresa l’aerostazione. L’8 aprile del 1959 servono ulteriori 4
miliardi e 150 milioni per completare l’opera. Trascorrono pochi mesi e, nel
luglio 1959, vengono stanziati altri 4 miliardi. Anche questi soldi non bastano
e, intanto, i giochi si avvicinano. Il Ministero della Difesa, guidato da
Andreotti, riesce a racimolare altri 800 milioni per consentire almeno
un’approssimativa apertura al traffico. A gestire questa enorme mole di denaro
viene incaricato, su suggerimento dello stesso Andreotti, il colonnello Giuseppe
Amici. Il cognome è tutto un programma, verranno coinvolti parenti, amici e
amici degli amici. Il 20 agosto, a cinque giorni dalla cerimonia inaugurale dei
XVII Olimpiade, i ministri Zaccagnini, Lavori Pubblici, e Andreotti riescono ad
aprire una minima parte dello scalo dell’Urbe “Leonardo da Vinci”. La vera
inaugurazione è rinviata a novembre dello stesso anno. La stampa dell’epoca
comincia a svolgere alcune inchieste per cercare di capire che cosa si cela
dietro i continui ritardi dei lavori. Il 5 maggio del 1961 il governo istituisce
una commissione d’inchiesta che accerta le numerose irregolarità della gestione
dell’opera e come il colonnello Amici, pur essendo in servizio, possedeva alcune
società, delle quali facevano parte la moglie, il figlio e parenti della moglie,
e che avevano un ruolo di rilievo nella costruzione dello scalo. Il 23 dicembre
1961, nella relazione conclusiva, la commissione d’inchiesta accerta
ufficialmente l’utilizzo“di iniziative e procedure criticabili non sempre
rispettose del pubblico denaro”. Il 14 giugno 1963 la magistratura ordinaria
decide per l’archiviazione del caso. Conclusione nessun colpevole. Nelle
casseforti di Montecitorio esistono numerosi documenti che accertano le colpe
dei politici e che non sono mai state rese pubbliche. Il presidente del
Consiglio Renzi, dopo il caso EXPO e il caso MOSE ha chiesto il Daspo a vita per
i politici corrotti. La domanda sorge spontanea: visto come funziona negli
stadi, siamo sicuri che possa funzionare in politica? Ai posteri l’ardua
sentenza.
Ecco dove
nasce la corruzione, scrive Marco Ventura su “Panorama”. Le tangenti sul Mose
non dicono nulla di nuovo. E' un male che parte dalla testa, la nostra. L’altro
giorno mi sono messo in fila al bar per pagare un caffè e cornetto quando è
arrivato un tale ben vestito che dando l’impressione di non aver visto che c’era
una fila (ma non vederci era impossibile) ha elencato alla cassiera, spiccioli
alla mano, quello che aveva consumato. Il tutto con un sorriso a occhi bassi di
conciliazione col mondo. La cassiera ha iniziato a farlo pagare, e siccome ho
protestato, è stata lei a dire subito: “Scusate, è colpa mia”. Dopo qualche
secondo, il tale pretendeva anche di non aver fatto brutta figura: “Non penserà
che non volevo fare la fila, mi manderà mica il cornetto di traverso...”. E la
cassiera, complice: “Eh, il signore è sempre corretto”… Come il caffè. Perché
racconto questo episodio minimo e così diffuso? Perché risiede qui, in questa
disinvolta trasgressione delle regole in nome di qualche potere, dell’amicizia e
della convenienza, il terreno fertile della corruzione piccola e grande. L’hanno
scritto in tanti: non sarà certo l’inasprimento delle pene o l’aggiunta di nuove
regole a sconfiggere le mazzette. La complessità del sistema aiuta i furbi, non
gli onesti. Il problema è nelle nostre teste. E dico “nostre” comprendendo la
mia. Anch’io ho trasgredito a qualche regola, anch’io ho approfittato di qualche
vantaggio personale, non importa se su scala piccola o grande e con quali
giustificazioni. Sono anch’io andato alla ricerca di qualche corsia
preferenziale. Quanti di noi possono dirsi puri? Sarà il sistema, la necessità
di difendersi dalle ingiustizie, il merito che in Italia conta meno di zero e
“non c’è altro modo”. Sta il fatto che la società italiana è corrotta, il “magna
magna” che va in scena a ogni grande evento (praticamente nessuno escluso) è
solo la finale del campionato italiano della corruzione che si gioca ovunque,
ogni giorno, su ogni campo e campetto. E non c’è argine o diga che tenga, per
restare al Mose. La collocazione dell’Italia nella classifica della corruzione
tra i paesi del G7, della UE, e del mondo, è solo lo specchio di una realtà che
ha invaso il quotidiano. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Perché non
c’è poi una differenza concettuale tra il piccolo favoritismo, la piccola
scorrettezza o scortesia, e la grande corruzione. Soltanto dal mea culpa può
scaturire la necessaria rivoluzione culturale: il disgusto per i comportamenti
scorretti e l’intolleranza verso chi trasgredisce. Solo così sarà possibile
riconquistare un senso della comunità. E il primato del merito. La corruzione si
combatte anche come fanno in America, recitando ogni mattina il giuramento alla
bandiera.
Quando si
dimostra che si è tutti uguali, per i manettari tira brutta aria.
Marco
Travaglio, scontro con Elisa ad AnnoUno. Elisa: "Disfattista e manettaro".
Travaglio: "Non dire cretinate". Una protagonista di "Announo" si scaglia contro
il vice direttore de "Il Fatto Quotidiano", accusandolo di vivere solo di
critiche: "Se vince Grillo io cambio paese, ma lei deve cambiare mestiere perché
non avrebbe nessuno cui andare contro". Siamo nello studio di AnnoUno, il
programma di Giulia Innocenzi. Ospite d'onore è Marco Travaglio, che si produce
nella sua consueta filippica manettara. Lo spunto, come ovvio, arriva dalla
scandalo Mose: sul Fatto Quotidiano si è spinto ad affermare che la presunzione
di innocenza è ridicola. Una presa di posizione che non è piaciuta ad Elisa, una
delle ragazze protagoniste della puntata di AnnoUno. "Ma la smetta di attaccare
tutti, di dire che rubano sempre tutti. Se in questo paese vince Beppe Grillo io
vado all'estero, ma lei che cosa fa? Di che cosa scrive?". Marco Manetta, come
sempre quando viene punto, perde le staffe: "Ti piace che rubino? Ti piace che
rubino i tuoi soldi?". Elisa ribatte: "Glielo dico come direbbe Sgarbi:
presunzione di innocenza, presunzione di innocenza, presunzione di innocenza".
Marco Manetta si contorce, e sbotta: "Per favore, ma per favore. La presunzione
d'innocenza - ribadisce - è un inutile gargarismo. Se vuoi dopo te lo spiego
cosa intendo, magari capisci il labiale". Poi però prende parola Silvia,
un'altra delle ragazze, e continua nel solco di Elisa: continua a demolire
Travaglio per la sua clamorosa inclinazione manettara. Il vicedirettore è
all'angolo. E in parallelo anche su Twitter si scatena il dibattito con una
pioggia di cinguetti: "#Travaglio strapazzato da due biondine", scrive Nicola di
Maio. "Voglio sposare la biondina che, limpida e divertita, ridicolizza
Travaglio. Non che ci voglia molto, però è sempre un piacere", rincara
Massimiliano Mannino. Infine, giusto per pescare un tris di commenti dal mazzo
ecco Terry: "Lo stanno distruggendo le ragazze...Travaglio hai stancato". Nello
studio di AnnoUno, insomma, si viene a creare una situazione paradossale. Nel
regno di Michele Santoro e di Giulia Innocenzi, sul banco degli imputati,
assediato dalla giuria popolare, ci finisce proprio lui, ci finisce proprio
Marco Travaglio con un vivace scambio di battute ad "Announo" del 5 giugno 2014
tra Marco Travaglio ed Elisa Serafini, una delle protagoniste del programma in
onda su La7. La 26enne milanese attacca il vice direttore de "Il Fatto
Quotidiano": "Lei vive di antagonismo da troppi anni, prima perché c’era
Berlusconi, adesso non va niente bene perché c’è Renzi. Se vince Grillo io
cambio paese, ma lei deve cambiare mestiere perché non avrebbe nessuno cui
andare contro. Perché bisogna misurare la qualità di un paese sul numero di
persone che vanno in galera?...Basta fare i manettari”. “Non si può essere così
disfattisti…lo capisco che lui ha creato una carriera - prosegue Elisa - ma se
va Grillo al governo lei deve cambiare lavoro perché non può andare contro una
persona che sostiene…Ma lei vive solo di critiche?”. La risposta di Travaglio
non si fa attendere: "E’ la cronaca che è disfattista, non sono io
purtroppo…Secondo te il giornalista è uno che lecca il c*** ai politici? E’ uno
che dice che va tutto bene quando va tutto male? Io racconto quello che
succede”. Ma è quando la giovane cita Vittorio Sgarbi che il giornalista sbotta:
"Ma non dire cretinate. Almeno leggi il labiale”.
Il Manifesto
del Forcaiolo, scrive Filippo Facci. Marco Travaglio ha finalmente scritto il
Manifesto del forcaiolo – in parte recitato ad Announo – ossia un articolo che
cerca di fiancheggiare la comprensibile rabbia legata ai vari scandali, così da
evidenziare i suoi autentici desideri in tema di giustizia. Darne conto è
interessante, perché sintetizza che paese diventeremmo se certe soluzioni
venissero effettivamente adottate: una sorta di Germania Est, coi Cinque Stelle
al posto della Stasi. Intanto va segnalato che il pentastelluto Mario Giarrusso
ha proposto seriamente il ripristino della ghigliottina – lo ha detto alla
Zanzara, su Radio24 – spiegando pure che gli arresti domiciliari andrebbero
aboliti. Diceva sul serio. Ma veniamo alle analisi e alle proposte di Travaglio.
1) Travaglio
fornisce una disamina della seguente profondità: «Destra, sinistra e centro
rubavano. Rubavano e rubano tutti, e insieme, sempre, regolarmente,
scientificamente, indefessamente… Esiste soltanto una gigantesca, trasversale,
post-ideologica associazione per delinquere che si avventa famelica su ogni
occasione per rubare». Tutti. Insieme. Sempre. Quindi anche il governo delle
larghe intese: «Continuano a rubare, secondo un sistema oliato e collaudato di
larghe intese del furto che precede e spiega le larghe intese di governo». Il
governo Pd-Ncd, dunque, serve a rispecchiare l’amicizia trasversale tra Frigerio
e Greganti (Expo) o tra Galan e Orsoni (Expo). E Renzi? Ruba anche lui? No, «i
suoi fedelissimi sono lì da troppo poco tempo. Ma rischia di diventare il
belletto per mascherare un partito marcio». Renzi, quindi, è la copertura della
gigantesca associazione per delinquere. Va rilevato che il Travaglio-pensiero –
si fa per dire – è un’evoluzione recente: nel 2010, sul Fatto, elogiava il
piddino Giorgio Orsoni (ora arrestato) definendolo «persona seria e normale».
2) Adesso però
è cambiato tutto, e le garanzie democratiche e costituzionali andrebbero
sospese. Lo scrive Travaglio, e tra le righe non si scorge alcun tono satirico:
«L’art. 27 della Costituzione, quello della presunzione di non colpevolezza,
diventa una barzelletta se si leggono le carte delle indagini… non c’è bisogno
della Cassazione, e nemmeno della sentenza di primo grado, per capire che
rubavano davvero». Basta Il Fatto Quotidiano che legga per noi le carte: carte
infallibili scritte da pm infallibili, come dimostra la storia giudiziaria
italiana. C’è da sentirsi tranquilli.
3) La terza
proposta è di conseguenza: «Cacciare ogni inquisito dai governi locali e
nazionali». È sufficiente essere inquisiti e non importa per che cosa: anche per
atto dovuto, anche per una qualsiasi delle scemenze per le quali in Italia non
esiste politico che non sia stato inquisito almeno una volta: o condannato, come
Grillo, o come Travaglio. Del resto «a certi livelli non esistono innocenti,
solo colpevoli non ancora presi», scrive il nostro. Bene. Si allarga il clima di
fiducia.
4) Anche la
quarta proposta è di conseguenza: «Radiare dai contratti pubblici tutte le
imprese coinvolte in storie di tangenti». E siccome «in storie di tangenti» sono
state coinvolte praticamente tutte le più importanti aziende italiane ed estere
(comprese Eni, Finmeccanica, Fiat, Autostrade, Coop) i lavori della
Salerno-Reggio Calabria saranno conclusi da Casaleggio via internet.
5) Ma è un
falso problema, perché prima c’è altro da fare: «Cancellare le grandi opere
inutili ancora in fase embrionale, dal Tav Torino-Lione al Terzo Valico». C’è
uno scandalo a Venezia e allora rinunciamo alla Torino-Lione, che è in fase
embrionale come può esserlo un ragazzino di 14 anni. Non è un discorso
pretestuoso, no.
6) Ma restiamo
allo stato di polizia che piacerebbe a Travaglio. Che cosa servirebbe? Questo:
«Introdurre gli agenti provocatori per saggiare la correttezza dei pubblici
amministratori… imporre a chi vuole concorrere ad appalti una dichiarazione in
cui accettano di essere intercettati, a prescindere da ipotesi di reato». Viene
il sospetto che Travaglio abbia visto «Americam Hustle» o, più indietro nel
tempo, «Le vite degli altri». E resta la curiosità di sapere che cosa accadrebbe
nel nostro Paese se, oltre alle mazzette vere, ci fossero anche quelle false
offerte da agenti provocatori e cioè corruttori: questo nello stesso Paese
post-sovietico in cui chiunque partecipasse a un appalto (anche quello per la
fontana del paesello) dovrebbe mettere a disposizione del maresciallo tutte le
proprie conversazioni e dunque quelle dei suoi amici e familiari. Molto bello.
7) Il problema
è che in galera c’è poca gente: occorre «piantarla con le “svuotacarceri”,
costruire nuovi penitenziari e, nell’attesa, riattare caserme dismesse per
ospitare i delinquenti che devono stare dentro». È così semplice. È la scuola
dell’amico Piercamillo Davigo, già ispiratore anche della battuta sui colpevoli
non ancora scoperti: in Italia ci sono pochi detenuti in rapporto alla
popolazione, diversamente dagli Stati Uniti. Ma segnaliamo un problema: Usa e
Italia adottano sistemi diversi. Comunque tutto si può fare: ma bisognerebbe,
anche qui, cambiare la Costituzione.
7)
Nell’attesa, si possono «radere al suolo tutte le leggi contro la giustizia
targate destra, centro e sinistra degli ultimi 20 anni». Tutte. Proprio tutte.
Soprattutto quella che bruciò di più alla magistratura, cioè la riforma
dell’articolo 513 che costrinse a cambiare la Costituzione nel 1999: si
tornerebbe, cioè, a quando un accusatore poteva tranquillamente denunciare
chicchessia, patteggiare una pena simbolica e quindi uscire dal processo senza
neanche presentarsi in aula per confrontarsi con la persona che aveva accusato.
Very Germania Est.
8) «Tutto il
resto non è inutile: è complice».
9) Per qualche
misteriosa ragione – scrive infine, cioè: in realtà lo scrive all’inizio – dopo
lo scandalo di Venezia dovremmo tutti chiedere scusa a Beppe Grillo: «Milioni di
persone perbene – elettori, giornalisti, intellettuali, eventuali politici e
imprenditori – dovrebbero leggersi l’ordinanza dei giudici di Venezia e poi
chiedere umilmente scusa a Beppe Grillo e ai suoi ragazzi». Perché? Travaglio
non lo spiega, se non deplorando gli «anni e anni sprecati ad analizzare il suo
linguaggio, a spaccare in quattro ogni sua battuta, a deplorare il suo
populismo, autoritarismo, giustizialismo… intanto destra e sinistra e centro
rubavano» Tutti. Insieme. Sempre. Travaglio ne approfitta per correggere la
rotta sull’alleanza grillesca con Nigel Farage: «L’abbiamo denunciata anche noi,
ed era giusto farlo, ma in un paese normale: dunque non in Italia». Traduzione:
c’è stato lo scandalo del Mose e allora Grillo potrebbe anche allearsi con
Farage. Travaglio l’ha deciso mercoledì. Martedì aveva scritto il contrario.
Grillo rischia
di far scoppiare la coppia Santoro-Travaglio. Santoro: "Beppe senza autorità
morale per dire chi è buono e chi è cattivo", scrive Maurizio Caverzan su “Il
Giornale”. I giornalisti sono stati convocati per parlare di Announo, il nuovo
programma di approfondimento condotto da Giulia Innocenzi, che da giovedì,
ospite Matteo Renzi, prenderà il posto di Servizio pubblico. A ben guardare,
però, tira aria di rifondazione anche per il talk show di Michele Santoro: un
nuovo inizio, una ripartenza, forse anche con un nuovo nome e qualche novità
nella squadra. Del resto, Todo cambia: in politica, nell'informazione, nel
rapporto con i leader, con Grillo, Renzi, la sinistra. Un cambiamento che
potrebbe comportare anche la separazione tra l'ammiraglio e il suo bombardiere
più agguerrito. «Fino a qualche tempo fa era tutto chiaro, il cattivo era
riconosciuto», spiega Santoro. «Di fronte a Berlusconi, io e Travaglio eravamo
uniti, anche se io ero su posizioni più liberali... Ora chi è il cattivo?».
Travaglio sta con Grillo, Santoro no. Inoltre, anche sul piano televisivo
assistiamo a un cambiamento profondo: «E io pensavo che Servizio Pubblico fosse
un ciclo finito. Ma Cairo, con cui c'è stato un confronto serrato, ci ha chiesto
di continuare anche per l'anno prossimo. Sono stato contagiato dalla sua voglia
e ho deciso di accettare». Tanto più che «La7 è il vertice dell'indipendenza e
sono onorato di lavorare in una rete in cui nessuno mi dice che cosa devo fare».
E la Rai? «Se mi offrisse di fare un programma, anche simbolico, tipo
Trasmissione zero, lo farei, perché no? È un lungo pezzo di storia
professionale...». Ma di ritorni, per ora non si parla. Della necessità di
cambiare Servizio pubblico invece sì. La riflessione era già in atto. E
l'attacco di Grillo ha fatto da detonatore. «Mi auguro che dismetta i toni
illiberali. Che impari a rispettare il lavoro dei giornalisti», afferma Santoro.
«Contro Vauro ci sono stati toni inaccettabili, fino alle minacce, innescate da
una forza politica che avrebbe il dovere di dissociarsi. Il mio amico Travaglio
dice che la Rete si esprime così. Io temo che si trasformi in una grande Piazza
Tahrir, anti-istituzionale a prescindere. Grillo è il Berlusconi del web», dice
al Giornale il conduttore che con il Cav ospite ha fatto il record storico: «Ti
restituisce quello che prende da lì, sull'immigrazione, sulla Tav... Fa il suo
mestiere, ma non ha l'autorità morale per dire chi sono i buoni e i cattivi. Usa
anche il gossip per colpire i presunti avversari... Si è creata una combinazione
mostruosa Casaleggio-Dagospia. Ora non voglio disturbare la sua campagna
elettorale, ma una volta terminata, potrei andare anch'io nelle piazze a
raccontare come stanno le cose. Sarebbe un'operazione di legittima difesa e per
la libertà di stampa». In difesa, Santoro gioca anche a proposito di crisi «dei
cosiddetti talk show». È la tv generalista a essere in crisi, dieci anni fa Rai
e Mediaset facevano il 90 per cento di share ora arrivano al 60. E poi,
mostrando uno studio dell'istituto di ricerche Barometro, sottolinea che «nella
storia di La7 Servizio pubblico compare in 4 posizioni della top 5, in 6 della
top 10 e in 15 tra le prime 20 (in share, ndr), mentre nell'ultima stagione
ricopre le prime sedici posizioni (in valori assoluti, ndr)». Se quest'anno c'è
stato un calo è perché «ora lo spettatore ha un rapporto diverso con la
politica». Alla maggioranza del pubblico interessa capire se Renzi ce la fa o
no. Per il resto «siamo invasi da replicanti della politica. Ma anche i big
hanno un richiamo limitato: Grillo da Mentana non ha fatto il botto... Lo stesso
Berlusconi forse non ha piacere a tornare da noi, perché dovrebbe misurarsi con
il 34 per cento dell'anno scorso. Magari avrà più interesse ad andare nel
programma di Giulia. Certo, è stato invitato; come pure Grillo». Che però andrà
da Vespa. «C'è la campagna elettorale e se gli serve fa bene... Ma mi pare una
sconfitta, un'incoerenza. Tra dire che la tv è morta e poi andare da Vespa...»,
punge Santoro, dribblato dallo Sciamano pentastellato. «In realtà, la tv si
mostra centrale anche quando nei blog si parla per una settimana dell'operaio
ospite di Servizio pubblico e per prendere i voti di Berlusconi si attacca il Pd
e la nuova peste rossa». Insomma, tutta colpa di Grillo e dei politici se i talk
vanno così così. E un po' di autocritica di voi televisivi? «Ci siamo adagiati
sul fatto che la temperatura esterna garantiva il successo delle nostre
trasmissioni. Ma adesso si riparte...». Auguri.
Michele
Santoro: "Travaglio? Occhio al fondamentalismo...scrive " Libero Quotidiano”. Su
Il Fatto Quotdiano viene intervistato Michele Santoro. Si parte da AnnoUno, la
trasmissione della santorina Giulia Innocenzi che ha sbancato in termini di
share. Il teletribuno fa i complimenti alla sua creatura, afferma di essere
sempre stato sicuro del fatto che avrebbe bucato lo schermo e si spinge ad
affermare che "la tv cambia", e dunque "AnnoUno è già il futuro". Ma il piatto
forte arriva quando nell'intervista Santoro parla di Beppe Grillo e,
soprattutto, di Marco Travaglio. Si parte da una riflessione sul guitto ligure:
"Non possiamo continuare a pensare che Grillo sia una specie di Masaniello che
urla per dire qualunque sciocchezza. Dobbiamo valutarlo per quello che è: un
leader politico, che deve avere una visione". E da queste considerazioni il
discorso passa in scioltezza al leader grillino su carta stampata, Marco
Travaglio appunto, il vicedirettore del Fatto Quotidiano che è il primo megafono
del leader pentastellato. Un'adorazione, quella di Travaglio per Grillo, che
Michele non riesce a digerire, tanto che negli ultimi giorni, dopo alcune parole
sibilline del conduttore di Servizio Pubblico, si è cominciato a parlare del
possibile divorzio tra Santoro e Marco Manetta. Così, parlando proprio con Il
Fatto, in un significativo cortocircuito, Santoro dice la sua sul vicedirettore
della testata. Il rapporto con Travaglio? "Un rapporto di grandissima amicizia
prima di tutto, di stima smisurata sotto il profilo professionale. Ma il vero
punto - si chiede Santoro - è cosa dobbiamo fare? Agire per il crollo del
sistema o per la rigenerazione?". Il teletribuno mostra di non avere particolari
dubbi: "Non possiamo sposare quello che fa Renzi, ma neanche quello che fa
Grillo. No, non dico Marco abbia perso la sua indipendenza. Sarebbe una
banalizzazione. Penso semplicemente che Marco sia portato a vedere tutto quello
che sta fuori da questa piazza Tahrir come un'elemento che non contenga tanti
spunti positivi. La sua è una visione pessimistica sul mondo politico
organizzato. Lui - prosegue nella tirata - è come se pensasse che non è che si
può stare in mezzo, bisogna stare dentro quella piazza. Però - attacca Michelone
- stando dentro piazza Tahir il rischio è il fondamentalismo al governo. E' una
differenza di analisi, non è una cosa banale che contrappone Santoro e
Travaglio". Dunque, continua il conduttore di Servizio Pubblico, "nel momento in
cui, quando andremo a disegnare un nuovo programma, questa differenza di
valutazione di approccio è giusto che venga fuori, si confronti, insieme
tracciamo la strada di come deve essere fatto un programma diverso da quello che
stiamo facendo tutti e due". La domanda si fa poi più esplicita: "Marco - chiede
Peter Gomez - quindi se ha voglia parteciperà al tuo programma il prossimo
anno?". La risposta: "E' possibilissimo, ma potrebbe anche essere possibile per
esempio che avendo io delle carte in mano da giocare, diverse da quelle del
programma, perché non pensare che ci possa essere un programma di Marco. Magari
con il mio aiuto". O magari no. Ma questo Santoro non lo dice. Quello che ha
detto, al contrario, sembra un po' un benservito di lusso al "fido" Travaglio.
Il divorzio è stato ormai consumato?
Santoro non
nasconde il comunista che è in lui.
Santoro:
"Resto un vecchio comunista". Il conduttore parla della Rai e del taglio di 150
milioni paventato da Renzi, scrive Franco Grilli su “Il Giornale”. Michele
Santoro si scaglia contro Matteo Renzi. Il tema del contendere è quello della
Rai e del taglio voluto dal premier. E se viale Mazzini indicesse uno sciopero,
il conduttore di Servizio Pubblico non esiterebbe ad aderirvi: "Perché sono un
vecchio comunista e se il mio sindacato me lo chiede io non faccio il crumiro",
spiega Santoro in una intervista a Repubblica. Sul taglio di 150 milioni dice:
"Significa imporre tagli lineari, costringere l'azienda a ridimensionare il
prodotto. Ma Renzi, che ha nell'intuito la sua più grande dote, ha capito che la
Rai è l'ultima sopravvissuta del vecchio sistema politico e i tagli sono un modo
per destabilizzare tutto. Nel senso che Grillo si è messo a difendere lo
sciopero passando così come l'alfiere del passato, col "vecchio" Pd e Forza
Italia che hanno fatto alleanza mentre lui li osserva dall'altra parte. Un
capolavoro politico". Infine, sul taglio agli stipendi di Vespa e Floris spiega:
"Pura demagogia, se non hai Maradona, lo stadio non lo riempi, così senza
Celentano non fai audience".
Un libro ricostruisce Tangentopoli con
retroscena e aneddoti.
«Berlusconi? Onestamente non posso dire che sia un mascalzone». Così parlò Carlo
De Benedetti, il nemico pubblico numero uno del Cav. Parole dal sen fuggite?
Tutt'altro. Ogni singola parola attribuita all'Ingegnere e contenuta nel libro
di Paolo Guzzanti, «Guzzanti vs De Benedetti» (368 pp, Aliberti editore) è stata
letta, ponderata e confermata dallo stesso editore di Repubblica ed Espresso.
Dalla biografia scritta dall'ex vicedirettore del Giornale emerge il ritratto di
un imprenditore che ammette di essere come Berlusconi: «È un autocrate come
tutti noi imprenditori, ma come persona non è affatto cattiva ed è anzi sicuro
di fare il bene. Il motivo per cui io lo combatto è che, essendo un imprenditore
al comando del Paese, è per definizione un rischio per la democrazia. Anch'io,
se mi mettessi a fare il politico, sarei un pericolo per la democrazia». Con
Silvio siamo al rapporto di amore-odio. Anzi: «Io non lo odio, lo disapprovavo,
è l'uomo che incarna un intero popolo in modo passionale, sentimentale, persino
affettuoso. Lo dico da suo avversario: non è assolutamente una carogna».
Roba da
far drizzare le orecchie ai colonnelli democratici. Anche perché di fianco
all'elogio come imprenditore all'avversario Silvio, le accuse contro i vertici
del Pd sono spietate. I primi a cadere sono D'Alema e Bersani: «Il segretario è
inadeguato, lui e D'Alema stanno ammazzando il Pd». E su Baffino: «Credo che
abbia fatto tantissimi errori e non capisca più la sua gente, come il caso
Puglia insegna. Su Berlusconi come uomo politico il giudizio è estremamente
negativo, ma almeno Silvio ha fatto qualcosa. D'Alema e quelli come lui non
hanno fatto niente». Il De Benedetti che ne esce fuori sembra il prigioniero
politico della sua stessa armata, da sempre schierata col centrosinistra. Come
quando è lo stesso De Benedetti ad ammettere che «Ezio Mauro talvolta si fa un
po' prendere la mano da certi suoi giornalisti...». Insomma, è l'Ingegnere la
vera vittima del mostro politico che ha contribuito a creare: «Mi odiano, ci
odiano e adesso si sono messi in testa che Ezio Mauro voglia diventare il leader
del Pd e questo li fa impazzire. Sono ridotti così male che hanno inventato
questa leggenda». Un po' di vetriolo c'è anche per l'ex premier Romano Prodi,
regista della mancata acquisizione della Sme da parte di De Benedetti a
vantaggio della cordata voluta da Bettino Craxi e guidata da Berlusconi, i cui
strascichi giudiziari hanno portato alla sentenza di risarcimento monstre da 600
milioni di euro. È tutta colpa del Professore: «Io detestavo Craxi, la cosa è
nota, ma in quel caso aveva perfettamente ragione: era il presidente del
Consiglio e Prodi compiva un'operazione di quella portata dando via aziende
statali senza nemmeno fargli una telefonata. Prodi così fece incazzare Craxi
come una belva». C'è ancora il tempo per ricordare quando stava per restare una
notte in galera per «colpa» della moglie di Bruno Vespa, l'allora gip romano
Augusta Iannini, dopo aver ammesso di aver pagato tangenti ai politici
(«C'eravamo dentro tutti - dice De Benedetti - questa è la verità e questo era
il metodo...»). Quel giorno del lontano 1993 l'editore di Repubblica li ricorda
così: «La gip Iannini mi fece un interrogatorio nel pomeriggio a Regina Coeli,
presente la pm Cordova. Poi a un certo punto la Iannini se ne andò e con la
Cordova finimmo l'interrogatorio. A quel punto chiesi di andare via, ma la Pm
disse: “Per me lei può uscire, pero c'è da firmare e siccome a quest'ora non c'è
più il gip lei stanotte sta qui”. Allora io prendo il mio avvocato, lo mando a
casa della Iannini, perché non voglio passare la notte a Regina Coeli e, con il
parere favorevole del Pm, la Iannini ha firmato. E quindi alle dieci di sera
sono uscito dalla prigione».
Da
quanto detto si riporta il commento di
Tiziana Maiolo su “Il Giornale”.
L'abilità di un finanziere come Carlo De Benedetti si coglie da mille
particolari. I soldi. La rete di relazioni. Il cinismo. La capacità di lasciare
una poltrona al momento giusto e con sostanziose liquidazioni. La forza di
ripartire dopo un rovescio. E anche la fortuna di uscire sempre immacolato dalle
vicende giudiziarie in cui finisce coinvolto.
Sarà
una coincidenza, una combinazione singolare, una concomitanza casuale; sarà
semplicemente che l'imprenditore che si è sempre proclamato «diverso» dai
colleghi non aveva commesso quanto gli era stato addebitato. Ma il tarlo di un
maligno interrogativo resta: essere l'editore più giustizialista d'Italia,
difendere a oltranza i magistrati che indagano su Silvio Berlusconi, è
un'assicurazione sulla vita?
Il caso
più lontano nel tempo è quello del Banco Ambrosiano, tempio della P2.
Siamo
negli Anni 80: De Benedetti entrò nell'istituto di credito con il 2 per cento
del capitale e la carica di vicepresidente (il numero uno era Roberto Calvi) e
ne uscì 65 giorni dopo, alla vigilia del crac, intascando una plusvalenza di 40
miliardi di lire. Fu accusato di concorso in bancarotta fraudolenta ed ebbe una
condanna a 6 anni e 4 mesi di reclusione in primo grado, ridotta in appello a 4
anni e 6 mesi, e annullata senza rinvio dalla Cassazione.
Nei
primi Anni 90 De Benedetti e altri sette manager furono assolti dall'accusa di
elusione fiscale: il pm aveva chiesto per il presidente Olivetti la condanna a
due anni e quattro mesi di reclusione e al pagamento di 15 milioni di multa per
una presunta evasione di complessivi 37 miliardi di lire. Il sofisticato
meccanismo si chiamava «dividend stripping» e consentiva, a certe condizioni, di
usare i dividendi azionari come credito d'imposta. Inoltre, come ricordano
Gianni Barbacetto, Peter Gomez e Marco Travaglio in «Mani sporche», De Benedetti
«ha chiuso con due oblazioni da 50 milioni di lire ciascuna altrettanti processi
per le manovre in Borsa sui titoli Olivetti (insider trading) e per i bilanci
del gruppo di Ivrea (false comunicazioni sociali)». Sentenza, quest'ultima,
revocata dopo la riforma del falso in bilancio voluta dal governo Berlusconi nel
2002.
Ma la
vicenda più clamorosa fu il coinvolgimento di De Benedetti in Tangentopoli dopo
l'arresto del direttore generale delle Poste, Giuseppe Parrella, e del suo
segretario Giuseppe Lo Moro, il quale parlò di mazzette ricevute dalla Olivetti
per la fornitura di telescriventi al ministero. Era il 1993, qualche anno dopo
la battaglia per il controllo di Segrate sfociata nella sentenza. In maggio il
finanziere anticipò i pubblici ministeri consegnando ad Antonio Di Pietro una
memoria in cui ammetteva vari giri di tangenti perché «vittima del sistema»: in
particolare oltre 10 miliardi di lire a Dc e Psi per l'appalto postale.
A
novembre fu emesso un mandato di cattura a suo carico. De Benedetti si costituì,
fu trasferito al carcere di Regina Coeli, interrogato nella notte dal pm Maria
Cordova e dal gip Augusta Iannini, ottenendo gli arresti domiciliari e quindi la
scarcerazione. Un trattamento di assoluto riguardo: mentre i manager di tante
aziende aspettavano giorni prima di essere ascoltati da un magistrato e mesi
prima di lasciare il carcere dopo aver vuotato il sacco, all'Ingegnere la rara
tempestività della giustizia italiana consentì di evitare la cella. Da questo
processo (l'accusa era corruzione) De Benedetti uscì in parte assolto e in parte
prescritto.
Chi invece riuscì pienamente a
trattare con i magistrati milanesi fu l’ingegner Carlo De Benedetti, che un bel
giorno si presentò a un incontro concordato, raccontò la sua e tornò a casa con
le sue gambe. Corse qualche rischio per la sua libertà invece al Palazzo di
giustizia di Roma, dove non vigeva il «rito ambrosiano» e dove fu arrestato per
un giorno, nello stupore dei suoi avvocati, che trovarono nella capitale due
magistrati (non a caso due donne) poco inclini alla trattativa alla milanese. Il
che può apparire stupefacente, vista la pessima immagine del tribunale di Roma,
da sempre chiamato «porto delle nebbie», e la cui reputazione fu strumentalmente
usata dai magistrati del pool ogni volta che si profilava un conflitto di
competenza tra Milano e la capitale. (...). Il 30 aprile 1993 l’ingegner De
Benedetti dichiara a la Repubblica, quotidiano con cui aveva qualche confidenza,
di «non aver mai corrisposto finanziamenti ai partiti politici o a entità a essi
collegate». Ma il Corriere della Sera del 17 maggio scriverà che «L’Ingegnere ha
incontrato i giudici consegnando loro un memoriale sulle tangenti pagate dalla
Olivetti». Stranamente due giorni dopo, il 19 maggio, esce una dichiarazione sul
Wall street journal in cui l’uomo di Ivrea afferma con sincerità: «Se dovessi
rifare tutto di nuovo lo rifarei: pagherei le tangenti ai politici per ottenere
le commesse pubbliche». Il re della coerenza. La voce circolava in quei giorni.
E De Benedetti aveva buoni avvocati e buoni orecchi. Così mise insieme un
dossier e il 16 maggio 1993, di domenica, lontano da occhi indiscreti, nella
caserma dei carabinieri di via Moscova a Milano, si incontrò con i pubblici
ministeri Di Pietro, Colombo e Jelo. (...). De Benedetti conosce bene la
lezione, e racconta di esser stato sistematicamente concusso dalle Poste
italiane e dai partiti di governo. Ha speso in tutto tra i 15 e i 20 miliardi di
lire, di cui 10 miliardi e 24 milioni solo alle Poste. La frase che detterà alle
agenzie sembra fotocopiata dallo schema fisso gradito alla Procura: «In Italia
negli ultimi quindici anni c’è stato un regime politico che ha prevaricato e
taglieggiato l’economia. Grazie all’opera di pulizia fatta dai giudici è
diventato possibile sconfiggere la tangentocrazia». Due giorni dopo, forse
pensando, giustamente, che i magistrati non leggano la stampa estera, dirà al
Wall street journal che l’avrebbe rifatto. Nessuno glielo contesterà, nessuno
dei suoi collaboratori verrà indagato e nei suoi confronti non verrà richiesta
nessuna rogatoria estera. (...).
A Roma Carlo De Benedetti ha a che
fare con due donne magistrato piuttosto agguerrite, la pm Maria Cordova e la gip
Augusta Iannini. Giovanni Maria Flick, che sarà in seguito il ministro alla
Giustizia del primo governo Prodi nel 1996, è il difensore di De Benedetti ed è
sconcertato davanti a una richiesta di arresto che a Milano non c’è mai stata.
Ma il Palazzo di giustizia di Roma, nonostante la cattiva fama, è più «normale».
Come dirà ai giornalisti la gip Augusta Iannini: Per me, la legge è uguale per
tutti. L’ingegner Carlo De Benedetti è uguale al signor Mario Rossi, al signor
Paolo Bianchi. E se i signori Mario Rossi o Paolo Bianchi fossero accusati degli
stessi fatti contestati nell’ordine di custodia cautelare all’ingegner Carlo De
Benedetti, sarebbero stati arrestati. La situazione è imbarazzante per il
presidente dell’Olivetti, che riteneva di aver pagato pegno a Milano, dove è
solo indagato, e invece si ritrova con un mandato di cattura a Roma per lo
stesso reato. La verità, a quanto pare, è che a Milano si sarebbero accontentati
del memoriale e non hanno approfondito lo scandalo di tutte quelle
apparecchiature obsolete, stampanti e telescriventi, vendute dall’Olivetti al
ministero delle Poste, costate parecchio, mentre dieci miliardi di lire finivano
in tangenti. Naturalmente nel memoriale De Benedetti scriveva che queste
tangenti gli erano state «estorte», ma questo è quel che dicevano tutti gli
imprenditori. Se Milano si era accontentata, i magistrati romani erano piuttosto
seccati, avevano raccolto una gran quantità di documenti e avevano cominciato a
fare due conti. Si era creato anche un piccolo incidente diplomatico interno al
Palazzo di giustizia, perché il procuratore capo Mele si era molto irritato
nello scoprire che la dottoressa Cordova, sua sostituta, aveva chiesto la misura
cautelare per De Benedetti senza consultarlo. Ne seguì un parapiglia di
dichiarazioni, in cui si inserì anche il pm milanese Gherardo Colombo, e che
alla fine giovò al presidente della Olivetti, che fu «un pochino» arrestato per
un giorno e anche in seguito, tra archiviazioni e reati caduti in prescrizione,
se la cavò.
Parlamento italiano: pomeriggio del 20 luglio 2011. Già è mortificante il fatto
che in quei luoghi non si votino le leggi, ma le autorizzazioni alla custodia
cautelare in carcere per alcuni dei suoi membri. Ma già li è chiaro: in Italia
la legge, come l’etica e la morale, non è uguale per tutti. Se sei del
centrodestra sono tutti d'accordo a sbatterti in galera, se sei del
centrosinistra invece ti graziano. E' questa la triste verità che emerge dai
voti che hanno spalancato le porte del carcere di Poggioreale per il deputato
Pdl Alfonso Papa e hanno salvato il senatore Pd Alberto tedesco. Ed è la stessa
triste verità che ispira il diverso trattamento concesso a Piergianni
Prosperini, l'ex assessore lumbard finito ai domiciliari perché accusato
di aver ricevuto delle tangenti per favorire un imprenditore in una gara
d’appalto per la promozione di eventi in Valtellina, e Filippo Penati del Pd,
capo della segreteria politica di Bersani e consigliere regionale lombardo con
incarico di vice presidente del Consiglio, ex sindaco di Sesto San Giovanni e
Presidente della provincia di Milano, indagato perché avrebbe preso mazzette
fino a 4 miliardi di lire. Questa è la giustizia all'italiana.
"Ho dimostrato a tutti di essere un uomo, chiedendo di votare per il mio
arresto. Ma ora ho il dovere di restare al mio posto, in Senato". A Tedesco non
lo sfiora nemmeno l'idea di lasciare la poltrona a Palazzo Madama. Assicura che
andrà avanti, puntualizza che aspetterà che la magistratura faccia il suo lavoro
e fa sapere che in futuro si batterà per l'abolizione della custodia cautelare.
E, mentre il senatore piddì resta in parlamento, Papa ha già passato una notte
in carcere. Eppure, come spiega il vicepresidente della Camera Antonio Leone, "a
carico di Tedesco sussiste un impianto accusatorio ben più pesante di quello
messo insieme per Papa dai pm napoletani". Finito nell'inchiesta che ha
sconvolto la sanità in Puglia, l'ex assessore di Vendola è accusato di
corruzione, concussione, turbativa d’asta, abuso d’ufficio e falso. Nel mirino
dei pm di Bari ci sono i presunti appalti truccati e le nomine dei vertici
dell'Asl: dal 2005 al 2009 la sinistra pugliese avrebbe, infatti, imposto i
primari e gli imprenditori che avrebbero poi dovuto vincere le gare d’appalto.
"La prassi politica dello spoil system - si legge nell'ordinanza del gip
Giuseppe de Benedictis - era talmente imperante nella sanità regionale da
indurre Vendola, pur di sostenere alla nomina a direttore generale di un suo
protetto, addirittura a pretendere il cambiamento della legge per superare, con
una nuova legge a usum delphini, gli ostacoli che la norma frapponeva
alla nomina della persona da lui fortemente voluta".
Di tutt'altro spessore le accuse rivolte a Papa, finito nell'inchiesta P4
portata avanti dai pm Henry Woodcock e Francesco Curcio della procura
partenopea. I reati contestati sono: corruzione, concussione, estorsione e
favoreggiamento personale. Secondo il gip di Napoli, Papa, Luigi Bisignani,
Enrico La Monica e Giuseppe Nuzzo "promuovevano, costituivano e prendevano parte
a una associazione per delinquere, organizzata e mantenuta in vita allo scopo di
commettere un numero indeterminato di reati contro la pubblica amministrazione e
contro l'amministrazione della giustizia". Insomma, per la procura di Napoli
Papa avrebbe fatto parte di "un sistema informativo parallelo" al fine di
acquisire informazioni sulle indagini e usarle per avanzare "indebite pretese e
indebite richieste" sugli indagati.
Per i due politici indagati sono state usate due pesi e due misure diverse.
Mentre il Pdl si è dimostrato garantista con entrambi i parlamentari, a Palazzo
Madama i numeri ci dicono che tutti i 34 suffragi necessari a negare i
domiciliari provengono dalle fila della sinistra....
Insomma, l'opposizione ha usato, come al solito, due pesi e due misure. Proprio
come viene fatto dalla magistratura. Risulta infatti emblematico le indagini
che, in questi giorni, hanno investito la Lombardia. Filippo Penati ieri,
Piergianni Prosperini oggi. Il capo della segreteria politica di Bersani ed ex
presidente della Provincia di Milano è indagato per corruzione, concussione e
finanziamento illecito ai partiti. L'accusa è di aver preso tangenti per circa 4
miliardi di lire tra il 2001 e il 2002 per la riqualificazione di due ex aree
industriali e per i servizi di trasporto dei comuni dell'Alto milanese. Un
illecito che Penati avrebbe proseguito fino a dicembre dell'anno scorso. Il
decreto di perquisizione firmato dai pm di Monza Walter Mapelli e Franca Macchia
parla di "gravi indizi di colpevolezza", eppure su Penati non grava alcuna
misura di custodia cautelare. Gli arresti domiciliari, invece, sono stati dati
per la seconda volta all'ex assessore lombardo Prosperini, accusato di
corruzione e false fatturazioni in relazione alle tangenti "incassate" per
favorire un imprenditore in una gara d’appalto per la promozione di eventi in
Valtellina.
"Il voto di ieri ha dato la conferma della doppia morale della sinistra che vota
contro gli avversari politici e salva i suoi sodali". Con queste parole il
viceministro Roberto Castelli ha sintetizzato il film andato in scena ieri in
parlamento. "Ora si capisce perché i capigruppo Pd si sono lamentati del voto
segreto: temevano giustamente che in tanti disobbedissero agli ordini - fa eco
il Pdl Lucio Malan - sempre che non fosse tutta una sceneggiata finalizzata a
salvare l’ex assessore alla Sanità". D'altra parte, a questo punto, è solo il
leader Idv Antonio Di Pietro a chiedere a Tedesco di dimostrare un po' di
coerenza e dimettersi. Il Pd tace.
Uno scandalo da “Il Corriere della Sera” e “Libero” e “Il
Giornale” :«Soldi anche al partito di Penati».
L'imprenditore Di Caterina accusa il dirigente Pd: «Spremuto come
un limone».
Non c'è soltanto il costruttore, consigliere comunale ed ex candidato sindaco
del centrodestra Giuseppe Pasini ad accusare il big del Pd lombardo
Filippo Penati di avergli chiesto 20 miliardi di lire nel 2000-2001 per il via
libera ai progetti urbanistici di Pasini sull'area ex Falck, e di essere poi
stato destinatario di più di cinque miliardi tramite due intermediari che sono
stati pagati in Lussemburgo (Piero Di Caterina) e in Svizzera (Giordano
Vimercati): a parlare con i pm, infatti, è proprio anche Di Caterina,
imprenditore del trasporto pubblico con la sua «Caronte».
Pasini raccontava che Di Caterina era stato il collettore indicatogli da Penati
per le erogazioni pretese (a suo dire) dall'allora sindaco ds di Sesto San
Giovanni, autosospesosi da vicepresidente del Consiglio regionale lombardo dopo
essere stato indagato dai pm monzesi Walter Mapelli e Franca Macchia per le
ipotesi di concussione, corruzione e finanziamento illecito ai partiti. E
affermava di aver dato in contanti a Di Caterina due miliardi di vecchie lire in
Lussemburgo. E Di Caterina? Conferma che è vero. Nei mesi scorsi ha reso anche
lui molti interrogatori, inquadrando questa ricezione di soldi in una sorta di
compensazione tra favori alla politica e recriminazioni imprenditoriali, ai
quali ricollega tutta una serie di finanziamenti che afferma di aver fatto nella
seconda metà degli anni 90 e fino al 2000 per le esigenze del partito di Penati,
in alcuni periodi anche cento milioni di lire al mese. Come quelli di Pasini,
anche i suoi verbali sono «segretati» ed è dunque arduo definirne i contenuti
esatti. Ma il senso lo si afferra anche solo dalla scarna risposta di Di
Caterina a chi lo ha interpellato: «Sono stato spremuto come un limone. Non se
ne poteva più di questo convivere gomito a gomito con i dinieghi immotivati, con
i ritardi, con gli ostacoli della politica e della dirigenza dell'alta
amministrazione. Adesso ho grande fiducia nei magistrati».
Che davvero Pasini abbia pagato Di Caterina, ai suoi occhi fiduciario di Penati,
è del resto provato da un documento acquisito dalla rogatoria in Lussemburgo
(facilitata da Pasini) presso la banca alla quale bonificò a se stesso 4
miliardi di lire nel 2001. Parte di essi rimbalzarono in Svizzera e, a detta di
Pasini, furono poi consegnati in contanti in strada a Chiasso a Giordano
Vimercati, in seguito capo di gabinetto del Penati presidente della Provincia di
Milano e anche rappresentante designato dalla Provincia in molte società
partecipate (come la Serravalle). L'altra parte della provvista di denaro,
invece, ebbe la destinazione dettata appunto dall'istruzione data da Pasini alla
banca il 16 marzo 2001 e ora in mano agli inquirenti: «A debito del conto
Pinocchio, vogliate mettere a disposizione per contanti L. 2.500.000 a favore di
Di Caterina Piero. Alla sua presenza, attendere mia conferma telefonica».
Il monte-tangenti svelato da Pasini, intanto, sale ancora e si attesta sugli 8
miliardi di lire. Ai 4 o 4,5 miliardi per l'area ex Falck consegnati in
Lussemburgo e Svizzera, e ai 1.250 milioni di lire per l'area ex Ercole Marelli
(anch'essa di Pasini) «mascherati» dietro il saldo negativo di una permuta tra
terreni con Di Caterina, il costruttore aggiunge un'altra tangente che colloca
prima, nel 2000, addirittura al momento di comprare dai Falck l'area dove
sorgevano le acciaierie. A suo dire, gli sarebbe stato fatto capire che
l'acquisto dell'area gli sarebbe stato consentito o comunque facilitato dalla
politica se avesse ingaggiato come consulenti due professionisti asseritamente
vicini alle coop rosse emiliane, indicati in Francesco Agnello e Giampaolo
Salami, ai quali Pasini paga compensi per 2 miliardi e 400 milioni di lire e che
ora sono anch'essi indagati per l'ipotesi di concussione.
Filippo
Penati continua a mostrarsi tranquillo. Indagato dalla Procura di Monza per
concussione e corruzione e finanziamento illecito dei partiti, ribadisce la sua
"totale estraneità ai fatti». E "per rispetto dell’istituzione" si autosospende
da vicepresidente del Consiglio regionale lombardo, ribadendo "fiducia nella
magistratura". Nega, Penati, la versione dell'imprenditore 82enne Giuseppe
Pasini. Colui che ha innescato la slavina denunciando il malaffare che, a suo
dire, caratterizzava i rapporti politico-affaristici a Sesto San Giovanni,
importante centro della periferia milanese di cui l’esponente del Pd è stato
sindaco per due mandati, fino al marzo 2002 - allora, naturalmente, era Ds.
Peraltro, gli avvisi di garanzia - una quindicina - hanno coinvolto un assessore
e svariati funzionari comunali. E proprio al 2001 risalgono tre dei numerosi
episodi denunciati da Pasini, con tangenti per cinque miliardi e 750 milioni di
lire. Soldi che, attraverso intermediari o operazioni coperte, sarebbero stati
poi da recapitare proprio a Penati. In un caso, due miliardi e mezzo consegnati
in contanti da una banca lussemburghese, istruita da Pasini, a Piero Di
Caterina, titolare di un’azienda di trasporti e a quel tempo considerato molto
vicino all’allora sindaco di Sesto. E poi la classica valigetta piena di soldi,
allungata da Pasini e dal figlio Luca a Giordano Vimercati, strettissimo
collaboratore dello stesso Penati, durante una trasferta a Chiasso - per strada,
come nei film. Infine, una sorta di mazzetta mascherata: Pasini che scambia un
suo terreno di valore con un altro di Di Caterina, però molto meno fruttuoso,
con un saldo negativo per il primo di un miliardo e 250 milioni di lire.
Vimercati e Di Caterina sono anch'essi indagati nell’inchiesta. Ma l’elemento
importante è che Di Caterina avrebbe sostanzialmente confermato il racconto di
Pasini.
In ogni caso, questi episodi configurano più che altro il reato di concussione -
Pasini spinto a pagare per ottenere vantaggi nello sfruttamento urbanistico
della grande area dismessa in cui sorgeva l'acciaieria Falck, vantaggi che poi
non si sarebbero concretizzati, costringendo l’imprenditore a svendere l’enorme
lotto. Le altre due ipotesi d’accusa - corruzione e finanziamento illecito dei
partiti - si riferiscono invece a circostanze successive. Anche risalenti a
quando Penati era presidente della Provincia di Milano - dal 2004 al 2009.
In questo senso, gli inquirenti stanno indagando anche su vicende legate al
Sitam, il Sistema integrato trasporti area milanese, cui aderiscono la maggior
parte degli operatori delle linee di trasporto pubblico su gomma della provincia
milanese e che in sostanza ne gestisce le tariffe - biglietti, abbonamenti e
quant'altro. Peraltro, proprio all'interno del Sitam ha lavorato per anni la
società di Di Caterina, Caronte srl. Cui poi, a seguito di accordi istituzionali
con l'Atm - azienda municipale del trasporto milanese -, è stato tolto
l'appalto. Con conseguenti polemiche scatenate dallo stesso Di Caterina, che tra
l'altro reclamava un pagamento inevaso da parte di Atm di 8 milioni e mezzo di
euro. L'imprenditore, un anno fa, aveva così indirizzato una lettera alle
autorità locali - sindaci e questore e Carabinieri e Guardia di Finanza e anche
Provincia. Con un passaggio che, letto alla luce degli episodi a lui stesso
contestati, quasi suona come una minacciosa allusione: "Si è creata una
situazione che impone di muoversi in una palude di relazioni di concussione
indiretta, che si alterna, ovviamente, a momenti di aria di relazioni
corruttive, che rendono il clima asfissiante in un brodo di complicità". Nello
scritto veniva esplicitamente citato anche l'attuale sindaco di Sesto San
Giovanni, Giorgio Oldrini.
Anche un altro grosso imprenditore di Sesto ha segnalato episodi da
approfondire. Così come i magistrati stanno investigando su questioni
indirettamente legate alla vicenda Serravalle, l'autostrada Milano-Genova di cui
la Provincia di Milano deteneva la maggioranza insieme con il Comune, e
nonostante questo acquistò nel 2005 un altro 15 per cento di quote
dall’imprenditore Gavio, per di più a cifre superiori al prezzo di mercato. Con
un'operazione censurata dalla Corte dei Conti perché "onerosa e priva di
qualsiasi utilità".
Per farla franca il vice presidente della Regione Lombardia Filippo Penati (Pd)
coinvolto in un’indagine per mazzette, inventa «l’autosospensione». Una «cosa
che nemmeno esiste», spiega un tecnico. «Sensibilità istituzionale», applaudono
ovviamente quelli della sinistra. Ma sempre con molta attenzione al portafoglio.
Questione di termini e di sostanza, perché c’è una bella differenza tra
dimettersi e autosospendersi. Come sa bene Penati, l’illustre esponente lombardo
del Pd, ormai sempre più chiaramente il partito della calce e martello. Pronto a
fare un passo indietro, ma non certo a rinunciare a nemmeno un euro del suo
pingue stipendio da 15.500 euro al mese (il 5 per cento in più di un
parlamentare). Più benefit vari. Perché il beau geste di rinunciare alla
funzione di vice presidente del consiglio regionale della Lombardia, non
sfiorerà nemmeno il suo portafoglio. Con la beffa ulteriore che Penati non sarà
nemmeno tenuto a partecipare alle riunioni dell’ufficio di presidenza.
Limitandosi semplicemente a incassare stipendio e indennità di funzione per
11.500 euro. A cui ne vanno aggiunti 4.000 di diaria, più gettoni e rimborsi
spese. Oltre allo staff personale (tra cui un dirigente da lui stesso scelto),
segretaria, uffici e benefit. E i 51.600 euro all’anno che gli sono dovuti per
aver rinunciato (bontà sua) all’auto blu. In quanto membro di un ufficio di
presidenza di cui fa parte, ma a cui non partecipa più. In attesa di indennità
di fine mandato e assegno vitalizio che spetta anche a chi partecipi a una sola
legislatura. E che nel suo caso saranno maggiorati dai gradi di vice presidente.
Ormai solo virtuali.
E così assume tutto un altro sapore la lettera inviata al governatore Roberto
Formigoni e al presidente del Consiglio, il leghista Davide Boni. «A seguito del
mio coinvolgimento nella vicenda giudiziaria relativa all’area Falck di Sesto
San Giovanni - scrive Penati annunciando l’autosospensione - desidero ribadire
la mia totale estraneità ai fatti. In merito anche alle notizie apparse sulla
stampa voglio precisare che non ho mai chiesto e ricevuto denaro da
imprenditori». Da subito, aggiunge, «non parteciperò più all’ufficio di
presidenza e già dal prossimo consiglio siederò tra i banchi dei consiglieri di
minoranza». Prefigurando così la sua pensione dorata all’ombra del Pirellone.
Detto dell’indennità di Penati, resta quello appare sempre più come un
regolamento dei conti all’interno del Pd. Non solo lombardo, visto che Penati ha
ricoperto anche il prestigioso incarico di capo della segreteria di Pier Luigi
Bersani. Col neo assessore della giunta Pisapia Pierfrancesco Majorino che gli
manda via Facebook, ormai la nuova frontiera della sinistra, un messaggio al
veleno. «Io, se fossi in Filippo Penati, anche per essere più forte nei
confronti dell’opinione pubblica nel voler dimostrare la mia innocenza, mi
autosospenderei dal Partito democratico». E Penati che si autosospende mettendo
nei guai il Pd che ora resta senza un uomo di peso nell’ufficio di presidenza.
Guerra di correnti che si incrocia agli affari delle cooperative rosse. Mazzette
milionarie per la procura di Monza, circolate tra Sesto san Giovanni, l’ex
Stalingrado d’Italia amministrata per anni da sindaco, e Milano dove Penati
sbarcò tra i velluti della Provincia guidata con una certa passione per le
scatole societarie e i travasi azionari. «Penati è innocente fino a prova
contraria - attacca l’europarlamentare Matteo Salvini - Ma in Lombardia spesso
la “sinistra degli ex onesti” è molto amica di palazzinari e cementificatori».
...
Questione morale? «Non c’è una questione morale», s’indigna il segretario
regionale del Pd Maurizio Martina anche se tra gli indagati per il Pd c’è pure
l’assessore di Sesto Pasqualino Di Leva. Perché alla fine è sempre questione di
termini.
Duro botta e risposta tra Massimo D'Alema e il vicedirettore del Giornale,
Alessandro Sallusti, durante la trasmissione Ballarò. Lo scontro ha visto tra
l'altro D'Alema mandare il giornalista "a farsi fottere". Sallusti ha accusato
D'Alema di "moralismo" facendo poi un paragone con la cosiddetta "affittopoli"
dei primi anni '90, quando alcuni politici, tra cui lo stesso D'Alema, furono
criticati perché abitavano in affitto in case di enti previdenziali pagando
l'equo canone. Da allora nulla è cambiato. A Milano prima il Comune, poi il
Policlinico, poi il Pio Albergo Trivulzio. La battaglia di “Libero” per
portare alla luce l'Affittopoli milanese sta portando i suoi frutti. A
"cedere" sulla trasparenza ha iniziato Palazzo Marino, dopo 18 giorni di
campagna stampa. Sul sito web del Comune sono stati pubblicati indirizzi e
intestatari degli affitti a prezzo stracciato in immobili di pregio. Quindi ha
seguito l'esempio anche il Policlinico, con una lista-monstre online sul portale
della Fondazione Ca' Granda. Tutti i giornali hanno dato l’elenco degli
affittuari privilegiati degli immobili del Pio Albergo Trivulzio. Il caso
è stato trattato anche su “Repubblica” di Milano: "Case in centro a 200 euro al
mese, ecco la nuova affittopoli di Milano. Agiati professionisti tra gli
inquilini del Comune, del Policlinico e del Pio Albergo Trivulzio. I canoni fino
a quattro volte più bassi rispetto a quelli di mercato concessi ad amici e
parenti". Un prestigioso trilocale di 150 metri quadri in corso Monforte, centro
storico di Milano, si affitta tramite agenzia, quindi sul mercato dei privati, a
51mila euro l'anno: 4.250 euro al mese, spese incluse. A poche centinaia di
metri da lì, 132 metri quadri con affaccio sulla Galleria Vittorio Emanuele
costano all'inquilino che fa parte di un manipolo di "fortunati" poco meno di
mille euro al mese. E basta fare ancora pochi passi per arrivare in corso
Italia, dove 70 metri quadri costano 210 euro ogni mese. Anche se le condizioni
di stabile e appartamento non sono all'altezza dell'indirizzo, il risparmio - va
da sé - è notevole.
Comune di Milano, Policlinico, Pio Albergo Trivulzio: tre enti, migliaia di
proprietà immobiliari in città e in provincia, un patrimonio poderoso di 3.700
tra case, negozi e locali in uso ad associazioni che, nonostante le promesse
cicliche e i ciclici scandali, resta gestito, nella migliore delle ipotesi, con
una buona quota di negligenza. Così si disegna una Milano a due facce: quella,
maggioritaria, delle famiglie e dei single che devono riservare una grossa fetta
del loro reddito all'affitto, spesa imprescindibile, anche a scapito di altre
voci altrettanto necessarie. L'altra faccia è quella di una Milano del
privilegio, che spesso non ha niente a che fare con il bisogno. Perché, se non è
una colpa pagare un canone bassissimo rispetto a un mercato immobiliare tra i
più cari d'Italia, è una colpa - degli enti pubblici - aver permesso che per
decenni si stratificassero privilegi. Con il risultato che oggi tanti di quegli
indirizzi in pienissimo centro sono abitati da professionisti - medici,
architetti, giornalisti... - e da qualche amico e parente di. Non solo da quei
bisognosi per aiutare i quali erano nati in anni lontani questi serbatoi
immobiliari, ancor oggi rimpinguati da lasciti privati. I tre enti, sotto la
spinta di partiti d'opposizione e giornali, hanno iniziato a pubblicare sui siti
gli elenchi degli immobili. Ma è un'operazione trasparenza con qualche alone di
troppo: a volte mancano le date di fine locazione, quasi sempre i nomi degli
inquilini, o ancora ci sono generici raggruppamenti di immobili senza alcuna
specifica economica. Fa una premessa Mario Breglia, presidente di Scenari
immobiliari: "Alcuni palazzi sono malconci, gli enti non pagano le manutenzioni
e quindi tocca agli inquilini anche ristrutturare". Ma i confronti sono pesanti.
Il quadrilocale in via Dogana vista Duomo a 453 euro al mese, 5.400 euro
all'anno? Sul mercato varrebbe cinque volte tanto. I 73 metri quadri in via
Bagutta a 331 euro? Un'agenzia immobiliare chiederebbe almeno il triplo. "Il
problema, però, non è quello di far pagare di più gli inquilini - argomenta
Breglia -, quanto quello della mancanza di regole certe su chi ha diritto a
quelle case, e sulle modalità di ricambio degli affittuari. Se un anziano padre
ha la pensione minima non dovrebbe subentrargli allo stesso canone il figlio
professionista. Milano ha fame di alloggi a canoni bassi per fasce sociali che,
altrimenti, sono costrette a lasciare la città". In via Pellico, nel cortile
alle spalle di boutique e bar famosi, c'è ancora l'84enne vedova del portinaio
dello stabile. Ma nel palazzo successivo c'è anche il modello con pied-a-terre
di 80 metri quadri a meno di 500 euro al mese, 5.700 euro in un anno. E in via
Caminadella, viuzza chic in zona Cattolica, 177 metri quadri non arrivano a
2mila euro al mese, grazie ai contratti del Policlinico. Per comprendere come
sia nata la giungla dei prezzi e dei favori è necessario andare indietro nel
tempo fino alla fine degli anni Settanta quando Trivulzio, Policlinico e in
parte anche il Comune affittavano le proprie case a prezzi di equo canone con
bandi aperti che premiavano i bene informati. "I primi a sapere delle case in
affitto erano i primari e i dirigenti dell'ospedale, ma anche i politici -
racconta un anziano funzionario del Policlinico, oggi in pensione - lo dicevano
agli amici, che facevano richiesta". Nulla cambia fino al 1992, quando la legge
359 introduce i "patti in deroga": ogni ente può decidere se affittare gli
appartamenti che si liberano a prezzi di mercato oppure confermando l'equo
canone. Trivulzio e Policlinico scelgono la seconda ipotesi per la maggior parte
del patrimonio, il Comune valuta caso per caso. Palazzo Marino negli anni
Novanta diversifica i nuovi contratti al punto che nello stesso stabile c'è chi
paga l'equo canone, chi è "concessionario di spazi" e chi versa cifre vicine a
quelle di mercato. Vicine, ma mai troppo: in via della Guastalla, zona
Tribunale, 105 metri quadri costano all'inquilino 1.208 euro al mese. Per chi è
già dentro le case nulla cambia invece fino al 1998, quando la legge 431 prevede
che l'equo canone sia sostituito da tariffe concordate fra Comune, sindacati
inquilini e associazioni dei proprietari immobiliari. Da quindici anni almeno,
quando un appartamento si svuota viene messo in affitto al prezzo "libero"
definito dall'agenzia del Territorio, in media tre quarti del valore corrente.
"È sbagliato porre l'accento sui casi di privilegio - dice Marco Bistolfi,
segretario provinciale del Sicet - la sopravvivenza del sistema dei prezzi
concordati per il rinnovo dei contratti ha consentito a inquilini poveri di
evitare il dramma degli sfratti". E a molti "fortunati" di risparmiare migliaia
di euro all'anno.
Dal TGCOM: Affittopoli bis, arrivata lista vip. La busta con i 1064
inquilini di appartamenti di proprietà del Pio Albergo Tribuzio di Milano, ente
pubblico senza scopi di lucro, è stata consegnata al presidente della
Commissione Casa e Demanio, Barbara Ciabò (Fli). "Se verrà fuori che ci sono
politici - ha detto Ciabò - che hanno abusato del loro ruolo per pagare di meno
penso che il loro comportamento potrà essere definito moralmente indegno.
Vedremo se ci sono delle irregolarità". La lista degli inquilini del Pio
Albergo Trivulzio consegnata al Comune di Milano potrebbe non essere completa: è
il sospetto sollevato durante i lavori della commissione consiliare Casa. Ad
avanzare il dubbio è Barbara Ciabò. "Sembra che manchino 150 immobili - ha
attaccato la consigliera futurista - se questo sospetto trovasse fondamento
sarebbe gravissimo: un vero affronto al consiglio comunale di Milano". Ad
alimentare i sospetti è stato anche Vincenzo Giudice, esponente del Pdl e
dipendente del Pat: nell'elenco mancherebbero gli immobili di via Sottocorno e
di via Menotti. Una chiave del giallo potrebbe essere legata al fatto che in
questi anni i beni non presenti nell'elenco potrebbero essere stati venduti. Ed
è proprio sul piano delle dismissioni immobiliari che il Pd è pronto a dar
battaglia.
C'è Braida del Milan e un Montezemolo.
C'è anche il direttore generale del Milan, Ariedo Braida, tra gli inquilini
delle case di proprietà del Pio Albergo Trivulzio. Il suo nome figura infatti
nella lista. Il dirigente rossonero vive infatti in piazza del Carmine, nel
quartiere Brera, dove ha un contratto dal 1 aprile dello scorso anno: 17.300
euro il canone annuo, più 1.244 di spese per una casa di 84,59 metri quadrati.
Tra gli altri nomi spicca anche un Cordero di Montezemolo, il cui nome è però
stranamente soltanto puntato con una 'D'. Il soggetto dall'illustre cognome è
intestatario dal 29 giugno scorso di un ufficio in piazza Mirabello di 43 metri,
per cui paga un canone di 9.100 euro più 1.800 di spese.
Spunta la poliziotta del caso Ruby.
Si trova, spulciando l'elenco, anche il dirigente della Sezione criminalità
organizzata della Squadra mobile di Milano, impegnata nell'inchiesta sul caso
Ruby, Maria José Falcicchia. Il nome della Falcicchia è legato a un'abitazione
di 75 metri quadrati in via San Marco 20 angolo via Montebello 7, vicinissimo
alla Questura, per il quale è previsto un canone di 11.262 euro più 980 di
spese. Il contratto risale al 13 gennaio 2011. Tra gli altri nomi si nota anche
Martino Pillitteri, figlio dell'ex sindaco Paolo e cugino dell'attuale assessore
ai servizi civici del Comune.
A Carla Fracci un appartamento in via della Spiga.
Il nome di Carla Fracci, maestra della danza classica, compare
nella lista degli affittuari del Pio Albergo Trivulzio di Milano. La Fracci
abita in via dell Spiga 5, nel cuore del quadrilatero della moda, in un
appartamento di circa 187 metri quadrati per un affitto di 45.593 euro, più
6.148 euro di spese.
Pisapia: "Fango contro di me".
"C'è stato un vortice di telefonate anonime, nel puro stile della macchina del
fango. Il fatto è semplice: la mia compagna abita da molti anni, da prima che
noi ci conoscessimo, in un appartamento di proprietà di un ente pubblico. Lei
non è candidata a niente, è un privato cittadino, è semplicemente una donna che
lavora. Paga il regolare affitto che è previsto". Così sul suo blog personale,
Giuliano Pisapia, candidato del centrosinistra alla poltrona di sindaco di
Milano, spiega l'affaire 'affittopoli' che coinvolgerebbe la compagna e
giornalista Cinzia Sasso. Cinzia Sasso, storica penna proprio di
Repubblica Milano. L'ipotesi è che la Sasso abbia avuto in locazione dal
1989 una casa del Pio Albergo Trivulzio a prezzi scontati. "Non è un reato,
abitare in una casa di proprietà di un ente pubblico. Mentre certo è un problema
l'incapacità degli enti che dispongono di un patrimonio immobiliare di gestire
al meglio le proprie disponibilità - scrive Pisapia.
Sul punto si riporta la testimonianza di Filippo Facci, vero Giornalista e
memoria storica degli eventi italiani e milanesi in particolare. "Anzitutto c’è un conflitto d’interessi, perché sono amico
personale di Giuliano Pisapia. Tutto pensavo, inoltre, tranne che l’appartamento
in cui vive la simpatica collega Cinzia Sasso, compagna di Pisapia, potesse
interessare ancora a qualcuno, visto che me ne occupai la bellezza di 17 anni fa
e che ne scrissi addirittura in un paio libri: nel 1994 e nel 1997. Quello che
posso fare, ora, è rinfrescare la memoria circa un paio di episodi che nessuno
ricorda, forse neppure Cinzia Sasso. La giornalista ha scritto una lettera al
Corriere della Sera in cui diceva: «Sono la compagna di Giuliano Pisapia e abito
in un appartamento di proprietà del Pat... siccome ho visto che alcuni nomi - ma
non il mio - sono stati pubblicati, preferisco violare la mia privacy per
raccontarti i fatti miei. Vivo da 22 anni in quell’appartamento... Dal 2008 il
mio contratto è scaduto; nel frattempo ho trovato un’altra casa e ho mandato al
Pat una lettera di disdetta del contratto di affitto». Probabile che Cinzia
Sasso, mentre scriveva, fosse già stata contattata dal collega di Libero Edoardo
Cavadini, a cui aveva detto: «Ero appena arrivata a Milano da Venezia e non
avevo ancora conosciuto Giuliano, stavo con il mio ex marito. Con lui ho
affittato la casa, ma sinceramente non ricordo come siamo entrati in contatto
con il Pio Albergo Trivulzio, è passato troppo tempo». Ecco, su questo posso
soccorrerla. A pagina 149 del mio libro-intervista a Paolo Pillitteri «Io li
conoscevo bene» (roba del 1994) l’ex sindaco di Milano racconta questo: «Si
immagini una mattina di primavera, oltre il Castello Sforzesco, vicino alla
Triennale. Io me ne pedalavo in bicicletta per parchi e viali. Incontriamo una
giovane coppia con un neonato in braccio, mi fermano: saluti, complimenti,
soliti commentini e confidenze». Lei è Cinzia Sasso di Repubblica, lui è
Giovanni Cerruti de La Stampa. Continua Pillitteri: «Poi un attimo di serietà e,
come spesso mi capitava, una richiesta: il nucleo familiare ha bisogno di un
nido, una casa, “tu che puoi, tu che sei il sindaco, tu che ci sei amico”: un
classico. Il lunedì successivo cerco il presidente del Pio Albergo Trivulzio,
Mario Chiesa, e gli chiedo se sia possibile assecondare la famigliola. Io, data
l’urgenza, insisto. Ma non è che scossi troppo il pragmatico Chiesa, visto che
la settimana dopo si fece viva per una risposta la mammina giornalista. In
breve: risollecito Chiesa in modo pressante, quasi gli do un ordine: finché dopo
qualche giorno m’informa che il tetto è stato trovato. I due, informati,
ringraziano sentitamente, non tanto me ma un mio funzionario». Poi, però, arriva
Mani pulite. «Le confesso che non mi sarei mai aspettato», concludeva
Pillitteri, «di dover leggere nelle cronache dei loro giornali invettive feroci
contro i clientelismi socialisti, questi craxiani “che avevano dato le case ai
loro amici”. Sono rimasto senza parole». L’ex sindaco di Milano probabilmente si
riferiva anche a quanto avrei annotato in un secondo libro, «Di Pietro,
biografia non autorizzata» (1997): cioè che Cinzia Sasso, assieme a Giuseppe
Turani, non ebbe problemi a pubblicare «I saccheggiatori. Facevano i politici ma
erano dei ladri» (Sperling&Kupfer, 1992) e cioè un libro concentrato soprattutto
sul sistema messo in piedi da Mario Chiesa, presidente del pio Albergo
Trivulzio: un libro che fu scritto nell’appartamento che Mario Chiesa aveva
procurato. Ciascuno sopravvive come può. Se faccio spallucce, ora, è perché ai
tempi, quando scrissi il libro-intervista con Pillitteri, rivelai ben altri
affitti di favore: ma non successe assolutamente nulla. Tra questi un equo
canone ad Antonio Di Pietro (vicenda che sarebbe esplosa un paio d’anni dopo) e
un altro a Giulio Catelani, allora procuratore generale a Milano. Non accadde
nulla, perciò, neanche per il caso più trascurabile di Cinzia Sasso, tanto che
la giornalista restò nell'appartamento e rinnovò il contratto nel 1999, come lei
stessa ha raccontato. Non averlo disdetto con largo anticipo, rispetto alla
candidatura a sindaco del suo attuale compagno, Giuliano Pisapia, è l’ingenuo
errore che le si può addebitare."
Bossi è la Lega e la Lega è Bossi,
secondo Facco, nonostante la malattia abbia ridotto il senatùr all'ombra di quel
personaggio movimentista del passato recente. Per dimostrarlo, l'autore racconta
fatti, episodi, ricordi personali, con tanto di documentazione (sono quasi 400
le note bibliografiche). «Bossi», sostiene l'autore, «è il responsabile
principale della trasformazione della Lega in un soggetto politico
partitocratico, dove agli scandali si uniscono le truffe perpetrate ai danni, in
primis, dei militanti e simpatizzanti. I crac delle Cooperative Padane, del
Villaggio in Croazia e della banca padana rappresentano l'epitome del modo di
fare politica del "lumbard", circondato da sempre di yes-men (and women) in
carriera». Nel libro ci sono diversi fatti inediti, mai conosciuti e-o
raccontati: dalla
strana busta paga
del figlio primogenito a spese dei militanti ignari, fino alla famosa questione
della militanza comunista del giovane Umberto: da lui sempre negata, ma ora
provata da un
documento scoperto in una vecchia sezione del Pci. E poi si va
dai tempi in cui elogiava "Mani pulite" alla sequela di condanne penali
incassate dai leghisti odierni. Un capitolo, infine, è dedicato alla vita
privata di Bossi che «ama la famiglia tradizionale» ma, secondo l'inchiesta di
Facco, non sembra negarsi svaghi al di fuori di essa. «E' un'inchiesta che
dovevo a me stesso perché ho un passato da leghista, ho creduto in questo
movimento e sono stato anche sul Po, alla metà degli anni '90», dice l'autore.
«Era giusto scrivere questo libro adesso, in cui la Lega si sente
particolarmente forte e pensa di fare il pieno di voti.
Bisogna che tutti gli elettori
sappiano chi è il padrone del partito che pensano di votare: un cialtrone, né
più né meno».
Ma non è tutto. Due pentiti
scrivono la storia di Carrocciopoli, così come ripreso da Alessandro Da Rod sul
Riformista.
Due libri coinvolgono i due alti
esponenti del partito. Il già titolare della Semplificazione è accusato di furto
ai danni della Lega emiliana nel periodo caldo delle cooperative padane. Il già
Ministro della Giustizia e viceministro delle Infrastrutture invece sarebbe il
candidato “Gamma” favorito dalla malavita calabrese.
Due pentiti. Due libri. Un camion di
letame sulla Lega Nord di Umberto Bossi. Non c’è dubbio che giovedì 2 dicembre
del 2010 non passerà alla storia del Carroccio come una giornata qualunque.
Perché presentare nello stesso giorno due libri come Umberto Magno, l’imperatore
della Padania di Leonardo Facco e Metastasi di Gianluigi Nuzzi e Claudio
Antonelli, significa scoperchiare l’intero vaso di Pandora di via Bellerio,
svelando ciò che il Carroccio ha sempre cercato di nascondere: problemi interni,
finanziamenti ai figli di Umberto Bossi, intercettazioni scomode e quant’altro.
Il primo è il più pesante. Facco, leghista della prima ora, ex giornalista della
Padania, ha riportato in 480 pagine tutta la vita del Senatùr, raccontandone
misfatti, debolezze sessuali e di potere. Nel secondo i due cronisti di Libero,
non hanno incentrato il loro libro sui rapporti tra la ’ndrangheta e la Lega
Nord, ma hanno comunque inserito in un capitolo una storia scomoda per i
leghisti. Quella di “Gamma”, leghista di Lecco che ha iniziato a fare carriera
nel suo feudo grazie anche all’aiuto dei voti della malavita organizzata. Ex
ministro della Giustizia, dirigente di una certa importanza, nessuno ha osato
dire il suo nome, ma l’unico che ha alzato la voce per replicare alle illazioni
è stato Roberto Castelli, viceministro alle Infrastrutture. Negli ambienti del
Carroccio, si vocifera che ci sia una cosa che accomuna i due libri in uscita in
questi giorni nelle librerie. Entrambi, in un modo o nell’altro, vanno a
colpire, oltre al Senatùr, i due esponenti che in questi mesi hanno perso più
posizioni di potere all’interno del partito. Da un lato Castelli, dall’altra
Roberto Calderoli, ministro per la Semplificazione. È utile ricordare che il
leghista lecchese fu l’unico questa estate a rilasciare un’intervista al
Giornale in cui raccontava pubblicamente dei problemi interni al partito. Come
allo stesso tempo accadde a Calderoli, finito sulla graticola per l’affare
Brancher, il ministro breve del Federalismo, anche lui comparso su svariati
quotidiani per difendersi dalle bordate che gli arrivavano dagli uffici di via
Bellerio.
Sarà un caso, ma in mesi così
difficili per la Lega Nord, tra cerchi magici, colonnelli, varesini e veneti,
nel libro di Facco ci si sarebbe potuto aspettare qualcosa di più sul potente
ministro dell’Interno Roberto Maroni. In realtà c’è ben poco, se non un richiamo
al caso Antonveneta, passando per spedizione in Serbia e la storia dei
finanziamenti alla sua portavoce Isabella Votino. Quisquilie se messe in
relazione ai file alla Wikileaks che riguardano Castelli e Calderoli. Perché se
il primo viene di fatto associato alla malavita organizzata dal pentito Giuseppe
Di Bella, sul secondo vengono persino pubblicati i documenti che
testimonierebbero un presunto furto ai danni della Lega emiliana nel periodo
caldo delle cooperative padane. Partiamo dal ministro per la Semplificazione. A
pagina 311 di Umberto Magno, Sacco racconta la storia delle “Coop made in
Padania Scrl” creatura bossiana organizzata per finanziare il partito, finita in
disgrazia quasi come Credieuronord. Presidente delle Coop in un primo momento
era proprio Calderoli. E attraverso le parole di Mario Morelli, ex consigliere
di amministrazione della catena di supermercati, Facco ripercorre tutti i
disastri dei calderoliani, tra dentifrici in esubero, immobili pagati uno
sproposito, flop economici e conti lasciati in sospeso. «Bossi, Calderoli e
altri padani - si legge nel libro - pensavano che un pizzico di coraggio, un
tantino d’inventiva, un po’ di voglia di fare mischiata all’improvvisazione
fossero elementi sufficienti per il successo». In realtà la vicenda, oltre ad
avere tratti grotteschi, tra cui quello di 24 milioni di buste di deodorante con
il sole della alpi rimaste invendute, finì molto male. Morelli, infatti, a cui
fu data la presidenza dopo l’addio di Calderoli nel 1999, si ritrovò di fronte
in poco tempo un debito di circa un miliardo di lire e un’azienda sull’orlo del
fallimento. «Una mattina - racconta Morelli - Calderoli mi convocò nel suo
ufficio chiedendomi di sostituirlo in quell’incarico. Motivò la sua richiesta
col fatto che questo incarico incideva negativamente sul rapporto politico che
aveva con Bossi». Del resto, quando Morelli parlò della situazione al Senatùr,
Bossi non la prese affatto bene. «Mi rispose con parole di fuoco - ricorda
Morelli - indirizzate contro il mio predecessore Calderoli: tuoni, fulmini e
saette». Non solo. Il caso scottante è che al fallimento delle Coop è conseguita
la protesta di chi quei soldi li aveva versati nelle tasche di Calderoli.
Emblematica la lettera di Genesio Ferrari, ex segretario della Lega emiliana che
chiede indietro i dieci milioni di lire versati anche grazie all’aiuto dei
militanti: «Il tutto si è risolto in una bolla di sapone». Quanto a Castelli, si
è già scritto molto. Ma il dato è comunque pesante, perché nel ’90 ci fu il boom
di voti per i leghisti. Il pentito Di Bella, vicino al boss della 'ndrangheta,
Coco Trovato, racconta a Nuzzi e Antonelli che la parola d’ordine tra le ’ndrine
di Lecco era votare “Lega”: Gamma era il loro uomo di riferimento.
TANGENTI E MASSONERIA.
Sono Pietro Palau Giovannetti, presidente del Movimento per la Giustizia Robin
Hood e della rete "Avvocati senza Frontiere", nonché direttore responsabile del
giornale on line www.lavocedirobinhood.it, Enti no profit che dirigo da oltre 25
anni, battendomi in prima persona per l'affermazione del principio di
uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e una giustizia pulita libera da
mafie, partiti, logge massoniche e corruzione. Mi permetto di richiedere la
solidarietà di tutti gli spiriti liberi e le persone oneste,
perché tra qualche giorno sarò tratto ingiustamente in
arresto, senza aver mai commesso alcun reato, se non
quello che non può certo considerarsi tale, di aver denunciato, sin dai tempi di
"mani pulite", la dilagante corruzione politico-giudiziaria e gli abusi nei
confronti dei soggetti più deboli che non hanno mezzi o stuoli di avvocati
prezzolati, in grado di condizionare le istituzioni, ostacolando il regolare
corso della Giustizia. Se nei prossimi giorni il P.G. di Brescia riterrà di
arrestarmi, sono pronto ad andare in carcere a testa alta, perché credo in una
Legge molto più grande di quella umana, controllata da logiche
perverse e dalle varie mafie che soffocano la legalità. Sono intimamente
convinto che in uno «Stato-mafia», come quello in cui viviamo
che imprigiona ingiustamente i deboli e lascia deliberatamente impuniti colletti
bianchi, criminali politici e mafiosi, "anche una prigione sia un luogo
adatto per un uomo giusto", come affermava Henry David Thoreau, grande
pensatore del Rinascimento americano, il quale nel saggio "Disobbedienza
civile", sosteneva tra l'altro che è ammissibile non rispettare le leggi quando
esse vanno contro la coscienza e i diritti dell'uomo, ispirando cosi i primi
movimenti di protesta e resistenza non violenta. A fronte del mio incessante
impegno civile e lotta alla "massomafia", ho subito oltre 750
procedimenti penali, di cui ben 114 solo in Cassazione, con le
accuse più disparate per pseudoreati di natura ideologica, scaturenti dalle mie
stesse denunce, ritenute assurdamente "corpi di reato", o dagli
articoli pubblicati sui siti web dell'Associazione. Procedimenti da cui sono
sempre stato per lo più assolto, per manifesta infondatezza delle notizie di
reato. Ma ciò nonostante, dal 1986, sono stato fatto continuamente oggetto di
rinvii a giudizio e addirittura di ripetute richieste di perizie psichiatriche,
come in uso nelle dittature dei Paesi dell'Est, costringendomi a difendermi,
senza sosta, in ogni sede, per gran parte della mia vita. Solo attraverso una
ferrea difesa e la mia fede nella vera Giustizia sono riuscito a contrastare
questa impressionante mole di attività persecutorie che non trovano precedenti
nella storia del diritto internazionale, anche tenuto conto dell'enorme
dispendio di risorse pubbliche impiegate per l'istruzione di svariate migliaia
di udienze e centinaia di procedimenti penali, privi di qualsiasi consistenza,
rilevanza e interesse sociale. Per l'abnormità delle procedure adottate il mio
caso richiama quello del pacifista nonviolento, Danilo Dolci,
che dagli anni '50, in Sicilia, dedicò la sua vita alla causa degli ultimi,
lottando per l'emancipazione dalla povertà e dall'ignoranza, venendo, come me,
ingiustamente arrestato e condannato per reati di opinione dalla magistratura di
regime dell'epoca, tutt'oggi, purtroppo, ancora, asservita agli interessi della
politica e della "massomafia", cioè di quel regime occulto
trasversale ai partiti che da oltre 150 anni governa il Paese. La sua condanna
venne infatti scandalosamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione,
seppure in sua difesa avessero testimoniato Premi Nobel ed intellettuali di fama
mondiale del calibro di Carlo Levi, Erich Fromm, Norberto Bobbio, Elio
Vittorini, Lucio Lombardo Radice, Padre David Turoldo, Don Zeno, etc., e
l'arringa fosse stata pronunciata da Piero Calamandrei, tra i padri fondatori
della nostra amata Costituzione. Oggi anch'io rischio il carcere, stante la
definitività di alcune inique condanne per oltre 5 anni di reclusione,
confermate dalla Cassazione per reati di pretesa "diffamazione, calunnia,
oltraggio, resistenza", nei confronti di magistrati, avvocati e altri
infedeli rappresentanti delle istituzioni, seppure, come riconosciuto dallo
stesso Tribunale di Sorveglianza - che qui cito testualmente - i cosiddetti "precedenti
penali" a me ascritti: "concernono sostanzialmente situazioni e
contesti legati ad iniziative sociali quali quelle patrocinate dal Movimento per
la Giustizia Robin Hood". Ma ciò nonostante mi vogliono mandare in
galera dopo avermi perseguitato per oltre un quarto di secolo, neanche
rappresentassi un pericolo pubblico! Le condanne inflittemi non
colpiscono infatti un pericoloso delinquente, bensì un Human Rights Defender
che, da oltre 25 anni, si adopera a tutela della legalità, denunciando
gli abusi del potere e l'impunità di cui godono gli affiliati ai vari comitati
d'affari e logge massoniche, che hanno occupato lo Stato, soffocando la
democrazia, attraverso il controllo capillare delle istituzioni, dell'economia,
dei media e della cultura, garantendosi in tal modo il «controllo
sociale» e una forma di governo parallelo, che Ernst Fraenkel denominò
"Doppio Stato". Cioè, la compresenza nell'assetto statuario di
"normatività" e "discrezionalità", dove a fianco di un sistema apparentemente
democratico, convive un ordine perverso, che applica, come ai tempi della
Germania nazista, la discrezionalità sistematica nell'applicazione e nel
rispetto delle leggi, allo scopo di intimidire, reprimere e sopprimere ogni
forma di dissenso, perpetuando proprio grazie a questa autoreferenziale
contraddizione di sistema, l'organizzazione del consenso e il dominio sui
governati, dove le istituzioni sono invase da politici, pubblici amministratori
e magistrati corrotti, in simbiosi con banchieri, massoni e mafiosi, mentre una
parte sana ma minoritaria e priva di mezzi dello Stato e della Società civile,
cerca di contrastarli, a rischio della propria stessa vita o di venire
delegittimati, come fu per Falcone, Borsellino, Cordova, De Magistris, Ingroia e
tanti altri fedeli servitori dello Stato. A riguardo, sin dagli anni
'80, ho infatti inascoltatamente segnalato, anche con grandi manifesti,
che la mafia aveva messo le mani sulla città, denunciando l'imperversante
speculazione edilizia e gli abusi ambientali nei quartieri metropolitani
milanesi, da parte dei vari comitati d'affari che, già da allora, all'ombra di
illecite protezioni, spadroneggiavano impunemente, controllando il territorio e
i gangli vitali delle istituzioni, attraverso quella che i P.M. di "mani pulite"
definirono come "corruzione ambientale", senza poi però
riuscire ad andare sino in fondo. Denunce, occorre ricordare, che hanno permesso
alla Procura di Milano di portare alla luce massicci episodi di corruzione nella
Guardia di Finanza e nella stessa magistratura, portando all'arresto, tra gli
altri, del Generale Giuseppe Cerciello, e dell'allora
insospettato Presidente del Tribunale di Milano, Diego Curtò,
entrambi da me denunciati, sin dal 1989, venendo io, però, dapprima, incriminato
per diffamazione e calunnia, nonché preso per "visionario", fino al loro arresto
e alla definitiva condanna degli stessi per fatti di corruzione (quest'ultimo,
come molti ricorderanno, in relazione alla megatangente Enimont
e al lodo Mondadori). Il Movimento per la Giustizia Robin Hood,
spezzando in parte l'azione ostruzionistica nei suoi confronti, ottenne poi il
riconoscimento quale Onlus nella sezione civile del Registro del Volontariato
della Regione Lombardia, con effetto retroattivo dal 1998, in forza di due
sentenze del T.A.R., di cui una per obblighi di fare. Nonostante l'alto
valore sociale di tali attività, come riconosciuto dallo stesso
Tribunale di Sorveglianza, lo scorso 15/1/13, i giudici bresciani che avevano
precedentemente sospeso il processo, rinviandolo a nuovo ruolo, in attesa
dell'esito dei giudizi pendenti in Cassazione per incidente di esecuzione e
avanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - che se accolti comportano la
revisione automatica del processo "non equo" -, hanno invece cambiato
indirizzo, riservandosi sulla revoca del mio affidamento ai Servizi Sociali,
cosa che implicherà nei prossimi giorni l'obbligo di arresto per scontare una
pena residua di 2 anni, 8 mesi, 17 giorni, dopo aver già
espiato anni 1, mesi 5 e giorni 7 di reclusione, oltre ad 1 anno di
Libertà controllata, neanche fossi un mafioso o un criminale,
per un totale di ben oltre 5 anni di carcerazione! Taluni media
falsamente garantisti quando si tratta di coprire i potenti, sicuramente
cercheranno di gettare altro fango, insinuando ogni sorta di dubbio e calunnia
nei miei confronti, a partire da il Giornale di Sallusti, che
ho già avuto modo di denunciare per il contenuto diffamatorio dell'articolo: "Il
nuovo eroe antipremier? E' in realtà un bancarottiere condannato per calunnia",
articolo apparso in data 14/5/11, in occasione del processo Mills e del
mio fermo illegale avanti al Tribunale di Milano, ad opera della Digos, che
molti forse ricorderanno, avendo destato anche presso la stampa estera, notevole
indignazione e scalpore per le modalità brutali e la manifesta ingiustizia.
Voglio quindi si sappia che, al di là delle calunnie della stampa di regime, non
ho mai subito alcuna definitiva condanna per reati societari come il padrone di
Sallusti e che l'unica vera ragione dell'accanimento di settori deviati della
magistratura nei miei confronti, risiede nel fatto che ho denunciato, per primo,
l'esistenza di poteri esterni allo Stato, ovvero di un «Regime occulto»,
in grado di condizionare l'intero arco parlamentare, media, forze dell'ordine e
organi giurisdizionali, sino alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, mettendo
in luce il ruolo di subalternità delle mafie agli apparati dell'alta
finanza e dello Stato e, quel che, sicuramente, più
disturba, alla Massoneria internazionale, secondo la stessa
prospettiva investigativa di Giovanni Falcone, che partendo dalle rivelazioni di
Tommaso Buscetta aveva capito, sin dal 1984, come la Massoneria rappresenti il «collante»
dei vari poteri criminali con la politica, le istituzioni e i servizi segreti.
Non credo perciò di meritare di andare in carcere per le mie denunce, come non
lo meritava neppure Sallusti, seppure coltivasse ragioni diametralmente opposte
alle mie, perché in un Paese veramente libero nessuno può venire incarcerato per
le proprie idee. Grazie di cuore per la Vs. attenzione e per il Vs. sostegno
nelle forme che più riterrete opportune.
Pietro Palau Giovanetti secondo
“Il Giornale”. E meno male che Sallusti sa cosa vuol dire essere perseguito per
reato di opinione. Le urla, «vergogna, vergogna», gli spintoni, la polizia che
arriva e trascina via il contestatore: il tutto sotto gli obiettivi delle
telecamere, che documentano in diretta l'ennesimo caso di repressione del
dissenso. La scena accade davanti al tribunale di Milano, blindato dale forze
dell'ordine per la nuova udienza a carico di Silvio Berlusconi. Protagonista
della protesta solitaria, racconteranno le cronache e le telecronache, un
avvocato: un professionista indignato per le malefatte del capo del governo, e
deciso a manifestare il suo sostegno a Ilda Boccassini e ai suoi colleghi.
Ma alle 15.36 di ieri pomeriggio un comunicato
dell'Ordine degli avvocati milanesi costringe a rivedere la faccenda: «A seguito
dei recenti fatti di cronaca divulgati in data 9 maggio 2011 in relazione allo
svolgimento del processo Mills, in occasione del quale si è riferito di un
contestatore, Pietro Palau Giovannetti, indicato dalla stampa come avvocato, si
comunica che tale Pietro Palau Giovannetti non risulta iscritto negli elenchi
professionali tenuti dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano».
E quindi? Se non è un avvocato, come hanno
scritto i giornali, chi è il signore alto e robusto che i carabinieri hanno
trascinato via mentre urlava «vergognatevi buffoni» ai militanti del Pdl in
attesa di Berlusconi sotto il tribunale? L'aspirante icona della sinistra (emulo
di Pietro Ricca, che nel 2003 urlò «buffone» a Berlusconi in tribunale e su
questo costruì una carriera) è in realtà un personaggio di cui le cronache
giudiziarie si sono dovute occupare in più di un'occasione. Titolare di una
piccola azienda di auto d'epoca, la Classic Cars, Palau finisce gambe all'aria
all'inizio degli anni Novanta e viene inquisito per bancarotta fraudolenta. A
quel punto si trasforma in un implacabile accusatore della magistratura che - a
suo dire - lo avrebbe ingiustamente inquisito. Attraverso l'associazione «Robin
Hood» di cui è presidente, segretario e unico militante lancia la sua crociata
contro le malefatte dei giudici. Se la prende in particolare con il procuratore
Francesco Saverio Borrelli, che accusa di malefatte di ogni genere: querelato
dal capo di Mani Pulite, Palau viene condannato per calunnia. Ma non si arrende,
anzi. E qui la faccenda si fa
interessante. Il nome di Palau Giovannetti viene infatti citato in una
intervista al Corriere, nel maggio 1997, dal pm Piercamillo Davigo. Si parla del
misterioso «dossier Achille», un documento attribuito al Sisde in cui si
ipotizzavano tra l'altro infiltrazioni ebraiche e massoniche nel pool Mani
Pulite. Ed ecco cosa dice Davigo: «Per carità, io posso fare solo un'ipotesi.
L'unica cosa che mi viene in mente è la valanga di denunce presentate da Pietro
Palau Giovannetti... La conosce la sua storia? Quel signore abitava in uno
stabile di un immobiliarista milanese, Virginio Battanta. Ricevuto lo sfratto,
Palau lo ha denunciato. Poi, quando è finito sotto inchiesta per due fallimenti,
ha cominciato a presentare esposti a Brescia contro i pm di Milano che, a suo
dire, non avrebbero indagato. Di lì è nato un groviglio di inchieste a catena,
con decine o forse centinaia di denunce incrociate, penso che ora se ne occupi
Trento ma non escludo che prima o poi, passando da una Procura all'altra,
finisca tutto a Trieste. Ecco, ricordo che una delle tante denunce di Palau fu
indirizzata al procuratore Cordova (all'epoca procuratore di Palmi), che
all'epoca era titolare della maxi-inchiesta sulle logge coperte. Che io ricordi,
quella è l'unica denuncia che abbia mai ipotizzato infiltrazioni
giudaico-massoniche, espressione forse usata in senso generico, approssimativo,
tra i magistrati di questa Procura».
Sono passati quattordici anni. E
lunedì scorso il bancarottiere che allora accusava la Procura milanese di essere
un covo di massoni riemerge all'improvviso, trasformandosi in «avvocato» e
incarnando per mezza giornata la nuova icona del popolo filo-giudici.
FILIPPO FACCI: UN TESTIMONE DI MANI PULITE.
Tutti si definiscono giornalisti,
pochi lo sono veramente. Testimonianza “Per fatto personale”, scritta da Filippo
Facci. "Alla fine del mio «Di Pietro, la storia vera» c’è un fuori-capitolo che
racchiude alcune peripezie personali che ho sempre omesso di raccontare. Non
farlo neppure stavolta sarebbe stata reticenza."
Avevo ventiquattro anni e volevo fare il giornalista. Nel gennaio 1991 vantavo
già tre o quattro querele e fu allora che incontrai Antonio Di Pietro per la
prima volta. Avevo cominciato presto, e dal giornaletto in cui spadroneggiavo, a
Monza, approdai a delle collaborazioni con «l’Unità» e con «la Repubblica».
Tuttavia le querele giungevano scientificamente solo al giornaletto che mi dava
da vivere e che perciò dovetti lasciare.
Di Pietro lo conobbi appunto per una querela: era in toga e me l’indicarono; gli
rivolsi un saluto formale che lui non ricambiò. Non gl’importava nulla di quella
causa, lo si capiva. Sembrava mestamente annoiato dalle sciocchezze e dalle
querele di me giornalistucolo, e quella sua burocratica indolenza non me la
sarei più schiodata dalla mente. La querela non ebbe seguito.
Finito il militare, i miei contatti con «l’Unità» e con «la Repubblica» erano
saltati. Mi ero sposato l’anno prima, a ventitré anni, ed ero disoccupato:
l’unico contatto che riuscii a procurarmi fu con la redazione milanese
dell’«Avanti!», dove per un paio d’anni avrei lavorato da abusivo. A me
importava solo di fare il giornalista.
Mi diedi da fare. Di Pietro lo rividi nel dicembre 1991 quando mi mandarono a
intervistarlo con la testuale premessa che era «amico nostro». L’incontrai di
nuovo seguendo Mani pulite: l’«Avanti!» era ritenuto il giornale dei ladri e lo
chiamavano «la gazzetta degli avvocati», e tra una diffidenza e l’altra i nervi
di una mia collega avevano cominciato a cedere; avevano mandato avanti me perché
secondo il mio caporedattore ero un «cane sciolto».
Ma un cronista dell’«Avanti!», al tempo, aveva poche alternative tra l’essere
considerato un cane sciolto o l’essere considerato un cane. Ricordo quando
entrai nella sala stampa del palazzo di giustizia e tutti uscirono, come capitò
anche a un cronista del «Secolo d’Italia». Ricordo quando davanti a una clinica
privata, dove un famoso finanziere era agli arresti ospedalieri, il gruppetto
dei cronisti cambiava marciapiede a seconda della mia posizione. Quando mi
capitò di pubblicare dei verbali d’interrogatorio che guastarono i piani di chi
scriveva in pool, poi, un collega mi disse a brutto muso che secondo lui i miei
verbali erano falsi. Un altro cronista mise in relazione la fuga notturna di un
dirigente socialista con una mia possibile spiata. Lo scrisse pure.
In tutto questo la situazione si era fatta ancora più complicata perché la sede
romana dell’«Avanti!» vedeva nella redazione milanese un avamposto craxiano –
ciò che era – e man mano che decresceva il potere di Craxi cresceva anche il
tentativo di isolarci e di toglierci peso. Io formalmente neppure esistevo: non
avrei potuto neanche stare in redazione; il direttore di allora, su cui non
esprimo un’opinione perché non ho l’immunità parlamentare, si chiamava Roberto
Villetti e ogni tanto telefonava da Roma per sincerarsi che io fossi rimasto a
casa o scrivessi comunque da fuori, quando invece in redazione praticamente ci
dormivo. A un certo punto, in un periodo in cui peraltro non arrivava più una
lira perché le tangenti erano finite – questo l’avrei appreso poi – Villetti
prese a togliermi anche la firma dagli articoli: ma neppure sempre, a giorni
alterni, quando capitava. Pensai di aggirare l’ostacolo ricorrendo alla doppia
firma col mio caporedattore milanese, Stefano Carluccio, un amico: ma a un certo
punto il direttore risolse togliendo solo la mia firma e lasciando quella di
Carluccio sotto articoli che però avevo scritto io.
Nell’insieme: lavoravo da abusivo per il giornale dei ladri, ero disprezzato dai
colleghi e da chiunque in quel periodo sapesse dove scrivevo, completamente
gratis, in teoria non potevo neppure entrare in redazione e sotto i miei
articoli c’era la firma di un altro. Però c’era la salute.
Continuai a seguire Di Pietro e Mani pulite anche quando l’atmosfera si fece
ancora più elettrica e quando due persone che conoscevo, inquisite, si
suicidarono. Scrivere sull’«Avanti!» certo mi forzava a guardare le cose da un
punto di vista speculare, ma probabilmente c’entrava anche il mio carattere e
un’età in cui avevo davvero poco da perdere. In ogni caso il clima che ribolliva
nel paese non mi piaceva. Mi venne naturale raccogliere del materiale su cui
lavorare: di giorno, quindi, seguivo la cronaca, e la sera ci ragionavo,
approfondivo, scrivevo, ne discutevo sino a tarda notte.
Continuai a occuparmi di Di Pietro anche quando l’«Avanti!» chiuse i battenti e
rimasi a spasso. Era la fine del 1992. Fu un brutto colpo, soprattutto perché
ormai ero catturato dagli avvenimenti. La redazione era chiusa ma spesso ci
dormivo dentro perché a casa c’era qualche problema. Presi a indagare, feci
domande in giro, raccolsi ritagli di giornale. Un paese intero invocava manette
e io intanto fingevo di fare il giornalista come di consueto: assumevo
informazioni, le ordinavo, le assemblavo, ne parlavo: solo che, il giorno dopo,
non usciva nessun mio articolo. Mi limitavo a ingrassare e limare un mio libro
impossibile, una sorta di rivisitazione della carriera di Di Pietro e della sua
inchiesta devastante. Non avevo nient’altro da fare, né di nient’altro
m’importava.
Era il periodo dei governi che non riuscivano a governare, l’anno delle bombe a
Milano e a Roma, delle speculazioni internazionali: l’atmosfera da torbido
complotto era illuminata solo dalla mirabolante traiettoria di Antonio Di
Pietro. Un sondaggio, tra «abbastanza», «molta» e «moltissima», gli attribuiva
il 90 per cento della fiducia degli italiani. Neppure certi suicidi eccellenti
avevano scosso l’opinione pubblica: il 60 per cento degli italiani riteneva che
l’uso della carcerazione preventiva andasse bene così. Neppure quel clima da
carboneria e la mia vocazione di bastiancontrario mi divertivano più: ero pur
sempre un ragazzo di ventisei anni che voleva fare il giornalista. Cercai di
defilarmi.
Scrivevo. Il libro era ormai denso e particolareggiato sino alla paranoia, quasi
quattrocento pagine che ingenuamente e nelle maniere più improbabili tentai di
proporre a qualche casa editrice. Non interessò a nessuno perché ero un perfetto
sconosciuto, ma nondimeno perché era il periodo che era. Sulla copertina di «tv
Sorrisi e Canzoni » l’icona del magistrato più amato dagli italiani troneggiava
su un titolo cubitale: Di Pietro facci sognare.
Conobbi Bettino Craxi semplicemente telefonandogli: fu poco prima che quasi lo
linciassero all’Hotel Raphaël, all’inizio del 1993. Non dirò nulla di lui.
Conobbi altre persone tra le più care, in quel periodo: uomini e ragazzi che
difendevano storie che non erano le loro, e che dicevano follie che un giorno
sarebbero state ovvie. L’effervescenza di Mani pulite mi disvelò codardie
raggelanti e dignità insospettabili.
Il mondo delle persone normali, a poco a poco, mi perse. Sfumarono amicizie e
affetti, il matrimonio era ormai consunto, mio padre intanto leggeva il
forcaiolo «Indipendente» di Vittorio Feltri. Poi, un giorno di aprile, mi
telefonò un personaggio di una fantomatica casa editrice straniera, uno che
diceva di aver saputo del mio dattiloscritto da qualche collega di Palazzo
Marino, la sede del Comune di Milano. Si disse interessato. Ci vedemmo due volte
in un bar del centro e nel secondo incontro mi mostrò anche un libro pubblicato
da questa casa editrice straniera, la Marshall di Dublino. Nel trattenere una
copia del mio lavoro mi disse che uno scritto come il mio in Italia non sarebbe
mai stato pubblicato, e con mio sbigottimento mi diede una busta che – verificai
poi – conteneva 4 milioni in contanti. Gli lasciai anche due mie foto. Una, lo
feci per scherzare, mi ritraeva che avevo circa un anno.
A metà luglio il settimanale «Il Sabato» pubblicò un dossier che conteneva tutta
una serie di notizie imbarazzanti per Antonio Di Pietro. Erano cose che perlopiù
conoscevo e che nel mio libro fantasma avevo sviluppato in parte meglio e in
parte peggio. Furono sbrigativamente bollate come «calunnie» come capitava a
ogni minimo rilievo mosso contro Di Pietro, ma fu un altro fatto a colpirmi. Mi
suonavano stranamente familiari, di quel dossier, almeno un paio di passaggi.
Ebbi l’impressione che l’estensore avesse quantomeno consultato il mio libro
fantasma, ma fu solo un primo campanello d’allarme. Presto un altro episodio
l’avrebbe terribilmente superato.
Il mio ex caporedattore, Stefano Carluccio, mi convinse a fare causa
all’«Avanti!» così da ottenere almeno il praticantato d’ufficio, un
riconoscimento legale che mi avrebbe permesso di fare l’esame da giornalista
professionista. All’Ordine della Lombardia c’era Franco Abruzzo, ritenuto vicino
a quel che rimaneva del Psi. La mia causa fu accolta. A Roma feci l’esame
scritto e scelsi un tema sul cosiddetto «nuovismo» maturato dopo Mani pulite,
anche se l’enfasi della titolazione avrebbe potuto indurmi a migliori consigli.
Fui soddisfatto del mio lavoro, ma tempo dopo appresi che mi avevano bocciato.
Diedi di nuovo l’esame scritto e scelsi l’analisi di un decreto legge sulla
giustizia, il Decreto Gargani. Presi il voto più alto di tutta la sessione.
Preparai l’orale e intanto non combinavo granché.
Nel dicembre 1992 avevo conosciuto l’ex sindaco di Milano Paolo Pillitteri, ex
amicone di Antonio Di Pietro, e mi aveva già confidato qualche notevole aneddoto
su Tonino, Ninì come lo chiamava lui. Passavo a trovarlo nella ridicola speranza
che potesse aiutarmi a trovare lavoro e mi dava udienza anche perché era avvolto
da una solitudine impressionante. Un giorno mi mostrò un faldone pieno di
appunti infarciti di correzioni illeggibili, voleva una valutazione. La forma
faceva abbastanza schifo e glielo dissi, ma gli proposi di fare un libro
intervista purché corredato di domande e risposte vere. Pillitteri aveva
lottizzato e piazzato giornalisti ai più alti livelli, ora aveva me. Ci mise un
po’ ad accettare. A lavoro finito, l’ex sindaco mi favorì due appuntamenti con
due editori, ma andò male. Nel febbraio 1994 tentai di mia iniziativa con la
romana Newton Compton e sorpresa: accettarono. Mi posero dei tempi di consegna
strettissimi così da uscire entro le elezioni del 27 marzo. Ero sbalordito.
L’esame orale da giornalista fu sempre in febbraio. Si doveva discutere una
tesina scelta dal candidato e rispondere a un po’ di domande. I commissari
sbirciarono il voto dello scritto e si compiacquero. Ma poi, di fronte a una
commissione composta da magistrati e giornalisti, cominciai a discutere la
tesina «Commistioni tra magistrati e giornalisti nell’inchiesta Mani pulite»
perché ero fatto così. Anche un po’ scemo, a riguardarmi oggi, ma ero uno che
non mollava mai. Gli altri aspiranti professionisti sgranarono gli occhi di
fronte all’harakiri e l’esame non fu piacevole, durò almeno il doppio del
consueto e anche la camera di consiglio si protrasse per un’ora secca. Fui
promosso col minimo dei voti, grazie, appresi, a un commissario che poi venne a
cercarmi.
Ero finalmente un disoccupato professionista e pensai che l’importante fosse non
fermarsi. Cominciai a girare da un avvocato all’altro per raccogliere varie
storie di malagiustizia, mia vecchia passione di quando sedicenne militavo nei
Radicali. Cercai di condensare queste storie in un altro volume in cerca di
fortuna. Ogni tanto ripensavo all’improbabilità di quell’editore straniero,
tutte le stranezze, i contanti senza ricevuta, neppure un numero telefonico o un
indirizzo dove rintracciarlo. Era sparito e pensai che potesse essere normale in
un periodo in cui nulla lo era.
Un vecchio amico di mio padre lavorava alla neonata «Voce» di Montanelli, e
provai lì. Erano in overbooking, ma il tizio mi procurò un appuntamento con
Maurizio Belpietro, vicedirettore del «Giornale ». Quest’ultimo mi accompagnò
dal capo della cronaca di Milano, Daniele Vimercati, e gli propose di mettermi
alla prova. Ma non mi chiamò mai. Era un ottimo giornalista, era vicino alle
posizioni di Bossi e io ero uno che aveva lavorato all’«Avanti!» da abusivo.
Un mattino mi segnalarono uno dei tanti anonimi su Mani pulite che circolavano
per le redazioni. C’era una copertina grigia col titolo Gli omissis di Mani
pulite e risultava edito da una certa «Marshall Ltd-Irlanda», firmato da
Anonimo giornalista. Centonovantadue pagine fitte. Era il mio libro, Anonimo
giornalista ero io. Sulla retrocopertina, piccolina, c’era anche la mia foto di
quando avevo un anno.
Rimasi di sale. Da una parte la rabbia per quell’incredibile lavoro perduto
nell’oceano degli anonimi, dall’altra un timore irrazionale di venire scoperto
per aver fatto qualcosa che in realtà non volevo neppure nascondere. Fu
difficile non parlarne con nessuno per mesi, per anni. Tanto più quando il
settimanale «Panorama», poco tempo dopo, in un trafiletto, fece cenno al volume
e titolò Veleni contro Mani pulite. Mi raccontarono che alcuni colleghi
della giudiziaria si divertirono con la caccia all’autore e seppi che non
sospettarono di me perché non mi ritenevano all’altezza.
Il libro intervista con Pillitteri, Io li conoscevo bene, uscì a marzo
inoltrato. «Panorama» ci dedicò un’intera pagina e altri articoli uscirono sulla
«Stampa» e sul «Messaggero». Spesso neppure mi nominavano, ma fui contento anche
se dell’argomento principe del libro, Antonio Di Pietro e certi suoi legami
imbarazzanti, preferirono non parlare.
Già lavoravo ad altro: la raccolta delle storie di malagiustizia mi
appassionava. In luglio, nei giorni del disgraziato Decreto Biondi, il mio amico
Luca Josi mi propose di presentarle sotto forma di libro in via di
pubblicazione, anche se propriamente non c’era il libro e non c’era l’editore;
diceva che si poteva contrapporlo a quanti, a fronte delle lagnanze garantiste,
invocavano ogni volta esempi e casi concreti.
Nella saletta di un hotel romano, non certo grazie a me, intervennero Vittorio
Sgarbi, l’avvocato Nicolò Amato e il professor Paolo Ungari. Uscì un trafiletto
sul «Giornale» e uno sul «Corriere della Sera». Fu un risultato, dati i tempi.
Qualche giorno dopo si fece vivo tal Roberto Maggi, già editore di Sgarbi con la
sua Larus di Bergamo. Aveva letto il trafiletto sul «Corriere ». Disse che il
libro gli interessava molto ma tutto venne rimandato a settembre. Gli credetti.
Passai l’intero agosto a lavorarci sopra.
In settembre, dopo ripetuti rinvii, Maggi si rese irreperibile e compresi poi
perché: stava per pubblicare La Costituzione italiana: diritti e doveri
commentata da Antonio Di Pietro con prefazione di Francesco Cossiga. Presto
avrebbe editato anche due testi di educazione civica sempre firmati dall’ex
magistrato. Roberto Maggi cercò di convincermi che aveva grandi progetti e che
non avrebbe avuto problemi a pubblicare anche me, perché era un liberale, e la
cosa incredibile è che io credetti anche a questo. Continuai a lavorarci. Non
ero cretino: ero di mente lineare, poco incline al barocchismo e al retroscena,
figlio di mezzi tedeschi, soprattutto crederci era gratis.
Il mio ultimo appuntamento alla Larus di Bergamo fu il 3 febbraio 1995. Attesi
due ore in una saletta e poi eccomi nell’ufficio di Maggi, dove appesa al muro
c’era una gigantografia di Antonio Di Pietro firmata da Bob Krieger. Mi spiegò
che non poteva permettersi di pubblicare il mio lavoro perché l’aveva mostrato
all’ex magistrato. In sostanza aveva cercato di farsi bello con lui bloccando il
mio libretto. Questo disse, almeno. Rimasi malissimo.
I primi di giugno 1995 ero a Monza a giocare a pallacanestro. Non possedevo un
telefono cellulare e sul bordo del campetto d’un tratto comparve mio padre: mi
disse che mi stavano cercando urgentemente dal «Giornale», quotidiano che
intanto lui era passato a leggere. Finii la partita e solo molto più tardi, da
una cabina del telefono, appresi che Di Pietro era stato inquisito a Brescia, e
mi proposero di scrivere un articolo tipo «io l’avevo detto» sulla base di
quanto avevo già scritto nel libro-intervista a Pillitteri. Dovetti precipitarmi
al «Giornale» con la canottiera ancora madida di sudore e ricordo l’orrore negli
occhi di Vittorio Feltri che allora se la tirava con l’eleganza
british-campagnola. Scrissi un affresco sul reticolo di amicizie discutibili
dell’eroe nazionale. Il giorno dopo, più di un quotidiano fu costretto a
inseguirmi. «L’Unità», circa il libro intervista con Pillitteri, scrisse di
«veleni», e «la Repubblica» che «il pamphlet rischia di diventare un best seller
che pare già depositato agli atti dell’inchiesta di Brescia». Il best seller mi
fruttò in tutto 1.081.623 lire. Cominciai a scrivere sul piccolo quotidiano
«L’Opinione» grazie a una raccomandazione di Pillitteri, ma stavano per
addensarsi nubi davvero nere.
Procure e redazioni, al tempo, erano invase da scritti anonimi contro la
magistratura milanese, e si prospettava l’ombra di un Mister X che fungesse da
suggeritore dei cosiddetti veleni indirizzati contro Di Pietro. Il clima da
spy-story era a mille. Il 3 luglio 1995 sul «Giornale» lessi questo titolo:
Mister X era già in un libro di due anni fa. Sottotitolo: Un memoriale
anonimo pubblicizzò tutti i veleni e gli omissis del gruppo di Mani pulite.
Testo: «Oggi andrebbe a ruba. Allora, nel maggio 1993, circolò per il tribunale
come i samizdat clandestini del dissenso russo. Gli omissis di Mani pulite,
un pamphlet di 192 pagine, raccontava già tutto. Gli anonimi e i Mister X che
sono venuti dopo avevano alle spalle quel superdossier».
Avevo la certezza che non sarebbe finita lì. Ebbi l’irrazionale sensazione che
qualcuno mi stesse cercando. Non mi trovò la Spectre, ma Stefano Zurlo del
«Giornale». Mi telefonò e mi chiese esplicitamente se Mister X fossi io. Negai.
Per giorni. A un mio generalizzato timore si accompagnava la consapevolezza che
la storia dell’inglese che scippa i libri dei giovani cronisti era incredibile,
nel senso di poco credibile.
Cedetti, ovviamente. La verità per la verità interessava relativamente, lo
sapevo bene: la scoperta di un ingenuo Mister X probabilmente avrebbe potuto
smentire chi prefigurava dei potenti burattinai di centrodestra dietro la
diffusione dei dossier anonimi. Decisi di correre il rischio. Al «Giornale»
incontrai Maurizio Belpietro per la quinta volta in una quinta veste diversa:
prima ero stato un imberbe che cercava lavoro, poi l’autore di un libro
intervista con Pillitteri, poi l’autore di un libro inesistente su casi di
malagiustizia, poi un giocatore di basket avvolto da un alone non propriamente
di mistero, ora un Mister X di ventotto anni che viveva al quartiere
Giambellino. Gli chiesi come avessero fatto ad arrivare a me e mi rispose che mi
aveva riconosciuto dalla foto di bambino stampata dietro il dossier.
«Il Giornale», il 24 luglio, aprì la prima pagina con uno spaventoso titolone:
Ecco l’autore del dossier Di Pietro. Sottotitolo: Filippo Facci, un
giovane cronista dell’«Avanti!», scrisse due anni fa un rapporto in cui
anticipava le accuse all’eroe di Mani pulite. Si insisteva ancora col
«samizdat clandestino del dissenso russo». Stavo per finire in un mare di guai.
La Procura di Brescia mi convocò e mi interrogò per sei ore: il samizdat russo
finì agli atti. Anche il libro intervista con Pillitteri era già finito agli
atti. Vi finì anche la faccenda del libro sui casi di malagiustizia fermato
dalla Larus. Mi chiesero del presunto editore inglese o irlandese e risposi che
mi si era presentato come «Olinco» o forse «Holinko», non avevo mai visto il suo
nome per iscritto. Gli inquirenti, com’era prevedibile, mi chiesero se avessi
mai ricevuto altri dossier anonimi e gli consegnai quelli che avevo. Vollero
sapere se li avessi utilizzati per scrivere il mio libro e li invitai a
verificare che in qualche caso li avevo addirittura smentiti. Il giorno dopo,
sul «Giornale»: Caso Di Pietro, cronista sotto torchio. Sottotitolo:
Sei ore e mezzo senza neanche una pausa caffè. Pochi giorni dopo trovai la
casa perquisita e devastata da chi cercava chissà che cosa. Non mancava nulla, a
parte qualche documento poco significante. Sporsi denuncia alla polizia e fui
interrogato di nuovo a Brescia.
Settembre coincise con propositi di rinnovata normalità: scrivevo sempre per
«L’Opinione», mi concentravo sul lato oscuro di Antonio Di Pietro e setacciavo
nuovi casi di malagiustizia. Ogni tanto, almeno una volta alla settimana,
sentivo Craxi al telefono. Mi chiamava lui. Gli piaceva che io venissi
praticamente dal nulla, per quanto poteva saperne.
Il 12 settembre 1995 sulla «Repubblica» uscì un articolone titolato Il
Mistero Holinko. Sottotitolo: Salamone indaga su un libro contro Mani
pulite. Un estratto: Chi è il signor Anthony
Holinko? E chi si nasconde dietro la Marshall Ltd, casa editrice fantasma con
sede forse a Dublino? La Digos bresciana sta indagando sul misterioso emissario
dell’ancor più misteriosa Marshall, la casa editrice che nel ’93 pubblicò il
libro Gli omissis di Mani pulite, un pamphlet che in Italia circolò
semiclandestino, spesso in fotocopie, e che anticipava alcuni dei temi recenti
delle accuse contro Di Pietro. Il pm Salamone sta cercando di capire se esistono
dei legami tra la casa editrice irlandese e un’altra entità oscura apparsa sullo
scenario recente di Mani pulite, l’agenzia investigativa americana, ma con
ufficio di corrispondenza a Parigi, che avrebbe svolto, per conto di chissà chi,
lunghe indagini sul passato dello scopritore di Tangentopoli.
Brescia. Dublino. L’America. Parigi. Il Giambellino. Un mattino mi contattò l’ex
mezzobusto del Tg2 Alda D’Eusanio, mai conosciuta prima. Disse che aveva letto
le mie disavventure e mi elencò dei colleghi che le avevano parlato bene di me,
tutti nomi però a me sconosciuti. La incontrai a Roma e mi spiegò che per il
programma «L’Italia in diretta», su Raidue, avrei potuto fare dei servizi su
casi di malagiustizia purché non trattassero di politici. Accettai e iniziai la
trafila per il contratto. Pensai che potessero c’entrare Pillitteri o Craxi.
Il 14 settembre ero ancora a Monza a giocare a pallacanestro. Trillò il
cellulare che mi ero finalmente procurato: era Craxi. Cercai di capire se
c’entrasse con la faccenda di Raidue: «La conduttrice mi ha parlato di come si
potrebbe trattare il tema del garantismo», gli dissi, omettendo nomi e cognomi
come era d’uso. Ma non riuscii a capire.
La conclusione della telefonata, testuale, fu la seguente:
Craxi:
A te ti controlleranno il telefono, devo supporre…
Facci:
Sì, forse, ma non è un problema…
Craxi
(scherzoso): Nessunissimo problema, neanch’io nessunissimo problema…
In realtà c’era problema. Aspettando la Rai, mi ributtai sull’«Opinione » e su
Di Pietro, tema che tirava molto. Furoreggiava l’inchiesta su Affittopoli e io
mi ero fissato di trovare i dati sull’appartamento a equo canone che il Fondo
pensioni Cariplo aveva concesso all’ex magistrato alla fine degli anni Ottanta.
Ne avevo già scritto nel mio libro fantasma e nel mio libro intervista a
Pillitteri, con tanto di indirizzo, ma la notizia non era mai deflagrata. Mi
procurai lo schedario del Fondo pensioni Cariplo e un funzionario mi diede tutte
le conferme del caso. Mi capitò di parlarne al telefono col mio amico Luca Josi.
Sinché un mattino, per coincidenze varie, capii che «il Giornale» avrebbe
probabilmente sparato la notizia l’indomani e mi prese il panico. Allertai il
direttore dell’«Opinione», Arturo Diaconale, e scrissi l’articolo in un
battibaleno. Nel tentativo di anticipare «il Giornale» telefonai a tutte le
agenzie di stampa perché preannunciassero quel che «L’Opinione» avrebbe
pubblicato, ma servì a poco. «Il Giornale» l’indomani sparò la notizia in prima
pagina e quasi nessuno si accorse che sull’«Opinione» ne avevo scritto anch’io.
Era il 22 settembre.
Il pandemonio fu il 29 settembre. Il pubblico ministero Paolo Ielo, al Tribunale
di Milano, denunciò «campagne giornalistiche coordinate da Hammamet» e citò
espressamente gli articoli che «il Giornale» aveva dedicato all’equo canone di
Di Pietro: disse che la diffusione della notizia era stata pilotata da Craxi a
Vittorio Feltri, e la riprova, aggiunse, ne era un’intercettazione telefonica
tra Craxi e Luca Josi, il mio amico. Feltri venne additato come un robot
craxiano e i telegiornali di mezzogiorno si scatenarono. Io ci misi poco a
capire com’era andata davvero: io avevo parlato a Josi dell’articolo che stavo
preparando per «L’Opinione» e lui probabilmente ne aveva fatto cenno a Craxi, ma
le varie telefonate erano state intercettate e i magistrati avevano capito che
si parlasse di un articolo per «il Giornale» anziché per «L’Opinione». Passai
una mezz’ora disperata: che fare? Esporsi di nuovo? Temevo per il mio contratto
con la Rai.
Mi esposi, chiaro. Telefonai al «Giornale» e feci pure fatica a farmi ascoltare.
Il giorno dopo, morale, ecco un’altra intervista dove spiegavo tutta la
dinamica. Vittorio Feltri titolò il suo editoriale Esigiamo pubbliche scuse
e però scrisse così: «Filippo Facci, e non un mio redattore, ha attinto
notizie da fonte socialista riguardo a Di Pietro … “L’Opinione” ha pubblicato la
notizia in questione proprio su segnalazione di Luca Josi. Facci, che è persona
onesta, ammette tutto ciò in un’intervista che riportiamo». Ma come? Era il
contrario della verità: io nell’intervista non dicevo niente del genere, non
avevo attinto a nessuna fonte socialista, avevo solo parlato a Josi di un
articolo che stavo preparando. Ma niente da fare, Feltri ripeté le stesse cose
al «Messaggero» e alla «Repubblica». In un’intervista al «Corriere della Sera»
giunse a dire: «Avevo ragione. Abbiamo rintracciato Filippo Facci il quale ci ha
confermato quel che sospettavamo». Cioè: adesso erano stati loro ad aver capito,
e ad aver rintracciato me, ricettore di notizie provenienti da Hammamet.
Il robot craxiano ero diventato io. Telefonai al «Giornale» e l’indomani fu
abbozzata una rettifica dallo stesso Feltri, ma era tardi: un altro delirante
articolo di un cronista giudiziario, sempre e incredibilmente sul «Giornale»
dello stesso giorno, mi citava tra gli «irriducibili collaboratori di Craxi» e
cercava di dimostrare chissà che cosa con un collage di intercettazioni varie.
Intanto «la Repubblica» titolava Craxi, il burattinaio e il «Corriere
della Sera» È Craxi il segretario di Forza Italia. Tutti i giornali
pubblicarono centinaia di intercettazioni tra Craxi e il resto del mondo. Altri
telefonisti craxiani erano Veronica Lario, moglie di Silvio Berlusconi, e
giornalisti come Enrico Mentana, Emilio Fede e Bruno Vespa. Un altro
telefonista, Alessandro Caprettini, direttore dell’«Italia settimanale», fu
licenziato. Il mio ex compagno di scrivania all’«Avanti!» Luca Mantovani,
portavoce del parlamentare di Forza Italia Vittorio Dotti, fu licenziato a sua
volta perché aveva spedito a Craxi la copia di un’interrogazione parlamentare.
Mancavo io.
Tra i telefonisti c’era anche Alda D’Eusanio, l’ex mezzobusto che mi aveva
proposto il lavoro alla Rai. I giornali pubblicarono un’intercettazione dove lei
diceva a Craxi «Sarò la tua voce» e l’associarono a un’altra intercettazione,
questa:
Craxi:
A te ti controlleranno il telefono, devo supporre…
Facci:
Sì, forse, ma non è un problema…
Craxi
(scherzoso): Nessunissimo problema, neanch’io nessunissimo problema…
C’era problema. «L’Unità» del 5 ottobre deprecava il mio «contratto milionario»
(66 milioni di lire lordi per un anno) e tre interpellanze parlamentari fecero
il resto. Il contratto venne stracciato con il consenso del presidente della Rai
Letizia Moratti. In sintesi: avevo dato una notizia vera, l’equo canone goduto
da Di Pietro, e avevo perso il lavoro.
Nel giorno in cui «l’Unità» sanciva la fine di ogni mia velleità contrattuale,
oltretutto, «Panorama» mi ritirava in ballo per il libro fantasma: un lungo e
complicato articolo citava un dossier anonimo che avevo consegnato alla Procura
di Brescia, uno dei tanti, e lo definiva «in stile Fbi». Si ritirava in ballo il
samizdat russo o irlandese scritto al Giambellino. Il quotidiano
«L’Indipendente» titolò Di Pietro spiato dai servizi segreti, citandomi.
Avevo ventott’anni, volevo fare il giornalista.
Nel periodo successivo divenni una specie di pendolare tra Milano e Brescia,
nella duplice veste di cronista e di testimone. Di Pietro ormai era nel mio
destino. Un’altra mia inchiesta sull’«Opinione», dopo una testimonianza che
rilasciai sempre a Brescia, fece aprire un filone d’indagine contro l’ex
magistrato per alcune sue presunte concussioni al ministero della Giustizia.
Senza farla troppo lunga: mi sarebbe capitato di far iscrivere Di Pietro nel
registro degli indagati altre due volte.
Di Pietro mi seppellì di querele e mi denunciò anche per calunnia. In una
memoria difensiva chiese di appurare i miei rapporti con Craxi e di inoltrare
rogatorie internazionali in Irlanda. Quando si discusse il rinvio a giudizio per
calunnia, pochi mesi dopo, l’udienza preliminare durò sei ore e io e Di Pietro
sfiorammo lo scontro fisico. L’ex magistrato ce l’aveva in particolare col mio
libro fantasma: «È da quel dossier» disse «che sono cominciati tutti i miei
guai». Ma quel dossier, che diversamente da altri non era un dossier ma solo un
disperato e tentato libro, diceva tutte cose vere. Cose che reggono, ancor oggi,
la prova del tempo. Fui prosciolto.
L’aria cambiò lentamente, ma cambiò.
Le storie di malagiustizia che riuscivo a trovare, grazie al rinnovato
garantismo berlusconiano e al mio buon rapporto con Maurizio Belpietro,
ottennero spazio sul «Giornale». Presi a collaborare anche con «Il Foglio» di
Giuliano Ferrara. Ogni tanto, per esempio su «Panorama», uscivano articoli
imbarazzanti che mi esaltavano come «il cronista che sapeva troppo ». Un
quotidiano di Trento, non trovandomi, e in mancanza d’altro, intervistò mio
padre. Dopo vari tentativi nel 1996 riuscii a trovare un editore anche per il
libro sui casi di malagiustizia, intitolato Presunti colpevoli: lo
pubblicò Mondadori. Altri giornali si soffermarono sul mio caso e a dirla giusta
fu «Il Foglio»: «Dopo tre anni di peregrinazioni, Filippo Facci ha trovato
l’editore, ma più probabilmente le condizioni politiche». Era la verità. Le
stesse condizioni politiche, un anno dopo, mi permisero di pubblicare una prima
biografia su Antonio Di Pietro sempre per Mondadori. Temendo chissà che cosa, Di
Pietro disse alla «Repubblica»: «So cosa vogliono fare,
… chi lo fa. E ho preso le mie contromisure. Anzi vorrei dare un consiglio: chi
sta realizzando la diffusione di un pamphlet che mi riguarda, ci pensi due
volte».
Il libro uscì lo stesso. In autunno, davanti al palazzo di giustizia milanese,
per la stupida legge dei corsi e ricorsi, ci fu una manifestazione del
centrodestra in cui il libro fu addirittura agitato da qualche manifestante, o
questo almeno lessi.
I primi di giugno 1999 ero di nuovo a Monza a giocare a pallacanestro quando un
mio compagno di squadra mi disse che alla sua fidanzata, studentessa alla
Cattolica, avevano chiesto di me durante un esame. Impossibile, dissi. Era vero.
L’esame era Storia del giornalismo italiano e nel tomo intitolato appunto
Storia del giornalismo italiano dalle origini ai giorni nostri, a pagina
366, c’era un capitoletto titolato «Le fonti e le disavventure delle notizie».
Si parlava di «tre casi limite, espressione di tre diversi momenti della storia
italiana: portano il nome di Zicari, Pecorelli e Facci».
Di Giorgio Zicari ricordavo che era talmente ben informato che l’accusarono di
essere colluso coi servizi segreti, di Mino Pecorelli che ebbe la fama di
ricattatore prima di essere preso a revolverate nel 1979. Il terzo ero io.
"Curiosa e ambigua la vicenda di Filippo Facci, un
giovane di 26 anni nel 1993, che rimane disoccupato quando l’«Avanti!» chiude il
31 dicembre 1992. Il quotidiano del Partito socialista, fondato il 25 dicembre
1896 da Leonida Bissolati, viene travolto dallo scandalo di Tangentopoli che
distrugge la carriera politica di Bettino Craxi, costretto a fuggire in esilio
nella sua villa di Hammamet, Tunisia. Facci è autore di un libro intervista al
cognato di Craxi, Paolo Pillitteri, ex sindaco di Milano. S’intitola Io li
conoscevo bene. Nel 1993, colleziona particolari e notizie su Antonio Di Pietro,
ne escono centonovantadue pagine che documentano le amicizie pericolose del
pubblico ministero più famoso d’Italia e simbolo del rinnovamento morale. Il
dattiloscritto viene pagato 4 milioni da un oscuro personaggio, sedicente
editore di una piccola casa editrice irlandese. Alcuni mesi dopo, pagine del
libro iniziano a comparire sui quotidiani, ma il volume ancora non è stampato.
Circolerà in seguito clandestinamente. I contenuti entreranno nell’inchiesta
giudiziaria su Di Pietro che si concluderà a Brescia nel marzo 1996 con il
proscioglimento dell’ex magistrato."
In autunno ricevetti qualche invito residuo a presentare la biografia su Di
Pietro, e uno mi colpì in particolare: era del Rotary Club Milano Giardini,
accanto al palazzo della stampa dove c’era la redazione dell’«Avanti!». Il
giornalista che mi aveva invitato era lo stesso che anni prima aveva impaginato
quel Di Pietro, facci sognare che troneggiava sulla copertina di «tv
Sorrisi e Canzoni». Fu lui a dirmelo. Quella sera, per farmi voler bene, dissi
subito qualcosa che ripeto ancor oggi: «Negli anni di Mani pulite, la
percentuale di italiani favorevoli ad Antonio Di Pietro ha oscillato tra il 90 e
il 95 per cento. Se mi applaudite, ora, presumo che sia perché al tempo
rientravate in quel residuo 5-10 per cento».
Nel maggio 2000, vagando per Milano in motorino, imboccai sparato via Giulio
Uberti in netto contromano: un’auto blu dovette inchiodare e rischiò seriamente
di mettermi sotto, la ruota anteriore del mio scooter si fermò a non più di un
centimetro dal suo paraurti. Alzai il braccio per scusarmi. Mi avvicinai e vidi
che alla guida c’era il pubblico ministero Paolo Ielo, autore peraltro di un
paio di querele contro di me. Sembrava impietrito. Abbassò il finestrino e mi
disse: «Facci, ma se poi ti mettevo sotto, chi ci credeva che era colpa tua?».
Antonio Di Pietro, per molti anni, rifiutò ogni invito in programmi televisivi
dove fosse prevista la mia presenza. Ha cambiato atteggiamento dal 2005 in poi.
Dei colleghi che uscivano dalla sala stampa quando vi entravo io, ora, almeno
quattro sono discreti amici. Il collega che mi accusò d’aver pubblicato dei
verbali falsi è passato a scrivere gialli metropolitani, come in fondo faceva
già allora. L’altro collega che m’accusò di aver favorito la fuga di un
dirigente socialista ha sposato una mia amica.
Nel tardo agosto 2009, con il ritorno di Vittorio Feltri in via Negri, ho
abbandonato «il Giornale» dopo quindici anni. Il collega che fece un collage di
intercettazioni telefoniche sul «Giornale» e fece strappare il mio contratto,
Gianluigi Nuzzi, oggi condivide il mio stesso incarico – inviato speciale a
«Libero» – sotto il mio stesso direttore, Maurizio Belpietro.
Dal 1992 a oggi è passata una mezza generazione e ci sono giovani e meno giovani
che di Antonio Di Pietro sanno a malapena che faceva il magistrato. Credo di
aver scritto questo libro anche per loro.
NON SOLO MANI PULITE.
Non solo Expo
2015, scrivono Emilio Randacio ed Attilio Bolzoni su “La Repubblica”.
Primo Greganti, Gianstefano Frigerio, Angelo Paris e gli altri arrestati e
indagati nell’inchiesta milanese gestivano appalti anche nella Sanità lombarda.
Intanto emergono nuovi particolari nell’indagine che ha portato all’arresto
dell’ex ministro di Forza Italia Claudio Scajola. E da Dubai, dove si trova da
latitante, Amedeo Matacena dice a Repubblica: faccio il maître, non tornerò in
Italia. Ieri sera la Cassazione ha confermato la condanna a 7 anni di reclusione
per Marcello Dell’Utri. La «cupola» o la «cordata»: così nelle carte della
procura viene indicato il gruppo di sette persone finite in carcere a Milano per
associazione a delinquere all’alba di giovedì. Un «circuito deflagrante e
perverso», scrive sempre la procura, pilotato dagli gli ex parlamentari Luigi
Grillo e Gian Stefano Frigerio insieme al «compagno G» Primo Greganti.
Quest’ultimo, alla vista dei militari che gli notificavano l’ordinanza
diciannove anni dopo quella che lo portò in cella durante Tangentopoli, è
scoppiato in lacrime. Insieme al direttore generale degli acquisti Expo Angelo
Paris, all’ex segretario Udc ligure Sergio Mattozzo (al quale i militari hanno
trovato in casa 12.500 in contanti nascosti), puntavano a mettere le mani su
appalti per mezzo miliardo. La fetta più corposa erano gli oltre 300 milioni che
vale il progetto della “Città della salute”, le cui buste con le offerte
dovevano essere segrete e sono invece state rinvenute e sequestrate durante gli
arresti.
Expo e sanità,
il sistema spiegato da un factotum dell’ex dc Frigerio. L’accordo con Greganti.
«Ragazzi, adesso c’è la Città della Salute», scrive Luigi Ferrarella su “Il
Corriere della Sera”. Il manuale d’istruzioni della catena di montaggio degli
appalti truccati, l’autopsia in diretta dei «delitti» compiuti nei lavori della
sanità o delle opere pubbliche come Expo: il Virgilio che guida in questo girone
infernale è, in una impagabile intercettazione ambientale nel circolo culturale
milanese «Tommaso Moro» dell’arrestato ex dc ed ex parlamentare berlusconiano
Gianstefano Frigerio, il suo factotum di fiducia: l’indagato Giovanni
Rodighiero, orgoglioso il 31 luglio 2012 di magnificare il sistema a un non
identificato dirigente sanitario tanto desideroso di esservi ammesso. «I
primari, i medici che gareggiano, vengono e vanno dai politici perché la Sanità
è gestita dai politici - esordisce Rodighiero - . Allora se tu hai il santo
protettore», che nel contesto sarebbe Frigerio, «il santo protettore ne prende
atto (delle tue esigenze ndr ), ti chiede il curriculum e poi va a parlare con
chi di dovere... Se gli garantisce il direttore generale che lo porta quello là,
questo si afferma... fa la gara e vince lui...». Il risultato è che «lui è
riconoscente a Gianstefano» e «Gianstefano è riconoscente al direttore
generale». E «dato che soldi non ce ne sono sempre», o «si rompe le scatole al
direttore generale di dargli un po’ di soldi o di mettere questo cavolo di
macchinario che serve... capito?». Si può così passare alla fase due: la gara
d’appalto per il tipo di fornitura in questione, e cioè - riassume il gip Fabio
Antezza - «i meccanismi tramite i quali si riesce a predeterminare
l’aggiudicazione a favore delle imprese per cui opera l’associazione, in primo
luogo con il confezionamento ad hoc di bandi di gara e capitolati». Anche qui lo
spiega Rodighiero, che fa l’esempio di una gara da 40 milioni di euro nella
ristorazione in ambito ospedaliero: «C’è il provveditore e c’è l’ingegnere che
stanno preparando il tutto, l’ingegnere l’ho fatto conoscere all’azienda. Come è
pronto il documento (lo schema del bando ndr ), viene dato a una persona fidata,
va in azienda, glielo dà, lo guardano... “questo non va bene e questo va bene...
c’è da aggiungere questo questo e questo... farla su misura a me”... Viene
ridato, l’ingegnere mette dentro e toglie (quello che l’impresa aveva chiesto di
aggiungere e levare ndr ), il provveditore e l’ingegnere sono in sintonia. E
quando è pronto il capitolato, è stato fatto su misura a te e non ad altri».
Terzo tempo: adesso c’è da concordare il prezzo per la corruzione. «Se hai
vinto, c’è un accordo a monte, che tu devi riconoscere ics...». Anche con
rateizzazioni della mazzetta: l’appalto «viene dato a te, perché si chiude con
l’accordo a te e tu sei l’uomo che deve andare dal direttore generale a dargli i
soldi, ogni anno... Subito tutti non li hai... hai un anticipo annuale alla
firma. Quando hai vinto l’appalto, un ics... ti tieni la tua parte e il resto
gliela dai a quello là... l’anno prossimo quando fanno i pagamenti gli dai la
rata... per nove anni». Quarta e ultima fase: il mantenimento degli accordi. E
qui, per quanto buffo possa sembrare nel contesto tangentizio, la credibilità è
tutto. L’importante è che l’accordo sia osservato qualunque cosa succeda,
perfino se quel determinato manager statale corrotto dovesse cambiare posto:
«Lui va via? Vai avanti a dargliela, eh?... è sempre stato così». Perciò i
componenti dell’associazione a delinquere temono come la peste quegli
imprenditori che non siano puntuali nel rispettare la tabella dei pagamenti
programmati. Lo si ascolta, in un’altra intercettazione, quando il 15 marzo 2013
uno dei mediatori che collaborano con Frigerio, Walter Iacaccia, gli esprime
l’irritazione per un imprenditore che non sta onorando una rata di 50.000 euro,
che Frigerio a sua volta attende di dover poi consegnare a un pubblico
ufficiale: «Io gli ho semplicemente detto (all’imprenditore inadempiente ndr ):
non devi farmi fare figure di cacca... perché se tu fai così, non sai cosa ti
precludi... ma soprattutto non puoi più chiedere favori... Ma che persona sei?
Io ci metto la faccia sempre... ma porca miseria, ma tu pensi veramente di poter
lavorare senza di noi?». Ieri, intanto, dai politici evocati «de relato» nelle
intercettazioni sono arrivate altre smentite. Dopo aver letto che Frigerio
asseriva «devo mandare un biglietto a Maurizio Lupi con il nome di Antonio
Rognoni (allora direttore generale uscente di Infrastrutture Lombarde ndr ) per
suggerirlo come presidente Anas», l’alfaniano ministro delle Infrastrutture ieri
ha dichiarato «con assoluta certezza di non aver mai ricevuto quel biglietto né
alcun altro tipo di comunicazione». Di «illazioni o millanterie» aveva già
parlato anche l’ex segretario pd Pierluigi Bersani, citato il 7 settembre 2012
da Frigerio che aggiornava Rognoni sul progetto della Città della Salute a Sesto
San Giovanni, del valore di 323 milioni e con stazione appaltante proprio
Infrastrutture Lombarde: «Ho sentito un po’ a Roma Bersani e poi gli altri sulla
Città della Salute, tu devi cominciare a fare delle riflessioni, poi, senza
responsabilità tue, mi dici come far partire un colosso macello perché è una
cosa grossa... Poi Bersani mi ha detto “a sinistra cosa fate?”, bisogna che
senta, se Rognoni mi dice Manutencoop per me va bene». Ma per Bersani questo
discorso non c’è mai stato. Le buste sigillate con le offerte relative alla gara
ancora da aggiudicare per la realizzazione della Città della Salute sono fra le
carte che l’altro ieri gli inquirenti hanno sequestrato a margine dei 7 arresti:
a detta del gip, per l’associazione capeggiata da Frigerio era «necessario
coinvolgere da subito un grande pool di imprese», procedendo «in accordo con
Primo Greganti» e spingendo sulla «Cooperativa Manutencoop» (il cui indagato
amministratore Claudio Levorato è una delle 12 persone per cui il gip ha
respinto l’arresto per carenza di esigenze cautelari) «in quanto la coop ha i
necessari collegamenti» a sinistra, là dove Frigerio si ritiene «coperto»
appunto da Greganti, il «compagno G» già arrestato in Mani pulite vent’anni fa.
Sin dal settembre 2012, ritiene quindi il gip, «il sodalizio imposta la consueta
strategia di individuazione delle opzioni anche politiche in grado di assicurare
un intervento efficace, e degli imprenditori da favorire con avvicinamento e
corteggiamento». Che le intercettazioni possano sempre avere più spunti di
lettura, del resto, affiora persino nel caso di Rognoni, sul cui conto
l’arrestato Sergio Cattozzo (ex segretario dell’Udc ligure e collaboratore di
Frigerio) il 20 gennaio di quest’anno esprimeva delusione dopo un iniziale
periodo di abboccamenti reciproci, concordando con Frigerio su quanto fosse
invece il caso di investire meno su Rognoni e più sul successore Angelo Paris,
general manager di Expo 2015 pure arrestato giovedì: «...perché fra poco c’è la
Città della Salute, ragazzi!... E siccome Rognoni a noi non ha dato niente, non
abbiamo nemmeno debiti nei suoi confronti». Greganti, per parte sua, appare
molto interessato a ritagliarsi un ruolo nella realizzazione del padiglione
della Cina (con la quale ha noti legami d’affari) all’Expo 2015. Il 21 marzo
scorso, al telefono con il liquidatore di Tempi Moderni S.r.l., Greganti -
annota il gip - «sottolinea che la Cina ha intenzione di predisporre l’intero
padiglione in modalità self-built», cioè costruendoselo da sola, «tuttavia
Greganti riferisce di aver comunque rappresentato l’importanza della sua
mediazione», per la quale sembrerebbe tenere rapporti con l’ambasciata di
Pechino e mandare una memoria in Cina. Intanto le comiche, come talvolta accade,
fanno capolino al confine di cose serie. E così giovedì, durante le
perquisizioni Gdf contemporanee all’arresto delle 7 persone, Cattozzo è quasi
riuscito a far sparire davanti ai militari, strappandoli da una agenda e
nascondendoli nelle mutande, alcuni post-it. I foglietti, una volta recuperati
dall’imbarazzante nascondiglio, si sono rivelati annotazioni di cifre e
percentuali e nomi: forse proprio la medesima contabilità delle tangenti su una
gara di Expo 2015 che i pm Antonio D’Alessio e Claudio Gittardi avevano
ascoltato in una intercettazione.
Caso Expo,
Greganti e la pista cinese. Come per Mani pulite la Cina è il cuore del
business dell'ex tesoriere Pci: il suo braccio operativo è la società Seinco,
scrive Luca Fazzo su “Il Giornale”. Sindrome cinese: scavi nell'Expo di Milano e
sbuchi in Cina. Negli affari di Primo Greganti, il «compagno G» tornato in cella
a ventun anni da Tangentopoli, riaffiora prepotentemente la potenza asiatica. Di
Cina l'ex tesoriere del partito comunista torinese aveva già parlato nel 1993,
quando aveva cercato di convincere i pm milanesi che i 621 milioni incassati da
Panzavolta non erano destinati a Botteghe Oscure ma a cercare appalti nella
Repubblica Popolare. E di Cina si torna a parlare nelle carte della retata che
l'altro ieri rispedisce in carcere Greganti insieme al suo coevo dell'altra
sponda, l'ex dc Gianstefano Frigerio.A stimolare l'interesse di Greganti è il
padiglione che il governo di Pechino deve realizzare per l'esposizione
universale milanese del 2015. Business di «grande interesse», secondo l'ordine
di custodia, per il «compagno G», che tiene rapporti con l'Ambasciata cinese in
Italia e manda memorie in Cina. «Beh i cinesi li abbiamo incontrati, li ho
incontrati a Milano», dice Greganti in una intercettazione, «fanno fare tutto
giù in Cina, qui c'è solo un problema di montaggio (...) Perché c'è un rapporto
con le Istituzioni, con l'Amministrazione, un rapporto con le altre imprese che
lavorano lì». «Comunque - aggiunge - in ogni caso, gli abbiamo detto noi siamo
qua (...) che se avete bisogno noi ci siamo, insomma, vi assistiamo in tutto,
voi state tranquilli, definiamo prima quali sono i costi, voi sicuramente
risparmiate, accelerate i tempi e noi vi diamo una mano». D'altronde «la Cmc già
c'ha un ufficio in Cina a Shangai». L'ultima affermazione è interessante, perché
riporta a uno degli assi conduttori dell'inchiesta su Expo: il rapporto tra
Greganti e le cooperative rosse, il ruolo del «compagno G» nell'assicurare alle
coop fette rilevanti della torta milanese. Secondo la Procura, il braccio
operativo di Greganti è una società torinese che si chiama Seinco. È a nome
della Seinco, per esempio, che l'11 dicembre scorso Greganti telefona a Riccardo
Casale, amministratore delegato di Sogin, il colosso pubblico dello smaltimento
nucleare: «Sono della società Seinco, gli dica Primo Greganti, lui si ricorderà
probabilmente». Oggi, negli uffici della Seinco i telefoni suonano a vuoto, la
mail è irraggiungibile. Ma fino a pochi mesi fa la Seinco era pienamente
operativa, il sito vanta appalti in Cina, a Cuba, lavori per le cooperative e
per il gruppo Ferruzzi (sarà ancora la consulenza dei 621 milioni?). Per il
giudice preliminare Fabio Antezza la Seinco è lo scherma dietro cui viaggiano le
tangenti: «Il documento in oggetto - scrive il gip commentando uno scambio di
mail tra Greganti e un dirigente della cooperativa Cmc - conferma il sovente
(sic) utilizzo da parte degli associati di fittizi contratti di consulenza come
mezzo attraverso cui giustificare la percezione delle indebite dazioni di
denaro». Il confine tra consulenza e tangente può risultare esile: e proprio su
questa linea è facile prevedere che si attesterà Greganti, quando dopodomani si
troverà faccia a faccia col giudice che lo ha arrestato. Anche a lui, come
vent'anni fa a Di Pietro, il tarchiato ex cassiere del Pci spiegherà di non
essere un collettore di mazzette ma un semplice, scrupoloso cucitore di rapporti
commerciali. D'altronde, anche a leggerle una per una, è impossibile trovare
nelle intercettazioni una sola frase in cui Greganti si sbilanci. Mentre
Frigerio ne dice di cotte e di crude, Greganti è sempre lui: attento, preciso,
taciturno. È innocente, o ha semplicemente imparato la lezione?
C'è il
compagno G, D'Alema si scopre garantista. L'ex premier freddo
sull'inchiesta. E Lupi si difende sul pizzino di Frigerio: mai ricevuto, scrive
Giannino della Frattina su“Il Giornale”. Dopo i sette arresti dell'alba di
giovedì e le 80 perquisizioni in 15 città che hanno decapitato i vertici
dell'Expo con il general manager Angelo Paris finito a San Vittore, Massimo
D'Alema si riscopre garantista. Sarà perché questa volta alle patrie galere sono
state associate anche due vecchie conoscenze di Mani pulite come l'allora
segretario della Dc Gianstefano Frigerio e il cassiere del Pci Primo Greganti e
quello erano tempi in cui «Baffino» era giovane e sognava per sé un futuro ben
più radioso di quanto sia poi stato. O forse perché quando l'inchiesta cominciò
a occuparsi delle tangenti rosse al Pci-Pds, fu proprio D'Alema a definire con
disprezzo il pool «soviet di Milano». In realtà un soviet che si occupò di tutti
fuorché dei comunisti, spianando loro la strada verso un potere che mai
avrebbero conquistato. Son passati gli anni ed ecco D'Alema a difendere (forse
per gratitudine) il «compagno G», quel «militante di scarsa fama, ma di sicura
fede» che, arrestato nel '93, tenne testa ai magistrati negando che una tangente
da 1,2 miliardi di lire fosse destinata al suo partito. Risparmiando così
qualche guaio ai «rossi», ma arrecandone parecchi al nostro sventurato Paese.
«Sono molto prudente a parlare di vicende giudiziarie che non conosco», ha detto
ieri D'Alema presentando il suo Non solo euro al Salone del libro di Torino con
il direttore del Tg3 Bianca Berlinguer. Tanto per non andare troppo lontano. «Ho
imparato - ha assicurato iper garantista - che il 40-45 per cento delle persone
accusate vengono prosciolte». Dicendosi perciò scettico sulla «smania di
pronunciare sentenze su istruttorie parziali». E assicurando che «oggi sono
finiti i partiti ma non la corruzione che è un fattore endemico nella società
italiana». A Roma, intanto, un «biglietto» galeotto fa tremare il ministro delle
Infrastrutture Maurizio Lupi che nella sfida dell'Expo si è buttato a capofitto.
Perché molti lavori e finanziamenti sono di sua competenza, ma anche perché
sogna di correre tra due anni per diventare sindaco di Milano dove fu assessore
nella giunta Albertini. Allora formigoniano di ferro, oggi in rampa di lancio
per prendere il suo posto al vertice di quella galassia ciellina da cui sta
cercando di estromettere il Celeste, ormai troppo invischiato nelle vicende
giudiziarie per essere un buon testimonial del nuovo corso dell'Ncd alfaniano.
«Leggo che nell'ordinanza per gli arresti dell'indagine sugli appalti di Expo -
si legge in una nota di Lupi - vengo citato da Gianstefano Frigerio. Il quale,
il 29 aprile dell'anno scorso, affermava: Devo mandare un biglietto a Maurizio
Lupi con il nome di Antonio per suggerirlo come presidente Anas. Posso dire con
assoluta certezza di non aver mai ricevuto quel biglietto né alcun altro tipo di
comunicazione». A parlare del biglietto è il gip di Milano Fabio Antezza
nell'ordinanza di custodia cautelare, mentre l'Antonio di cui si parla è quel
Rognoni arrestato un mese fa nell'inchiesta su Infrastrutture Lombarde. A
Milano, intanto, il giorno dopo le manette il sindaco Giuliano Pisapia e il
governatore Maroni spingono per accelerare al massimo la nomina del sostituto di
Paris. «Purtroppo - dice Maroni - Paris faceva tutto e deve essere sostituito
immediatamente con una persona che abbia due requisiti: grande competenza e
professionalità e, visto questo rigurgito di Tangentopoli, magari se viene da
fuori e non ha avuto rapporti con questi ambienti è meglio». Fretta e condizioni
che sembra non siano piaciute al commissario Expo Giuseppe Sala a cui spetta la
decisione. E martedì a Milano arriva il premier Matteo Renzi.
Come prima,
più di prima, scrive Gian Antonio Stella su “Il Corriere della Sera”. Per
piacere: evitateci lo stupore scandalizzato, «chi se lo immaginava?», «non
l’avrei mai detto...». Tutto sono, gli arresti di ieri per l’Expo 2015, tranne
che una clamorosa sorpresa. Perché, ferma restando l’innocenza di tutti fino
alle sentenze, le cose stavano procedendo esattamente come era andata troppe
altre volte. Il solito copione. Recitato per i Mondiali di nuoto, le
Universiadi, la World Cup di calcio, l’Anno Santo... Anni perduti nei
preliminari, discussioni infinite sui progetti, liti e ripicche sulla gestione e
poi, di colpo, l’allarme: oddio, non ce la faremo mai! Ed ecco l’affannosa
accelerazione, le deroghe, il commissariamento, le scorciatoie per aggirare
lacci e lacciuoli, le commesse strapagate, i costosissimi cantieri notturni non
stop. Sono sei anni, dal 31 marzo 2008, che sappiamo di dovere organizzare
l’Expo 2015. E anni che sappiamo, dopo i trionfi di Shanghai 2010 dove il nostro
padiglione fece un figurone, che l’impresa è difficile se non temeraria. Eppure
solo Napolitano, all’ultimo istante, si precipitò alla grandiosa esposizione
cinese per ricevere il passaggio del testimone e mettere una toppa sulle vistose
assenze del nostro governo. Dopo di allora, tanti proclami, annunci,
rassicurazioni... Mentre cresceva, nonostante l’impegno generoso di tanti, la
paura di non farcela. È una maledizione, la fretta. E ci caschiamo sempre. O
forse è peggio ancora: c’è anche chi scommette sui ritardi e sulla accelerazione
febbrile col cuore in gola. Quando il rischio che salti tutto fa saltare le
regole che erano state fissate e i prezzi schizzano sempre più su, più su, più
su. Proprio come previde nel 2010 la presidente degli architetti milanesi
denunciando «perplessità in merito al rispetto delle scadenze per il
completamento dei lavori, alla trasparenza delle procedure e alle modalità che
saranno utilizzate per affidare gli appalti». Già la prima di quelle gare, del
resto, fu un’avvisaglia: vinse un’impresa con un ribasso enorme da 90 a 58
milioni ma l’anno dopo già batteva cassa per averne 88. Per non dire delle
infiltrazioni nei subappalti di imprese in odore di mafia: il capo della polizia
Pansa, mesi fa, comunicò che 23 aziende erano state escluse. Lo stesso sindaco
Pisapia, però, spiegò d’essere sulle spine: troppi, sei mesi di analisi
burocratiche, per verificare la serietà di una ditta. Tanto più se la fretta si
fa angosciosa. L’unica sorpresa, nella retata di ieri che segue il fermo un mese
fa del direttore generale di Infrastrutture Lombarde Giulio Rognoni, sono i nomi
di alcuni degli arrestati. Già tirati in ballo vent’anni fa, nella stagione di
Mani pulite, come se non fosse cambiato niente. Dal costruttore Enrico Maltauro
all’ex pci Primo Greganti fino all’ex dicì Gianstefano Frigerio, poi candidato
da Forza Italia (lifting anagrafico...) col nome d’arte di Carlo. Ma come,
direte: ancora? Ancora, accusano i magistrati. E parlano d’«una cupola» che
«condizionava gli appalti» in favore di «imprese riconducibili a tutti i
partiti». Cosa significa «tutti»? Mancano solo un paio di settimane alle
elezioni europee. E un anno all’apertura dell’Expo: i dubbi su quello che è oggi
il più grande investimento nazionale e rischia di trasformarsi da vetrina della
speranza e del rilancio in una vetrina infangata devono essere spazzati via in
fretta.
Romanzo
criminale bipartisan, scrive Marco Lillo su “Il Fatto Quotidiano”. Gli arresti
di Reggio Calabria nei confronti di Claudio Scajola (per aver favorito nella
latitanza l’ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena) e quelli nei confronti
di due ex democristiani passati a Forza Italia, Gianstefano Frigerio e Luigi
Grillo, per gli appalti dell’Expo di Milano, insieme al compagno Primo Greganti,
fotografano due momenti di un unica storia iniziata venti anni fa. Se le accuse
saranno confermate non sarà poi tanto esagerato parlare di un ‘romanzo
criminale’ che affianca e spesso si intreccia con la storia ufficiale del
partito fondato e tuttora guidato nei fatti da Silvio Berlusconi. Claudio
Scajola è stato arrestato, con l’accusa di avere favorito l’ex parlamentare
calabrese di Forza Italia Amedeo Matacena nella sua latitanza. L’ex parlamentare
calabrese che ha avuto un momento di gloria quando testimoniò in favore di
Marcello Dell’Utri al suo processo, è stato condannato a 5 anni per i suoi
rapporti con le cosche di Reggio. Voleva andare in Libano da Dubai dove era
stato localizzato ed era in attesa di estradizione. Nella sua ordinanza, il
gip scrive che le investigazioni “vedono Scajola in pole position nell’impegno
volto all’individuazione di uno Stato estero che evitasse per quanto possibile
l’estradizione di Matacena o la rendesse quantomeno molto difficile e laboriosa.
Tale Stato Scajola lo individuava nel Libano, impegnandosi con personaggi esteri
di rango istituzionale per ottenere tale appoggio per tramite di importanti
amicizie”. La storia è intrigante perché c’è un punto di connessione tra la fuga
di Dell’Utri e quella del suo vecchio amico degli inizi di Forza Italia. Secondo
il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Raho:
“C’è qualche identità personale in relazione alle due indagini. Si tratta di un
personaggio destinatario di perquisizione che ci risulta protagonista nella
vicenda Dell’Utri, Speziali”, cioé Vincenzo Speziali, nipote e omonimo dell’ex
senatore del Pdl, sarebbe lui l’uomo che aveva un gancio con l’ex presidente del
Libano Gemayel, candidato alle prossime elezioni e in buoni rapporti con Silvio
Berlusconi. L’indagine della Dia di Reggio Calabria racconta quindi che un ex
ministro dell’interno nonché ex coordinatore del partito di Silvio Berlusconi,
avrebbe favorito un condannato definitivo per concorso esterno con la
’ndrangheta nella sua fuga. Non solo. Ci racconta che la destinazione finale e
il gancio della fuga di Matacena a Beirut sarebbero comuni con quella appena
avvenuta del fondatore di Forza Italia, Marcello Dell’Utri. L’immagine di
Scajola, ministro dell’Interno che guidò il Viminale nel triste momento del G8
di Genova nel 2001, che viene portato negli uffici della Dia di Roma e poi nel
carcere di Regina Coeli è certamente inquietante ma almeno appartiene ormai al
passato dell’Italia berlusconiana. Come anche l’immagine di Marcello Dell’Utri
trattenuto in ospedale a Beirut o quella di Matacena, per ora libero di
circolare a Dubai. L'altra indagine, quella di Milano sugli appalti delll’Expo,
invece è molto più inquietante perché riguarda l’oggi. Non solo nel campo del
centrodestra ma anche in quello del centrosinistra. L’ordinanza di arresto di
Milano ha colpito quella che sembra, secondo la ricostruzione dell’accusa, una
sorta di cupola bipartisan degli appalti. Sono stati infatti arrestati Primo
Greganti, il compagno G simbolo del coinvolgimento del Pci nell’indagine Mani
Pulite nel 1992 da un lato e Gianstefano Frigerio, simbolo della continuità tra
le mazzette della prima repubblica e la politica della seconda repubblica,
dall’altro lato. Frigerio infatti, nato nel 1939 a Cernusco sul Naviglio, è
stato condannato definitivamente a tre anni e nove mesi per le mazzette sulle
discariche lombarde (corruzione) e a due anni e undici mesi in altri due
processi della Tangentopoli milanese. Era il capo della Dc a Milano ed è
diventato deputato di Forza Italia grazie a Berlusconi nel 2001. Primo
Greganti, classe 1944, divenne famoso per il suo silenzio con i magistrati ai
tempi di Tangentopoli. Il primo marzo 1993 venne arrestato su richiesta del pm
Antonio Di Pietro, con l’accusa di corruzione, per aver ricevuto in Svizzera,
tra il 1990 e il 1992, 621 milioni dal gruppo Ferruzzi per appalti Enel. Denaro
che, secondo la magistratura, rappresentava la prima delle due quote riservate
al Pci-Pds delle tangenti concordate con il sistema dei partiti (l’1,6 per cento
sul valore delle commesse). Il compagno G. negò sempre ogni addebito e continuò
a ripetere che si trattava di consulenze personali. Alla fine Greganti patteggiò
solo una pena di 3 anni poi ridotta di sei mesi. Tra gli arrestati di ieri c’è
anche un vecchio democristiano ligure, Luigi Grillo, poi passato a Forza Italia
e decisivo nella nascita del primo Governo Berlusconi nel 1994. Grillo parlava
al telefono con l’ex ministro della difesa del primo Governo Berlusconi. Non dei
bei tempi del 1994 ma della nomina di un manager pubblico, Giuseppe Nucci, che
aspirava a una nomina a Terna. Previti parla con Grillo dell’argomento Nucci e
quest’ultimo parla con Greganti. Insomma, se Frigerio, Greganti e Grillo sono
personaggi del passato. Gli affari di cui si occupavano sono quelli di oggi,
dell’expo di Milano. In carcere è finito infatti anche il direttore dell’ufficio
contratti dell’Esposizione di Milano, Angelo Paris. I pm contestano
un’associazione a delinquere per pilotare bandi. In carcere è finito anche il
genovese Sergio Catozzo, ex Cisl, ex Udc infine berlusconiano. Ai domiciliari
Antonio Rognoni, direttore generale di Infrastrutture Lombarde, già arrestato
due mesi fa per presunte irregolarità negli appalti delle opere pubbliche. E’
indagato anche il ras della Manutencoop Claudio Levorato. Al presidente della
cooperativa bolognese rossa, come si diceva una volta, i magistrati contestano
l’associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d’asta e al traffico di
influenze. L’uomo della Manutencoop Levorato e l’amico di Berlusconi,
Gianstefano Frigerio, sono stati intercettati il 7 novembre 2013 mentre
parlavano dell’appalto della Città della Salute. Frigerio propone, mentre una
cimice della Dia registra le sue parole, a Levorato di usare i suoi appoggi
politici nel Governo di centrosinistra (allora guidato da Letta) per favorire la
nomina di Antonio Rognoni, allora presidente della società Infrastrutture
Lombarde che si occupa degli appalti dell’Expo, alla guida dell’Anas. Frigerio
dice: “io gli ho detto che una mano gliela do, per quello che posso fare io ,
della parte di Governo con cui ho rapporti io. Questa è una carta che può
servire anche a lei perché un pezzo di Govemo ce l’ha anche lei … forse anche di
più”. Frigerio suggerisce di piazzarlo al posto di direttore dell’Anas e
Levorato non si scandalizza. In una conversazione intercettata c’è anche una
telefonata del febbraio scorso in cui Frigerio sostiene di volersi mettere in
contatto con Lorenzo Guerini, il nuovo portavoce della segreteria, il volto
nuovo del Pd di Matteo Renzi. Il 24 febbraio scorso Frigerio dice all’amico
Cattozzo “devo parlarne con Guerini” e Cattozzo replica: “devo organizzare un
incontro con te e Guerini così lo tiriamo dentro, stiamo parlando di sette
miliardi di lavoro”. Ma Lorenzo Guerini dice al Fatto: “Non li ho mai visti né
sentiti. Non so chi sia questo Cattozzo”. Anche Pierluigi Bersani è tirato in
ballo da Frigerio. L’ex parlamentare berlusconiano racconta di avere parlato con
lui degli appalti dell’expo. Bersani al Fatto dice: “Pura millanteria non ho mai
incontrato questa persona. Non mi sono mai occupato di queste questioni”.
La giustizia è
e rimane la vera questione politica in Italia, scrive Fabio Camilleri su “La
voce di New York”. Gli ultimi “clamorosi arresti” quali monotone variazioni sul
tema. E mettere la testa sotto la sabbia non serve, a meno di non volerla
perdere. A Milano arrestano l’Expo, a Reggio Calabria arrestano l’ex ministro
Claudio Scajola e, per non restare indietro con la campagna elettorale, arresta
pure la Camera dei Deputati, autorizzando i ceppi per Francantonio Genovese,
deputato del partito Democratico, già sindaco di Messina. Per una volta, provo a
ritenere che siano stati raccolti sufficienti indizi di colpevolezza in ciascuno
di questi casi. Solo che rinchiudere in prigione prima del processo, lo sanno
ormai anche i muri, dopo ventidue anni di ManiPulite Continua, è
possibile se ricorrono uno o più dei “pericoli” per il processo medesimo: e cioè
che l’inquisito si dia alla macchia, oppure che ricada nel peccato, o, infine,
che provi a strappare le carte del Pubblico Ministero. Gli stessi muri di prima
sanno che queste ultime generalmente sono tutte previsioni (di legge) che si
autoavverano. In concreto, il pericolo c’è se chi accusa lo afferma. Perciò non
ci resta che giurare in verba magistri: se li hanno arrestati, evidentemente un
motivo c’era. Così va in Italia e così, per una volta, vorrei provare a ritenere
anch’io. Solo che la mia buona volontà Legge e Ordine viene subito messa alla
berlina. Già Scajola ristretto (in via cautelare) perché avrebbe aiutato un
condannato per un reato di dubbia oggettività (“vicinanza”, “sostegno
intermittente”, “contatti” “conoscenze” e via enumerando da una secolare
coscienza, si dice per dire, inquisitoria) a fuggire, da uno stato in cui era
legittimamente libero (gli Emirati Arabi Uniti, che avevano rigettato le
richieste italiane) ad uno (il Libano) in cui è invece possibile l’arresto (come
per Dell’Utri), qualche scossone alle mie buone intenzioni lo dà subito. Ma il
vero tormento viene da Milano. Perché il Procuratore Aggiunto Robledo ha
formalmente espresso il suo dissenso sull’indagine Expo, e non ha controfirmato,
come gli altri, l’ordinanza di custodia cautelare? Perché il Procuratore Capo di
Milano, Edmondo Bruti Liberati ha ribadito che “Robledo non ha condiviso
l’impostazione dell’inchiesta e non ha vistato gli atti”? Prima, possibile,
risposta. Sono cosucce, miserie burocratiche; allora la conferenza stampa
risulterebbe una tribuna vistosamente sproporzionata per una bega interna.
Seconda, possibile, risposta. No, in effetti non sono proprio cosucce, tanto è
vero che si è aperto un conflitto pure innanzi il Consiglio Superiore della
Magistratura; allora non è chiaro in che cosa consista “l’impostazione
dell’inchiesta”. Se le manette hanno fondamento, allora è grave che un alto
magistrato, con funzioni direttive, faccia mancare la sua approvazione in un
momento così delicato, qual è la presentazione al pubblico, sia pure al
pubblico-bue dei risultati di un’indagine preliminare così significativa. Se è
fondata l’opposizione, allora è grave che un altro alto magistrato con funzioni
direttive abbia chiesto la custodia cautelare, nonostante un così incisivo
dissenso sui contenuti dell’indagine. C’è una terza ipotesi, però. Che il
contrasto non sorga realmente dai contenuti dell’indagine, ma che riduca questi
ad un semplice sfondo spendibile sul piano formale, su cui possano ergersi
maestose le supreme ragioni del “riparto dei fascicoli”. Sarebbe l’ipotesi
peggiore, se possibile. Significherebbe la manifesta e totale strumentalità
delle indagini rispetto a vicende di rango, se così si può dire, eminentemente
personale. E le persone in galera? E noi che osserviamo? Insisto: se gli arresti
per la vicenda Expo sono fondati, cioè vi sono elementi sufficienti di
colpevolezza e così via, non si può discettare di “impostazione dell’inchiesta”
e inscenare un improbabile aventino procuratorio; se, invece, “l’impostazione
dell’inchiesta” non è questione di “incompetenza per scrivania”, ma è locuzione
che tradisce verità contenutistiche, rimaniamo col dubbio che la libertà
personale di un certo numero di persone sia stata impropriamente mutilata, senza
però, che ci si spinga oltre una sorta di arbitrato interno, eretto, con regale
indifferenza, su carne viva. E sorvolo sul timing. Questa ulteriore espressione
di eccellenza istituzionale e civile dovrebbe interessare anche il Governo in
carica. Invece, la custodia permessa nei confronti dell’On. Genovese, quanto al
Partito Democratico, olezza di viltà preelettorale. L’indagine che lo riguarda è
aperta da anni; ha già attinto alla moglie, amici, collaboratori e vari altri
soggetti; aveva ripetutamente espresso l’autodafè contemporaneo (“dichiaro la
mia piena fiducia nell’operato della magistratura”, o formula equivalente), gli
indizi sono acquisiti e stanno ormai macerando come neanche i mosti d’annata;
dunque, l’arresto preventivo serve per “comunicare”. Ignorare le implicazioni
allusive delle “indagini sensibili” non serve, caro Renzi. Significherebbe
riconoscere di essere sotto tutela. Se vuole fare qualcosa di nuovo, di
veramente politico e nobile, il Presidente del Consiglio deve intestarsi la
questione giustizia e calarvi con la scure di Gordio: carriere, CSM,
responsabilità civile, nuovi codici, soprattutto, nuovo Ordinamento Giudiziario,
non a carriera “automatizzata”: altrimenti, può già preparare il collo; e la
testa non la salva nemmeno se la ficca cinque metri sotto la sabbia
dell’ignavia. L’annunciato trionfo elettorale, se non agisce in questa
direzione, servirà solo ad amplificare il tonfo della caduta.
Ancora manette
in favore di tv. L'arresto di Scajola e l'agghiacciante parabola di questi 20
anni. Da Renzi ci si aspetta il segno di una riforma intellettuale e morale,
Fabrizio Rondolino su “Europa Quotidiano”. Il nostro codice di procedura penale,
all’articolo 274, è molto chiaro: le «esigenze cautelari», cioè l’obbligo di
arresto, necessitano di tre requisiti essenziali: il rischio di inquinamento
delle prove («purché si tratti di pericolo concreto e attuale»), il rischio di
fuga dell’imputato, il rischio di reiterazione del reato. È molto difficile
ravvisare nell’arresto di Claudio Scajola la presenza anche di un solo requisito
richiesto dal codice. Scajola non stava fuggendo (e, nel caso, sarebbe bastato
ritiragli il passaporto come per esempio è accaduto con Berlusconi), non
inquinava nessuna prova perché al momento prove contro di lui non ce ne sono, né
tantomeno era in procinto di reiterare il reato. Già, il reato. Di che cosa è
accusato l’ex ministro? Secondo la Dia di Reggio Calabria, Scajola avrebbe
intrattenuto rapporti “sospetti” con Chiara Rizzo, la moglie dell’ex
parlamentare del Pdl Amedeo Matacena, condannato in via definitiva per concorso
esterno in associazione mafiosa (un reato a sua volta di assai incerta
definizione), e avrebbe “interessato” un faccendiere italiano con interessi in
Libano – lo stesso implicato nella fuga di Dell’Utri – per favorirne la
latitanza. La parabola di questi vent’anni è agghiacciante. Nel fuoco di
Tangentopoli un isolato deputato missino agitò le manette nell’aula di
Montecitorio e fu, giustamente, subissato di critiche. E molti, se non tutti, si
scandalizzarono alle immagini di Enzo Carra, allora portavoce di Forlani,
ammanettato come un assassino colto in flagrante. Oggi la galera ha sostituito
l’avviso di garanzia, fra gli applausi della plebe urlante (che spesso e
volentieri magari passa col rosso, non paga le tasse e devasta gli stadi) e di
mezzo sistema politico. Non era necessario arrestare Scajola, e tanto meno era
necessario allestire una gogna pubblica, chiamando giornalisti, fotografi e
telecamere come se si trattasse di una conferenza stampa o di un reality show. E
non era neppure necessario richiedere l’arresto di Francantonio Genovese, il
deputato del Pd coinvolto nell’inchiesta della procura di Messina sui
finanziamenti alla formazione professionale: eppure la Giunta per le
autorizzazioni, con il voto decisivo di un Pd evidentemente spaventato dalla
campagna elettorale, ha concesso senza batter ciglio ciò che i pm chiedevano.
Lasciamo da parte, per favore, la solita stucchevole retorica sulla presunzione
d’innocenza e sulla piena fiducia nell’operato dei giudici. In Italia da molti
anni non è così, le sentenze si emettono prima dei processi (mentre spesso i
processi si concludono con un nulla di fatto) e vale invece, sempre, la
presunzione di colpevolezza, tanto più se sei un politico. I politici, come per
esempio sostengono ormai apertamente Travaglio o Grillo, si dividono in
inquisiti e non ancora inquisiti. Ai primi le manette in favore di telecamera,
ai secondi il sospetto incancellabile. Può andare avanti un paese così? No, non
può. Non si cura la rabbia con la vendetta, non si placa l’indignazione (spesso
giustificata) con l’esemplarità del gesto inquisitorio. Succede invece l’esatto
contrario, in una spirale di rancore e di rivalsa dalla quale, alla fine,
nessuno può sperare di salvarsi. Soprattutto, nessuno può sperare che così si
ricostituisca una civiltà giuridica ormai dispersa e si gettino le basi di una
nuova, indispensabile etica pubblica. Da Matteo Renzi, che alla sua ultima
Leopolda prima di diventare segretario del Pd e presidente del consiglio aveva
pronunciato parole importanti e impegnative sulla giustizia, ci si aspetta non
una battuta più o meno polemica né tantomeno una guerra ideologica e
personalissima “a la Berlusconi”, ma il segno di un cambiamento culturale,
psicologico, emotivo – di una riforma intellettuale e morale.
La bufala della "giustizia a orologeria": nel 2014 almeno 27 fra condanne,
arresti, indagini e prescrizioni, scrive Claudio Forleo
su “International Business Times”.
Ecco, puntuali come un orologio rotto che segna l'ora giusta solo due volte al
giorno, arrivare i commenti dei soliti fenomeni che vedono negli arresti di oggi
non una classe politica marcia fino al midollo, ma il solito complotto ordito
dalle toghe politicizzate. E' la colossale balla della "giustizia ad
orologeria", quella che si farebbe viva solo prima delle Elezioni, allo scopo di
condizionare il voto. Lo sostiene Elisabetta Gardini, candidata alle Europee
nel partito di Berlusconi: "Avvenimenti come l'arresto di Scajola impediscono
di parlare di ciò che preme alla gente". Le fa eco su Twitter Bruno
Vespa, uno che ama solo i processi 'alla Cogne', non quelli ai politici. "Arresti
eccellenti in campagna elettorale. Giusto per rendere il clima più sereno e
trasparente". Chiaro, no? Se un ex ministro dell'Interno, fino all'altro
ieri in corsa per un posto alle Europee, viene accusato di aver aiutato la
latitanza di un condannato per mafia, chi se ne frega! Se si vota ogni anno
(Politiche, Europee, Comunali, Regionali) e se la classe dirigente si fa
arrestare, condannare o indagare almeno una volta al mese, è ovviamente colpa
dei magistrati che fanno politica e che avvelenano il clima. Teoria riciclata
anche quando le elezioni non sono alle porte. Qualsiasi arresto, sentenza o
apertura di indagine è sempre 'a orologeria', che sia Ferragosto o Natale una
'spiegazione' si trova sempre. Purtroppo per questi teorici del complotto di
serie Z notizie del genere sono le più frequenti quando si parla di politica in
Italia, voto o non voto. Da gennaio ad oggi contiamo almeno 3 condanne, 6 rinvii
a giudizio, 6 arresti o richieste di arresto (compresi i casi Scajola, Greganti
e Frigerio) 10 aperture di indagini e 2 prescrizioni.
Parlamentari, ministri, candidati, consiglieri regionali, membri
di spicco dei partiti (presenti e passati).
Ecco il dettaglio:
2 maggio: Luigi
Lusi, ex tesoriere della Margherita, poi senatore del PD, condannato a otto
anni di carcere per appropriazione indebita. Avrebbe intascato 25 milioni di
euro.
16 aprile: Maurizio
Gasparri, ex ministro e vicepresidente del Senato, rinviato a giudizio per
peculato. Si sarebbe appropriato di una somma pari a 600mila euro dell'allora
gruppo PDL per intestarsi una polizza sulla vita.
11 aprile:
richiesta d'arresto per Marcello Dell'Utri. Il braccio destro di Silvio
Berlusconi che, pur non facendo più politica attiva, resta il padrino di Forza
Italia che riscrive la Costituzione con Renzi. Ma la "persona perbenissimo"
(copyright dell'ex premier) fugge a Beirut. La richiesta di estradizione è di 48
ore fa.
3 aprile:
nuovo arresto per Nicola Cosentino, già reduce da svariati mesi a
Secondigliano (solo dopo aver perso il seggio da parlamentare), poi tornato a
fare politica attiva con Forza Campania e ad incontrarsi con Denis Verdini nei
giorni che precedono la nascita del governo Renzi. L'accusa è di concorrenza
sleale ed estorsione con metodo mafioso.
1° aprile: chiusa
indagine sulle spese pazze nella Regione Campania e notifica dell'atto, che in
genere precede la richiesta di rinvio a giudizio, per Umberto Del Basso De
Caro (PD, sottosegretario alla Sanità), Domenico De Siano ed Eva Longo (senatori
di Forza Italia). Per tutti l'accusa è di peculato.
31 marzo: Silvio
Berlusconi incassa l'ennesima prescrizione, la settima della sua 'carriera',
nell'ambito del procedimento Fassino-Consorte. Dopo la condanna in primo grado
ad un anno per rivelazione di segreti d'ufficio, la Corte d'Appello di Milano
dichiara il reato estinto.
27 marzo:
il governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, da poco passato con il
NCD di Alfano, viene condannato a sei anni di reclusione e all'interdizione dai
pubblici uffici per aver firmato falsi bilanci all'epoca in cui era sindaco di
Reggio Calabria, Comune poi sciolto per infiltrazioni mafiose, il primo
capoluogo di provincia nella storia d'Italia a subire questo provvedimento.
Scopelliti, che avrebbe comunque dovuto lasciare la carica per effetto della
legge Severino, non fa una piega, come il ministro degli Interni e leader del
suo partito: candidato alle Europee.
27 marzo: l'ex
tesoriere dell'UDC Giuseppe Naro è condannato ad un anno di reclusione
per concorso in finanziamento illecito ai partiti: avrebbe intascato
dall'imprenditore Di Lernia una tangente da 200mila euro.
26 marzo: Lorenzo Cesa,
segretario dell'UDC e candidato alle Europee, è indagato per finanziamento
illecito nell'inchiesta su tangenti e fondi neri che coinvolge Finmeccanica e il
SISTRI, il sistema di tracciabilità dei rifiuti mai entrato in funzione.
19 marzo:
richiesta d'arresto per il deputato del Partito Democratico Francantonio
Genovese, re delle preferenze alle parlamentarie PD, ras di Messina e
dintorni. portatore di conflitti di interesse e soprattutto re della formazione
professionale in Sicilia. Lui si 'autosospende' dal partito, in compenso i
colleghi della Giunta per le Autorizzazioni di Montecitorio se la prendono
comoda: Genovese resterà al suo posto almeno fino a dopo le Europee. Ma guai a
parlare di 'ritardi ad orologeria', sono solo molto scrupolosi.
3 marzo:
l'ex presidente della Regione Lombardia, oggi presidente della Commissione
Agricoltura nonchè 'diversamente berlusconiano', il Celeste Roberto
Formigoni, viene rinviato a giudizio. per associazione a delinquere e
corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulla Sanità: la sua Giunta, nel corso
degli anni, avrebbe adottato provvedimenti favorevoli ad aziende private, in
cambio di viaggi e regali di varia natura.
Marzo: al
sottosegretario alla Cultura Francesca Barraciu, già indagata per
peculato in Sardegna, vengono contestati altri 40mila euro di rimborsi non
giusitificati ottenuti all'epoca in cui era consigliere regionale. La posizione
della Barraciu si aggrava nonostante le rassicurazioni arrivate dal PD sul
chiarimento che il sottosegretario avrebbe offerto ai magistrati.
28 febbraio:
il ministro per le Infrastrutture Maurizio Lupi è indagato per concorso
in abuso di atti d'ufficio per la nomina all'Authority di Olbia di un ex
deputato del PDL, Fedele Sanciu, il quale non avrebbe i titoli per ricoprire
tale incarico.
27 febbraio: Filippo
Penati, accusato di concussione a Monza nell'inchiesto sulle tangenti del
cosiddetto 'sistema Sesto' incassa la prescrizione nonostante avesse più volte
dichiarato di volerci rinunciare.
21 febbraio: l'ex
sindaco di Roma Gianni Alemanno e l'ex presidente della Regione Lazio Renata
Polverini sono indagati per finanziamento illecito relativamente ad una
provvista di denaro di 25mila euro, che sarebbe stata "realizzata con false
fatture di Accenture e destinata ad un falso sondaggio sulla qualità dei servizi
scolastici".
28 gennaio: Nunzia
De Girolamo, ex ministro delle Politiche Agricole, viene iscritta nel registro
degli indagati nell'ambito dell'inchiesta condotta sulle nomine all'ASL di
Benevento.
23 gennaio: Silvio Berlusconi è
iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano nel terzo filone di
inchiesta sul caso Ruby (per cui ha già ricevuto una condanna in primo grado a
sette anni). Per lui e gli avvocati-parlamentari Longo e Ghedini l'accusa
è di corruzione in atti giudiziari.
16 gennaio:
richiesta di rinvio a giudizio per l'ex presidente della Regione Piemonte Roberto
Cota e per altri 39 consiglieri regionali. L'inchiesta è ancora sul grande
scandalo delle spese pazze.
14 gennaio: Davide
Faraone, membro della segreteria PD, è indagato nell'ambito dell'inchiesta
sulle spese pazze nella Regione Sicilia.
Una lista infinita, e abbiamo considerato solo l'anno in corso. Ma condanne,
imputazioni o indagini a carico non limitano la carriera dei politici o dei
manager che orbitano nella stessa galassia. Nonostante il rinvio a giudizio per
la strage di Viareggio (disastro colposo plurimo), Mauro Moretti è stato scelto
dal governo Renzi come AD di Finmeccanica. Paolo Scaroni ha guidato l'ENI per un
decennio nonostante una condanna ricevuta durante Mani Pulite e altre indagini a
carico. Come dimenticare le liste dei partiti per le prossime Europee, piene di
impresentabili, come abbiamo riassunto nell'articolo dello scorso 17 aprile.
Quella della giustizia ad orologeria è una bufala, mentre una bella indagine a
carico, meglio ancora una condanna, fa curriculum.
Da Ruby a
Tangentopoli bis: a Milano inchieste col trucco. Dalle carte del Csm
sullo scontro tra Bruti e il suo vice Robledo spuntano anomalie anche per
assegnare il caso Expo. Le nuove accuse del pg Minale. E il procuratore capo
attacca i pm. Scomparsa gli indagati per mafia dal fascicolo sull'esposizione
2015, scrivono Michelangelo Bonessa e Luca Fazzo su “Il Giornale”. Che fine
hanno fatto le accuse di associazione mafiosa che Ilda Boccassini ha utilizzato
per conquistare la gestione dell'inchiesta sugli appalti dell'Expo? Di queste
accuse, nell'ordine di custodia eseguito l'altro ieri mattina, quello che ha
portato in carcere tra gli altri Primo Greganti e Gianstefano Frigerio, non c'è
più traccia. E così anche di questo dovrà occuparsi il Consiglio superiore della
magistratura, che la prossima settimana interrogherà tra gli altri proprio la
Boccassini: e dovrà capire se lo scontro in corso a Milano sia figlio di
protagonismi personali e di «populismo giudiziario», come sostiene ieri il
procuratore Bruti Liberati. O se invece, come afferma il principale accusatore
di Bruti, il procuratore aggiunto Alfredo Robledo, a Milano una ristretta
cerchia di magistrati, tutti più o meno legati a Magistratura Democratica, si
impadronisca di tutti i fascicoli più delicati in violazione delle regole della
stessa Procura. Nelle carte già in mano al Csm ci sono già alcuni dati di fatto
da cui sarà impossibile distaccarsi. Sono i punti fermi che ha messo Manlio
Minale, l'anziano procuratore generale, spiegando al Csm che in almeno due casi
non è stata attivata la «necessaria interlocuzione» con Robledo, modo ostico per
dire che il procuratore aggiunto è stato scavalcato, e che nell'inchiesta sulla
Serravalle, che lambiva il Comune di Milano, il ritardo di Bruti nell'avviarla
«ha pregiudicato le indagini». Ma davanti al Csm, Minale ha parlato anche di
Expo, e qui le cose si fanno ancora più interessanti. Al Csm, Robledo aveva
denunciato come una plateale anomalia il fatto che una inchiesta per reati di
corruzione non fosse coordinata da lui, competente per questi reati, ma da Ilda
Boccassini, ovvero dal pool antimafia. Ed ecco quanto dichiara Minale: «Robledo
era portatore di un convincimento assoluto, che in quel procedimento ci fossero
solo reati contro la pubblica amministrazione» e che dunque lui «fosse stato
ingannato e messo da parte (...) tant'è che anche ultimamente ho detto: Guarda
che io voglio essere tranquillo, mi sono fatto dare le iscrizioni e risultano
iscritti alcuni indagati per 416 bis», cioè per associazione mafiosa. Così, con
la presenza anche di un filone mafioso dell'indagine su Expo, si
giustificherebbe la presenza della Boccassini nell'inchiesta. Ma l'altro ieri
vengono eseguiti gli arresti, e nell'ordine di cattura non c'è traccia di accuse
di mafia. Nella retata dell'Expo si parla di appalti, di tangenti, di politica,
ma non di Cosa Nostra né di 'ndrangheta. E allora, che fascicolo venne fatto
vedere a Minale, con le accuse di associazione mafiosa? Forse i vecchi fascicoli
sulla penetrazione 'ndranghetista in Lombardia, da cui ufficialmente scaturisce
l'inchiesta Expo. Ma è una parentela assai remota, passata per mille passaggi
successivi. Non era certo di quei filoni, che Robledo si sentiva spodestato per
scarsa affidabilità politica. Proprio ieri, per andare al contrattacco Bruti
Liberati sceglie un convegno all'università Statale. E lì afferma esplicitamente
che il «populismo giudiziario è un virus endemico nei corridoi delle Procure
della Repubblica, ma da noi a Milano ha potenti antidoti». La frase di Bruti
parte da una citazione di un libro di Luigi Ferrajoli, padre fondatore di
Magistratura Democratica, che si riferiva soprattutto a Antonio Ingroia,
capofila di quei pm che «cercano di costruire un consenso popolare non solo alle
proprie indagini ma anche per la propria persona». Ma questo, per Bruti, è anche
il caso di Alfredo Robledo. E quei «potenti antidoti» di cui parla ieri Bruti
sembrano voler dire che il procuratore è convinto di uscire vincente dallo
scontro, in cui si sente attaccato non in nome della trasparenza ma del
«populismo» e dell'ambizione personale.
MIRACOLATI.
I SALVATI DA MANI PULITE.
Mani
Pulite, in tv i conti non tornano,
scrive Michele Brambilla su “La Stampa”. Ci sono leggende metropolitane che
resistono ai secoli come gli spinaci che danno forza, e quindi non c’è da
stupirsi se «1992» comincia con la scena, mille volte raccontata, di Mario
Chiesa che butta nel water sette milioni di lire e tira lo sciacquone. Un fatto
totalmente inventato. Ma l’ex presidente della Baggina milanese, che ha
minacciato Sky di trascinarla in tribunale per quella scena, dovrebbe
soprassedere perché a inventare quell’episodio fu proprio lui. Me lo confidò
egli stesso nel decennale del suo arresto, in un’intervista. Quando gli agenti
andarono ad arrestarlo, gli sequestrarono sette milioni in banconote pagategli
dall’imprenditore Luca Magni, che aveva spifferato tutto a Di Pietro. Ma gli
investigatori sapevano che i milioni avrebbero dovuto essere quattordici, divisi
in due tranche: e chiesero notizie degli altri sette. «Li ho buttati nel water»,
rispose Chiesa, ma in realtà i soldi erano lì in bella vista sulla scrivania,
incartati in un giornale, sotto il naso degli agenti che non se ne accorsero.
Sarebbero serviti, poco dopo, per pagare l’anticipo all’avvocato difensore. Ma a
parte questa, che è più che altro una curiosità, sono altri i conti che non
tornano a chi ha vissuto quei giorni come testimone privilegiato, cioè come
giornalista che scrisse già il primo giorno la cronaca dell’arresto, e che poi
avrebbe continuato a seguire gli sviluppi dell’inchiesta con ahimè nefaste
conseguenze sulla vita privata, visto che Di Pietro era dotato di un’energia
sovrumana e gli arresti si succedevano senza soste giorno e notte. Intanto, a
seguire Mani Pulite per il Corriere della Sera non c’era la bella bionda di
«1992» ma i meno attraenti Goffredo Buccini e il sottoscritto. Ma è un
dettaglio. Quello che il giornalista non ritrova è altro. È la resistenza a
confessare da parte degli imprenditori, resistenza che si noterà soprattutto
nella seconda puntata. In realtà gli imprenditori facevano la fila per andare a
confessare le tangenti. Noi cronisti li vedevamo, al pomeriggio, in coda di
fronte alla porta di Di Pietro. Perché confessavano? Un po’ perché avevano paura
di essere beccati, ma molto perché a Milano c’era tutto un mondo che si era
stancato di ingrassare i partiti. È per quella stanchezza, o almeno anche per
quella, che Mani Pulite è decollata. Poi c’è Di Pietro. Quando ha fatto il
politico, diciamo che non ha mostrato proprio il physique du rôle. Ma come
investigatore era un fenomeno. Noi cronisti giudiziari avevamo già assistito a
qualche inchiesta sulla corruzione, ma avevamo assistito anche alla loro
conclusione: il nulla o quasi. Al massimo finiva in galera qualche sottopanza
della politica, però ai pezzi grossi non si arrivava mai. La sera in cui
arrestarono Chiesa, invece, noi tutti capimmo che era successo qualcosa di
nuovo, perché Chiesa era uno degli uomini più potenti di Milano, e se avevano
osato mettergli le manette voleva dire che avevano prove mai avute prima. E
allora: un po’ perché Chiesa era stato preso «con le mani nella marmellata»,
come ci disse Di Pietro la mattina dopo, un po’ perché avevamo visto tanti
imprenditori che parevano penitenti in fila davanti a un confessionale, capimmo
che Mani Pulite sarebbe stata davvero un grande ribaltone. Fu il giornalismo
politico a non comprendere subito che i vecchi partiti erano al capolinea. Alle
elezioni di aprile 1992 i grandi quotidiani, in blocco, appoggiarono il Pri di
Giorgio La Malfa, scambiato per il nuovo che avanzava e destinato, invece, a
guadagnare lo zero virgola. Il Paese andava da un’altra parte e sarebbe stata la
Lega – che nella fiction ha il volto rozzo dell’ex soldato Pietro Bosco – a
sfondare a sorpresa. «1992», comunque, non pretende di essere un documentario ma
narrativa, e ha il merito di rendere bene l’Italia di quegli anni, oltre che di
non farcela rimpiangere. E non rimpiangere il passato, di questi tempi, è già
qualcosa.
Da Chiesa
all’avviso a Berlusconi. I segreti dell’inchiesta e di uno scoop.
Protagonisti e retroscena dell'inchiesta che ha cambiato l'Italia, scrive
Goffredo Buccini su “Il Corriere della Sera”.
Eravamo giovani, pensavamo che il bene stesse tutto di qua e il male tutto di
là. Mani pulite la vedemmo così, dall’inizio e per molto tempo. Mario Chiesa
l’avevano preso del resto come un magliaro, mentre cercava di buttare nel water
una mazzetta da sette milioni d’allora, lirette: il cattivo ridotto a caricatura
per punizione. In quei primi giorni girava una battuta tra noi, nella sala
stampa del Palazzo di Giustizia: «Figuriamoci se parla!». Al tempo, non usava.
Infatti l’ingegnere amico di Bettino Craxi, che si sognava sindaco di Milano ed
era frattanto diventato signore e padrone della «Baggina», l’ospizio dei
milanesi con un patrimonio immobiliare miliardario, se ne restò muto come un
pesce nelle prime settimane a San Vittore. Aveva due insidiose spine nel fianco,
è vero: Luca Magni, il piccolo imprenditore che, strangolato dalle tangenti,
s’era rivolto al capitano dei carabinieri Roberto Zuliani per disperazione e
l’aveva inguaiato; e Laura Sala, che di Chiesa era la moglie separata, e aveva
cominciato a raccogliere per la causa civile carte bancarie che sarebbero poi
diventate micidiali in mano agli investigatori. Tutto sommato, però, il primo
arrestato di Mani pulite aveva fondati motivi per essere fiducioso e per pensare
che stavolta non fosse diversa dalle altre. Quando, sette anni prima, avevano
portato in galera Antonio Natali, presidente della Metropolitana milanese e
imbuto delle tangenti per i partiti di maggioranza e opposizione, Craxi in
persona s’era mosso, da presidente del Consiglio, per fargli coraggio con una
calorosa visitina in cella. Poi lo aveva fatto eleggere senatore, e allorché
Saverio Borrelli aveva chiesto l’autorizzazione a procedere, il Senato
gliel’aveva negata tra applausi da centro, destra e sinistra dell’emiciclo,
raccontano i verbali della seduta. L’inchiesta Mani pulite poteva cominciare già
nell’85, ma allora i partiti comandavano, gli imprenditori avevano il loro
tornaconto, le ruberie finivano sotto la voce «costi della politica» e tutti
facevano finta che fosse normale. «Figuriamoci se parla!», ci dicevano quindi
vecchie lenze della giudiziaria come Annibale Carenzo o Adriano Solazzo, al bar
senza orpelli di via Freguglia che odorava di mensa aziendale, in un Palazzo di
Giustizia che, come loro, ne aveva vissute tante ma era assolutamente marginale
nella mappa del reale potere cittadino e mai aveva visto un politico finire e
restare seriamente impigliato nella rete. Chiesa lo sapeva. E aspettava con
calma che venisse qualcuno a liberarlo. Lo chiamavano «il Kennedy di Quarto
Oggiaro» per via del ciuffo giovanilista. Dal Pio Albergo Trivulzio, la
«Baggina» per la sua collocazione nella periferia grigia e dignitosa di Baggio,
questo manager svelto di mano aveva distribuito case a prezzi stracciati ad
amici e amici degli amici, giornalisti inclusi, e aveva tenuto la borsa aperta
per le bustarelle socialiste del dopo-Natali. Ne sapeva insomma abbastanza per
essere convinto di finire tra i salvati con un trattamento simile all’antico
boss della Metro, che di Craxi era ritenuto da molti il papà politico. Il 17
febbraio Ettore Botti, capocronista del Corriere, richiamò chi era di corta: al
telefono di casa, perché i cellulari (giganteschi e pesanti, Fabio Poletti di
Radio Popolare usava uno zaino per portare il suo, da campo...) ce li avrebbero
«cuciti» addosso solo di lì a poco, quando l’inchiesta sarebbe diventata un
lavoro senza pausa dalle nove di mattina alle due di notte. Ettore era un
napoletano che aveva fatto strada a Milano: calvinista creativo, generoso e
iracondo, detestava intrallazzi e intrallazzatori e s’era puntato già da un
pezzo la fasulla icona della metropoli da bere che nascondeva party alla coca,
modelle alla Terry Broome e tanta, tanta politica marcia. «Questo è uno grosso,
ma chissà se parla», disse. Era già un passo avanti rispetto al «figuriamoci» di
noi ingenui, Ettore aveva fiuto e talento. A Milano giravano del resto da anni
barzellette sui socialisti ladri, e finivano per insozzare così la migliore
tradizione d’una città governata per decenni da socialisti e socialdemocratici
perbene, quelli come Bucalossi o Aniasi, che avevano fatto la Resistenza, creato
una metropoli operosa e aperta, incoraggiato una cultura di cui Streheler e il
Piccolo Teatro erano solo la manifestazione più visibile. Prima che arrestassero
Chiesa un ragazzo di bottega della cronaca giudiziaria poteva imparare molto
sull’inossidabilità di certa politica, assistere allo smantellamento del
processo per le tangenti Icomec, agli inutili sforzi del sostituto procuratore
Francesco Greco per acciuffare ancora e sempre Natali, reso inattaccabile dal
Parlamento. Si intuiva una corruzione «sistemica», come nel caso delle
bustarelle all’assessorato per l’Edilizia privata, con l’ufficetto parallelo da
cui Sergio Sommazzi velocizzava le pratiche dei grandi costruttori milanesi. Di
gente come Silvano Larini si parlava a mezza voce, come di una fantomatica foto
di Craxi col boss Epaminonda che tutti cercammo e nessuno trovò mai: nelle notti
di Brera balordi e politici, fandonie e perdizioni si mischiavano in un cocktail
fascinoso come una canzone della Vanoni. Il primo squarcio davvero imbarazzante,
e subito richiuso, venne da un’inchiesta pittoresca, cui pochi crederono
davvero. A fine anni Ottanta, nel nucleo operativo dei carabinieri di via
Moscova lavorava un tenente toscano con una faccia da bambino che gli faceva
dimostrare persino meno della sua età. Si chiamava Sergio De Caprio, tutta
Italia l’avrebbe conosciuto più tardi come il Capitano Ultimo capace di piantare
una Beretta sulla faccia di Totò Riina. A Milano s’inventò la Crimor, la
squadretta specializzata contro boss e picciotti, mettendo insieme gli avanzi
delle altre sezioni, mattocchi come lui che nessuno voleva tra i piedi. Usavano
nomi di battaglia come Aspide o Vichingo, si mimetizzavano per settimane vivendo
come i sospetti che pedinavano, piazzavano cimici ovunque. Seguendo Tonino
Carollo, rampollo ripulito del clan Fidanzati che assieme a un gruppo di
immobiliaristi sognava di lottizzare terreni a sud di Milano, finirono per
inciampare in Attilio Schemmari, potente assessore all’Urbanistica, e a sfiorare
Paolo Pillitteri, primo cittadino e cognato di Craxi, che quando entrava a San
Siro si faceva precedere in tribuna vip da un portavoce capace di dire
seriamente frasi come «fate largo, sta passando il sindaco». In Procura c’era
una giovane pm, Ilda «la Rossa» Boccassini, che a volte superava per passione
certi limiti e che, tanto per avviare l’interrogatorio della moglie d’un
indagato, le chiese: «Signora, lo sa che suo marito ha un’amante?». L’inchiesta
di Ilda e Ultimo la chiamammo Duomo Connection, senza molta fantasia, il grande
intrigo di Pizza Connection era di pochi anni prima: costò il futuro politico a
Schemmari (un altro che, come Chiesa, si sognava sindaco) ma arrivò meno lontano
di quanto immaginassimo. Presero un po’ di colletti bianchi, qualche prestanome,
Pillitteri fu lambito con cautela, nei giornali di Milano il Psi contava
parecchio. Questa era la città dove tutto incominciò. Tonino Di Pietro ha
raccontato di recente a Marco Damilano che, prima delle vacanze di Natale del
1991, ci fu una riunione tra i rappresentanti degli imprenditori e i segretari
amministrativi dei partiti nazionali. Le «migliori imprese», un centinaio, erano
tutte coinvolte nel sistema, ha ricordato. Si stabilirono le percentuali, quella
volta: 25 per cento alla Dc, 25 al Psi, 25 ai ministri in carica dei partiti
minori, 25 al Pci-Pds non in forma di quattrini ma di quota lavoro per le
cooperative. Un anno prima di pizzicare Chiesa, Tonino aveva descritto nel
numero di maggio di Società Civile il sistema della dazione ambientale, dove
salta il confine tra corruzione e concussione, e chi deve pagare non aspetta
nemmeno la richiesta perché sa che in quell’ambiente così fan tutti. A Natale
1991, il sistema aveva ormai una sua contabilità condivisa. Ma i soldi stavano
finendo, e con essi andava logorandosi il patto che tutto teneva. In questa
Milano, Di Pietro era l’archetipo dell’outsider furbo e deciso a salire in alto.
Stava nella stanza 254 della Procura, esattamente all’altro capo del lunghissimo
corridoio che si dipanava dagli uffici del procuratore Borrelli: un segno di
marginalità, perché il peso dei sostituti si misurava con la prossimità al capo.
Eppure Tonino ne faceva anche un tratto di indipendenza. Andava per le spicce.
Quattro anni prima, indagando sulle patenti facili, aveva arrestato un centinaio
di esaminatori e esaminandi, li aveva fatti portare in una caserma della
stradale e li interrogava sbraitando, agitandosi, passando a grandi falcate da
un terzo grado all’altro, con un innato senso scenico. Aveva messo in piedi
anche lui una squadretta come quella di De Caprio. Ma i suoi moschettieri,
raccolti in prevalenza tra poliziotti e vigili urbani, non sembravano pervasi
dal sacro fuoco come i carabinieri di Ultimo. Comunicavano un senso di
trattativa. Come Tonino. Rocco Stragapede, il più fedele, ciabattava come
Tonino, come Tonino ammiccava, lasciandoci passare infine con il sussiego d’un
maggiordomo fidatissimo. Lui ci riceveva nella 254 coi piedi sulla scrivania, si
tirava su i calzoni e si grattava le caviglie con voluttà: chiamava tutti noi,
ragazzini borghesi dagli studi facili, «dottori», un po’ con rispetto e un po’
con ironia. Faceva il Bertoldo, stava sperimentando un personaggio, il figliolo
di mamma Annina, il contadino di Montenero di Bisaccia emigrato al nord,
laureato chissà come mentre faceva mille lavori e assurto infine alla gloria
della toga: noi non sapevamo nemmeno dove fosse Montenero di Bisaccia. Se
recalcitrava nel darci qualche notizia talvolta banale, lo punivamo
storpiandogli il cognome tutti insieme, nei pezzi del giorno dopo: diventava per
refuso Antonio Di Dietro, e allora borbottava senza prendersela più di tanto.
Eravamo tutti attorno ai trent’anni, la sala stampa non era ancora affollata dai
colleghi delle tv, i vecchi marpioni della giudiziaria non credevano s’andasse
lontano e lasciavano fare a noi ragazzini. In quei primi giorni d’inchiesta, la
scoperta di una seconda cassaforte segreta di Chiesa ci apparve una notizia
clamorosa e definitiva. Nemmeno Di Pietro immaginava fino in fondo dove si
sarebbe arrivati. Borrelli, figlio d’arte (il padre Manlio era stato presidente
di corte d’appello), napoletano raffinato e certo non inviso dapprincipio ai
salotti politici della città, l’aveva sempre guardato dalla siderale distanza
del corridoio, entomologo illustre che contempla una curiosa specie d’insetto:
continuava a gravarlo di processetti per droga, finché una parola sbagliata
cambiò il corso degli eventi come una valanga. L’ingegnere della Baggina aveva
resistito quando Di Pietro gli aveva scovato in Svizzera i conti Levissima e
Fiuggi e, beffardo, aveva sibilato all’avvocato Diodà: «Riferisca al suo cliente
che l’acqua minerale è finita». Crollò quando Craxi, sotto una pressione
popolare inattesa che di lì a poco sarebbe sfociata nel terremoto elettorale del
5 aprile (crollo del pentapartito, primo boom della Lega), gli affibbiò il
famoso epiteto di «mariuolo»: una mela marcia isolata, insomma. C’era un
prefabbricato giallo al centro del cortile della procura: attorno carabinieri e
poliziotti, dentro Tonino e il «mariuolo». Ogni tanto Nerio Diodà faceva
capolino per prendere aria, e aveva una faccia diversa. Chiesa stava parlando,
parlò per sette giorni. Quando smise di parlare, ci fu un attimo di sospensione,
giusto il tempo di digerire il risultato elettorale. Poi, il 22 aprile,
arrestarono otto imprenditori: avevano lavorato per il Pio Albergo Trivulzio,
pagato il solito obolo all’ingordo ingegnere. Entrarono a San Vittore,
confessarono, uscirono. Noi stavamo nei giardinetti davanti al carcere, basiti,
a prendere appunti, quando spuntò Vittorio D’Ajello, difensore di uno degli
otto, un vecchio avvocato chiacchierone e affabile che ne aveva viste di cotte e
di crude, e quasi strillò: «Andranno avanti per anni! Faranno centinaia di
arresti!». Verso sera, Di Pietro si lasciò andare a una confessione con Paolo
Colonnello, il cronista del Giorno, che tra noi gli era più vicino: «Potrei
arrivare a Craxi… ma bisogna andarci piano». Quella notte, chiusi i giornali,
noi ragazzi della giudiziaria la tirammo lunga in una trattoria di via Moscova
vicino al Corriere. Il pool dei giornalisti nacque così, quando capimmo che ci
sarebbero stati da raccontare dieci avvisi di garanzia e cinque arresti al
giorno, e bisognava controllare che le notizie fossero tutte vere e non
inquinate, in un contesto dove già si vedevano all’opera i primi avvelenatori di
pozzi: non vale la pena di evocare qui la corte dei miracoli di faccendieri,
cialtroni, spie a mezzo servizio e finti giornalisti che già da quel ’92 hanno
messo le loro mani sporche dentro e sopra Mani pulite, sarebbe un’altra storia.
E si è detto fin troppo su quel gruppetto di ragazzi che fummo; ma per il tempo
che durò la nostra leale collaborazione tra cronisti di testate rivali – meno
d’un anno – nessuna notizia fu occultata, ciascuna fu verificata almeno due
volte, i colleghi dei giornali più deboli e quindi più esposti a pressioni
politiche furono protetti dal fatto che tutti gli altri giornali avrebbero dato
quella notizia e dunque capiredattori e direttori non avrebbero avuto motivo di
censurare il loro lavoro. Il salto di Mani pulite avvenne perché gli otto
imprenditori denunciarono i cassieri segreti dei partiti, gli «elemosinieri», e
mandarono in galera personaggi come Maurizio Prada della Dc o Sergio Radaelli
del Psi: così il muro del silenzio si incrinò. Uno del calibro Prada, allora
presidente dell’azienda municipale dei trasporti, dovette infatti vivere la
faccenda come un tradimento e iniziò a raccontare le tangenti che le aziende a
loro volta offrivano per primeggiare. Un’autentica reazione a catena, tipica del
sistema messo a punto da Di Pietro: vai dentro, denunci i complici, diventi per
loro inaffidabile, esci. Confessioni estorte? Indubbiamente sì, da un certo
punto di vista. E tuttavia perfettamente legali. Roberto Mongini, presidente
milanese della Dc, capace di emergere da San Vittore indossando una maglietta
«Mani Pulite Team» che fece furore, ha di recente spiegato a Federico Ferrero
come, se non fosse stata usata la carcerazione preventiva «con mano piuttosto
pesante», è chiaro che avrebbe parlato il 10 per cento di chi ha invece
confessato. Si potrà discutere altri vent’anni sull’accettabilità di una
procedura del genere (sempre avallata da un gip, sempre dallo stesso gip, Italo
Ghitti). Quasi tutte le grandi aziende finirono nei guai, la Fiat tra le prime:
il Corriere di Ugo Stille, allora affidato di fatto al vicedirettore Giulio
Anselmi, aveva Fiat nella proprietà ma tenne la barra dritta. Sei giorni dopo la
confessione degli otto, ventitré giorni dopo le elezioni politiche, Borrelli
capì che Tonino non poteva restare solo, e gli affiancò due pm di cui aveva
grande fiducia, Colombo e Davigo. Gherardo Colombo era un colto cattolico di
sinistra che aveva guardato in faccia il drago, avendo scoperto col collega
Turone gli elenchi della P2 e lavorato sui fondi neri dell’Iri. Piercamillo
Davigo era un giurista affilato, incorruttibile, prodotto di una destra
perbenista e militaresca. I nemici lo chiamavano Vichinsky, il procuratore delle
purghe staliniane. A conoscerlo, lo si sarebbe detto più simile a Javert, il
drammatico sbirro dei Miserabili. «Non ci sono innocenti ma colpevoli non ancora
scoperti», usava dire, ed era difficile capire fin dove scherzasse. Dietro di
loro, il procuratore aggiunto Gerardo D’Ambrosio, «zio Jerry», da molti
sospettato di essere una quinta colonna del Pci che gli avrebbe pagato gli studi
da ragazzo povero, in realtà giudice espertissimo dai tempi di piazza Fontana,
amico di Galli e Alessandrini ammazzati dal terrorismo rosso. Il Primo maggio
caddero sotto gli avvisi di garanzia il sindaco in carica e il suo predecessore,
Paolo Pillitteri e Carlo Tognoli. Si aprì ufficialmente la caccia a Craxi, che
al bar del tribunale presero a chiamare «Cinghialone»: la 2021 dimensione umana
degli indagati era già passata in un tritacarne e dimenticata. Anche da noi
giornalisti. Nato un metodo, molto controverso, nato il pool Mani pulite,
l’Italia impazzì. «Liberaci dal male che ci perseguita», scrivono a Tonino da
ogni parte dello Stivale. Nascono comitati, si fanno fiaccolate, manifestazioni
di sostegno sotto Palazzo di Giustizia al grido di «Tonino non mollare!», si
mescolano le facce di Sabina Guzzanti e Paolo Rossi a quelle degli ancora
missini di Gianfranco Fini. Escono agiografie in cui si racconta seriamente che
l’estate prima Di Pietro ha salvato una donna che stava affogando in mare,
portandola al sicuro con poche maschie bracciate, acclamato «come un Dio» dagli
altri bagnanti. Va a ruba il poster degli Intoccabili con le facce del pool in
fotomontaggio, Borrelli e i suoi si concedono due passi in Galleria e l’evento
diventa un bagno di folla. In capo a un anno le televisioni renderanno
permanente questo show, con il bravo Andrea Pamparana a seguire i processi per
il nuovo tg di Mentana e il surreale Paolo Brosio piantato da Fede davanti alle
rotaie del tram ad annunciare la fine del mondo: tv berlusconiane, perché a
lungo il Cavaliere tentò, se non di andar d’accordo coi pm, di farli suoi, come
fuoriclasse stranieri che è meglio giochino nella tua squadra. Mi capitò di
scendere a Montenero di Bisaccia per la morte di mamma Annina, la madre di Di
Pietro, e di portare da Milano in macchina con me Davigo e Colombo: fu come
avere sui sedili il Gigi Riva dei mondiali messicani e il Mussolini della
conquista d’Etiopia, alle stazioni di servizio la gente cercava di entrarmi
nell’abitacolo dai finestrini. Molto, e molto di male, si può dire adesso di
tanti voltagabbana che, dopo avere votato e omaggiato potenti e corrotti per
decenni, si misero ad applaudire come tricoteuse coloro che stavano mozzandone
la testa. E tuttavia nella garagista che dalle parti del tribunale ci implorava,
«dite a Tonino che sto con lui», c’era anche altro, una voglia di cambiare
genuina, poi andata persa. Quella fu l’estate di Craxi, ancora a giugno
candidato alla presidenza del Consiglio e affossato da una prima ondata di
indiscrezioni sui verbali di Chiesa. Sentendo che il suo tempo stava per finire,
Bettino pronunciò un memorabile discorso alla Camera sul sistema di
finanziamento della politica che sapeva di chiamata in correità per tutti gli
altri leader di partito (tranne un giovane Massimo D’Alema, nessuno fiatò). Poi,
nel segno di quella duplicità tra uomo di Stato e nemico dei magistrati che lo
stava perdendo, lasciò circolare voci insistenti sul suo «poker contro Di
Pietro», un miscuglio di veleni e mezze notizie che riscaldarono molto il clima
di quei mesi già roventi: apripista di un lungo elenco di rivelazioni vere o
presunte, tutte volte a dimostrare che l’eroe nazionale era un mezzo eroe o,
addirittura, un poco di buono. Dalla Mercedes facile ai cento milioni in
prestito a costo zero, dai rapporti con D’Adamo e Gorrini all’abitudine che
Pillitteri aveva di chiamarlo simpaticamente «Ninì» quando non era ancora un pm
spaccamontagne, dall’amicizia con il discusso ex capo della Mobile Eleuterio Rea
fino all’ambiguo Chicchi Pacini Battaglia sulla cui intercettazione («sbancato»
o «sbiancato» da Tonino?) si interrogheranno i posteri se ne avranno voglia, va
rammentato che Di Pietro conosceva, sì, qualcuno tra quelli che arrestò e
tuttavia l’arrestò ugualmente, e che è uscito pulito da una lunga serie di
processi: anche se non ama ricordare che il proscioglimento a Brescia conteneva
rilievi deontologici abbastanza insidiosi da porre in una luce meno romantica il
suo successivo abbandono della magistratura, con la toga sfilata per l’ultima
volta davanti alle telecamere, in diretta come tutto quello che avveniva ormai
in tribunale, il 6 dicembre ’94. Tuttavia, se in questa parte della vicenda non
tutti gli angoli sono stati illuminati è anche colpa di noi giornalisti, di
quegli stessi che seguirono l’inchiesta dalle prime battute. Giovani entusiasti
com’eravamo, non ci demmo pena di guardare se in tanto fango ci fosse qualche
fiorellino di verità. Manichei come chi trova in ogni atto giudiziario la
conferma di ciò che ha sempre pensato, derubricammo alla voce «veleni» quanto di
dissonante poteva emergere dal 22 23 passato di Di Pietro, perdendo così
qualcosa della nostra funzione. Fu un grave errore, perché lasciammo per mesi il
monopolio di questi filoni a un giornalismo di parte, preso in una logica di
scontro tra fazioni, e dunque non consentimmo ai lettori indipendenti e moderati
di formarsi sin da subito un’opinione in proposito. Ma più grave, perché
avveniva sotto i nostri occhi ogni giorno, fu non dare peso alla processione
degli avvocati accompagnatori, quei legali che in barba alla loro deontologia
salivano in procura non per difendere il cliente ma soltanto per farlo
confessare in fretta ciò che i pm volevano: grave fu non interrogarci subito
sull’archetipo di questa stravagante categoria forense, il mercuriale e quasi
ignoto Geppino Lucibello, amico intimo di Di Pietro, diventato in un attimo e
per lungo tempo l’avvocato che con più certezza garantiva all’indagato un veloce
disbrigo della pratica e spesso gli evitava il fastidioso passaggio all’ufficio
matricola del carcere milanese. Il 15 dicembre del ’92 si levarono infine grida
di giubilo in sala stampa quando arrivò la notizia che a Craxi era stato
consegnato il primo avviso di garanzia. Troppi erano, ormai da troppo, troppo
vicini all’inchiesta. Il primo a suicidarsi fu Renato Amorese, segretario
socialista di Lodi: non un personaggio di primo piano, ma la dignità non
presuppone appeal da copertina. «Mi hanno sputtanato», disse. Sergio Moroni,
deputato socialista, s’ammazzo il 2 settembre, dopo avere mandato a Napolitano,
allora presidente della Camera, una lettera terribile in cui s’interrogava su
una politica da cambiare ma parlava anche di processo «sommario e violento» e di
«decimazioni». Sua figlia Chiara, che ne ha ereditato la passione e siede in
Parlamento, ha raccontato a Federico Ferrero che era insopportabile per lui
«essere scaraventato nel calderone dei ladri». Poi si uccisero Gabriele Cagliari
e Raul Gardini. Il saggio recente di Ferrero cita uno studio di Nando Dalla
Chiesa e colloca a 43 il numero delle vittime «per cui è accertata una morte
cagionata dall’onta del coinvolgimento nel giro della corruzione e del
finanziamento illecito». Molti anni dopo è doveroso riflettere su questo dato.
In un’Italia che festeggiava, come liberata dall’invasore, l’azione dei pm che
annunciavano di dovere «rovesciare il Paese come un calzino», c’era chi,
abbandonato in un cono d’ombra con le proprie paure e i propri rimorsi, decideva
di non poter sopravvivere in questo mondo sottosopra. La sensazione di uno
smottamento complessivo era tangibile. A dicembre del ’93, un anno dopo il primo
avviso di garanzia a Craxi e un anno prima dell’addio di Di Pietro alla toga,
Saverio Borrelli accettò di darmi una delle tre interviste che, in nemmeno dieci
mesi, gli avrebbero attirato l’astio di una bella fetta di mondo politico o di
ciò che ne sarebbe rimasto. Mancava poco alle nuove elezioni legislative, che si
sarebbero poi tenute a marzo del ’94. I partiti tradizionali affogavano, Achille
Occhetto pensava di avere tra le mani una «gioiosa macchina da guerra», sui muri
delle grandi città erano apparsi manifesti misteriosi con bambini su sfondo
azzurro che balbettavano teneramente uno slogan: «Fozza Itaia». Alla domanda
«non temete di influenzare pesantemente il voto?», Borrelli mi rispose: «Vorrei
rilanciare la palla sull’altra sponda, a chi farà politica domani: prendete
consapevolezza di questa situazione, dico io. Chi sa di avere scheletri
nell’armadio, vergogne del passato, apra l’armadio e si tiri da parte. Tiratevi
da parte prima che ci arriviamo noi…». È difficile capire perché un magistrato
introverso, che da ragazzo si sognava pianista e aveva indossato la toga solo
cedendo al padre, uno che se n’era stato zitto fino ai sessant’anni e oltre,
decidesse di colpo di uscire allo scoperto così clamorosamente. Può darsi, come
insinuano molti, che le luci della ribalta abbagliarono l’antico giurista
secchione. Può darsi anche, però, che il procuratore sentì davvero come compito
suo quello di esporsi per mettere al riparo i propri sostituti: la sua
successiva uscita di scena, in punta di piedi, con il solo incarico di
presidente dell’amato Conservatorio di Milano che poi gli sarebbe stato tolto
dalla Gelmini senza troppi complimenti, farebbe propendere per questa seconda
ipotesi. Alcuni eventi avevano infatti caricato sulle spalle dei magistrati
milanesi un fardello pesante come mai. Nell’inchiesta erano entrati la Fininvest
di Berlusconi e il Pci-Pds, e i fascicoli relativi avevano portato uno strascico
ideologico inquinante. Il filone delle tangenti rosse venne affidato a Tiziana
Parenti, detta Titti, che subito puntò sul tesoriere Pds Marcello Stefanini per
le mazzette che sarebbero state versate dal gruppo Ferruzzi a Primo Greganti. In
galera, il «compagno G.» ruppe lo schema confessione-scarcerazione e non disse
una parola sul suo partito, accreditando ulteriormente l’idea di una certa
diversità comunista. Titti non aveva grande esperienza, pareva spaesata nella
macchina ormai rodata del pool, dal suo buen retiro all’Elba accusò i colleghi
più anziani di «isolarla»; il tifo della stampa di destra non l’aiutava di
certo. L’avviso di garanzia a Stefanini fu il punto di non ritorno nella crisi
dei suoi rapporti con D’Ambrosio, incaricato di sovrintendere a questo filone e
da sempre sospettato di essere troppo tenero con Botteghe Oscure. Le accuse
reciproche di avere voluto affossare o salvare gli ex comunisti accompagneranno
entrambi: Titti avrà un seggio con Forza Italia e poi mollerà la politica,
D’Ambrosio è attualmente un senatore del Partito democratico. È ormai il tempo
dei grandi latitanti. Il 7 febbraio del ’93 si consegnerà a Di Pietro, appena
varcato il valico di Ventimiglia dopo mesi trascorsi in Polinesia, Silvano
Larini, l’architetto amico di Craxi, l’uomo delle notti al Giamaica di Brera,
detentore di uno dei segreti più resistenti della storia repubblicana: il
mistero del conto Protezione, numero 633369 sull’Ubs di Lugano, spuntato per la
prima volta oltre dieci anni addietro dalle carte della P2 di Licio Gelli. Il
conto è sempre stato suo, spiega, ma Craxi, accompagnato da Claudio Martelli,
durante una passeggiata tra corso di Porta Romana e piazza Missori, nell’autunno
dell’80, gli chiese di prestarglielo per operazioni di finanziamento all’estero:
i primi tre milioni e mezzo di dollari arrivarono il mese stesso, altrettanti
furono accreditati a febbraio dell’anno successivo. La via della latitanza
l’aveva presa anche Giovanni Manzi. Meno picaresco dell’architetto, Manzi era
presidente della società aeroportuale e soprattutto veniva considerato uno dei
grandi collettori delle tangenti socialiste. A metà gennaio, pochi giorni prima
della resa di Larini, Ettore Botti nel suo ufficio da capocronista del Corriere
ebbe una dritta buona da Adriano Solazzo, il decano dei cronisti giudiziari,
ormai pensionato ma sempre informatissimo: Manzi era stato visto qualche
settimana addietro a Santo Domingo, puerto escondido dei fuggiaschi di mezzo
mondo. Ettore volle mandare me, che avevo pochissima esperienza di estero. Il
direttore Paolo Mieli mi mise accanto Alessandro Sallusti, a quel tempo
formidabile collega dell’ufficio centrale. Sandro e io partimmo con l’incarico
di trovare almeno una foto, una ricevuta, insomma una prova non taroccata del
passaggio di Manzi nell’isola dove vero e falso s’acquistavano per un pugno di
banconote. Sbarcati in quella specie di lunapark del sesso gremito di italiani
pieni di voglie, ci dividemmo andando dove vanno due cronisti che non sanno che
pesci pigliare: Sandro in ambasciata, io nel giornale locale. Entrambi con una
domanda cauta ma chiara: dove potrebbe sistemarsi un connazionale danaroso che
desidera riservatezza? La sera ci ritrovammo in albergo con la medesima
risposta: Casa de Campo, un resort di lusso con cinquecento ville, a un’ora e
mezzo di macchina dalla capitale. Ci mettemmo una settimana, villa dopo villa,
cancello dopo cancello, con un pacco di foto del «señor Giovanni» e un pacchetto
di dollari da distribuire ai giardinieri. All’ultima villa, quella giusta,
dietro un ennesimo cancello sbattuto in faccia, sentimmo parlare italiano.
Restammo acquattati nell’erba davanti al muro di cinta per tutta la mattina.
Quando Manzi ci mandò fuori il suo gigantesco guardaspalle, Julio, cominciò la
trattativa: avevamo ricostruito i suoi quattro indirizzi precedenti, Santo
Domingo era un’isola cara ai socialisti, se voleva lasciar fuori chi l’aveva
aiutato doveva incontrarci. La mattina 26 27 dopo «el señor Giovanni» si lasciò
intervistare nel nostro albergo. I poliziotti non l’avevano trovato per mesi;
due giornalisti qualsiasi, venuti da Milano, ci misero sette giorni. Fu uno
scandalo, i dominicani non poterono più far finta di nulla: dovettero
arrestarlo, rimpatriarlo. Manzi scese dall’aereo a Malpensa e trovò i
carabinieri, noi trovammo Botti che «corrompendo» il personale di terra era
venuto a prenderci sotto la scaletta dell’aereo per festeggiarci. Quell’autunno
gli italiani guardarono in diretta tv il disfacimento dell’Italia sino ad allora
conosciuta. Il 28 ottobre Di Pietro portò in aula, per la tangente Enimont,
Sergio Cusani: tutte le udienze furono trasmesse dalla Rai in una infinita soap
opera che registrò ascolti clamorosi. Bocconiano, ex leader del Movimento
studentesco, amico personale di Gardini, Cusani era accusato di avere mediato
tra il patron della Ferruzzi e i politici. Non volendo tradire il rapporto con
Gardini, morto nel frattempo suicida, rifiutò di collaborare coi pm e mantenne –
tra i pochi – un atteggiamento di grande dignità, scegliendo il difensore più
lontano per storia e attitudine dagli «avvocati accompagnatori »: Giuliano
Spazzali, un passato in Soccorso Rosso, vero antagonista della cultura del
pentimento catartico sottesa a Mani pulite. Decidendo di processarlo da solo, Di
Pietro volle trascinare alla sbarra in qualità di testimoni, e dunque con
l’obbligo di rispondere e dire il vero, i principali leader dei partiti che
finora erano sempre sfuggiti a un confronto diretto con lui grazie alle
guarentigie parlamentari. Processualmente, zero. Mediaticamente, un cataclisma.
Ne sortirono udienze memorabili. I milanesi facevano la fila nei corridoi del
tribunale per trovare posto in aula. Tutti, tranne l’orgoglioso Craxi, uscirono
con le ossa rotte. Il penoso farfugliamento di Arnaldo Forlani, incapace di
controllare la propria salivazione davanti alle telecamere, resta forse
l’immagine più imbarazzante di quel cambio di stagione. Di Pietro, esaltato
dalle tv e da firme importanti come Gian Antonio Stella e Paolo Guzzanti infine
apparse accanto a noi ragazzi a ritrarne il profilo, affinò il dipietrese,
cominciando a usare scientificamente frasi come «che c’azzecca?», entrate poi
nel lessico popolare. Quello, per lui, fu il vero diploma di laurea.
Quell’autunno gli italiani guardarono in diretta tv il disfacimento dell’Italia
sino ad allora conosciuta. Il 28 ottobre Di Pietro portò in aula, per la
tangente Enimont, Sergio Cusani: tutte le udienze furono trasmesse dalla Rai in
una infinita soap opera che registrò ascolti clamorosi. Bocconiano, ex leader
del Movimento studentesco, amico personale di Gardini, Cusani era accusato di
avere mediato tra il patron della Ferruzzi e i politici. Non volendo tradire il
rapporto con Gardini, morto nel frattempo suicida, rifiutò di collaborare coi pm
e mantenne – tra i pochi – un atteggiamento di grande dignità, scegliendo il
difensore più lontano per storia e attitudine dagli «avvocati accompagnatori »:
Giuliano Spazzali, un passato in Soccorso Rosso, vero antagonista della cultura
del pentimento catartico sottesa a Mani pulite. Decidendo di processarlo da
solo, Di Pietro volle trascinare alla sbarra in qualità di testimoni, e dunque
con l’obbligo di rispondere e dire il vero, i principali leader dei partiti che
finora erano sempre sfuggiti a un confronto diretto con lui grazie alle
guarentigie parlamentari. Processualmente, zero. Mediaticamente, un cataclisma.
Ne sortirono udienze memorabili. I milanesi facevano la fila nei corridoi del
tribunale per trovare posto in aula. Tutti, tranne l’orgoglioso Craxi, uscirono
con le ossa rotte. Il penoso farfugliamento di Arnaldo Forlani, incapace di
controllare la propria salivazione davanti alle telecamere, resta forse
l’immagine più imbarazzante di quel cambio di stagione. Di Pietro, esaltato
dalle tv e da firme importanti come Gian Antonio Stella e Paolo Guzzanti infine
apparse accanto a noi ragazzi a ritrarne il profilo, affinò il dipietrese,
cominciando a usare scientificamente frasi come «che c’azzecca?», entrate poi
nel lessico popolare. Quello, per lui, fu il vero diploma di laurea. Era pronto
all’ultimo grande salto, in politica. Il nuovo padrone dell’Italia, Silvio
Berlusconi, uscito trionfatore dalle elezioni del 27 marzo 1994, pensò di
offrirgli il trampolino del ministero degli Interni, invitandolo a parlarne a
Roma, in via Cicerone, nello studio di Cesare Previti. Tonino ha raccontato di
avere cortesemente rifiutato, avendo un lavoro da finire (quello di ripulire
l’Italia, evidentemente). Io ho sempre saputo che fu fermato in corsa da
Borrelli e da Davigo, altro oggetto dei desideri del nuovo centrodestra
berlusconiano. Il clima, tra politica e magistratura, era, se possibile, perfino
peggiorato. In un’intervista agli inizi di maggio, Borrelli mi disse che, ove
tutto fosse precipitato, loro avrebbero accettato un incarico di governo «se
Scalfaro gliel’avesse chiesto». Gli diedero del golpista. In realtà la risposta
venne dopo mie estenuanti insistenze e molte ipotetiche e subordinate, ma il
titolo uscì secco: essendo il procuratore un galantuomo, non smentì una virgola.
Ben più grave, dal punto di vista dei rapporti tra poteri dello Stato, il
pronunciamento di Di Pietro e dei suoi colleghi a luglio, che affossò il decreto
del neoministro Biondi sui limiti alla carcerazione preventiva: ancora e sempre
in diretta tv, si minacciarono dimissioni di massa, forzando la mano al
presidente Scalfaro che non firmò il decreto. La pausa estiva non placò le
acque. Tra governo e pm si andava allo scontro finale. Il 5 ottobre Borrelli si
lasciò intervistare di nuovo e mi disse che sarebbero arrivati «a livelli
altissimi». Si riferiva all’inchiesta su Telepiù, ma tutti lessero quella frase
come un preavviso di garanzia a Berlusconi. Che il Cavaliere fosse ormai nel
mirino era un segreto di Pulcinella. Quando successe ero a Roma, alla Camera:
Paolo Mieli mi aveva fatto inviato e spedito a seguire anche la politica, era il
21 novembre. Gianluca Di Feo, il mio socio di quegli anni, da figlio di
carabiniere qual era, capì che quel movimento di generali in procura non poteva
spiegarsi, come gli dissero, con la festa della Virgo Fidelis, protettrice
dell’Arma: sapeva che non erano quelli i giorni giusti. Si attivò così la
macchina dei nostri controlli, in poche ore Gianluca ed io arrivammo all’invito
a comparire che i pm di Milano avevano mandato a Berlusconi mentre presiedeva a
Napoli una conferenza mondiale sulla criminalità. Una storia molte volte
raccontata, compreso l’abbraccio con Mieli prima di andare a scrivere, il suo
scaramantico fondo di dimissioni pronto nel cassetto, la notte insonne che io e
Gianluca passammo nel timore di avere preso un abbaglio. Molte volte ci chiesero
chi fosse la nostra fonte. Gianluca e io siamo gli unici a conoscerne
l’identità. Non l’abbiamo ovviamente mai rivelata allora, anche protetti da un
direttore galantuomo come Mieli, non lo faremo certo adesso. Fece bene la
Procura a mandare quell’atto al presidente del Consiglio mentre era impegnato su
un palcoscenico mondiale? Penso di no. Dovevamo pubblicare la notizia noi,
quando l’avemmo? Sono sicuro di sì. Il resto non credo sia così importante in un
Paese che vent’anni dopo ancora non ha riportato il proprio tasso di corruzione
a livelli fisiologici. Pochi mesi fa, è tornata al disonore delle cronache
l’autostrada Milano-Serravalle. Fu uno dei piatti forti dell’estate 1992. Bruno
Binasco, un imprenditore ora indagato, lo era anche allora, sia pure come
braccio destro di Marcellino Gavio, che nel frattempo è morto. Con qualche
ragione, questo decano dell’intrallazzo racconta di avere conosciuto tutti i
politici. Tutti. Mani pulite non ci ha salvato, forse perché dovevamo salvarci
da soli. Dovremo farlo, prima o poi: per non restare ingabbiati altri vent’anni
in un déjà vu collettivo peggiore di qualsiasi galera.
Filippo Facci
su “Libero Quotidiano” racconta Mani Pulite: così Di Pietro diventò idolo.
Tangentopoli 20 anni dopo: murales, strisioni, titoloni dei giornali: un
carrozzone che ha reso il pm "meglio di Pelè". Ieri raccontavamo che i
cosiddetti principi del foro, con poche eccezioni, durante Mani pulite non
batterono chiodo. Non era sfuggito che avvocati poco noti, ma graditi ad Antonio
Di Pietro, erano i difensori di tutti i principali accusatori di Tangentopoli:
cambiare avvocato si traduceva in un cambio di atteggiamento e in una potenziale
svolta processuale, ergo si usciva dal carcere o neppure ci si entrava. Il
semi-sconosciuto Giuseppe Lucibello, compagno di bisboccia di Tonino, assunse
difese clamorose come quella del banchiere Pierfrancesco Pacini Battaglia. Anche
il democristiano Roberto Mongini, che di legali ne cambiò addirittura tre,
cambiò e cominciò a parlare. Uno come Salvatore Ligresti rimase in carcere per
cinque mesi sinché cambiò avvocati e fu subito liberato previo cambio di
atteggiamento. Autentica guerra di nervi fu poi quella combattuta da Michele
Saponara, presidente dell’Ordine degli Avvocati: il socialista Loris Zaffra, da
lui difeso, rimase a San Vittore per sei mesi sinché non dette incarico a un
altro e fu l’apriti sesamo. Eppure, fiutata l’aria, Zaffra era giunto a far
verbalizzare: «Non intendo avvalermi di un altro avvocato ». «La Procura»,
accusò Saponara, «fece sapere alla famiglia di Zaffra che se voleva tornare
libero doveva cambiare avvocato». A tal proposito, ascoltato dagli ispettori
ministeriali nel 1995, Saponara produrrà una testimonianza secondo il quale un
pm del Pool aveva urlato a Zaffra: «Se non cambia legale, si dimentichi di
uscire». Ma le accuse non trovarono conferma. Col tempo, e col progredire
dell’inchiesta, architrave di Mani pulite diverrà invece lo studio del professor
Federico Stella, eminenza grigia, difensore dell’Eni e futuro ghostwriter di
Antonio Di Pietro. Il professor Stella difese l’imprenditore Fabrizio
Garampelli, che con le sue confessioni spedì in galera praticamente chiunque
tranne se stesso; difese uno sterminato numero di dirigenti dell’Eni «buono» ed
elaborerà ben due proposte di legge per uscire da Tangentopoli, entrambe
appoggiate dal Pool: una a ottobre 1992, elaborata in seno all’Assolombarda, di
cui pure era difensore, e un’altra praticamente identica nel settembre 1994,
presentata in pompa magna alla Statale di Milano. A dispetto di queste
semplificazioni, comunque, in Mani pulite trovarono spazio anche avvocati con
posizioni più varie e sfumate. Quando L’Espresso nella primavera 1993 pubblicò
una specie di hit parade degli avvocati di Tangentopoli (titolata «Primo Bovio,
ultimo Chiusano») il presunto vincitore, Corso Bovio, scrisse così al
settimanale: «La qualità di un avvocato non si misura dalla durata della
carcerazione... Credo che la sua funzione sia quella di far rispettare la
dialettica del processo. Mi autoassolvo, ma non sento di assolvere il mio
ruolo... Perry Mason non è famoso perché pilota le confessioni o patteggia le
pene. Oggi sono vincenti l’inquisizione, il pentitismo, lo Stato di Polizia con
le sue manette e le sue galere». Intanto il pool proseguiva con una
tripartizione precisa: Di Pietro interrogava, Colombo spulciava le carte e
Davigo vergava le richieste di autorizzazione a procedere. Italo Ghitti invece
autorizzava gli arresti «privilegiando la rapidità al cesello», come dirà
Colombo. Dirà invece Di Pietro, appena più grezzo: «Io andavo dai colleghi e
segnalavo un’operazione che mi puzzava. "Vedi che cosa è successo qui?" Questo
secondo me è un reato di porcata... Cari Davigo e Colombo, cavoli vostri, entro
domattina trovate una soluzione che dal punto di vista giuridico non faccia una
piega perché non voglio rischiare una sconfitta dal tribunale della Libertà”».
Traduzione: io lo metto dentro, il come e il perché trovatelo voi. Ha raccontato
Primo Greganti, storico inquisito comunista: «Avevano emesso un mandato
d’arresto illegittimo. Ma, dopo aver ammesso l’errore, Di Pietro mi disse:
“Adesso vado da Davigo, e vedrai che lui un motivo per tenerti dentro lo trova”.
Fatto sta che tornai in cella per altri ventisei giorni». A Di Pietro era
permesso tutto, anche perché si avviava a divenire un eroe nazionale: partecipò
alla festa della Polizia e l’applaudirono per due minuti. Il suo status era
cambiato in un niente: gli avevano riverniciato la stanza, aveva quattro
scrivanie, tre computer e due poltroncine girevoli in similpelle. Gli giungevano
migliaia di lettere da tutt’Italia, soprattutto immaginette sacre e santini di
Padre Pio, e la sera le portava a casa per leggerle al figlio. Il Corriere della
Sera, nella sola settimana dal 7 al 15 maggio, sfoderò questi titoli: «Il pm
contadino, quasi un eroe», «La domenica tranquilla dell’eroe», «Il fascino
discreto dell’uomo onesto». Il dipietrismo nacque ufficialmente in maggio. La
prima scritta era stata individuata nel parcheggio dello stadio di San Siro: «Di
Pietro, sei meglio di Pelè». Poi un «Grazie Di Pietro» in via Manin e poi lo
striscione «Di Pietro sindaco» ancora a San Siro. E così via. «La rabbia degli
onesti corre sui muri» titolò l’Unità del 10 maggio. A metà del mese ecco la
prima fiaccolata pro Di Pietro con cabaret finale a cura di Lella Costa, David
Riondino, Paolo Rossi più una giovanissima Sabina Guzzanti. Il 30 maggio, su
Italia Uno, Gianfranco Funari nel suo programma «Mezzogiorno italiano» fece
partire uno spot quotidiano con immagine di Di Pietro che camminava e una voce
di sottofondo che lo incitava: «Vai avanti... vai avanti...». Anche la strage di
Capaci registrò il tentativo di sfruttare la morte di Falcone per portare acqua
a Mani pulite. Il magistrato morì un sabato, e lunedì 25 maggio «la Repubblica»
uscì in edizione straordinaria col titolo «L’ultima telefonata con Di Pietro».
La morte del magistrato siciliano ebbe il potere di accelerare l’elezione del
presidente della Repubblica dopo un interminabile gioco di fumate nere, veti e
contro-veti. Il 25 maggio elessero Oscar Luigi Scalfaro, sponsorizzato da Marco
Pannella e Bettino Craxi, che non se ne pentiranno mai abbastanza. Dopo le
tormentate elezioni di Giorgio Napolitano e Giovanni Spadolini alla Camera e al
Senato, anche la corsa per palazzo Chigi s’avviava a conclusione: «Craxi»,
sussurravano tutti. Ma la sera del 3 giugno la notizia era un’altra: «C’è anche
il nome di Craxi nell’inchiesta sulle tangenti» disse il Tg1. Di Pietro precisò:
«Allo stato il mio ufficio non ha rilevato nulla di penalmente rilevante che
possa riguardare la famiglia Craxi». Allo stato, Craxi non sarebbe stato
presidente del Consiglio, punto. La sua parabola si fece discendente anche se il
3 luglio pronunciò un discorso alla Camera destinato a passare alla Storia,
parole che per buona parte riverserà in un altro discorso che pronuncerà il
successivo 29 aprile 1993, giorno precedente all’assedio dell’Hotel Raphael.
Craxi chiese al Parlamento di assumersi le proprie responsabilità per trovare
una soluzione politica alla crisi della Prima Repubblica. Lo fece quando
mancavano quasi sei mesi a un suo coinvolgimento effettivo in Mani pulite, e
quando l’eventualità che potesse essere inquisito pareva semplicemente
impensabile. Racconterà il segretario amministrativo della Dc Severino
Citaristi: «Dissi a Forlani che era il momento di prendere posizione, ma
invano». Secondo Giovanni Pellegrino, Pds, allora presidente della giunta per le
autorizzazioni a procedere del Senato, «Quando Craxi fece quel discorso c’era
ancora qualche margine per fare almeno delle riforme che consentissero di uscire
dal pantano, ma non se ne fece niente perché Occhetto aveva altri programmi:
pensava che il Pds sarebbe uscito indenne e che gli altri partiti sarebbero
stati cancellati dalla geografia politica». Agosto fu il mese dei tre corsivi
sull’«Avanti!» vergati da Bettino Craxi. Il segretario socialista il 23 la mise
giù dura: «Col tempo potrebbe persino risultare che il dottor Di Pietro è
tutt’altro che l’eroe di cui si sente parlare, e che non è proprio oro tutto
quello che riluce». Senza farla tanto lunga: il poker di Craxi non era un bluff,
tutte le carte - Mercedes svendute, frequentazioni, prestiti eccetera -
verranno calate negli anni successivi e saranno decisive per le dimissioni di Di
Pietro dalla magistratura. Ma allora non c’era neanche il tavolo per giocare. Di
fatto, per qualche tempo, fioccarono le scarcerazioni: «Come mai», notò anche il
Corriere della Sera, «Di Pietro rinuncia alla sua proverbiale risolutezza?
Perché una linea tanto morbida?» Se lo chiese anche Gherardo Colombo: «È
successo che tornando dalle ferie estive dissentisse su iniziative di
Piercamillo e mie in tema di custodia cautelare... Ciò si verificava
contestualmente al fatto che la stampa avesse avuto da ridire su alcuni aspetti
dell’indagine». Ma forse, a contribuire a una certa cautela, il 3 settembre era
stato anche il terribile suicidio del deputato socialista Sergio Moroni. La sua
toccante lettera spedita al Presidente della Camera, letta al Tg2 e pubblicata
da tutti i giornali, denunciava un clima da caccia alle streghe e risvegliò
qualche orgoglio parlamentare. Ma erano colpi di coda. Il 19 settembre il
cassiere socialista Vincenzo Balzamo passò da Palazzo di Giustizia e fu preso
d’assalto dai cronisti: e nessuno di loro ricorda quel giorno con particolare
orgoglio. Ma la sindrome era tale che L’Avanti!, poco tempo dopo, titolò
«Querci: ho dato 400 milioni a Balzamo» quando nessun altro giornale fece
altrettanto, anche perché Balzamo intanto era sul letto di morte. Il 2 novembre
fu stroncato da un infarto e l’Indipendente titolò in prima pagina «Balzamo,
infarto da mazzetta». Quello stesso giorno altri giornali titolavano invece «Di
Pietro in autostrada soccorre una ferita» e resta il fatto che tutte le accuse
contro il segretario amministrativo del Psi, di lì poi, sarebbero state deviate
su Craxi.
Filippo Facci
su "Libero Quotidiano. Mani Pulite vent'anni dopo: Tangentopoli? E' finita
per coprire Tonino Di Pietro. Il leader Idv di dimise alla fine del 1994,
spaventato dall’ispezione ministeriale: aveva troppe cose da nascondere. Sono in
pochi ad avere il coraggio di dire la verità (tutta) circa la fine di Mani
pulite: perché è una verità che non serve a nessuno. Non serve a quei manettari
professionali che hanno sempre bisogno di prefigurare un'elite disonesta e
vessatoria (in genere politica) che a loro dire lucra su una maggioranza onesta
e vessata, ciò che un tempo avrebbero chiamato società civile. Non serve ai
partiti d'ampio respiro che vorrebbero rappresentare grandi fasce di
popolazione: troppo estese per poter rivendicare moralità e moralismi come
precetti-cardine. Non conviene alla magistratura più militante, tantomeno
conviene a quell'informazione che sullo sfondo della contrapposizione
casta/cittadini si illude di raschiare eternamente copie e ascolti. Sicché
circolano scampoli di verità. Mani pulite finì perché Antonio Di Pietro si
dimise alla fine del 1994: il neogoverno berlusconiano gli sventolò un'ispezione
ministeriale davanti al naso e poi, un secondo dopo che si era dimesso, la
richiuse; Di Pietro ammise pubblicamente di essere rimasto condizionato
dall'ispezione - se non ricattato - talché si dimise dopo averne saputo la
chiusura, e però intanto continuò a spiegare al mondo che non aveva niente da
nascondere. Un sostanziale baratto, un affare in cui ciascuno pensava di fottere
l'altro: da una parte perché Di Pietro da nascondere aveva un sacco di cose
(tutte nero su bianco nella sentenza del Tribunale di Brescia n.65/1997 del
29.1.1997, dove si spiega che certi suoi comportamenti gli avrebbero fruttato
perlomeno dei provvedimenti disciplinari) e dall'altra perché le sue ambizioni
politiche erano stagliate da un pezzo, e lo si è visto. E perché? Perché «Mani
pulite è finita, i tempi sono cambiati, non c’è più acqua nel mulino delle
indagini, voglio scendere da cavallo prima di essere disarcionato»: così aveva
confidato al gip Italo Ghitti nell'aprile precedente. Senza un certo clima, poi,
Di Pietro valeva poco: e lo dimostra quando accadde al Pool dopo l'abbandono. Pm
come Paolo Ielo ed Elio Ramondini tentarono di riesumare, concludere, archiviare
o smistare procedimenti che erano stati l'architrave di Mani pulite: ma che
erano rimasti un po' così, sospesi in quella fase preliminare dominata dagli
interrogatori di Di Pietro, che in definitiva aveva portato sino in fondo solo
il processo-vetrina a Sergio Cusani e il processo Enimont che ne era il clone:
istruttorie semplici perché fondate perlopiù su confessioni. Ramondini e Ielo
ebbero l'ingrato compito di raccappezzarsi nelle montagne di faldoni di cui
soltanto Di Pietro conosceva una logica che spesso non c'era. Ramondini scoprì
che montagne di atti sulla Fiat erano preclusi alle procure di mezz'Italia. Ielo
perdette mesi per riordinare le carte dei filoni Pci-Pds, e quei pochi processi
che si sono conclusi si devono a lui. La vecchia guardia del Pool, invece,
puntava su Berlusconi: e questo convinceva pochissimo una larghissima fetta di
Paese. Lo scenario era stava cambiando. Prima c'era Di Pietro che martellava,
mentre agli altri pm, come dirà Francesco Greco, «competeva un lavoro di
ricostruzione successivo agli interrogatori... ma la situazione si è modificata
nel corso del 1994 quando le collaborazioni diminuirono fino a cessare. Fu lo
stesso Di Pietro a dire che non arrivava più acqua al suo mulino, la tecnica
investigativa cambiò». L'acqua, a dirla tutta, arrivava al mulino direttamente
dal carcere. Era il carcere, irrogato o temuto, che stimolava le collaborazioni.
Era il carcere, coi suoi effetti, che era venuto a mancare durante quel cambio
di stagione che Tonino aveva subodorato. E' quasi divertente come i colleghi
Barbacetto e Gomez e Travaglio, nel loro tomo «Mani pulite», appena rinfrescato,
cerchino di dissimulare questa verità elementare: «Fin dai primi interrogatori,
per una fortunata e forse irripetibile somma di abilità investigative,
situazioni psicologiche e condizioni politiche, economiche e ambientali, i
magistrati si trovano davanti persone che presto o tardi finiscono per
confessare». Cioè: confessavano perché erano in galera e volevano uscire.
Confessavano perché non volevano finirci, bene che andasse. Erano quelle le
«situazioni psicologiche»: le altre, «politiche, economiche e ambientali»,
fecero parte del contesto «irripetibile» che permise un uso spropositato delle
manette. La prassi di Mani pulite, sin dall'inizio, aveva ipotizzato reati i più
gravi possibili così da giustificare ogni volta la carcerazione preventiva:
questo anche per violazioni di tipo amministrativo come il noto finanziamento
illecito dei partiti. Per capirlo, in fondo, è sufficiente guardare quanti dei
1230 condannati di Mani pulite abbiano subito delle carcerazioni preventive a
dispetto di pene poi risultate inferiori ai due anni, condanne ossia a
cosiddette pene sospese, con la condizionale: quasi tutti. E' noto: effettive
condanne al carcere, alla fine di Mani pulite, praticamente non ce ne sono
state. Eppure la regola è sempre stata chiara: tizio, se è presumibile che sarà
condannato a meno di due anni, in carcere preventivo, non ce lo dovresti
mettere; certo, la regola implica una capacità «prognostica» - direbbe un
tecnico - di prevedere a quanti anni Tizio sarà probabilmente condannato: tra i
compiti del magistrato c'è anche il cercare di presumerlo. Diciamo che il Pool
ha sempre presunto molto male. Di Pietro ne era maestro da sempre: sparare reati
incredibili e sbattere dentro perché tanto, per derubricare un reato, c'era
sempre tempo. Il clima manettaro che aveva permesso ogni cosa, dalla fine del
1994 e con le dimissioni di Di Pietro, scomparve. Dall'altra parte, bene o male,
c'era una classe politica rinnovata e legittimata, non è che il Pool avrebbe
potuto respingere a vita tutte le norme del Parlamento. Dall'estate 1994,
oltretutto, molti indagati dell'inchiesta sulle Fiamme Gialle (e su Berlusconi)
non avevano collaborato neppure se carcerati: perché erano militari, forse, o
perché non vollero e basta. Capitò anche con la Fininvest: del resto
collaborare, assecondare l'accusa, non è obbligatorio. Dirsi innocenti, o
crederlo, o addirittura esserlo, è ancora possibile, è lecito: e non per questo
si marcisce dentro, nei paesi civili. Nei paesi civili si va in galera dopo una
condanna, non prima. E si attende il processo con la prospettiva di finirci, non
di uscirne. Da qui la svolta spiegata dal pm Francesco Greco: «Dopo le
dimissioni di Di Pietro cominciammo a lavorare prevalentemente su documenti e
con altre tecniche, quali intercettazioni telefoniche ed ambientali, in
precedenza trascurate in quanto non necessarie». Non necessarie perché c'era il
carcere. Ora, invece, potevano e dovevano ricominciare a lavorare come dei
magistrati normali. Ma questi sono scampoli di verità, come detto. La verità
tutta, per dirla male, anzi malissimo, è che troppa gente rimase insospettita
dal mancato coinvolgimento dei vertici del Pci e viceversa dalla pervicacia con
cui si puntava su Berlusconi. Ma detta un po' meglio, il vero problema non fu la
serpeggiante impressione che Mani pulite fosse ormai agli sgoccioli: stanca,
talvolta astratta, con tutti quei cronisti che ciondolavano per i corridoi
facendosi domande sul proprio futuro. Altri colpi di scena, del resto, non
sarebbero mancati. Il problema, come il Pool non comprese per forma mentis, fu
che l’inesorabile fine di una stagione non potè non coincidere con l'indagine
sulla Guardia di Finanza. Quegli imprenditori che cominciarono a confessare
d’aver pagato anche i finanzieri, perché chiudessero un occhio, fu l'inizio di
una voragine che in potenza non avrebbe mai avuto fine. Un reparto accusò
l’altro, un reparto arrestò l’altro. Intere legioni di militari finirono in
carcere e alcuni erano collaboratori del Pool: qualcuno arrestato, qualcuno
suicidato. Quell’immagine di finanzieri che iniziavano ad arrestarsi tra di loro
divenne la metafora di un Paese che si stava divorando. Onesti e disonesti,
concussi e concussori, taglieggiatori e vittime: parole sempre più svuotate di
significato, termini utili per delimitare, secondo fazione, le proprie simpatie
e i propri interessi. Nel Paese in cui tutti pagavano tutti si scoprì che,
poveretti, gli agenti della Guardia di Finanza incassavano mazzette perché
avevano stipendi da fame, e trescavano con l’esercente che, poveretto, senza
fatture false avrebbe chiuso bottega, e trescavano col grande stilista che,
poveretto, senza fatture false la bottega non l’avrebbe neanche aperta. La
famosa dazione ambientale, che da lontano e sui giornali pareva solo
un’associazione per delinquere, era vicina, vicinissima: dal fiscalista, dal
commercialista, dal certificatore di bilanci, dall’impiegato comunale e
regionale e statale, dall’avvocato, dal notaio, in negozio, al bar, nelle
famiglie, con la domestica, nel 740, nello scontrino che non ti hanno dato, ma
che tu non hai preteso. La cosiddetta inchiesta «Fiamme sporche» contò centinaia
e centinaia di indagati ma comincerà a trasfigurare lo spettacolo di Mani pulite
agli occhi del suo pubblico, a confondere proscenio e platea, a disamorare
progressivamente da un'ubriacatura legalitaria ormai triennale e che dapprima
era parsa tuttavia così liberatoria, espiatoria, deresponsabilizzante. Poi non
più. Dirà anni dopo Francesco Saverio Borrelli: «L’atteggiamento dell’opinione
pubblica cominciò a cambiare più o meno in coincidenza con l’indagine sulla
Guardia di finanza... finché si trattò di colpire l’alta politica e i suoi
rappresentanti, i grandi personaggi dei partiti che stavano sullo stomaco a
tutti, non ci furono grandi reazioni contrarie. Anzi. Ma, quando si andò oltre,
apparve chiaro che il problema della corruzione non riguardava solo la politica,
ma larghe fasce della società, insomma che investiva gli alti livelli proprio in
quanto partiva dal basso». Dirà pure Piercamillo Davigo: «Le vicende che mi
hanno più depresso sono le piccole vicende. Mi sono capitati processi dove
centinaia di persone hanno pagato somme di qualche milione per non fare il
servizio militare. Centinaia di persone... Eppure tutti i giovani venivano da
buone famiglie che li finanziavano, perché a diciannove anni non si hanno dei
milioni cash nel portafogli. Questo la dice molto lunga sulla diffusione di
certi comportamenti e sulla valutazione che di essi viene data nel complesso
della società». La ciliegina finale è a cura di Enzo Carra, ex portavoce
democristiano (ora all'Udc) che proprio Davigo aveva fatto condannare: «Mani
pulite fu un piccolo squarcio nei nostri vizi pubblici e privati; poteva essere
una grande occasione per metterli sotto accusa, questi vizi, insieme ai corrotti
e ai corruttori. E’ stata una grande occasione mancata per cambiare le regole e
i comportamenti nella nostra società... Con un’eccezionale prova
dell’italianissima arte di arrangiarsi il cammino è ripreso come prima, o
quasi... Invece di cambiare sistema si è cambiato discorso». Non c'è molto altro
da aggiungere.
Filippo Facci
su "Libero Quotidiano": Eccessi e le forzature che stravolsero Mani Pulite.
Vent'anni dopo. I pm di Milano hanno calpestato l'articolo secondo cui solo in
aula una testimonianza diventa prova. La verità è che il Pool di Milano era
assortito fantasticamente e fu insuperabile nel fare ciò che volle fare. Di
Pietro. Davigo. Colombo. Borrelli. Poi Ielo e Greco. Un po' meno D'Ambrosio, che
in realtà non faceva un tubo se non dichiarazioni disastrose. Resta che per
abbattere una Repubblica - che non è, in genere, un compito del potere togato -
il Pool e tutta la magistratura stravolsero o sovra-interpretarono il Codice di
procedura penale varato nel 1989: lo neutralizzarono e poi ridestarono come un
frankenstein inquisitorio/accusatorio. A un Di Pietro usato come ariete (le
manette come regola) si affiancò infatti una contro-legislazione operata
dall’alto: alcune sentenze della Corte costituzionale (su tutte la 255/92) e
una legge suicida (il Decreto Scotti-Martelli) ristabilirono lo strapotere
delle indagini preliminari; ai pm era sufficiente estrarre verbali
d’interrogatorio e riversarli in processi che non contavano più nulla, ridotti a
vidimazioni notarili delle carte in mano all’accusa. La loro totale
discrezionalità dipendeva perlopiù dalla loro buona o cattiva disposizione,
dalle trattative ossia che l’indagato fosse disposto ad accettare pur di uscire
dal procedimento o dalla galera preventiva: colpevole o innocente che si
ritenesse. Le condanne di Mani pulite (si parla di Milano) nacquero in
maggioranza da patteggiamenti e riti abbreviati: 847 su 1254, esiti che erano
stati ottenuti quando il carcere preventivo era la regola e quando nelle
indagini tutto si esauriva, complice la stampa e le sue storture. Tutti quei
nuovi riti erano divenuti le scorciatoie pagate a caro prezzo da chi aveva
voluto uscire dal tritacarne giudiziario, dal Rito ambrosiano: ma tutto erano
fuorché normalità, soprattutto per chi non era disposto a starci. Forse non è un
caso che tra i 1320 indagati che il Pool spedì ad altre procure competenti il
numero dei proscioglimenti fu altissimo. Tutta gente non colpevole ma che non
figura, però, nella casistica ufficiale di Mani Pulite, come se Milano avesse
teso a sbarazzarsi delle posizioni scomode e indisponibili alla confessione
liberatoria. Si dovrà aspettare anni perché una riforma elementare ristabilisca
un principio chiave che Mani pulite aveva fatto a pezzi: l'articolo 513, quello
in base al quale solo nel processo una testimonianza può diventare una prova,
non nel parlatorio di un carcere o in una caserma di polizia. Esattamente come
accade nei film americani, dove tutto ciò che non avviene durante il processo,
semplicemente, non esiste. In una sentenza bresciana che trattava delle
omissioni di Mani pulite - sentenza favorevole a Di Pietro - il giudice fu
costretto a scrivere che «le mancanze di approfondimenti rilevate appaiono del
tutto in linea con i già evocati frenetici ritmi di lavoro che connotarono la
prima fase di Mani Pulite». Chiamato a testimoniare, il pm Francesco Greco la
mise così: «Difficilmente in Mani pulite i filoni investigativi venivano
approfonditi oltre un certo livello, perché non c’era il tempo per farlo.
Scoperto un episodio si andava a quello dopo». Il Pool era composto da gente
cazzuta e competente, ma Mani pulite per certi aspetti fu un’indagine
superficiale in cui la velocità primeggiò sulla qualità e sull’accuratezza. I
magistrati sceglievano gli obiettivi a seconda delle possibilità del momento, e
fu Francesco Saverio Borrelli a parlare di «Blitzkrieg»: «Era la guerra lampo
tipica degli eserciti germanici, una penetrazione impetuosa su una fascia molto
ristretta di territorio, lasciando ai margini le sacche laterali». Il Pool agiva
allo stesso modo: «Tendeva ad arrivare rapidamente ad assicurarsi risultati
certi, lasciando ai margini una quantità di vicende da esplorare in un secondo
momento». Il punto è che i risultati giunsero perciò in un secondo momento
(quando giunsero) oppure dal 1994 in poi, quando la stampa e il Paese già
pensavano ad altro. Le carte che dimostrano come il Pds si finanziò in maniera
illecita, per fare l'esempio più clamoroso, diventarono migliaia in tutto lo
Stivale: ma non se ne accorse nessuno, perché nella fase più calda ed efficace -
quando tutto era possibile, forzature comprese - il Pool si era concentrato sul
Psi e sulla Dc. Il Pci-Pds si salvò anche per questo. Il Pool di Milano fece
delle scelte. Forse non poteva evitarle, ma le fece, e questo contribuì a
scrivere una storia perlomeno parziale. Per descrivere i singoli casi (segretari
di partito abbattuti o neppure sfiorati, imprenditori salvati e altri suicidati,
Eni buono ed Eni cattivo eccetera) non basterebbe un libro, ma il vizio
d'origine è riscontrabile sin dai primi mesi dell'inchiesta, quando si propinò
la favoletta degli imprenditori concussi e dei cattivi concussori, cioè i
politici. Il 28 novembre 1992, a botta calda, il famoso Mario Chiesa fu
condannato a sei anni e sei mesi e sei miliardi da restituire: il 160 per cento
dei soldi ricevuti; mentre Fabrizio Garampelli, il concusso, difeso da legali
graditi all'accusa, dovette rimborsare solo il 15 per cento senza che frattanto
avesse mai smesso di lavorare: la sua azienda vinceva gli appalti del Pio
Albergo Trivulzio da vent'anni - con ogni presidente - e continuò a farlo. Altri
imprenditori se la cavarono con meno di due anni e la condizionale. Dirà lo
stesso Mario Chiesa: ««Tangentopoli non nasce solo per la prepotenza dei
politici. Di imprenditori estorti non c’è nemmeno l’ombra... corruttori pronti a
prendere calci nel culo, a subire ogni vessazione, sempre pronti a presentarti
ventisette donne pur di non uscire dalla loro nicchia ed evitare di misurarsi
col libero mercato... Una logica da gironi danteschi: nel primo c’erano le
imprese garantite per i lavori a cavallo del miliardo, nel secondo quelle per
opere sui tre miliardi... sino alla Cupola, sei o sette imprese che si
riuniscono e pianificano investimenti e leggi ad hoc per dividersi gli appalti
secondo una logica mafiosa». Confermerà, molti anni dopo, Piercamillo Davigo:
«Le imprese si sono sempre giustificate dicendo che erano state costrette a
farlo, che erano concusse, ma quello che si è appurato nei processi o nei
patteggiamenti, con le innumerevoli condanne, mi fa propendere per l’altra
ipotesi, quella di una prevalente corruzione. Anche perché, molte volte, al
versamento delle tangenti si accompagnavano sistematiche pratiche di alterazione
delle gare attraverso gli accordi tra le imprese stesse. Insomma, molti
imprenditori costituivano una categoria di soggetti abituati a vivere di
‘protezione’, al riparo della concorrenza, con un mercato privilegiato in cui
gli appalti venivano suddivisi e spartiti al loro interno; in questa situazione
il costo delle tangenti era rappresentato, a ben vedere, da cifre tutto sommato
modiche rispetto ai benefici che se ne ottenevano». Mani pulite è anche questo,
anzi, fu soprattutto questo, un'inchiesta giudiziaria che ebbe conseguenze
politiche alla cui ombra potè accadere ogni cosa. E per forza: il Paese, agli
albori del 1993, era un groviglio di manette, di malcontento e di retorica.
Retate ad Ancona, Vercelli, Bergamo, Monza, in tutte le città d'Italia. Una
manifestazione contro la manovra economica degenerò in scontri con 60 feriti.
Gli scioperi fiorirono dappertutto e vennero contestati i sindacati. La Lega
invitò a non acquistare i Bot, fallì un attentato contro la sede della
Confindustria, scesero in piazza i commercianti contro l'annunciata minimum tax.
Al segretario della Cisl, Sergio D’Antoni, tirarono un bullone in testa.
Arrestarono l'intera giunta regionale dell’Abruzzo e l'intera giunta comunale di
Vercelli. Ma è impossibile, ora, spiegare lo scenario in cui scivolavano le
inchieste di quel periodo, ed è ancor oggi impossibile trovare un filo comune
tra accadimenti che mozzavano il respiro: la bomba che il 14 maggio 1993 scoppiò
al quartiere Parioli di Roma, l'autobomba che il 27 luglio scoppiò a Milano in
via Palestro, le altre due l'indomani scoppiarono a Roma in piazza San Giovanni
in Laterano e a San Giorgio al Velabro. L'opinione pubblica e i mass media si
ritrovarono in un conformismo che si pensava smarrito. Durante il funerale delle
vittime di via Palestro si distinsero frasi come queste: «Metteteli tutti a pane
e acqua: la forca, ci vuole la forca!»; «Giuràtelo che li metterete tutti alla
forca!»; Di Pietro, fatti ridare i soldi che hanno rubato, devi sequestrare
tutto, hai capito?». Dopo quel paio di suicidi eccellenti che avevano calamitato
l’attenzione sui metodi della magistratura (Gabriele Cagliari e Raul Gardini) si
ripartì tranquillamente in quarta. Un sondaggio, elaborato dopo i suicidi,
spiegava che il 60 per cento degli italiani riteneva che la carcerazione andasse
bene così. Ormai la magistratura prendeva i contorni di un grande gendarme con
potere d’interdizione permanente su uomini e cose. Un faro accecante sul vuoto
della politica. Il mondo giornalistico intanto esplodeva in entusiasmi
conformisti di cui solo noi siamo capaci, come l'era Monti in parte dimostra. Il
settimanale «L’Europeo» regalava gli adesivi circolari «Forza Di Pietro»,
«Panorama» esaltava l’Italia «dei tanti Di Pietro che sono fedeli alle mogli,
una nuova specie di uomo». Chiara Beria di Argentine scriveva sull'Espresso
sempre su Di Pietro: «Un implacabile nemico delle mazzette, un giudice mastino
che interrompe i lunghi, estenuanti interrogatori offrendo Ferrero Rocher».
Maria Laura Rodotà scriveva su Panorama: «Il nuovo eroe italiano, il nuovo
modello, a grande richiesta... Di Pietro, eroe tranquillo, un role model, un
modello di comportamento italiano». Laura Maragnani scriveva su Donna: «Di
Pietro fa sognare anche le donne. Piace. Strapiace. C'è chi lo definisce un sex
symbol, un eroe per gli anni Novanta... Dicono di lui che sia duro, testardo, di
metodi spicci. E che sia onesto, onestissimo. Basta questo a farlo adorare alle
donne? O è merito anche del suo anti-look, del calzino corto che si ribella alla
tirannia sell'apparire?». Ah, saperlo.
Si è
tradito sulle manette facili ai tempi di Mani Pulite.
Il commento di Filippo Facci. L'ex pm ribatte alle accuse, ma finisce per
ammettere: non ho mai violato la legge, volontariamente. «Cosa può dirci dei
rapporti tra Craxi e Ligresti?». La domanda fu rivolta a Mario Chiesa pochi
giorni dopo il suo arresto (17 febbraio 1992, alba di Mani pulite) e peccato che
non c’entrasse un tubo con la faccenduola per cui Chiesa era stato arrestato. Ma
per almeno un anno, di lì in poi, la parola «Craxi» diverrà la parola più
ricorrente dell’intera inchiesta nonché «l’apriti sesamo» in grado di far
lasciare il carcere a chiunque si decidesse a pronunciarla, venendo così
incontro alle attese degli inquirenti. Ecco perché ci vuole un certo coraggio (o
semplice ignoranza o cattiva memoria, a distanza di vent’anni) per negare o non
ricordare che Bettino Craxi e il Psi siano stati palesemente l’obiettivo di Mani
pulite sin dal principio", spiega Filippo Facci su Libero in edicola oggi. In
questi giorni Antonio Di Pietro, uno dei grandi protagonisti di Tangentopoli, è
stato accusato di aver usato in modo scriteriato la carcerazione preventiva nel
corso dei giorni dell'inchiesta. E l'ex pm ribatte, ma si tradisce e finisce per
ammettere: non ho mai violato la legge, volontariamente. E infatti sono i numeri
a rivelare l'utilizzo politico che il pool fece delle manette. Per ogni reato -
questo il metodo - si ipotizzava l'affiliazione a un sistema per giustificare la
detenzione. E questo lo capirono tutti, non solo gli ex ambasciatori Usa (che
oggi, seppur post-mortem, lo accusano).
Cimici, furti,
spiate e bombe: quanti gialli nell'era del pool, scrive Filippo Facci su "Libero
Quotidiano". Nei primi anni di Mani pulite una trentina di case, uffici e studi
vengono «visitati» non si sa da chi. Tra questi quelli dei parlamentari Arnaldo
Forlani, Giorgio Postal (sottosegretario ai Servizi di sicurezza), Calogero
Pumilia, Riccardo Misasi, Calogero Mannino, Guido Carli (a quest’ultimo rubano
la chiave del suo studio privato al ministero del Tesoro), Gianni De Michelis,
Carmelo Conte, Rino Formica, Margherita Boniver (nei giorni in cui presentava
una relazione sul caso Moro), Carlo Vizzini, Alfredo Biondi, Giorgio Pisanò,
Silvia Costa, Gianfranco Macis (della Commissione stragi, sostenne che
cercassero alcuni documenti) e Giovanni Galloni (vicepresidente del Csm). Il 9
gennaio 1991 Vincenzo Parisi, ascoltato dalla Commissione stragi, afferma che
«vorrebbero fare dell’Italia una terra di nessuno». I Servizi segreti? «Escludo
quelli di casa nostra». Il 19 giugno 1991, giorno in cui si apprende del
trasferimento a Roma di Giovanni Falcone, viene visitato l’ufficio del ministro
della Giustizia Claudio Martelli. Il 19 marzo 1992 viene visitato l’ufficio
romano del ministro dell’Interno Vincenzo Scotti. Il 20 marzo 1992 viene
visitato l’ufficio del sottosegretario alla Difesa Clemente Mastella. Nello
stesso giorno viene visitato il monolocale del giornalista Michele Santoro. Il
16 marzo 1992 l’agenzia Ansa trasmette d’intesa la notizia di una circolare del
capo della polizia Vincenzo Parisi in cui si allertano i prefetti contro un
fantomatico piano mirante a destabilizzare le istituzioni. «In tale ottica»,
spiega Parisi, «potrebbero inquadrarsi l’intrusione notturna negli archivi della
Commissione parlamentare sul caso Bnl-Atlanta e la serie di furti e avvertimenti
a danno di periti, consulenti, difensori, giornalisti, ufficiali di polizia
giudiziaria connessi all’inchiesta condotta dal giudice Rosario Priore sul caso
Ustica». Dal giugno 1992 in poi circolò una quantità incredibile di verbali
falsi, «veline» e dossier anonimi. Tra il 5 e il 6 luglio 1992, ignoti
s’introducono nell’ufficio milanese di Bettino Craxi di piazza Duomo. Due porte
blindate vengono superate senza scasso ma non viene asportato nulla. L’inquilina
della porta accanto (peraltro, in quel periodo, intervistata da Piero
Chiambretti), uscita nottetempo in pianerottolo per via di alcuni trambusti
notturni, raccontò di essere stata così tranquillizzata: «Non si preoccupi,
Pubblica sicurezza». Episodio analogo due giorni dopo al Club Turati di via
Brera 18, dove Vittorio Craxi, figlio di Bettino, aveva un ufficio. Identiche
modalità di scasso nell’ufficio di un’associazione di cui era presidente Anna
Craxi. Visite notturne sono state denunciate anche da un legale di Craxi, Enzo
Lo Giudice, e dall’ex segretaria Enza Tommaselli. Il 5 febbraio 1993 una
telefonata annuncia una bomba nell’ufficio romano di Stefania Craxi e Marco
Bassetti. La Digos, intervenuta, non trova bombe ma, nell’appartamento
adiacente, rinviene un calco della serratura dell’ufficio. Negli stessi giorni
il deputato Dc Bruno Tabacci denuncia il ritrovamento di una microspia nella
tasca laterale della sua automobile. Nel marzo 1993 un inconoscibile personaggio
offriva materiale (fotocopie di assegni della Cassa di Risparmio di Torino,
tabulati, verbali di protesto) allo scopo di dimostrare che Giuseppe Davigo,
padre di Piercamillo, avesse emesso assegni a vuoto per decine di milioni nel
corso del 1992. Il 16 aprile 1993 l’avvocato Giuseppe Lucibello scopre una
microspia lungo il cavo telefonico del suo ufficio. Il 27 luglio 1993 bombe a
Milano e a Roma. Ventidue minuti dopo la mezzanotte, Palazzo Chigi rimane
telefonicamente isolato fino alle tre. Nel dicembre 1993 e nel gennaio 1994
vengono visitati gli appartamenti romani di due deputati leghisti. L’onorevole
Publio Fiori trova una «cimice» nella cornetta del telefono e un’altra viene
trovata più tardi dai tecnici intervenuti per la bonifica. Il 27 e 28 aprile
1995 vengono visitate le congregazioni di Piazza Pio XII e l’ufficio
dell’arcivescovo argentino Jorge Mejia. Spariscono vari fascicoli riservati.
Nell’agosto 1995 viene devastata e semidistrutta persino l’abitazione dello
scrivente, come regolarmente denunciato. Vengono asportati alcuni documenti
d’archivio. In un’altra visita del primo ottobre vengono asportati alcuni
floppy-disk. L’11 e 12 novembre 1995 vengono visitati gli uffici del dicastero
del cardinale Joseph Ratzinger e messi a soqquadro. Vengono inoltre saccheggiati
i cassetti del sottosegretario alla Congregazione monsignor Joseph Zlathansky
(contenevano dossier in copia unica sulle carriere degli ecclesiastici). Il 29
novembre 1995 viene visitato l’appartamento del parlamentare Giuseppe
Tatarella. Il 4 febbraio 1996 viene visitato l’appartamento di Marco Pannella.
Nello stesso periodo vengono visitati gli uffici di Willer Bordon e Clemente
Mastella. Nel febbraio 1996 si apprende che erano stati intercettati per
clonazione oltre duecento telefoni cellulari di politici, manager, giudici e
giornalisti. Tra questi: i parlamentari Gianni Letta e Adolfo Urso, l’ex
questore Achille Serra, alcuni dirigenti del Pds, della Rai, del Centro
nazionale ricerca, della Consob, il giudice Michele Coiro, un generale della
guardia di finanza e uno dei carabinieri, sette cronisti di La Repubblica e due
dell’Ansa. Il 21 marzo 1996 nell’appartamento del parlamentare Cosimo Ventucci
irrompono quattro uomini vestiti come poliziotti. Lo immobilizzano, maltrattano
la moglie e la figlia e spariscono senza asportare nulla. Il 6 luglio 1996 viene
visitato l’appartamento del parlamentare Roberto Maroni.
Chi ricorda
quando Pisapia sparava a zero su Di Pietro?.
Oggi costretti
a convivere, ma in passato il sindaco di Milano criticava Tonino: "Arresti per
le confessioni", scrive Filippo Facci su "Libero Quotidiano". Politica significa
scendere a patti col diavolo o addirittura con Di Pietro. Non esiste passato,
non esiste memoria: altrimenti mettere insieme tre personaggi come loro -
Antonio Di Pietro, Giuliano Pisapia e Bruno Tabacci - risulterebbe impossibile.
È vero, alla fine l’Italia dei valori non è entrata nella giunta milanese: ma
spunteranno altri incarichi, perché la politica è questo. Resta da chiedersi: ma
come fanno? Non si fa politica col risentimento, è vero, ma lo stesso: come
fanno? Cominciamo con Bruno Tabacci, uno che a poco più di trent'anni dirigeva
l'ufficio studi del Ministero dell’Industria e in seguito ha diretto la
segreteria tecnica del Ministero del Tesoro. Dal 1987 al 1989 è stato presidente
della Regione Lombardia e ha affrontato brillantemente l'emergenza
dell'alluvione in Valtellina, poi è arrivato Di Pietro e gli ha rovinato la
vita. No, non solo con Mani pulite: prima ancora. Nel 1989 Tabacci fu indagato
nella cosiddetta inchiesta «Oltrepò Pavese» (che verteva su anomale distrazioni
della Protezione Civile a favore di un centinaio di parroci) ma dopo un po’ di
frittura fu prosciolto una prima volta. Però aveva già tratto un’impressione
precisa: «Di Pietro», disse, «era ansioso di utilizzare le inchieste anche per
la pubblicità che gliene derivava sui giornali. Un furbo. Ho scoperto dopo che
le mie frequentazioni milanesi erano più prudenti delle sue». Poi, eletto
deputato nell’anno di Mani pulite, la procura di Mantova notificò a Tabacci
quattro avvisi di garanzia, e chiese anche l’autorizzazione per arrestarlo: per
scongiurare che scattassero le manette dovette intervenire il pidiessino
Giovanni Correnti. Ma nel 1996 Tabacci fu prosciolto ancora. Poi, nella
primavera 1993, riecco Di Pietro a chiedere l’autorizzazione a procedere sempre
contro di lui: ricettazione e finanziamento illecito dei partiti. E Tabacci, nel
marzo 1996, fu assolto anche per questi due reati. Morale: per colpa di Di
Pietro era stato decapitato come presidente della regione Lombardia, come
segretario regionale della Dc e come aspirante ministro: anzi, a margine
dell’ultimo proscioglimento, nel 1996, Tabacci dovette avvedersi che ministro,
semmai, era divenuto il suo accusatore. Ecco: come fanno? Come fa, lui, a stare
dalla stessa parte di uno come Di Pietro? Come è possibile che nel gennaio
2008, a proposito di nuovi partiti, si leggesse addirittura di una fantomatica
«cosa bianca» condivisa da Tabacci e Di Pietro? Poi c'è Giuliano Pisapia, che
non era soltanto l'avvocato di Tabacci: era e resta un garantista coi fiocchi,
figlio di quel professor Giandomenico Pisapia che era stato relatore del nuovo
Codice Penale varato nel 1989. Doveva essere una rivoluzione copernicana, quel
Codice: nelle intenzioni si proponeva la terzietà del giudice, la pari dignità
giuridica tra accusa e difesa, la custodia cautelare come extrema ratio, la
segretezza delle indagini, la pubblicità del processo, soprattutto la prova e il
contraddittorio che dovevano formarsi rigorosamente in aula. E chi è stato il
prim'attore nello stravolgimento del Nuovo Codice, simbolicamente ma anche
praticamente? Lui, quel Di Pietro che Pisapia aveva già conosciuto quando
istruiva sconosciutissime indagini sulle messaggerie telefoniche del Videotel:
«Di Pietro», ha raccontato Pisapia, «fece scattare un grosso blitz: senza
seguire le regole, alcune persone, anziché essere invitate a comparire come
previsto dal Nuovo codice, furono prelevate alle 6 di mattina e portate non in
Procura ma nella sede della Criminalpol, e interrogate con modalità non conformi
al Codice, nella convinzione che questo modo choccante di interrogare favorisse
la racconta di dichiarazioni utili». Un'inchiesta finita in nulla. Poi lo aveva
incontrato ancora nell’inchiesta cosiddetta Patenti facili, un'istruttoria
estenuante durante la quale Di Pietro chiese assoluzioni e derubricazioni per
gli stessi reati che pure gli avevano consentito arresti di massa. Disse
Pisapia: «L'ho conosciuto all'interrogatorio di un'anziana titolare di una
scuola guida che era stata convocata a piede libero ma con modalità estranee al
Codice, e cioè non con un formale invito a comparire in Procura ma con una
telefonata e in una caserma della polizia stradale. Pochi giorni dopo ho
ritrovato Di Pietro all'interrogatorio di un funzionario della Motorizzazione
civile, arrestato. Tutte e due furono prosciolti: la donna già alla fine delle
indagini preliminari, l'uomo in appello, dopo aver scontato numerosi mesi tra
carcere e arresti domiciliari. Da subito emerse chiaramente la sua concezione
dell'arresto o della minaccia all'arresto, troppo spesso finalizzato alla
ricerca della prova, della confessione». Ora quell'uomo è suo alleato politico,
suo e di Bruno Tabacci. Non esiste passato, non esiste memoria.
«Mani Pulite
ha tolto libertà a magistrati». Le accuse della Forleo in un libro: «Indagare
sulla destra va bene, ma se cambi colore di caimano ti fai male», scrive
Giuseppe Guastella su “Il Corriere della Sera”. «Fino a Tangentopoli, e fino a
qualche anno fa, il problema era dell’indipendenza della magistratura dal potere
politico, adesso è dell’indipendenza del magistrato rispetto alla magistratura
». Il «singolo magistrato » che «non si vuole allineare, non si vuole schierare,
vuole essere libero, finisce per pagare i suoi errori. E li paga cari». Parola
del gip Clementina Forleo, che il Csm ha trasferito a Cremona per
incompatibilità ambientale, la quale vede questa situazione come la conseguenza
degli «eccessi» di Mani Pulite, specialmente nell’uso del carcere, che hanno
«rafforzato il consenso popolare verso certa politica» e minato «la fiducia» nei
magistrati. Torna sul tema dei «poteri forti», Forleo, in un
libro-intervista di Antonio Massari (Alberti). Nel '94, quando lei diventò
giudice a Milano, i «magistrati erano uniti» nella «battaglia fisiologica e
sempre in corso» contro un potere politico che «aveva un colore ben definito:
c’era un nemico». «Berlusconi?», chiede l’autore. «Il pool si ribellò a un
decreto del governo Berlusconi» risponde parlando in astratto. I fatti erano
«gravissimi, ma lo strumento carcerario doveva essere limitato ai più gravi». E
anche se «il sistema era talmente radicato che c’erano poche vie d’uscita», non
farlo fu un errore. Il risultato del rafforzamento del potere politico è che ora
i magistrati sono «più prudenti» e gli inquirenti «finiscono comunque per
rispondere alle logiche di potere interne, nonostante l’obbligatorietà
dell’azione penale», ragiona Forleo, gip dell’inchiesta Unipol- Antonveneta,
firmataria della custodia per il banchiere Gianpiero Fiorani, chiedendosi
retoricamente se «Fazio (indagato, ndr.) e sua moglie sarebbero rimasti liberi
all’epoca di Tangentopoli». «Fiorani, in galera, c’è finito. Fazio invece no. Né
lui che all’epoca dei fatti era il governatore della Banca d’Italia, né sua
moglie che, peraltro, non mi risulta sia stata indagata, neanche per
favoreggiamento, nonostante fosse anch’ella in contatto con Fiorani» con cui
scambiava «informazioni importanti». «Oggi si è rotto l’idillio tra certa
magistratura e certa politica e ciò ha causato autentici scempi, quale il
silenzio dell’Anm di fronte alla vicenda di Luigi de Magistris», il quale aveva
scoperto che tra i magistrati potevano esserci «personaggi conniventi con i
potentati politici ed economici». La magistratura faccia «i conti con se stessa»
affrontando «la questione morale», perché «oggi il singolo magistrato è più
debole» e c’è il rischio che qualcuno possa «scivolare in comodi compromessi»,
come le è già capitato di vedere con amarezza. Le sue posizioni a difesa di de
Magistris, per la separazione delle carriere, contro le correnti e la richiesta
al Parlamento di usare nell’inchiesta Unipol le telefonate degli allora ds
Latorre e D’Alema («consapevoli complici di un disegno criminoso», scrisse)
hanno dato il via ai «vergognosi attacchi» contro di lei, anche dalla
magistratura: «Si sono toccati i fili che fanno morire. Perché fino a quando
s’era attaccato il nemico della magistratura, il nemico di destra, era andato
tutto bene. Avevo avuto la solidarietà. La magistratura era stata compatta nel
proteggere il giudice Forleo. Poi, quando spunteranno caimani d’altro colore,
tutti si dilegueranno». Tre giorni dopo, lesse l’appello ai giudici del
presidente Napolitano alla «riservatezza» e a non inserire in atti «valutazioni
non pertinenti» come «una pressione» che le fece «male», «un’offesa al Paese».
In un altro passaggio definisce caimano «il potere esecutivo, qualunque colore
abbia». Il libro ripercorre i procedimenti del Csm che l’avrebbe trasferita dopo
«un processo sommario», «una pagina nera nella storia della magistratura » che
l’ha fatta sentire come «un dissidente perseguitato», dichiara. Lì parlò dell’ex
procuratore Gerardo D’Ambrosio il quale, eletto senatore ds, si schierò «contro
la trascrizione delle telefonate». Lo vide andare a pranzo con i pm delle
scalate bancarie e la cosa la indignò: «Se qualcuno lascia la toga per diventare
un politico, poi dovrebbe avere il buon gusto di non creare confusione di ruoli.
Io non ho avuto dubbi sul rigore dei colleghi: colsi l’inopportunità del gesto
di D’Ambrosio». L’ex procuratore ha sempre ribattuto che si trattò di un
incontro occasionale e non si parlò delle inchieste. Una rivelazione, infine. Ha
ricevuto la proposta di candidatura. Da chi? «Non dal centrodestra» né dall’Idv
di Di Pietro.
Ci fu una
regia occulta degli Usa dietro Mani pulite? Le rivelazioni dell'ex ambasciatore
americano.
L'ex ambasciatore americano in Italia Bartholomew, prima di
morire, racconta che intervenne per spezzare i legami tra il Consolato Usa a
Milano e il pool di Mani pulite, scrive Orlando Sacchelli il 29/08/2012 su “Il
Giornale”. Domenica scorso è morto Reginald Bartholomew, ambasciatore degli
Stati Uniti in Italia dal 1993 al 1997. Aveva 76 anni e servì il suo Paese sotto
la presidenza di Bill Clinton. Prima di morire ha voluto togliersi alcuni
sassolini dalle scarpe, raccontano dettagli inediti sulla sua esperienza nel
Belpaese in quelli che furono anni molto caldi, in piena "Mani pulite", con la
crisi finale (e poi la scomparsa) della Prima Repubblica e la nascita della
Seconda. "Quella era la stagione di Mani Pulite - racconta l'ex ambasciatore -
un pool di magistrati di Milano che nell’intento di combattere la corruzione
politica dilagante era andato ben oltre, violando sistematicamente i diritti di
difesa degli imputati in maniera inaccettabile in una democrazia come l’Italia".
Sembra di risentire le parole di Bettino Craxi. Invece no. A puntare il dito
contro certi metodi è un uomo non coinvolto direttamente nello scontro politico
italiano. Un personaggio che potremmo definire super partes. "La classe politica
si stava sgretolando - ha ricordato Bartholomew - ponendo rischi per la
stabilità di un alleato strategico nel bel mezzo del Mediterraneo". Qualcosa,
aggiunge, nel consolato a Milano "non quadrava". L’ex ambasciatore quel punto
"rivendica il merito di aver rimesso sui binari della politica il rapporto fra
Washington e l’Italia". In che modo? Pose fine a quello strano legame diretto
che si era creato tra il Consolato e il pool di Mani pulite - tollerato dal suo
predecessere Peter Secchia - e riportò la gestione dei rapporti a Roma,
all'ambasciata. Potrebbe essere la conferma, sia pure indiretta, dell'esistenza
di un rapporto tra gli Usa e l'inchiesta che spazzò via la classe politica che
aveva governato l'Italia per oltre 40 anni. Una "manina" oltreoceano aveva
schiacciato il bottone per far saltare tutti i vecchi equilibri (ormai superati
vista la caduta del Muro) e ridisegnare la politica nel nostro Paese? L'ex
ministro socialista Rino Formica alcuni mesi fa parlò del ruolo che, a suo dire,
avrebbe giocato l'Fbi. Bartholomew racconta a Molinari anche di un'importante
iniziativa che prese. Quella di far venire a Villa Taverna (sede dell'ambasciata
Usa a Roma) il giudice della Corte Suprema americana Antonino Scalia,
approfittando di una sua visita in Italia. Gli fece incontrare "sette importanti
giudici italiani" e li spinse a confrontarsi sui metodi usati dalla Procura di
Milano. "Nessuno obiettò quando Scalia disse che il comportamento di Mani pulite
con la detenzione preventiva violava i diritti basilari degli imputati", andando
contro i "principi cardine del diritto anglosassone". Il racconto poi vira sui
nuovi interlocutori politici degli Usa dopo il disfacimento della vecchia classe
politica: D'Alema, Fini e, inevitabilmente, Berlusconi. Il Cavaliere si presentò
accompagnato da Letta e "voleva il mio imprimatur per la sua entrata in
politica". C'è anche un curioso aneddoto su Prodi, che si offese a morte per non
essere stato ricevuto alla Casa Bianca dopo il suo ingresso a Palazzo Chigi nel
1996. Bartholomew si sofferma anche sull’avviso di garanzia a Berlusconi del
1994, che fu anticipato dai giornali quando Berlusconi presiedeva, a Napoli, i
lavori per la Conferenza mondiale sulla criminalità organizzata, sotto l'egida
dell'Onu. L'ex ambasciatore rivela che fu "un’offesa al presidente degli Stati
Uniti, perché era al vertice e il pool di Mani Pulite aveva deciso di sfruttarlo
per aumentare l’impatto della sua iniziativa giudiziaria contro Berlusconi". C'è
un po' di confusione sulle date: l'avviso, infatti, arrivò il 21 novembre 1994 e
non nel luglio precedente durante i lavori del G7. La sostanza però non cambia
di molto. Alcuni osservano che Bartholomew fu ambasciatore in Italia proprio
negli anni in cui prese corpo il grande piano di privatizzazioni (o svendita?)
del patrimonio pubblico del nostro Paese, pianificato a bordo del panfilo reale
Britannia nel giugno 1992. Ma questo è un altro mistero su cui presto, forse,
bisognerebbe provare a fare piena luce. Parlando a Radio 24 Antonio Di
Pietro ha commentato la ricostruzione dell'ex ambasciatore: "Queste cose dette
da una persona che non c’è mi spingono a dire 'pace all’anima sua'. Altrimenti
l’avremmo chiamato immediatamente a rispondere delle sue affermazioni per dirci
'chi, come, dove e quando'. Io non ho mai incontrato questo Bartholemew, invece
so che gli Stati Uniti all’epoca furono molto collaborativi per quanto riguarda
le rogatorie che noi effettuammo. Vent’anni dopo una persona fa delle
affermazioni in relazione a comportamenti che lo stesso suo Paese ha fatto in
modo totalmente diverso, mi sembra una cosa che non ha né capo né piedi.
Bartholemew è una persona che vuole sconfessare se stesso e il suo Paese e
quindi non fa onore al suo Paese, ma ripeto non c’è più quindi pace all’anima
sua". Di tutt'altro avviso è Bobo Craxi, responsabile Esteri del Psi nonché
figlio dell'ex leader socialista: ""Appare con tutta evidenza l’inquietante
intreccio, nel 1992-94, tra il pool dei magistrati milanesi e il Consolato
generale dell’alleato americano. La mano straniera che ha orientato il golpe
mediatico-giudiziario non è un’invenzione, ma è rivelato dalle parole del
diplomatico americano: c’è materia per storici e per politici. Se non vi fosse
anchilosi, bisognerebbe per lo meno promuovere una commissione d’inchiesta". Ma
secondo Bobo Craxi "non verrà fatta neanche un’interrogazione parlamentare, in
questa legislatura". Per Stefania Craxi (Riformisti italiani) "la verità si fa
lentamente strada". La primogenita di Bettino Craxi si domanda: "Come mai
nessuno si agita per proporre una Commissione parlamentare di inchiesta, l’unico
strumento che potrebbe forse squarciare il fitto velo di ipocrisia che ancora
copre quella torbida stagione?". Si fa sentire anche l'ex procuratore capo di
Milano ai tempi di Mani pulite, Francesco Saverio Borrelli: "Mi stupiscono
queste dichiarazioni perché provengono da un americano e se ci sono prassi
poliziesche o carcerarie contrarie ai diritti dell’uomo sono proprio certe
prassi seguite negli Usa". Anche lui, come Di Pietro, dice di non voler
polemizzare con un defunto, ma respinge in modo secco quelle dichiarazioni
"perché non c’è nulla di fondato". Gherado Colombo e Pier Camillo Davigo,
invece, preferiscono non commentare.
La verità
scottante dell'ex console americano: "Di Pietro mi anticipò l'inchiesta su Craxi
e la Dc".
Semler, console Usa a Milano ai tempi di Tangentopoli: "Alla fine
del '91 Di Pietro mi anticipò l'arresto di Chiesa". E l'ex pm cosa dice?
Continua a smentire, scrive Orlando Sacchelli, il 30/08/2012 su “Il Giornale”.
L'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Reginald Bartholomew, prima di
morire ha svelato a un giornalista de La Stampa, Maurizio Molinari, gli
stretti legami tra il Consolato americano di Milano e il pool di Mani pulite. Un
retroscena inquietante. Subito Di Pietro e Borrelli sono scattati sulla
difensiva. Il primo minacciando querela (come al solito), il secondo
argomentando che "se c'è qualcuno che viola i diritti umani sono proprio gli
americani" (Batholomew ha accusato il pool di aver operato violando in modo
inaccettabile i diritti della difesa). Oggi tocca a Peter Semler, 80 anni, ex
console degli Stati Uniti a Milano, dare la propria versione dei fatti. L'uomo
che avrebbe avuto un filo diretto con Di Pietro in un'intervista a La Stampa
racconta particolari molto interessanti. "Parlai con Di Pietro, lo incontrai nel
suo ufficio, mi disse su cosa stava lavorando prima che l'inchiesta sulla
corruzione divenisse cosa pubblica. Mi disse - aggiunge - che vi sarebbero stati
degli arresti". Altri dettagli su cui riflettere: i due si incontrarono alla
fine del 1991 ("credo in novembre", dice Semler). E Di Pietro cosa fa?
Preannuncia al console americano che l'esponente socialista milanese Mario
Chiesa stava per essere arrestato (le manette scattarono il 17 febbraio 1992).
Ma che interesse aveva, il pm, a svelare il contenuto - segreto - delle proprie
indagini a un diplomatico americano? Semler va avanti e racconta: "Mi disse (Di
Pietro, ndr) che le indagini avrebbero raggiunto Bettino Craxi e la Dc. Aveva
ben chiaro dove le indagini avrebbero portato". Preveggenza? Semplice fiuto di
ex poliziotto? O qualcosa di più? Gli interrogativi sono tanti. L'ex console
prosegue parlando del viaggio di Di Pietro negli Stati Uniti: "Sono stato io a
suggerire all'ambasciata di Roma di invitarlo, poi fu il Dipartimento di Stato a
organizzargli il viaggio. Avvenne dopo l'inizio delle indagini". E il suo
giudizio sull'ex pm a distanza di anni resta molto positivo: "Era un personaggio
straordinario, cambiò l'Italia". Insomma, Semler conferma quanto raccontato da
Bartholomew. Di Pietro continua a respingere al mittente ogni accusa. E in
un'intervista a La Stampa puntualizza: "Mani pulite non è cominciata nel
'92. E' cominciata a metà degli Anni Ottanta con una serie di inchieste che
portarono a nulla per ragioni politiche... noi invertimmo il percorso. Che Dc e
Psi e anche il Pci fossero partiti corrotti in Italia lo sapevano tutti. In
fondo Mani pulite fu la scoperta dell'acqua calda". Sappiamo bene, però, che a
essere spazzati via furono i partiti che erano al governo. L'ex Pci si salvò. E
sugli "strani" rapporti con Semler? Di Pietro ammette, ma solo in parte: dice
che lo incontrava perché lui (l'ex console) lo desiderava: "Faceva il suo
lavoro, voleva capire e capì perfettamente". Poi dice: "Non ho mai violato il
segreto istruttorio". Semler, però, dice il contrario. Uno dei due mente.
Lo strano
legame degli Usa con il pool di Mani pulite,
scrive “Il Giornale”. La regia degli Usa dietro Mani pulite. O meglio, un legame
troppo stretto fra Washington e il Pool di Antonio Di Pietro. Una liason che
passava attraverso il consolato di Milano. È una voce autorevole, anzi
autorevolissima, quella che a tanti anni di distanza dà corpo a una delle
leggende che accompagnarono la Rivoluzione italiana: quella che sosteneva la
vicinanza fra l'establishment statunitense e i pm della Procura di Milano. A
confermare quella lettura inquietante di uno dei periodi più controversi e
drammatici della storia italiana è, nientemeno, l'ex ambasciatore in Italia
Reginald Bartholomew. Le sue parole sono state raccolte circa un mese fa da
Maurizio Molinari della Stampa e il colloquio è stata pubblicato ieri dal
quotidiano torinese, tre giorni dopo la morte del diplomatico, avvenuta domenica
a 76 anni in un ospedale di New York. Bartholomew, ricorda Molinari, fu
catapultato a Roma in piena tempesta. Mani pulite era scoppiata il 17 febbraio
dell'anno precedente, il 1992, con l'arresto di Mario Chiesa e il Pool macinava
arresti su arresti. L'Italia era di fatto nelle mani di un gruppetto di
magistrati, osannato dall'opinione pubblica: Antonio Di Pietro, Piercamillo
Davigo, Gherardo Colombo, Gerardo D'Ambrosio, il coordinatore, il procuratore
della Repubblica Francesco Saverio Borrelli. Clinton, preoccupatissimo per la
piega che aveva preso il nostro Paese, di fatto in decomposizione, decise di
puntare su un ambasciatore non politico. Finalmente nel '93 ecco il veterano del
Foreign Service in Via Veneto. «Qualcosa non quadrava - è il suo racconto - nel
rapporto fra il consolato Usa di Milano e il pool Mani pulite», un gruppo di
magistrati «che nell'intento di combattere la corruzione dilagante era andato
ben oltre violando sistematicamente i diritti di difesa degli imputati in
maniera inaccettabile in una democrazia come l'Italia, a cui ogni americano si
sente legato». Dunque, come si può capire, la realtà era molto complessa. Ma la
sostanza era che l'allora console generale a Milano Peter Semler aveva dato
disco verde a Borrelli e ai suoi pm. E questo per Bartholomew era inaccettabile.
Se il suo predecessore a Villa Taverna aveva lasciato fare, lui decise che così
non si poteva andare avanti. Bartholomew, su cui Clinton aveva scommesso, era
convinto che la nuova Italia, uscita dalle macerie della prima repubblica,
dovesse essere disegnata da una nuova classe politica e non da un manipolo di
toghe. «D'ora in avanti - svela il diplomatico, riferendosi a quel rapporto
speciale fra il consolato e il palazzo di giustizia - tutto ciò con me cessò».
Anzi, Bartholomew prese alcune iniziative per sensibilizzare l'establishment
americano su quel che stava avvenendo nelle aule di giustizia italiane. Qualcosa
che andava ben oltre i confini dello stato di diritto. Così l'ambasciatore fece
venire a Villa Taverna «il giudice della Corte Suprema Antonino Scalia,
sfruttando una sua visita in Italia, per fargli incontrare sette importanti
giudici italiani e spingerli a confrontarsi con la violazione dei diritti di
difesa da parte di Mani pulite». Infine Bartholomew parla di quel che accadde
nel'94 con l'avviso di garanzia a Berlusconi e in realtà sembra pasticciare con
le date mescolando l'arrivo in Italia per il G7 di Clinton, nell'estate, e
l'emissione del provvedimento giudiziario che colpì il premier, recapitato
direttamente in edicola dal Corriere della Sera in autunno, nel corso di una
conferenza internazionale contro al criminalità. «Si trattò - spiega lui - di
un'offesa al presidente degli Stati Uniti, perché era al vertice e il pool di
Mani pulite aveva deciso di sfruttarlo per aumentare l'impatto della sua
iniziativa contro Berlusconi». «Gliela feci pagare - è la secca conclusione - a
Mani pulite». Come? Forse altre rivelazioni arriveranno con una seconda
probabile puntata, ma certo Barholomew racconta di aver tessuto freneticamente
la tela dei rapporti con i politici emergenti: D'Alema, Berlusconi, Fini. Ignorò
invece completamente Di Pietro e soci. «Queste cose dette da una persona che
oggi non c'è più - ribatte ai microfoni di Radio24 Antonio Di Pietro - mi
spingono a dire pace all'anima sua. Altrimenti l'avremmo chiamato immediatamente
a rispondere delle sue affermazioni per dirci chi, come, dove e quando. Io -
aggiunge l'ex pm - non ho mai incontrato questo Bartholomew, invece so che gli
Usa all'epoca furono molto collaborativi per quanto riguarda le rogatorie».
Ancora più duro Francesco Saverio Borrelli: «Mi stupiscono queste dichiarazioni
perché provengono da un americano e se ci sono prassi poliziesche o carcerarie
contrarie ai diritti dell'uomo sono proprio certe prassi seguite negli Usa. Non
voglio polemizzare con un defunto, ma respingo quelle dichiarazioni e
valutazioni radicalmente, perché non c'è nulla di fondato». Per Bobo Craxi,
figlio di Bettino, Bartholomew narra invece quel che si è sempre sospettato: «La
mano straniera che ha orientato il golpe non è un'invenzione e esprimere stupore
e sorpresa per l'intervista sarebbe persino riduttivo». E il capogruppo del Pdl
alla Camera Fabrizio Cicchitto si sofferma sui «singolari rapporti fra il
consolato di Milano e Di Pietro», riproponendo una domanda antica: «Ma chi era
Di Pietro?».
Vent’anni
di Mani Pulite. Quando la giustizia era giustizialista e l’ideale
socialdemocratico non era rappresentato dall’ex PCI,
scrive Iljester su “Paper Blog”.
Quando si parla di ‘Mani Pulite’, il complottismo è un ingrediente quasi
inevitabile, ma non tanto perché ci piace, quanto perché ripercorrendo gli
eventi di quella stagione, tuttora la domanda è pressante: perché il partito
socialista e la democrazia cristiana sì e il partito comunista no? Del resto non
credo che Bettino Craxi mentisse quando affermò nell’aprile del 1993, nel suo
discorso al Parlamento, che tutto il panorama politico italiano era coinvolto in
un sistema di finanziamenti illeciti ai partiti. Era questo un sistema che non
poteva non coinvolgere tutti. Non poteva essere che esistessero partiti —
soprattutto grandi e potenti (e il PCI-PDS era piuttosto potente) — che lo
ignorassero e non lo utilizzassero. Credo invece che ci si volle fermare lì. A
un passo dalla completezza dell’indagine che fece crollare mezza Repubblica
italiana. E questo rende ancora più evidente l’ingiustizia di quegli anni e
l’idea che si volle agevolare una precisa parte politica a danno delle altre.
Forse perché quella parte politica ormai era destinata a cadere in disuso, e
forse perché il suo vero avversario non era la Democrazia Cristiana, ma il suo
stesso partito ‘fratello’, il Partito Socialista, ormai il vero interlocutore a
sinistra in un contesto socialdemocratico che teneva fuori i comunisti o gli
ex-comunisti dal governo e persino dal PSE. Del resto, analizzando col senno di
poi gli eventi di quegli anni ci si accorge come siamo in un contesto storico
piuttosto particolare sia dal punto di vista nazionale che internazionale.
Abbiamo la caduta del muro di Berlino e la Germania riunita. Abbiamo il
dissolvimento dei regimi comunisti in Europa, abbiamo una forte crisi del
socialismo reale in mezzo mondo e abbiamo gli attentati mortali (e mafiosi) a
Falcone e Borsellino in un contesto di profonda debolezza economica della lira.
Un vero e proprio momento di vulnerabilità politico-economica che se non fu
orchestrato di sana pianta (e ci sarebbe voluto un Grande Fratello orwelliano
per questo) fu comunque sfruttato per azzerare la politica italiana e sostituire
come grande interlocutore a sinistra il partito socialista con il neonato
partito post-comunista, appena riciclatosi come entità socialdemocratica dopo la
fine del Comunismo, che altrimenti rischiava di scomparire nella soffitta delle
obsolescenze ideologiche. Dunque, l’idea parve essere questa: ridisegnare il
panorama politico italiano, spostando l’asse della politica italiana ancor più a
sinistra, con un nuovo (per modo di dire) soggetto politico diverso dal partito
socialista ma capace di prenderne il posto anche nel Governo. E Mani Pulite fu
lo strumento forse inconsapevole di questo progetto. Fino a che punto poi ci
siano state delle responsabilità personali, io sinceramente non lo so. So per
certo che quando il Partito Socialista tracollò, trascinandosi dietro la
Democrazia Cristiana, e si preannunciarono le elezioni del 1994, il Partito
Democratico della Sinistra, l’ex P.C.I. (la mitologica macchina da guerra di
Achille Occhetto) pensava già di avere il governo in tasca, forte del fatto che
nel panorama politico — visto pure il clima di caccia alle streghe — non vi era
(più) nessuna forza politica in grado di contrastarlo. Poi sappiamo come andò a
finire quella storia. Ciononostante, i dubbi sulla completa bontà di quella
stagione rimangono. L’Italia non è mai stato un paese cristallino (ma del resto,
è difficile trovare una nazione che non abbia i suoi scheletri nell’armadio), e
niente nel nostro paese è mai accaduto per caso. Perciò, a distanza di venti
anni, ci si domanda ancora perché? Perché l’allora PDS, ex PCI, non fu
toccato dal vortice giudiziario? Guardando l’Italia degli ultimi venti anni,
è difficile credere alla integrale moralità di un partito ed è difficile pensare
che quella stagione segnò la fine di un sistema di corruzione politica che
tuttora persiste e insiste, coinvolgendo volente o nolente, guarda caso, anche
l’erede di quel PCI scampato a Mani Pulite, oggi chiamato PD.
Mani pulite
favorì alcuni imputati,
scrive Franca Selvatici su “La Repubblica”. "Noi siamo usciti da Mani Pulite
perché si è pagato... quelli più bravi di noi non ci sono nemmeno entrati". Così
parlò Chicchi Pacini Battaglia nell' ormai celebre sfogo del 10 gennaio 1996.
Gli aggiustamenti di tiro e le precisazioni fatte uscire dal carcere non sono
bastate a dissipare l' ombra del dubbio sull'inchiesta milanese avviata nel 1992
da Antonio Di Pietro. Dubbi ne hanno, sicuramente, gli investigatori del Gico
della Guardia di Finanza, che hanno indagato su Pacini e sulla "banda delle
ferrovie". Le recentissime trame del banchiere e dei suoi amici dimostrano -
secondo gli uomini delle Fiamme Gialle - che Mani Pulite non ha fatto emergere
tutta la verità sulla corruzione. E' un concetto che gli investigatori ripetono
più volte nel loro rapporto del 26 luglio ' 96 che ha dato corpo all'inchiesta
spezzina e che oggi è - con vasti omissis - allegato agli atti depositati. Del
"sodalizio" scoperto dal Gico fanno parte - si sottolinea nel rapporto - anche
"vecchie conoscenze delle inchieste cosiddette Mani Pulite, essendo stati
peraltro in tale contesto anche arrestati". Ne deriva - secondo gli
investigatori - "che tali attività giudiziarie non avevano minimamente inciso
sul vincolo associativo; ma anzi i partecipi stavano realizzando nuovi piani
delittuosi a testimonianza dell'indissolubilità del vincolo". Il concetto è
ulteriormente chiarito in un altro passaggio del rapporto: che "alcuni dei
partecipi di attività illecita anche pregressa siano ancora strettamente legati
al Pacini e che i capitali accumulati da essi con l'illecita attività siano
gestiti dallo stesso Pacini" lo si capisce "dalle quotidiane disposizioni
impartite dal Pacini alla segretaria Pensieroso". "Parallelamente - sostengono
gli investigatori - tali circostanze dimostrano come il ruolo del Pacini,
evidenziatosi nelle indagini condotte dalla autorità giudiziaria di Milano, sia
emerso solo parzialmente e come la sua collaborazione con tale autorità
giudiziaria sia stata meramente strumentale e rivolta esclusivamente a rendere
dichiarazioni tese a limitare i danni". Della "estesa e pericolosissima lobby"
che l'inchiesta di La Spezia ha scoperto attiva e rampante ancora nel corso del
1996 facevano parte - sostiene il Gico - anche Publio Fiori, Paolo Cirino
Pomicino e Luigi Bisignani: "gli ultimi due vecchie conoscenze delle inchieste
Mani Pulite". Ma gli investigatori si spingono più avanti: a loro giudizio, le
nuove indagini hanno fatto emergere elementi di prova su "come alcuni partecipi
(della lobby, ndr) possano essere stati favoriti da appartenenti alla autorità
giudiziaria, in concorso anche con l'avvocato Federico Stella di Milano".
Affermazione, a quanto pare, sviluppata in una parte del rapporto coperta da
omissis. Le conclusioni del Gico sono molto pesanti. Mani Pulite ha fatto flop.
Mani Pulite non ha tagliato alle radici la mala pianta. "Evidentemente -
concludono le Fiamme Gialle - la sola via giudiziaria, peraltro notoriamente
lunga e incerta, non è servita e non serve a debellare tale fenomeno che sembra
connaturato alla vita sociale del nostro Paese. C' è peraltro da sottolineare
che la cosiddetta via giudiziaria, già oggettivamente insufficiente vista la
carenza di strutture, uomini e mezzi adeguati, appare - sia alla luce di noti
fatti di cronaca che dai risultati della presente indagine - resa più difficile
se non impossibile da attività contrarie ai doveri d' ufficio, quando non ci si
trovi di fronte a vere e proprie partecipazioni associative, di un rilevante
numero di appartenenti alla autorità giudiziaria". Soprattutto a Roma -
precisano in un altro passo del rapporto - ma forse anche a Milano. Fra gli
scampati di Mani Pulite, gli investigatori del Gico iscrivono a pieno titolo
l'ex amministratore delle Ferrovie Lorenzo Necci, accusato di corruzione da vari
arrestati ma difeso a spada tratta da Pacini Battaglia che da allora - secondo
il Gico - lo tiene in pugno ("Sono il suo salvatore della patria", grida in una
conversazione) oltre ad amministrarne i risparmi all' estero. Proprio ieri al
tribunale del riesame, il pm Alberto Cardino ha depositato due intercettazioni
che riguardano la moglie di Necci, Paola Marconi. E' il 22 gennaio 1996. Nei
suoi uffici di viale Parioli, Pacini "annota appuntamenti e dazioni di denaro"
con la segretaria Eliana Pensieroso (che secondo il Gico ha "accantonato un
miliardo di lire nella banca svizzera del principale"). Pacini: "Devi segnà una
scheda Paola e una scheda Renzo... Erre". Pensieroso: "Erre". Pacini: "Poi ti
spiego tutto. Mi ci scrivi Erre, 1996, e ci metti: 80, 130, 140... fermati,
posso sbagliare, Erre te lo do subito... fermati... dov'è? scusa, ecco... cento,
cento?". Pensieroso: "... Quaranta mi ha detto: ' 96, 140". Pacini: "' 96, 140,
segna". Pensieroso: "L' ho segnati". Pacini: "Ora ti dovresti segnare Paola... e
ci scrivi ' 96, 30". Pensieroso: "Allora: '96, 30". Pacini: "E dobbiamo... a
Paola... dargliene altri 70... lo puoi mettè fra parentesi, 30 più 70, poi ti si
dice quando gli si danno... chiaro?". Qualche giorno più tardi, il 30 gennaio,
Pacini e la segretaria fanno il riepilogo. Pensieroso: "Poi vabbè Orlando me lo
segno io perché è roba mia... poi ci ho 70. Paola? Lei quel biglietto che le ho
dato io me l'ha fatto strappare, però...". Pacini si vanta di avere rapporti
privilegiati con alcuni di loro, ma li odia, li teme e li disprezza. "Ricordati
bene - dice all'amico Emo Danesi - che tutta la gente ha sempre molta paura, non
sa se tu sei controllato, non sa se i giudici ti guardano, non sa se c'hai quei
servizi che ti controllano... sei in un merdume". I giudici che gli piacciono
sono quelli che incassano e archiviano. Per questo è furioso con Giorgio
Castellucci, il pm romano che coordina l' inchiesta sulla Tav e che non la
chiude. L' 11 gennaio si sfoga con Danesi: "Io sono stato molto chiaro. Ho
detto: ragazzi, chiamate Castellucci e gli dite: ' Hai preso i soldi? Sì. L'hai
distribuiti con quegli altri? Sì. Ora hai rotto i coglioni, ora te questa
pratica la chiudi perché se non la chiudi te, noi ti mandiamo sul giornale e ti
diciamo anche come hai preso i soldi... perché noi ne abbiamo le palle piene". E
il 2 febbraio rincara la dose: "Castellucci becca i soldi e incrimina gli
altri... quello (Renato Squillante, ndr) becca i soldi e ci rompe i
coglioni...". Il 19 febbraio Alessandra, figlia di Lorenzo Necci, si consiglia
con Pacini Battaglia sul suo futuro politico. "Alle quattro vedo Letta per
parlare un attimino del mio collegio", annuncia. Pacini è perplesso: "Io sono
convinto che lui (il papà di Alessandra, ndr) non si schiera con Forza Italia...
te fai Forza Italia e lui no... è troppo ridicolo". Alessandra: "Perché tu dici
che lui si schiera a sinistra?". Pacini: "Lui credo che non si schieri da
nessuna parte, poveromo, perché da qualsiasi parte si schiera lo fanno a
pezzi...". Ma Alessandra è tentata e allora Pacini le suggerisce di fare una
bella intervista, o meglio di farla fare a papà, per spiegare che lei è
maggiorenne e ha fatto tutto di testa sua. Pacini: "Lo deve far papà, non tu...
lo fai te dicendo: io ho preso la decisione contro il volere di mio padre...".
Poi Pacini spiega ad Alessandra come pagarsi la campagna elettorale: "Io muovo i
fondi neri, tu ti fai sponsorizzare da Ciarrapico, che c'ha tutti i soldi lui, e
prendi Mazzi, Todini, Salini, è già risolto, lo mettono nel loro bilancio, alla
luce del sole".
Dallo Ior a
Mani pulite: le verità di Bisignani.
Le rivelazioni nel libro intervista di Paolo Madron, scrive “Lettera 43”. Il
destino dello Ior, che papa Francesco «ha intenzione di riformare trasformandolo
in una vera banca della solidarietà al servizio dell'evangelizzazione». I
rapporti dei servizi segreti degli Stati Uniti con Beppe Grillo. E il gotha
della finanza, da Agnelli a De Benedetti, che «cercò disperatamente di bloccare
il pool dei giudici di Milano» nell'inchiesta Mani pulite. Ne L'uomo che
sussurra ai potenti, nel libro scritto con Paolo Madron, ed edito da
Chiarelettere (in libreria dal 30 maggio) Luigi Bisignani alza il velo su fatti
centrali della recente storia politica italiana, come la «congiura» di Alfano e
Schifani alle spalle di Berlusconi prima che lo stesso Cavaliere annunciasse la
sua nuova discesa in politica alle elezioni politiche di febbraio 2013. «Secondo
alcune autorevoli indiscrezioni», svela, papa Francesco ha intenzione di fare
della banca vaticana «uno strumento di aiuto per le chiese povere e per le
missioni sparse nel mondo. I centri missionari saranno uno dei punti
fondamentali di papa Francesco, secondo la miglior tradizione dei gesuiti».
Secondo Bisignani, la riforma dello Ior avverrà attraverso la riclassificazione
di tutti i conti e saranno «autorizzati solo quelli che fanno capo ufficialmente
a congregazioni e ordini religiosi. Nessuno potrà più gestire fondi, depositi e
titoli se non nell'esclusivo interesse di enti religiosi». Bisignani ha quindi
spiegato che «la Curia conosce bene le sue intenzioni». «Non fu un caso se nel
conclave precedente, per scampare il pericolo della sua salita al soglio
pontificio come voleva il suo grande elettore di allora, Carlo Maria Martini,
gesuita come lui, gli fu preferito Ratzinger. Meglio conosciuto nei palazzi
apostolici e quindi considerato più malleabile». I rapporti dei servizi segreti
degli Stati Uniti con Beppe Grillo sono il tema di un altro capitolo del libro-
intervista. Bisignani oltre a raccontare una vicenda già conosciuta come il
pranzo tra Beppe Grippo e alcuni agenti e diplomatici amercani e il dispaccio
dell'ex ambasciatore Ronald Spogli, aggiunge: «Avendo avuto anch'io il dispaccio
in mano, c'è qualcosa che andrebbe approfondito» in quanto sono stati occultati
«chirurgicamente quasi tutti i destinatari sensibili» tra cui oltre alla Casa
Bianca, al dipartimento di Stato e alla Cia «c'è da scommetterci ci fosse il
dipartimento dell'Energia e la National secuity agency, che si occupa
soprattutto di terrorismo informatico». «Agli americani è noto il rapporto
strettissimo che Grillo ha con due loro vecchie conoscenze. Franco Maranzana, un
geologo controcorrente di 78 anni, considerato il suo più grande suggeritore su
tematiche energetiche e ambientali non politically correct, in contrasto così
con la linea ecologica che viene attribuita al movimento. E soprattutto Umberto
Rapetto, un ex colonnello della guardia di finanza». Secondo Bisignani
l'incontro con Grillo dovrebbe essere avvenuto nel marzo del 2008 in quanto il
rapporto dell'ambasciatore Spogli dal titolo Nessuna speranza. Un'ossessione
per la corruzione reca la data del 7 marzo 2008. Con ogni probabilità,
secondo Bisignani, quel documento è finito nelle mani del presidente Obama.
Quindi fornisce le conclusioni del rapporto sulle idee di Grillo: «La sua
miscela fatta di spumeggiante umorismo, supportata da dati statistici e
ricerche, fa di lui un credibile interlocutore per capire dal di fuori il
sistema politico italiano». Inoltre, racconta che dopo le elezioni del febbraio
scorso una delegazione di grillini «capeggiata dai due capigruppo in parlamento,
Vito Crimi e Roberta Lombardi, è andata a omaggiare l'ambasciatore David Thorne.
Lo stesso che, parlando agli studenti, ha pubblicamente lodato il nuovo
movimento come motore necessario per le riforme di cui ha bisogno l'Italia». La
fortezza in cui si arroccò il capitalismo per respingere l'offensiva giudiziaria
di Mani pulite contro il sistema delle tangenti fu «Mediobanca». «Fu lì»,
racconta Bisignani, «che si tenne una riunione riservata presieduta da Enrico
Cuccia, il custode di tutti i segreti. Vi presero parte, oltre all'avvocato
Agnelli e a Cesare Romiti, Leopoldo Pirelli accompagnato da Marco Tronchetti
Provera, Carlo De Benedetti, Giampiero Pesenti, Carlo Sama per il Gruppo
Ferruzzi e ovviamente l'amministratore delegato dell'istituto Vincenzo
Maranghi». Proprio Maranghi, dopo una perquisizione della polizia giudiziaria a
Piazzetta Cuccia, organizzò nella notte «un pulmino che portò via tutte quelle
carte dal contenuto inquietante» che non erano state scoperte. Agli
investigatori era infatti sfuggita una parete mobile «celata dietro una libreria
in una delle sale del piano nobile dell'istituto, dove si custodivano altri
segreti». Secondo Bisignani, «tutta la storia di Mediobanca è fitta di episodi
simili» a quello sul 'pulmino' di Maranghi, come il caso dei fondi neri scoperti
nella Spafid, la fiduciaria di Mediobanca che «custodiva la contabilità
ufficiale e parallela dei grandi gruppi», fino alle «carte segrete su Gemina»
rinvenute in «una botola» dalla guardia di finanza. Tornando alla riunione
'anti-pool' in Mediobanca «fu unanimemente decisa la totale chiusura a ogni
possibile collaborazione con la procura di Milano» nonché la «perentoria
denuncia dei metodi che stavano destabilizzando il paese e la sua economia».
Cuccia incaricò Romiti di «coordinare ogni iniziativa» e ordinò «a quegli
imprenditori che avevano interessi nell'editoria» di supportare la linea «senza
tentennamenti». Il fronte però si sfaldò presto un po' perché i tg di
Berlusconi, che «all'epoca non faceva parte del giro di Mediobanca», cavalcarono
l'onda di Mani Pulite ma soprattutto perché le delle ammissioni di un dirigente
Fiat «fecero cambiare radicalmente la strategia decisa» facendo scattare il
«tana libera tutti».
Follie
televisive. Le sedute spiritiche di Formigli….,
scrive Pietro Cerullo il 24 marzo 2015 su “Destra.it”. Lunedì 23,
Formigli, più che “Piazza pulita”, ha condotto una seduta spiritica: evocato è
apparso Claudio Signorile, già numero due del Partito Socialista di Bettino
Craxi e ministro non compianto dei trasporti negli anni ottanta, quando
scomparve avvolto dalle famigerate “lenzuola d’oro” delle FF.SS. Come in un
gioco di prestigio. Il desso, con la supponenza dell’intellettuale abusivo, ha
spiegato che non esistono i corrotti, ma la corruzione. C'è dunque l’opera, ma
non gli autori. Per la contraddizion che non consente, direbbe Dante, se c’è
l’effetto c’è la causa; se c’è il quadro c’è l’autore. Causa ed autore, udite
udite, è il sistema. Ma se il sistema non è figlio della politica e della
burocrazia , sarà figlio del popolo? Per un verso potrebbe esserlo, dato che il
popolo vota i politici che poi scelgono gli alti burocrati. Chi si arricchisce e
ruba però sono loro, non gli elettori. In effetti Signorile detto il sottile
propone una spiegazione, se non originale, consueta: la colpa è del Fascismo:
nel dopoguerra ci fu soluzione di continuità - argomenta - sul piano
istituzionale, con il passaggio dalla monarchia alla repubblica, non quella
dell’apparato burocratico. Intende che non ci fu lo sterminio di tutti i
pubblici impiegati, anche se molti soccombettero alle vendette partigiane ed
all’epurazione? La matematica non gli suggerisce che i superstiti si sono nel
frattempo comunque estinti, per l’ineluttabile trascorrere degli anni? Se non
erro, ricorre il settantesimo anniversario della Repubblica democratica
antifascista nata dalla Resistenza. Da un pezzo non ci può essere in servizio
attivo chi sia, non dico formato, ma nato sotto il Fascismo! Estinta non è
purtroppo la razza ladrona cresciuta all’ombra dei partiti, dei sindacati, delle
Regioni, tutta roba che non c’era durante il Fascismo e che nessuna inchiesta
della magistratura è riuscita ad espiantare. Che, anzi, riemerge non nelle
sedute spiritiche, ma nelle dirette televisive per spiegarci che ancora si
aggira, di persona o tramite figli e nipoti, nelle stanze dei ministeri, per
esempio come il figlio dello stesso Claudio Signorile, per proporre ad Incalza
“un sistema di monitoraggio anticorruzione”. Ha detto letteralmente così. Che
dobbiamo fare?
Appalti
grandi opere: caso Incalza, i rapporti di Claudio Signorile, l’autostrada
Roma-Latina e “l’interesse” del figlio.
Il tarantino
ex ministro, definito da Michele Emiliano padre della Patria. Per ora, padre di
uno che secondo i Ros era in un'operazione "limitativa della concorrenza delle
piccole imprese", scrive “Noi Notizie”, citando “La Rete”. Il caso di Ercole
Incalza, il salentino di Francavilla Fontana che è in galera per presunte
tangenti, è visto come una sorta di tangentopoli dei nostri tempi. Il ministro
che si è dimesso (senza essere indagato) è emblema della gravità della
situazione. Poi spuntano fuori anche individui del passato che provano a esserci
pure nel presente. Esempio: Claudio Signorile, di Taranto. Era ministro dei
Trasporti trent’anni fa e pochi mesi orsono, il candidato del centrosinistra
alla presidenza della Regione Puglia, Michele Emiliano, ne ha parlato come di
padre della Patria. Ecco come descrivono lui e il figlio, Jacopo Benedetto, in
odore di candidatura al consiglio regionale pugliese, i carabinieri del Ros,
nell’ambito dell’inchiesta sul caso Incalza e su ipotesi di tangenti a tanti
zeri (complessivamente, e in euro) sulle grandi opere. Testo pubblicato dal
Corriere della Sera. Con una doverosa premessa: fino a prova del contrario, in
un procedimento giudiziario sono tutti innocenti. Chissà perché, allora, finiti
nelle stesse carte della stessa inchiesta, uno deve andarsene e un altro è
considerato, da chi sta per assumere un ruolo-chiave, padre della Patria. Chissà
che ne pensi Michele Emiliano, oggi. “Dall’attività di indagine è emerso che
l’ex ministro Claudio Signorile e il figlio Jacopo Benedetto, sono tuttora in
rapporti, per vicende riguardanti appalti pubblici, sia con Incalza e Pacella
(ora ai domiciliari) che con Perotti. In particolare sono state rilevate
comunicazioni, circa l’interesse di Jacopo Benedetto Signorile di entrare,
insieme a Perotti, nella direzione lavori per la realizzazione dell’autostrada
Roma Latina (opera da 2,8 miliardi di euro, di cui 970 di contributo pubblico,
progetto preliminare approvato dal Cipe nel 2004) su cui l’Anac presieduta dal
dottor Raffaele Cantone, nel novembre 2014, ha accolto i rilievi segnalati da
Ance Lazio e Acer (costruttori di Roma) in quanto limitativa per la concorrenza
delle piccole imprese”.
La seconda
generazione di Tangentopoli.
Perotti, Li
Calzi, Trane, Gaspari: hanno ereditato da padri e zii le posizioni chiave negli
appalti. E adesso li sostituiscono anche come protagonisti degli scandali. Lo
spaccato più amaro di come funziona l'Italia, scrive Gianluca Di Feo su “L’Espresso”.
Largo ai giovani. Basta con i vecchietti di Mani Pulite, gli anziani reduci alla
Primo Greganti e Gianstefano Frigerio che hanno continuato a smistare mazzette
per decenni. Anche per loro è arrivata la rottamazione, perché adesso la scena è
tutta per la seconda generazione di Tangentopoli: i figli di coloro che
vent'anni fa dominavano il mercato delle bustarelle e degli appalti. L'inchiesta
di Firenze segna uno storico passaggio di testimone, anzi di imputato: nel 1992
erano stati i padri a finire in cella, adesso la stessa sorte tocca a loro.
L'ereditarietà della corruzione è incarnata dalla saga della famiglia Perotti.
Negli anni Sessanta Massimo è stato l'enfant prodige degli appalti: entra
all'Anas con concorso ed è il più giovane ingegnere a dirigere i lavori
dell'Autosole. Scala la gerarchia interna fino a diventare direttore generale
dell'Azienda pubblica: costruisce due terzi delle strade siciliane, arbitrando
quei cantieri che fanno da sfondo al “Giorno della civetta” di Leonardo
Sciascia. Una carriera che negli anni Ottanta lo porta alla presidenza della
Cassa del Mezzogiorno, la più grande mangiatoia della Prima Repubblica, con
l'incarico di liquidarla. Venne arrestato dalla procura di Milano nel 1985, in
uno scandalo di grandi opere e finanziamenti alla politica che anticipava Mani
Pulite: la vittima più celebre fu Pietro Longo, il segretario del Psdi, che
perse la poltrona e si ritrovò poi per cinque mesi a Rebibbia con una condanna
definitiva. Perotti senior dovette lasciare la Cassa, pur respingendo le accuse
di concussione. Dopo un mese di cella è tornato a casa. E che casa: una villa
che domina Firenze, usata pochi mesi fa per girare lo spot di un marchio di
calze interpretato da Julia Roberts. Il procuratore capo di Firenze Giuseppe
Creazzo spiega il meccanismo con il quale l'ex dirigente del ministero dei
Lavori pubblici (ora consulente esterno) Ercole Incalza avrebbe manovrato
numerosi appalti pubblici assieme all'ingegner Stefano Perotti. A Perotti
sarebbe stata affidata la direzione dei lavori in cambio di consulenze
retribuite allo stesso Incalza. Secondo il pm Creazzo "il meccanismo ha favorito
un incremento dei costi" delle opere.di Andrea Lattanzi. La dimora con vista
sulla cupola di Brunelleschi non è l'unico lascito che Massimo Perotti ha
consegnato all'erede Stefano, protagonista assieme a Ercole Incalza dell'ultima
retata. In un ventennio di appalti il babbo aveva intessuto rapporti con tutti i
signori delle infrastrutture, un capitale senza prezzo, trasmesso integralmente
al rampollo. Lo racconta la moglie di Perotti junior, parlandone al
figlio Philippe, destinato a essere il terzo della dinasty: «Tuo padre sì si è
sposato a 23 anni, a 24 ha dato la tesi a 25 aveva appena appena iniziato a
lavorare. Come te, uguale. E non aveva fatto un cazzo nella vita. Aveva avuto
tanto da suo padre, perché aveva avuto già una casa, il permesso di sposarsi
senza guadagnare però nient'altro». Eccolo, il modello dominante dell'Italia di
sempre: il merito non esiste, contano le relazioni, conta essere dentro il giro
importante, dimostrare la fedeltà a una consorteria. «Per cui tu non devi
pensare: “Io oggi non sono come papà”... Perchè che tu ti devi paragonare con i
soldi che fa papà è questo che sbagli Philo... Perchè papà oltretutto se
guadagna bene e tanto e anche perchè ci sono state delle coincidenze. Papà è
bravo... però ha avuto delle coincidenze fortunate di entrare nel mondo della
politica grazie a suo padre... okay? Grazie ad un certo giro di politica...
lavori pubblici eccetera che non è detto che in futuro sarà sempre uguale a
come è stato fino adesso...». Il passaggio dinastico è simile anche per
Giovanni Li Calzi, figlio dell'architetto rosso di Tangentopoli. Il padre
Epifanio ebbe un posto in pole position: fu Mario Chiesa ad accusarlo nel primo
verbale firmato a San Vittore. Progettista di grido, ex assessore ai Lavori
Pubblici delle giunte di sinistra della Milano da bere, alla fine di febbraio
1992 Epifanio Li Calzi fu chiamato a sostituire proprio il “mariuolo” Chiesa
come direttore dei lavori dell'ospedale Sacco. L'incarico durò poco: è entrato
in carcere come collettore del Pci-Pds nella spartizione metropolitana. Era già
stato indagato quattro anni prima, nello scandalo delle “Carceri d'oro” e poi
assolto. Dai processi di Mani Pulite invece esce grazie alla prescrizione. E
torna in affari. Con il figlio Giovanni Li Calzi crea la InAr, che macina
appalti in Lombardia e nel mondo: costruiscono i padiglioni degli ospedali in
Brianza e nel Sud Sudan. Creano anche una fondazione per promuovere
l'architettura sociale. Ormai il suo passato rosso è dimenticato e gravita
nell'area ciellina, la stessa del ministro Maurizio Lupi ma soprattutto del
Celeste Roberto Formigoni che dal Pirellone domina la Regione. Li Calzi senior è
morto l'anno scorso, quando il quarantenne Giovanni – come dimostrano le
intercettazioni del Ros che lo hanno fatto finire nel registro degi indagati – è
ormai pienamente inserito nel sistema di potere. Una grande differenza tra padri
e figli è l'orientamento politico. La prima generazione aveva referenti chiari
nei partiti. Perotti era considerato uomo del Psi, Li Calzi del Pci anche se gli
atti giudiziari li descrivono come maestri nell'applicare il manuale Cencelli
alla spartizione degli appalti: sanno stare al mondo e dialogare con chiunque. I
quarantenni si sono evoluti e sembrano avere sostituito i rapporti personali
alle tessere. Come Pasquale Trane, erede del leggendario Rocco ed esponente di
punta della “Sinistra ferroviaria” di matrice socialista. Rocco Trane era
l'ombra di Claudio Signorile, potente ministro dei Trasporti, il factotum nelle
transazioni oscure. Come le mazzette sul piano aeroporti da 1350 miliardi di
lire che gli fruttarono una condanna per concussione. Ma solo in primo grado.
Perché la prescrizione è stata una benedizione per gli assi di denari della
Prima Repubblica. Rocco Trane si è spento all'improvviso due anni fa, mentre
partecipava al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione: un altro indizio di
come si sia spostato il baricentro degli interessi. Ma il giovane Pasquale è
rimasto lungo gli stessi binari: sempre treni, anche se ad alta velocità. Per i
quali adesso è sotto inchiesta. Nel settore di famiglia si è radicato un altro
nome da amarcord: Giovanni Paolo Gaspari, nipote di quel Remo entrato negli
annali come il “cementificatore d'Abruzzo”. Lo zio è stato un pilastro della Dc,
al governo per quasi trent'anni; il giovane subito dopo la laurea è entrato alla
Comunità europea, due anni dopo era all'Eni. Nel 1994 è direttore finanziario
della Tav e dal 2001 con Pietro Lunardi si installa al dicastero delle
Infrastrutture, come consigliere del ministro, incarico che ha mantenuto ancora
oggi passando indenne attraverso i cambiamenti di maggioranza. È sua la frase
intercettata che per i pm incastra Ercole Incalza: «Ercolino… è lui che decide i
nomi… fa il bello e il cattivo tempo ormai là dentro…o dominus totale».
CLAUDIO SIGNORILE. Bari 9 settembre 1937. Politico. Eletto alla Camera nel 1972,
1976, 1979, 1983, 1987, 1992 (Psi), fu ministro per il Mezzogiorno nello
Spadolini I e II (1981-1982), per i Rapporti col Parlamento nel Fanfani V
(1982-1983), dei Trasporti nel Craxi I e II (1983-1987). Da ultimo nel Pd: nel
2007 partecipò alle primarie per l’assemblea costituente ma non fu eletto,
«comunque va bene anche così: la nostra lista ha raccolto un bel po’ di voti.
Mentre lo Sdi guarda al passato, noi andiamo verso il futuro».
«Faceva rima con ferrovie, dove c’era un treno, un ponte, una bretella c’era
lui» (Antonello Caporale).
«È stato uno dei grandi leader del Partito socialista, uno dei protagonisti
della svolta del Midas che vide l’inizio dell’ascesa di Bettino Craxi. Quando il
suo partito è stato travolto da Mani Pulite, si è chiamato fuori. Mentre la
maggior parte dei suoi compagni migrava verso Arcore lui è rimasto socialista,
anzi socialista di sinistra» (Claudio Sabelli Fioretti).
Famiglia borghese. Elementari e medie a Bari, liceo a Taranto, università a
Roma. «La mia generazione era indifferente tra socialisti e comunisti. Era la
sinistra. Il mio primo comizio lo feci a Roccanova, in un fienile che era
insieme sezione della Cgil, del Psi e del Pci. La scelta socialista la feci dopo
l’Ungheria».
Giorgio Dell’Arti - Massimo Parrini Catalogo dei
viventi 2009, Marsilio
Taranto: la città in cui una parte della Magistratura si è ribellata totalmente
al Potere Politico, scrive Michele Imperio su “La Notte On Line”. Procede nel
caos più assoluto l’opera risanatrice – se così si può chiamare – dell’Ilva di
Taranto. I fatti più recenti sono che il g.i.p. del Tribunale di Taranto che si
occupa di questa vicenda Patrizia Todisco ha respinto un’istanza del commissario
governativo Sandro Bondi intesa a ottenere il reimpiego nell’opera di
risanamento di 230 milioni di euro sequestrati alla famiglia Riva, come disposto
da una delle leggi chiamate salva-Ilva, minacciando un nuovo sequestro senza
facoltà d’uso da parte del Procuratore della Repubblica Franco Sebastio perchè i
lavori di risanamento si stanno svolgendo con ritardo. Ormai tutti a Taranto
hanno compreso che, al di là della vicenda giuridica e dell’opera risanatrice,
due schieramenti sono a confronto in singolar tenzone fra loro. L’uno che vuole
ribaltare la titolarità dello stabilimento e passarlo dai Riva ad un altro
gruppo industriale, segnatamente i Gavio, dei quali – secondo taluni – sarebbe
socio occulto il potente ex Ministro dei Trasporti tarantino Claudio Signorile,
l’altro invece che vorrebbe risanare l’Ilva nel segno della continuità della
famiglia Riva. Il primo schieramento si fa forte di alcuni segmenti mediatici e
politici. Scrive l’Huffigston post un blog molto vicino al settimanale
“L’Espresso” e quindi all’ex Sinistra democristiana di Carlo De Benedetti e di
Matteo Renzi: “La storia dell’Ilva è nota, ed è noto che dopo anni di colpevole
distrazione la magistratura è intervenuta per riportare legalità nel polo
siderurgico tarantino, uno dei più grandi e dei peggio gestiti, rispetto
all’impatto su ambiente e salute, del mondo. Diranno le sentenze, se e quando
arriveranno, in che dimensione e fino a quale profondità la politica nazionale e
locale si sia fatta autrice o complice di reati; in particolare complice dei
reati contestati alla famiglia Riva, che acquistò per poche lire la fabbrica
dall’Iri negli anni ’90 e per quindici anni ha accumulato miliardi di profitti
(Falso: Riva ha gestito l’Ilva per quindici anni l’ha pagata un miliardo e mezzo
di vecchie lire nel 1995 il massimo che potesse pagare un imprenditore privato
dell’acciaio italiano in quanto la produzione di acciaio era stata fino ad
allora quasi tutta in mano pubblica e negli anni buoni i profitti sono ammontati
fino a un massimo di 800 milioni di euro ma poi ci sono stati anche gli anni di
crisi n.d.r.) senza impiegarne lo “zero virgola” per ridurre, come prescrive la
legge e come si è fatto nella siderurgia di mezzo mondo dalla Germania alla
Corea (con il concorso finanziario al 50% dello Stato, che in Italia invece non
vuole contribuire n.d.r.), la potenza di avvelenamento dei forni e dei depositi
(tuttora a cielo aperto) di ferro e carbone (Falso anche questo: Riva ha
investito in ambientalizzazione e precisamente in elettrofiltri, sistema
dell’urea, altoforno 4 rifatto ex novo e altre opere oltre 4 miliardi di euro
n.d.r). Ma in attesa dei processi e delle sentenze – continua l’Huffigton post –
alcune verità già sono assodate. Una è che dei veleni dell’Ilva e delle
omissioni dei Riva si sa da tempo. Le prime denunce sull’altissimo impatto
inquinante della fabbrica di acciaio tarantina risalgono a più di vent’anni fa,
merito di associazioni ecologiste e di gruppi auto-organizzati di abitanti di
Taranto che a lungo sono stati gli unici a urlare che mettere lavoro contro
ambiente e salute era una scelta senza dignità e senza futuro. Gli altri, quasi
tutti gli altri, hanno lasciato che il problema marcisse: l’azienda
naturalmente, il sindacato, la politica. Di questa fitta rete di silenzi,
compiacenze e aperte complicità ha fatto parte integrante la sinistra, che
governa la Regione da 8 anni e Taranto da 6. La sinistra che con troppi suoi
esponenti sia locali che nazionali ha intrattenuto robuste relazioni “informali”
con i Riva: valgano per tutti gli esempi di Pierluigi Bersani (ieri osannato in
quanto supporter di Prodi presidente della Repubblica oggi invece criminalizzato
in quanto ostile a Matteo Renzi n.d.r.), che da responsabile economico dei Ds
accolse dai proprietari dell’Ilva nel 2006 un finanziamento elettorale di 100
mila euro – formalmente lecito ma quanto meno “inopportuno” -, o di Ludovico
Vico, già deputato Pd e oggi commissario del Partito democratico a Lecce, che
nel 2010 al telefono con Girolamo Archinà (“spicciafaccende” dei Riva)
prometteva di far “buttare sangue” a uno dei due scriventi, colpevole di
battersi in Parlamento contro un’ennesima norma “ad aziendam” inventata per
legalizzare l’illegalità dell’Ilva.” Il segmento politico che appoggia i Gavio è
quello che ruota attorno al ministro dell’economia Fabrizio Saccomanni
dell’allegra brigata Saccomanni, Draghi, gitanti del Britannia e vari e della
rediviva corrente del P.D. che fa capo all’on.le Claudio Signorile.
L’imprenditore Beniamino Gavio aveva dato notizia tramite il quotidiano
“Repubblica” di essere a capo di una cordata di imprenditori interessata a
rilevare l’Ilva e a risanarla. Tra questi aveva incluso anche l’imprenditore
Vittorio Malacalza imprenditore notoriamente molto liquido. Ma intervistato da
“Il Messaggero” Vittorio Malacalza lo ha smentito: “La cordata di imprenditori
per l’Ilva proposta da Beniamino Gavio – ha detto – “non e’ una boutade”, ma “e’
un”operazione difficile” e la famiglia Malacalza al momento non intende farsi
coinvolgere. Ho letto le dichiarazioni di Gavio e, dopo quell’ipotesi qualcuno
mi ha anche chiamato dal ministero dell’Economia per sapere se veramente eravamo
interessati. Dunque il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni spinge in
questa direzione. Gavio quindi ha bleffato dichiarando disponibilità che in
effetti non ci sono e quindi – allo stato – l’ipotesi più plausibile per un
risanamento italiano (a meno che non si voglia dare anche l’Ilva a soggetti
stranieri) rimane ancora quella dei Riva, i quali sono già titolari dello
stabilimento e quindi non devono alcunchè per rilevarlo e inoltre sono gli
imprenditori dell’acciaio in Italia dotati ancora di maggiori disponibilità
finanziarie. Ma Emilio Riva il capostipite fiaccato dai processi e ormai
ottantaseienne sta morendo e i figli vorrebbero – giustamente – una garanzia
politica che lo stabilimento dopo il risanamento rimanga il loro e non passi
invece, risanato e per un piatto di lenticchie a qualche altro imprenditore
sostenuto da parti politiche a loro avverse. A livello mediatico i Riva non
hanno alcuno sponsor mentre a livello politico essi sono – forse – sostenuti
dall’attuale ministro dell’Ambiente Andrea Orlando, il quale recentemente ha
autorizzato con decreto ministeriale senza prescrizioni alcune discariche
interne all’Ilva per le quali la Procura della Repubblica di Taranto,
ritenendole illegittime, aveva disposto addirittura l’arresto del presidente
della Provincia Gianni Florido ultimo dei moikani P.D. pro-Riva e tuttora
detenuto neanche per averle autorizzate ma solo per aver tentato, senza
riuscirci, di farle autorizzare con prescrizioni. Ma i Riva sono mal visti dal
gruppo pelilliano-signoriliano che attualmente spadroneggia nel P.D. tarantino.
All’ultimo congresso provinciale del P.D. i floridiani (ossia i seguaci del
presidente della Provincia Gianni Florido attualmente detenuto per la questione
delle discariche e di tendenza lavorista) sono praticamente scomparsi e tutta la
segreteria comunale e provinciale si compone ora di pelilliani-signoriliani
(pelilliani da Michele Pelillo deputato unico rappresentate del P.D. tarantino
in Parlamento e vicino alle posizioni dell’on.le Claudio Signorile) i quali ora
si atteggiano a spassionati ambientalisti. C’è stato alcuni mesi fa un
referendum cittadino in questo senso cha ha visto la partecipazione di solo il
15% della cittadinanza, a riprova del favore della cittadinanza per il
risanamento e non per la dismissione dell’impianto. Ebbene il nuovo segretario
del P.D. Walter Musillo appena eletto, ha significativamente dichiarato: “Al
referendum per la dismissione o la continuità dell’Ilva ho votato per la totale
dismissione dell’Ilva”. Quasi a voler far intendere quale sarà la sua linea
politica: spingere per la dismissione totale dell’impianto per assimilare il
P.d. alla Todisco, agli ambientalisti e ai grillini e al tempo stesso per
favorire lo spossessamento della titolarità dello stabilimento in capo ai Riva
se dovesse prendere piede il piano Gavio-Signorile.
Continua Michele Imperio su “La Notte On Line”. Il partito socialista dal nostro
punto di vista era un bel partito. Ha garantito liberà e benessere agli italiani
per quasi cinquanta anni (1945-1992). Ha supportato molti imprenditori di
successo che hanno dato benessere e occupazione a migliaia di famiglie italiane.
Però il Partito Socialista aveva al suo interno una pecora zoppa. Questa pecora
zoppa era l’on.le Claudio Signorile. Anche lui come altri esponenti socialisti
ha puntato su alcuni imprenditori Lucio Manisco Simi, Aldo Belleli (Belleli) ma
poi li ha scaricati. I maligni dicono perchè non ha ricevuto quanto richiesto.
Però non si possono comprendere – secondo noi – le odierne vicende giudiziarie
dell’Ilva di Taranto se prima non si conoscono sia pure per pochi cenni le
vicende personali di questo ex parlamentare. Dopo le stragi palermitane del 1992
che servirono – come disse Riina – a sbalzare di sella Craxi e Andreotti e dopo
le inchieste parallele alle stragi cosiddette di Tangentopoli, nessun socialista
è rimasto politicamente in vita tranne lui Claudio Signorile. Nessuna inchiesta
lo ha mai sfiorato né mai la stampa ha pronunciato il suo nome. Una volta è
stato processato e condannato a tre anni di reclusione per la bancarotta
fraudolenta di Edilevante la società che gestiva il giornale di sua proprietà il
Quotidiano di Lecce Brindisi e Taranto. Ebbene mai alcun giornale locale ha
dedicato un rigo a questa vicenda. Mai! Chi lo ha saputo, se lo ha saputo, è per
il tramite del passaparola. Sicuramente ha entratura anche in magistratura
perchè le inchieste sul finanziamento illegale del partito socialista non lo
hanno mai nemmeno sfiorato. Nel tempo Signorile ha fatto una metamorfosi, si è
trasformato da uomo politico in business men, cioè il soggetto che mette la sua
fitta rete di relazioni nella stampa, nella politica, probabilmente anche nella
magistratura a disposizione di imprenditori che vogliono emergere e che sorretti
da lui, effettivamente emergono. Che stia ora dietro i Gavio non è un mistero
per nessuno e – guarda caso – Bemiamino Gavio da Alessandria è già – in pratica
– il principale imprenditore che opera nel porto di Taranto. Ora è anche
interessato a rilevare l’Ilva. Lo dice lui stesso al quotidiano “Repubblica”:
«Sono pronto a dar vita a una cordata con banche e imprenditori per rilevare
l’Ilva». L’annuncio di una nuova avventura imprenditoriale in uno dei pochi
business che ancora mancano al gruppo, l’acciaio, oppure una sorta di chiamata
alle armi della migliore imprenditoria italiana per evitare che il colosso
malato faccia la fine di Parmalat e, una volta risanato, finisca in mani
straniere? La battaglia perduta con il gruppo Salini per il controllo di
Impregilo si è conclusa con una buonuscita di poco inferiore ai cinquecento
milioni. E ora questa liquidità potrebbe essere investita in nuove operazioni.
Magari in alleanza con l’altra famiglia più liquida d’Italia, i Malacalza, che
dall’addio alla produzione siderurgica hanno incassato più di un miliardo di
euro. Il patron Vittorio, che di Marcellino Gavio, padre di Beniamino era grande
amico, per il momento resta alla finestra. Lui non è uomo da cordata, anche se
ritiene la sfida “stimolante e difficile”, ma la mossa di Gavio ha bisogno dei
suoi tempi e potrebbe presto riservare nuove sorprese. Si tratta solo di
attendere, anche perché nella massima riservatezza il governo sarebbe già sceso
in campo per verificare le reali disponibilità delle banche e degli imprenditori
“sollecitati” da Beniamino Gavio con le sue dichiarazioni. Signorile ha sempre
considerato Taranto una cosa sua e ha sempre concorso indirettamente per
l’elezione del sindaco. Nel 1993 totalmente integrato nel PDS dopo la fine
rovinosa del partito socialista Signorile in pieno scandalo delle lenzuola
d’oro, uno scandalo che sembrava doverlo lambire ma che poi – dopo la morte
misteriosa di Ludovico Ligato - non lo ha più interessato, impose alla Sinistra
tarantina il suo candidato sindaco che era nientedimeno che l’allora Procuratore
Aggiunto della Repubblica Gaetano Minervini, quindi un Magistrato. Minervini
perse le elezioni non fu eletto sindaco. La colpa fu attribuita alla
sponsorizzazione di Signorile il quale, per questo motivo venne temporaneamente
scaricato dal PDS. Un altro sarebbe a quel punto politicamente morto ma
Signorile no, lui può fare tutto quello che vuole, stare a destra come stare a
sinistra. Fa un accordo con Silvio Berlusconi per le successive elezioni
regionali. La sua nuova proiezione politica, la dott.sa Rossana Di Bello (Forza
Italia), eletta alla Regione Puglia nel listino bloccato senza voti, diventa
immediatamente assessore regionale al turismo nella Giunta Distaso
(centro-destra) e poi per due volte sindaco di Taranto per un centro-destra di
marca finiana-democristiana che esclude la destra civica locale. Sia nella prima
che nella seconda occasione Claudio Signorile si mobilita a suo sostegno. Ma un
anno dopo la sua seconda elezione Signorile ripassa nel P.D., la dott.sa Di
Bello non lo segue e litiga con l’ex parlamentare. Ebbene sul capo della dott.sa
Di Bello si riversano quasi contemporaneamente un dissesto dei conti del Comune
e trentasei processi per abuso innominato in atti d’ufficio più la minaccia di
un mandato di cattura se non si dimette immediatamente da sindaco. Lei si
dimette – ovviamente – ma dopo nella fase dibattimentale in nessuno di questi
trentasei processi la Giudicante trova il vantaggio patrimoniale essenziale e la
sussistenza del reato. Dunque per trentacinque volte la Di Bello viene assolta.
Manca ancora all’appello il trentaseiesimo processo da cui pure la dott.sa
Rosanna Di Bello sarà assolta ma che viene di volta in volta rinviato per non
sbloccare il sequestro dei beni del coimputato l’ex vicesindaco di Taranto on.le
Michele Tucci, con grave disdoro della Procura della Repubblica. Il giudice che
ha istruito questi trentasei processi è la stessa persona che il Procuratore
capo della Repubblica Franco Sebastio ha selezionato all’atto del al suo
insediamento (2009) – su diciannove magistrati in organico alla Procura della
Repubblica di Taranto – per condurre l’inchiesta “Ambiente Svenduto” quella che
riguarda le presunte corruzioni poste in essere dall’Ilva per andare avanti in
condizioni di illegalità sotto il profilo del’impatto ambientale. Questo
Magistrato che conduce questa inchiesta ha sicuramente qualche contatto con il
signoriliano onorevole Michele Pelillo se è vero come è vero che a inizio 2012
quando c’è la campagna elettorale per l’elezione del sindaco (vinta dal
vendoliano Ippazio Stefano proprio grazie al veto opposto dalla direzione
regionale del P.D. alla candidatura del signoriliano Michele Pelillo) Pelillo in
televisione dichiara furioso: IO SO CHI NON VUOLE CHE IO DIVENTI SINDACO A
TARANTO! CHI NON LO VUOLE E’ LA GRANDE INDUSTRIA, MA VEDRETE!!!!!!!! VEDRETE
CHE FINE FARA’ LA GRANDE INDUSTRIA!!!!!!!!!! VEDRETE!!!!!!!!!!!! E infatti pochi
mesi dopo a luglio 2012 dopo che Ippazio Stefano ha vinto le elezioni comunali
(si dice per l’appoggio di Emilio Riva patron dell’Ilva) parte con gran clamore
l’inchiesta sull’Ilva con il sequestro senza facoltà d’uso dell’impianto (per
fortuna non andato in porto grazie all’intervento del governo che così ha
evitato che quarantamila lavoratori fra occupazione diretta e indotta fra
Taranto e Genova andassero a spasso) l’arresto di Emilio e Nicola Riva i
titolari dello stabilimento poi esteso anche al figlio di Emilio Fabio Riva
tuttora latitante a Londra, l’arresto dell’addetto alle pubbliche relazioni
dell’Ilva Girolamo Archinà, dell’assessore provinciale Michele Conserva, del
presidente della Provincia Gianni Florido, l’incriminazione a piede libero del
governatore della Puglia Niky Vendola dell’assessore all’ambiente Lorenzo
Nicastro,, dell’onorevole Nicola Fratoianni, del sindaco di Taranto Ippazio
Stefano, il maxisequestro di otto miliardi di euro in danno della famiglia Riva.
Insomma una strage. L’inchiesta è sicuramente una risposta al dramma ambientale
tarantino, laddove l’inquinamento prodotto dall’Ilva (ma non solo dall’Ilva) è
tale che ci sono bambini che si ammalano di cancro a sette anni e che
consapevoli del loro destino scrivono al padre: Papà distruggi quel mostro
(riferito all’Ilva)! Ma dietro il dramma c’è anche la strumentalizzazione. Se ne
accorge per primo il vescovo di Taranto Mons. Benigno Papa il quale già nel 2009
pubblicamente denuncia: “quello che non dovrebbe accadere è cavalcare la giusta
tematica della salvaguardia dell’ambiente per motivazioni strumentali cioè non
tanto perchè stia veramente a cuore questo problema ma perché dalla protesta si
possa ricavare un qualche utile personale o di gruppo. Qualora dovesse accadere
questo, dovrei pensare che ci sia un inquinamento spirituale che è peggiore
dell’inquinamento ambientale!” Perchè parlava così? Era per caso informato
Benigno Papa di quanto alcuni Magistrati e alcuni politici stavano per fare?
Voleva mandare un messaggio a quei Magistrati? Non lo sappiamo. Sappiamo per
certo però che quelle parole sono state pagate a caro prezzo perché nel
Norimberga bis (così viene chiamato a Taranto il processo Ambiente svenduto con
56 imputati eccellenti) c’è anche il suo segretario particolare Marco Gerardo
che a momenti veniva arrestato dai magistrati della Procura per aver accettato
da Emilio Riva un contributo di poche migliaia di euro per una processione.
Alcuni addirittura insinuano che anche quella sarebbe stata una tangente.
Pazzesco! L’inchiesta “Norimberga bis” o “Ambiente Svenduto” come lo si vuol
chiamare, viene condotta con un sospetta severità : il presidente della
Provincia Gianni Florido ha una discussione con un suo funzionario Luigi
Romandini? Tentata concussione! Arrestato! Il presidente della Regione Niky
Vendola ha una discussione con un suo funzionario Giorgio Assennato?
Concussione! Incriminato! E hai voglia a chiarire da parte di Assennato per otto
ore che non c’è stata nessuna concussione. Solo differenti punti di vista tra
lui e il governatore Niky Vendola laddove alla fine Giorgio Assennato ha
riconosciuto che il presidente Vendola aveva ragione e lui torto! Niente da
fare! Incriminato anche lui! Per falsa testimonianza! Il sindaco di Taranto
Ippazio Stefano non ha avuto discussioni con nessuno (per fortuna sua) ma viene
incriminato lo stesso! Anche lui! Omissioni di atti d’ufficio! Non ha emesso
ordinanze contingibili e urgenti! Il sindaco confida agli amici: “Non capisco
cosa stia succedendo! Mi sento boicottato da tutti! In particolare da quelli del
P.D.”. In effetti i Magistrati cercano di creare un clima di “caccia alle
streghe” di “dagli all’untore” intorno all’inchiesta “Ambiente Svenduto”.
Chiunque non si è allineato sin da principio alla linea di ambientalismo estremo
sostenuta da verdi e grillini e anche dalla Procura viene criminalizzato. Ma ciò
non per ragioni di giustizia bensì per chiari scopi politici. Il primo è
chiaramente quello di assimilare i giudici e il P.D. al movimento ambientalista
estremo di Beppe Grillo: e quindi lo scopo è quello di fare di Taranto il primo
laboratorio politico in Italia per la formazione di una maggioranza alternativa
a quella delle larghe intese (Grillo-Verdi-P.D). Il secondo – come abbiamo già
detto – è quello di favorire il passaggio di proprietà dell’Ilva di Taranto a un
altro gruppo industriale che potrebbe diventare sponsor di quell’altra
maggioranza alternativa alle larghe intese. Lo denuncia questa volta non viene
dall’arcivescovo ma dal quotidiano “Il Sole 24 ore” L’intento dei giudici di
Taranto – scrive espressamente il giornale della Confindustria – sembra essere
quello di spossessare i Riva della titolarità della fabbrica.
L’Ilva di Taranto è strettamente connessa all’Ilva di Genova nel senso che a
Taranto si produce l’acciaio a caldo che serve anche alle produzioni a freddo di
Genova, continua Michele Imperio su “La Notte On Line”. Se si ferma l’Ilva di
Taranto si ferma anche l’Ilva di Genova. Né si possono differenziare le due
proprietà nel senso di attribuire a una famiglia la proprietà dello stabilimento
di Taranto e ad altra famiglia la proprietà dello stabilimento di Genova. Questa
è la principale ragione per cui è in atto un incredibile scontro fra
Magistratura e Potere Politico. Da una parte infatti quella fetta di
Magistratura tarantina di fede o di impronta signoriliana (diciamo così ) fa il
tifo per la soluzione Gavio-Signorile. Dall’altra parte il
Potere Politico ligure ma anche quello nazionale semplicemente aborriscono
all’idea che le maestranze liguri possano finire sotto le grinfie di un
Signorile e si comportano di conseguenza. Secondo il Procuratore
generale della Corte di Appello di Lecce Giuseppe Vignola,
Magistrato integerrimo e universalmente stimato, la mossa di minacciare la
chiusura totale e definitiva dell’Ilva adottata dal dott. Franco
Sebastio Procuratore Capo della Repubblica di Taranto il 12 luglio 2012
era una mossa tendente in realtà a sollecitare il Governo a revisionare l’Aia
concessa all’Ilva. Infatti un un’intervista a “Repubblica” del 18 agosto u.s. il
dott. Giuseppe Vignola ha così dichiarato: “Questa (la
revisione dell’Aia) è proprio una bella notizia. Leggo che i ministri hanno
sostanzialmente recepito tutte le nostre indicazioni, facendole proprie e
inserendole come diktat nell’Aia, l’autorizzazione governativa che permette
all’Ilva di lavorare. Se non le rispettano, devono chiudere. È lo stesso
concetto che sostenevamo noi. Significa quindi che quello che era stato fatto
andava nella direzione giusta, e soprattutto che non eravamo impazziti. Ordinare
la chiusura di una produzione industriale è stato un provvedimento assai
sofferto, ma secondo noi era l’unica strada percorribile. Il punto principale è
che l’Ilva rispetti le prescrizioni. Se lo può fare, continuando a produrre per
noi non ci sono problemi. La risposta in questo senso la potranno dare i tecnici
che sono stati nominati custodi, ma credo che sia assolutamente possibile. Fermo
restando la legge, deve prevalere il buon senso………… Il sequestro era
inevitabile. Siamo di fronte a un lavoro davvero ineccepibile che non ci
lasciava altre strade, visto anche l’atteggiamento tenuto fino a quel momento
dell’Ilva. L’azienda, lo dissi subito dopo il sequestro, di giorno rispettava le
prescrizioni imposte e di notte le violava come confermano i rilievi fotografici
che abbiamo eseguito per più di un mese nel corso dell’inchiesta. Non era un
atteggiamento collaborativo e la maggior parte delle volte nascondeva i problemi
con interventi di facciata. Sono davvero contento dell’intervento del governo.
Mai come in questo momento sono contento della sintonia tra pezzi dello Stato
proprio nel momento in cui sembrava riprodursi un braccio di ferro tra politica
e magistratura. Mi dà tranquillità, non volevamo sentirci soli in una battaglia
così importante. Una battaglia che stiamo vincendo”. Quindi un conflitto
Magistratura -potere Politico, secondo Vignola, solo apparente e momentaneo e
rivolto a fin di bene. Però i Magistrati tarantini, che fino a un certo punto si
sono coordinati con lui, non sono sembrati poi del suo stesso parere. Infatti
subito dopo l’emissione dell’AIA la Procura di Taranto ha abbandonato questo
coordinamento (diciamo così) con la Procura Generale di Lecce e ha imbastito
invece una strana alleanza con la Procura della Repubblica di Milano. Infatti
Procura di Taranto e Procura di Milano in sinergia fra loro dopo la revisione
dell’Aia e al fine di far fallire ogni possibile accordo fra Stato e impresa,
hanno caricato l’Ilva di due sequestri non a caso notificati a Riva lo stesso
giorno. uno del valore di otto miliardi e mezzo di euro proveniente dalla
Procura della Repubblica di Taranto , l’altro del valore di un miliardo e mezzo
di euro proveniente dalla Procura della Repubblica di Milano per frode fiscale,
provvedimenti che – peraltro – hanno inibito Riva dal
presentare e dal finanziare il piano industriale per il risanamento, che doveva
essere presentato il giorno dopo. Come si spiega allora questa mossa,
particolarmente aggressiva, con le parole rassicuranti del Procuratore Generale
della Corte di Appello di Lecce? Il tempestivo intervento della Procura della
Repubblica di Milano in questa vicenda fa pensare invece all’ennesimo tentativo
di questo Ufficio Giudiziario di voler condizionare al massimo livello possibile
tutte le vicende politiche di questo paese nel terrore che possa salire al
Potere un giorno una coalizione di governo che faccia finalmente luce sia sulle
odiose responsabilità di questa Procura nelle stragi di Palermo del 1992 (ne era
sicuramente coinvolto il suo giudice Francesco Di Maggio e i
suoi due agenti segreti a lui più vicini gli ordinovisti neofascisti
Rosario Cataffi e Giuseppe Gullotti) sia sulle sue altrettanto odiose
responsabilità nella cosiddetta trattativa Stato-Magistratura-Mafia, che
cominciò proprio a Milano nel 1994 quando alcuni Magistrati della Procura della
Repubblica di Milano (e segnatamente – secondo la denuncia di Pierluigi
Vigna Armando Spataro, Francesco Di Maggio e Alberto Nobili,
marito di Ilda Boccassini) decisero di coprire i miliardari
traffici illeciti dell’Autoparco Milanese di Cosa Nostra in cambio di indicibili
contropartite politiche. Quali odiose manovre politiche si nascondono dunque
dietro lo smarcamento dalla Procura Generale di Lecce sotto questa nuova
sinergia fra Procura della Repubblica di Taranto e Procura della Repubblica di
Milano? Otto miliardi di euro di cui si vorrebbe il sequestro in danno dei
Riva sarebbe il costo delle opere di risanamento ambientale che
Riva in questi anni non avrebbe fatto per ambientalizzare lo stabilimento. Si
tratta chiaramente di una cifra esagerata, cui si è giunti sulla base della
stima di uan semplice impiegata dell’Arpa Puglia Barbara Valenzano.
Peraltro Riva ha acquistato l’impianto sedici anni fa (1996) e
il massimo dell’utile netto di esercizio è stato di 800 milioni di euro. Poi ci
sono stati anche gli anni in cui l’utile è stato sensibilmente inferiore.
Riva – peraltro – ha già investito in ambientalizzazioni
quattro miliardi e mezzo di euro. Dunque quelle somme non le ha mai guadagnate.
Come si può pretendere da un imprenditore che debba spendere più di quanto
incassa? Ad imposibilia nemo tenetur – dicevano i latini. I tecnici del
Ministero dell’Ambiente che hanno revisionato l’AIA hanno invece quantificato il
valore delle opere di ambientalizzazione in un miliardo e ottocento milioni di
euro. Naturalmente nessuno dice la verità. La verità è che l’Ilva di Taranto
guadagna in modo esponenziale in funzione della produzione ed è congegnata nel
senso che se produce sette milioni di tonnellata d’acciaio pareggia i costi, se
produce otto milioni di tonnellate d’acciaio guadagna se produce nove milioni di
tonnellate di acciaio guadagna bene se produce dai dieci milioni di tonnellate
in su straguadagna. Fino al 2002 Riva è stato autorizzato a produrre fino a otto
milioni di tonnellate di acciaio. Dopo il 2002 con la concentrazione su Taranto
delle produzioni a caldo di Taranto e di Genova Riva è stato autorizzato a
produrre fino a dodici milioni di acciaio a caldo con l’intesa però che il
superguadagno sarebbe stato destinato anche al risanamento ambientale,
risanamento che, fino a oggi, con le violazioni che denunciava Vignola, aveva
fatto solo parzialmente. Gli aneliti affaristici e i giochi di potere di cui
abbiamo parlato nelle puntate scorse, confermati da questa sinergia fra Procura
di Taranto e Procura di Milano (i due Uffici fanno anche riunioni congiunte per
meglio coordinarsi) hanno fatto sì che tutte le regole codicistiche che
ripartiscono funzioni e ruoli dei vari uffici giudiziari in questo processo
siano saltate. Soprattutto è mancata la figura del giudice terzo fra accusa e
difesa ruolo totalmente obliterato dalla dott.sa Patrizia Todisco.
Com’è noto il legislatore istituì la figura del g.i.p. come giudice terzo che
doveva verificare se l’attività istruttoria dei P.M. fosse eccessivamente
sbilanciata rispetto alle posizioni dell’accusa e nel caso attenuarla. Invece in
questo processo il g.i.p. Patrizia Todisco si è spesso
affiancata all’azione dei pubblici ministeri a volte scavalcandoli come quando
ad esempio con un’ordinanza di 500 pagine ha sollecitato l’incriminazione del
governatore della Puglia Niky Vendola (per molto meno la dott.ssa
Clementina Forleo fu trasferita su due piedi da Milano a Cremona)
oppure (caso ancora più clamoroso) quando ha sequestrato al liquidità delle
aziende dei Riva a Brescia e a Verona contro la volontà dichiarata anche alle
stampe del Procuratore capo della Repubblica di Taranto Franco Sebastio.
Avendo capito che identificandosi ancora in Riva la titolarità
dell’azienda ogni mossa della magistratura tarantina (e milanese) provocava il
plauso fragoroso del popolo ambientalista e grillino schizzato a Taranto a
percentuali vicine al 33% dei consensi, il Potere Politico ligure abilmente
gestito dal valoroso esponente del P.D. Andrea Orlando attuale ministro
dell’ambiente e quello nazionale a un certo punto hanno sostituito Riva con due
figure neutre i commissari Sandro Bondi e Edo Ronchi ma
l’aggressione giudiziaria contro l’Ilva al di là dei buoni intendimenti del
Procuratore generale di Lecce Giuseppe Vignola è continuata lo
stesso. Quattro mesi fa invocando l’ottemperanza di una legge salva-Ilva il
commissario Bondi aveva chiesto lo sblocco di 230 milioni di euro sequestrati ai
Riva per destinarli al risanamento dell’impianto. Per quattro mesi la dott.sa
Patrizia Todisco non ha risposto. Dopo quattro mesi ha
risposto: rigetto perchè il lavori si stanno svolgendo con ritardo. In realtà le
opere sono state tutte appaltate ma sono ferme perchè i sindacati nazionali
vorrebbero il coinvolgimento delle imprese locali. E mentre l’Ilva rischia di
fermarsi di nuovo, l’impresa Marcegaglia (pannelli
fotovoltaici) ha annunciato la cessazione delle attività della sua azienda a
Taranto, con la conseguente chiusura e il licenziamento di 134 dipendenti, dal
prossimo 31 dicembre 2013. Vestas (turbine eoliche) ha confermato la
indisponibilità’ a riaprire l’attività’ di produzione delle turbine eoliche nel
sito di Taranto e conseguentemente ha confermato l’esubero di 120 unità’
lavorative (solo parte dei quali saranno riassorbiti in un altro sito
industriale della stessa azienda sul posto). A giorni anche Evergrin
(trasporti marittimi) annuncerà il proprio disimpegno da Taranto per trasferirsi
in un porto istriano, con il licenziamento di altre migliaia di lavoratori. Poi
sarà la volta dell’Ilva stessa che annuncerà che a Taranto continuerà solo la
produzione a freddo perché la produzione a caldo sarà trasferita almeno
momentaneamente in Brasile (il che significherà il licenziamento di altri 5.000
dipendenti). Certo, ognuno ha le sue buone ragioni ufficiali, ma perchè tutti
assieme? Quanto avrà inciso alla fine su questa devastazione occupazionale di
Taranto il conflitto – che c’è, nessuno lo può negare – tra una parte della
Magistratura tarantina e il Potere Politico Nazionale?
Io, la sinistra e i meriti di Craxi".
Amato: quanti errori, ma fu un rapporto pulito, scrive Franca Selvatici
su “La Repubblica”.
Presidente Amato, molti vorrebbero capire come e perché la sua
storia politica la portò al fianco di Craxi, a condividerne le responsabilità e
le idee; come e perché foste insieme per anni, come e perché lui e altri furono
travolti dalla slavina politica e lei invece no.
"Dovremo fare un passo indietro e cominciare dall'epoca in cui Bettino Craxi
emerse nella politica italiana, quando il Psi sembrava affondare (...) Nel
partito il nostro leader di riferimento restava Giolitti, ma lo scossone interno
al partito, nel famoso Comitato centrale dell'hotel Midas, portò all'ascesa di
Craxi come segretario. Ci aspettavamo che fosse possibile eleggere Giolitti alla
segreteria e invece un'intesa tra quelli che chiamavamo "i colonnelli" (Craxi,
Claudio Signorile, Enrico Manca) lo aveva impedito. Tuttavia pensavamo che il
nuovo assetto interno non avrebbe retto, che la competizione tra le correnti
avrebbe reso la situazione altamente instabile. Più avanti, nel 1980, ci fu un
Comitato centrale in cui sembrava che la prospettiva di una segreteria Giolitti
si potesse realizzare. All'epoca non ricoprivo una posizione dirigenziale nel
partito, ma facevo parte del Cc e del gruppo che si riconosceva in Giolitti.
Grazie al rapporto che avevo con Norberto Bobbio, convinsi anche lui a
partecipare alla riunione per sostenere la candidatura giolittiana. Ma in
quell'occasione furono due, a mio avviso, gli eventi determinanti. Il primo fu
il discorso dello stesso Giolitti, che non riuscì a far breccia nella
maggioranza. L'altro fu il sostegno fornito a Craxi da Gianni De Michelis, che
si staccò dalla corrente della sinistra lombardiana guidata da Signorile. A quel
punto non c'era più nulla da fare (...)".
Il tentativo di farlo fuori deve averlo non poco innervosito.
"Passò del tempo e dovetti riconoscere che Craxi, ormai saldamente in sella come
segretario del Psi, si era dimostrato in grado di fare cose di cui prima, per
quel poco che lo conoscevo, non lo avrei creduto capace. A un certo punto
maturarono in me due convinzioni. La prima era che l'uomo era riuscito a dare
una voce unica ai socialisti, accrescendone enormemente la credibilità. Per
lungo tempo il Psi era stato visto come un partito in cui non c'era accordo su
nulla (...). Con Craxi tutto ciò era finito: era lui ad esprimere la posizione
socialista, sovrastando ogni altra voce. Il suo secondo merito era stato quello
di agganciare il Psi alla famiglia del socialismo internazionale. Così, in una
successiva riunione del Cc socialista, intervenni per differenziarmi dalla
componente giolittiana. Piuttosto che rimanere su un'incerta posizione di
astensione, dissi, è meglio prendere "il Craxi per le corna" cioè accettarne
pregi e difetti per lavorare con lui in un clima di leale cooperazione".
Molti ebbero l'impressione che a un certo punto, negli anni del
pentapartito, l'obiettivo ultimo dell'alternativa fosse andato smarrito.
"Questo fu materia di disputa tra me e Giolitti. Si può dire che Craxi, una
volta rientrato il Psi al governo, avesse abbandonato l'orizzonte
dell'alternativa, assumendo come prospettiva strategica l'alleanza con la Dc? Io
continuavo a pensare che non fosse così. Per come si misero poi le cose nel
1989-90, devo dire che forse aveva ragione Giolitti. Ma il governo Craxi, nel
1983, nacque all'insegna di una felice ambivalenza. E all'epoca il Psi
raccoglieva consensi proprio in questa prospettiva".
Nel 1983 lei fu chiamato da Craxi al governo, come
sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Qui viene la fase centrale della
sua esperienza con lui. Fu all'altezza delle aspettative che la avevano spinta a
schierarsi con lui e a separarsi da Giolitti?
"Sì, e a Palazzo Chigi vidi emergere altre doti del personaggio. Constatai che,
dopo aver affermato la predominanza della propria voce sul cicaleccio del Psi,
si rivelava in grado di imporsi e decidere anche in sede di governo. In un
esecutivo di coalizione è fondamentale che il capo del governo senta il momento
della decisione, se ne assuma la responsabilità e la sappia imporre, facendo
percepire a tutti che la scelta tocca a lui e a nessun altro. Ebbene, questa
capacità Craxi la dimostrò più volte in modo efficacissimo. Si ricorda
soprattutto il clamoroso episodio di Sigonella, che suscitò consensi anche a
sinistra per una certa riscoperta dell'orgoglio nazionale nei riguardi degli
Stati Uniti (...). Penso poi alla decisione di scommettere la testa, nel 1985,
sul referendum promosso dal Pci per abrogare il decreto che aveva tagliato la
scala mobile: fu una scelta salvifica per l'economia nazionale. Ma Craxi lo
emanò anche perché su quel terreno era in grado di contrapporsi ai comunisti, di
sfidarli in un duello che lui aveva la possibilità di vincere".
Nello scontro tra Berlinguer e Craxi, che divampò sulla scala
mobile, c'erano anche altre poste. La questione morale era già un problema
acuto.
"C'è da osservare come i due leader concentrassero la loro attenzione su aspetti
diversi ed egualmente importanti della crisi italiana, ma come nessuno dei due
riuscisse a cogliere quanto di buono c'era nelle posizioni dell'altro (...).
Berlinguer, tramontato il progetto del compromesso storico, aveva sottolineato
con forza la diversità comunista come espressione di una superiore tensione
morale, rispetto alle gravi degenerazioni della vita pubblica. A Craxi quel tema
non interessava: era un uomo di potere, attento anche ai poteri abusivi, e non
vide la portata di una questione che stava crescendo nel Paese. Nel Psi
cominciavano a emergere fenomeni negativi, ma non erano al centro della sua
attenzione. Al contrario Berlinguer aveva capito che la questione morale sarebbe
presto divenuta esplosiva, ma non avvertiva la domanda di un governo
responsabile che saliva dalla società".
La lotta tra Pci e Psi era una lotta per la vita o per la morte;
sia Craxi che Berlinguer sembravano viverla così. Il che lasciava ben poco
spazio a possibilità d'intesa.
"E' stata proprio questa attitudine a concepire la lotta politica in termini di
mors tua vita mea a determinare l'epilogo sbagliato del lungo duello a sinistra,
vanificando la "felice ambiguità" che avrebbe dovuto portare all'alternativa.
Ciò avvenne dopo la caduta del Muro di Berlino, quando i socialisti commisero un
errore letale, del quale anch'io, che pure non ero convinto della linea adottata
allora dal partito, devo assumere la mia parte di responsabilità. Qui
s'intrecciano comportamenti personali e fatti politici. Io non ero tra quelli
che dicevano sempre di sì a Craxi. Non era così il mio rapporto con lui. E a
volte lui si accorgeva che non ero d'accordo semplicemente perché tacevo.
Piuttosto che manifestare fragorosamente il mio dissenso, come faceva in qualche
occasione De Michelis, preferivo rimanere in silenzio. Perché lo facevo? Perché
sentivo la soverchiante autorità del capo? Oppure perché affidavo il rapporto
con il mio interlocutore a un gioco intellettuale, nel quale un'argomentazione
che non viene raccolta finisce per cadere? Non lo so, potrebbero essere vere
entrambe le cose. Fatto sta che molte volte Craxi aveva accolto il mio punto di
vista perché aveva percepito che io, tacendo, non condividevo il suo. Comunque
sia, dopo il 1989 Craxi era il leader potenziale di tutta la sinistra italiana".
Ma intanto arrivano governi democristiani: Fanfani, Goria, De
Mita, Andreotti e il Caf.
"Nella legislatura iniziata nel 1987, le ragioni della governabilità ci avevano
indotto a sostenere governi a guida democristiana. Ma gli eventi ormai stavano
maturando e pareva che quella fase di transizione storica dovesse finire. La
caduta del Muro faceva pensare che fosse ormai una questione di mesi. Ci fu il
governo Goria, nel quale io fui vicepresidente del Consiglio e ministro del
Tesoro. Lasciai il governo nel 1989, quando a Palazzo Chigi tornò Giulio
Andreotti, perché - così mi disse Craxi - con le mie politiche di bilancio e il
sostegno al ticket ospedaliero avevo superato il limite che il Psi poteva
tollerare. Se anche altre fossero le ragioni della mia esclusione
dall'esecutivo, non l'ho mai saputo (...). Per due mesi mi isolai completamente
nella mia casa di Ansedonia. Poi Craxi mi telefonò e mi prospettò l'ipotesi che
il partito, entrato Martelli al governo, avesse non più uno, ma tre
vicesegretari, tra i quali dovevo esserci anch'io. Accettai e tornai a via del
Corso, con un compito che in sostanza era sempre lo stesso e, lo sottolineo, non
aveva niente a che fare con l'amministrazione del partito. Era ormai alle spalle
il crollo del Muro di Berlino, il Pci si era sciolto, era nato il Pds. Quello
poteva essere l'anno della conquista di una sinistra unita. Quando cadde, nel
1991, il governo Andreotti, messo in crisi dal Psi, io ebbi la sensazione che
fosse arrivato il momento di sciogliere la "felice ambiguità" e puntare
sull'alternativa. Si trattava di provocare lo scioglimento anticipato delle
Camere e cambiare le carte in tavola. Il mondo mutava sotto i nostri occhi, era
caduto il Muro, la nostra collaborazione con la Dc si faceva sempre più stentata
(...). La crisi del 1991 sembrava offrire l'occasione per una svolta. Non andò
così. Per un insieme di circostanze, Craxi accettò che nascesse un nuovo governo
Andreotti. Osteggiato dalla Dc e dagli stessi pidiessini, che in teoria erano i
beneficiari della crisi, ma non osavano affrontare le elezioni, Craxi rinunciò.
E io ho sempre pensato che, nonostante le enormi difficoltà della situazione, il
Craxi di Sigonella non avrebbe rinunciato".
Aveva perso le doti dell'epoca di Palazzo Chigi? E come mai?
"Non so se avesse dei motivi particolari di preoccupazione. Forse ebbe un peso
anche la sua malattia, molto seria, alla quale teneva testa solo grazie alla sua
fibra veramente robusta, perché nei fatti non si curava, era sregolatissimo. Mi
venne detto da medici esperti che l'incedere del diabete determina anche
incertezze nuove nel carattere delle persone che ne soffrono. Può essere dunque
che il suo ritrarsi da una decisione rischiosa fosse anche la conseguenza di un
cattivo stato di salute. Certo è che fu un passaggio determinante, perché a quel
punto finimmo per contare più sulla definitiva disfatta dell'ex Pci che non
sulla prospettiva di assumere noi la guida della sinistra. Sbagliammo: invece di
attendere che il cadavere del Pds passasse sul fiume, avremmo dovuto invocare
noi le ragioni della convergenza. Questa fu la prima occasione nella quale colsi
in Craxi un certo appannamento. La seconda, notissima, riguardò il referendum
sulla preferenza unica. Craxi esortò gli elettori ad astenersi, chiese loro di
andare al mare e non ai seggi, senza rendersi conto che avrebbe ottenuto
l'effetto opposto" (...).
Poi nel 1992 esplose Tangentopoli, che costrinse Craxi a
rinunciare all'ipotesi di tornare a Palazzo Chigi. E a quel punto nacque il
primo governo Amato. Ci furono tentativi di coinvolgere direttamente Palazzo
Chigi nello scontro tra i giudici di Milano e i politici inquisiti.
"C'è, che molti mi rimproverano, del cosiddetto 'poker d'assi'. Io, come capo
del governo, non pensavo di dover partecipare alla direzione del partito né che
quella fosse la sede adatta per fare i conti con Antonio Di Pietro. Ci fu alla
fine di agosto, a via del Corso, una riunione cui Craxi mi invitò, perché
tenessi una relazione sulla situazione economica alla vigilia della legge
finanziaria. Io illustrai i problemi dei conti pubblici e poi lui affrontò
l'argomento Di Pietro, enumerando le accuse nei suoi confronti che sono passate
alla storia come "poker d'assi": un'espressione attribuita a Rino Formica,
benché lui non l'avesse usata. Da allora non partecipai più alla direzione del
Psi, anche perché non ero d'accordo con quel modo di procedere. Craxi, prima
dell'estate, aveva espresso più volte i suoi dubbi sulla persona di Di Pietro,
che poi sono stati anche oggetto di indagini della procura di Brescia, dalle
quali l'ex pm di Mani pulite è uscito completamente scagionato. All'epoca io,
Balzamo e Martelli suggerimmo a Craxi di passare quegli elementi ai suoi
avvocati, in modo che facessero un esposto in sede giudiziaria. Rimanemmo tutti
sorpresi quando invece vedemmo gli stessi argomenti apparire in forma di corsivi
dell'"Avanti!". Fu una scelta personale di Craxi, che non condivisi
assolutamente".
Poi viene il momento forse più acuto di contrasto con Craxi e di
tensione tra il suo governo e l'opinione pubblica. Il segretario del Psi voleva
chiaramente provvedimenti politici di garanzia per i politici accusati di
corruzione.
"Gli ultimi colloqui che ebbi con lui riguardarono proprio questi temi. Si pose
la questione del finanziamento illecito dei partiti. Io ritenevo corretto
depenalizzarlo, come in effetti poi si è fatto, ma reputavo impensabile
eliminare ogni sanzione per comportamenti del genere o addirittura depenalizzare
reati molto gravi come la corruzione e la concussione. Anche qui tra me e Craxi
ci furono punti di vista diversi. Io gli spiegavo che qualcosa si poteva fare,
ma c'erano dei limiti invalicabili. Craxi mi ascoltava, non mi contraddiceva, ma
chiaramente non era persuaso. Nel nostro ultimo incontro, però, parlammo anche
di politica. E lui mi disse: "Visto che si va verso un sistema elettorale
maggioritario, tu devi cercare di ridurre la tensione tra noi e gli ex
comunisti, perché in futuro un rapporto con loro lo dovremo comunque
riallacciare". Mi parlò così anche se la sua vicenda giudiziaria era già
cominciata e stava iniziando, da parte del Pds, un'inaudita strumentalizzazione
dell'inchiesta Mani pulite per distruggere Craxi".
In definitiva oggi qual è il suo giudizio sulla figura di Craxi?
"E' una persona che ha contato molto nella mia vita, mi ha fatto crescere e mi
ha fatto anche soffrire. Ho sempre continuato a rispettarlo, anche dopo la sua
disgrazia politica. I socialisti, in questi ultimi anni, si sono specializzati
nelle polemiche personali. Io invece certe riflessioni critiche continuo a
tenermele dentro. Considero immorale attaccare una persona con cui ho avuto quel
tipo di legame. Posso comportarmi così perché il mio rapporto con Craxi è stato
sempre pulito, per cui non devo prendere le distanze da lui per rendere la mia
immagine più accettabile ad altri. Per queste ragioni non mi sono mai associato
a facili cori di critica, nemmeno dopo che tra me e lui era sceso il silenzio,
che ciascuno di noi due probabilmente spiegava con una responsabilità
dell'altro: io che non lo avevo più cercato dopo la sua partenza definitiva per
Hammamet, lui che non mi aveva fatto neppure una telefonata dopo la caduta del
mio governo".
Infine venne l'epoca dei fax da Hammamet.
"Ho taciuto anche quando lui, reagendo regolarmente allorché leggeva cose che
non gli garbavano in qualche mia intervista, mandava in giro fax contenenti
allusioni su di me che assolutamente non meritavo, no proprio non meritavo (e
lui lo sapeva bene). In simili circostanze ho ritenuto che fosse mio dovere
morale astenermi da ogni commento. Il mio silenzio può essere stato male
interpretato, ma non me ne importa niente, perché conosco la realtà di quel
rapporto e continuo a rispettarlo".
Ha imparato cose da lui?
"Da Craxi ho imparato diverse cose su come si fa politica, perché è stato un
leader di grandi qualità. Da lui ho imparato a percepire quando arriva il
momento della decisione e tu te ne devi assumere la responsabilità. Ho imparato
inoltre che non si può esaurire la politica sulla scena domestica: quando ancora
non si parlava di globalizzazione, lui mi fece capire bene che bisogna guardare
sempre oltre l'orticello di casa e sapersi creare una rete di rapporti
internazionali (...). Craxi commise diversi errori, ma quando si valuta l'opera
di un uomo, bisogna fare con equanimità il bilancio del bene e del male".
Craxi,
siluro ad Amato: è colpevole come me,
scrive Sebastiano Messina su “La Repubblica”. Quando era ancora
presidente del Consiglio, Giuliano Amato andò a parlare alla London School of
Economics. E ai giornalisti inglesi che gli chiedevano di Tangentopoli rispose
così: "Io ritengo che ben poche persone erano al corrente delle cose che stiamo
scoprendo adesso...". Quattro anni sono passati, ma Bettino Craxi non ha
dimenticato quella frase. Macché, tuona adesso dal suo rifugio di Hammamet: tu
lo sapevi benissimo, caro Giuliano, avevi le mani in pasta come me, pagavi le
tue campagne elettorali con i soldi del cassiere di Via del Corso e raccoglievi
fondi anche per conto tuo. E giù con una scarica di accuse, una requisitoria che
evoca anche nel lessico gli ordini di cattura scritti da Di Pietro ("Egli non
poteva non sapere..."), una mitragliata contro il suo ex consigliere più fidato,
contro l' uomo che una volta, prima di essere travolto dagli eventi, lui stesso
designò come il suo successore alla guida del Psi. Altri tempi. Allora Craxi
comandava a Via del Corso e Amato era ben saldo a Palazzo Chigi. Poi è venuta la
grande piena di Mani Pulite, che ha spazzato via i socialisti, comprese le
ville, le auto blindate e quel sorriso arrogante che nascondeva la certezza di
un potere eterno e crescente. E oggi che la bufera è finita, l' ex leader
socialista non riesce a mandar giù il fatto che il destino cinico e baro abbia
riservato al suo fedelissimo una sorte così diversa dalla sua. Lui, Bettino,
costretto a curarsi i suoi mali tra i palmizi tunisini, con un ordine di arresto
che pende sulla sua testa, mentre Giuliano non è stato sfiorato da un solo
processo, anzi guida solennemente l' Antitrust, con tutti gli onori, la blindata
e la scorta, e sta addirittura per mettere il bollo socialista all' "operazione
Cosa 2". Poteva, Craxi, lasciare che il fato continuasse su questa strada
biforcuta? Figuratevi. Ha aspettato il momento giusto, la vigilia di quel
congresso pidiessino dove gli ex avversari delle Botteghe Oscure stenderanno un
tappeto rosso per accogliere il compagno Amato, poi ha affidato all' ultima arma
che gli è rimasta - il fax - la sua requisitoria contro l' ex Dottor Sottile.
Aggiungendo perfidamente che ci sarà un seguito, non finisce mica qui: "Di tutto
ciò si può tornare a parlare più nel dettaglio...". Ma vediamo cosa c' è scritto
nel suo atto d' accusa. Nella mente di Craxi, il suo ex braccio destro deve aver
commesso il reato di usurpazione di potere. "Giuliano Amato - scrive Craxi -
tutto può fare salvo che ergersi a giudice delle presunte malefatte del Psi, di
cui egli, al pari di altri dirigenti, porta semmai per intero la sua parte di
responsabilità... Il sottoscritto, per le sue responsabilità di segretario, è
trattato alla stregua di un gangster e condannato all' ergastolo... Guarda caso,
invece, a Giuliano Amato, vicesegretario vicario del Psi, forte delle sue
amicizie e altolocate protezioni, non è toccato nulla di nulla. Buon per lui".
Poi vengono gli insulti. Craxi chiama Amato "becchino del Psi", "trasformista",
"voltagabbana", e - citando Cossiga - addirittura "una cosa vomitevole", come
"tutti i craxiani che sono diventati anti-craxiani". Un uomo, dice, che "si è
impancato a sputar sentenze morali". Non può farlo, lo sferza l' ex segretario,
proprio lui che con "le cattive abitudini contratte dal Psi, finanziamento
illegale in testa, è stato a contatto quotidiano", come "potrebbe risultare in
modo inconfutabile". E qui cominciano le accuse, quella che un magistrato
definirebbe una chiamata in correità. "Innanzitutto va ricordato che, dopo aver
per intero condiviso avventure e disavventure del craxismo di governo, Giuliano
Amato si dedicò interamente al partito. Negli anni in cui io mi occupai delle
Nazioni Unite, lavorando per lunghi periodi nel mio ufficio al Palazzo di vetro
di New York, Amato era vicesegretario vicario ed era impegnato nella gestione
del partito. I suoi rapporti personali con l' amministratore Vincenzo Balzamo
erano diretti ed eccellenti...". Da questa premessa Craxi fa discendere cinque
capi d' accusa. Primo: sapeva tutto. "Egli era perfettamente al corrente della
natura complessiva del finanziamento del partito. Era evidente che egli non
poteva non sapere". Secondo: prendeva i soldi anche lui. "Di questi
finanziamenti egli si è sempre avvalso naturalmente e personalmente per le sue
spese di lavoro politico, per le sue campagne elettorali che furono sempre
finanziate dal partito, tanto in sede nazionale che in sede locale. Anche in
questo caso non credo che il tutto avvenisse tramite assegni e trasferimenti
bancari documentati". Terzo: forse si muoveva anche in proprio. "Resta inoltre
da considerare se per far fronte alle spese delle sue campagne elettorali,
furono organizzate, come pare, anche raccolte di fondi che non rientravano nel
controllo dell' amministrazione centrale". Quarto: collaborava. "E' poi
certamente toccato a Giuliano Amato di occuparsi di iniziative, strutture e
progetti di interesse del partito e che tuttavia comportavano un interessamento
diretto, ed incarichi specifici di collaborazione con l' amministrazione del
Psi". Quinto: era consenziente. "Non è mai capitato a mia memoria che Giuliano
Amato in incontri personali e confidenziali con il segretario del partito avesse
esternato le sue perplessità, le sue preoccupazioni e il suo disappunto per il
sistema generale su cui si imperniava il finanziamento del partito, parte del
quale, come tutti sapevano, era costituito da forme che si concretavano in
aperta e risaputa violazione della legge sul finanziamento dei partiti". La
requisitoria finisce qui, con l' inquietante accenno a quei "dettagli" di cui
"si può tornare a parlare". Amato, che i suoi collaboratori definiscono
"addolorato" dalla bordata craxiana, è amareggiato ma non sorpreso. Sapeva da
tempo di essere, come gli dicevano i suoi amici, "sotto impeachment craxiano".
Già quattro mesi fa aveva ricevuto la prima avvisaglia, leggendo un'intervista
in cui Craxi lo accostava a Martelli e a Formica per dire: "Potrei fare una
lunga lista di traditori e vigliacchi. C' è perfino chi si impanca a
moralizzatore. Parola di Giuda". Conoscendo bene Bettino, Giuliano Amato capì
che quello era solo l'inizio. Non si sbagliava.
Il primo
traditore di Craxi fu suo figlio Bobo.
Accusa il Cavaliere di non essere stato un amico, ma quando scoppiò tangentopoli
disse: Non sono mai stato craxiano, scrive Filippo Facci su “Il Giornale”.
Meriti la peggiore delle cattiverie, Bobo: la verità. Meriti ciò che fedeli e
amici di tuo padre, anzi del padre di tua sorella Stefania, si sono
ripetutamente e sommessamente ripetuti per anni, silenziosamente, scuotendo la
testa, consolandosi nella speranza che peggio, in fondo, tu non potessi dire né
fare. E invece sì, ci riesci ogni volta, ci riesci per la vergogna nostra: e
parlo senza timor di smentita di compagni e amici e ripeto familiari che Bettino
Craxi amava senza disperazione, com’era invece nel tuo caso. Ora ti sei
inventato questo, Bobo: che Silvio Berlusconi non andò ad Hammamet dal 1994 al
2000 e che dunque non fu un buon amico. «È evidente che ha tradito un rapporto».
Vien da rispondere che il rapporto intellettivo con tuo padre, tu, l’hai tradito
alla nascita, Bobo, ma sarebbe una battuta becera e degna di quell’Umberto
Cicconi, ex fotografo di tuo padre, che resta il tuo intellettuale di
riferimento. Niente battute, Bobo, la verità basta e avanza. Perché vedi, tu eri
il figlio con dei problemi, quello che avrebbe fatto sembrare un lavoratore
persino Claudio Martelli, il figlio da sopportare nonostante la sua arroganza
che faceva danni incommensurabili ogni qualvolta apriva bocca. Eri quello che
non aveva né ha mai lavorato in vita sua e che da solo non avrebbe sfondato in
politica neppure in dieci vite, il figlio che boicottava ogni giovane anima di
cui tuo padre, pardon il padre di tua sorella, amava circondarsi anche ad
Hammamet: nella speranza che qualcuno, certo non tu, potesse raccogliere il suo
testimone politico e comportarsi magari come un figlio. Ti fu perdonato tutto,
Bobo: persino quella volta che ti scappò quel «non mi sono mai considerato un
craxiano» dopo il primo avviso di garanzia spedito al tuo ex padre, nel dicembre
1992, quando stavi per tentare il salto del quaglione tra coloro che volevano
«restituire l’onore ai socialisti», ricordi? Ora però basta, Bobo, basta
davvero. Il Craxi perdente e zoppicante, la sera tardi, amava ripetere che tutto
avrebbe voluto, diceva, «tranne che essere riabilitato da coloro che mi hanno
ucciso». C’è chi, come tua sorella, ha incorniciato questa frase dietro la
scrivania: la stessa sorella che ormai ti definisce pubblicamente «una tragedia
familiare» che non è nazionale, per fortuna, solo per via della tua irrilevanza
politica. Hai bussato col cappello in mano dai lanciatori di monetine, hai fatto
bisboccia cogli odiatori professionali, con le iene che poi hanno tentato di
smangiucchiare ogni visione craxiana con due lustri di ritardo. In politica il
tradimento non esiste o quasi, Bobo: ma tu eri un figlio, perlomeno di sangue.
Non eri altro, non avevi altro. Da vent’anni davi aria alle parole col tuo
politichese vacuo e fatto di nulla: poi, per un collegio di lenticcchie, per il
posticino con lo stipendino e la pensioncina, hai svenduto a prezzi di saldo un
cognome che non ti appartiene più da tempo, perché l’hai regalato agli
scippatori del socialismo europeo, a coloro cui neppure una latitanza parve
bastare. Questi sono i tuoi compagni di strada, i traditori indicati da tuo
padre: ecco perché della tua biografia, Bobo, resterà l’esser nato come figlio
di Bettino Craxi e in secondo luogo il tuo esser passato con quelli che lui
giudicò i propri assassini, punto, amen, riposi in pace, pensavamo. E invece no.
Ancora parli. Parli di Berlusconi: con tutti gli sciacalli che pure ci furono
anche a destra, tu vai a parlare proprio di Berlusconi, vai a parlare dell’uomo
che per almeno dieci anni si cercò di associare al padre di tua sorella
perlomeno sotto il profilo dell’epilogo politico-giudiziario. Eppure tutto era
cominciato proprio nel periodo in cui Berlusconi già orecchiava la politica o a
esser precisi il consenso: il periodo in cui una percentuale di italiani che
sfiorava il 90 per cento voleva Craxi espressamente in galera, e insomma lo
odiava di un odio viscerale, liberatorio, risolutore. Ebbene, giusto all’acme di
questa passione civile (sera del 29 aprile, dopo alcune mancate autorizzazioni a
procedere contro Craxi) il Berlusconi già mentalmente politico non ebbe a
rifuggire le telecamere di Raitre, e così disse: sono venuto a trovare un amico
perché sono tanto contento per lui. Un gesto che molti che circondano Berlusconi
(oggi) non vollero o poterono permettersi (allora) ma che il futuro vincitore
delle elezioni avrebbe comunque pagato salato. E Berlusconi quel prezzo lo pagò,
ma è la ragione per cui non poté mai più permettersi di incontrare Craxi da
vivo: anche perché il primo a sconsigliarlo politicamente fu proprio Craxi, se
non lo sai. Andarono altri, ad Hammamet. Il padre di tua sorella li portava alla
Medina per una menta fresca e per un passaggio finto distratto nel cimitero
italiano dove avrebbe voluto essere sepolto, diceva. Berlusconi il cimitero l’ha
visto per la prima volta nel 2000, nel giorno dei funerali, quando disse che non
c’era nulla da dire. E tu ovviamente parlavi, Bobo.
Ecco cosa
c'è dentro i messaggi di Bettino Craxi".
Stefania, la figlia dello statista e segretario del Psi, racconta com'è nato il
libro ("Io parlo, e continuerò a parlare") raccolta dei pensieri del padre in
esilio - Il Libro, scrive Paola Sacchi su “Panorama”. «Scriveva di notte o la
mattina. In quegli appunti Bettino Craxi fotografa vent’anni prima l’Italia di
oggi: il dramma della disoccupazione giovanile, i problemi con l’Europa. Mette
in guardia dai pericoli di una democrazia che si stava avvitando su se stessa
diventando una finta democrazia, oppure una videocrazia, così la definì. Ci
sono i ritratti di quelli che definiva gli extraterrestri: da Giuliano Amato a
Giorgio Napolitano a Romano Prodi e Massimo D’Alema, gli uomini nuovi della
Seconda Repubblica che nuovi non erano. Ma in Craxi non c’è mai rancore, c’è una
lucidità politica impressionante che fa la differenza tra chi è uno statista, un
grande politico e chi non lo è». Stefania Craxi, presidente della Fondazione
dedicata alla memoria del padre, racconta a Panorama.it come è nato il libro
«Io parlo e continuerò a parlare» (Mondadori), raccolta degli scritti
dell’esilio tunisino (1994-2000) per il 70 per cento inediti a cura dello
storico Andrea Spiri.
Quando ha
iniziato a nascere l’idea di questo libro?
«Da una delle
ultime interviste in cui Craxi dice: “La Storia andrà riscritta bene con tutti i
suoi falsi eroi e falsi miti, è l’unica cosa che posso fare, ma la partita della
storia non gliela faccio vincere”. E termina dicendo: “Io parlo e continuerò a
parlare”».
Quindi, la
sua unica arma rimasta erano quegli appunti.
«Sì, scriveva.
Senza mai decidersi a fare un libro di memorie. Forse non lo voleva fare o forse
quando lo ha deciso era troppo tardi. E scriveva dietro i fogli riciclati della
rassegna stampa che ogni giorno un compagno gli mandava, uno di quei compagni
che niente gli doveva, mai stato senatore, mai stato deputato o presidente di
qualcosa, ma legato a Craxi solo dalla militanza politica. E quindi, lui la
mattina scriveva o le riflessioni delle notte insonni, oppure reagiva a quello
che leggeva».
Inviava poi
i suoi scritti in Italia, attraverso il famoso fax di Hammamet.
«Sì, cercava
di farli pubblicare, spesso venivano cestinati nelle redazioni, qualcuno veniva
pubblicato su un foglio dell’Avanti clandestino. Il libro che ne viene fuori (è
solo una parte degli appunti) è uno sguardo sulla seconda Repubblica visto da
Hammamet. Ed è da un lato una cronaca puntuale di quello che accadeva in quegli
anni, dall’altro non è un libro di memorie ma di attualità. Lui vede con
vent’anni di anticipo che questo paese sarebbe stato ridotto in macerie. Lui
vede cosa sarebbe successo dell’Europa così come si andava costruendo e di come
avrebbe messo l’Italia in difficoltà. È strabiliante perché il libro sembra
scritto ieri. Ma chi cerca scoop o parole di rancore non ne troverà. Troverà una
descrizione senza infingimenti del sistema politico e la visione di quella che
sarebbe stata la Seconda Repubblica».
E dei
personaggi della Seconda Repubblica cosa dice?
«C’è qualche
notazione sui cosiddetti uomini nuovi che si aggiravano in quel momento sullo
scenario politico come degli extraterrestri (così lui li definiva), spacciandosi
per essere stati fino al giorno prima sulla luna. Lui sostanzialmente dice: ma
come nuovi, se hanno partecipato tutti attivamente alla Prima Repubblica? C’è
la rivendicazione orgogliosa di una vita vissuta, anche con tutto il suo carico
di errori, per il bene del paese. L’altra cosa che emerge, per chi vuole leggere
questo libro anche con l’anima non solo con l’intelletto, è un dolore, una
nostalgia che a chi non ha pregiudizi fanno molto male al cuore. Sono le pagine
dedicate all’esilio».
Qualche
aggettivo per definire i cosiddetti personaggi nuovi?
«C’è una
carrellata su Amato, Napolitano D’Alema, Prodi…Sono ritratti precisi e c’è per
tutti un’invocazione a dire la verità sulla storia della Prima Repubblica di cui
avrebbero potuto essere precisi e autorevoli testimoni. Per ognuno c’è una
definizione, ma questo lasciamolo al lettore. Craxi rivendica anche i meriti
della Prima Repubblica che aveva risollevato le sorti di un paese contadino
uscito dalla guerra che diventò la quinta potenza mondiale».
Come vedeva
Silvio Berlusconi già da allora?
«Craxi
preconizza la persecuzione giudiziaria nei suoi confronti e il tradimento di
Fini. Quanto agli altri politici della Seconda Repubblica sostanzialmente Craxi
dà loro dei bugiardi».
Stefania Craxi
intervistata da Sabelli Fioretti. Oltre 150 interviste sugli old boys net, sui
voltagabbana e sui leccapiedi. Un nome ricorrente, Bettino Craxi. Da lui hanno
riparato molti ex sessantottini quando hanno avuto bisogno di un tetto, attorno
a lui si è formata una corte di incredibili adulatori, partendo da lui si è
verificato quel fenomeno carsico dei craxiani, prima osannanti, poi rinneganti,
poi di nuovo entusiasti. Stefania Craxi ha letto quasi tutte le interviste. E
ogni volta che compariva il nome del leader socialista ha preso appunti. Poi mi
ha detto: “Vogliamo fare il punto su tutte le bugie che sono state raccontate?”
Ed io: “Vogliamo”. Eccoci qui ad esaminare, una per una, le bugie degli
intervistati.
E’ armata?
“Perché?”
Ho letto
che gira armata.
“Una volta.
Quando era vivo mio padre”.
Lo avrebbe
difeso sparando?
“Si”.
Meno male
che non c’era il giorno delle monetine al Raphael.
“Meno male”.
Lo avrebbe
difeso sparando?
“Sarebbe stato
eccessivo. Però sicuramente avrei reagito”.
Cazzotti?
“Anche”.
Ha preso
mai a cazzotti qualcuno?
“Da bambina”.
Chi?
“Toby Varley.
Era una specie di torello scozzese che stava in classe con me. Gli diedi un
pugno perché aveva picchiato mio fratello”.
Bobo, suo
fratello, adesso è a destra con un po’ di socialisti. Lei?
“Io no.
Nemmeno mio padre, se fosse vivo, farebbe più politica”.
Mi dica la
prima bugia letta in queste interviste.
“La corte di
Craxi. Non è mai esistita. E’ un’invenzione giornalistica”.
Non
esistevano i craxiani?
“Esistevano i
craxini. Quelli che, dicendo di agire in nome e per conto di mio padre, avevano
comportamenti indifendibili”.
Molti
craxiani si sono eclissati.
“Davanti
all’aggressione subita si sono nascosti, hanno trovato rifugio dove meglio hanno
potuto”.
Ottimo
rifugio Forza Italia. L’ha votata anche lei?
“Sì, nel ’94”.
E dopo?
“Dovevo
scegliere fra uno di An e Giuliano Amato. Ho preso la scheda e ho scritto:“Viva
Craxi”.”
Craxi ha
distrutto il partito socialista. Parola di Enzo Biagi.
“Mio padre ha
preso il Psi al 9,5% e ha indicato a tutta la sinistra la strada del socialismo
riformista. Prima di Blair, di Schroeder, di Jospin. Adesso in Italia sono tutti
riformisti, perfino Bossi. Io allora sono conservatrice. Sa che ci sono tante
bugie nelle sue interviste?”
Ho ricevuto
complimenti migliori.
“Non è colpa
sua. E’ colpa di tutta questa gente che ora dice che con era mai d’accordo con
mio padre. Tutto questo dissenso io non lo ricordo”.
Evidentemente era sottotraccia.
“Amato un
giorno ha detto: “Quando ero in dissenso con Craxi stavo zitto”. Ah però! Che
dissenso!
Erano tutti
giolittiani.
“Giolittiani,
e lombardiani, e achilliani. Dovevano essere correnti grossissime”.
Amato l’ha
delusa…
“Perché non è
venuto al funerale di mio padre? Senza di lui Amato sarebbe ancora oggi un
professore universitario. Nessun moto dell’animo l’ha spinto a fare un gesto, ad
andare sulla sua tomba?”
Una scelta
di sopravvivenza. Galli della Loggia mi ha detto: “Doveva abbandonare Craxi se
voleva continuare ad avere un ruolo politico”.
“Una scelta
umanamente ignobile. Non si può fare politica senza sentimenti. Se Amato avesse
difeso una storia che era anche la sua, avrebbe avuto un grandissimo ruolo nella
sinistra oggi”.
La Boniver
ha invece marcato la sua fedeltà a Bettino Craxi.
“Per forza. E’
una donna”.
Anche Ugo
Intini. Piero Fassino mi ha detto che è uno leale, coerente, onesto, gli
facevano ponti d’oro per andare a destra ed è rimasto a sinistra.
“Mi scusi: ha
detto Ugo Intini? Quello che ha rifatto il Psi, poi se n’è andato, poi s’è
spostato di qua e di là come tutti? Io non tollero questa scrematura moralistica
tra i socialisti onesti e i socialisti disonesti”.
Perché no?
Ci sono i socialisti che hanno rubato e quelli che non hanno rubato.
“Intini era il
più anticomunista di tutta la dirigenza craxiana e si è fatto eleggere dai
comunisti. E’ un raro caso di sindrome di Stoccolma politica. Nessuno, nessuno,
nessuno di quelli che avevano responsabilità politiche poteva non sapere come si
finanziavano. Non potevano prendere venti milioni al mese e dire adesso: “Toh!”.
Però, tutto sommato, non ho voglia di prendermela con i pesci piccoli”.
E
prendiamocela con quelli grossi allora. Martelli mi ha detto: “Ho restituito 500
milioni dei miei, Craxi non l’ha fatto”. Come dire: Craxi si è arricchito e non
ha restituito una lira.
“Traditori
come Martelli saranno giudicati dalla storia. O magari anche dalla cronaca. Mio
padre non è morto ricco. Non aveva gusti lussuosi. Una volta a Saint Moritz,
ospite di Berlusconi, gli servirono a tavola una cernia. Lui chiese: “Dove hai
preso un pesce a Saint Moritz?” Berlusconi disse: “Non sai quanto mi è costato”.
E Craxi: “Fallo portare indietro. Voglio un uovo al tegamino”.
Era il
partito dei satrapi, degli arroganti…
“Ci sono
socialisti, che hanno avuto un comportamento indifendibile. Mio padre rimase
molto colpito quando vide la villa sull’Appia di Claudio Martelli. E vide
camerieri in guanti bianchi servire la cena”.
Massimo
Fini mi ha detto: Martelli potrebbe essere qualunque cosa. Non ha morale.
“Martelli non
era socialista. A casa nostra, per tutta la vita, abbiamo avuto la cameriera a
ore. Mia mamma quando papà era premier, andava a fare la spesa al mercato in
tram”.
Però il
tesoro del Psi…
“C’è. Ne sono
sicura. Dov’è?”
E lo chiede
a me?
“Se lo sono
fregato. Ne sono sicura. Sono spariti conti, sono spariti immobili. C’è gente
che si è tenuta per sé i soldi del partito dopo il disastro. Il conto del
partito che aveva Pacini Battaglia dove è andato a finire? Qualcuno ha richiesto
i soldi indietro a Chiesa?”
Come
finanzia la Fondazione Craxi?
“Con soldi
miei. Io faccio l’imprenditore. Fortunatamente non sono riuscita a fare quello
che volevo fare. La giornalista”.
L’ha fatto
per un po’.
“Volevo fare
l’inviato di guerra. Sono riuscita a fare qualche collaborazione. Tele Alto
Milanese, Donna Moderna, Montecarlo, Canale 5. Poi con mio marito decidemmo di
fare i produttori”.
Solita
domanda. Il nome facilita?
“Ancora oggi
nessuno si fa negare se sente che lo chiama Stefania Craxi. E’ evidente che io
non ho avuto le condizioni di partenza del figlio del portinaio. Ma la mia
società di produzione ha avuto uno sviluppo enorme negli anni in cui mio padre è
stato in esilio”.
Esilio?
Latitanza.
“E-si-li-o”.
Craxi
stimolava l’adulazione?
“Mio padre
aveva talmente nella testa altro, che tra un adulatore, un mariuolo e una brava
persona, a volte non coglieva la differenza”.
Lei era una
figlia ribelle?
“Io la
domenica non uscivo con gli amici fino a quando non capivo che mio padre non mi
avrebbe portato con sé. Mi ricordo quando prendevamo la metropolitana e andavamo
alle corse dei cavalli. Poi, quando è diventato presidente del Consiglio, tutto
questo è scomparso. E’ scomparsa anche l’intimità. Venivo a Roma, andavamo a
mangiare al ristorante e con noi c’erano quindici persone. E tra le quindici
persone c’erano anche gli adulatori”.
Tanti nani,
tante ballerine.
“Bugia.
Nell’assemblea nazionale di cui tanto si parla forse c’era qualche ballerina di
troppo ma c’erano anche Veronesi, Treu, Portoghesi, Pini”.
Quando
Craxi non fu più trendy, sparirono tutti.
“Sparì tutto
il gruppo dirigente”.
Perfino
Formica.
“A Formica
voglio bene. Ma glielo ho detto: avete fatto politica insieme per 40 anni, sono
legami più forti di un matrimonio. Com’è che non sei andato a trovarlo?”
Giulio
Anselmi mi ha raccontato di una telefonata violenta che gli fece Craxi. “Dopo le
elezioni”, gli urlò, “la farò cacciare giù dalle scale del Corriere della Sera”.
È possibile?
“Possibilissimo. Ma non era un atto di arroganza”.
Di
gentilezza?
“Arrogante è
chi maltratta i deboli e adula i forti. Mio padre era umorale con tutti. Ma non
ha fatto mai cacciato nessuno da nessun posto”.
Paolo
Flores d’Arcais mi ha raccontato di essere stato cacciato da Mondo Operaio.
“Mio padre non
ha mai cacciato nessuno”.
Flores non
se n’è andato da solo.
“Flores me lo
ricordo al congresso di Torino, mi stava sempre appiccicato. Mi dicono sia uno
psicolabile, ma non lo conosco. Passava per essere un giovane intellettuale di
moda”.
Simona
Ercolani mi ha raccontato della televisione di Anja Pieroni.
“Era la
televisione del partito”.
Anja fu una
passione di suo padre.
“Cazzi suoi.
Mia mamma ne ha sofferto. Ma io non credo ai santi. A mio padre le donne
piacevano, aveva preso una sbandata. Mi rese furibonda, ma oggi posso capirlo.
Detto questo il rapporto fra mio padre e mia madre fu solidissimo,
importantissimo, bellissmo, fortissimo. Fino all’ultimo. Sa una cosa?”.
Dica.
“Lei è
magnanimo nei miei confronti. Guardi che può essere anche più duro”.
La
accontento. Lei aveva una casa a Nervi per il week end da 5 milioni al mese.
“Non sono mai
stata aiutata dalla famiglia, ma non ero povera. Era il ’92, ’93. Ero già un
imprenditore”.
Era l’’88,
’89.
“Non ho mai
avuto soldi dai miei”.
Con suo
padre aveva un rapporto tosto…
“Litigavamo
spesso sulle persone che si metteva intorno”.
Come quelli
della moda. Tutti craxiani…
“Quelli della
moda devono molto al governo di mio padre”.
Che fine
hanno fatto?
“Spariti.
Qualcuno ha perfino smentito di avere “vestito” mia madre”.
E i
giornalisti?
“Mio padre non
ha mai avuto un buon rapporto con loro. Pensava che fossero tutti un po’
cialtroni”.
Giampaolo
Pansa mi ha detto: “Il Tg2 non è socialista, è craxiano”. Che fine hanno fatto
tutti questi craxiani televisivi?
“Ci sono la
Maglie, Anna La Rosa, Giuliana Del Bufalo…Donne. Solo le donne”.
Ferdinando
Adornato mi ha detto dei craxiani che hanno fatto gli spot per Bettino e poi
l’hanno dimenticato, folgorati sulla via di Occhetto. Alludeva alla Foschini, a
Michele Cucuzza…
“Scomparsi. Ma
io non stigmatizzo. La gente tiene famiglia. C’era la caccia al socialista”.
Voltagabbana per legittima difesa?
“Solo gli
stupidi non cambiano mai opinione”.
Questa è
una sciocchezza. Chi cambia idea per interesse è un lazzarone.
“Bettiza,
quando lei lo ha intervistato, si è definito molto amico di mio padre”.
Vero.
“Strano. Gli
ho chiesto di venire a fare una conferenza su Craxi per la Fondazione e mi ha
detto di no”.
C’è qualche
altro giornalista che le è rimasto impresso?
“Peppino
Turani. Fu un campione di moralismo su mio padre e poi finì nel processo
Enimont. Ma sa, io provo un rancore tanto grande che non ho posto per i piccoli
rancori”.
Quando
pensa a un voltagabbana, chi le viene in mente?
“Oscar Luigi
Scalfaro. E’ stato quattro anni ministro di mio padre e poi è stato complice di
tutto quello che è successo a mio padre”.
Renzo Foa
ha ricordato che, dentro il Pci, “craxiano” era diventato un insulto. Un po’
come fascista.
“E’ vero.
Anche Berlinguer diceva delle cose gravissime su mio padre. Craxi è un pericolo
per la democrazia”.
C’era
un’antipatia reciproca fisica.
“Nella storia
di questo Paese Berlinguer è un conservatore e mio padre è un modernizzatore”.
Antonio
Ghirelli mi ha detto che anche Pertini detestava Craxi.
“Pertini
detestava chiunque. Ce l’aveva col mondo. Era cattivissimo. L’ho sempre sentito
parlare male di tutti”.
Ghirelli
racconta anche che Craxi gli raccomandò Onofrio Pirrotta.
“Lo faceva per
aiutare. Diceva: quello ha bisogno di lavorare. Una volta mi chiamò per
raccomandarmi Alessandra Mussolini. Diceva: poverina, con quel cognome non la fa
lavorare nessuno”.
E lei l’ha
fatta lavorare?
“No. E lei,
dopo, disse cose poco gradevoli su mio padre”.
Luciano
Pellicani mi ha detto: grande stima, però io Craxi non lo frequentavo.
“Gli amici di
mio padre erano a Milano ed erano pochissimi, Massimo Pini, Caterina Caselli,
Nedda Liguori. A Roma solo Spartaco Vannoni. Quella frase, comunque, non fa
onore a Pellicani”.
Curzi mi ha
detto: se facevi la voce grossa, Craxi ti rispettava.
“Non è così.
Se mio padre si rendeva conto di avere torto, non chiedeva scusa ma trovava il
modo di fartelo capire. Era molto orgoglioso”.
Giulio
Savelli mi ha detto: il governo Craxi non ha cambiato nulla.
“Il taglio
della scala mobile, i missili Pershing e Cruise, il Concordato…non riuscì a fare
la grande riforma dello Stato, questo è vero, però aveva un partito piccolo e
governava sempre contro. Contro una parte del sindacato, contro i poteri forti,
contro i comunisti, contro la chiesa cattolica, contro la Democrazia Cristiana”.
I suoi
figli come hanno preso le vicende del nonno?
“Al più
grande, a scuola, gli altri bambini dicevano: “Tanto tuo nonno Di Pietro lo
arresta”.Ancora oggi è un bambino sofferente. Mia figlia Anna no. L’altro giorno
ha cominciato un tema così: “Io sono la nipote di Bettino Craxi”.”
Adesso
dobbiamo fare il gioco della torre.
“Dio mio”.
Vespa-Santoro, chi salva?
“Vespa non ha
mai usato la piazza, i sentimenti”.
Che male
c’è a far leva sui sentimenti della gente?
“Dove sta
scritto che i sentimenti della gente sono buoni? Santoro agisce sugli istinti
bassi delle persone”.
Sgarbi-Urbani?
“Salvo Sgarbi.
Nel bene e nel male è un patriota”.
Berlusconi-Agnelli?
“Salvo
Berlusconi”.
Anche suo
padre lo salvò.
“Mio padre lo
ha aiutato molto. E mi farebbe piacere che Berlusconi se lo ricordasse di più”.
Perché lo
aiutò?
“Rompeva il
monopolio Rai”.
Il
risultato è che siamo di nuovo al monopolio.
“Adesso
Berlusconi fossilizza il mercato. Ma allora raccontava che avrebbe contrastato
il potere americano culturale nel mondo”.
Craxi che
rientra precipitosamente in Italia per fare un decreto che riaccenda le tv
berlusconiane spente dai pretori…
“Credeva di
fare bene. Poi Berlusconi era bravo a raccontarla. “I lavoratori…come
facciamo…siamo costretti a licenziarli”.
Berlusconi
è mai andato ad Hammamet?
“Durante
l’esilio mai. Quando l’ho visto al funerale gli ho detto: “Sei qui con sette
anni di ritardo”.”
Cofferati-D’Alema?
“Salvo
D’Alema. Cofferati me lo ricordo riformista pacato e me lo ritrovo capopopolo
che porta la sinistra in un vicolo cieco”.
Lerner-Ferrara?
“Salvo
Ferrara. Ha continuato sempre a dichiararsi craxiano”.
Di
Pietro-Spazzali?
“Sono stati
entrambi le pedine di un brutto gioco”.
Dotti-Previti?
Salvo Previti.
La sua battaglia sugli elenchi dei giudici politicizzati mi sembra sacrosanta”.
Fassino-Rutelli?
“Butterei
Rutelli anche se fosse da solo. Ha detto che voleva vedere mio padre mangiare il
rancio della galera”.
E lei gli
ha detto che era un grandissimo stronzo. Come è finita la causa?
“L’ho persa in
tribunale, in appello e in Cassazione. Adesso devo pagare la multa. 50 mila
lire”.
Ha chiesto
la rateizzazione in 36 rate.
“Così per 36
volte posso scrivere dietro al bollettino postale la causale “per aver dato del
grandissimo stronzo al sindaco di Roma”. Una soddisfazione. Mio padre disse:
“Grazie a mia figlia oggi si sa quanto costa dare del grandissimo stronzo al
sindaco”.”
Salvi Fiat
e Romiti.
Scrive Filippo Facci per "Libero Quotidiano". Cesare Romiti ha scritto «Storia
segreta del capitalismo italiano» (Longanesi, prefazione di Ferruccio de
Bortoli) e racconta un sacco di cose, ma colpisce in particolare il passaggio
dove rivela - scriveva ieri il Corriere - che «sono stati i magistrati del pool
di Mani Pulite a "suggerirgli" di scrivere la lettera-articolo sul «Corriere
della Sera» nella quale il 24 aprile 1993 si rivolge agli industriali
invitandoli a collaborare con i giudici». Interessante davvero, perché se è vero
che «la storia la si racconta, non la si cambia» (parole dello stesso Romiti)
forse è la volta che un pezzo della storia della Fiat e di Tangentopoli si può
raccontarla davvero. Proviamoci. Si torna dunque alla primavera 1993, periodo di
passione anche per la Fiat: il 17 aprile si diffusero voci su un possibile
arresto di Cesare Romiti. Gianni Agnelli, nello stesso momento, parlava al
Teatro la Fenice di Venezia (che presto sarebbe andato a fuoco) e il suo
discorso fu interpretato come un segnale: «Anche da noi», disse, «si sono
verificati episodi non corretti». E qui, secondo una leggenda giornalistica,
accadde qualcosa. Un paio d'ore dopo, i pm Colombo e Di Pietro uscirono
dall'ufficio e si chiusero in un angoletto coi loro cellulari. C'è un cronista
che lo giura ancor oggi: avrebbe udito un «fermate gli arresti» mentre un altro
cronista sentì distintamente «fermate l'arresto». Ma i pm hanno smentito. Alla
fine comunque erano tutti contenti: Davigo disse che c'era stato «un segnale
positivo» e altri quattro manager Fiat, già latitanti, rientrarono con dei voli
privati. Solo l'avvocato Carlo Taormina non era tanto contento: «Il mio cliente
Giuseppe Ciarrapico», disse con prosa non proprio indiretta, «è in galera:
perché Romiti no?». Il procuratore Capo, Francesco Saverio Borrelli, rispose: «I
legali della Fiat hanno espresso disponibilità a collaborare». Taormina replicò
ancora: «Il codice non prevede soluzioni del genere, un arresto o è motivato o
non lo è. Alla base di ogni collaborazione, inoltre, vi è sempre un accordo:
quale?». Il 21 aprile 1993 un elicottero sorvolò Milano segnalando la propria
posizione praticamente ogni secondo. Atterrò e il prezioso passeggero fu chiuso
in questura, completamente isolata per l'occasione. Giunsero delle volanti a
sirene spiegate: era il Pool. Questo per interrogare un semplice teste: Romiti.
Il numero due della Fiat lodò dapprima Enrico Berlinguer (la questione morale) e
poi disse che le responsabilità delle tangenti Fiat erano tutte addebitabili
agli amministratori delle società controllate (dunque non a lui) e parlò di un
conto estero di nome Sacisa. Disse ai magistrati: «In altre circostanze saremmo
diventati amici». Il clima si distese. Di Pietro fece persino il burlone:
telefonò all'avvocato della Fiat e gli disse davanti a tutti: «Guardi che per
Romiti le cose si mettono male». E risate. Anche di Romiti. Ecco, però due
giorni prima, come risulterà, Romiti aveva fatto bruciare delle carte: il
manager Antonio Mosconi metterà a verbale che «A Vaduz (Liechtenstein, ndr)
dovevano scegliere chi doveva attribuirsi i fatti... hanno deciso di distruggere
tutto il resto del conto Sacisa, in modo da dare ai magistrati qualche
informazione per farla contenta e chiudere il conto con la Procura... ritengo
che tutto ciò sia stato coordinato e disposto da Romiti, in quanto fu lo stesso
Romiti che dette ordine in tal senso». Ma tutto questo, allora, non si sapeva
ancora, e Romiti era tutto preso dalla sua opera di distensione con la procura:
su esplicita richiesta del Pool, apprendiamo oggi. Già, perché qui arriviamo al
«suggerimento» dei magistrati che il 24 aprile sfociò in questo titolo cubitale
del Corriere della Sera: «Aiutiamoli questi giudici, stanno ripulendo l'Italia».
L'esortazione di Romiti, notare, giungeva a un anno e mezzo dall'inizio
dell'inchiesta, dopo una quindicina di arresti in casa Fiat, dopo la minaccia
del commissariamento e dopo la fuga di quattro dirigenti latitanti. Romiti, quel
mattino, si presentò in procura con Corriere della Sera in mano e presentò un
memoriale che accennava a «degenerazioni politico-istituzionali non addebitabili
alla volontà degli imprenditori». Al chiaro compiacimento del Pool si opporranno
le perplessità del gip Italo Ghitti, cui non piaceva per niente quella
collaborazione. Nei fatti, Romiti non era neppure indagato e i pm accettarono
che le responsabilità fossero state attribuite ai dirigenti subalterni. La
maggior parte dei giornali scrisse della deposizione di Romiti definendola «una
svolta» (il generale è roba da far impallidire il filo-berlusconismo del Tg4) e
fece eccezione qualche altra uscita di Carlo Taormina («Devo rilevare disparità
di trattamenti rispetto ad altri personaggi», disse) ma soprattutto l'articolo
«latitante, ripassi domani» scritto da Frank Cimini sul Mattino il 28 aprile. Fu
querelato assieme al suo direttore: «La tesi era che alcuni grandi imprenditori
prima facevano accordi con i politici per avere i soldi e poi facevano accordi
con i magistrati per non andare in galera. L'articolo non piacque ai pm milanesi
che mi citarono in giudizio». Il 29 aprile 1993, in compenso, il Corriere della
Sera titolò così: «Il Mattino: l'editore non vuole più Pasquale Nonno».
L'editore era Stefano Romanazzi, in stretti rapporti d'affari con la Fiat.
Pasquale Nonno lasciò la direzione trenta giorni dopo. Ma per scoprire che la
deposizione di Romiti era stata ridicola non sarebbe occorso molto tempo. Il 21
gennaio 1994, al valico di Ponte Chiasso, i finanzieri infatti fermarono il
manager Fiat Ugo Montevecchi con una valigia di carte: stava cercando di far
rientrare qualche scampolo documentale dello stesso conto Sacisa che Romiti
aveva ordinato di bruciare dopo averlo fatto trasferire da Lugano a Vaduz. Nella
valigia furono trovate anche delle altre carte che lasciavano intuire
l'esistenza di un altro conto che Romiti aveva celato agli inquirenti. Per
capirne di più, i magistrati tornarono a torchiare il manager Antonio Mosconi,
che cedette: Romiti, disse, sapeva e disponeva del conto Sacisa e aveva
predisposto una riunione a Vaduz per far bruciare un po' di carte. Inoltre, a
Milano, aveva presentato un memoriale che era una collezione di omissioni.
Mosconi stava prefigurando una serie di esemplari inquinamenti probatori, roba
da arresto. Il Pool arrestò Romiti? No, la Fiat licenziò Mosconi. Il manager
Francesco Torri sostituì Mosconi e diventò amministratore delegato. E il 13
dicembre venne liquidata un'altra lingua lunga: Giorgio Garuzzo, licenziato da
Giovanni Agnelli in persona. L'altro manager Paolo Mattioli, invece, condannato
a due anni e mezzo, non fu licenziato: il suo nome fu stampigliato nella gerenza
del quotidiano «La Stampa». Il dignitoso primato di chi ha maggiormente premiato
i silenti e punito i delatori, in Mani pulite, fu conteso tra la Fiat e il Pds.
1992:
questa è la realtà, non la fiction. La lettera del suicida Gabriele Cagliari,
scrive “Tempi”. Grazie alla serie in onda su Sky si torna a parlare di
Tangentopoli e Mani Pulite. Ripubblichiamo il messaggio inviato alla famiglia
dall’allora presidente di Eni prima di togliersi la vita in carcere.
Grazie alla fiction in onda su Sky, “1992”, in Italia si è tornato a parlare di
Tangentopoli e Mani Pulite. A nostro modesto avviso, non c’è modo migliore per
capire cosa accadde in quegli anni che rileggere questa lettera di Gabriele
Cagliari, presidente dell’Eni arrestato nel 1993 dai pm milanesi Fabio De
Pasquale ed Antonio Di Pietro. Cagliari fu accusato di aver versato ai partiti
una maxi tangente. Dopo quattro mesi nel carcere di San Vittore a Milano si
suicidò il 20 luglio del 1993. Questa è la lettera che inviò alla sua famiglia
il 10 luglio 1993. «Miei carissimi Bruna, Stefano, Silvano, Francesco,
Ghiti: sto per darvi un nuovo, grandissimo dolore. Ho riflettuto intensamente e
ho deciso che non posso sopportare più a lungo questa vergogna. La
criminalizzazione di comportamenti che sono stati di tutti, degli stessi
magistrati, anche a Milano, ha messo fuori gioco soltanto alcuni di noi,
abbandonandoci alla gogna e al rancore dell’opinione pubblica. La mano pesante,
squilibrata e ingiusta dei giudici ha fatto il resto. Ci trattano veramente come
non-persone, come cani ricacciati ogni volta al canile. Sono qui da oltre
quattro mesi, illegittimamente trattenuto. Tutto quanto mi viene contestato non
corre alcun pericolo di essere rifatto, né le prove relative a questi fatti
possono essere inquinate in quanto non ho più alcun potere di fare né di
decidere, né ho alcun documento che possa essere alterato. Neppure potrei
fuggire senza passaporto, senza carta d’identità e comunque assiduamente
controllato come costoro usano fare. Per di più ho sessantasette anni e la legge
richiede che sussistano oggettive circostanze di eccezionale gravità e
pericolosità per trattenermi in condizioni tanto degradanti. Ma, come sapete, i
motivi di questo infierire sono ben altri e ci vengono anche ripetutamente detti
dagli stessi magistrati, se pure con il divieto assoluto di essere messi a
verbale, come invece si dovrebbe regolarmente fare. L’obbiettivo di questi
magistrati, quelli della Procura di Milano in modo particolare, è quello di
costringere ciascuno di noi a rompere, definitivamente e irrevocabilmente, con
quello che loro chiamano il nostro “ambiente”. Ciascuno di noi, già compromesso
nella propria dignità agli occhi della opinione pubblica per il solo fatto di
essere inquisito o, peggio, essere stato arrestato, deve adottare un
atteggiamento di “collaborazione” che consiste in tradimenti e delazioni che lo
rendano infido, inattendibile, inaffidabile: che diventi cioè quello che loro
stessi chiamano un “infame”. Secondo questi magistrati, a ognuno di noi deve
dunque essere precluso ogni futuro, quindi la vita, anche in quello che loro
chiamano il nostro “ambiente”. La vita, dicevo, perché il suo ambiente, per
ognuno, è la vita: la famiglia, gli amici, i colleghi, le conoscenze locali e
internazionali, gli interessi sui quali loro e loro complici intendono mettere
le mani. Già molti sostengono, infatti, che agli inquisiti come me dovrà essere
interdetta ogni possibilità di lavoro non solo nell’Amministrazione pubblica o
parapubblica, ma anche nelle Amministrazioni delle aziende private, come si fa a
volte per i falliti. Si vuole insomma creare una massa di morti civili,
disperati e perseguitati, proprio come sta facendo l’altro complice infame della
magistratura che è il sistema carcerario. La convinzione che mi sono fatto è che
i magistrati considerano il carcere nient’altro che uno strumento di lavoro, di
tortura psicologica, dove le pratiche possono venire a maturazione, o ammuffire,
indifferentemente, anche se si tratta della pelle della gente. Il carcere non è
altro che un serraglio per animali senza teste né anima. Qui dentro ciascuno è
abbandonato a stesso, nell’ignoranza coltivata e imposta dei propri diritti,
custodito nell’inattività nell’ignavia; la gente impigrisce, si degrada e si
dispera diventando inevitabilmente un ulteriore moltiplicatore di malavita. Come
dicevo, siamo cani in un canile dal quale ogni procuratore può prelevarci per
fare la propria esercitazione e dimostrare che è più bravo o più severo di
quello che aveva fatto un’analoga esercitazione alcuni giorni prima o alcune ore
prima. Anche tra loro c’è la stessa competizione o sopraffazione che vige nel
mercato, con differenza che, in questo caso, il gioco è fatto sulla pelle della
gente. Non è dunque possibile accettare il loro giudizio, qualunque esso sia.
Stanno distruggendo le basi di fondo e la stessa cultura del diritto, stanno
percorrendo irrevocabilmente la strada che porta al loro Stato autoritario, al
loro regime della totale asocialità. Io non ci voglio essere. Hanno distrutto la
dignità dell’intera categoria degli avvocati penalisti ormai incapaci di
dibattere o di reagire alle continue violazioni del nostro fondamentale diritto
di essere inquisiti, e giudicati poi, in accordo con le leggi della Repubblica.
Non sono soltanto gli avvocati, i sacerdoti laici della società, a perdere la
guerra; ma è l’intera nazione che ne soffrirà le conseguenze per molto tempo a
venire. Già oggi i processi, e non solo a Milano, sono farse tragiche,
allucinanti, con pene smisurate comminate da giudici che a malapena conoscono il
caso, sonnecchiano o addirittura dormono durante le udienze per poi decidere in
cinque minuti di Camera di consiglio. Non parliamo poi dei tribunali della
libertà, asserviti anche loro ai pubblici ministeri, né dei tribunali di
sorveglianza che infieriscono sui detenuti condannati con il cinismo dei
peggiori burocrati e ne calpestano continuamente i diritti. L’accelerazione dei
processi, invocata e favorita dal ministro Conso, non è altro che la sostanziale
istituzionalizzazione dei tribunali speciali del regime di polizia prossimo
venturo. Quei pochi di noi caduti nelle mani di questa “giustizia” rischiano di
essere i capri espiatori della tragedia nazionale generata da questa
rivoluzione. Io sono convinto di dover rifiutare questo ruolo. E’ una decisione
che prendo in tutta lucidità e coscienza, con la certezza di fare una cosa
giusta. La responsabilità per colpe che posso avere commesso sono esclusivamente
mie e mie sono le conseguenze. Esiste certamente il pericolo che altri possano
attribuirmi colpe non mie quando non potrò più difendermi. Affidatevi alla mia
coscienza di questo momento di verità totale per difendere e conservare al mio
nome la dignità che gli spetta. Sento di essere stato prima di tutto un marito e
un padre di famiglia, poi un lavoratore impegnato e onesto che ha cercato di
portare un po’ più avanti il nostro nome e che, per la sua piccolissima parte,
ha contribuito a portare più in alto questo paese nella considerazione del
mondo. Non lasciamo sporcare questa immagine da nessuna “mano pulita”. Questo vi
chiedo, nel chiedere il vostro perdono per questo addio con il quale lascio per
sempre. Non ho molto altro da dirvi poiché questi lunghissimi mesi di lontananza
siamo parlati con tante lettere, ci siamo tenuti vicini. Salvo che a Bruna, alla
quale devo tutto. Vorrei parlarti Bruna, all’infinito, per tutte le ore e i
giorni che ho taciuto, preso da questi problemi inesistenti che alla fine mi
hanno fatto arrivare qui. Ma in questo tragico momento cosa ti posso dire,
Bruna, anima dell’anima mia, unico grandissimo amore, che lascio con un
impagabile debito di assiduità, di incontri sempre rimandati, fino a questi
ultimi giorni che avevamo pattuito essere migliaia da passare sempre insieme, io
te, in ogni posto, e che invece qui sto riducendo a un solo sospiro? Concludo
una vita vissuta di corsa, in affanno, rimandando continuamente le cose
veramente importanti, la vita vera, per farne altre, lontane come miraggi e,
alla fine, inutili. Anche su questo, soprattutto su questo, ho riflettuto a
lungo, concludendo che solo così avremo finalmente pace. Ho la certezza che la
tua grande forza d’animo, i nostri figli, il nostro nipotino, ti aiuteranno a
vivere con serenità e a ricordarmi, perdonato da voi per questo brusco addio.
Non riesco a dirti altro: il pensiero di non vederti più, il rimorso di avere
distrutto i nostri anni più sereni, come dovevano essere i nostri futuri, mi
chiude la gola. Penso ai nostri ragazzi, la nostra parte più bella, e penso con
serenità al loro futuro. Mi sembra che abbiano una strada tracciata davanti a
sé. Sarà una strada difficile, in salita, come sono tutte le cose di questo
mondo: dure e piene di ostacoli. Sono certo che ciascuno l’affronterà con
impegno e con grande serenità come ha già fatto Stefano e come sta facendo
Silvano. Si dovranno aiutare l’un l’altro come spero che già stiano facendo,
secondo quanto abbiamo discusso più volte in questi ultimi mesi, scrivendoci
lettere affettuose. Stefano resta con un peso più grave sul cuore per essere
improvvisamente rimasto privato della nostra carissima Mariarosa. Al dolcissimo
Francesco, piccolino senza mamma, daremo tutto il calore del nostro affetto e
voi gli darete anche il mio, quella parte serena che vi lascio per lui. Le mie
sorelle, una più brava dell’altra, in una sequenza senza fine, con le loro
bravissime figliole, con Giulio e Claudio, sono le altre persone care che lascio
con tanta tristezza. Carissime Giuliana e Lella, a questo punto cruciale della
mia vita non ho saputo fare altro, non ho trovato altra soluzione. Ricordo
Sergio e la sua famiglia con tanto affetto, ricordo i miei cugini di Guastalla,
i Cavazzani e i loro figli. Da tutti ho avuto qualcosa di valore, qualcosa di
importante, come l’affetto, la simpatia, l’amicizia.
A tutti lascio il ricordo di me che vorrei non fosse quello di una scheggia che
improvvisamente sparisce senza una ragione, come se fosse impazzita. Non è così,
questo è un addio al quale ho pensato e ripensato con lucidità, chiarezza e
determinazione. Non ho alternative. Desidero essere cremato e che Bruna, la mia
compagna di ogni momento triste o felice, conservi le ceneri fino alla morte.
Dopo di che siano sparse in qualunque mare. Addio mia dolcissima sposa e
compagna, Bruna, addio per sempre. Addio Stefano, Silvano, Francesco; addio
Ghiti, Lella, Giuliana, addio. Addio a tutti. Miei carissimi, vi abbraccio tutti
insieme per l’ultima volta. Il vostro sposo, papà, nonno, fratello. Gabriele»
Intervista al giornalista Frank Cimini:
"QUELLO PARLA
DA SOLO"
di Stefano
Carluccio su “Critica Sociale”. Frank Cimini, cronista di giudiziaria al Palazzo
di giustizia di Milano, è da sempre una voce fuori dal coro. E’ forse uno dei
pochi giornalisti che non ha ceduto al lavaggio del cervello da parte dei
procuratori e dei loro sostituti. Al punto da guadagnarsi una querela
miliardaria per aver scritto, l’unico a farlo, che nell’ufficio di Borrelli si
era consumato un patto ignobile per evitare il carcere all’amministratore
delegato della Fiat, Cesare Romiti.
Ma per quale ragione non passare le veline della procura rischia
di mandarti fuori gioco?
“Per i cronisti l’imputato è sempre il diavolo, è il mostro. Il cronista sta
sempre dalla parte dell’accusa, perché sono i p.m. che passano le notizie sulle
inchieste, sono i p.m. che forniscono il pane quotidiano. Ma questa non è una
novità di tangentopoli: è sempre accaduto”.
Essere garantisti oggi, significa passare per complici di
malfattori. Non si sta giocando con i principi?
“Si è sempre giocato con i principi. Ma l’Italia è il paese dei miracoli. Ora il
miracolo è il garantismo del Pci - Pds. D’Alema garantista, Violante garantista:
cose da non credere. E questo solo perché un sostituto procuratore sta scrivendo
in forma giudiziaria una verità storica e politica arcinota, cioè che il Pci-
Pds si è sempre finanziato con il denaro delle cooperative a cui faceva vincere
le gare d’appalto nelle regioni rosse e non solo lì. Da cronista mi pare di
capire che D’Alema teme che il miracolo di essere passato fin qui illeso possa
terminare e allora compie il miracolo di scoprirsi garantista. In realtà la
cultura giuridica del Pci-Pds è storicamente l’opposto della cultura dello Stato
di diritto”.
Omissioni?
“Beh, gran parte delle notizie sul finanziamento illecito al Pci - Pds era già
tutto nelle carte della procura di Milano. Ma i magistrati si sono mossi con
opportunismo. Esattamente come hanno fatto con la Fiat, con i nuovi vertici
dell’Eni, ecc. Hanno ritenuto che non fosse opportuno proseguire le indagini su
determinati filoni probabilmente in cambio di un consolidamento del loro ruolo.
I mandati di cattura per Craxi potevano essere spiccati già un anno fa, vista la
piega presa. Eppure hanno aspettato. Perché? Perché, lo sanno anche i muri del
Tribunale, il pool vorrebbe ad ogni costo bloccare Salamone che indaga su Di
Pietro. Un’azione giudiziaria in base a un’opportunità. Ma nel codice di
procedura penale non esiste la nozione di opportunità”.
Si tratta di colpi di coda?
“Non c’è dubbio che nelle recenti misure adottate dal pool contro Craxi c’è il
tentativo di reagire anche ad un calo sensibile del consenso fin qui registrato
dall’inchiesta. Insomma per riguadagnare terreno e spazio sui giornali tornano a
gettare tutto sul capro espiatorio, il simbolo di ogni male. Ma Craxi non ha
inventato il sistema delle tangenti, lo ha ereditato. Forse non avrà fatto nulla
per cambiare la situazione, ma almeno è stato l’unico ad ammettere che la
politica si finanziava in modo anche illecito. E’ l’unico che ha detto la
verità, mentre altri continuano a far finta di nulla. E forse sta pagando anche
per questa verità”.
Le polemiche vanno avanti da anni, ma come spezzare il connubio
tra toghe e media?
“Il problema è di metodo. La stampa crea gli eroi, ma alla fine il successo
divora le sue creature. E allora: i pubblici ministeri sono terrorizzati
all’idea che qualcuno limiti l’uso del carcere e l’uso dei pentiti, perché
dovrebbero fare le indagini che non hanno mai fatto. Gli toccherebbe lavorare.
Bene: una riformetta piccola piccola potrebbe essere, allora, quella di vietare
di pubblicare sui giornali nome e cognome dei singoli magistrati che conducono
le inchieste. Si taglierebbe la testa a tanto protagonismo che, come la vicenda
Tortora ancora ha la forza di confermare, è il più delle volte all’origine dei
comportamenti dei magistrati. Se sui giornali comparisse solo l’ufficio che sta
conducendo una determinata inchiesta, tante violazioni non avrebbero nemmeno più
scopo e tutti lavorerebbero con più libertà: i magistrati e i giornalisti. Ma
credo che alla corporazione togata quest’idea non piaccia. Come farebbe Caselli
ad andare tre volte alla settimana in televisione a fare il suo comizio? S’è mai
alzata una vestale della par condicio a dire ‘Che fa questo, parla da solo?“.
Falsa
rivoluzione.
Intervista a Frank Cimini su “L’Inkiesta”. Non lo dice adesso che sono passati
vent’anni e una revisione critica di quei fatti appare fisiologica, prima che
doverosa. Lo scriveva, unico, già allora, quando i giornalisti erano i “cantori”
del pool di toghe milanesi guidato da Antonio Di Pietro. «Tangentopoli è una
falsa rivoluzione e i magistrati finti eroi che volevano accrescere il potere
della loro casta». Sotto la barba ispida e nera e lo sguardo acuto di Frank
Cimini sono passati trent’anni di cronaca giudiziaria milanese. Tra i capitoli
più turbolenti, “Mani Pulite”. Cimini fu il primo a prendersi una querela dai
magistrati che indagavano sulla corruzione. «Il pool mi chiese 400 milioni per
un articolo pubblicato nel 1993 sul Il Mattino intitolato “Latitante,
ripassi domani” in cui spiegavo che i pubblici ministeri non volevano
interrogare un manager della Fiat perché temevano raccontasse le tangenti
all’ombra dell’azienda torinese, verso la quale la Procura mantenne sempre un
trattamento di favore. Persi in primo grado, ma vinsi in appello». Per Cimini ci
sarebbe un “epitaffio” efficace in grado di commemorare Tangentopoli. «L’unico
modo serio e paradossale di celebrare quest’anniversario sarebbe apporre una
targa con incise le parole intercettate dal Gico della Guardia di Finanza al
banchiere Francesco Pacini Battaglia: “A me Di Pietro e Lucibello mi hanno
sbancato, si pagò per uscire da Mani Pulite”».
Perché
proprio quelle parole per ricordare un fenomeno complesso come Tangentopoli?
Mani Pulite è
caratterizzata da una serie di imputati, tra i quali lo stesso Pacini Battaglia,
Prada, Redaelli, che erano difesi dall’avvocato Giuseppe Lucibello, intimo amico
di Di Pietro. Nell’ intercettazione si faceva riferimento all’unica disastrosa
operazione finanziaria compiuta da Pacini Battaglia a vantaggio del costruttore
Antonio D’Adamo, che a Di Pietro aveva regalato un cellulare e una macchina.
Di Pietro
venne però assolto per quella vicenda dopo essere stato indagato dalla Procura
di Brescia per concussione.
Fu prosciolto
perché l’Anm, per la prima e unica volta nella sua storia, si schierò con un
indagato, ed era Di Pietro, che non si poteva toccare. Al di là dell’esito
giudiziario, ci sono dei fatti storici che lo stesso pubblico ministero non ha
mai smentito: il prestito di 100 milioni di lire ricevuto da Giancarlo Gorrini e
poi restituito dal magistrato in una scatola delle scarpe, il figlio del
magistrato che lavorava per lo stesso Gorrini, i vestiti che Di Pietro comprava
in una boutique di Porta Venezia e il costruttore D’Adamo pagava. Questo era
l’uomo simbolo di Mani Pulite.
Da dove
arriva quella che lei inquadra come l’onnipotenza di Di Pietro e dei magistrati
che lo affiancavano? Come nasce Mani Pulite?
Mani Pulite è
potuta scoppiare per un’anomalia tutta italiana. I partiti si erano molto
indeboliti perché avevano delegato completamente alla magistratura la soluzione
della vera emergenza di quegli anni, il terrorismo. La magistratura acquistò un
enorme credito verso i politici che, in quegli anni, si erano dimostrati
incapaci di dare una risposta agli “anni di piombo” ed erano impegnati a
ingrassare alle spalle degli imprenditori.
Ma prima
del 1992 la politica non era corrotta? E perché la magistratura non perseguiva i
politici corrotti?
Prima del 1992
le notizie di reato c’erano, eccome, ma si faceva finta di niente per due
ragioni. La prima era di politica internazionale. Fino al 1989, anno della
caduta del muro di Berlino, le forze politiche italiane costituivano un blocco
molto unito, impossibile da scalfire. La seconda era quella a cui accennavo
prima: la politica era un potere forte che s’indebolì in seguito all’incapacità
di trovare una soluzione politica per la madre di tutte le emergenze, il
terrorismo. Certamente è innegabile che la politica “facilitò” il lavoro della
magistratura perché era largamente corrotta.
Nella sua
azione contro la corruzione, la magistratura usò metodi oggi riconosciuti da
molti come non rispettosi della Costituzione. È d’accordo?
È vero. Il
pool fece violenza sulla Costituzione. Mi ricordo quei magistrati andare in
televisione e parlare senza contraddittorio, da eroi intoccabili. Si verificò,
inoltre, un uso spropositato della custodia cautelare, e si registrarono tanti
episodi di arroganza e mancanza di umanità. Uno su tutti: quando Borrelli negò
all’indagato Pillitteri di andare ai funerali del cognato Bettino Craxi nel
2000.
Il
comportamento dei magistrati è colpevole anche nella rilettura di alcuni suicidi
di detenuti eccellenti?
Raul Gardini,
che si tolse la vita, fu trattato come un delinquente. Chiese di poter essere
interrogato, ma non gli venne concesso. A differenza di quanto accadde per
Romiti e De Benedetti che ebbero questa opportunità. Cusani, che non aveva
incarichi in Montedison, fu condannato al doppio della pena rispetto a Carlo
Sama, dotato di poteri a lui ben superiori, perché non collaborò. Nacque in
quegli anni l’idea di premiare chi collaborava coi magistrati. Alcuni indagati
che non collaborarono arrivarono a togliersi la vita.
Perché la
magistratura esercitò quelli che definisce abusi di potere?
Perché, a
parte Di Pietro, che agiva per sua vanità e tornaconto personale, gli altri
volevano accrescere il potere della casta, arrivare a governare il paese. Tanto
che Borrelli, a un certo punto, disse: “Se il Presidente della Repubblica ci
chiama per governare, noi dobbiamo andare”. Nella sua opera fu aiutata anche
dagli avvocati che, pur di ottenere le parcelle milionarie, si vendevano alla
Procura i loro assistiti. Tanti di questi legali poi sono diventati garantisti,
ma allora funzionava così, quello era il clima.
Prima ha
detto che alcuni imprenditori furono salvati. Chi erano e perché gli si
risparmiò l’umiliazione del carcere?
Cominciamo
dalla Fiat, che era intoccabile. Andò così. Agnelli, che allora non aveva poteri
formali all’interno dell’azienda, disse: “Dobbiamo uscirne”. Allora Romiti si
presentò a Di Pietro e, in un memoriale, elencò le tangenti che la Fiat aveva
pagato, ma, come poi emergerà da altre indagini, quello rappresentò
l’inquinamento probatorio più clamoroso di Mani Pulite perché erano più le
tangenti nascoste da Romiti che quelle rivelate. Nei giorni seguenti, si svolse
una riunione negli uffici di Borrelli, a cui partecipò anche l’avvocato
Giandomenico Pisapia, il papà di Giuliano, legale dell’azienda, e dal quel
momento le indagini si fermarono. La stessa cosa accadde per De Benedetti, che
presentò un memoriale in cui ometteva molte cose, ma si salvò.
Parte della
vulgata su Tangentopoli, alimentata anche da una lettura degli eventi di
Berlusconi, racconta che le “toghe rosse” risparmiarono il Pci-Pds. Come andò?
Questa delle
“toghe rosse” è una becera leggenda berlusconiana. La verità è che i magistrati
e in particolare Borrelli, uomo molto intelligente, sapeva che se si fosse
indagato su tutte le forze politiche il Parlamento si sarebbe compattato contro
la magistratura, avrebbe votato l’amnistia e i pm sarebbero andati a casa.
L’unica che provò a indagare fu Tiziana Parenti ma tutto il pool la bloccò e
chiese al gip l’archiviazione per Marcello Stefanini, il tesoriere diessino. Il
gip si oppose all’archiviazione e invitò i pm a indagare sui rapporti tra
Greganti e i vertici del partito, ma loro non fecero nulla.
Siamo a un
bilancio. Quali sono stati gli esiti di Tangentopoli?
Fu una falsa
rivoluzione. Quella vera la può fare solo la politica, i processi penali non
trasformano la società. Ad alimentare questo falso mito contribuì la stampa
perché gli editori erano sotto schiaffo del pool. In Italia nessuno ha dei
bilanci puliti e venne sancito un patto tra editori e magistrati. Noi vi
sosteniamo mediaticamente, voi ci salvate. Fino all’avviso di garanzia a
Berlusconi, che cambiò le cose perché i suoi giornali si rivoltarono contro il
pool, ero la sola voce critica in Procura. Litigavo spesso con D’Ambrosio, che
pure stimavo.
Oggi
Gherardo Colombo va nelle scuole e predica che va cambiata la società civile
attraverso un’assimilazione delle regole. Ma anche allora la società civile
sembrava pervasa da un moralismo anti – corruzione.
La società
civile non esiste ora e non esisteva allora. Il popolo si entusiasmò per il
regicidio , ma poi ogni italiano, quando può, se ne frega e non paga le tasse.
In Italia non c’è cultura delle regole. A Colombo, che ha scritto un libro
intitolato “Farla Franca: la legge è uguale per tutti?”, io dico: l’hanno fatta
franca gli imprenditori perché la magistratura li ha salvati; l’ha fatta franca
Di Pietro perché per molto meno altri sono andati in galera. I magistrati
facciano i magistrati, non hanno credibilità per dare lezioni di morale a
nessuno.
Tangenti
rosse: gli antenati di Penati.
Quel che
accade in questi giorni ha un famoso precedente: quello svelato nell'inchiesta
Mani pulite. Che però non portò a indagini in tutte le direzioni. Un giornalista
che in quegli anni era in prima linea sul fronte di Tangentopoli spiega che cosa
successe davvero. E perché, scrive Frank Cimini su “Panorama”. Ma se le accuse
si dimostrassero fondate, che cosa può avere spinto gli esponenti della sinistra
oggi nel mirino a mantenere in piedi il meccanismo dei finanziamenti come se
Mani pulite non fosse mai esistita? Che cosa può avere fatto loro credere che
l’avrebbero comunque fatta franca? Forse proprio l’esperienza della prima
Tangentopoli e le indulgenze che la magistratura milanese ritenne di dovere
applicare a Primo Greganti e Achille Occhetto, storici antenati di Penati e
Bersani. Se si torna con la memoria a quegli anni ci si rende facilmente conto
che il buco nero di Mani pulite è rappresentato non tanto dalle indagini fatte e
come, ma da quelle non eseguite fino in fondo a causa della necessità – secondo
l’impostazione del mitico pool coordinato da Francesco Saverio Borrelli – di
avere una sponda dentro il palazzo della politica in modo da evitare che
l’eventuale coinvolgimento di tutti i partiti portasse a un’amnistia destinata a
vanificare tutto il lavoro investigativo. A livello politico a beneficiarne fu
il Pci-Pds. Punto centrale dell’intera vicenda fu nel 1993 la decisione del gip
storico dell’inchiesta Italo Ghitti di rigettare per ben due volte la richiesta
di archiviare le accuse a carico dell’allora tesoriere del partito Marcello
Stefanini, ordinando nuove indagini in 12 punti che non furono eseguite, al di
là di una folkloristica rogatoria a Berlino quattro anni dopo la caduta del
Muro. Ghitti fece un elenco lungo. Chiese, al punto A (e le sue «tirate
d’orecchie» arrivarono sino alla lettera N) di «accertare se Stefanini Marcello
o qualche altro funzionario della tesoreria Pci/Pds avesse nel 1990 e 1991 la
disponibilità del conto corrente 132316 presso Sbs di Chiasso; in caso negativo,
accertare chi ne avesse la disponibilità effettiva nel 1990 e 1991». Su quel
conto, secondo indiscrezioni, erano transitati 1 miliardo e 50 milioni arrivati
dalla Germania Est sul conto «Gabbietta» di Primo Greganti, più altri 100
milioni. Nei punti immediatamente successivi, Ghitti indicava di proseguire gli
accertamenti su Primo Greganti: conti correnti suoi, delle aziende, della
famiglia, patrimonio immobiliare suo, delle sue società, della sua famiglia.
Voleva sapere se da questi conti ci fosse stato un movimento di denaro a favore
di Stefanini, o di manifestazioni del partito, o di società di cui il partito
deteneva o detiene quote di maggioranza. Indagini non eseguite. Al punto G,
Ghitti chiedeva di accertare «quali contributi siano stati erogati dalla Forni
impianti industriali ingegner De Bartolomeis spa in ciascuno degli anni
decorrenti dal 1988 a oggi, in via ufficiale e occulta, alla tesoreria del
Pci/Pds». Seguivano altre richieste di accertamenti per società di Greganti o
per altre ancora, e infine la ricostruzione minuziosa dell’acquisto, da parte
del compagno G, dell’appartamento di via Tirso a Roma, dove da due anni si era
trasferito con la famiglia. A questo punto, dopo un simile cannoneggiamento
Ghitti ipotizzava che il pool fosse stato sul fronte Pci/Pds molto meno
efficiente di quanto accaduto nei confronti, per esempio, dei socialisti. Tra i
12 punti da approfondire figurava la società Maritalia in rapporto con Greganti,
comparsa anni dopo tra le carte del dossier Mitrokhin. Dopo la primavera,
l’autunno. Il pool ribadì la richiesta di archiviazione. Ghitti rigettò per la
seconda volta. Il pool dei pm fece in sostanza finta di niente. Accadde che il
giudice fu candidato ed eletto al Csm. La pratica passò a una collega che
archiviò, come è spesso accaduto nella storia giudiziaria. Nel senso che, se una
procura tiene il punto e decide che le indagini non le fa, non c’è verso di
schiodarla. A Milano è accaduta in anni recenti una vicenda clamorosa, quella
del piccolo aereo finito contro il Pirellone nel 2002. Il gip indicò i punti sui
quali indagare, con i nomi delle persone da iscrivere nell’apposito registro; in
aula il pm replicò papale papale che non avrebbe fatto nulla di tutto ciò. Il
giudice andò in maternità, subentrò un collega che archiviò. Insomma, il pool
era forte di una prassi. Ma sarebbe sbagliato, anche a 20 anni dai fatti,
pensare che solo il Pci-Pds beneficiò della logica dei due pesi e due misure.
L’elenco è lungo. Basta ricordare la Mediobanca che si era pappata la Montedison
con le parole dell’avvocato Giuliano Spazzali al teleprocesso contro Sergio
Cusani: «Se il dottor Di Pietro decidesse di farsi una passeggiata in via
Filodrammatici lo accompagnerei volentieri». La Fiat «graziata» dopo che Cesare
Romiti aveva presentato un elenco di mazzette pagate pieno di lacune. In una
riunione con i legali del gruppo nell’ufficio del procuratore capo Borrelli si
decise non solo di non chiedere la custodia cautelare per il pericolo di
inquinamento delle prove ma di non indagare più. Lo stesso accadde per Carlo De
Benedetti, altro imprenditore dalla memoria corta. L’indagine rispondeva a
criteri politici, non nel senso delle «toghe rosse», ma del consenso da
ricercare anche tramite i giornali di cui erano editori molti indagati
eccellenti i quali si trovavano sotto schiaffo. Gli imprenditori furono salvati
a scapito dei politici, con l’eccezione della Quercia. Su una sola azienda si
indagherà poi fino in fondo. In tutto l’Occidente non c’è impresa privata che
abbia subito il numero di perquisizioni e di arresti di Fininvest e a
giustificare il tutto c’era la discesa in campo del fondatore al quale
evidentemente non bastò nel 1992 e nel 1993 l’appoggio alla «rivoluzione
giudiziaria» con le sue tv e Paolo Brosio 24 ore su 24 davanti al palazzo per
conto del Tg4. Che l’uomo simbolo di quel «repulisti», Gerardo D’Ambrosio, sia
stato eletto senatore nelle liste dell’unico partito miracolato dalle indagini è
solo la ciliegina sulla torta. Del miliardo di lire pagato sulla
defiscalizzazione di Enimont fu accertata la destinazione di Botteghe Oscure ma
non l’identità delle persone che incassarono i quattrini e quel gran giurista di
Antonio Di Pietro, altro inquisitore finito in politica, ricordò a tutti noi
comuni mortali: «La responsabilità penale è personale».
Negli anni di
Mani Pulite, Frank Cimini è stato il corrispondente da Milano del Mattino di
Napoli. Sempre presente in Procura e in tribunale, è stato uno dei giornalisti
più attenti e affidabili fra quanti raccontarono Tangentopoli.
«Dalle Br alle
Olgettine, vi racconto come politici e magistrati hanno sfasciato la giustizia»,
scrive Chiara Rizzo su “Tempi”. Va in pensione Frank Cimini, uno dei più noti
cronisti di giudiziaria in Italia, testimone critico di 35 anni di processi.
«Tutto è andato a rotoli quando la politica si è consegnata alla magistratura».
Va in pensione oggi Frank Cimini, 60 anni, cronista di giudiziaria diventato
un’istituzione a Milano. Barba socratica e battuta pronta e tagliente, Cimini,
dopo un’esperienza come ferroviere, ha cominciato la professione tra il 1976 e
il 1977: prima come praticante al Manifesto, poi come corrispondente del
quotidiano il Mattino di Napoli (Cimini è nato in Connecticut, a New
Haven, da genitori originari della costiera amafiltana). In 35 anni di carriera
è stato testimone oculare, e critico, della storia giudiziaria e politica
italiana.
Cimini, come si sente ad andare in pensione?
«Ho
solo finito il lavoro come giornalista dipendente, ma proseguirò quello più
divertente da giornalista indipendente con un blog appena nato:
giustiziami.it.
Su questo sito, cui lavorano anche altri giovani e attenti cronisti di
giudiziaria di Milano, avrò più libertà di scrittura perché non dovrò dipendere
da alcuna linea editoriale».
Dai processi alle Br a quelli alle olgettine. Come ha visto
cambiare la giustizia italiana in questi anni e qual è oggi il suo giudizio sul
sistema del nostro paese?
«Resto
molto critico: mi pare che si vada di male in peggio, e questo al di là dal
fatto che, personalmente, trovo terrificante un sistema di uomini che giudicano
altri uomini. Ora quando sento parlare di riforma della giustizia mi viene
l’orticaria. Negli ultimi anni non la si è fatta perché Silvio Berlusconi la
intende come una legge per salvarsi dai suoi processi, mentre i suoi avversari
intendono mantenere lo status quo. Non penso che la situazione cambierà nel
breve-medio periodo. Negli anni di cui sono stato testimone, la giustizia ha
subìto dei danni e, secondo me, questo è accaduto prima della discesa in campo
del Cavaliere. La situazione si è poi aggravata con Berlusconi, ma non solo per
colpa sua. Qualsiasi persona di buon senso sa che non c’è una via d’uscita a
breve, e questo perché la classe politica non ha le competenze per affrontare la
situazione e riformarla, dato che governa sulla base della cronaca quotidiana,
di emergenza in emergenza».
Di chi è la responsabilità di questo peggioramento della
situazione?
«Le
responsabilità sono tanto della magistratura quanto delle classe politica. La
politica, ad esempio, si è consegnata mani e piedi alla magistratura per la
“lotta al terrorismo”. Da quella, che è stata la “madre delle emergenze”, si è
passati ad altre emergenze: la mafia, Mani pulite… Così, negli anni Novanta la
magistratura è saltata al collo della politica. In mezzo a questo ciclone di
eventi è arrivato Berlusconi, e la situazione è peggiorata».
È arcinota, tra cronisti e avvocati, la sua antipatia nei
confronti di un pm “storico” di Milano, Antonio Di Pietro. Perché?
«Personalizzare
è sbagliato. Ma volendo rispondere dico che un personaggio come Di Pietro, per
fermarsi agli ultimi vent’anni, ha finito per nuocere alla stessa magistratura
che lo aveva scelto a proprio simbolo. Di Pietro è un personaggio negativo sotto
ogni punto di vista: ha usato il codice di procedura penale come carta igienica.
A mio avviso, la magistratura ha usato la sua figura per aumentare il proprio
peso, il proprio potere, ma sarebbe stato meglio se si fossero scelti un simbolo
migliore, visti i metodi che ha usato. A Palazzo di giustizia tutti ne hanno
parlato come di personaggio che viveva a “scrocco” degli indagati, e che faceva
cose che nessun magistrato avrebbe dovuto fare. Se queste azioni furono
commesse, ciò è avvenuto però con la “copertura mediatica” del “giudice che
ripuliva l’Italia dalla corruzione e dal malaffare”. Il 1993 è stato davvero
l’anno del terrore e i politici hanno avuto paura di un magistrato che in realtà
non era molto più lindo di coloro su cui indagava».
Oggi in un’intervista Luciano Violante, ex magistrato, da sempre
di sinistra, concorda con la sua analisi e sostiene che la politica ha abdicato
alla magistatura, delegandole grandi questioni politiche, come il terrorismo,
mafia e corruzione. Poi aggiunge che «Vanno separate le carriere. Ma quelle di
pm e giornalisti». Lei che ne pensa?
«Su
questo posso essere d’accordo: i giornalisti le informazioni le prendono
direttamente dalle procure e appena c’è un’inchiesta, salvo altri scopi
editoriali, i giornali sono schierati con l’accusa. Il punto, però, è da che
pulpito viene la predica. Violante è un altro magistrato che con le sue
inchieste ha fatto scandalo: un esempio è l’inchiesta intimidatoria e senza
riscontri che condusse su Edgardo Sogno (personaggio che comunque giudico
scandaloso). Violante lo accusò di essere autore di un golpe e lo mise in
carcere: Sogno venne prosciolto in seguito da ogni accusa. Non dimentichiamo poi
che Violante è stato uno dei fondatori del partito dei giudici, e all’epoca
dell’antiterrorismo è stato tra coloro che si sono più battuti per una “delega
in bianco” alla magistratura. Ora, va bene che solo i paracarri non cambiano
idea, e prendiamo atto che Violante lo ha fatto: ma lui è uno di quelli che ha
voluto le leggi premiali sui pentiti e con i disastri che ne sono stata
conseguenza, sarà impossibile uscire dal pantano che si è creato. Violante è
stato una delle incarnazioni della via giudiziaria al socialismo».
L’opinione pubblica oggi parla sempre di più di temi finora
trascurati, come l’abuso della custodia cautelare o l’emergenza delle carceri.
Crede che qualcosa stia cambiando sotto questo profilo?
«Ho
visto il carcere usato sempre più come una discarica sociale, e usato anche
all’interno degli scontri di potere tra politica e magistratura per regolare i
conti. In Italia c’è un uso eccessivo del carcere e della custodia cautelare ma
li vedo ancora come problemi che nel nostro paese sono ridotti a tema da
convegni e manifestazioni, senza che poi di fatto cambi nulla».
Trasferito da
Milano a Portici e licenziato, scrive “Iustitia”. Negli anni caldi di
Tangentopoli Frank Cimini è stata la firma giudiziaria del Mattino da Milano,
sempre presente con il suo barbone nelle riprese televisive dalle aule del
tribunale appena dietro alla Boccassini, a Colombo, a Di Pietro e agli altri
protagonisti del pool guidato da Francesco Saverio Borrelli. Per Massimo Bordin,
storico direttore di Radio Radicale, è tra i cronisti giudiziari più affidabili
sulla piazza milanese. “Con il pool – ricorda Cimini - ho ancora un contenzioso
giudiziario aperto, insieme all’allora direttore Pasquale Nonno. Scrissi poco
meno di venti anni fa un articolo intitolato “Latitante, ripassi domani’. La
nostra tesi era che alcuni grandi imprenditori prima facevano accordi con i
politici per avere i soldi e poi facevano accordi con i magistrati per non
andare in galera. L’articolo non piacque ai pm milanesi che citarono in giudizio
me e Nonno. Condannati in primo grado, assolti in appello, aspettiamo la
sentenza della Cassazione”. Nato nel Connecticut, a New Haven, da genitori
emigrati dalla costiera amalfitana, Cimini ha speso al Mattino venticinque dei
suoi cinquantasette anni: due da collaboratore, sei da redattore (l’assume il
primo novembre del 1987 Pasquale Nonno), otto da inviato, otto da corrispondente
e uno, l’ultimo, da cassintegrato. Venticinque anni interrotti il 30 agosto da
una lettera di licenziamento. Ma facciamo un passo indietro. Nel giugno 2009
viene firmato lo stato di crisi per il Mattino e l’azienda lo inserisce
nell’elenco dei giornalisti in cassa integrazione, che termina il 30 giugno
2010; un mese prima gli arriva una lettera ‘sorprendente’: lei non è più il
corrispondente da Milano, ma da Portici-Ercolano, un trasferimento che significa
l’intera autostrada del Sole e un pezzetto della Napoli - Pompei - Salerno, per
un totale di 775 chilometri. Cimini affida la replica a Mario Fezzi, uno dei
maggiori esperti italiani di lavoro giornalistico. Il 9 agosto arriva la
“contestazione di addebito”: “Ci risulta che Ella continua a tutt’oggi a non
fornire e scrivere articoli in relazione agli avvenimenti della zona di Sua
competenza”. Seguono il dettaglio dei giorni nei quali non ha scritto le
corrispondenze richieste e la chiusa: “La invitiamo a farci pervenire le Sue
giustificazioni entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della presente”,
con la firma di Massimo Garzilli. Il 30 agosto l’atto conclusivo: “Le intimiamo
il licenziamento per giusta causa con effetto immediato dalla ricezione della
presente”. Firmano la lettera Garzilli e il direttore Virman Cusenza, che aveva
già sottoscritto a maggio, insieme al capo del personale Raffaele Del Noce, la
notifica del trasferimento. Chi segue questa vicenda con animo ingenuo rimane
sorpreso dalle due firme. Sorprende la firma di Cusenza per ragioni, usiamo un
aggettivo fuori dal tempo, ‘umane’: si può sottoscrivere il licenziamento
costruito a tavolino di un proprio giornalista senza cercare una mediazione?
Ancora più sorprendente la firma di Garzilli, che dopo oltre venti anni da
direttore amministrativo dal 2008 è in pensione, ma firma ancora le lettere di
contestazione e le lettere di licenziamento. E allora, dal gennaio 2008 in che
cosa è cambiato il ruolo di Garzilli? In attesa di un intervento del comitato di
redazione del Mattino (Marisa La Penna, Daniela Limoncelli e Salvo Sapio), c’è
da registrare la dura presa di posizione del sindacato milanese. “È stato
attuato – dichiara a Iustitia Giovanni Negri, presidente dell’Associazione
lombarda dei giornalisti - un licenziamento annunciato. Un trasferimento di
ottocento chilometri per un giornalista che lavora da più di trent’anni a Milano
e scrive per il Mattino da venticinque era inaccettabile. La Lombarda ha gestito
oltre sessanta stati di crisi, occupandosi anche delle redazioni o dei
corrispondenti milanesi di giornali di altre regioni e ha trovato soluzioni
accettabili e condivise. In questo caso invece il dottor Garzilli, che conosco
da trent’anni e si è sempre proposto come interlocutore serio delle
rappresentanze sindacali, non ha trovato il tempo per coinvolgere la Fnsi e
l’Associazione lombarda, che è il sindacato regionale con il maggior numero
d’iscritti d’Italia, per cercare insieme una soluzione potabile per un problema
drammatico. In ogni caso non è mai troppo tardi per discutere”.
La
“medaglia” di Frank,
scrive Boffi Emanuele su "Tempi". Era il cronista del Mattino di Napoli.
Scriveva verità scomode. Fu il primo giornalista querelato dal pool di Milano.
Detto tutto su Mani Pulite? Per il soldato Cimini: “C’è di più, c’è di più”. Il
Foglio ha cominciato, e condurrà fino alla fine di quest’anno, una rievocazione
dei fatti del ’93, «l’anno più lungo della storia italiana», l’anno in cui «fu
abrogata per via giudiziaria la vecchia e infragilita democrazia dei partiti»
come ha scritto Giuliano Ferrara (Il Foglio, 13.01.03). Nella sua rubrica delle
lettere sul Corriere della Sera Paolo Mieli è ritornato spesso sulle vicende di
quel periodo. Mieli era direttore del quotidiano di via Solferino nell’aprile
del ’94 quando, con un formidabile scoop, raccontò dell’avviso di garanzia al
presidente del Consiglio Silvio Berlusconi un giorno prima che gli fosse
recapitato. I contorni di quella vicenda sono ancora per molti aspetti da
definire ma, di fatto, fu proprio l’ex direttore del Corriere ad avere, sulle
pagine di Tempi, un primo ripensamento di quel periodo (Tempi, 1 aprile ’98,
ripresa allora anche da Panorama e l’Espresso). Abbiamo chiesto a Frank Cimini,
che lavora oggi per Ap Biscom e che in quegli anni era cronista de Il Mattino,
di tornare su quelle vicende. Cimini faceva parte di quel ristretto “pool di
giornalisti” che seguì da vicino le indagini della Procura di Milano.
Cimini,
sono passati dieci anni da quel ’93 e si comincia a dire qualcosa di diverso.
«Beh,
meglio tardi che mai…»
Nell’intervista a Tempi del ’98 Mieli dichiarò che la stampa aveva aiutato i
magistrati, aveva teso un tranello a Berlusconi, si era intiepidita col
successivo governo Prodi.
«Ma
c’è di più, c’è di più».
Prego.
«È
chiaro che la stampa usò i magistrati e che i magistrati usarono la stampa. Il
problema è che, come ho detto in un’intervista a Sette qualche anno fa, e mi son
preso pure una querela con il giornalista che mi ha intervistato…»
Un attimo.
Chi ha querelato chi?
«Piercamillo
Davigo ha querelato me e Michele Brambilla. Io per quel che avevo detto e lui
perché l’aveva riportato. Ma ormai la vicenda è finita nel dimenticatoio».
Qual è la
tua tesi su Tangentopoli?
«Ci
fu uno scambio. Chi erano e chi sono gli editori dei grandi giornali? Erano
tutte persone che erano imputate e che si schierarono, come “aziende” diciamo,
come nel caso della Fiat, dalla parte della Procura. In cambio ebbero
l’impunità; sono ridicole le indagini che vennero fatte sull’azienda torinese,
su De Benedetti, su Mediobanca, se confrontate con quello che successe dopo a
Berlusconi. E Berlusconi è stato messo sotto torchio non in quanto imprenditore,
perché i grandi industriali non l’hanno pagata, ma per quella sua “discesa in
campo”. Se non fosse entrato in politica avrebbe ricevuto lo stesso trattamento
di favore che hanno ricevuto gli imprenditori. La logica di Tangentopoli fu di
salvare i grandi industriali e di farla pagare ai politici. E, per quel che
riguarda le notizie…»
C’era un
accordo fra voi giornalisti e i magistrati di Milano?
«No,
non c’era bisogno. Era un accordo tacito e nella logica delle cose. Tutti i
mezzi di informazione erano schierati, non si riusciva nemmeno a sollevare una
qualunque obiezione. Nessuno si poneva domande, comprese le televisioni di
Mediaset. Ancora oggi io non capisco certi atteggiamenti di esponenti di Forza
Italia e di Alleanza Nazionale che distinguono in un periodo “buono” di Mani
Pulite, fino al ’94, e in uno “cattivo”, dal ’94 in poi. Eh no! O è stato tutto
“buono” o è stato tutto “cattivo”».
Cioè?
«È
stato tutto un errore fin dall’inizio. La logica che c’era dietro, l’utilizzo
della carcerazione preventiva, il clima che si respirava…»
Perché
certi partiti ebbero un “trattamento di favore”?
«I
magistrati avevano bisogno di una sponda politica. Se avessero condotto le
indagini che dovevano fare, se fossero arrivati ai vertici dei Ds, Occhetto e
D’Alema, se tutto questo fosse avvenuto… io penso che in tre giorni avrebbero
fatto l’amnistia e l’operazione sarebbe finita. Non è un caso che abbiano
lasciato fuori quel partito la cui unica operazione di potere che gli era
riuscita, da quando esisteva, era stata quella di inserirsi nella magistratura».
Quando hai
iniziato a renderti conto di come andavano veramente le cose?
«Ho
iniziato a essere critico dopo che il povero Lorenzo Papi fu incarcerato».
Eri libero
di raccontare quel che vedevi?
«Io,
purtroppo, ne sto ancora pagando le conseguenze. Lucibello mi insegue
chiedendomi miliardi. Io ho solo una cosa che, a questo punto, è una medaglia.
Era l’aprile del ’93; io fui il primo ad essere querelato da Di Pietro e dal
pool per un articolo sulla Fiat dal titolo: “Latitante ripassi domani”. Era
stata fatta una riunione nell’ufficio di Borrelli con gli avvocati di Romiti.
Nonostante avessero ammesso alcune tangenti, Romiti non venne arrestato. Ma la
vicenda grave non è questa, perché io sono sempre contento se uno non viene
imprigionato. Non bisogna arrestare mai».
Allora qual
era il problema?
«Il
problema è che, dopo quell’episodio, non vennero più fatte indagini sulla Fiat
che era il motore principale del rapporto fra affari e politica in quegli anni.
Quell’articolo mi costò una citazione in una causa civile che dura tuttora».
Quante
medaglie hai collezionato?
«Questa
è quella di cui vado più fiero, perché sono stato il primo. Fino ad allora era
impensabile che il pool potesse querelare un giornalista. Io sono stato il primo
e purtroppo, dopo di me, è toccato a tanti altri».
Vuoi farmi
credere che eri l’unica voce fuori dal coro?
«Assolutamente
no. Erano in tanti a capire ma, forse per mancanza di coraggio, non so, la
verità è stata detta solo molto dopo. Certo, meglio tardi che mai».
E dopo la
querela ti sei dato una calmata o hai continuato?
«Sono
sempre andato avanti. Certo, nei limiti del possibile».
In che
senso?
«Mi
è andata abbastanza bene finché al Mattino rimase come direttore Pasquale Nonno,
anche lui inquisito e con molti amici inquisiti. Chi può essere più garantista
di un inquisito con amici inquisiti? Solo che dopo…»
Solo che
dopo…
«Ad
un certo punto Nonno lasciò Il Mattino e per me, con il nuovo direttore Sergio
Zavoli, iniziarono i problemi».
Cioè? Non
ti proteggevano più?
«Non
solo, non mi pubblicavano più i pezzi. La storia del miliardo di Sama al Pci, Il
Mattino non me la pubblicò; uscì solo su La Gazzetta del Mezzogiorno. Era il
dicembre del ’93, era un sabato e la domenica dopo c’era il ballottaggio a
Napoli Bassolino-Mussolini. E così non mi pubblicarono la notizia che anche il
Pci, per la defiscalizzazione di Enimont, aveva preso un miliardo, almeno così
diceva Sama. E non me lo pubblicarono dicendomi, testualmente, che «avrebbe
influito sul ballottaggio»».
Scusa, non
vorrei aggiungere una stelletta sulla tua divisa. Ho il permesso di scrivere
tutto?
«E
perché? Mi sembra di essere stato nei limiti della decenza, no?»
Stefania
Craxi: "Con mio padre oggi l'Italia starebbe meglio".
La figlia di
Bettino Craxi difende il padre e attacca la sinistra: "È guidata da un
democristiano", scrive Francesco Curridori su “Il Giornale”. "Je suis Craxi” è
la scritta, volutamente polemica, che compare su una foto che la figlia Stefania
ha postato sul suo profilo Facebook per ricordare i quindici anni dalla
scomparsa del padre Bettino. Intervistata dal Messaggero, lei attacca la
sinistra italiana per aver “perso l’ennesima occasione per fare i conti con
Craxi” a differenza della “stragrande maggioranza dei cittadini italiani” che “è
disposta a riconoscere i meriti di mio padre, perché fa un confronto fra
un'Italia che cresceva prospera e la nazione miserrima di oggi, la sinistra non
ne è capace”. “Trovo vergognosa – continua Stefania Craxi - l’incapacità della
sinistra, che si dichiara a mezza bocca socialista, di confrontarsi con la
storia”, e che ha subito una "grande sconfitta storica" essendo guidata da “un
giovane democristiano, che li ha portati proprio nel Partito socialista europeo,
di cui uno dei fondatori è proprio mio padre”. Per quanto riguarda l’ex
sottosegretario agli Esteri suo padre “non ha mai corrotto nessuno” e
Tangentopoli, fatta eccezione per qualche ladro, riguardava perlopiù il
“finanziamento illegale ai partiti a cui tutti partecipavano, non ruberie
personali”. “Era – aggiunge - una debolezza del sistema nata con l'avvento della
Repubblica, durante la Guerra Fredda” e suo padre, con quel famoso discorso alla
Camera, chiedeva solo “di dare una morte politica alla Prima Repubblica” perché
“quel reato andava giudicato non dalla magistratura, ma alla luce della storia”.
L’ex deputata definisce, poi, la scena delle monetine lanciate fuori dall’Hotel
Raphael “una scena vergognosa e infame”, compiuta da italiani che “cercano
sempre un capro espiatorio, ma subito dopo vogliono l'uomo della provvidenza che
li tiri fuori dai guai, lavandosene le mani e non assumendosi le proprie
responsabilità”. Infine, sulla candidatura di Amato al Quirinale la figlia
Stefania si chiede: “Com’è possibile che il vice di mio padre diventi Capo dello
Stato mentre lui, considerato dalla sinistra un delinquente, è morto in
esilio?”. Alla fine si dice convinta che se suo padre oggi fosse alla guida del
Paese “l’Italia non sarebbe in queste condizioni”.
Hammamet, i
socialisti con la maglietta "Je suis Craxi" per ricordare il leader del Psi,
scrive Paolo Corallo, dell’Ansa su huffingtonpost. Il capanno non è più lì,
sulla spiaggia di Salloum, a pochi chilometri da Hammamet. Una mareggiata l'ha
spazzato via. Ma Stefania Craxi ha comunque voluto iniziare in quel posto le
commemorazioni del padre a quindici anni dalla morte (la ricorrenza esatta sarà
lunedì prossimo) insieme al centinaio di vecchi socialisti che hanno accolto
l'invito della Fondazione Craxi e sono venuti in Tunisia per ricordare il loro
leader. Nel luogo dove Craxi si ritirava per giornate intere a leggere e a
scrivere all'ombra del capanno che aveva costruito lui stesso con l'aiuto di
Nicola Mansi, l'uomo che è stato sempre al suo fianco e che sarebbe ingiusto
definire solo autista. Pochi i volti noti tra gli italiani giunti ad Hammamet
per la ricorrenza. Qualche ex deputato, come Saverio Zavettieri, e chi, come
Lucio Barani, parlamentare lo è diventato nella Seconda Repubblica, eletto nelle
liste di Forza Italia. Barani, noto per portare sempre un garofano rosso al
bavero della giacca, questa volta si è presentato con una maglietta nera con su
ricamata la frase "Je suis Craxi" e l'immancabile garofano. Ne ha fatte fare una
decina che ha distribuito per fare delle foto di gruppo. Ad Hammamet è venuta
anche l'eurodeputata azzurra Elisabetta Gardini, che non ha un passato
socialista, ma che è qui per la vecchia amicizia che la lega a Stefania Craxi. E
c'è l'ex sottosegretario nel governo Monti Gianfranco Polillo, anche lui da
tempo esponente del partito di Berlusconi. Assenti invece i principali dirigenti
del Psi craxiano. Era previsto Fabrizio Cicchitto, che però ha dovuto rinunciare
a causa di un'influenza che lo ha colto alla vigilia della partenza. Stesso
motivo che sembra abbia bloccato a Roma l'altro figlio di Bettino Craxi, Bobo,
che pure aveva annunciato di voler essere presente. Completamente assenti i
massimi dirigenti del partito socialista dell'era craxiana. Ma i commenti acidi
sono riservati solo ad uno, Giuliano Amato, forse perchè sui giornali lo si dà
per favorito nella corsa al Quirinale. Certo è che tutti tengono a ricordare che
Amato non è mai venuto ad Hammamet, nè prima nè dopo la morte di Craxi. "Brava!"
è il commento generale che accoglie la lettura ad alta voce da parte di Stefania
di una sua intervista fresca di giornata al "Fatto Quotidiano", in cui le
frecciatine ad Amato abbondano. "Mi fa piacere se viene eletto - dice Stefania -
ma poi qualcuno mi dovrà spiegare perchè mio padre è morto in esilio ed il suo
vice va ora al Quirinale". E così Amato viene accomunato ai comunisti, da sempre
accusati di non aver mosso un dito per Craxi, ma di aver anzi pensato di poter
avere un vantaggio dalla sua rovina politica e giudiziaria. Di questo si è
parlato per tutto il tempo trascorso dove prima c'era il capanno, mangiando
nella casa dei pescatori tunisini, ricavata da un vecchio bunker della Seconda
Guerra Mondiale. Stefania ha organizzato una grigliata nel patio della povera
abitazione dove spesso Craxi si fermava a pranzo. La padrona di casa conserva
ancora le foto, belle incorniciate, di quando Bettino Craxi si presentava con la
spesa fatta e stava delle ore in loro compagnia. "Vengo qui ogni anno il giorno
della sua morte - spiega Stefania con un sorriso triste - è la mia messa laica".
Per la prima volta ha voluto portare un gruppo di vecchi socialisti nel luogo
dove il padre scriveva le sua verità che poi mandava via fax ai giornalisti che
lo avevano seguito quando era uno dei più influenti uomini politici del paese. E
da quella spiaggia scrutava il mare, puntando verso la Sicilia, l'Italia, che è
poco distante, appena oltre la linea dell'orizzonte. Forse ricordando quando
nella casa di Giuseppe Garibaldi a Caprera, dove si recava ogni 2 giugno per
l'anniversario della morte, si fermava sempre davanti ad una finestra e spiegava
che l'eroe risorgimentale si sedeva spesso lì a guardare verso l'Italia. Questo
quando Garibaldi era un esule, così come anche Craxi, si considerava, costretto
alla lontananza da una patria ingrata.
“Je suis
Craxi”, Barani: un messaggio, una parabola che racchiude il senso politico di un
programma,
scrive Monica Gasbarri su “Il Clandestino web”. In occasione
della ricorrenza dei 15 anni dalla morte di Bettino Craxi, il senatore del
gruppo Grandi Autonomie e Libertà, eletto nelle file di Forza Italia, Lucio
Barani, si è recato ad Hammamet per commemorare questo anniversario con
un’iniziativa che lui stesso ha raccontato: “Sono sbarcato ad Hammamet per
commemorare il quindicesimo anniversario della scomparsa di Bettino Craxi con
indosso la polo nera e la scritta “Je suis Craxi” con accanto un garofano”.
Barani, intervistato da Data24News, ha spiegato come è nata questa idea e qual è
il significato profondo di una frase che ha fatto immediatamente presa.
Senatore,
in occasione dell’anniversario della scomparsa di Bettino Craxi, lei si è recato
ad Hammamet per partecipare alla commemorazione. Che significato ha la vicenda
Craxi nella storia politica italiana?
«E’
una vicenda ancora attuale a 15 anni dalla morte di Craxi, e, soprattutto, a
oltre 20 anni dal golpe mediatico-giudiziario ordito nei confronti dell’Italia e
degli italiani per cancellare alcuni partiti politici (come i Socialisti, i
Socialdemocratici, i Liberali, i Repubblicani e la Democrazia Cristiana più
riformista) per portare al potere il Partito comunista e i catto-comunisti. Un
golpe ordito dai poteri forti per impadronirsi, insieme ai giudici e a certa
stampa, del potere in Italia ed essere congeniali al gioco internazionale di
vendita e invasione dei mercati italiani. Come ci insegna Gian Battista Vico,
anche questa situazione è un esempio dei tanti “corsi e ricorsi storici”: una
volta le invasioni si facevano con i mercenari e gli eserciti, oggi con
l’economia».
Qual è
invece la genesi della frase “Je suis Craxi” di cui lei si è fatto promotore?
«Si
tratta di uno slogan inventato da me, come segretario del nuovo PSI e come
socialista, ma non ha un tono nostalgico; perché sono convinto che non ci
sarebbe stato bisogno del Je suis Charlie nell’Europa di Craxi, di Mitterand,
Kohl, della Thatcher, di Aznar: erano politici, conoscevano l’arte del dialogo.
Un politico non si inventa, non si prende dalla società civile. “Je suis Craxi”
è un messaggio, una parabola, il senso politico di un programma di sviluppo. Ha
tutto in sé, passato presente e futuro».
Questa
frase, quindi, è anche una proposta…
«Perciò
questa frase è la storia di quello che è stato e di quello che non sarebbe stato
se ci fossero stati degli statisti, dei riformisti. Craxi era l’uomo del
dialogo, della tolleranza e della solidarietà internazionale, come ha ricordato
il vescovo ad Hammamet. Se si fosse tenuta questa linea saremmo stati una grande
Italia».
Oggi, si
può tornare indietro a quell’Italia?
«Per
la situazione che stiamo vivendo ora le responsabilità ci sono e vanno ricercate
nell’incapacità del Partito Comunista di governare, negli abusi delle
cooperative rosse. In questo senso sono convinto dell’attualità di Craxi: c’è
bisogno che tornino dei riformisti veri e non dei dilettanti. Serve qualcuno che
torni a fare la politica, e questo vale anche per il Presidente della Repubblica».
Ci può
tracciare un identikit del suo Presidente ideale?
«Deve
assolutamente essere un politico come Pertini. La diagnosi per la cura di una
malattia è facile: se hai un’infezione ci vuole un antibiotico, ma il tuo
organismo non deve essergli resistente. Quindi non può essere un comunista. Ci
vuole qualcuno che combatta e che lo sappia fare e che abbia dimostrato
scientificamente che è bravo, che è capace».
Se dovesse
fare un nome?
«Non
vorrei fare nomi, per non bruciare nessuno, ma Craxi aveva un figlio politico
che lo ha seguito in tutto il suo percorso: Giuliano Amato. Nonostante io possa
avere dei risentimenti nei suoi confronti… ma non possiamo vivere di sentimenti
e risentimenti, perché da politici deve prevalere l’interesse nazionale».
Tornando a
Craxi, un suo ricordo personale…
«Senza
dubbio quando gli ho portato la cittadinanza onoraria con fascia tricolore e
gonfalone. E lui ha pianto dicendomi: “hai avuto un coraggio che nessuno ha
avuto, ora che sono in disgrazia. Questo gesto mi conforta”. Nel suo discorso di
ringraziamento si è dovuto interrompere sette volte per la commozione. Questo è
il “mio” Craxi. L’altro ricordo che ho fortissimo in mento è il momento in cui
ho dato la prima palata di terra a nome di tutti i socialisti nel cimitero di
Hammamet dove io ero l’unico con la fascia tricolore».
Chiudiamo,
invece, con un ricordo politico…
«Quando
ha fatto circondare l’aereo americano a Sigonella. In quel momento è venuto
fuori l’orgoglio italiano. Ne eravamo tutti fieri. E questo è un ricordo molto
attuale: perché se lui ci fosse stato, gli indiani i marò non li avrebbero mai
presi, e se lo avessero fatto, lui sarebbe andato lì a riprendersi i suoi
ragazzi».
Filippo Facci
su “Libero Quotidiano”: Ad Hammamet tutti dicono "Je suis Bettino". Chi ha
rubato la memoria di Craxi? La scritta “Je suis Craxi” risalta sulla
maglietta a sfondo nero. Ecco, questa non l’avevo ancora vista. Per il resto, io
ne ho viste cose che voi renziani non potete immaginarvi. Erano tutti qui, a
Tunisi, esattamente quindici anni fa, durante i funerali di Bettino Craxi nella
cattedrale di Place de l’Independence: seicento posti a sedere, oltre mille
persone in piedi, voli dall’Italia raddoppiati più tre charter da Roma e Milano
e Reggio Calabria. Berlusconi che venne col suo volo privato e ospitò Francesco
Cossiga. Il premier - che nel 2000 era D’Alema - aveva offerto i funerali di
Stato e funerali di Stato furono: ma dello stato tunisino. Le divise del
picchetto d’onore erano berbere. Le litanie erano in arabo. D’Alema spedì un po’
di sottosegretari e dintorni - Minniti, Dini, Angius - che entrarono nella
cattedrale qualche minuto dopo, ma finirono nel ciclone lo stesso. Li presero a
monetine, all’uscita, com’era capitato a Craxi sotto il Raphael sette anni
prima. Chi le tirò, a Tunisi? Difficile dirlo, perché non c’erano solo reduci,
fedelissimi, famigli, ex indagati, ex assessori e amministratori e boiardi, e
poi tanti giornalisti, tanti amici: c’era anche tanta gente cosiddetta comune,
oltre a tanti, troppi voltagabbana e forcaioli che avevano tradito Craxi nel
momento di massima debolezza: ma che erano lì, sfrontati e impuniti, a spiare il
vento, sedicenti “socialisti” che erano tornati a invocare riabilitazioni
tardive, postume, fuori tempo massimo. Piccoli e grandi uomini al cospetto della
bara di Bettino Craxi, uomo di stato italiano, 1934-2000. Ma qui in Tunisia lui
è sempre stato “Monsieur le president”, c’è la sua casa con la sua moglie che
risiede e paga le tasse qui, c’è la sua tomba, c’è una via dedicata a lui, ci
sono ristoranti come il mitico Achour che espongono ancora il suo ritratto:
quello che non c’è è il problema della sua “riabilitazione”, della sua eredità
politica, tutto il discorso del dividere il grano dal loglio, lo statista da
Tangentopoli. Craxi, qui, è sempre rimasto Craxi. Non dovranno passare
cent’anni, qui, perché un popolo intero se ne ricordi una volta per tutte.
Quello che c’è, pure, qui, è un pellegrinaggio continuo alla sua tomba. E poi le
commemorazioni, come questa che è stata organizzata dalla Fondazione Craxi e
cioè da Stefania. Sarebbe interessante chiedersi quante altre tombe di politici
italiani, a parte Mussolini a Predappio, vivano una situazione del genere: in
terra straniera, poi. Io ne ho viste cose che non voglio ripensare, la verità è
questa. Io sono già stato qui. Il cimitero dov’è sepolto, Craxi, me lo mostrò
quand’era ancora vivo, nel luglio 1999. Sono già stato anche alla capanna sul
mare a Salloum, dove Bettino andava a scrivere e a pensare. E anche a dormire: i
suoi amici pescatori mostrano il suo letto e le fotografie con lui. È quasi una
visita guidata, qualche decina di craxiani ha sborsato 400 euro per tre giorni
in camera doppia (cinque stelle: vabbeh, lasciamo stare) e volo da Milano e
Roma. Piccole visite, la proiezione del film “Esilio”, una messa in francese,
una commemorazione al cimitero vicino alla medina. E c’è un sacco di gente,
vecchie glorie, vecchio sottobosco ma anche ragazzini, politici giovani con
moglie, parlamentari, ex parlamentari, europarlamentari. Il vulcanico Lucio
Barani ha portato le magliette con ricamato “Je suis Craxi”. Barani è l’ex
sindaco di Aulla e Villafranca che concesse la cittadinanza onoraria a Craxi e
gli fece erigere un monumento da latitante; ai funerali del 2000 fu l’unico
sindaco d’Italia presente con la fascia tricolore. Ecco: qui è pieno di tanto
come lui, in perfetto equilibrio tra l’integrità politica e la scampagnata. La
parte della nostalgica un po’ mesta, che le viene bene, se la prende Stefania
Craxi: è lei che ha organizzato tutto, ovviamente. Su Facebook ha ricevuto
37mila messaggi. Mentre nessun residuale partitino socialista, in Italia, ha
organizzato niente. Ma niente proprio: la grande rimozione continua. Anche se,
intanto, l’immagine di Craxi è sempre più ingombrante e quella dei socialisti
italiani è inesistente. Il sole sta calando e la messa per Craxi sta per
cominciare. Poi domattina tutti al cimitero cristiano, accanto alla medina,
prima di ripartire.
BETTINO PER
SEMPRE - QUANDO CRAXI SPIEGÒ IL SOCIALISMO: “CHE CAZZO SIA, NON L’HA ANCORA
CAPITO NESSUNO” - BERLUSCONI: ‘’LA MORTE IN ESILIO PAGINA VERGOGNOSA” - E IL
SENATORE BARANI IN AULA MOSTRA LA MAGLIETTA “JE SUIS CRAXI”.
Filippo Facci:
15 anni senza Bettino: una messa in francese, una cena in piedi e tanti aneddoti
per ricordare l’ex premier - La lettera di Berlusconi a Stefania Craxi e
l’intervento in Aula di Barani: “Una volta nessuno si sarebbe permesso di rapire
delle volontarie italiane, di imprigionare dei militari italiani. Con Craxi
l’Italia era rispettata nel mondo”...scrive “Dagospia”.
Filippo Facci
per “Libero Quotidiano”. Ci sono un po’ di cose che disorientano. La messa per
Craxi, alle 18, è in francese, e la chiesa (presunta) ha l’illuminazione di uno
studio televisivo: è difficile trovare un po’ di nostalgico raccoglimento.
Disorienta la capanna sul mare a Salloum, dove Bettino andava a scrivere e a
pensare: perché non c’è alcuna capanna, d’inverno tolgono il cannicciato e
restano quattro pali, c’è solo una spiaggia bella e sporca, qualche mucca, un
dromedario disinvolto - pare - e uno scenario da Cinico tv; la casa dei
pescatori tunisini, dove Craxi arrivata con le buste della spesa, è ricavata da
un vecchio bunker della Seconda Guerra Mondiale. Stefania ha organizzato
una grigliata. In serata, poi, disorienta un po’ meno il docufilm «Esilio»
proiettato in una sala dell’hotel: molti l’hanno già visto, ma almeno si vede
Craxi dopo tre giorni passati a parlare di Craxi. Quando passa l’immagine di
Giuliano Amato i fischi sono inevitabili. La saletta è piccola ma strapiena, si
vede quell’omone che parla con tanti personaggi che sono morti anche loro:
Mitterrand, Reagan, la Thatcher, Arafat, un incredibile quantità di politici o
ex politici nostrani, amici come Lucio Dalla, Luciano Pavarotti. E allora viene
da pensare che un’epoca sarebbe morta comunque, anche se Craxi non fosse morto
prematuramente e in quella maniera ingiusta e irrisolta. Lo capisci anche perché
a questa commemorazione mancano amici storici - il formidabile autista Nicola
Mansi, le segretarie Serenella Carloni ed Enza Tomaselli - che intanto sono
morti anche loro. Lo capisci perché ci sono un sacco di vecchi che parlano di
vecchiaia, è tutto un amarcord anche se alcuni erano nessuno e ora, però, ti
sommergono di aneddoti. Ci sono personaggi straordinari, belli, dignitosissimi,
soprattutto dal sud e dall’Umbria. Mentre da Milano, patria del riformismo e del
craxismo, nessuno. In compenso ci sono giovani in numero sorprendente. Nel
registro del cimitero è pieno di «Non ti ho mai conosciuto, ma». Facciamo
qualche nome: gli ex parlamentari Saverio Zavettieri e Angelo Cresco, il
penalista Roberto Ruggiero che difendeva Ferdinando Mach di Palmstein e Maurizio
Costanzo, gli ex segretari Gianfranco Polillo (ora collaboratore di Brunetta:
coraggio) e Costantino Dell’Osso, l’assessore Stefano Maullu della giunta
Formigoni, e naturalmente il senatore Lucio Barani che è in formissima: è lui ad
aver portato le magliette «Je suis Craxi». C’era anche tanto sottobosco romano e
qualcuno che ha disertato la messa perché si è infilato in camera con una
squillo ventenne, mentre alla cerimonia ha mandato la moglie.
Disorientano molte cose, si diceva: ma d’un tratto, sabato sera, si sono
ricomposte tutte. È successo a route El Fawara, nella mitica villa di Craxi dove
Anna - la moglie, che vive e risiede lì - accoglie una minoranza di fedelissimi.
E per chi manca da una quindicina d’anni, ecco: forse quello è l’unico momento
davvero commovente, duro da affrontare benché annegato in una cena in piedi
semplicemente fantastica (soprattutto perché il cibo tunisino, fuori di lì, è da
suicidio) dove tutto pareva come prima, col dettaglio che manca Craxi. È
cambiato il televisore, la tappezzeria dei divani, qualche dettaglio: ma la
mitica stanza dei fax è identica, il tavolone rotondo che era ingombro di libri
e giornali è sempre lo stesso. La piscina è vuota, logico. Ecco, la piscina.
L’ultima volta che vidi Craxi, nel luglio 1999, lo vidi alzarsi faticosamente
dalla sdraio e - malato com’era - saltellare su un piede solo per poi tuffarsi
nell’acqua di testa. Era un pazzo, Craxi. Tre anni prima, nel 1996, ero ancora
lì a casa sua, nella famosa villa che nel 1969 costava 40 dinari al mq: qualcosa
che - compreso un giardino di circa 400 mq - si poteva comprare per
l’equivalente di 7500-10mila euro di oggi; ero in quella villa con Luca Josi,
comunque, e verso le tre del mattino ricordo Craxi che stava ammaliando un
bivacco di attenti ragazzotti (da ore) spaziando da incredibili retroscena sul
terrorismo a improbabili affreschi sulla guerra d’Africa; si parlava del
socialismo, ovviamente: il socialismo di qua, il socialismo di là, perché il
socialismo, del resto il socialismo. «Che poi il socialismo», scandì Bettino, e
ci mise in mezzo un pausa delle sue, lunga, lunghissima, «che cazzo sia, non
l’ha ancora capito nessuno». Risate timide dei ragazzotti. Poi isteriche. Poi a
un certo punto stramazzarono dal ridere, e Bettino li guardava come se gli
stessero facendo un affronto, ma poi sorrise, cominciò a ridere anche lui,
forte, ma un po’ di lato, perché si vergognava. Qualche tempo dopo Lucio Barani,
sindaco in provincia di Massa, gli portò la cittadinanza onoraria con la fascia
tricolore e il gonfalone. Craxi pianse. Poi il 19 gennaio 2000 morì, e tutto
quel che accadde quel giorno lo racconteremo un’altra volta. L’Ansa diede la
notizia alle 17.46, mentre la Camera discuteva di una possibile commissione
d’inchiesta su Tangentopoli che non si farà mai, e che Craxi chiedeva già il 24
gennaio 1993. Al Senato, dopo che Nicola Mancino diede la notizia della morte,
ci fu un silenzio di quattro minuti. Poi ancora l’Ansa: «Da Palazzo Chigi si fa
sapere che si è pronti ai funerali di Stato». I familiari li rifiuteranno.
Bettino fu vestito in grigio come nelle grandi occasioni, cravatta rossa,
garofano all’occhiello, un ramoscello coi fiori del giardino di Hammamet, tra le
mani un rosario inviato dal Papa. Fu trasportato su un furgone Transit
fin dentro una fossa (nel casino generale un fotografo ci cadde dentro, lo
tirarono fuori i colleghi a braccia) ma la bara era troppo piccola: dovettero
togliere il rivestimento di zinco per poterla chiudere. La bara veniva
dall’Italia, ultimo coerente omaggio del suo Paese: nei paesi musulmani i morti
si avvolgono in un lenzuolo. C’erano vicino - ci sono ancora - alcune tombe di
nobili francesi dell’altro secolo, e poi quella della madre di Anna Craxi,
Giuseppina, più uno spazio vuoto che Anna ha riservato per sé, vicino a Bettino.
I due lo decisero insieme nel 1967. Silvio Berlusconi non venne al funerale,
venne direttamente al cimitero e pianse insieme a Francesco Cossiga. Domenica ha
diffuso una lettera indirizzata a Stefania Craxi: ha celebrato l’amico che
«colse e anticipò i temi ancora attuali della politica italiana» e la cui morte
resta «tra le pagine più vergognose della nostra storia recente». Il senatore
Lucio Barani, invece, ieri è intervenuto in aula con la polo «Je suis Craxi». Ha
detto questo: «Una volta nessuno si sarebbe permesso di rapire delle volontarie
italiane, di imprigionare dei militari italiani. Nessuno si sarebbe permesso di
buttare bombe nella redazione di un giornale satirico. Un tempo esisteva la
politica, arte della mediazione e del dialogo. Craxi sapeva dialogare con varie
ideologie nel contesto internazionale, e per questo l’Italia era rispettata in
Europa e nel mondo intero». Qualcosa da aggiungere?
Il Cav
ricorda Craxi: "La morte in esilio pagina vergognosa".
"Bettino seppe cogliere e anticipare i temi ancora oggi attuali della politica
italiana", scrive Sergio Rame su “Il Giornale”. Silvio Berlusconi scrive a
Stefania Craxi per ricordare Bettino, "un amico leale e sincero, un uomo più
avanti del suo tempo". Nella lettera per il quindicennale della scomparsa del
leader socialista che la Fondazione Craxi ha organizzato ad Hammamet, l'ex
premier sottolinea che la capacità di Bettino Craxi di "cogliere e anticipare i
temi ancora oggi attuali della politica italiana lo rendono tuttora protagonista
a pieno titolo delle vicende di questi giorni". "Il tuo papà è stato per me un
amico leale e sincero al quale mi univa un affetto profondo - scrive Berlusconi
a Stefania Craxi - è stato un uomo più avanti del suo tempo. Le sue idee, la sua
capacità di cogliere e di anticipare con lucidità i temi ancora oggi attuali
della politica italiana lo tendono tuttora protagonista a pieno titolo delle
vicende dei nostri giorni". Il Cavaliere ricorda come Craxi seppe cogliere,
"quando nessuno ne era consapevole, la necessità di riformare in nostro assetto
istituzionale, per mettere il nostro Paese in condizione di essere governabile e
di poter competere con le altre nazioni", dando così vita a "una sinistra
moderna, democratica, europea". La sua morte in esilio è per Berlusconi "tra le
pagine più vergognose della nostra storia recente". Dopo aver manifestato la
propria amarezza per non essere presente ad Hammamet, Berlusconi ha fatto notare
che adesso Craxi riposa in una terra che amava. "Una terra che, in questi anni
turbolenti, ha dimostrato di saper scegliere la strada della democrazia, della
tolleranza e della laicità dello stato - ha scritto l'ex premier - una strada
che lui stesso avrebbe indicato e favorito, se fosse stato ancora presente.
Speriamo che la scelta della Tunisia possa essere di esempio alle molte
situazioni difficili e tormentate del mondo arabo". Per Berlusconi la strada
indicata da Craxi fin dagli anni Ottanta si è rivelata quella giusta. "La
sinistra comunista è morta, anche se le sopravvivono molti dei suoi protagonisti
e dei suoi metodi - ha spiegato il leader di Forza Italia - il socialismo
liberale e riformatore è invece forte e attivo e sarà un protagonista del 21°
secolo. Anche le riforme istituzionali, dopo decenni di tentativi infruttuosi,
sono finalmente avviate proprio come lui aveva preconizzato". Con questi ricordi
e con questi sentimenti Berlusconi ci ha tenuto a manigestare la propria
vicinanza a Stefania Craxi. "Il tuo papà è certamente molto orgoglioso di una
figlia che gli dimostra tanto amore e che ha dedicato e continua a dedicare la
sua vita alla difesa e al ricordo del suo papà Bettino - ha concluso - ti prego
di far giungere alla tua mamma, a Bobo e a tutti gli amici che sono lì convenuti
per ricordarlo, il mio saluto più partecipe e affettuoso".
Bettino
Craxi e le profezie su Berlusconi, Fini, D'Alema e Napolitano,
scrive “Libero Quotidiano”. "L’on. Napolitano non poteva non avere un ruolo nel
sistema di relazioni politiche tra il Pci, il potere sovietico ed i regimi
comunisti dell’est, cui era connesso un sistema articolato di finanziamenti
illegali di cui i comunisti italiani erano i primi, tra i partiti comunisti e
non del mondo, ad avvantaggiarsene". Parola di Bettino Craxi. Il volume
Bettino Craxi. Io parlo, e continuerò a parlare, curato dallo storico Andrea
Speri, raccoglie appunti, profezie e commenti sulla politica italiana del leader
socialista annotate con cura nei suoi anni ad Hammamet. Craxi parla di tutti, da
Napolitano a Berlusconi, da Fini a D'Alema. Su Re Giorgio Craxi è durissimo e lo
mette davanti alle sue responsabilità storiche: "Per gli incarichi politici che
ha rivestito, per le esperienze e le conoscenze che ha accumulato, e d’altro
canto certamente non solo lui, non potrebbe senza dubbio non rendere su tutta la
materia una preziosa testimonianza. Ricostruire in modo completo, chiaro ed
onesto, i termini reali in cui si svolse la lotta politica in Italia e la lotta
per il potere, è diventato sempre più necessario, specie di fronte a tante
mistificazioni, a tante censure ed anche a tante ingiustizie". Poi è il turno di
Berlusconi. Craxi già prevede l'accanimento giudiziario durato per venti lunghi
anni: "C’è un vero e proprio piano al massacro che procede con gradualità e per
linee convergenti, ma che ha al fondo un obiettivo, uno e uno solo, e cioè
Silvio Berlusconi. Del resto il trattamento sin qui riservato al gruppo
Fininvest attraverso indagini, inchieste, processi e quant’altro, ha un
carattere eccezionalissimo che non è stato riservato proprio a nessuno. Gli
strateghi della conquista del potere, i teorici della "falsa rivoluzione", e i
loro collaboratori ed aiutanti, puntando alla distruzione politica personale di
Berlusconi sanno che questa comporterà quasi automaticamente il disfacimento di
Forza Italia. Nel frattempo ci si preoccuperà di accentuare l’isolamento e la
criminalizzazione di Bossi. la via sarà allora definitivamente aperta a un
ventennio almeno di egemonia catto-comunista". Poi Craxi parla di Gianfranco
Fini e delle sue mosse politiche mentre il Cav dovrà combattere negli anni la
sua battaglia contro l'assedio giudiziario: "Fini invece, se sarà risparmiato
dall’attacco dei più sfegatati, verrà affidato il compito di dimostrare che la
democrazia funziona e che l’opposizione può svolgere il suo ruolo di opposizione
senza rompere troppo le scatole. Nel frattempo, in attesa del risultato finale,
si svolgono le manovre di accompagnamento che seguono, come in questi casi la
storia insegna, tattiche consuete. Una volta è il bastone e la carota, un’altra
è il pugno di ferro e il guanto di velluto, un’altra ancora è il giorno delle
promesse, delle concessioni, delle generose diplomazie segrete". A questo punto
Craxi parla di D'Alema e delle sue manovre a sinistra dopo la caduta dei
socialisti sotto i colpi di Tangentopoli: "D’Alema vuole ridare la vita ai
socialisti facendoli rinascere dalle "macerie" del Socialismo craxiano. E chi é?
Mai questo eroico condottiero che i socialisti dovrebbero accogliere come il
loro liberatore? Purtroppo non è altro che uno dei tanti che hanno concorso o
hanno assistito cinicamente al massacro socialista ed alla distruzione di uno
dei grandi edifici della democrazia italiana". Poi l'accusa a Baffino:
"L’aggressione politica antisocialista, che era scuola, cultura ed anima della
nuova generazione comunista, visti i tempi, non sarebbe di certo bastata. Per
ridurre il psi in un cumulo di rovine è stata necessaria un’aggressione
politica-giudiziaria di portata impressionante e dall’altro lato il concorso
pusillanime di una classe dirigente socialista che, almeno per la sua gran
parte, ha dato prova di opportunismo e di viltà". Infine già a fine anni 90,
Craxi prevede un futuro nero per l'Italia in Europa: “C’è da chiedersi perché si
continua a magnificare l’entrata in Europa come una sorta di miraggio, dietro il
quale si delineano le delizie del paradiso terrestre. Non sarà così. alle
condizioni attuali, dal quadro dei vincoli così come sono stati definiti, ad
aspettare l’Italia non c’è affatto un paradiso terrestre. Senza una nuova
trattativa e senza una definizione di nuove condizioni, l’Italia nella migliore
delle ipotesi finirà in un limbo, ma nella peggiore andrà all’inferno”.
Giuliano
Amato al Quirinale? Craxi disse: è quello che si è comportato peggio.
Giancarlo Perna ha ricostruito la storia politica di Giuliano Amato, dal legame
con Bettino Craxi alla Corte Costituzionale. Ritratto spietato di un personaggio
eminente di cui si parla come possibile Presidente della Repubblica, scrive
Blitz quotidiano. “Giuliano Amato al Quirinale” scatena il pungiglione di
Giancarlo Perna su Libero. Quello di Giuliano Amato, avverte Giancarlo Perna,
è”un nome che spunta sempre quando è vacante una poltrona. Non è mai il primo a
essere fatto, ma è immancabile. Amato era già stato in lizza nel 1999 e nel
2006. A volerlo al posto di Carlo Azeglio Ciampi era nientemeno che Papa
Wojtyla. Sette anni dopo, fu Berlusconi a candidarlo per il centrodestra nel
tentativo di bloccare Giorgio Napolitano. In entrambi i casi, Amato fu sconfitto
senza fare una piega e continuò a navigare”. Rinunciando a analizzare “le sue
tecniche di sopravvivenza” Giancarlo Perna ne tenta una casistica: “Pur restando
a sinistra, ha strizzato l’occhio ai cattolici, si è mostrato comprensivo con
Berlusconi, ha dato una mano alla destra collaborando con Gianni Alemanno
sindaco di Roma. Di qui, le simpatie sparse che si è conquistato. Compensate
dalle diffuse diffidenze per questo volteggiare tra gli opposti. Amato ha avuto
un cursus impareggiabile. A volte è in auge, altre in ombra ma sempre in
possesso di una poltrona, grande o piccola che sia. L’importante per lui è
sedere su qualcosa. [...] È l’uomo delle emergenze, il commissario straordinario
che si chiama al capezzale di un organismo in coma. È stato premier (due volte,
1992 e 2000), ministro del Tesoro e dell’Interno, vicepresidente della
Convenzione che ha varato la Costituzione Ue, giudice della Coorte
costituzionale dal 2013. Va aggiunto che, salito prestissimo alla cattedra di
Diritto Pubblico, Giuliano è stato, per unanime riconoscimento, il
costituzionalista principe della sua generazione. [...]Come ex parlamentare
(cinque legislature) riceve novemila euro mensili, più altri ventiduemila tra
vitalizio di ex docente e l’indennità di ex presidente dell’Antitrust (è stato
anche questo, me ne ero dimenticato!). Un totale di 31mila euro lordi al mese,
più di mille al giorno, l’ideale per suscitare l’ira popolare. Stufo di essere
preso di mira, Amato ha precisato di tenere per sé solo i ventiduemila euro -
che netti sono la metà - e di dare ai poveri i novemila di ex parlamentare (…)
“All’origine dei suoi successi non ci sono solo le capacità” tuona Perna: “La
sua strada è costellata anche di inquietanti bugie e odiosi voltafaccia.
Ripercorriamoli. Quando fu premier la prima volta dichiarò: «Con questo concludo
la mia carriera politica. Non pretendo di essere il protagonista di molte
stagioni». Oggi, ventitre anni e cinquanta incarichi dopo, stiamo ancora
parlando di lui. Poi si mise all’opera e ci scippò nottetempo i soldi dai conti
correnti bancari il 10 luglio 1992. Una randellata sul rapporto di fiducia tra
cittadino e stato. Più indicativa la sua storia con Craxi. Prima che Bettino
diventasse segretario nel ’76, lo osteggiò da sinistra (Giuliano militò anche
nel Psiup). Quando poi i craxiani vinsero, scrisse ai suoi amici Stefano Rodotà
e Franco Bassanini: «Piuttosto che fare politica con questi cravattari sarebbe
meglio ritirarsi a vita privata. Noi invece non ci ritireremo». Infatti, dopo un
anno era già prostrato ai piedi di Bettino di cui fu per un quindicennio il
caudatario, condividendone le tresche al governo e nel Psi. Quando Craxi fu
soprannominato Ghino di Tacco, Amato fu detto Ghino del taschino per
sottolinearne la soggezione. Il nomignolo si aggiunse a quello di Dottor Sottile
che si era guadagnato per l’abilità manovriera e l’acume spaccacapello di cui
era dotato. Quando poi, con Tangentopoli, voltò le spalle a Craxi con la frase
«non immaginavo tanto marciume» (lui che sapeva tutto), fu detto il Cobra (…)
Filippo Facci
su “Libero Quotidiano”: vi racconto il giorno delle monetine a Craxi, quando
nacque l'antipolitica. Vent'anni fa: la folla livorosa davanti all'Hotel
Raphael, l'ascolto tv impazzito, il discorso alla Camera, tra polizia e
telecamere, moriva il craxismo e si chiudeva la Prima Repubblica. L’episodio
delle monetine contro Craxi all'Hotel Raphael (30 aprile 1993, vent’anni ieri)
viene evocato e ritrasmesso di continuo perché resta il principale simbolo di un
decennio, l’iconografia del passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica:
eppure le vere ricostruzioni storiche, al di là di raffazzonati copia/incolla
giornalistici, latitano. Persino il discorso alla Camera pronunciato il giorno
prima in un silenzio tombale (discorso citatissimo e poco letto) viene ancor
oggi confuso con un altro del luglio precedente, e questo per la semplice
ragione che Craxi, il 29 aprile 1993, lo riprese testualmente. Furono i giorni
dell’assedio all'Hotel Raphael e del linciaggio come estetica rivoluzionaria,
forse la nascita ufficiale dell’antipolitica. Craxi scrisse il suo discorso a
Monte Mario, a casa di un’amica. Il discorso pareva funzionare, ma il calcolo
dei voti pro e contro non lasciava scampo. Antichi favori andavano nella
direzione di un appoggio segreto dei Radicali e della parte di Rifondazione
comunista legata ad Armando Cossutta e al Manifesto, ma non bastava. Mancavano
almeno 58 voti. Il 29 aprile Craxi si affacciò nell'Emiciclo vestito di blu e
con una cartellina rosa sotto braccio. Dopo il suo discorso, il voto fu una
scheggia: la voce del presidente della Camera Giorgio Napolitano scandì la
concessione di sole due autorizzazioni a procedere su sei, fatto che viene
sempre trascurato: sì alle indagini per corruzione a Roma e per finanziamento
illecito a Milano, no per corruzione «in luogo non accertato» e per il reato di
ricettazione. C'era una logica, non era «un’assoluzione» come si è sempre detto.
Ma lo spettacolo stava per cominciare: striscioni, mazzi di volantini gettati
tra i banchi, un deputato leghista che incrociò le braccia simbolizzando le
manette, pugni battuti sui banchi, e grida, «Ladri di regime», «Mafiosi», il
presidente della Camera che ordinò di sgomberare le tribune, e tafferugli, risse
tra parlamentari. Tutti i volantini e i cartelli di protesta erano già stati
preparati, dunque preventivati. Il democristiano Francesco D’Onofrio fece capire
che i voti a favore di Craxi erano giocoforza venuti anche dall’opposizione, e
Gianfranco Fini perse la calma: «Se dici queste cose sei un mascalzone, siete
dei ladri che avete difeso altri ladri». Più tardi annuncerà una lettera al
procuratore capo di Milano Francesco Saverio Borrelli in cui esprimerà
«solidarietà e sincero apprezzamento», e soprattutto auspicherà che sia superato
«l’inammissibile scudo dell’immunità parlamentare». In quelle ore, del resto, lo
chiesero un po’ tutti. La sinistra ritirò il sostegno al governo Ciampi alle 20
e 22: il nuovo Consiglio dei ministri non si era neppure insediato. Il verde
Francesco Rutelli era stato ministro dell’Ambiente per poche ore, tanto che il
premier Carlo Azeglio Ciampi sarà costretto a un rimpasto prima ancora di aver
ricevuto la fiducia dalle Camere. Presto il voto segreto per le autorizzazioni a
procedere verrà abolito, e i lavoratori, il 1° maggio, l’unica festa vorranno
farla a Craxi. Dirà Giovanni Pellegrino, Pds, allora presidente della giunta per
le autorizzazioni a procedere del senato: «Noi della sinistra consentimmo che
venisse cancellato l’istituto dell’autorizzazione a procedere, strumento a
tutela dell’autonomia del potere politico rispetto al potere giudiziario. E si
aprì la strada alla mattanza di partiti di governo. Avevamo una sponda al
Quirinale, e l’ansia di raccogliere i frutti sul piano elettorale era tale che
facemmo in modo che quel Parlamento venisse sciolto anticipatamente». Eppure,
quel 29 aprile, Bettino Craxi ancora non sapeva che cosa l’avrebbe atteso
l’indomani. Cenò all’hotel Raphael, tranquillamente, con pochi fedelissimi e con
la donna che amava. Sembrava tutto normale. Più volte raccontato o più spesso
mostrato, il racconto del giorno successivo riposa anche sui ricordi della
giornalista che raccolse quelle immagini ormai celebri, la giornalista Rai
Valeria Coiante: «Eravamo a Piazza Navona, c’era la manifestazione del Pds,
facevo le mie interviste di routine. Arriva la notizia: negata autorizzazione a
procedere per Craxi. Si avvicina il collega Fabrizio Falconi del Tg4: «Andiamo
al Raphael, si sta radunando un sacco di gente». C’eravamo solo noi, quel
giorno, io col mio operatore e lui col suo. A un certo punto il cordone dei
poliziotti mi allontana dall’operatore, io comincio a dargli istruzioni col
microfono, lui era in cuffia, era l’unico modo per comunicare con lui in quel
casino: «Rimani sempre acceso, prendi tutto, fammi quelli coi cartelli e con le
mille lire... ». La folla urlava sempre di più, un mare di persone si riversava
nel vicolo stretto, la polizia infilava i caschi e parava gli scudi. Craxi esce
dal portone, esplode un boato, «Eccolo eccolo» urlo nel microfono, mi abbasso e
supero il cordone di polizia, corro verso la macchina di Craxi. Vengo investita
da una tonnellata di metallo vario in tondini, monete, «stanno tirando di tutto!
Pezzi di vetro, monete, tirano di tutto!»...La sera, in montaggio, mentre ero lì
che assemblavo il pezzo e pulivo la pista audio, entra in sala Gianni Minoli
(allora creatore del celeberrimo Mixer e direttore di Raidue) . «Fammi vedere»,
dice. «Aspetta, sto levando l’audio e sto mettendo gli effetti». «No, fammelo
vedere così». Va be’, penso io, la voce la levo dopo. «Ok, è incredibile.
Perfetto. Va bene così, non toccare niente». «Ma sembro ‘na pazza... fammi
levare almeno dove sfondo i livelli». «Non se ne parla, va in onda così». Quel
filmato fece sette milioni di telespettatori al primo passaggio». Largo Febo,
cioè la piazzola davanti al Raphael, in realtà è un buco che le immagini di
repertorio restituiscono ogni volta molto più grande: non è che ci stia tutta
questa folla, tra auto e polizia e telecamere. Eppure, oggi, a sentir le
testimonianze, erano tutti lì. C’erano quelli del Msi, della Lega, c’erano i
reduci di un comizio di Achille Occhetto in Piazza Navona, passarono di lì anche
molti studenti del Liceo Mamiani che erano in corteo: nell'insieme fu più che
sufficiente per far scrivere a tutti che quella era «l’Italia». Il che, tutto
sommato, era drammaticamente vero.
Il sindaco
Pisapia indagato: sì, no, forse?
La Procura indaga sulle trascrizioni delle unioni gay. Il primo cittadino si
autoaccusa. I pm negano: inchiesta contro ignoti. Ma lui insiste. A ragione,
scrive Maurizio Tortorella su “Panorama”. Sabato 17 gennaio 2015, durante un
convegno del Pd, il sindaco di Milano Giuliano Pisapia aveva pubblicamente
annunciato di essere indagato dalla Procura di Milano: l'accusa? L'omissione in
atti d’ufficio, per avere trascritto alcuni matrimoni gay contratti all’estero,
contravvenendo alla richiesta del prefetto Francesco Paolo Tronca, che in
ottobre gli aveva ordinato di cancellare tutte le trascrizioni in materia
basandosi a sua volta su una circolare del ministro dell'Interno, Angelino
Alfano. Il problema è che ieri, lunedì 19 gennaio, il procuratore Edmondo Bruti
Liberati e il pubblico ministero Letizia Mannella hanno comunicato ufficialmente
che non è vero: insomma, c'è sì un’inchiesta a carico di ignoti, però Pisapia
non è affatto indagato. E (sotto, sotto) i due pubblici ministeri hanno anche
fatto capire che l'indagine probabilmente finirà in nulla, con una richiesta di
archiviazione. La Procura di Milano, a quanto pare, non ha alcun desiderio
d'ipotizzare un reato per il sindaco. Ma, da buon penalista, Pisapia insiste:
com'è possibile che la Procura apra un’inchiesta sulle trascrizioni dei
matrimoni gay, e che il reato venga lasciato "a carico di ignoti" quando è
palese che il presunto colpevole è solo lui? “Quegli ignoti, in realtà, sono
noti" dichiara Pisapia, rivendicando con responsabilità e onestà intellettuale
il suo diritto a essere indagato, e sottolineando correttamente come il problema
non dovesse rimanere chiuso nei cassetti della procura. "Le trascrizioni le ho
fatte io perché le ritenevo legittime" ha aggiunto il sindaco. "Io non so se
cercassero ignoti tra soggetti che, invece, ignoti non lo erano. Era comunque
giusto che mi assumessi le responsabilità di quello che ho fatto”. Parole che
gli fanno onore.
Procura di
Milano, alla fine per lo scontro pagherà solo Robledo. La Procura generale della
Cassazione chiede al Csm di rimuovere il procuratore aggiunto: contro di lui le
intercettazioni con l'avvocato della Lega Nord, scrive Luca Fazzo su “Il
Giornale”. Poteva finire con un nulla di fatto, con entrambi i contendenti
lasciati in qualche modo al loro posto; poteva finire con la cacciata di
entrambi i contendenti, e con l'azzeramento di fatto del gruppo dirigente della
Procura; e invece con un colpo di scena la faida interna al palazzo di giustizia
milanese sembra avviata a risolversi con la sconfitta piena solo di Alfredo
Robledo, il procuratore aggiunto che con il suo esposto al Consiglio superiore
della magistratura aveva sollevato nel marzo dello scorso anno il caso delle
presunte irregolarità nella gestione da parte del procuratore capo Edmondo Bruti
Liberati praticamente di tutte le inchieste più delicate. Nei confronti di
Robledo, il procuratore generale della Cassazione ha fatto partire nei giorni
scorsi una richiesta eccezionale: trasferimento immediato in via cautelare, di
fatto l'allontanamento dall'ufficio e il trasferimento a un altro incarico.
Tecnicamente, le accuse che potrebbero portare al defenestramento di Robledo non
sono collegate ai temi sollevati nel suo esposto, e di cui si è molto discusso
in questi mesi. La richiesta di rimozione del magistrato viene motivata dal pg
con una serie di intercettazioni che arrivano dall'altro capo d'Italia, ovvero
dalla indagine che la procura di Reggio Calabria sta svolgendo sui contatti tra
alcuni esponenti della Lega Nord e il mondo della criminalità organizzata: è
l'indagine che ha portato all'incriminazione dell'ex tesoriere del Carroccio,
Belsito, accusato di avere utilizzato canali contigui alla 'ndrangheta per
spostare e investire all'estero parte dei fondi del partito. Nell'ambito di
quella inchiesta è stato intercettato anche l'avvocato di fiducia dei vertici
leghisti, Domenico Aiello, e così la Dia ha registrato una serie di contatti
telefonici tra il legale e Robledo, all'epoca titolare delle indagini sui
finanziamenti pubblici al partito di Bossi. Contatti che indicano una certa
confidenza tra i due, e nei quali Robledo sembra garantire a Aiello che
l'inchiesta sarebbe stata condotta anche a carico di esponenti di altri partiti.
Ma è evidente che le notizie provenienti da Reggio Calabria hanno finito col
fare parte a pieno titolo dello scontro senza precedenti in corso alla Procura
di Milano, dove Robledo accusava Bruti di avere forzato la mano per affidare
tutte le inchieste con risvolti politici (dal San Raffaele a Ruby alla
Serravalle a Expo) solo a pm di sua fiducia, aggirando le norme interne
all'ufficio e le competenze dei diversi dipartimenti. Lo stesso consiglio
giudiziario di Milano, l'organismo locale di autogoverno della magistratura, ha
stigmatizzato questo comportamento di Bruti. Ma sia il procuratore capo che
Robledo (accusato da Bruti di interferenze e comportamenti irregolari) erano
usciti incolumi dalle azioni disciplinari avviate dal Csm. E la settimana scorsa
aveva preso quota la ipotesi di una soluzione ponte, con Robledo parcheggiato in
un'altra procura in attesa del pensionamento di Bruti. Invece stamane a sorpresa
dal Csm arriva la notizia della richiesta di rimozione immediata di Robledo
avanzat dal pg della Cassazione, Ciani. Una richiesta che verrà esaminata dal
Csm in tempi brevissimi, e che se dovesse venire accolta segnerebbe una vittoria
per ko di Bruti e del suo schieramento nello scontro con Robledo.
Milano, altri
guai per il pm Alfredo Robledo: "Ha favorito l'avvocato della Lega Nord". Il pg
della Cassazione contro l'aggiunto di Milano, già al centro di uno scontro con
il procuratore capo Bruti Liberati. Il motivo sono le intercettazioni di
un'inchiesta antimafia rivelate da l'Espresso. Secondo l'accusa il legale girava
a Roberto Maroni e Matteo Salvini le notizie ottenute dal magistrato che
indagava su Belsito, scrive Paolo Biondani “L’Espresso”. Alfredo Robledo Il
procuratore aggiunto di Milano, Alfredo Robledo, rischia il posto per i suoi
rapporti telefonici con l'avvocato della Lega, Domenico Aiello. Un caso
giudiziario nato da una serie di intercettazioni della procura antimafia di
Reggio Calabria e rivelato per la prima volta il 25 ottobre scorso da un
articolo de “l'Espresso” . Robledo è il magistrato che da mesi è protagonista di
uno scontro senza precedenti con il suo procuratore capo, Edmondo Bruti
Liberati. Oggi il procuratore generale della Cassazione, Gianfranco Ciani,
titolare dell'azione disciplinare, ha depositato al Csm una richiesta di
trasferimento d'ufficio a carico di Robledo, chiedendo che venga decisa
d'urgenza, come misura cautelare. Secondo l'accusa, Robledo dovrebbe non solo
cambiare città, ma addirittura perdere le funzioni di pubblico ministero. Il
vice-presidente del Csm, Giovanni Legnini, ha già fissato un'apposita udienza
della sezione disciplinare, che è chiamata a pronunciarsi il 5 febbraio. Il
trasferimento forzato di Robledo consacrerebbe la vittoria di Bruti Liberati
nella scontro con il suo aggiunto, che è già stato rimosso dall'incarico di
coordinatore delle indagini milanesi sui reati collegati alla corruzione. Il Csm
e lo stesso pg della Cassazione, però, devono ancora pronunciarsi sugli altri
capitoli ancora aperti della disfida tra toghe che ha spaccato la procura di
Milano. A Robledo vengono contestati i rapporti amichevoli con Domenico Aiello,
il penalista di fiducia di Roberto Maroni, diventato l'avvocato della Lega dopo
lo scandalo dei finanziamenti pubblici sottratti dall'ex tesoriere Belsito, che
ha coinvolto anche Umberto Bossi favorendo il cambio della guardia al vertice
del partito. Quell'inchiesta era diretta proprio da Robledo. Tra il 2012 e il
2013, mentre era ancora in corso l'indagine milanese sui soldi della Lega, la
procura reggina ha intercettato l'avvocato Aiello per tutt'altri motivi: il
professionista, che è di origine calabrese, risultava in contatto con
imprenditori sospettati di collusioni con la 'ndrangheta. Quella procura
antimafia ha così intercettato anche Robledo, ma solo indirettamente, perché era
in contatto con l'avvocato Aiello. Anche i parlamentari leghisti sono stati
intercettati solo indirettamente: sotto controllo c'era solo il telefonino
Aiello. Nella primavera del 2013 la procura di Reggio Calabria ha trasmesso un
faldone di intercettazioni ai pm di Brescia, competenti a indagare sui
magistrati di Milano, ipotizzando che Robledo avesse rivelato all'avvocato della
Lega notizie riservate sulle proprie indagini. Dopo un anno di accertamenti, i
pm bresciani Fabio Salamone e Paolo Savio hanno chiesto l'archiviazione di tutte
le accuse a carico di Robledo. Secondo i due magistrati competenti, quelle
comunicazioni tra Robledo e Aiello non hanno rilevanza penale: non ci sono i
presupposti per accusare il pm milanese, in particolare, di ipotetiche
violazioni del segreto istruttorio. Nelle motivazioni della loro richiesta, gli
stessi pm bresciani precisano però che l'archiviazione riguarda solo la vicenda
penale, «al di là di ogni valutazione sull'opportunità di frequenti contatti»
tra magistrato e avvocato «per ragioni non sempre strettamente correlate con le
rispettive qualità». Ora il pg della Cassazione, che invece rappresenta l'accusa
nei procedimenti disciplinari e può occuparsi anche di vicende personali che non
costituiscono reato, ha riletto gli stessi atti dell'indagine bresciana
ipotizzando, come precisa l'agenzia Ansa, uno «scambio di favori»: un
comportamento penalmente irrilevante, ma considerato inopportuno per un
magistrato. Sotto accusa, in particolare, ci sono alcuni sms inviati da Robledo
ad Aiello, e da quest'ultimo a parlamentari della Lega come Maroni, Salvini e
Speroni, mentre era ancora in corso l'inchiesta milanese sul caso Belsito. Il 28
dicembre 2012, ad esempio, Aiello manda a Maroni un sms che allude a una
riunione dei pm milanesi: «Finita riunione in Procura con capo e agg. Domani
sera mi daranno altri nominativi ns consiglieri indagati. Hanno intercettazioni
gravi contro Pdl, mentre su di noi pare ci sia una impiegata gola profonda».
Nello stesso periodo l'avvocato Aiello telefona anche all'attuale leader
leghista Matteo Salvini, sostenendo che Robledo gli avrebbe promesso di spedire,
prima delle elezioni del 2013, «gli stessi avvisi a Pd, Idv e Pensionati. (…) Mi
ha detto: “Domenico, te lo garantisco, ci puoi spendere la tua credibilità”».
Quando l'inchiesta milanese sui rimborsi-truffa coinvolge effettivamente anche
gli altri partiti, l'avvocato della Lega scrive un sms di ringraziamento al pm
milanese: «Uomo di parola! Poi grande magistrato!». E Robledo gli risponde con
una citazione in latino che sembra confermare una promessa: «Caro avvocato,
promissio boni viri est obligatio!». Esaminate tutte le intercettazioni, i
magistrati bresciani hanno concluso che va giudicato «assolutamente
comprensibile» che l'avvocato della Lega si preoccupi di informarsi sulla
posizione degli indagati della proprio parte politica. Quanto alle notizie sugli
altri partiti, Robledo si sarebbe limitato a fornirgli una «generica
informazione che l'indagine avrebbe riguardato in tempi brevi anche
l'opposizione», senza però rivelargli segreti investigativi. Ora però il pg
della Cassazione rilancia l'accusa, sostenendo che Robledo, il 18 dicembre 2012,
avrebbe anticipato ad Aiello almeno una notizia molto precisa, e cioè che la sua
inchiesta stava per coinvolgere altri 7-8 consiglieri regionali. Cosa
effettivamente successa il giorno dopo. Sotto accusa, sempre sul piano
disciplinare, c'è anche una serie di telefonate in cui Robledo avrebbe suggerito
ad Aiello di chiedere copia di una consulenza tecnica a carico della Lega, che
era stata anticipata nel febbraio 2013 da “l'Espresso”. Quando poi Aiello si
vide negare quei documenti integrali, Robledo, sempre secondo il pg della
Cassazione, avrebbe scaricato la colpa sul procuratore capo, Bruti Liberati. Da
altre telefonate, sempre secondo la ricostruzione dei pm bresciani, risulta
«evidente che Robledo si sia avvalso dell'aiuto del legale per intervenire nella
procedura dinanzi la Commissione europea» che lo vedeva contrapposto all'ex
sindaco di Milano, Gabriele Albertini, mentre quest'ultimo si era candidato alle
regionali in Lombardia contro Maroni. Nei mesi precedenti, Albertini aveva
accusato il pm milanese di aver condotto indagini illegali sui derivati
finanziari acquistati dal Comune di Milano. Contro-denunciato da Robledo, l'ex
sindaco, che rivestiva la carica di europarlamentare di Forza Italia, aveva
chiesto l'immunità politica, che però gli è stata negata. Di questo caso si era
occupata la stessa procura di Brescia, che alla fine ha chiesto di processare
proprio Albertini per calunnia ai danni di Robledo. In quel contesto, nelle sue
conversazioni con l'avvocato Aiello, Robledo chiedeva «solo che la mia lettera
vada alla Commissione, che prenda atto che questo ha detto balle totali». Ora
però il pg della Cassazione sostiene che Robledo, per poter preparare la sua
lettera, avrebbe ricevuto dall'avvocato Aiello una serie di documenti,
presentati da Albertini al Parlamento europeo per ottenere l'immunità, che
andrebbero considerati «non pubblici». Aiello glieli avrebbe fatti arrivare per
email. Nell'indagine bresciana erano finite anche alcune intercettazioni,
registrate sempre dai pm antimafia calabresi, delle telefonate tra Aiello e il
pm milanese Eugenio Fusco, titolare di un'inchiesta sul gruppo Finmeccanica che
sembrava poter coinvolgere anche la Lega. Ma i magistrati bresciani hanno
concluso che queste conversazioni, oltre a essere penalmente irrilevanti,
«rientrano nella prassi comune dei contatti tra pm e difensori».
Sull'archiviazione dell'inchiesta penale su Robledo, l'ultima parola spetterà ai
giudici bresciani. Ma ora il procuratore aggiunto rischia di essere allontanato
da Milano con un trasferimento disciplinare che potrebbe segnare la fine della
lunga stagione dei veleni in procura.
Quel filo
segreto tra la Lega e Robledo.
Il pm di Milano intercettato al telefono con l’avvocato di Maroni. L’antimafia
lo denuncia. E l’indagine finisce a Brescia, scrive Paolo Biondani su
“L’Espresso”. Da una parte c’è il procuratore aggiunto di Milano, Alfredo
Robledo, che in quei giorni sta indagando sui presunti ladroni del cerchio
magico di Umberto Bossi. All’altro capo del telefono c’è l’avvocato Domenico
Aiello, che dopo aver difeso Roberto Maroni sta diventando, proprio per effetto
di quel terremoto giudiziario, il penalista di fiducia dell’intero partito
padano. E in mezzo, ad ascoltare tutto, ci sono i carabinieri di una procura
antimafia del Sud Italia. Che non si aspettavano certo di dover registrare dei
colloqui riservati tra il pm anti-Lega e l’avvocato della Lega. Su questo strano
cortocircuito tra giustizia e politica sta indagando da circa un anno la Procura
di Brescia. Un’inchiesta riservatissima, che per il pm Robledo era iniziata
molto male. L’alto magistrato, almeno fino a pochi giorni fa, risultava ancora
indagato, a quanto pare per un’ipotetica violazione del segreto istruttorio. Ma
in questi mesi i pubblici ministeri bresciani hanno ormai approfondito il caso,
che sembra essersi ridimensionato. E ora a Brescia, dove nel frattempo il nuovo
procuratore Tommaso Buonanno ha scalzato lo storico pm Fabio Salamone, i
magistrati sarebbero orientati a chiedere l’archiviazione. Il verdetto finale
comunque spetterà ai giudici delle indagini e fino ad allora Robledo resterà,
suo malgrado, formalmente inquisito. Proprio come il suo grande nemico, il
procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati, a sua volta sospettato di
omissione di atti d’ufficio, per un’inchiesta sulla Sea dimenticata in
cassaforte e rivendicata da Robledo dopo un articolo de “l’Espresso”. La nuova
indagine bresciana non c’entra nulla con il feroce scontro tra Robledo e Bruti:
è invece uno spezzone di un’istruttoria altrui, molto più ampia e ancora
segreta. Si sa soltanto che una procura antimafia, per ricostruire le trame di
un colletto bianco, ha intercettato (come sempre) tutti i suoi interlocutori,
imbattendosi per caso in Aiello. E così, tra il 2012 e il 2013, per qualche
tempo finisce sotto controllo pure il telefonino dell’avvocato. Che, a sorpresa,
si sente più volte con Robledo. I carabinieri annotano. E nella primavera 2013
la loro procura manda a Brescia due denunce di reato. Il tenore delle
intercettazioni ha convinto quella procura antimafia che il pm Robledo e
l’avvocato Aiello stiano orchestrando manovre per colpire l’ex sindaco di
Milano, Gabriele Albertini. Che è un rivale politico: proprio in quei mesi si è
candidato contro Maroni in Lombardia. Altre telefonate fanno temere che il
magistrato possa avere anticipato all’avvocato qualche notizia riservata della
sua inchiesta sui presunti rimborsi-truffa incassati da altri partiti. Di qui la
trasmissione al Nord delle intercettazioni. A Brescia però, per fortuna di
Robledo, i pm sono in grado di ricostruire un quadro più completo. Albertini,
infatti, è già indagato (e oggi rischia il processo) con l’accusa di calunnia
proprio ai danni del magistrato milanese: era lui che tentava di screditarlo.
Denunciato da Robledo, l’ex sindaco cercava di avere l’immunità dal parlamento
europeo, che poi lo ha bocciato. In quelle telefonate Robledo non nasconde
l’antipatia per Albertini, ma cerca solo di d’informarsi se la Lega a Bruxelles
voterà a suo favore. Mentre per i rimborsi, all’avvocato che gli contesta di
perseguitare solo la Lega, il pm ribatte che indagherà su tutti i partiti, come
poi succederà, ma senza fornirgli particolari segreti. In attesa che i giudici
bresciani tirino le somme, certo è che il pm e l’avvocato non parlavano di altre
indagini che avrebbero potuto interessare entrambi. Nel 2010, quando è diventato
il difensore di Maroni, Aiello guidava il ramo penale dello studio
internazionale “Dla Piper”, dove a gestire il settore degli appalti era
l’avvocata Giorgia Romitelli. Che nel marzo 2014, su richiesta di Robledo, è
finita agli arresti domiciliari nell’inchiesta che ha decapitato Infrastrutture
Lombarde, la centrale regionale delle grandi opere.
Robledo
chiede alla Finanza di aiutarlo a incastrare Bruti.
Caos a Milano,
l'aggiunto scrive al Csm e controaccusa il suo capo: "Su Expo dice il falso, ho
le prove". E allega una relazione della GdF, scrive Anna Maria Greco su “Il
Giornale”. Alfredo Robledo non ci sta. Reagisce con durezza alle controaccuse
del procuratore di Milano, Bruti Liberati, e scrive una nota al Csm, accusandolo
di aver detto il «falso» e chiedendo di essere ascoltato per replicare. «Sono
radicalmente inventate e prive di qualunque fondamento - tuona - le affermazioni
su Expo». E da Magistratura indipendente arriva l'appello al Guardasigilli
Andrea Orlando: si mandino gli ispettori alla Procura di Milano. Raccontano che
l'aggiunto abbia dato in escandescenze martedì, quando ha saputo che nella
lettera mandata al Csm il suo capo denunciasse l'episodio, definito «surreale»,
del doppio pedinamento di un indagato, che l'aggiunto avrebbe disposto
rischiando di far saltare le indagini sull'Expo 2015. No, Robledo non ci sta e
ha richiesto urgentemente alla Guardia di finanza una dettagliata relazione,
allegata alla nota di due pagine inviata al Csm, per confutare la ricostruzione
del suo capo. Una ricostruzione che tenta di presentare lui, il grande
accusatore di irregolarità e violazioni nel Palazzo di giustizia milanese, come
il colpevole di iniziative che hanno portato «grave intralcio» ad importanti
inchieste. Ma Robledo fa una smentita a tutto campo. E con toni durissimi: «Le
inveritiere affermazioni del procuratore» di Milano Edmondo Bruti Liberati -
scrive - sul presunto "doppio pedinamento" (nelle indagini su Expo, ndr)
appaiono altamente lesive della dignità della funzione di procuratore aggiunto,
coordinatore del dipartimento dei reati contro la pubblica amministrazione che
attualmente svolgo, e turba «il regolare svolgimento della funzione». Uno
scontro senza precedenti. Nella sua lettera al Csm, resa nota martedì, Bruti
contesta il fatto che l'aggiunto (il quale polemicamente non ha firmato le 7
richieste d'arresto per l'inchiesta Expo, sostenendo che gli sarebbe stato
impedito di valutare compiutamente i fatti, «in violazione della normativa») non
sia stato tenuto al corrente delle indagini. Nate, secondo il capo, nella
Direzione antimafia guidata da Ilda Boccassini e coassegnate al Dipartimento sui
reati contro la pubblica amministrazione, di cui Robledo è responsabile. Come
esempio dei danni che l'aggiunto avrebbe causato, mettendosi di traverso alla
sua gestione della procura, il capo parla della vicenda del doppio pedinamento.
Contro il suo aggiunto ribelle Bruti denuncia molto altro, sostenendo di non
aver potuto dire tutto nell'audizione a Roma del 15 aprile, perché allora
l'indagine sull'Expo era ancora coperta dal segreto. Il procuratore sostiene
infatti che, inviando il mese scorso al Csm copie di atti di questo
procedimento, ancora «in delicatissima fase di indagine», Robledo «ha posto a
grave rischio il segreto delle indagini». Ma l'aggiunto controbatte, su tutta la
linea. Palazzo de' Marescialli deve ora valutare la fondatezza delle accuse di
Robledo e delle controaccuse di Bruti Liberati. Per il primo, il procuratore
avrebbe affidato troppe inchieste politicamente delicate (a cominciare da quella
Ruby) a pm come la Boccassini e Francesco Greco, non per competenza ma perché li
riteneva più fidati. Da notare, che Bruti Liberati è uno degli storici esponenti
della corrente di sinistra Magistratura democratica, mentre Robledo è vicino a
Magistratura indipendente. E proprio da Magistratura indipendente è arrivata la
richiesta di un'ispezione. A farla il togato Antonello Racanelli, nel corso del
plenum del Csm alla presenza del Guardasigilli Andrea Orlando. Il ministro ha
replicato dicendo di attendere le decisioni del Csm per decidere. «Il quadro
ormai è chiaro - racconta un consigliere di una delle commissioni interessate,
la prima (incompatibilità ambientale e funzionale) e la settima (organizzazione
degli uffici) - non ci dovrebbero essere altre audizioni». Il procuratore capo
Bruti, che a luglio termina il suo incarico, dopo questo scontro clamoroso
difficilmente potrà essere confermato alla guida dell'ufficio di Milano. Ma per
lui, anche se la vicenda al Csm si chiude senza conseguenze, potrebbe profilarsi
un'indagine disciplinare. In particolare, sulla vicenda del fascicolo
Sea-Gamberale, dimenticato dal procuratore in cassaforte, come lui stesso ha
ammesso. Ma anche per il suo vice Robledo potrebbero esserci conseguenze, perché
anche se il suo comportamento fosse ritenuto «incolpevole», ci potrebbe essere
all'orizzonte un trasferimento per incompatibilità con i colleghi dell'ufficio.
Ed ancora.
«Incompatibilità ambientale» Via da Milano il pm Esposito, scrive Luigi
Ferrarella su “Il Corriere della Sera”. Stop come pm e via dalla Procura di
Milano: la sezione disciplinare del Csm ha deciso in via cautelare il
trasferimento a Torino di Ferdinando Esposito per «incompatibilità ambientale»
(con la sede giudiziaria di Milano) e «funzionale» (con il ruolo inquirente) del
pm della Procura di Milano, nipote dell?ex procuratore generale della Cassazione
(Vitaliano) e figlio del magistrato (Antonio) che in Cassazione nell?estate 2013
presiedette il collegio di 5 giudici che condannarono Silvio Berlusconi per
frode fiscale Mediaset. Tra i capi di «incolpazione» disciplinare (per cui ora
proseguirà il procedimento di merito) c?erano la disponibilità per quasi 4 anni
di un attico per il quale circa 150.000 euro di affitto furono saldati dalla
società di un manager e da un banchiere all?epoca inquisito dalla Procura di
Milano; i rapporti con l?avvocato ed ex amico Michele Morenghi, per i quali il
pm è al momento indagato a Brescia; prestiti di denaro da più persone, tra le
quali un consulente proposto a un collega pm; e la storia del bigliettino dato
durante le indagini a questo collega pm per chiedergli «inventiamoci qualcosa?è
una cazzata ma è importante che le versioni coincidano». Esposito impugnerà il
trasferimento cautelare disciplinare alle Sezioni Unite civili della Cassazione.
IN MEMORIA
DI RENATO ALTISSIMO: L’INGANNO DI TANGENTOPOLI.
Addio a
Renato Altissimo, fu il volto del Pli durante la Prima Repubblica.
17 aprile
2015. Si è spento a 75 anni a Roma l’ex segretario del Partito Liberale
Italiano. Più volte ministro con Cossiga, Spadolini, Craxi e Fanfani, scrive “Il
Corriere della Sera”. È morto dopo una lunga malattia l’ex segretario del
Partito Liberale italiano, Renato Altissimo. Più volte ministro e deputato, era
ricoverato all’Ospedale Gemelli di Roma. Del Pli fu segretario dal congresso di
Genova del maggio 1986 alle dimissioni del maggio 1993. Fu più volte ministro:
della Sanità nel Governo Cossiga I, nei Governi Spadolini I e II, nel Governo
Fanfani V, Ministro dell’Industria nel Governo Craxi I, tra il 1983 e il 1986.
All’esplodere di Tangentopoli, per qualche periodo potè sbandierare un singolare
record: quello di essere l’unico segretario dell’allora «pentapartito» - ovvero
i governi formati da una coalizione composta da Dc, Psi, Pri, Psdi e appunto Pli
- a non essere indagato. Da Forlani a Craxi, tutti gli altri erano stati
raggiunti da avvisi di garanzia.
Il Pli e
quel record di pochi mesi: nessun indagato in Mani Pulite.
Mentre la Prima Repubblica franava travolta dal ciclone di Mani Pulite,
Altissimo ebbe buon gioco nel mostrare, solitario, il vessillo immacolato della
«questione morale» sventolato dal Pli. Ma il primato però durò poco meno di un
anno: il 15 marzo 1993 anche il nome del leader liberale finì nelle carte
giudiziarie della procura di Milano. Il 4 dicembre 1993 Altissimo ammette in
conferenza stampa (in effetti tutti gli altri leader di partito fecero la
medesima ammissione soltanto in tribunale) di aver ricevuto denaro in maniera
illecita, 200 milioni di lire in contanti. Imputato poi nel processo per la maxi
tangente Enimont, è stato definitivamente condannato per finanziamento illecito
ad 8 mesi nel giugno 1998. Dopo la condanna, Altissimo sostanzialmente sparì
dalla scena politica. Piemontese, figlio di industriali (per un certo periodo fu
anche vicepresidente di Confindustria, la sua attività era nell’indotto Fiat)
all’ex segretario Pli (sovente assai abbronzato, sovente sorridente) era
accostata la parola «galantuomo», forse perchè - salvo l’inciampo di
Tangentopoli - il suo nome non venne mai associato a scandali e a pratiche di
lottizzazione. Fama (anche) di seduttore e viveur: nelle foto pre-tangentopoli
lo si vedeva sempre accanto a bellissime donne. E con De Michelis (altro
ministro-viveur) lo si vedeva a quel «Tartarughino» che fu un buen retiro
serale, a Roma, per diversi esponenti della Prima Repubblica. Altissimo era
ricoverato al Gemelli da diverse settimane per numerosi problemi cardiaci e
respiratori che si sono aggravati progressivamente ed estesi ad altri organi,
tanto da far decidere ai sanitari, negli ultimi giorni, il suo trasferimento al
centro di rianimazione a causa di una progressiva insufficienza multi-organo che
lo ha portato alla morte.
Con
Altissimo muore il sogno di noi giovani liberali.
Lo storico segretario Pli fu il primo a capire la modernità e le intuizioni di
Craxi, scrive Nicola Porro su “Il Giornale”. La cosa che per prima colpiva noi
giovani liberali, spesso neanche maggiorenni, di Renato Altissimo era la sua
abbronzatura. Ma era, appunto, solo la prima impressione. Due sere fa è mancato.
E per chi alla fine degli anni 80 ha creduto nel Partito liberale, questa
scomparsa rappresenta una botta. Altissimo per noi giovani della Gli (così si
chiamavano gli under 26 iscritti al Partito liberale pre-Mani pulite) è stato il
segretario. Chi ha passato qualche anno della propria vita a via Frattina, la
sede storica del Pli, sapeva che Altissimo era sempre lì. A due passi sempre
vicino a lui Luca De Martino, al piano di sotto lo stanzone della direzione, di
fronte gli uffici dei funzionari e quello di Camillo Ricci, la sua ombra stampa.
E ancora un piano più sotto Gregorio Fontana che ieri, come oggi, si occupava di
organizzazione interna del partito. Renato Altissimo doveva fare i conti con il
partito più storico della Prima repubblica, con la sua proverbiale litigiosità,
ma al contempo si era circondato di giovani ragazzi, che in quella
organizzazione innestavano linfa vitale. Poi è arrivata Mani pulite: si pensava
di esserne fuori. E poi le indagini su de Lorenzo, e la crisi e il congresso che
vide prevalere Raffaele Costa. Altissimo per noi giovani liberali, se ancora non
lo aveste capito, era qualcosa di più di un leader politico. Anche in quelle ore
veramente drammatiche, in cui perdemmo la nostra verginità, non riuscivamo a
farne una colpa ad Altissimo. Con le sue sigarette, la sua perenne tazza di
caffè americano in mano, i suoi week end in Costa azzurra, alla fine Renato era
sempre e comunque uno di noi. Gli piaceva il nostro partito, gli ha dedicato la
sua vita, almeno quella che ho conosciuto. Era appassionato come può esserlo un
liberale, che mantiene sempre quell'arietta blasé di chi ha vissuto ben altro.
Sì certo, per noi destri liberali era troppo social , troppo affascinato
dall'aura di Craxi. Ma con il senno di poi, aveva forse torto? Era quello un
brandello di modernità, sia pure arrogante, per tratti marcia, che comunque
Renato aveva intuito e ben compreso. Amava le imprese, anzi l'industria da cui
per storia familiare proveniva. La conosceva nelle sue viscere e ci parlava da
pari a pari. Quanto più lontano si possa immaginare dall'aristocratico snobismo
di un Malagodi, ma al tempo stesso il migliore testimone di quella tradizione.
Il Pli finisce con Mani pulite. Per molti di noi ha cessato di esistere un paio
di sere fa al Gemelli di Roma.
Morto Renato
Altissimo, volto e anima dei liberali della prima Repubblica, scrive Matteo
Basile su “Il Giornale”. L'ultimo messaggio lo ha affidato a Twitter lo scorso
22 febbraio 2015: «Sono abbastanza curioso di vedere 1992. Vediamo se per la
prima volta ci sarà una ricostruzione obiettiva di Tangentopoli». Difficilmente
Renato Altissimo sarà rimasto soddisfatto perché la serie tv di fedele alla
storia ha ben poco. L'ex storico segretario del partito liberale è scomparso
ieri a al Policlinico Gemelli di Roma prima di assistere alla fine della fiction
su una delle pagine più controverse della storia d'Italia. Una pagina che lo ha
visto protagonista. Come protagonista Altissimo è stato, tra luci e ombre, della
vita politica del nostro Paese degli ultimi 30 anni. Altissimo è stato esponente
di spicco del Partito liberale italiano, del quale è stato segretario dal 1986
fino alle dimissioni del maggio 1993, travolto da Tangentopoli, e dopo essere
stato più volte ministro. Alla Sanità, nel primo governo guidato da Cossiga e
nei Governi Spadolini e Fanfani, poi ministro dell'Industria con Craxi tra il
1983 e il 1986. Una carriera sempre in prima fila, fino allo scandalo tangenti.
Il 15 marzo 1993 riceve alcuni avvisi di garanzia e dopo due mesi ammette di
aver ricevuto denaro in maniera illecita: 200 milioni di lire in contanti.
Imputato nel processo per la maxi tangente Enimont, è stato condannato ad 8 mesi
nel giugno 1998. Ma la passione per la politica non lo ha mai abbandonato. Nel
2004 entra nel nuovo Partito Liberale Italiano e si schiera nel Centrodestra,
con cui si candida nel 2006 senza essere eletto. Nel 2011 entra nel Consiglio
nazionale del Pli e lo scorso anno, poco prima delle elezioni europee, insieme
agli storici amici e compagni di partito Alfredo Biondi e Carlo Scognamiglio
fonda «I Liberali» con l'obiettivo da lui stesso dichiarato di «Rifondare
un'Italia liberale». Quei Liberali che pochi minuti dopo la notizia della sua
scomparsa lo hanno ricordato così: «Addio, e grazie a Renato Altissimo, oggi i
liberali italiani perdono una colonna della loro storia».
Etica e
diritti Vademecum per la famiglia dei liberali,
scrive Marcello Veneziani su “Il Giornale”. M a i liberali tifano per il Brasile
o per la Germania? Lo chiedo dopo aver visto l'abuso di liberalismo per
giustificare tutto e tutti, cani e porci. Non solo il trionfo dei porci comodi e
l'individualismo più sfrenato, ma anche il gay pride, l'animalismo e gli uteri
in affitto, le droghe (ma leggere, mi raccomando) e i figli artificiali (ma non
più di dieci a testa, mi raccomando). Tutto nel nome della civiltà liberale,
compresa la scomparsa della civiltà. Eppure io sapevo che il liberalismo non ha
una vocazione totalitaria, è anzi il pensiero fondato sulla limitazione dei
poteri, si ferma alle soglie dell'ambito privato, vigila per evitare le
ingerenze dello Stato e tutela la libertà, compresa la libertà d'opinione,
rifiutando di concepire reati ideologici. In tema di omosex, ad esempio, sarebbe
più liberale auspicare la privatizzazione del sesso e non la sua esibizione
pubblica e la sua copertura governativa, la sanzione speciale e penale del
sacrilegio di lesa omosessualità e la sua centralità politica, sociale e
istituzionale. Sei gay, sono fatti tuoi. Nessuno ti impedisce di esserlo, dice
il liberale, e se ledono i tuoi diritti c'è la legge ordinaria a difenderti come
tutti i cittadini; ma da qui a fare cortei con sindaci e ministri, innalzare
l'omosessualità a programma parlamentare, chiedere la statalizzazione (...)(...)
della gayezza, la sua tutela a norma di legge come per i beni artistici,
reclamare lo stravolgimento della realtà e della natura, confondere unioni gay
con famiglie, ce ne corre. E poi ci sono liberali e liberali. Si può essere
liberali e conservatori, liberali e patrioti, come furono i grandi liberali
italiani, risorgimentali e continentali, e si può essere liberal e progressisti,
liberal e internazionalisti, come furono in gran parte gli angloamericani. Se
non mi sono distratto nel frattempo, Il Giornale rientra nella prima specie, sin
dai tempi di Montanelli. La «e» dopo liberal conta molto, e conta molto pure la
congiunzione che ne segue: visto che tutti si definiscono liberali, e dunque non
è un segno distintivo, mi dite poi che altro siete oltre che liberali? Non
vorrei che si usasse la definizione di liberale per coprire il fallimento sui
veri temi liberali: visto che non si abbassa la pressione fiscale, non si
sfoltiscono le leggi e i vincoli, non si smette di vessare i cittadini e non si
riconosce la libertà come responsabilità e intreccio di diritti e di doveri,
allora usiamo la scorciatoia variopinta di applicare il liberalismo monodose,
uso individuale, in casa e da passeggio, col gatto, la provetta e il gay. Mi
sembra la sorte parallela a quella della sinistra che, avendo smesso di fare la
lotta di classe e di tutelare i proletari (con prole) e avendo accettato il
dominio del capitalismo, risarcisce il gentile pubblico col liberalismo
domestico o da sfilata, quello della libertà individuale di sesso, transgenia,
droga, morte e migrazione. L'argomento che usano ambedue è lo stesso: ma se lui
è gay a te che importa, mica tocca la tua famiglia e la tua vita. Ma avete mai
sentito dire che c'è una differenza tra sfera pubblica e sfera privata, c'è una
differenza tra due che insieme fanno figli e due omosessuali e la prima dicesi
famiglia, la seconda è unione; c'è differenza tra padre e madre, c'è differenza
tra persone e animali (voi direte, a vantaggio degli animali e sulla battuta ci
sto anch'io, ma si dà il caso che siamo uomini; e fino a che i codici non li
scriveranno i cani, nella gerarchia degli esseri gli uomini vengono prima degli
animali)? Non dobbiamo tener conto di queste differenze? Avete mai sentito
parlare di civiltà, sapete che cos'è una comunità, famigliare o civica? Beh, la
civiltà, come le comunità, ha un ambito privato e un altro in cui interagisci
con gli altri, ti connetti a un tessuto comune e rispetti linguaggi comuni,
costumi, tradizioni, principi condivisi. E poi non conta nulla educare le
giovani generazioni, indicare priorità, modelli di vita e beni comuni? E tu, che
liberale sei? Mi chiederete. No, io non pretendo di essere liberale, per me la
libertà è un mezzo e non un fine, è come l'ossigeno che mi fa vivere, ma non
posso avere come ideale di vita l'ossigeno. La libertà è una condizione
preliminare, una necessità, e perciò va difesa; ma diventa un valore nell'uso e
nei frutti. Non sono liberale ma ho preso lezioni anche dai grandi liberali, a
cominciare dai classici che per me sono Tocqueville, Ortega, Berlin e Aron e da
noi Cuoco, i risorgimentali, Croce, Pareto, Mosca, Panfilo Gentile e Prezzolini.
E non giocando da liberale mi permetto di fare il guardalinee. Non dimenticate
che i liberali veri sono sempre stati una piccola, rispettabile minoranza;
l'unico partito liberale di Massa era una sezione del Pli nell'omonimo comune.
Per diventare popolare, il liberale deve coniugarsi a qualcos'altro, quella «e»
famosa che gli dà sostanza e contenuti. Sapete poi che se vi definite liberali e
moderati non avete opposto nulla al renzismo? Poteva servire con estremisti e
comunisti, non con lui...Tornando a noi, se anche da queste colonne ripetiamo a
scoppio ritardato quel che dicono tutti gli altri giornali su gay, sesso, droga,
animali, genetica e via dicendo, se ci accodiamo al coro del politically correct,
perché dovrebbero preferirci, leggerci e comprarci? Ricordatevi le leggi di
mercato, cari liberali. Sono inesorabili e voi dovreste saperlo più di me.
Addio ad
Altissimo, ex segretario del Pli.
Leader dei liberali, è stato più volte ministro. Morto dopo una lunga malattia,
scrive “La Stampa”. «Sono abbastanza curioso di vedere “1992”. Vediamo se per la
prima volta ci sarà una ricostruzione obiettiva di Tangentopoli». Così, poco
meno di due mesi fa e prima di essere ricoverato al Gemelli di Roma dove è morto
questa sera, Renato Altissimo si soffermava via Twitter sulla celebre serie
trasmessa qualche giorno fa su Sky e incentrata su una delle vicende chiave
della biografia di un pilastro del Partito Liberale Italiano, lo scandalo delle
mazzette che rivoluzionò la politica 25 anni fa. Altissimo fu, tra l’altro,
deputato in ben cinque legislature e più volte ministro: Nel governo Cossiga I,
nei governi Spadolini I e II e nel governo Fanfani V da titolare della Sanità,
nel governo Craxi I da responsabile dell’Industria. Celebre anche per essere un
“viveur” e un assiduo frequentatore delle notti romane - in particolare di quel
“Tartarughino” che fu un buen retiro serale per diversi esponenti della Prima
Repubblica - Altissimo, volto abbronzato, fronte ampia e immancabile basettone,
fu travolto, come tanti altri, dal principale processo giudiziario di Mani
Pulite, l’inchiesta sulla maxitangente Enimont. Lo scandalo delle mazzette da
150 miliardi non travolse solo Altissimo coinvolgendo nomi celebri come La Malfa
o Forlani e sotterrando, di fatto, il Pli. Altissimo fu, tra l’altro, deputato
in ben cinque legislature e più volte ministro: Nel governo Cossiga I, nei
governi Spadolini I e II e nel governo Fanfani V da titolare della Sanità, nel
governo Craxi I da responsabile dell’Industria. Celebre anche per essere un
“viveur” e un assiduo frequentatore delle notti romane - in particolare di quel
“Tartarughino” che fu un buen retiro serale per diversi esponenti della Prima
Repubblica - Altissimo, volto abbronzato, fronte ampia e immancabile basettone,
fu travolto, come tanti altri, dal principale processo giudiziario di Mani
Pulite, l’inchiesta sulla maxitangente Enimont. Lo scandalo delle mazzette da
150 miliardi non travolse solo Altissimo coinvolgendo nomi celebri come La Malfa
o Forlani e sotterrando, di fatto, il Pli. Altissimo, che nel 1993 ammise di
aver ricevuto diversi milioni in maniera illecita, fu definitivamente condannato
a 8 mesi nel 1998. Venti anni dopo, con un libro scritto a quattro mani con
Gaetano Pedullà e pubblicato nel 2012 tornerà su quegli anni raccontando le sue
verità ed inediti retroscena sotto un titolo che non lasciava spazio a dubbi:
«L’inganno di Tangentopoli». Il suo percorso politico, però, non si concluse.
Nel 2014, tornava infatti sulla scena con “I Liberali”, movimento che,
promuovendo il rilancio dell’economia e un’accelerazione sulle privatizzazioni,
raggruppa, tra gli altri, alcuni pilastri del liberalismo italiano come Alfredo
Biondi o Carlo Scognamiglio. E, fino a oggi, Renato Altissimo.
Gli ex della
prima Repubblica. RENATO ALTISSIMO: “Silvio adesso si lamenta ma fu lui a
esaltare le toghe”. L’ex segretario del Pli: “E’ l’Italia più illiberale che si
sia mai vista”. Ricordi e giudizi, scrive Giovanni Cerruti su “La Stampa”. La
risata è sempre la stessa, l’abbronzatura anche. «E poi dicevano di noi, che le
notti della Prima Repubblica andavamo al Tartarughino... ». Di anni ne son
passati quasi venti, le sigarette sono un ricordo e il bicchiere è sempre mezzo
pieno, ma è acqua minerale. Le vetrate di Villa Floreana guardano un mare che ha
il colore delle nuvole, roba da pomeriggio in depressione. E invece basta un
nome, Ruby, e Renato Altissimo si eccita. «Ruby! Il premier rischia di saltare
per Ruby! Non lo mandano via perché si è fatto gli affari suoi. No, per Ruby! E
il benservito arriva dalla magistratura, non dalla politica! Come per noi nel
1992». Ruby, e all’ultimo segretario del Partito Liberale passa la voglia di
ridere e monta la rabbia. «Ma che Paese è diventato il mio Paese? E’ l’Italia
più illiberale che abbia mai conosciuto». Sarà per questo che Altissimo, ora che
è nonno e si avvicina ai 71 anni, l’altra settimana ha ripreso la tessera del
suo partito. «A questa età mi restano due passioni: le belle donne che non mi
filano più e la politica che è sparita». Dal ’94 abita tra Londra e questa villa
di famiglia. «Ma adesso voglio tornare a Roma a cercare la politica, la bella
politica. La rovina dell’Italia non è il bunga bunga, è la politica che non fa
più niente». E’ stato quattro volte ministro della Sanità, una dell’Industria,
segretario del Pli fino al maggio del ’92. Ha visto cadere la Prima Repubblica,
pure a lui sono arrivati avvisi di garanzia, ben 19, e gli è rimasta addosso una
condanna piccola e fastidiosa, 8 mesi per un finanziamento di 200 milioni di
lire da Montedison. «Sulla magistratura potrei raccontare cose che voi umani
nemmeno immaginate. Mi dicono: dài, appena otto mesi, non ci pensare. E io ci
penso, perché sono una persona perbene: per pagare le quattordicesime agli
impiegati del partito andavo a prelevare i soldi dal conto corrente di mia
madre». Mai stato un bacchettone, né un moralista sulle disgrazie altrui.
«Andavo al “Tartarughino”, il piano bar dietro piazza Navona. Quante me ne hanno
dette per un paio di bicchieri di whisky». Altra epoca. Le cronache mondane,
anche le più pettegole, si fermavano sul portoncino. «C’erano belle donne,
certo. E tiravamo tardi cantando le canzoni di Sanremo con il duo
Antonio&Marcello al piano, sai che peccaminosa trasgressione». Adesso, invece?
«Ma adesso invece cosa? Si scopre il filone politica e sesso? E tutti i film
degli Anni 70 della serie “All’onorevole piace la gnocca” ve li siete
dimenticati?». Sta scrivendo un libro. «Perché voglio che i miei nipoti sappiano
che il nonno è stato una persona perbene. E sappiano che la Prima Repubblica è
stata ammazzata, che c’è stato un “golpe”, che hanno colpito noi del
Pentapartito e salvato ex comunisti, la sinistra Dc di De Mita e quel Msi che
campava d’aria, d’amore e lasciti di vedove. Noi vittime della “dittatura della
magistratura”, secondo il senatore di sinistra Giovanni Pellegrino. Il risultato
è che si è infilato Silvio e in questi anni, senza la politica, c’è stato il
“Sacco d’Italia”: l’hanno spogliata e spolpata tutta, Telecom, Autostrade,
banche...». Di questo, dopo quasi vent’anni di silenzio, di isolamento
volontario, di ritorno agli affari di famiglia, vorrebbe parlare Altissimo. Ma
dall’Italia non c’è giorno che non arrivi una nuova puntata di cronaca
giudiziaria, con Berlusconi che sembra sempre più in affanno. «Mi capita spesso
di pensare ai nostri anni, e alla fine di Bettino Craxi. Perché c’erano anche le
telecamere di Mediaset fuori dall’hotel Raphaël, a riprendere quelli che
tiravano le monetine a Bettino. E le tv di Silvio ci davano dentro con gli
evviva ai magistrati. Oggi lui si lamenta e paga: sono state anche le sue tv a
inaugurare tutto questo scempio». L’ha conosciuto bene, il Cavaliere. Nella Roma
dei primi Anni 90, alle colazioni del mercoledì con Fedele Confalonieri e Gianni
Letta in via dell’Anima, Renato Altissimo aveva un posto fisso. «Ci ha aiutato,
non lo dimentico. Gli spot elettorali del Partito Liberale sulle sue reti erano
gratis. Ci avesse dato mozzarelle e le avessimo rivendute, negli anni di
Tangentopoli saremmo finiti in galera». Ma il Berlusconi politico non l’ha mai
convinto. «Con questa legge elettorale, poi, che ammazza la politica: il mio
labrador si chiama Kim e lo consiglierei per il Senato: è meno ingombrante di un
cavallo, non tradisce e non manda sms». A vent’anni, lui veneto di Portogruaro,
ha cominciato a imparare il dialetto piemontese battendo circoli e bocciofile
attorno a Torino, a cercare iscritti per il suo Pli. «Ecco perché non mi piace
l’Italia di oggi e sono convinto che sia giusto tornare. Perché non c’è la
politica, non c’è la passione, non ci sono idee. La Prima Repubblica non è
caduta perché erano tutti una massa di ladroni, ma perché la “dittatura della
magistratura” ha voluto distruggere e Silvio è stato svelto ad approfittarne. Io
ero un giovane ricco che con la politica si è impoverito, e dei miei colleghi di
allora nessuno vive da nababbo». L’Italia è vicina, i giornali arrivano, la tv è
sempre accesa, il computer anche. Da Londra o Cap Ferrat non si è perso una
puntata delle ultime su Berlusconi. E per il vecchio amico non riesce a
prevedere un radioso futuro. «Se si dimette si arrende alla magistratura, se
resta è uno sfregio alle istituzioni, dipendesse da lui e dai suoi resterebbe lì
tutta la vita. Forse dovrebbe andare a elezioni anticipate: “Voglio riformare
questa Repubblica Giudiziaria - potrebbe dire -, poi tolgo il disturbo e vado a
occuparmi dei miei affari e delle mie Ruby”. E se ogni tanto volesse invitare
quelli che andavano al Tartarughino...». Quegli applausi alle toghe«C’erano
anche le tv del Cavaliere a riprendere quelli che tiravano le monetine a
Bettino. E ci davano dentro con gli evviva ai magistrati, inaugurando tutto
questo scempio»Se questa è politica...«Il premier rischia di saltare per Ruby!
Non lo mandano via perché si è fatto gli affari suoi. No, per Ruby! E il
benservito arriva dalla magistratura! Come per noi nel 1992»Tangentopoli
insegna«La Prima Repubblica è stata ammazzata, c’è stato un "golpe", hanno
colpito noi del Pentapartito e salvato ex comunisti, la sinistra Dc di De Mita e
il Msi».
Le verità
di Altissimo «Mi chiesero il 5% per pagare il Pci»,
scrive Fabrizio Boschi su “Il
Giornale”. Lui sa cose che in pochi sanno, e soprattutto, ha visto cose che in
pochissimi in Italia avrebbero il coraggio di raccontare. Non solo l'ex leader
del partito Liberale, Renato Altissimo oggi le racconta, nero su bianco. È
uscito il suo libro intervista con l'ex direttore del Tempo, Gaetano Pedullà
L'inganno di Tangentopoli (Marsilio, prefazione di Giuliano Ferrara), che a
vent'anni da Mani Pulite, smaschera politici e imprenditori complici di quella
diabolica macchina raccatta soldi. Altissimo (oggi 72enne), esce allo scoperto e
apre gli armadi della vergogna, tirando fuori tutti gli scheletri possibili.
Quando politici e manager «trattenevano» per loro le mazzette, quando negli
affari tra l'Italia e i paesi ex Urss una quota era destinata al Pci, quando
Cuccia invitò Craxi a guidare una «rivoluzione», portando al governo la sinistra
socialista e comunista, marginalizzando la Dc: Craxi rifiutò e venne abbattuto.
Il più volte ministro svela inediti retroscena di quella stagione buia della
storia d'Italia di cui Dagospia ha pubblicato alcune anticipazioni. Bombe a
ripetizione. Negli anni Settanta, quando lavorava nell'azienda di famiglia, la
Altissimo, che produceva fanaleria per auto, ricevette una visita. «Mi contattò
un tale ragionier Bianchi, a nome di una azienda di import-export di Milano, che
mi propose di entrare nel mercato jugoslavo. Ma per farlo dovevamo versare il 5%
su un conto in Svizzera del Partito comunista italiano». Poi c'erano le «creste
di Tangentopoli». «Eravamo vicini alle elezioni del '92 e andai al gruppo
industriale Sama. Mi consegnarono una valigetta dicendomi che era un contributo
per la campagna elettorale del Pli. Fui poi condannato per aver preso 200
milioni di lire, ma in quella valigetta c'era molto meno. Qualcuno aveva fatto
la cresta persino sui soldi destinati al finanziamento della politica». Nel
marzo '93, dopo l'avviso di garanzia, Altissimo racconta di aver chiamato
l'allora direttore della Stampa, Ezio Mauro, per replicare nelle sue pagine.
«Non mi faccia perdere tempo - fu la risposta - non c'è niente da spiegare. I
soldi li ha presi o no?». Poco dopo la sua nomina alla Stampa, Altissimo ne
parlò con Agnelli. «Come mai - gli chiese - avete messo un filocomunista al
timone del giornale di Torino?». «Perché un comunista in redazione val bene la
pace in fabbrica», rispose l'avvocato. Da ministro dell'Industria (con Craxi),
conobbe l'ad della Heinz, produttrice del famoso Ketchup, che voleva comprare la
Sme, sotto il controllo pubblico, per circa 3.500 miliardi di lire. «Feci
presente questo interesse a Prodi, allora presidente dell'Iri, a cui faceva capo
la Sme». Ma lui si mise a ridere: «Mi rivelò che la Sme era zeppa di liquidità e
l'Iri non avrebbe mai potuto venderla». Qualche mese dopo Altissimo ricevette
una telefonata dell'ingegner De Benedetti. «Renato, volevo informarti che
abbiamo concluso ieri l'acquisto della Sme». Era stata venduta per soli 497
miliardi, pagabili in cinque anni. E Prodi? «Fu lui a telefonarmi - racconta
Altissimo nel libro - "Renatino, volevo dirti che ho venduto la Sme. Sarai
contento finalmente". Gli chiesi come mai era stata venduta a sette volte meno
il suo valore, mentre c'erano soggetti pronti a offrire di più. "Perché De
Benedetti ha un taglietto sul pisello che altri non hanno", fu la risposta di
Prodi, alludendo a pressioni di consorterie ebraiche».
L' inganno
di Tangentopoli. Dialogo sull'Italia...Anche
questa era Tangentopoli.
Recensione di
Giovanni Basile. Gira e rigira l’argomento Tangentopoli tira
comunque in libreria, forse perché mai passato di moda. Per come vanno le cose
al momento, viene spontaneo il trito e ritrito “si stava meglio quando si
stava peggio”: ieri si arraffava per il partito, oggi per se stessi. I
politici targati Prima repubblica avevano quanto meno più spessore culturale e
competenza in confronto ai correnti nani, ballerine, veline, imbucati,
improvvisati e mangioni di ogni risma proliferanti a livello nazionale e locale.
In questo libro intervista a Renato Altissimo si ripercorre lo scandalo delle
tangenti proprio da chi ha sbagliato: qualche avviso di garanzia per
finanziamento illecito al partito e successiva condanna. Altissimo, già
segretario del glorioso Partito Liberale Italiano - oggi vive a Londra -, era
quel politico che in televisione vedevi sempre in forma smagliante, fisico
asciutto, perenne abbronzatura, uno insomma dall’aria di sapersi godere la vita.
Ex manager nel settore industriale, varie volte deputato e ministro, Altissimo
snocciola la propria versione su Mani Pulite: racconto di parte, il suo, ma
lucido e significativo. Dopo il crollo del muro di Berlino, la magistratura
avrebbe avuto mano libera nell’inchiodare alle proprie responsabilità i partiti
di allora, usciti distrutti ad eccezione di Msi e Pci: il primo in quanto fuori
dall’ arco costituzionale e, quindi, dai giochi di potere; il secondo perché di
struttura così bene organizzata da rendere difficile provare l’esistenza di
finanziamenti illeciti e corruzioni. Parte della magistratura avrebbe tenuto un
orientamento più morbido verso Botteghe Oscure, rispetto alle altre forze
politiche coinvolte nello scandalo. La discesa in campo del Cavaliere di Arcore
avrebbe ribaltato le aspettative della gioiosa macchina da guerra occhettiana,
pronta a prendere le briglie del potere per manifesta dissolvenza di
democristiani e socialisti, alle prese con avvisi di garanzia e manette. Tesi,
queste, dal sapore revisionista ma con qualche fondamento, forse, da non
scartare a priori. Chissà: la Storia fornirà un giorno le risposte. Senza alcun
dubbio, quella classe politica non può però certo passare per vittima
sacrificale di giudici prevenuti e in malafede: di degrado e fanghiglia da
scoprire ce n’erano eccome, e questa è ormai verità giudiziaria. Un intero
assetto istituzionale, stratificato a più livelli, pur con differenti gradazioni
di responsabilità, era comunque contaminato dal sistematico ricorso alla
corruzione in tutte le sue forme - soprattutto attraverso le cosiddette “dazioni
di danaro” con cui i partiti si finanziavano. Gaetano
Pedullà intervista l’ex segretario PLI con domande ficcanti, il quale non
nasconde le responsabilità avute in quella vicenda. Il dialogo rivela fatti poco
edificanti, intrecci, collusioni e qualche innegabile strumentalizzazione dietro
quella clamorosa inchiesta. Purtroppo, il bubbone, a distanza di vent’anni,
sembra tutt’altro che sanato: anzi, le cronache degli ultimi mesi dicono che
niente è cambiato, se non addirittura peggiorato. Non meno interessante,
argomentata, partigiana, è l’introduzione del rissoso Giuliano Ferrara.
Forza e coraggio, allora: queste pagine provocanti sul nostro recente passato
meritano attenzione.
Altissimo
Renato; Pedullà Gaetano - L' inganno di Tangentopoli. Dialogo sull'Italia...Dopo
aver messo "l'Italia in esilio" per un finanziamento al partito che gli è
costato una condanna nell'inchiesta di Mani pulite, da Nizza e da Londra, dove
vive, Renato Altissimo non ha mai smesso di osservare con attenzione le vicende
italiane. Mai prima d'ora, però, aveva sentito così vicino il clima cupo di
quegli anni, tanto da voler rendere pubblica in questo libro-intervista con
Gaetano Pedullà una dettagliata, quanto scomoda, testimonianza diretta, per
capire fino in fondo quella stagione e non ricadere negli stessi errori. Se è
vero che la storia è scritta dai vincitori, infatti, Tangentopoli rischia di
restare una vicenda senza storia. Non solo perché a vent'anni di distanza i vizi
dell'Italia sono sempre gli stessi, la corruzione è diffusa, il debito pubblico
ha toccato vette inesplorate e il vento dell'antipolitica ha svuotato di potere
istituzioni e democrazia. Se a questo si aggiungono l'indignazione ancora
percepibile in gran parte del Paese e il camaleontismo di chi ha tratto
grandissimi benefici da quella stagione, ecco che diventa difficile trasferire i
fatti di allora dalle pagine della cronaca a quelle della storia. Un compito
arduo quanto doveroso, perché senza determinarne gli anticorpi, presto o tardi
potremmo trovarci a dover fare i conti con una nuova Tangentopoli, persino più
dirompente di vent'anni fa. Prefazione di Giuliano Ferrara.
Bombastico
libro intervista dell'ex leader del Partito liberale Renato Altissimo con il
giornalista Gaetano Pedullà, dal 27 giugno in libreria, scrive “Dagospia”. A
vent'anni da Mani Pulite, "L'inganno di Tangentopoli", edito da Marsilio, svela
inediti retroscena di quella stagione, ancora oggi di concertante attualità per
le analogie con il virus della corruzione, la debolezza della classe politica,
la "facile soluzione" di svendere pezzi dello Stato per uscire dalla crisi.
Eccone alcune anticipazioni.
RENATO
ALTISSIMO. TANGENTI AL PCI, UN FIUME DA MOSCA. Qui racconto per la prima volta
una storia che mi vide personalmente coinvolto non come esponente politico, ma
come imprenditore. Negli anni settanta lavoravo nell'azienda di famiglia, la
Altissimo, una delle società leader in Europa nella produzione di fanaleria per
auto. Un giorno fui contattato da un tale ragionier Bianchi, a nome di una
piccola azienda di import/export di Milano, che mi chiese un appuntamento e mi
venne a proporre di entrare nel mercato jugoslavo. Nel Paese di Tito c'era un
importante produttore di auto (su licenza Fiat), la Zastava, di cui avevamo
tentato più volte di diventare fornitori. Sempre però senza successo. Il
ragionier Bianchi pose subito in chiaro le cose. Se volevamo lavorare con quella
azienda c'era solo un modo: il 3% delle commesse andava versato su un conto
svizzero intestato ad alcune persone che avrei dovuto incontrare in Jugoslavia;
il 2% andava alla società del ragionier Bianchi e un altro 5% su un altro conto,
pure questo in Svizzera, di pertinenza del partito. Quale partito? Il ragionier
Bianchi mi disse candidamente: Partito comunista italiano. Mi sembrò
incredibile. E per verificare che il mio interlocutore dicesse il vero andai
personalmente a Belgrado per incontrare i generali che avrebbero potuto
consentire quell'affare. Ogni dettaglio dell'offerta era vero. Questo episodio,
seppur minimo, testimonia come su tutto quanto veniva intermediato tra l'Italia
e i Paesi ex sovietici c'era da accantonare una quota per il Pci. E siccome
parliamo di Paesi ricchi di materie prime, a cominciare da gas ed energia, è
chiaro che di soldi dovevano arrivarne tanti.
LA "CRESTA" SU
TANGENTOPOLI. C'erano in vista le elezioni del 1992 e andai a trovare Sama -
come era d'uso con i vertici dei grandi gruppi industriali - per presentargli il
programma del mio partito, soprattutto sulla politica economica. Lui mi
trattenne pochissimo, mostrandosi poco interessato al programma, ma
accompagnandomi cordialmente alla porta del suo ufficio mi consegnò una
valigetta dicendomi che era un contributo per la prossima campagna elettorale
del Pli. Appena rientrato a Torino consegnai la valigetta al funzionario del
partito che si occupava dell'amministrazione dei fondi elettorali. Tempo dopo,
al processo fui chiamato a rispondere per questo finanziamento e condannato per
aver preso 200 milioni di lire. Anche se in realtà in quella valigetta non
c'erano tutti quei soldi. Che vuol dire? Quanto c'era davvero in quella
valigetta? C'erano 150 milioni di lire. Al processo però non lo rivelai perché
non volevo mettere in difficoltà il funzionario del mio partito, che avrebbe
potuto essere accusato di aver preso per sé una parte della somma. Dunque, lei
rivelò al processo di aver ricevuto 200 milioni di lire, ma nella valigetta ce
n'erano solo 150. Come mai? Qualcuno aveva fatto la cresta persino sui soldi
destinati al finanziamento della politica? È la spiegazione più plausibile.
D'altra parte, poi ho scoperto che questo era un comportamento diffuso. Se
c'erano i politici che trattenevano per sé una parte o la totalità dei soldi che
intascavano, c'erano anche manager o funzionari delle imprese che allo stesso
modo approfittarono di quell'andazzo, tenendo per sé qualche mazzetta. Con i
soldi che arrivavano, che ci facevano i partiti? I dirigenti potevano usare
quelle somme a piacimento? Assolutamente no. E poi c'era poco da usare... quei
soldi erano sempre molto meno di quanto costassero segreterie, campagne
elettorali, stipendi ai dipendenti, materiale per la propaganda... Certo un uso
disinvolto, come quello che ha potuto fare vent'anni dopo il tesoriere della
Margherita Luigi Lusi, non era proprio pensabile.
LA POLITICA DA
"ABBATTERE". Craxi diventa il simbolo della vecchia politica corrotta. La gente
gli tira le monetine...Che paradosso! Craxi che voleva modernizzare il Paese
trasformato in simbolo del vecchio... Ma tutto ha una sua logica. Uno come lui
non avrebbe mai consentito quell'assalto alla diligenza, quel grande banchetto
ai danni dello Stato, che avvenne poco dopo grazie al «nuovo» corso della
politica, imposto dalle inchieste e dai tribunali. Un episodio illuminante in
questo senso lo racconta Paolo Cirino Pomicino nel suo libro Dietro le quinte. È
Craxi a parlare. «Era l'estate del 1990. Venne un grande amico imprenditore e mi
portò un messaggio di Enrico Cuccia. In pratica mi invitava a nome della grande
borghesia azionista e anticlericale a guidare una sorta di "rivoluzione",
portando al governo l'intera sinistra socialista e comunista e marginalizzando
la Dc, che nel frattempo avrebbe dovuto frantumarsi». Il presidente di
Mediobanca, dunque, cercava già allora uno spazio di espressione politica per
quei circoli azionisti costretti, da cinquant'anni, a muoversi da padroni
soltanto nel recinto finanziario tra via Filodrammatici, Fiat e Banca d'Italia.
«Ma Craxi lasciò cadere il messaggio: in esso vedeva il primo passo
dell'asservimento della politica agli interessi economici dei poteri forti». Per
tutti questi motivi Craxi era il vero ostacolo da abbattere. E fu abbattuto.
PRODI, DE
BENEDETTI E QUEL TAGLIETTO SUL...Era il 1985 e all'epoca ero ministro
dell'Industria. A gennaio fui invitato a Nizza a una cena organizzata da Tito
Tettamanti, un amico svizzero, e qui conobbi l'amministratore delegato della
Heinz, un colosso mondiale del settore alimentare che produce, tra l'altro, il
famoso Ketchup. Questo signore mi fece i complimenti per gli orientamenti
espressi dal governo - era premier Bettino Craxi - in materia di privatizzazioni
e mi rivelò di essere molto interessato all'acquisto della Sme, fiore
all'occhiello dell'industria agroalimentare italiana, sotto il controllo
pubblico. Suoi erano importanti marchi come Motta, Alemagna, Bertolli, i
supermercati Gs e Autogrill. Gli spiegai subito che una possibile vendita non
era competenza del Ministero dell'Industria, ma di quello delle Partecipazioni
statali. Comunque avrei fatto presente la manifestazione d'interesse al
professor Romano Prodi, allora presidente dell'Iri, a cui faceva capo la Sme.
Gliene parlò? Certo. Prodi mi invitò a colazione nella foresteria della sede
dell'Iri a via Veneto; colazione alla quale parteciparono anche Natalino Irti,
membro del Consiglio di presidenza dell'istituto, e Michele Tedeschi, direttore
dell'Iri. La posta in ballo era alta e gli americani erano disponibili a pagare
bene. Una grossa opportunità per le casse dello Stato. Prodi però si fece una
grande risata e ci disse subito che non era possibile nemmeno minimamente
pensare a una cessione. La Sme, ci rivelò, era zeppa di liquidità e l'Iri non
avrebbe mai potuto venderla perché assoluta-mente indispensabile per far cassa e
comunque essenziale per gli equilibri del gruppo. Il prezzo, inoltre, era molto
elevato. La valutazione che ne fece fu di circa 3500 miliardi di lire. Concluso
l'incontro, chiamai al telefono il mio amico Tettamanti e gli spiegai che l'Iri
non intendeva vendere la Sme, ritenendola fortemente strategica in termini
finanziari. Peccato, fu la risposta, perché gli americani avrebbero
probabilmente potuto pagare la cifra ipotizzata dal professor Prodi. Dopo
qualche mese ricevetti attraverso la batteria del Viminale una telefonata
dell'ingegner De Benedetti. «Renato, volevo informarti che abbiamo concluso ieri
l'accordo per acquisire la Sme», mi disse candidamente. Cercando di nascondere
la sorpresa, risposi di essere compiaciuto in quanto da sempre favorevole alla
privatizzazione dell'imponente apparato industriale dello Stato. Subito dopo
però scoprii che la Sme era stata venduta non per i 3500 miliardi di lire
ipotizzati da Prodi, ma per appena 497 miliardi, per di più pagabili in cinque
anni. Ne chiese conto al professor Prodi? Certo. Fu proprio lui a telefonarmi. «Renatino,
volevo dirti che ho venduto la Sme. Sarai contento finalmente», mi disse con
tono ironico. Io però gli chiesi subito come mai il gruppo era stato venduto a
un acquirente che pagava sette volte meno il valore stimato dall'Iri, mentre
c'erano altri soggetti interessati e pronti a offrire di più. «Perché De
Benedetti ha un taglietto sul pisello che altri non hanno», fu la risposta di
Prodi, alludendo, immagino ancora ironicamente, a presunte pressioni di
consorterie ebraiche. Una versione che non stava in piedi. Come tutta quell'operazione
che infatti crollò. Merito di Craxi, che chiamò molti, me compreso, per
sollecitare Barilla a partecipare con Ferrero e Berlusconi a una cordata capace
di avanzare una controproposta.
MAURO, UN
COMUNISTA IN REDAZIONE. La Dc, il Psi, ma anche voi che avevate fatto parte di
molti governi, possibile che siate rimasti improvvisamente senza un megafono,
senza la possibilità di spiegare le vostre ragioni? Si chiusero tutte le porte.
Per dare un'idea posso raccontare un episodio. Dopo aver ricevuto un avviso di
garanzia, riportato con enfasi da tutta la stampa italiana, cerco il direttore
della «Stampa», Ezio Mauro, e gli chiedo di dire la mia dalle pagine del suo
giornale. «Non mi faccia perdere tempo - fu la risposta - non c'è niente da
spiegare. I soldi li ha presi o no?» I processi si facevano così. I giornali
erano i tribunali. E il filo diretto con le procure non era un mistero per
nessuno. Bastava vedere gli atti che pubblicavano. Verbali di interrogatori,
intercettazioni telefoniche... tutti documenti che in gran parte non sarebbero
potuti uscire dai tribunali. Si è fatto un'idea di come sia avvenuta questa
saldatura tra grande stampa e tribunali? L'Italia è un Paese che non ha editori
puri. E allora come ora i giornali servivano a tutt'altro che a informare i
lettori. Ne ebbi una prova lampante proprio con Mauro. Poco dopo la sua nomina
alla direzione della «Stampa», ne avevo parlato con l'avvocato Agnelli. «Come
mai - gli chiesi - avete messo un filocomunista al timone del giornale di
Torino?». «Perché un comunista in redazione val bene la pace in fabbrica» mi
rispose l'avvocato. Anche così si usavano i giornali. E la sinistra aveva
occupato molte posizioni di comando, inserendo centinaia di giornalisti, molti
dei quali in contatto diretto con le procure.
L'inganno di
Tangentopoli: Dialogo sull'Italia a vent'anni da Mani Pulite. Pierantonio
Zanotti, Gaetano Pedullà. Marsilio Editori - 162 pagine.
1 Recensione.
Dopo aver messo «l'Italia in esilio» per un finanziamento al partito che gli è
costato una condanna nell'inchiesta di Mani Pulite, da Nizza e da Londra, dove
vive, Renato Altissimo non ha mai smesso di osservare con attenzione le vicende
italiane. Mai prima d'ora, però, aveva sentito così vicino il clima cupo di
quegli anni, tanto da voler rendere pubblica in questo libro-intervista con
Gaetano Pedullà una dettagliata, quanto scomoda, testimonianza diretta, per
capire fino in fondo quella stagione e non ricadere negli stessi errori. Se è
vero che la storia è scritta dai vincitori, infatti, Tangentopoli rischia di
restare una vicenda senza storia. Non solo perché a vent'anni di distanza i vizi
dell'Italia sono sempre gli stessi, la corruzione è diffusa, il debito pubblico
ha toccato vette inesplorate e il vento dell'antipolitica ha svuotato di potere
istituzioni e democrazia. Se a questo si aggiungono l'indignazione ancora
percepibile in gran parte del Paese e il camaleontismo di chi ha tratto
grandissimi benefici da quella stagione, ecco che diventa difficile trasferire i
fatti di allora dalle pagine della cronaca a quelle della storia. Un compito
arduo quanto doveroso, perché senza determinarne gli anticorpi, presto o tardi
potremmo trovarci a dover fare i conti con una nuova Tangentopoli, persino più
dirompente di vent'anni fa.
Cosa dicono le
persone: Finalmente comincia a venire a galla la verità che la sinistra
giustizialista e i suoi armigeri (alias procuratori e magistrati - la vera
casta- la più pericolosa!!!) ha tenuto nel fondo della sabbie mobili e spero che
i cadaveri della verità possano affiorare..... Un esempio? La bara di D'Ambrosio
come mai è stata omaggiata dal Capo Borelli e alcuni suoi accoliti (in alta
uniforme) ma non da Di Pietro..... Come mai? Sarebbe interessante poter
ascoltare il cervello dell'Antonio e non dalla sua lingua. Direbbe cose
diverse!!!
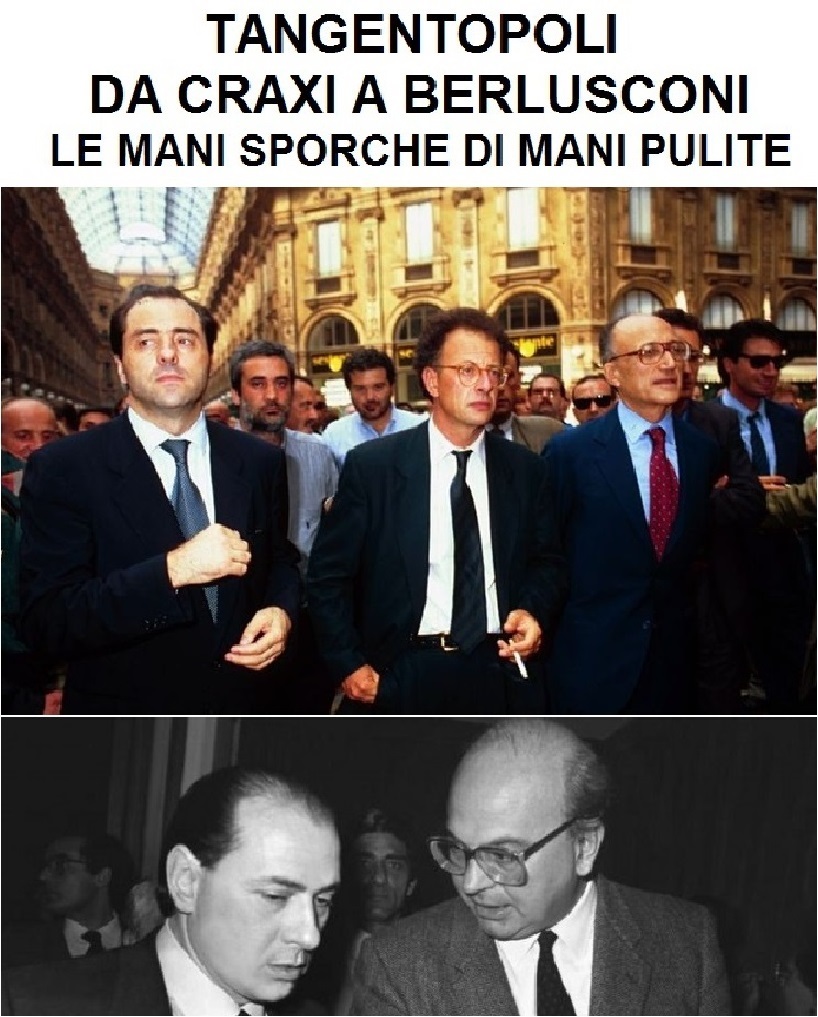




 Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge. PRESENTAZIONE SU
PRESENTAZIONE SU

 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996


 FACEBOOK:
(personale)
FACEBOOK:
(personale)
 WEB TV:
WEB TV:
 NEWS:
NEWS: